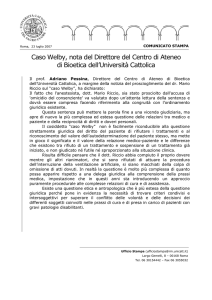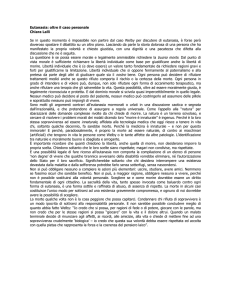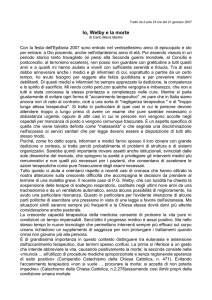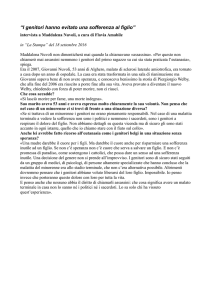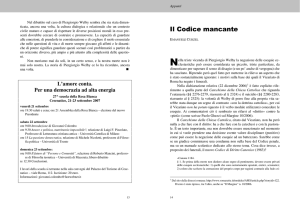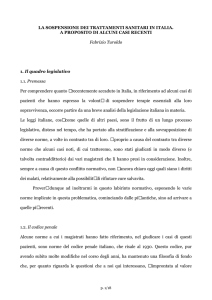EDITORIALE•DIRITTO PENALE
Esiste un “diritto a essere lasciati
morire in pace”? Considerazioni
in margine al caso Welby
di FRANCESCO VIGANÒ
Straordinario di diritto penale nell’Universtità degli Studi di Milano
N
on v’è dubbio: la conclusione della drammatica
vicenda di Piergiorgio Welby - ad opera di un
anestesista che, aderendo alla pressante richiesta del paziente, ha disconnesso il respiratore che lo teneva in vita, praticandogli contemporaneamente un
trattamento sedativo per accompagnarne il decesso rappresenta una sconfitta per l’ordinamento giuridico
italiano, che si è rivelato incapace di fornire un’indicazione univoca, prima che il fatto venisse commesso, circa la liceità o illiceità di quello stesso fatto. Dum Romae
consulitur, Sanguntum expugnatur.
Naturalmente, l’ordinamento non potrà ora esimersi
dal prendere posizione, trattandosi di decidere - ad opera della magistratura requirente e giudicante - se la condotta di quell’anestesista sia, de lege lata, penalmente rilevante. Resta però un senso di disagio nel discutere, ex
post, della possibile responsabilità penale di un professionista che, di fronte alle titubanze della politica e della stessa magistratura italiane, ha deciso di rompere gli
indugi e di prestare ascolto alla propria coscienza, affrontando così il rischio di un procedimento penale per
omicidio. Ma tant’è: certe questioni, con il loro spaventoso carico di sofferenza, non possono essere rinviate all’infinito, con tutti i palleggiamenti di responsabilità cui
si è assistito nelle ultime settimane.
Pur con l’amaro in bocca, vorrei qui cogliere l’occasione per abbozzare alcune risposte ai quesiti sollevati dal
caso Welby: sul piano, in particolare, della determinazione delle regole di condotta che vincolavano ex ante i
sanitari, dedicando in chiusura qualche cenno al connesso ma distinto piano delle possibili conseguenze sanzionatorie della condotta dell’anestesista che, nel caso di
specie, ha disconnesso il respiratore.
P
rendiamo le mosse, dunque, dal piano della determinazione delle regole di condotta. La domanda,
in buona sostanza, suona(va): che cosa avrebbero
dovuto fare i medici di fronte alla richiesta di Piergiorgio
Welby? Detto diversamente (ma il senso è identico):
aveva o non aveva Piergiorgio Welby il diritto di pretendere che i medici disconnettessero il respiratore che lo
teneva in vita?
Il dibattito politico e mediatico sul punto si è polarizza-
to sfortunatamente sui due concetti di eutanasia e di accanimento terapeutico. Sfortunatamente, perché il primo
concetto, evocando un fantasma da molti demonizzato
come attentato alla sacralità della vita umana, non appare affatto funzionale all’obiettivo di una discussione
razionale e pacata sul problema; mentre, come meglio
dirò tra breve, il concetto di accanimento terapeutico è
del tutto fuorviante rispetto alla soluzione del problema
stesso. Decisamente in ombra è rimasto, invece, il punto di vista cruciale del diritto fondamentale di ciascuno a
non essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria
volontà: punto di vista che pure la richiesta di Piergiorgio Welby immediatamente richiamava.
Tale diritto, come tutti i giuristi sanno, è espressamente
sancito nel nostro ordinamento dall’art. 32 comma Cost., che fa salve le sole ipotesi in cui tale trattamento sia
imposto per legge, e comunque entro i limiti segnati dal
rispetto della persona umana; ed è implicitamente riconosciuto, a livello internazionale, dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, adottata in seno
al Consiglio d’Europa («un intervento nel campo della
salute non può essere effettuato se non dopo che la persona abbia dato consenso libero e informato»), nonché
dall’art. 3 Conv. eur. dir. umani («nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona
interessata [...]»). Analoghi, solidi riconoscimenti sono
attribuiti a tale diritto fondamentale all’interno di molti
ordinamenti contemporanei: dagli Stati Uniti, dove il
diritto in questione è considerato dalla giurisprudenza
come un corollario del diritto di privacy, ossia del diritto
“a essere lasciati soli” nelle faccende che riguardano più
intimamente la propria esistenza; all’Inghilterra, dove
viene fondato su un’antica tradizione di common law
corroborata, oggi, dall’incorporazione nel diritto inglese
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a mezzo dello Human Rights Act del 1998; alla Germania, dove viene considerato come un portato del principio di
autonomia dell’individuo, il quale è a sua volta alla radice della “dignità umana”, che l’art. 1 della Costituzione
federale definisce inviolabile.
Duplice, come la giurisprudenza nordamericana ha
ben messo in luce, è il fondamento di questo diritto.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 1/2007
5
EDITORIALE•DIRITTO PENALE
Da un lato, alla sua base v’è il riconoscimento di una
sfera di libertà (o di autonomia) della persona nelle
scelte che più intimamente la riguardano, tra le quali
non possono non annoverarsi le scelte concernenti la
propria salute. Ma, dall’altro, vi è anche l’idea di una
sfera di inviolabilità dello spazio fisico, corporeo: che è
concepito come una sorta di sacro recinto, che nessuno può invadere senza il consenso del suo titolare. Un
trattamento sanitario coattivo - imposto, cioè, con la
forza a chi non lo desideri - costituisce per l’appunto
una violazione del diritto fondamentale in parola sotto entrambi questi profili: perché interferisce indebitamente con la libertà di scelta dell’individuo nelle decisioni che attengono alla propria salute, e assieme
perché costituisce una indebita intrusione nel corpo di
costui, non solo non autorizzata, ma addirittura imposta con la forza. Tanto che, secondo un’opinione ormai pacifica presso i costituzionalisti italiani, l’imposizione con la forza di un trattamento sanitario - risolvendosi necessariamente in una invasione dello spazio
fisico del paziente - chiamerebbe immediatamente in
causa anche la garanzia costituzionale della libertà personale di cui all’art. 13 Cost.
Entro queste coordinate non poteva non essere inquadrata la richiesta di Piergiorgio Welby, che era - lo ricordiamo - anzitutto quella di essere disconnesso dal respiratore che lo teneva in vita: e cioè quella che fosse
interrotto un trattamento medico, che egli - in piena coscienza delle conseguenze cui in tal modo si esponeva aveva deciso di rifiutare. La prosecuzione di tale trattamento nonostante il dissenso del paziente costituiva,
all’evidenza, una coazione a subire il trattamento; e costituiva una coazione particolarmente invasiva del corpo
del paziente, come ben sa chiunque abbia visto con i
propri occhi all’opera un respiratore.
La richiesta di Welby era dunque, semplicemente, che
fosse posta fine a questa coazione, e alla connessa violazione del proprio diritto fondamentale ex artt. 13 e 32
comma 2 Cost.
A
ll’accoglimento della richiesta di Welby sembravano, d’altra parte, ostare alcune obiezioni.
La prima, e più radicale, obiezione è quella sostenuta da
una parte - minoritaria - della dottrina giuridica, secondo cui il diritto fondamentale in parola troverebbe comunque un limite nelle superiori esigenze di salvaguardia della vita umana, concepita come il valore supremo
nel nostro ordinamento. A ciascuno, secondo questa
prospettiva, spetterebbe insomma una libertà di rifiutare ogni trattamento medico, a meno che non si tratti di
un trattamento c.d. di sostegno vitale, ossia di un trattamento necessario per la propria stessa sopravvivenza;
giacché, in tal caso, le istanze di tutela della vita prevarrebbero, e il trattamento in questione potrebbe essere
imposto al paziente anche in assenza di una specifica
norma di legge autorizzatrice, operando comunque - a
6
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 1/2007
giustificazione della coazione - la generale norma scriminante di cui all’art. 54 c.p.
L’obiezione non può essere radicalmente falsificata al
metro del diritto positivo italiano: dopo tutto, anche la
libertà di cui all’art. 32 comma 2 Cost., come qualsiasi
diritto fondamentale, non può a priori essere assunta come assoluta e non bilanciabile con altri diritti fondamentali con la quale possa entrare di volta in volta in
conflitto (nel caso di specie, con la stessa vita umana, riconducibile allo spettro dei “diritti inviolabili” riconosciuti dall’art. 2 Cost.). Tuttavia, non può non registrarsi il sempre più massiccio consenso che riscuote - a livello interno e internazionale - l’opinione opposta, secondo cui il diritto fondamentale a rifiutare il trattamento medico vale di regola anche con riferimento a
trattamenti di sostegno vitale, i quali non potranno
dunque essere imposti con la forza ad un soggetto dissenziente. Ciò che determina, nel nostro ordinamento,
un (almeno parziale) superamento del tradizionale
principio di indisponibilità della vita umana da parte
del suo stesso titolare: principio che, seppur deducibile
da talune vecchie norme di rango ordinario (in primis gli
artt. 579 e 580 c.p.), non è più generalmente avvertito
come idoneo a costituire un limite al diritto di libertà
dalla coazione sul corpo direttamente desumibile dalla
Costituzione.
La questione è stata del resto ampiamente tematizzata,
in Italia e all’estero, in relazione al rifiuto opposto dai
testimoni di Geova a trattamenti emotrasfusionali; e la
conclusione che un po’ dovunque si è raggiunta, negli
ultimi decenni, è quella della necessità di rispettare la
volontà contraria del paziente, anche quando il rifiuto
del trattamento esponga quest’ultimo ad una morte
certa. La medesima conclusione è stata raggiunta in tema di sciopero della fame nelle carceri - ove si è per lo
più negato che l’amministrazione carceraria abbia il
potere di procedere all’alimentazione forzata degli scioperanti, persino in presenza di imminente pericolo di
morte - e più recentemente, nel nostro Paese, in relazione al rifiuto di interventi di amputazioni di arti in
cancrena (fatta eccezione per i soli casi in cui le condizioni psichiche del paziente compromettessero la sua
capacità di rendersi conto delle conseguenze della propria decisione).
Breve: il diritto a non subire trattamenti sanitari contro la propria volontà comporta, secondo l’opinione
largamente prevalente in Italia e all’estero, l’illiceità di
qualsiasi coazione terapeutica, anche quella necessaria
per assicurare la sopravvivenza del paziente. Il diritto
fondamentale in parola è (anche) diritto di essere lasciati morire in pace, se e in quanto il paziente lo desideri.
L
a seconda possibile obiezione pone in dubbio che,
nel caso di specie, si fosse semplicemente in presenza del rifiuto di un trattamento medico. La richiesta di Welby sarebbe stata, piuttosto, quella di essere
EDITORIALE•DIRITTO PENALE
aiutato a morire attraverso delle condotte attive: lo spegnimento del respiratore, da un lato; e la somministrazione di farmaci sedativi, dall’altro.
L’obiezione è ben nota alla letteratura e alla giurisprudenza internazionale, ma è stata ovunque superata.
Quanto al primo profilo, è indubbio che lo spegnimento del respiratore sia una condotta naturalisticamente
attiva: si tratta, in fondo, di premere un pulsante, o di
girare una manopola. Ma la questione cruciale attiene
al significato giuridico di questo atto, che - per quanto riguarda almeno il medico che ha in cura il paziente - è
quello di determinare l’interruzione del trattamento che
egli stesso, a suo tempo, aveva iniziato. Il respiratore
ben può essere riguardato, in effetti, come il braccio
meccanico, come la longa manus del medico che pratica
un trattamento di assistenza respiratoria ad un paziente
non più in grado di respirare da sé: anziché essere effettuata manualmente a mezzo di un pallone di gomma, la
ventilazione è praticata attraverso una macchina che
regola il ritmo respiratorio, insufflando forzatamente
l’ossigeno nei polmoni del paziente. Ma pur sempre di
un trattamento medico si tratta, sia pure attuato attraverso un mezzo meccanico; onde la sua interruzione dovrà essere riguardata come omissione dell’ulteriore trattamento. E ciò anche se tale omissione debba attuarsi attraverso una condotta naturalisticamente attiva, come
la pressione di un pulsante o la rotazione di una manopola.
In questa prospettiva, è anzi la stessa prosecuzione del
trattamento nonostante il dissenso del paziente che configura una lesione del suo diritto fondamentale ex artt. 13
e 32 comma 2 Cost.; mentre l’interruzione del trattamento, in questa situazione, dovrebbe essere riguardata
come una condotta imposta dall’esigenza di rispettare
tale diritto fondamentale. Non è un caso, del resto, che
questa soluzione sia prevalsa presso la giurisprudenza inglese (1) e statunitense (2), ogniqualvolta si sia concretamente posto il problema dell’interruzione di un trattamento di sostegno respiratorio su richiesta del paziente.
Quanto poi alla richiesta di sedativi per lenire le sofferenze associate alla morte per soffocamento, va tenuto
presente che la somministrazione di terapie palliative
costituisce - per comune riconoscimento - un preciso
dovere a carico del medico nei confronti del paziente
morente, persino nell’ipotesi in cui tali terapie possano
produrre quale effetto collaterale l’anticipazione della
morte del paziente. La dottrina italiana e straniera discute da tempo sul fondamento giuridico di questa conclusione: ma nessuno, nemmeno gli autori che più
apertamente si ispirano alla teologia morale cattolica,
dubita seriamente della liceità, ed anzi della doverosità,
di simili condotte.
Nessuna meraviglia, dunque, che Piergiorgio Welby insistesse sul suo sacrosanto diritto a terapie palliative,
una volta che gli fosse stata riconosciuta la possibilità
pratica di esercitare il suo diritto fondamentale di rifiu-
tare la prosecuzione del trattamento di sostegno respiratorio che lo teneva in vita.
U
na terza obiezione era stata, infine, sollevata dai
medici curanti di Welby, i quali - pur riconoscendo in linea di principio la vincolatività della volontà del paziente in ordine alla interruzione del
trattamento di sostegno rianimatorio in atto - osservavano tuttavia come il subentrare di uno stato di incoscienza dovuto alla sedazione avrebbe comportato il risorgere dell’obbligo di rispristinare la ventilazione assistita e di salvare, così, la vita del paziente, non più in
grado di reiterare il proprio dissenso.
L’obiezione muove, invero, dal corretto presupposto secondo cui, in situazioni di emergenza, il medico è
senz’altro legittimato a procedere a interventi urgenti a
tutela della salute e della vita del paziente, pur in mancanza di un suo consenso (v., in tal senso, l’art. 8 della
Convenzione di Oviedo). Tuttavia, ciò non può sensatamente valere per un paziente che rifiuti anticipatamente un determinato trattamento di sostegno vitale,
con una determinazione pensata anche per l’immediato
futuro nel quale egli non sarà più in grado di reiterare tale rifiuto. Il problema si pone, del resto, frequentemente
nei reparti ospedalieri, in relazione a testimoni di Geova
che, prestando il consenso ad un’operazione chirurgica,
esprimano un netto rifiuto ad essere sottoposti alle emotrasfusioni che si dovessero rendere necessarie durante
l’operazione, e dunque quando il paziente medesimo
sarà incosciente per effetto dell’anestesia; e si è posto, altresì, in un passato non lontano in relazione al rifiuto di
alimentarsi da parte di detenuti in sciopero della fame,
essendosi da taluno sostenuto che si sarebbe comunque
dovuto procedere all’alimentazione forzata, una volta
che lo scioperante cadesse in stato di incoscienza per effetto della prolungata inedia. Simili soluzioni appaiono,
francamente, farisaiche, e finiscono nei fatti per conculcare il diritto fondamentale del paziente a rifiutare il
trattamento medico: essendo pressoché sempre prospettabile un obnubilamento delle facoltà psichiche del paziente in prossimità della morte e una sua conseguente
impossibilità di reiterare il dissenso.
Delle due l’una, insomma: o si fa sul serio con il principio di autodeterminazione (e con il rifiuto di ogni “coazione terapeutica”, per quanto ben intenzionata); ovvero si riconosce apertamente che la libertà di decidere se
sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario deve cedere a fronte alle istanze di tutela della vita come valore
impersonale ed oggettivo. Superfluo evidenziare, a questo
Note:
(1) Cfr., per un precedente esattamente in termini, Re B (adult: refusal of
medical treatment), (2002), 2 All ER 449, deciso dalla Court of Appeal britannica.
(2) Cfr. Satz v. Perlmutter, 379 So.2d 359, deciso nel 1978 dalla Corte
Suprema della Florida, e Mc Kay v. Bergstedt, 801 P.2d 617, deciso nel
1990 dalla Corte Suprema del Nevada.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 1/2007
7
EDITORIALE•DIRITTO PENALE
punto, come la prima strada mi paia l’unica sostenibile,
alla luce di un’idea di “dignità” umana che è, anzitutto,
rifiuto di strumentalizzare l’individuo, e la sua libertà,
per scopi che lo trascendono.
L
a conclusione è, dunque, nel senso che i medici
curanti di Welby avrebbero dovuto senz’altro rispettare la sua volontà, e interrompere quindi il
trattamento di sostegno respiratorio in atto; trattamento che - in presenza di un esplicito dissenso da parte di
un paziente pienamente capace di formare e di esprimere la propria decisione - comportava ormai una continua e ingiustificata lesione del suo diritto fondamentale
ex artt. 13 e 32 comma 2 Cost.
Dal che però il dubbio, insistentemente agitato dai sostenitori della tesi avversa: si sarebbe in tal modo operata una surrettizia legalizzazione dell’eutanasia, tramite il
riconoscimento, già de iure condito, di un vero e proprio
“diritto a morire”?
A me pare che anche questo dubbio fosse infondato, sol
che si fosse riflettuto brevemente sulle categorie consolidate nel dibattito internazionale in tema di eutanasia.
Il primo punto da tenere presente è che con l’espressione “eutanasia” non si indica affatto un fenomeno unitario, bensì una pluralità di situazioni eterogenee: ciascuna meritevole di separata considerazione, e comunque
non affrontabile sulla base di principi unitari.
Una prima distinzione, magari inessenziale dal punto di
vista della teologia cattolica ma di fondamentale rilievo
dal punto di vista giuridico, è quella tra eutanasia attiva
e passiva: distinzione che corre lungo la linea di demarcazione tra azione ed omissione, ben nota ai penalisti di
ogni Paese, e che si traduce, nella materia all’esame, in
quella tra “uccidere” e “lasciar morire”. La seconda distinzione, che si interseca rispetto alla prima, è quella
tra eutanasia volontaria (o “consensuale”) e non volontaria (o “non consensuale”), secondo che il soggetto passivo abbia, o non abbia, espresso un consenso alla condotta “eutanasica” (attiva od omissiva).
Ora, la quasi totalità degli ordinamenti contemporanei
(con le rilevanti eccezioni, in particolare, del Belgio e
dell’Olanda) considera penalmente rilevante ogni forma di eutanasia attiva, ricondotta alla fattispecie generale dell’omicidio o al più - ricorrendone gli specifici
presupposti - alle fattispecie privilegiate di omicidio del
consenziente o di istigazione/aiuto al suicidio. Un caso
come quello di Ramón Sampedro - il pescatore galiziano divenuto tetraplegico, la cui vicenda è stata narrata
nello splendido film di Alejandro Amenábar “Il mare
dentro” - continuerebbe verosimilmente ad essere considerato, nella gran parte dei Paesi occidentali, come un
caso di illecita eutanasia attiva consensuale, caratterizzato dalla commissione di una condotta attiva - la somministrazione per via orale di un cocktail letale di farmaci - produttiva della morte di un paziente su richiesta
di costui. E il recente caso Pretty, deciso dalla House of
Lords britannica (3) e poi dalla Corte europea di Stra-
8
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 1/2007
sburgo (4), ha confermato l’inesistenza, anche a livello
sovranazionale, di un vero e proprio “diritto a morire” inteso come diritto dell’individuo ad ottenere di essere
aiutato da terzi a porre fine alla propria esistenza attraverso una condotta attiva diretta a tale scopo.
Completamente diversa è la soluzione prevalente a livello internazionale per le ipotesi di c.d. eutanasia passiva. I casi di eutanasia passiva consensuale, anzitutto, sono null’altro che le ipotesi in cui si omette di intervenire su un paziente che consapevolmente rifiuta un trattamento medico di sostegno vitale, esercitando quello
che pressoché tutti gli ordinamenti riconoscono essere
un suo diritto fondamentale. Del tutto ovvia, allora, la
conclusione nel senso della liceità di una simile condotta omissiva: conclusione che non discende, però, da un
(problematico e discutibile) riconoscimento di un vero
e proprio “diritto a morire” (né da un altrettanto problematico “diritto al suicidio”), ma che è piana e naturale conseguenza dello stesso diritto a rifiutare un qualsiasi trattamento medico, anche se di sostegno vitale.
Come, per l’appunto, nel caso di Piergiorgio Welby.
Assai più “difficili” sono, infine, le ipotesi di eutanasia
passiva non consensuale, caratterizzati pure dalla omissione ab initio, ovvero dalla interruzione, di trattamenti
di sostegno vitale nei confronti di pazienti che non siano in grado di esprimere un chiaro e attuale rifiuto dei
trattamenti medesimi: ipotesi, queste, nella quale si
iscrive l’altro notissimo caso italiano di Eluana Englaro,
la giovane in stato vegetativo permanente il cui padre
sta da tempo chiedendo (sinora senza successo) l’autorizzazione giudiziale alla interruzione dei trattamenti di
alimentazione e idratazione artificiale, che ne assicurano tuttora la sopravvivenza. Anche qui, va registrato
un consenso internazionale sempre più ampio - e il riferimento è a puntuali decisioni rese dalle massime magistrature statunitensi, inglesi, tedesche - nel senso della
liceità, a date condizioni, della interruzione di tali trattamenti; ma è evidente che il problema è qui decisamente più complesso di quanto non sia per il caso di
Piergiorgio Welby, la liceità dell’interruzione del trattamento non potendo in queste situazioni essere pianamente dedotta dalla necessità di inchinarsi di fronte all’esercizio di un diritto fondamentale da parte del paziente medesimo.
Insomma: nessuna conseguenza “a catena” sarebbe stata
innescata da una decisione giudiziale autorizzativa dell’interruzione del trattamento di sostegno respiratorio
che teneva in vita Welby. Il caso di Eluana Englaro, e
gli altri mille casi di “aiuto a morire” o di “aiuto nel morire” che verosimilmente si presenteranno ai giudici italiani nel prossimo futuro, dovranno essere pazientemente ridiscussi, sulla base delle specificità delle situaNote:
(3) House of Lords, [2001] UKHL 61.
(4) C. eur. dir. umani, Sez. III, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, in
questa Rivista, 2002, 914.
EDITORIALE•DIRITTO PENALE
zioni cliniche di volta in volta coinvolte, le quali necessariamente implicheranno il riferimento a principi giuridici diversi e “su misura” rispetto a tali specificità.
U
na decisione giudiziale era stata, in effetti, sollecitata dai legali di Piergiorgio Welby, i quali
avevano promosso un’azione avanti al giudice
civile (anticipata in via cautelare ex art. 700 c.p.c.), finalizzata ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’interruzione del trattamento di sostegno
respiratorio e del correlativo dovere dei sanitari di interrompere tale trattamento, previa somministrazione
di idonee terapie sedative.
Il giudice designato del Tribunale di Roma aveva tuttavia, con un’ordinanza del dicembre scorso, dichiarato
inammissibile il ricorso. Il giudice aveva invero riconosciuto, in linea di principio, l’operatività nella materia
dei trattamenti medici del «principio dell’autodeterminazione e del consenso informato», fondato sugli artt.
2, 13 e 32 Cost. e declinato nel senso che «qualsiasi atto invasivo della sfera fisica, sia di natura terapeutica
che non terapeutica, non può avvenire senza o contro
il consenso della persona interessata, in quanto l’“inviolabilità fisica” costituisce il “nucleo” essenziale della
stessa libertà personale; mentre l’imposizione di un determinato trattamento sanitario può essere giustificato
solo se previsto da una legge che lo prescrive in funzione di tutela di un interesse generale e non [solo] a tutela
della salute individuale». Tuttavia, il giudice si era arrestato a fronte della considerazione che l’ordinamento
positivo non appresterebbe strumenti concreti di tutela
di tale diritto; di talché esso diritto, pur essendo indubitabilmente «sussistente» e «positivamente acquisito»,
non sarebbe suscettibile di esecuzione forzata, essendo
in definitiva la sua attuazione «rimess[a] alla totale discrezionalità di qualsiasi medico al quale la richiesta
venga fatta, alla sua coscienza individuale, alle sue interpretazioni soggettive dei fatti e delle situazioni, alle
proprie concezioni etiche e professionali» (5).
Per altro verso il giudice, richiamando un precedente
della Corte d’Appello milanese sul caso Englaro, aveva
insistito sul carattere di soggettività e di discrezionalità
insito nel concetto di «accanimento terapeutico», indicato quale limite al dovere di cura da parte del medico;
con conseguente impossibilità per il giudice di riempire
un tale spazio «non ancora regolato dal diritto». «Solo
la determinazione politica e legislativa» - aveva concluso il giudice - «facendosi carico di interpretare la accresciuta sensibilità sociale e culturale verso le problematiche relative alla cura dei malati terminali, di dare risposte alla solitudine ed alla disperazione dei malati di
fronte alle richieste disattese, ai disagi degli operatori
sanitari ed alle istanze di fare chiarezza nel definire concetti e comportamenti, può colmare il vuoto di disciplina, anche sulla base di solidi e condivisi presupposti
scientifici che consentano di prevenire abusi e discriminazioni».
Anche qui, mi pare però - con tutto il rispetto per il
giudice che si è trovato a decidere, nell’arco di pochi
giorni, una questione di tale delicatezza e di tali implicazioni - che i fraintendimenti siano molteplici.
Va sgomberato anzitutto il campo dall’improprio riferimento all’accanimento terapeutico, pure insistentemente
evocato nel dibattito che ha accompagnato il caso
Welby. La nozione di accanimento terapeutico - o quelle, funzionalmente omologhe, di “futilità” e di “sproporzionatezza” delle terapie - è comunemente identificata,
anche dalla dottrina della Chiesa cattolica, come il limite al dovere di cure: una terapia, si afferma, in tanto
è doverosa in quanto apporti al paziente un beneficio
superiore ai suoi effetti collaterali indesiderati; non lo è,
ovviamente, nel caso contrario. Stabilire quando un
trattamento possa definirsi ancora ‘utile’ e ‘proporzionato’, e quando sconfini invece in un (inutile) accanimento terapeutico, è normalmente compito della
scienza medica, e non del giudice o del legislatore. Ma
nel caso di Welby il punto in discussione era tutt’affatto
diverso: ed era quello di chiarire se un paziente capace
di autodeterminarsi abbia, o meno, il diritto di rifiutare
un determinato trattamento, anche se per avventura considerato appropriato dal punto di vista della scienza medica,
e comunemente praticato ai pazienti nelle sue medesime condizioni (come è, per l’appunto, il caso della respirazione assistita). Questo problema non può, evidentemente, essere delegato alla discrezionalità dei medici:
è l’ordinamento giuridico che deve risolverlo, bilanciando il diritto all’autodeterminazione in materia sanitaria e all’inviolabilità del proprio corpo con il valore
(oggettivo e sovraindividuale) attribuito alla vita umana, secondo le cadenze che abbiamo poc’anzi ripercorso.
Ma a chi toccherà, a questo punto, esprimere la voce
dell’ordinamento: soltanto al legislatore, come ha ritenuto il Tribunale di Roma, o se necessario anche al giudice?
È, a mio avviso, stupefacente come il Tribunale si sia arrestato a metà strada, non traendo le naturali conseguenze dalle proprie stesse premesse. Una volta infatti
che si riconosca - come fa giustamente il Tribunale - l’esistenza, a livello costituzionale, di un diritto fondamentale a rifiutare un trattamento medico indesiderato, non
si vede perché tale diritto dovrebbe risultare condizionato ad una legge ordinaria che ne assicuri la concreta
attuazione. La tutela di un diritto fondamentale, in un
ordinamento costituzionale, prescinde dalle determinazioni della maggioranza, e se necessario prevale su queste stesse determinazioni; e in ogni ordinamento costituzionale è compito della magistratura assicurare la tutela dei diritti fondamentali, anche in assenza di una
legge che si faccia carico di una tale tutela. Nel caso di
Nota:
(5) Cfr. Trib. Roma, Sez. I civ., ord.16 dicembre 2006, Welby c. Antea
Associazione Onlus e G.C., in www.cittadinolex.kataweb.it.
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 1/2007
9
EDITORIALE•DIRITTO PENALE
specie, il ricorrente aveva per l’appunto chiesto al giudice una pronuncia di accertamento della lesione in atto
del proprio diritto fondamentale; pronuncia dalla quale
non poteva che discendere l’ordine di cessare tale lesione,
rivolto ai medici che stanno proseguendo il trattamento di sostegno respiratorio nonostante il dissenso del paziente.
Certo, sarebbe auspicabile che il legislatore intervenisse
a disciplinare la materia, sancendo una volta per tutte il
principio della necessità del consenso informato del paziente per qualsiasi trattamento medico, salve eccezioni
puntualmente individuate. Ma, da un lato, non c’è da
farsi illusioni in proposito, giacché temi come questo
sono troppo ‘sensibili’ nell’attuale clima politico-culturali, sia per le forze di maggioranza che per quelle di opposizione. Dall’altro, l’intervento del legislatore - per
quanto auspicabile - non è affatto necessario, stante la
possibilità di derivare la soluzione del caso direttamente
dalle norme costituzionali; senza dimenticare, poi, che
un ipotetico intervento legislativo dovrebbe comunque
svolgersi entro i limiti fissati da quelle stesse norme costituzionali e dai principi che da esse discendono, pena
- è ovvio - l’illegittimità costituzionale della soluzione
che dovesse essere individuata.
Del resto, la strada di una soluzione giurisprudenziale al
dilemma posto da Piergiorgio Welby non avrebbe rappresentato una novità nel panorama internazionale: in
un po’ tutti gli ordinamenti ai quali mi sono sin qui riferito, sono state proprio le decisioni dei giudici a dare corpo ai principi fondamentali che oggi vengono assunti,
anche in Italia, quali cardini in questa delicata materia.
C
iò non è, purtroppo, avvenuto nel caso Welby;
di fronte al sostanziale non liquet pronunciato
dalla magistratura romana, un anestesista ha
preso l’iniziativa, e ha disconnesso il respiratore. Il che
obbliga ora il giurista (e il penalista in ispecie) ad occuparsi, come ricordavo all’inizio, dei profili concernenti le possibili conseguenze sanzionatorie del fatto, in
particolare con riguardo alla possibile responsabilità
per il delitto di omicidio del consenziente di cui all’art.
579 c.p.
Se si conviene con l’itinerario argomentativo sin qui
seguito, peraltro, l’idea di una possibile responsabilità
penale di quel medico appare immediatamente scontrarsi con il riconoscimento di un diritto fondamentale,
in capo al paziente, di rifiutare qualsiasi trattamento medico, anche quello necessario quoad vitam. Come potrebbe, in effetti, essere considerata delittuosa una condotta imposta dall’esigenza di rispettare un altrui diritto
fondamentale?
Ad ogni buon conto, ogni residuo dubbio si dipana ove
si tenga ferma la natura nella sostanza omissiva dell’interruzione del trattamento di sostegno respiratorio, secondo quanto poc’anzi argomentato. In base alla regola
generale codificata nel nostro ordinamento dall’art. 40
comma 2 c.p. (ma una regola identica esiste in ogni al-
10
DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 1/2007
tro ordinamento contemporaneo), una omissione in
tanto può essere penalmente rilevante in quanto contravvenga ad un dovere giuridico di azione; onde il problema diviene quello di stabilire se sussista nel caso
concreto, per il medico, un dovere di praticare e di proseguire il trattamento di sostegno vitale. La risposta
non può che suonare negativa, laddove il paziente rifiuti
tale trattamento, esercitando il proprio diritto fondamentale di cui agli artt. 13 e 32 comma 2 Cost.: e ciò in
quanto l’autodeterminazione del paziente, come la dottrina penalistica e la stessa giurisprudenza oggi ampiamente riconoscono, costituisce il limite insuperabile
della stessa posizione di garanzia del sanitario rispetto al
paziente. Il medico resterà in tal caso obbligato alla esecuzione di quei trattamenti utili e consentiti dal paziente, come per l’appunto le terapie palliative; ma non potrà più ritenersi penalmente responsabile per avere
omesso quei trattamenti che il paziente aveva legittimamente rifiutato.
A quanto emerge dai primi resoconti di stampa, nel caso di specie l’anestesista in questione aveva conosciuto
Piergiorgio Welby qualche giorno prima del fatto, ed
aveva da lui ricevuto l’incarico di sospendere la terapia
di sostegno respiratorio, previa somministrazione di una
idonea terapia sedativa. A quell’anestesista il paziente
aveva dunque conferito l’incarico di occuparsi della sua
salute, secondo le modalità liberamente concordate appunto - tra medico e paziente; e quell’anestesista era
così divenuto titolare di una posizione di garanzia nei
confronti di Welby, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
40 comma 2 c.p. Se tale ricostruzione dei fatti fosse
confermata, del tutto legittima apparirebbe allora la decisione dell’anestesista - in qualità di nuovo medico curante, scelto liberamente dal paziente - di limitarsi a
praticare quella sola terapia consentita dal paziente (la
somministrazione di sedativi), e di interrompere correlativamente la terapia di sostegno respiratorio in atto,
ormai rifiutata dal medesimo: ponendo così fine alla lesione del suo diritto fondamentale, che si era sino a
quel momento consumata.