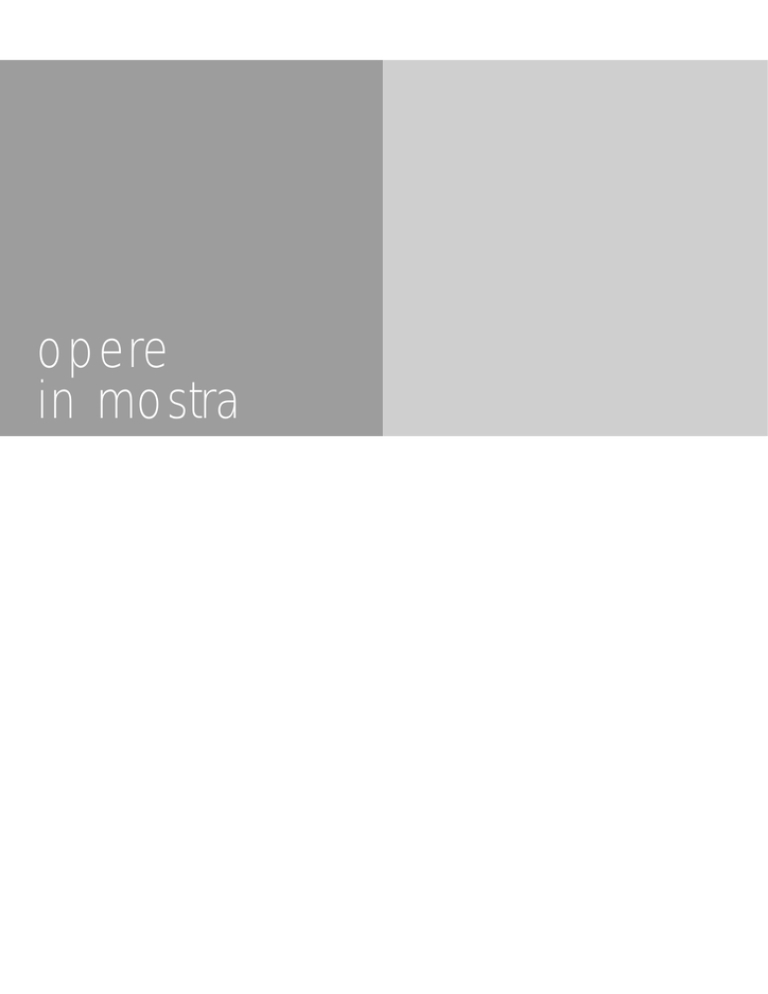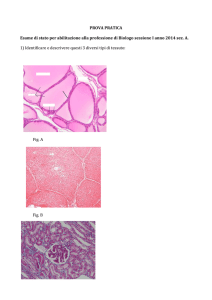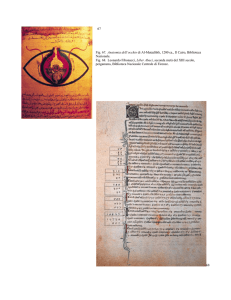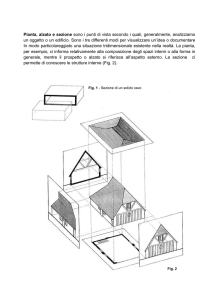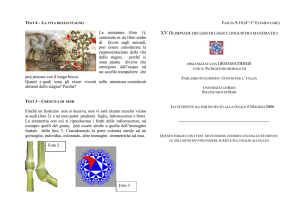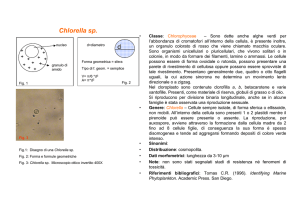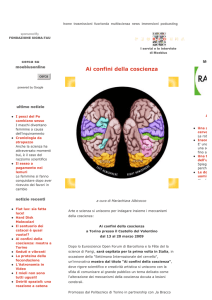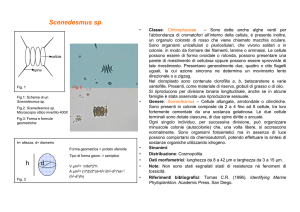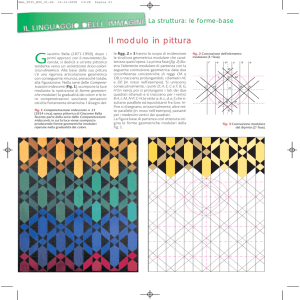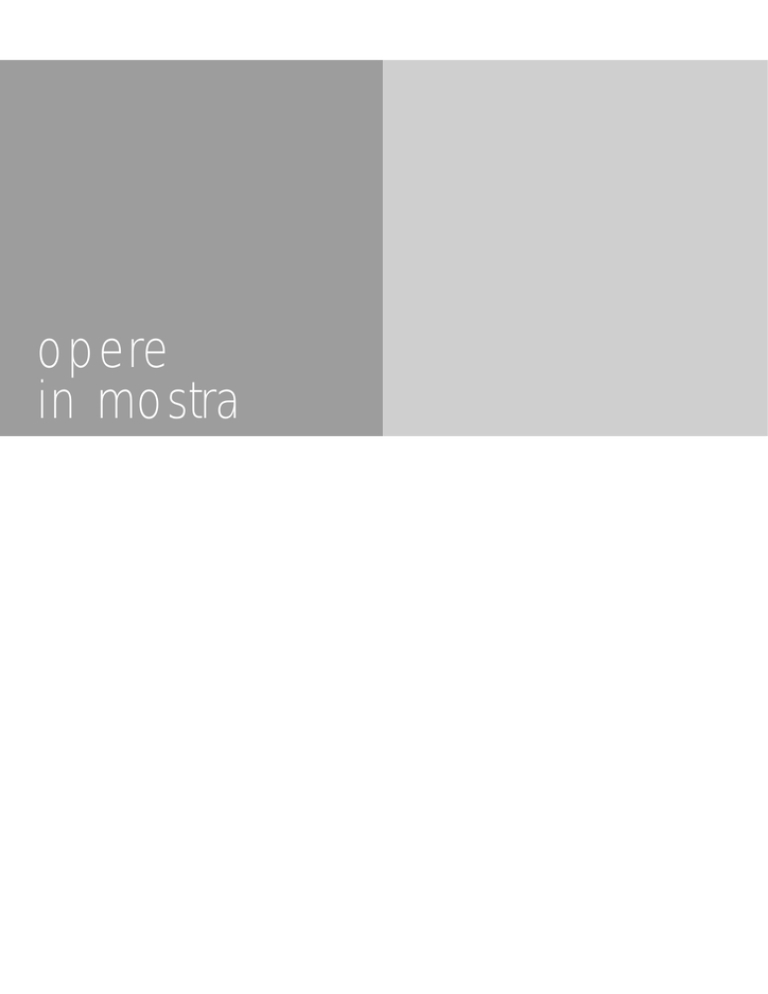
opere
in mostra
1
Sarcofago con Muse
Da Civita Castellana
Marmo
Alt. cm 52, lungh. cm 156,
largh. cm 56
Metà del II secolo d.C.
Civita Castellana, Museo
Archeologico Nazionale,
Forte Sangallo, inv. 59646
Sul campo principale sono le
nove Muse. È singolare che la
sesta figura da destra, femminile
nel corpo e nelle vesti, rechi volto e pettinatura da giovinetto,
da cui discende la congettura
che il defunto si sia lasciato effigiare sotto le spoglie di una Musa. L’opera è stata realizzata da
un artigiano locale, che ha prestato poca cura alla riproduzione dell’anatomia: difatti, se si
eccettua la settima Musa, tutte le
altre sono caratterizzate da corpi pesanti, mentre i rapporti tra
le loro varie parti sono approssimativi. Lo stretto legame che unisce Apollo alle nove dee fa sì
che in numerosi sarcofagi sulla
fronte esse appaiano insieme ad
Apollo musagete; nella fattispecie, egli, identificabile nel giovane nudo con plettro, occupa
invece il pannello di sinistra, cui
risponde sulla destra il grifo. Per
la datazione del sarcofago vengono in soccorso un esemplare
del Louvre di analogo soggetto,
riferito al 160 d.C., e un sesterzio di Antonino Pio del 140143 d.C., rinvenuto proprio al
suo interno.
2
Statua di Polymnia
Da Roma, area di Villa Fiorelli
sul lato prospiciente via Terni
Marmo pario
Alt. cm 156
Copia romana da un originale
della tarda età ellenistica
Ultimo quarto del II secolo d.C.
Roma, Musei Capitolini,
Centrale Montemartini,
inv. 2135
Raffigurata in atteggiamento sognante e pensoso, completamente avvolta nel mantello e appoggiata a uno sperone roccioso, la giovane Musa reggeva un
rotolo di versi, simbolo dell’arte
da lei rappresentata. Si tratta di
una splendida interpretazione
romana ispirata al gruppo di
Muse disegnate da Philiskos di
Rodi nel II secolo a.C. quali parti integranti di un unico complesso scultoreo, come rivela nella
replica la presenza di un punto
di vista privilegiato. La politura
originaria dell’opera è perfettamente conservata perché la statua venne nascosta in antico in
un cunicolo sotterraneo. Considerata l’assoluta qualità artistica
e la cura dei particolari che sembrano conservare la freschezza
dell’originale, la scultura doveva
far parte di un ciclo decorativo
di una importante residenza imperiale, da situare in una zona
non molto lontana dall’area del
rinvenimento, che per fasto doveva gareggiare con i palazzi
del Palatino.
228
3
Statua di Calliope
Dalla collezione Cesi (?),
poi collezione Boncompagni
Ludovisi
Marmo greco, probabilmente
pentelico
Alt. cm 119
Età adrianea
Roma, Museo Nazionale
Romano, Palazzo Altemps,
inv. 8580
La Musa siede su una roccia; veste un chitone a mezze maniche
cinto sotto i seni e un ampio mantello panneggiato sulle gambe.
La testa e gli avambracci sono di
restauro; gli attributi dello stilo e
della tavoletta, pur moderni, sono comunque compatibili con il
personaggio, riconoscibile come
Calliope, patrona della poesia
229
epica. Di provenienza ignota,
corrisponde però a un tipo ben
attestato nei cicli di Muse provenienti da grandi ville del II secolo d.C., e potrebbe pertanto la
statua in esame essere stata parte di un ciclo simile.
4
Busto di Omero
Da Roma, Esquilino
Marmo bianco
Alt. totale cm 71
Sono di restauro naso, busto
e piede
Copia romana da un originale
ellenistico del II secolo a.C.
Roma, Musei Capitolini
- Palazzo Nuovo, Sala
dei Filosofi, inv. 557;
già collezione Albani
Questo tipo di ritratto è conosciuto in due repliche: questa capitolina e una al British Museum.
La caratteristica del tipo in esame è la particolare astrattezza
degli occhi, asimmetrici, intorno
ai quali la superficie sembra ribassata. La barba incornicia il
volto, ma è rasata immediata-
mente al di sotto del labbro inferiore, mentre i baffi, folti, coprono i solchi ai lati delle labbra fino a congiungersi con i peli della barba. Questo contribuisce a
rendere ancora più astratta l’espressione. Il capo è incorniciato da capelli resi a fitte incisioni,
molto radi all’altezza delle tempie e scompartiti da una benda
che scende fino al collo.
5
Affresco con Achille e Briseide
Da Pompei, Casa del Poeta
Tragico (R. VI, 8, 5)
Intonaco dipinto
Alt. cm 127, largh. cm 122
Integro, eccetto la parte
superiore sinistra, con lacuna
integrata
IV stile; epoca flavia
(50-79 d.C.)
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 9105
L’affresco rappresenta uno dei
più celebri episodi dell’Iliade:
Briseide dal capo velato è allontanata da Achille, seduto davanti alla sua tenda, per essere
condotta, contro la volontà sua
e dell’amato eroe, da Agamennone. A separare, o idealmente
ancora a congiungere, i due è
Patroclo, visto di spalle, mentre
da dietro il seggio osserva la
scena Fenice, l’anziano consigliere del Pelide, che col suo gesto fa trasparire la preoccupazione per l’“ira funesta” che ne
seguirà. Intorno stanno i Mirmidoni, armati ma impotenti, e il
messaggero identificato dal caduceo. Nello sguardo fisso, che
si staglia dal lucido scudo, e nel
gesto plateale di Achille sta il
dramma dei due amanti, rappresentato come in un atto di tragedia in un originale della pittura greca del tardo classicismo,
forse un quadro del ciclo dipinto
da Theon di Samo, esposto a
Roma nel portico di Filippo e ripreso nella domus pompeiana.
6
Testa di Esiodo (?)
(cosiddetto Pseudo-Seneca)
Da Stabiae (Castellammare)
Marmo
Alt. cm 22
La parte inferiore del collo
è incurvata per l’inserimento
in un’erma
Età antonina
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 150196
La testa trasmette un archetipo
del medio ellenismo (230-160
a.C.), che, per il suo realismo
quasi da figura di genere, rompe con le norme dell’estetica
classica e che viene riprodotto
in numerose repliche, tra cui brilla quella, in bronzo, dalla Villa
dei Papiri. Il tipo fu identificato
con Seneca, ma la scoperta nel
1813 di un ritratto del filosofo,
accompagnato da iscrizione e
dotato di caratteri fisionomici
del tutto diversi, sfatò tale arbitraria identificazione. Per la presenza di una corona d’edera,
premio degli agoni teatrali, in
una copia ora al Museo delle
Terme, e per l’abbinamento del
tipo con Menandro, in una doppia erma di Villa Albani, si distingue il riconoscimento con il
commediografo Aristofane (V secolo a.C.), vissuto molto tempo
prima della realizzazione dell’originale, allora eventualmente
da intendersi come ritratto di ricostruzione. Altra suggestiva interpretazione ha invece puntato
sul nome di Esiodo, di fatto immaginato nella tradizione ellenistico-romana quale ascreus senex (Virgilio, Ecl., 6, 70).
230
7
Erma di Virgilio (?)
Da Roma, area presso
il Mausoleo di Augusto (1937)
Marmo lunense
Alt. cm 48
I secolo d.C.
Roma, Musei Capitolini,
Centrale Montemartini,
inv. 2410
La resa infossata degli occhi nelle sporgenti arcate sopraccigliari, il volto scavato e segnato da
profonde rughe, come il collo, e
le labbra sottili quasi serrate permettono di collocare l’erma nella tradizione ritrattistica tardorepubblicana, come anche la geometrizzazione della testa appena segnata da rade ciocche. La
trattazione delle superfici è però
più fredda e manieristica tanto
231
da suggerire una datazione in
età augustea che, confortata dal
contesto di provenienza, ha permesso di formulare la suggestiva
identificazione con il poeta Virgilio.
8
Vaso calatoide
con Saffo e Alceo
Da Agrigento
Ceramica attica a figure rosse
Alt. cm 53, diam. max. cm 38
Pittore di Brygos
470-460 a.C.
Monaco di Baviera, Staatliche
Antikensammlungen, inv. 2416
Il vaso, dalla particolarissima forma, presenta una scena chiaramente identificata dalle iscrizioni
che qualificano le due figure rappresentate come Saffo e Alceo,
pur non offrendocene il ritratto. Il
poeta di Mitilene è raffigurato di
profilo, avvolto nell’himation, con
i capelli cinti da una sottile fascia
e il volto barbato concentrato nell’esecuzione musicale: con le dita
della sinistra a pizzicare le corde
e il plettro nella destra, Alceo accompagna con le note del barbiton il canto, reso attraverso l’indicazione di piccoli cerchietti vicino
alla bocca del poeta, che rivolge
a Saffo in piedi davanti a lui. La
poetessa di Lesbo, rappresentata
di tre quarti, con i lunghi capelli
sciolti sulle spalle cinti da un diadema, indossa un himation bordato di nero sopra un sottile chitone fittamente pieghettato e decorato a puntini; stringe nella destra il plettro mentre tiene con la sinistra il barbiton che sembra aver
appena smesso di suonare. Saffo
è colta nell’attimo di volgersi indietro verso Alceo quasi sorpresa
nel suo incedere dalle parole che
nel canto sembra rivolgerle il poeta che le rese omaggio in un celebre verso definendola “cinta di
viole, pura, riso di miele”.
9
Statua di Euterpe
Dalla collezione Farnese
Marmo grechetto
Alt. cm 168
Età imperiale
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6398
L’identificazione con la Musa Euterpe è fatta sulla base del doppio flauto che la figura stante
stringe con la mano destra. Tuttavia, poiché gli avambracci sono di restauro (integrazioni Albacini), l’identificazione non è
certa; anche la testa probabilmente antica è rilavorata. Ruesch sostiene che poteva trattarsi
di una statua di imperatrice in
costume sacerdotale, ispirata a
un originale greco di IV secolo
di scuola prassitelica.
10
Lekythos ariballica
con supplizio di Marsia
Da Armento
Ceramica attica a figure rosse
a rilievo
Alt. cm 36
400-375 a.C.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 81396
La scena illustra la punizione del
Sileno Marsia, colpevole di aver
sfidato Apollo. Al centro è una
palma a cui è legato Marsia in
procinto di essere scuoiato dallo
Scita alla sua sinistra, mentre a
destra, in costume di citaredo, assiste all’imminente supplizio Apollo verso il quale vola una Nike a
sottolineare la vittoria del dio nella competizione musicale. A destra una Musa seduta è intenta a
suonare una grande kithara; davanti a lei sono un’altra Musa,
rappresentata di spalle, e un giovane nudo che si appoggia a un
pilastro con aria afflitta. Nel registro superiore due Muse, una seduta e l’altra in piedi, assistono alla scena. A sinistra del gruppo
centrale, una Musa, appoggiata
a un pilastro e con nella destra il
doppio aulos suonato da Marsia,
sembra dialogare con un giovane
afflitto in piedi davanti a lei, mentre un’altra Musa, seduta su una
roccia e rappresentata di spalle,
si volge verso il Sileno e altre tre
Muse, una seduta e le altre in piedi, assistono al supplizio. Questa
lekythos è significativa perché offre una delle poche rappresentazioni in cui le dee compaiono, secondo l’indicazione di Esiodo, in
numero di nove.
232
11
Cista con gara tra Apollo
e Marsia
Da Preneste
Bronzo
Alt. cm 54, diam. cm 26,5
Terzo quarto del IV secolo a.C.
Roma, Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia,
inv. 13135; già collezione
Barberini
Sul corpo della cista, entro un
fregio fitomorfo, si svolge, in una
scena perfettamente centrata,
uno dei rari esempi di tale modalità narrativa in simile classe
di materiale, la rappresentazione della contesa tra Marsia e
Apollo, ambientata nel santuario
del dio. Al centro troneggia proprio Apollo, il quale assiste all’esibizione di Marsia che suona
233
i flauti. Dietro a lui osservano la
scena Artemide armata e una figura femminile seduta su una
roccia e con specchio (Afrodite).
Seguono una giovane donna
senza attributi, verosimilmente
identificabile con una Musa, e
un giovinetto. Dietro al Sileno sono rappresentati una figura femminile seduta su un seggio (Latona), seguita da un fanciullo con
lungo bastone (Olimpo?); infine,
vengono una giovane donna
ammantata appoggiata a un pilastrino, anch’essa interpretabile
come Musa, e una figura maschile barbata, seduta su una
roccia (Zeus).
Il manico presenta due slanciate
figure alate e nude di Geni; i
piedi sono nella forma di tre
zampe feline.
12
Ritratto di Pindaro
Provenienza sconosciuta
Marmo
Alt. totale cm 53
Copia romana da un originale
della metà del V secolo a.C.
circa
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6144
Il ritratto rappresenta il poeta lirico Pindaro (518-438 a.C.) quale anziano col volto scavato dalle rughe; nella stilizzazione arcaizzante della barba è stato individuato un tratto denotante l’associazione con cerchie aristocratiche conservative e improntate a
vita lussuosa. Esso costituisce la
copia da un originale, del quale
sfuggono i termini cronologici
precisi: vengono messe in cam-
po sia l’epoca dello stile severo
sia quella alto-classica intorno alla metà del V secolo a.C., laddove nella critica più recente si è
data preferenza alla seconda
opzione con l’ausilio della forma
e del movimento delle ciocche
della chioma, contenente gli ingredienti stilistici più progrediti rispetto al viso che ritroviamo nelle teste sul fregio del Partenone e
su coeve stele funerarie. Già da
tempo sono state poi notate le
analogie fisionomiche del ritratto
con la testa del Centauro D del
frontone occidentale del tempio
di Zeus a Olimpia, specialmente
nella contrazione del sopracciglio, nella fattispecie segno di intensa attività spirituale.
13
Erma cosiddetta di Solone
Dalla collezione Farnese
Marmo
Alt. cm 53
Sono di restauro orecchio
destro, naso, collo ed erma
Copia romana da un originale
della fine del II secolo a.C.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6143
Del ritratto, arbitrariamente battezzato nel passato col nome di
Solone, esiste un’ulteriore copia
a Roma (Musei Capitolini - Palazzo Nuovo, Sala dei Filosofi,
inv. 573). Contrariamente alla
proposta invalsa nella critica più
remota di collocazione nel IV
secolo a.C., la datazione dell’originale intorno al 100 a.C. si
giustifica in base alle analogie
nella riproduzione dell’incarnato
con una testa bronzea di Delo,
mentre per l’impianto dell’acconciatura si raccomanda un parallelo con il ritratto di Carneade,
ed è stata ravvisata una consonanza, più vaga, anche con il
cosiddetto Gladiatore Borghese.
14
Busto di Pitagora
Dalla collezione Albani,
già Giustiniani
Marmo greco
Alt. totale cm 49,3
Sono di restauro naso e parte
superiore dell’erma
Copia romana da un originale
del II-I secolo a.C.
Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala
dei Filosofi, inv. 594
L’erma è il ritratto di un uomo in
età matura, con il volto incorniciato da una barba resa a fitte
incisioni, fluente all’altezza del
mento, lunga fino al petto e appuntita. I baffi ricoprono quasi
completamente il labbro superiore, mentre quello inferiore è carnoso e pronunciato. Gli occhi,
lievemente infossati, e il solco
sulla fronte rendono evidente
che si tratta della rappresentazione di un “pensatore”. Un turbante avvolge e circonda la
sommità della testa. L’immagine
è comunemente attribuita a Pitagora, filosofo e matematico, nato a Samo nella prima metà del
VI secolo a.C., fondatore di un
movimento con fini etici e religiosi. Intorno alla sua figura si
formò un mito ed egli fu venerato anche per la capacità di predire il futuro. Il turbante è considerato un riferimento ai viaggi
del filosofo in Oriente.
234
15
Ritratto di Socrate
Dalla collezione Albani,
già Cesi
Marmo greco
Alt. totale cm 54,8
Sono di restauro naso, guancia
sinistra, parte del labbro
superiore e parte della barba
e dei capelli
Copia romana da un originale
greco della seconda metà
del IV secolo a.C.
Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala
dei Filosofi, inv. 508
Il ritratto è quello di un uomo anziano, dal volto pieno, con la
fronte solcata da due rughe parallele. Il naso è piccolo e schiacciato, quasi camuso. Gli zigomi
sono sporgenti e il volto è rico-
235
perto da una folta barba che si
divide in due grandi ciocche
che, incontrandosi sul mento, formano un motivo a spina di pesce. I capelli, resi con morbidezza, lasciano scoperta gran parte
della fronte per l’incipiente calvizie. È questa, senza dubbio,
l’immagine attribuita a Socrate,
nota in una serie di copie presenti nelle maggiori collezioni
pubbliche e private. L’archetipo
si riferisce usualmente allo scultore greco Lisippo che scolpì l’originale fra il 340 e 330 a.C.
16
Rilievo con Socrate e Diotima
Da Pompei
Bronzo
Alt. cm 15
I secolo a.C.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, s.n.i.
Il rilievo bronzeo, proveniente
da Pompei, decorava un cofanetto. L’iconografia era diffusa
ed è attestata anche in alcune
placchette fittili. Essa è da attribuire a un artista ellenistico che
voleva raffigurare l’incontro tra
Socrate e Diotima. La donna è
seduta su uno sgabello e ricorda
nella posa instabile delle gambe
il modello della celebre Tyche di
Antiochia; di fronte a lei Socrate, avvolto nel mantello e caratterizzato dal consueto volto “si-
lenico”, resta in piedi in una posizione di riposo, appoggiandosi al bastone impugnato nella
destra e tenendo la sinistra sull’anca (probabilmente l’artista riprende nel corpo il tipo statuario
creato per Socrate poco dopo
la sua morte, intorno al 380
a.C.). Tra i due si trova una figura nuda di un Eros alato, con
in mano una cassetta, da cui
Diotima prende qualcosa. Se ne
è dedotto che l’iconografia intendeva illustrare, attingendo
ecletticamente a modelli di epoche diverse, l’introduzione di Socrate ai segreti dell’amore da
parte di Diotima.
17
Riunione di filosofi
Da Pompei, Villa di T. Siminius
Stephanus
Mosaico
Alt. cm 86, largh. cm 85
I secolo a.C.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 124545
All’interno di una bella cornice
formata da foglie, frutti e maschere comiche si riconosce un
emblema eseguito con tessere
molto fini. La scena è ambientata in uno spazio sacro, indicato
dalla colonna votiva, situato all’aperto (l’albero), al quale si accedeva dal portale sormontato
dai vasi. All’interno sono rappresentati sette intellettuali (significativamente come i Sette Sapienti), riconoscibili dal costu-
me: i loro atteggiamenti spaziano da quello del filosofo seduto,
concentrato nell’attività del pensare (il terzo da destra), a quello
dello scienziato impegnato in
una dimostrazione (il terzo da sinistra che indica con un radius
la sphaera celeste), a quello dell’oratore stante in procinto di
parlare (il primo da destra). I primi due da sinistra conversano invece tra loro. Per l’identificazione del soggetto sarebbe decisivo il riconoscimento dell’altura in
alto a destra, in cui si è voluta riconoscere l’Acropoli di Atene.
Se così fosse la scena potrebbe
raffigurare una riunione dell’Accademia platonica.
18
Statua di letterato (Isocrate?)
Da Ercolano, grande peristilio
della Villa dei Papiri
Marmo bianco
Alt. col plinto antico cm 181
Sono di restauro braccio destro
e avambraccio sinistro con
la parte superiore del bastone
Copia romana da un originale
greco della fine del IV inizio del III secolo a.C.
Età augustea
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6126
niente dal medesimo contesto, è
stata proposta un’identificazione
con l’oratore Isocrate. Lo confermerebbe la veneranda età lodata dalle fonti e la sua qualità di
retore lontano dall’esercizio forense, confermata dall’atteggiamento fiero ma pacato che traspare dalla statua. La testa tuttavia è una replica moderna del tipo noto come Omero-Sofocle.
I papiri legati in un fascio presso
i piedi connotano come letterato
il personaggio anziano, ma ancor vigoroso e saldo, che indossa chitone, himation e calza
sandali. Vista la sua vicinanza
con la statua di Eschine prove-
236
19
Erma-ritratto di Epicuro
Da Roma, piazza Santa Maria
Maggiore, 1742
(dono di Benedetto XIV)
Marmo
Alt. totale cm 55
Sono di restauro naso,
orecchie, frammenti della barba
ed erma
Copia romana da un originale
greco della metà
del III secolo a.C.
Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala
dei Filosofi, inv. 522
Questo ritratto identifica il filosofo Epicuro, riconosciuto in una
serie di raffigurazioni che presentano tutte la caratteristica di
un volto particolarmente scarno
e allungato con la fronte solcata
237
da numerose rughe e con un’espressione particolarmente accigliata. Nel ritratto capitolino le
gote sono molto scarne e il volto
è per la gran parte incorniciato
da barba e baffi molto folti con
ciocche ondulate e arricciate fino al mento a dare l’immagine
di una certa trascuratezza. Le
ciocche dei capelli sono rese
con incisioni profonde e presentano un piccolo cercine sulla
sommità del capo.
20
Erma-ritratto di Antistene
Da Tivoli, Villa Adriana
Marmo
Alt. cm 64
I-II secolo d.C.
Città del Vaticano, Musei
Vaticani, Galleria delle Carte
Geografiche, inv. 2888
Antistene era stato discepolo di
Socrate e alla sua figura guardavano come a un modello sia i
cinici sia gli stoici. In età ellenistica fu quindi elaborato un suo
ritratto retrospettivo, testimoniato
dall’erma di età imperiale e
identificato con certezza grazie
all’iscrizione in un altro esemplare conservato nella Sala delle
Muse, sempre ai Musei Vaticani. La datazione ellenistica del tipo, opera del grande scultore Fi-
romaco, attivo a Pergamo nel II
secolo a.C., deriva dall’eclettismo della composizione, che
riunisce l’impostazione tardoclassica del volto e in particolare della barba curata al patetismo visibile nella massa dei capelli spettinati e nell’inarcarsi
delle sopracciglia. Attraverso
questi espedienti Firomaco voleva dunque comunicare la rispettabilità e la serietà del maestro
di filosofia (la barba), l’energia
del pensatore (la fronte mossa) e
anche la sua natura di polemista
pugnace, ben esemplificata invece dal sollevarsi della capigliatura, quasi selvaggia come
quella di un essere semiferino.
L’enfasi data alla fatica del pensiero ha consentito di attribuire il
ritratto a una committenza stoica
e non cinica.
21
Statua seduta di Ermarco
Marmo
Alt. col plinto cm 107,
lungh. cm 50, prof. cm 80
I-II secolo d.C.
Firenze, Villa Corsini,
inv. 70989-92250
La statua è una copia in piccolo
formato derivante da un originale raffigurante il filosofo epicureo
Ermarco, probabilmente eretto
poco dopo la sua morte, intorno
al 250 a.C. Ermarco, che veste
un ampio mantello e calza le
krepides, è rappresentato come
un uomo anziano e severo, con
barba e capelli ben curati, mentre, seduto, è impegnato in una
lezione, segnalata dal braccio
destro alzato e dal volto sollevato e girato verso un immaginario
interlocutore. La forma sofisticata
del seggio attesta il ruolo ormai
assunto dalla “cattedra” nell’immagine del saggio e in particolare del “maestro”. L’immagine
di Ermarco corrisponde a quella
degli altri maggiori filosofi epicurei, che amavano visualizzare
il conseguimento della pace interiore, cardine dell’epicureismo, mediante la cura del corpo
e degli abiti, la tranquillità e la
rilassatezza delle pose compassate. L’ideale proposto è classico, come mostrano le pettinature
e il tipo statuario.
22
Statua di filosofo cinico
Da Lanuvio, cosiddetta
Villa di Antonino Pio
Marmo greco
Alt. cm 171
La mano destra è stata
integrata con il volumen
al posto dell’originario bastone
Seconda metà del II secolo d.C.
Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala
del Gladiatore, inv. 737
La statua è una copia in ottimo
stato di conservazione del potente ritratto di un filosofo cinico
della metà del III secolo a.C. L’adesione alla scuola cinica è resa evidente dalla trascuratezza
generale dell’uomo, che porta,
arrotolato disordinatamente, un
mantello troppo corto e fatto con
un tessuto grossolano. Inoltre
barba e capelli sono trasandati
e arruffati, il volto è rugoso, il
ventre è prominente e il filosofo
è rappresentato a piedi nudi.
L’immagine di un cinico doveva
essere provocatoria e coerente
con l’atteggiamento di sfida verso la società fatto proprio da
questi filosofi, evidentemente
condiviso dal committente della
statua. Da ciò deriva l’impressione quasi di insolenza che il
vecchio filosofo dà guardando
negli occhi l’interlocutore, facendo credere di star bene nonostante la sua vita fuori dagli
schemi. L’immagine del filosofo
si allontana così da quella del
buon cittadino, come da quella
del pensatore di tradizione epicurea e stoica.
238
23
Busto di Posidonio
Dalla collezione Farnese
Marmo
Alt. cm 44
Sono di restauro orecchie
e punta del naso
Età augustea
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6142
Il ritratto dello storico Posidonio
di Apamea è noto solamente
grazie a questo busto, con il nome iscritto sul petto, databile in
età augustea, di qualità eccezionale, derivante da una statua
stante eseguita intorno al 70
a.C. Dalla presenza di chitone
e mantello nel busto si può dedurre che anche l’originale li
portasse. Nel ritratto di Posidonio, presentato come un uomo
239
avanti con gli anni (nel 70 a.C.
aveva circa sessantacinque anni), i capelli aderiscono alla calotta cranica, seguendo nella stilizzazione delle ciocche modelli
classici, probabilmente policletei, alcune rughe attraversano la
fronte mentre la barba, molto curata, è appena accennata. L’immagine di Posidonio, caratterizzata dall’atteggiamento calmo e
sicuro, è ormai lontana da quella dei fondatori della scuola stoica; le manca infatti la fatica del
pensare, sostituita dal classicismo dell’impostazione, coerente
con il programma culturale dello
storico, che si proponeva di trasmettere la cultura greca a Roma. Ormai solo la barba ricorda la sua condizione di filosofo.
24
Busto di Cicerone
Dalla collezione Albani,
già Barberini
Marmo bianco
Alt. totale cm 95
Sono di restauro busto e piede
I secolo a.C. - I secolo d.C.
Roma, Musei Capitolini Palazzo Nuovo, Sala
dei Filosofi, inv. 589
Il ritratto raffigura un uomo di
mezza età, dal volto tondo caratterizzato dalla fronte alta solcata da rughe profonde. Il naso
è aquilino, lungo e pronunciato;
gli occhi piccoli e distanti, il labbro inferiore pronunciato. Evidente è il rigonfiamento del collo
a segnare il “doppio mento”. I
capelli sono resi a ciocche poco
rilevate e rade, soprattutto all’al-
tezza delle tempie, a enfatizzare
la fronte larga e spaziosa. Il volto è ruotato verso sinistra ed è inserito su un busto di restauro non
pertinente. Il ritratto fa parte di
una serie, probabilmente postuma, che fissa l’immagine dell’oratore in un cliché iconografico
teso a evidenziarne l’aspetto volitivo e autoritario. La datazione
del ritratto non è riferibile necessariamente all’età repubblicana,
ma potrebbe anche essere relativa al periodo augusteo.
25
Affresco con cosiddetta Saffo
Da Pompei (R. VI, insula occ.)
Intonaco dipinto
Alt. cm 31, largh. cm 31
55-79 d.C.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 9084
Una delle testimonianze più significative dell’espressione della
cultura romana in ambito domestico è rappresentata da dipinti
e pavimenti musivi delle domus
pompeiane, che offrono quasi
un catalogo delle possibilità di
esibire la propria ambizione intellettuale offerte ai proprietari,
che mettono in scena se stessi
facendosi ritrarre come intellettuali, rivolti allo spettatore, sulle
pareti delle loro residenze. È il
caso del pregevole affresco – la-
voro di un pittore particolarmente abile che ha saputo dare
un’impronta personale a un soggetto di repertorio – raffigurante
una donna mentre compone,
con lo stilo leziosamente appoggiato sulle labbra in atteggiamento meditativo e il dittico
aperto nella sinistra. Il ritratto ne
mostra la condizione di giovane
donna distinta, con indosso gli
orecchini e una preziosa reticella aurea per contenere i capelli.
La poesia, come lo scrivere – attività quest’ultima che nel mondo
romano era quasi del tutto preclusa alle donne –, è per lei un
diletto del tempo libero.
26
Frammento di affresco
con attore e la sua maschera
Da Pompei
Intonaco dipinto
Alt. cm 45, largh. cm 33
IV stile
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 9036
Il frammento proviene da Pompei, ma non si conosce la pertinenza specifica. Vi compare in
primo piano un uomo con tracce
di barba sul volto, vestito di
manto bianco, in atteggiamento
pensoso con braccio destro piegato al gomito e mano che tocca il mento; sta seduto e guarda
di fronte a lui un secondo uomo
stante che regge con entrambe
le mani una maschera tragica.
Lo stato lacunoso della parte si-
nistra non permette di avere certezza sulla rappresentazione; tuttavia, la presenza della maschera ha permesso di riconoscere
nella pittura una raffigurazione
di carattere teatrale, presumibilmente la preparazione di un attore a uno spettacolo. Il soggetto trova confronto con l’affresco
dell’Attore Re da Ercolano (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9019) e con il mosaico con gli attori dalla Casa
del Poeta tragico (VI 8, 3-5) di
Pompei (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9986).
La pittura, di buona fattura, può
ascriversi al cosiddetto IV stile.
240
27
Rilievo ellenistico con poeta
e Musa
Da Roma, area intorno
al Colosseo (1896)
Marmo pentelico
Alt. cm 40, largh. cm. 38
III secolo a.C.
Roma, Musei Capitolini,
Centrale Montemartini,
inv. 1409
Il rilievo raffigura una Musa che
solleva lo sguardo verso un vecchio poeta: la posa è quella di
una giovane allieva ammirata
che si volge verso il suo maestro. La scena riassume la concezione del lavoro intellettuale
dell’età ellenistica che pone in
primo piano la figura del pensatore e la sua energia creativa,
che rivolge il suo canto alle Mu-
241
se. Il rapporto tra Muse e poeta
è ribaltato rispetto all’età classica quando ogni sapere era un
dono divino e non il frutto del lavoro di un grande intellettuale.
La finezza dell’opera e la delicata sensibilità nella trattazione dei
panneggi riconducono a un originale greco del III secolo a.C.
28
Testa di Musa di Philiskos
Da Roma, tempio di Apollo
Sosiano (1937)
Marmo pario
Alt. cm 26
Prima metà del II secolo a.C.
Roma, Musei Capitolini,
Centrale Montemartini,
inv. 3279
La testa rivela una qualità artistica di rilevante importanza ancora leggibile nonostante una evidente corrosione della superficie
marmorea. Si tratta probabilmente di un originale greco nel
quale si apprezza una vivacità e
un’armoniosa composizione dell’insieme ben lontane dalla fredda rifinitura dei particolari che
caratterizza le copie romane. La
struttura geometricamente com-
patta, i lineamenti delicati e quasi indefiniti, armoniosamente fusi
tra loro, e la trattazione pittorica
tendente allo sfumato delle superfici sono notazioni stilistiche
che riportano a un ambiente di
cultura rodia collocabile nella
prima metà del II secolo a.C. È
molto probabile che si tratti del
frammento superstite di una delle Muse del ciclo di Philiskos di
Rodi che decoravano la cella
del tempio di Apollo Sosiano.
Potrebbe trattarsi della Musa
con piccola cetra nota da una
statuetta romana proveniente
dalla Casa di Ottavio Quartione
a Pompei.
29
Gruppo scultoreo “frontonale”
Da Luni, Tempio Grande
Terracotta con ingobbio avorio
Alt. max. conservata cm 122,
largh. max. conservata cm 165
Ricomposto da cinque grandi
frammenti
Dopo il 177 a.C.
Firenze, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 7122471227, 72747
È una delle opere più significative della coroplastica tardorepubblicana il gruppo ad altorilievo, originariamente policromo, che decorava la testata del
columen centrale del tetto del
tempio (della tipologia arcaica
a frontone “aperto”) di Luna, divinità, identificata con Diana,
eponima della colonia di Luni
dedotta nel 177 a.C. da Marco
Emilio Lepido. La dea, riccamente vestita, è infatti raffigurata
assisa su un trono: alla sua destra è Apollo seminudo riconoscibile dalla cetra; alla sua sinistra, con speculare ponderazione, è un personaggio di più discussa interpretazione: il Genius
Coloniae o il Genius Populi Romani, Dioniso-Liber cui ben si
addice la cornucopia traboccante di grappoli, o Honos, la
cui presenza sarebbe giustificabile in chiave ideologica. Ai lati
della triade divina stanno due
statue di Muse che rivelano sicure affinità con quanto conosciamo della serie creata da Philiskos per il tempio di Apollo Medico a Roma, simbolo della propaganda di Lepido.
30
Rilievo con scena di scuola
filosofica
Da Ostia, ambiente presso
il tempio di Ercole (I, XV)
Marmo tasio
Alt. cm 50, largh. cm 51,
spess. cm 6-12
IV secolo d.C.
Ostia, Museo Ostiense,
inv. 130
La lastra è inquadrata da una
cornice con modanatura liscia.
La scena è ambientata all’interno
di una stanza, chiusa sul fondo
da una tenda con frange. Al centro della rappresentazione campeggia un personaggio maschile
stante su un piccolo podio, con
la testa leggermente rivolta alla
sua destra; la mano destra è alzata nel gesto dell’adlocutio,
mentre nella sinistra tiene un rotulus. Accanto a lui, in posizione
simmetrica, due personaggi maschili, entrambi seduti dietro un
banco, sono raffigurati nell’atto
di scrivere su tavolette con uno
stilo. Sullo sfondo due gruppi di
personaggi che, con atteggiamenti diversi, partecipano alla
scena dimostrando il proprio
coinvolgimento con il gesticolare
delle mani. Il rilievo è stato variamente interpretato: come scena
di ammaestramento cristiano e,
da ultimo, come scena di scuola
filosofica. Con quest’ultima ipotesi concorda anche il più recente
riconoscimento del personaggio
centrale come oratore o insegnante. Il confronto con numerosi
sarcofagi tardoantichi con filosofi
consente di datare il rilievo
ostiense nel pieno IV secolo.
242
31
Sarcofago cosiddetto
“dei Fratelli”
Marmo
Alt. cm 130, largh. cm 270
260 d.C. circa
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6603
Sul sarcofago il defunto, probabilmente un senatore romano,
identificato dalla ripetizione dello stesso ritratto, compare quattro volte consecutivamente, con
abiti diversi e impegnato in attività differenti, ciascuna scelta
per il suo significato simbolico.
Da sinistra: l’apice della carriera
pubblica, mediante la toga “ufficiale” contabulata; la vita contemplativa tramite il mantello da
filosofo sul torso nudo; la devozione, mediante la toga “repub-
243
blicana” e la presenza di un piccolo assistente al sacrificio al
suo fianco; il culmine della vita
privata, ossia il matrimonio, mediante la dextrarum iunctio con
la moglie e la toga panneggiata come nella prima età imperiale. La diversificazione del costume consente di presentare un
catalogo delle virtù tipiche di un
uomo di ceto elevato. Gallerie
analoghe di immagini che ritraevano più volte la stessa persona,
diversificando adeguatamente i
tipi statuari, sono attestate anche
nelle fonti letterarie.
32
Lastra con conversazione
filosofica fra coniugi in viaggio
Dal Museo Kircheriano
Marmo bianco a grana fine
Alt. cm 35, largh. cm 92
280 d.C. circa
Roma, Museo Nazionale
Romano, Terme di Diocleziano,
inv. 8942
Nella lastra, che potrebbe essere pertinente a un sarcofago di
grandi dimensioni, è raffigurato
il viaggio di due coniugi proprietari terrieri intenti in una conversazione filosofica durante il
tragitto dalla città alla loro tenuta di campagna. Si tratta di un
viaggio simbolico verso un mondo spirituale. Non sono più dunque solo alcuni neoplatonici a
voler fuggire i disordini della so-
cietà per concentrarsi maggiormente sulla vita interiore, sulla
pace dell’anima e sulla ricerca
di Dio: questo habitus mentale si
diffonde tra il III e il IV secolo
d.C. anche fra i ceti abbienti,
come rivela una serie di immagini, soprattutto sarcofagi, dove
la lettura e la discussione cominciano già sul carro, strada facendo. La datazione proposta
procede da un impaginato che
è affollato di personaggi, compresi in uno spazio ristretto che
limita la loro resa stilistica affidata non tanto all’attenta costruzione dei personaggi medesimi
nei loro rapporti modulari, quanto alla facoltà di renderli in sintesi, accentrando l’attenzione sugli elementi accessori e sull’ambientazione della scena.
33
Statua di Urania
Dalla collezione Cesi,
poi collezione Boncompagni
Ludovisi
Marmo greco a grana fine
Alt. cm 124
Età adrianea
Roma, Museo Nazionale
Romano, Palazzo Altemps,
inv. 8579
La statua, in origine un tipo di
Calliope o di Clio, è stata restaurata radicalmente per rappresentare Urania, Musa dell’astronomia: moderni infatti oltre alla testa e al busto da sotto i seni,
sono le braccia con le mani che
reggono lo stilo e il globo. È affine a sculture appartenenti ai
grandi cicli delle ville di età
adrianea e antonina.
34
Statua di Clio
Provenienza sconosciuta
Marmo
Alt. cm 91
II secolo d.C. (?)
Roma, Museo Nazionale
Romano, Terme di Diocleziano,
inv. 2001.750
viene datato al più tardi nella
prima metà del II secolo d.C.,
marca il limite temporale inferiore; e quale ulteriore indizio a tal
fine si è impiegato anche il frammento fittile dal frontone di Luni.
Il torso mutilo riproduce il tipo
della Clio della Glyptothek di
Monaco di Baviera, pur senza
fornire alcun indizio a riguardo
della presenza o meno di attributi; se le superfici abrase non
consentono una datazione troppo precisa, ne è stato comunque
messo in campo un inquadramento in epoca traianea. Per l’origine dell’archetipo della Clio,
un rilievo da Smirne ora a Leida,
che ne trasmette una ripresa e
244
35
Kylix con Apollo e Clio
Da Spina, Valle Trebba,
tomba 128
Ceramica attica a figure rosse
Alt. cm 13,6, diam. cm 30,5,
diam. con anse cm 38,5,
diam. piede cm 11,75
Pittore di Eretria
435-430 a.C.
Ferrara, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 3035
La kylix, ricomposta da ventinove frammenti, presenta nel tondo
interno, dalla superficie piuttosto
rovinata, Apollo e Clio, entrambi identificati dalle iscrizioni.
Apollo, in piedi, è raffigurato di
profilo come un giovane imberbe dai lunghi capelli, cinti da
una corona di alloro, che gli ricadono in fluenti riccioli sulle
245
spalle; avvolto nell’himation che
gli lascia scoperto il petto, il dio
tocca con la sinistra le corde di
una grande lyra mentre offre con
la destra protesa una phiale alla
Musa in piedi davanti a lui.
Clio, rappresentata con il corpo
di prospetto e la testa di profilo,
indossa un pesante peplo e ha i
capelli raccolti sulla nuca cinti
da una sphendone riccamente
decorata. Essa si volge verso il
dio mentre, tenendo nella sinistra una phiale e nella destra
una oinochoe, si accinge a
compiere una libagione. L’intenso scambio di sguardi tra le due
figure ne rivela l’intimo e profondo legame conferendo un’atmosfera di solenne armonia alla
scena dall’esecuzione estremamente accurata.
36
Kylix con Clio che incorona
Mousaios
Da Spina, Valle Pega,
tomba 293A
Ceramica attica a figure rosse
Alt. cm 11,9, diam. cm 29,
diam. piede cm 11,7
Pittore di Calliope
425-420 a.C.
Ferrara, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6631
Nel tondo interno di questa coppa ricomposta da numerosi frammenti è raffigurato, avvolto nell’himation, un giovane dai corti e
riccioluti capelli che l’iscrizione
sopra la testa identifica come
Mousaios, il mitico poeta, figlio
o discepolo di Orfeo, sepolto
secondo la tradizione sulla collina del Mouseion di fronte all’A-
cropoli di Atene. Il giovane, che
ha appena concluso la sua esecuzione musicale, tiene con la
destra la lyra mentre si volge a ricevere la corona che la donna in
piedi davanti a lui gli porge. È
Clio, come indica l’iscrizione,
che, vestita di un sottile chitone e
con i capelli raccolti sulla nuca
cinti da una tenia a più giri, si
appresta a dare a Mousaios il riconoscimento della sua investitura poetica. La scena costituisce
un modello per le raffigurazioni
anonime di coronamento in un
contesto musicale. Clio è infatti
la Musa che, per il suo nome,
esprime in modo esemplare la
gloria e l’immortalità donata ai
poeti dalle nove dee, mentre
Mousaios è il poeta per eccellenza che non a caso trae il suo
nome dalle Muse stesse.
37
Erma doppia di Erodoto
e Tucidide
Dalla collezione Farnese
Marmo
Alt. cm 58
Sono di restauro naso (Erodoto)
e punta del naso (Tucidide)
Iscrizioni con i nomi (scorretti)
sui due lati dell’erma
Età antonina
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6239
Il ritratto di Tucidide (460/455
circa - 400 a.C.) risale forse a
un originale esposto sull’Acropoli
di Atene, approntato, a giudicare dal lessico formale, intorno al
370-360 a.C., dunque a circa
quarant’anni di distanza dalla
morte dello storico; il ritratto somiglia nella fisionomia alle teste
su coeve stele funerarie attiche.
Quello di Erodoto (484-424
a.C.) ha invece sollevato maggiori dubbi: infatti, se talora ne è
stata asserita l’appartenenza alla
prima metà del IV secolo a.C.,
dunque in età più o meno coeva
al Tucidide, lo si è anche considerato, ma, con ogni verosimiglianza, a torto, prodotto classicistico, soprattutto per il motivo a
larga tenaglia della chioma sulla
fronte, che ha spronato al confronto con il ritratto di Omero nel
tipo Modena, per il quale si ripresentano i medesimi dubbi.
Statue di Erodoto si trovavano a
Costantinopoli, Alicarnasso e
nella biblioteca di Pergamo.
38
Statua di Melpomene
Da Roma, scavo per
le fondamenta della Villa
Di Giura in via Aventina (1933)
Marmo greco a patina scura
Alt. cm 160, alt. col plinto
cm 169
I secolo a.C.
Roma, Museo Nazionale
Romano, Palazzo Massimo
alle Terme, inv. 114896
se repliche: viene convenzionalmente definita Melpomene Farnese, da una replica della collezione Farnese oggi a Napoli.
Sulla base di tali confronti si può
ipotizzare che tenesse nella mano sinistra una maschera tragica, tipico attributo della Musa
della tragedia.
La bella statua, raffigurante un
personaggio femminile stante,
vestito di ampia tunica senza
maniche e di mantello che le copre parzialmente la chioma,
manca purtroppo delle braccia
con gli attributi. La stessa immagine è però riconoscibile già su
una base tardoellenistica da Alicarnasso, ed è nota da numero-
246
39
Erma-ritratto di Eschilo
Da Ercolano, Villa dei Papiri
Marmo
Alt. cm 57
È di restauro il naso
Età augustea
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6139
L’erma-ritratto è identificata con
Eschilo perché alcune copie sono state trovate associate a sicuri ritratti di Sofocle. È probabile
che il tipo derivi dall’originale
facente parte del gruppo raffigurante i tre poeti tragici e dedicato da Licurgo nel teatro di Dioniso nel 330 a.C., come sembrerebbe confermato anche dalla
forte affinità stilistica con il Sofocle dei Musei Vaticani. Eschilo vi
appariva rappresentato come
247
molti cittadini del suo tempo,
senza indulgere particolarmente
sulla sua attività di poeta e intellettuale, in analogia con le immagini degli altri due poeti tragici. Poche rughe sulla fronte
contribuiscono a definire l’età
matura; la barba, abbastanza
lunga, è molto curata e solo i capelli un po’ arruffati. L’erma indica inoltre l’adozione del consueto costume del cittadino, con il
mantello indossato sul torace nudo, e fa pensare che l’originale
fosse una statua stante.
40
Cratere a volute con Oreste
e le Erinni
Da Ruvo di Puglia
Ceramica apula a figure rosse
sovraddipinta
Alt. con coperchio cm 77
Pittore della Black Fury
380-370 a.C.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 82270
Dalla raffinatissima decorazione
accessoria del vaso risalta con la
forza di un dipinto su tavola la
metopa in cui un ceramografo
apulo con grande efficacia rappresenta dinamicamente uno degli atti principali di un mito teatrale molto popolare in ambito
italiota: la saga di Oreste. Una
candida scenografia ionica spartisce lo spazio abitabile dell’a-
zione visibile, allestito con chiari
simboli apollinei: i tripodi, l’alloro. L’eroe ha trovato dunque
scampo a Delfi, dopo l’uccisione
della madre Clitemnestra: lo riconosciamo, nel santuario, avvinghiato all’omphalos e assistito
da Artemide come una statua su
un piedistallo insieme ai suoi cani, araldici nella loro posa divergente che pure nella bicromia
pare impossibile anticipazione
dell’affresco malatestiano di Piero della Francesca. A sinistra sta
Apollo. Con gesto perentorio
scaccia una delle Erinni che inseguono il mortale: orribile e vendicativa brandisce un serpente,
buia come il mondo degli Inferi
che eccezionalmente ha lasciato
per ristabilire l’ordine cosmico.
Lo scompiglio è però totale: la
vecchia Pizia fugge inorridita.
41
Erma di Euripide
Dalla collezione Farnese
Marmo
Alt. cm 51,4, largh. cm 51,7
Sono di restauro parte
del naso, ciocche di capelli
e tasselli sull’erma
I secolo d.C.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 6135
L’erma raffigura un ritratto di Euripide, come è indicato anche
nell’iscrizione, una testimonianza preziosa perché ha risolto il
problema dell’identificazione
del personaggio. È probabile
che la testa copi la statua eretta
da Licurgo nel 330 a.C. nel
gruppo raffigurante i tre maggiori poeti tragici nel teatro di
Dioniso ad Atene. Euripide è
rappresentato come un uomo
anziano, con i capelli lunghi, la
fronte calva e una barba molto
curata. Il corpo era coperto dal
solo mantello sul torso nudo. È
probabile che la statua ateniese
fosse seduta e raffigurasse il
poeta con un volumen nella sinistra. L’intento dell’artista era di
costruire l’immagine di un “bel
vecchio”, insistendo così sulla
sua età avanzata. Le sopracciglia leggermente aggrottate
danno al ritratto un’aria pensosa, tipica però di molte immagini di anziani nelle stele attiche
del tempo. Anche questa statua
si proponeva di raffigurare Euripide come un buon cittadino,
solo più anziano, e quindi meno
attivo, di Sofocle.
42
Cratere con Oreste e Ifigenia
in Tauride
Da Ruvo di Puglia, necropoli
in località Sant’Angelo
Ceramica apula a figure rosse
sovraddipinta
Alt. cm 62,6, diam. orlo cm 32
Pittore dell’Ilioupersis
350-325 a.C.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 82113
L’incontro di Oreste con la sorella in Tauride è sceneggiato su
due registri: i protagonisti sono
riconoscibili dai loro nomi iscritti
in bianco. In basso Pilade contempla l’amico Oreste seduto
sull’altare, col capo chino, mentre incedono verso di loro Ifigenia e un’offerente che regge una
phiale sulla testa. In alto, divisi
da un arbusto di lauro in fiore,
siedono i numi tutelari, pure loro
fratelli, Apollo e Artemide, davanti a un tempio ionico a battenti dischiusi. In due passi dell’Ifigenia in Tauride di Euripide
viene annunciato che la vera liberazione di Oreste dalla persecuzione delle Erinni (cfr. cat. 40)
sarebbe avvenuta solo quando
dalla lontana Tauride avrebbe ricondotto in patria la sorella Ifigenia, salvata dal sacrificio grazie ad Artemide, insieme al simulacro della dea: logica conclusione degli esordi drammatici
in Aulide. Quest’ultima tappa è
argomento della decorazione
del vaso che conferma l’interesse dei ceramografi italioti, e
dunque della loro gentilizia
clientela, per la dimensione familiare della tragedia di Oreste.
248
43
Affresco con Medea
Da Pompei, Casa dei Dioscuri
(R. VI, 9, 6)
Intonaco dipinto
Alt. cm 128, largh. cm 104
40-79 d.C.
IV stile
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 8977
L’affresco rappresenta una delle
scene cruciali della Medea di
Euripide. La protagonista, riccamente abbigliata, con la spada
tra le mani e l’espressione assorta, è ritratta nel momento in cui,
ancora incerta, nella casa di
Corinto, medita l’uccisione dei
figli avuti dal fedifrago Giasone.
I bambini giocano con aria malinconica, quasi presaga del destino di morte che li attende,
249
mentre un pedagogo, anch’egli
in trepida attesa, sta per varcare
la porta. Le linee compositive
concentrano l’attenzione dello
spettatore sullo sguardo dell’eroina, allucinato, come denuncia l’addensarsi, diremmo scopadeo, delle ombre sul volto.
Questa Medea è meno possente e scultorea, ma più completa
nella composizione e ricca di
colori dell’altra celebre replica
da Ercolano sempre al museo di
Napoli (inv. 8976): entrambe
derivano tuttavia probabilmente
da un celebre quadro di Timomaco di Bisanzio degli inizi del
III secolo a.C.
44
Statua di Sofocle
Da Terracina
Marmo
Alt. cm 218
Età augustea
Città del Vaticano, Musei
Vaticani, Museo Gregoriano
Profano, inv. 9973
Statua raffigurante il tragediografo Sofocle, probabilmente copiata da quella che Licurgo fece
erigere verso il 330 a.C. ad
Atene nel teatro di Dioniso all’interno di un gruppo comprendente anche le immagini di Eschilo e
di Euripide. Sofocle, con la barba curata, è rappresentato come
un buon cittadino, pronto a parlare nell’assemblea, e non come
poeta tragico (a questa attività
allude solo la capsa contenente
diversi volumina, ma si tratta di
un’aggiunta del copista). Egli appoggia il braccio sinistro con
tranquillità all’anca, mentre il destro è stretto nel mantello, che avvolge il corpo con molta cura.
Questo dettaglio è significativo
perché adotta uno schema tipico
dell’oratore classico, che non gesticolava, a differenza di quanto
avveniva nel IV secolo a.C. Licurgo volle quindi far rappresentare Sofocle come un cittadino
modello del passato ateniese,
impegnato nelle attività civiche;
anche il volto, assolutamente generico, trasmette lo stesso messaggio di omologazione nella
massa dei cittadini.
45
Statuetta di Sofocle
Provenienza sconosciuta
Argento
Alt. cm 10,4
I-II secolo d.C.
Ancona, Museo Archeologico
Nazionale delle Marche,
inv. 537
La statuetta rappresenta un personaggio barbato, stante sulla gamba destra e con la sinistra piegata
in avanti, avvolto fino al polpaccio nel mantello che lascia trasparire le forme piene del corpo. Il
volto, dal naso consunto, mostra
la fronte solcata da una leggera
depressione orizzontale, ed è dominato dai grandi occhi con spesse pliche palpebrali. I capelli, trattenuti da un cercine, scendono in
mosse fiammelle sulla fronte, men-
tre i baffi e la barba, che si arriccia in brevi ciocche, circondano
la piccola bocca serrata, dal labbro inferiore carnoso, che conferisce al viso un’espressione grave e
assorta. L’atteggiamento della figura, con il braccio destro piegato sul petto e la mano che spunta
dal mantello, e il braccio sinistro
interamente fasciato dall’indumento e appoggiato sul fianco, appare riprendere fedelmente la statua
del Sofocle Laterano (cat. 44).
Analoghi sono l’andamento delle
pieghe del mantello e la resa dei
lineamenti del volto, che riproducono il drammaturgo nel pieno
della maturità. Difficile ipotizzare
quale destinazione avesse questo
pregevole esemplare, di cui non
sono conservate tracce degli agganci originari a una base o quale applique di un oggetto.
46
Menandro e la sua Musa
Marmo
Alt. cm 42, largh. cm 56
I secolo a.C.
Città del Vaticano, Musei
Vaticani, Museo Gregoriano
Profano, inv. 9985
Il rilievo intende rappresentare l’ispirazione poetica del poeta comico Menandro, colto mentre è
intento a comporre, e lo fa rinnovando profondamente la immagine di lui, rispetto a come era stata tramandata dal primo ellenismo (293-292 a.C.), quando
era stata eretta ad Atene la celebre statua seduta opera dei figli
di Prassitele. Alla tunica e all’ampio mantello di quella statua si sostituisce nel rilievo un’immagine
sempre seduta, ma con il torso
nudo e il mantello panneggiato
intorno alle gambe, in modo da
costruire una rappresentazione
più nobile e dunque eroizzata di
Menandro (probabilmente era
questa la volontà dei committenti
romani del I secolo a.C.). Il poeta, seduto, tiene dunque nella sinistra una maschera comica e
guarda verso la Musa stante che
si trova sul lato opposto del rilievo. Tra i due altre maschere comiche si trovano su un bel tavolino. Maschere e Musa ispirano
dunque in egual modo il poeta.
250
47
Statua di attore mascherato
da Papposileno
Da Torre Astura, spiaggia
presso una villa romana (1957)
Marmo greco
Alt. cm 90,5
II secolo d.C.
Roma, Museo Nazionale
Romano, Palazzo Massimo
alle Terme, inv. 135769
Il personaggio, che nel dramma
satiresco si distingue per essere il
corifeo dei Satiri, indossa sulle
gambe una calzamaglia villosa
e sul corpo una tunica con maniche lunghe di lana piuttosto grezza e dal pelo riccio. La volontà
di sottolineare il fatto che la maschera, vicina a quella dei personaggi della “commedia nuova”, sia indossata da un attore si
251
palesa nell’apertura della bocca
che lascia intravedere labbra e
denti veri mentre dai fori degli
occhi traspare il movimento delle
pupille. Anche la gestualità – che
si coglie ugualmente, pur mancando le mani e parte delle
braccia –, il capo leggermente
sollevato e l’espressione del volto
denunciano l’intensa concentrazione del recitare.
La pertinenza a una villa romana si può giustificare con il valore ornamentale dell’immagine,
dovuto anche al suo legame con
i temi dionisiaci, particolarmente
cari all’arte decorativa romana,
ma anche con il richiamo al
mondo teatrale e a un genere in
voga a Roma (come attesta Orazio nell’Arte poetica) evidentemente ancora coltivato da qualche dotto amatore.
48
Anfora con Muse sull’Elicona
Ceramica attica a figure rosse
Alt. cm 33, diam. cm 15
Pittore del Nano
430 a.C.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 81478
Una Musa stante, rappresentata
di profilo verso destra, con i capelli sciolti che le ricadono sulle
spalle, è completamente avvolta
in un himation che lascia intravedere il sottile chitone ionico e
con la destra tiene per uno dei
bracci una lyra; di questa è visibile la parte posteriore della cassa di risonanza contraddistinta
dalle scaglie del carapace a indicare il guscio di tartaruga con
il quale originariamente veniva
fatta la lyra. La Musa offre lo
strumento a una compagna in attesa davanti a lei invitandola a
esibirsi nella musica e nel canto.
Questa, vestita con un chitone
fittamente pieghettato e un himation, ha i capelli raccolti in un
sakkos; il pittore ha cercato di
rappresentarla di tre quarti con
la sinistra sul fianco, il busto leggermente piegato in avanti con
il braccio destro sul ginocchio
corrispondente mentre poggia il
piede su una sporgenza rocciosa che, alludendo all’Elicona,
identifica indiscutibilmente le
due figure femminili come Muse.
49
Cratere a campana
con Apollo, Tersicore e Clio
Ceramica attica a figure rosse
Alt. cm 31, diam. max. cm 34
Pittore di Clio
440-430 a.C.
Berlino, Staatliche Museen,
Antikensammlungen,
inv. F 2401
Al centro una Musa, vestita con
un sottile chitone pieghettato e
con i fianchi avvolti in un himation, è seduta su una roccia; porta piccoli orecchini e una collana, e ha i capelli raccolti sulla
nuca, legati da una sottile tenia
a più giri, ornati da un diadema: l’iscrizione che corre sopra
la testa la identifica come Tersicore. La Musa pizzica con le dita della mano sinistra le corde di
una lyra e, in un atteggiamento
di assorta concentrazione, volge
la testa dal delicato profilo verso
Apollo, in piedi dietro di lei. Il
dio, avvolto nell’himation, con i
lunghi capelli sciolti sulle spalle
cinti da una corona e con nella
destra un ramo di alloro, ha assistito alla performance musicale
di Tersicore insieme a Clio, identificata dall’iscrizione, che abbigliata come la compagna fa un
gesto di approvazione. Da questo vaso, considerato il suo capolavoro per la dignità e la
compostezza delle figure, prende il nome il Pittore di Clio, ceramografo attivo ad Atene nel
terzo venticinquennio del V secolo a.C.
50
Lastra con suonatrice
di kythara danzante
Da Ancona, area Cardeto
Calcare
Alt. cm 174, largh. cm 100
I secolo a.C.
Ancona, Museo Archeologico
Nazionale delle Marche,
inv. 100
Sulla lastra leggermente convessa, delimitata superiormente da
un tralcio vegetale e ai lati da
due sottili lesene, incede verso sinistra, in un elegante passo di
danza, una figura femminile che
stringe sotto il braccio una cetra.
Forzature prospettiche si notano
nella resa della posizione di tre
quarti, nella capigliatura e soprattutto nel busto, dove il braccio sinistro e lo strumento sono
posti di profilo, mentre la spalla
destra è vista frontalmente. Una
certa raffinatezza esecutiva distingue invece le vesti, il cui leggero fluttuare e aderire alle gambe è reso con perizia, apprezzabile specialmente nel frastagliato incresparsi delle pieghe
del lungo apoptygma che spunta
dalla cetra, negli orli zigzaganti
del mantello disposto trasversalmente sul petto e nel cedevole incurvarsi del panneggio del peplo aperto a ventaglio tra le
gambe. Si tratta probabilmente
di un’opera attribuibile a una
bottega provinciale che si ispira,
non senza impaccio, a modelli
neoattici o pergameni. La provenienza da un’area sepolcrale induce a propendere per la pertinenza della lastra a un monumento funerario circolare.
252
51
Statuetta di Cristo docente
Da Civita Latina (?),
già collezione Sangiorgi
Marmo lunense (statua);
marmo greco (sedia)
Alt. cm 72
Mancano la punta del naso,
l’avambraccio destro, la metà
anteriore del piede destro,
l’indice sinistro
Restaurata nell’Ottocento
III secolo d.C. non avanzato
Roma, Museo Nazionale
Romano, Palazzo Massimo
alle Terme, inv. 61565
te capigliatura di tradizione
apollinea ed è rappresentato come un intellettuale, mentre accompagna con la destra sollevata la spiegazione del testo contenuto nel rotolo semiaperto, di
cui ha appena interrotto la lettura, tenendo però il segno con la
mano sinistra. La novità della trasmissione della dottrina cristiana
è dunque affidata a un’immagine usata tradizionalmente per un
docente. La qualità della resa si
estende a dettagli come il seggio
con zampe leonine.
La statuetta togata seduta, interpretata di norma come Cristo docente, è un notevole esempio di
classicismo teodosiano. Cristo vi
è caratterizzato come un “ragazzo prodigio” dalla lunga e fluen-
A p. 226
Erma-ritratto di Eschilo
(cat. 39).
A p. 254
Busto di Posidonio
(cat. 23).
253
Referenze fotografiche
Alte Pinakothek, Monaco
di Baviera: fig. 14
alle pp. 224 e 225
Antikenmuseum Basel
und Sammlung Ludwig, Basilea
(foto di Claire Niggli): fig. 6
a p. 44
Archivi Alinari, Firenze:
figg. 4-7 a p. 194
Archivio fotografico dei Musei
Capitolini (foto di Stefano
Castellani, Alessandra Ciniglio,
Araldo De Luca, Antonio Idini,
Roberto Lucignani, Barbara
Malter, Attilio Maranzano,
Studio Vasari): fig. a p. 8,
fig. 2 a p. 67, fig. 8 a p. 73,
fig. 10 a p. 75, fig. 1
a p. 92, fig. 1 a p. 98, fig. 6
a p. 104, figg. 14 e15
a p. 116, figg. 3 e 4
a p. 137, fig. 1 a p. 150,
fig. 1 a p. 162, fig. 14
a p. 187; cat. 2, 4, 7, 14,
15, 19, 22, 24, 27, 28
Archivio fotografico della
Soprintendenza Archeologica
di Roma (foto di Giorgio
Cargnel, Luigi Colasanti,
Romano D’Agostini, Luciano
Mandato): fig. 7 a p. 46,
figg. 12 e 13 a p. 54, fig. 3
a p. 68, fig. 5 a p. 103,
fig. 2 a p. 136, fig. 11
a p. 145, fig. 13 a p. 146,
fig. 15 a p. 148, fig. 5
a p. 159, figg. 2 e 3
a p. 165, fig. 5 a p. 167,
fig. 1 a p. 172, figg. 5 e 6
alle pp. 178 e 179, fig. 7
a p. 180, fig. 8 a p. 181,
figg. 9-11 alle pp. 182-184,
fig. 13 a p. 185; cat. 3, 3234, 38, 47, 51
Archivio fotografico
della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio Sezione Etruria Meridionale:
fig. 3 a p. 155; cat. 1, 11
Archivio fotografico
della Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Ostia antica:
cat. 30
Archivio fotografico
della Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Napoli
e Caserta - Napoli, Museo
Archeologico Nazionale:
cat. 48
Fotografica Foglia s.a.s.
di Alfredo e Pio Foglia, Napoli,
su concessione della
Soprintendenza Archeologica
di Pompei: fig. 1 a p. 78,
figg. 5-9 alle pp. 138-142
Photo RMN: fig. 2
alle pp. 152 e 153
(foto di Hervé Lewandowski D 00727809), fig. 4
a p. 157 (foto di Chuzeville D 00866372)
Archivio fotografico
della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana:
fig. 8 a p. 47, fig. 16
a p. 118, fig. 17 a p. 119,
figg. 18 e 19 a p. 120,
fig. 20 a p. 121; cat. 21, 29
Graphische Sammlung
Albertina, Vienna: figg. 14
e 15 a p. 198, figg. 19, 22
a p. 199
© Scala Group, Firenze: fig. 3
a p. 17, figg. 22 e 23 a p. 132,
figg. 8 e 9 a p. 195, figg. 2325 alle pp. 200 e 201
Hamburger Kunsthalle, Amburgo:
figg. 13, 16 e 17 a p. 198,
figg. 18, 20 e 21 a p. 199
Luigi Spina, Santa Maria
Capua Vetere: cat. 12
Archivio fotografico
della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia
e Romagna - Ferrara, Museo
Archeologico Nazionale:
fig. a p. 10, fig. 10 a p. 49;
cat. 35 e 36
Hessisches Landesmuseum,
Darmstadt: fig. 11 a p. 221
Archivio fotografico
della Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Marche Ancona, Museo Archeologico
Nazionale delle Marche:
cat. 45, 50
Archivio fotografico
della Soprintendenza Speciale
per il Polo Museale Veneziano Venezia, Museo Archeologico
Nazionale: fig. 13 a p. 115
Archivio Mondadori Electa,
su concessione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali:
fig. 12 a p. 197
Archivio Mondadori Electa:
fig. 26 alle pp. 202 e 203
(foto di Antonio Quattrone),
fig. 3 a p. 212, fig. 7
a p. 217, fig. 9 a p. 219
(foto di Laurent Lecat), fig. 13
a p. 223 (foto di Sergio Anelli)
Artothek, Weilheim: fig. 12
a p. 222 (foto Imagno)
Artothek, Weilheim: fig. 11
a p. 196 (foto di Joachim Blauel)
Biblioteca Apostolica Vaticana,
Città del Vaticano, fig. 2
a p. 192
Istituto Archeologico
Germanico, Roma: fig. 7
a p. 71, fig. 9 a p. 74
Kunsthistorisches Museum,
Vienna: fig. 2 a p. 211
Erich Lessing / Contrasto,
Milano: fig. 14 a p. 147, fig. 6
a p. 160, fig. 10 a p. 221
Massimo Listri / Corbis: fig. 1
a p. 134, fig. 10 a p. 144
Roberto Lucignani, Roma: fig. 6
a p. 167, fig. 7 a p. 169,
figg. 8 e 9 alle pp. 169 e 170
Musei e Gallerie Pontificie,
Città del Vaticano: fig. 5
a p. 69 (foto di M. Sarri), fig. 2
a p. 88 (foto di L. Giordano),
fig. 1 a p. 190, fig. 28
a p. 204, fig. 1 a p. 208;
cat. 20 (foto di A. Bracchetti),
44, 46
Museu Nacional Arqueològic,
Tarragona: fig. 12 a p. 146.
Luciano Pedicini, Archivio
dell’Arte, Napoli: fig. a p. 2,
fig. 2 a p. 15, fig. 6 alle pp. 26
e 27, fig. 7 a p. 29; fig. 8
a p. 30, fig. 9 a p. 32, fig. 14
a p. 55, fig. 15 a p. 57,
fig. 1 a p. 64, fig. 4 a p. 68,
fig. 6 a p. 70, fig. 12
a p. 185, fig. a p. 226,
fig. a p. 254; cat. 5, 6, 9,
10, 13, 16-18, 23, 25, 26,
37, 39-43
Staatliche Antikensammlungen
und Glyptothek, Monaco
di Baviera: fig. 4 a p. 19,
fig. 21 a p. 122; cat. 8
Staatliche Museen,
Antikensammlung - Bildarchiv
Preussischer Kulturbesitz,
Berlino: fig. 11 a p. 50;
cat. 49
Szépmüvészeti Múzeum,
Budapest: fig. 10 a p. 196,
fig. 29 alle pp. 206 e 207
The Bridgeman Art Library /
Lauros / Giraudon: fig. 1
a p. 12, fig. 4 a p. 214,
fig. 5 a p. 215, fig. 7
a p. 216
The Bridgeman Art Library:
fig. 5 alle pp. 20 e 21,
fig. 16 alle pp. 60 e 61
© Copyright the Trustees
of The British Museum: fig. 1
a p. 38, fig. 2 a p. 40, fig. 11
a p. 113, fig. 12 a p. 114