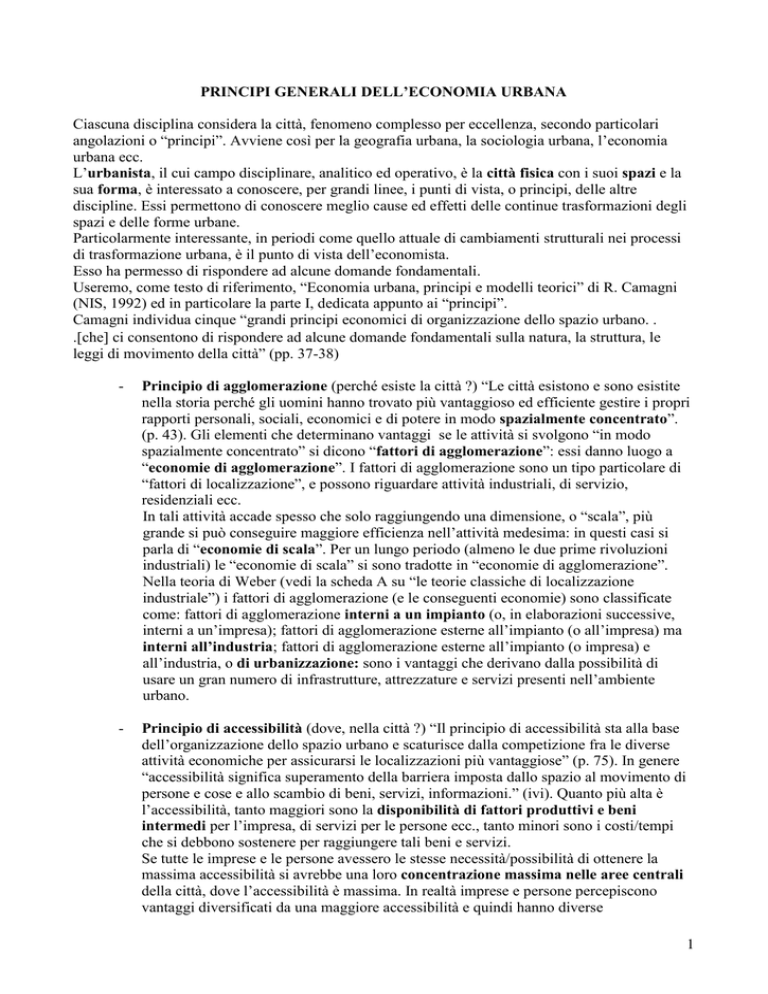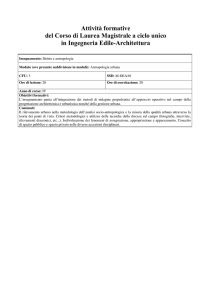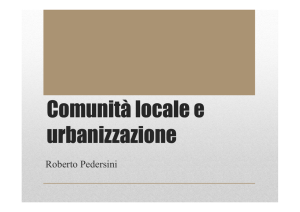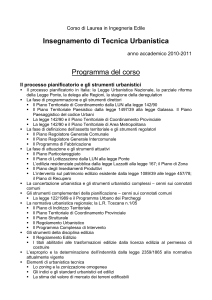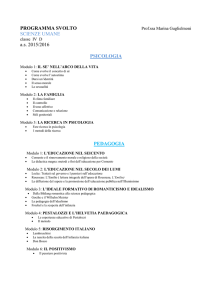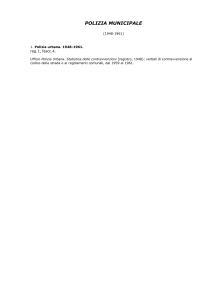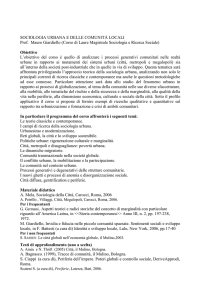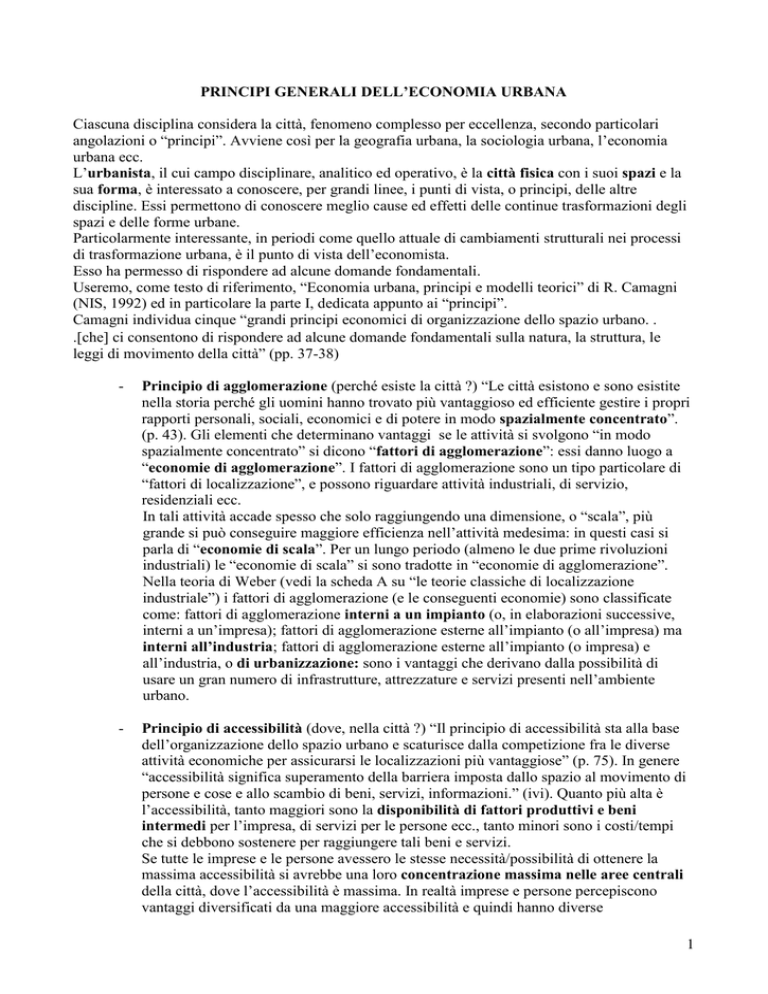
PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA URBANA
Ciascuna disciplina considera la città, fenomeno complesso per eccellenza, secondo particolari
angolazioni o “principi”. Avviene così per la geografia urbana, la sociologia urbana, l’economia
urbana ecc.
L’urbanista, il cui campo disciplinare, analitico ed operativo, è la città fisica con i suoi spazi e la
sua forma, è interessato a conoscere, per grandi linee, i punti di vista, o principi, delle altre
discipline. Essi permettono di conoscere meglio cause ed effetti delle continue trasformazioni degli
spazi e delle forme urbane.
Particolarmente interessante, in periodi come quello attuale di cambiamenti strutturali nei processi
di trasformazione urbana, è il punto di vista dell’economista.
Esso ha permesso di rispondere ad alcune domande fondamentali.
Useremo, come testo di riferimento, “Economia urbana, principi e modelli teorici” di R. Camagni
(NIS, 1992) ed in particolare la parte I, dedicata appunto ai “principi”.
Camagni individua cinque “grandi principi economici di organizzazione dello spazio urbano. .
.che ci consentono di rispondere ad alcune domande fondamentali sulla natura, la struttura, le
leggi di movimento della città” (pp. 37-38)
-
Principio di agglomerazione (perché esiste la città ?) “Le città esistono e sono esistite
nella storia perché gli uomini hanno trovato più vantaggioso ed efficiente gestire i propri
rapporti personali, sociali, economici e di potere in modo spazialmente concentrato”.
(p. 43). Gli elementi che determinano vantaggi se le attività si svolgono “in modo
spazialmente concentrato” si dicono “fattori di agglomerazione”: essi danno luogo a
“economie di agglomerazione”. I fattori di agglomerazione sono un tipo particolare di
“fattori di localizzazione”, e possono riguardare attività industriali, di servizio,
residenziali ecc.
In tali attività accade spesso che solo raggiungendo una dimensione, o “scala”, più
grande si può conseguire maggiore efficienza nell’attività medesima: in questi casi si
parla di “economie di scala”. Per un lungo periodo (almeno le due prime rivoluzioni
industriali) le “economie di scala” si sono tradotte in “economie di agglomerazione”.
Nella teoria di Weber (vedi la scheda A su “le teorie classiche di localizzazione
industriale”) i fattori di agglomerazione (e le conseguenti economie) sono classificate
come: fattori di agglomerazione interni a un impianto (o, in elaborazioni successive,
interni a un’impresa); fattori di agglomerazione esterne all’impianto (o all’impresa) ma
interni all’industria; fattori di agglomerazione esterne all’impianto (o impresa) e
all’industria, o di urbanizzazione: sono i vantaggi che derivano dalla possibilità di
usare un gran numero di infrastrutture, attrezzature e servizi presenti nell’ambiente
urbano.
-
Principio di accessibilità (dove, nella città ?) “Il principio di accessibilità sta alla base
dell’organizzazione dello spazio urbano e scaturisce dalla competizione fra le diverse
attività economiche per assicurarsi le localizzazioni più vantaggiose” (p. 75). In genere
“accessibilità significa superamento della barriera imposta dallo spazio al movimento di
persone e cose e allo scambio di beni, servizi, informazioni.” (ivi). Quanto più alta è
l’accessibilità, tanto maggiori sono la disponibilità di fattori produttivi e beni
intermedi per l’impresa, di servizi per le persone ecc., tanto minori sono i costi/tempi
che si debbono sostenere per raggiungere tali beni e servizi.
Se tutte le imprese e le persone avessero le stesse necessità/possibilità di ottenere la
massima accessibilità si avrebbe una loro concentrazione massima nelle aree centrali
della città, dove l’accessibilità è massima. In realtà imprese e persone percepiscono
vantaggi diversificati da una maggiore accessibilità e quindi hanno diverse
1
necessità/possibilità di pagare per ottenerla. Compare in tal modo la “rendita
differenziale” che è il prezzo della maggiore accessibilità di un’area, e che diviene - in
base alla competizione tra le diverse attività (imprese, persone ecc.) per assicurarsi i
vantaggi derivanti dalla maggiore accessibilità - un principio ordinatore della
distribuzione delle attività nello spazio urbano.
La prima analisi del “principio di accessibilità” si fa risalire a J. H. von Thunen (vedi la
scheda A su “le teorie classiche di localizzazione industriale”); importanti
approfondimenti sono stati svolti dalla “scuola di Chicago” ( anni Venti), che ha
interpretato la struttura sociale della città prima attraverso un modello a cerchi
concentrici (Park, Burgess e McKenzie), poi attraverso un più articolato modello a
settori (Hoyt); da Losch (40’s) e da Alonso (60’s) che hanno approfondito gli aspetti
generali del mercato dei suoli urbani e della localizzazione delle residenze e delle attività
produttive. Fenomeni anche recenti come la concentrazione centrale delle attività
direzionali (che sono attività a maggior valore aggiunto e quindi in grado di “pagare”
rendite differenziali più elevate) o il ritorno di ceti a reddito medio-alto nelle zone
centrali (gentrification) sono interpretabili alla luce del principio di accessibilità.
-
Principio di interazione spaziale (come, nella città ?) “Ogni attività localizzata nello
spazio fisico, sia essa una unità di produzione, una unità demografica o una città,
sviluppa con l’ambiente circostante una complessa rete di rapporti bidirezionali che si
svolgono su molteplici livelli” (p. 95). Dalle relazioni commerciali ai movimenti
pendolari, dallo scambio di informazioni e messaggi alle più diverse forme di
integrazione e collaborazione tra attività, persone, gruppi, la gamma e il numero di tali
“rapporti” sono quasi infiniti e costituiscono uno degli elementi primari della vita stessa
delle città.
“Questi rapporti sembrano organizzarsi sulla base di campi gravitazionali, sensibili alla
dimensione delle attività localizzate sul territorio e alla loro distanza relativa”. Una delle
teorie più fertili in proposito è quella “gravitazionale”, così detta in analogia al modello
newtoniano di gravitazione universale. L’idea che una serie di movimenti territoriali, da
quelli migratori a quelli per gli acquisti al dettaglio, sia direttamente proporzionale alla
“massa” dei centri di origine/destinazione, e inversamente alla reciproca distanza, si è
affermata tra la fine dell’800 e gli anni 30’s. Nel secondo dopoguerra, a partire dagli
studi di G.K. Zipf, si sono moltiplicate le applicazioni di modelli gravitazionali per
l’interpretazione di molti fenomeni: gli spostamenti di viaggiatori in corriera o in treno,
le chiamate telefoniche tra coppie di città, l’area di diffusione dei quotidiani ecc. In
genere il tipo di formula adottata è stato:
Tab K Pa Pb ab
In cui T misura l’intensità della interazione tra le unità territoriali a e b;
K è una costante che viene stimata in termini econometrici;
P è la popolazione, in genere assunta come espressione della massa delle unità
territoriali;
e sono in genere ipotizzati uguali a 1:
può essere uguale a 1 o 2
è la distanza fra le due unità territoriali
-
Principio di gerarchia (quali città e dove?) “L’osservazione della realtà empirica . . . ci
mostra . . . non solo la coesistenza di diverse dimensioni urbane, ma anche come a queste
2
-
ultime corrispondano funzioni economiche differenti, e come esistano distanze
geografiche differenti tra città di diversa dimensione” (pp.117-118). In altri termini si
tratta di spiegare come si distribuiscono nel territorio i diversi tipi di centri urbani, se vi è
relazione tra tale distribuzione e la loro dimensione e tra questa e i diversi tipi di attività
che in essi si svolgono. In genere avviene che i centri più piccoli ospitano attività il cui
raggio di influenza, o di mercato, e le cui economie di scala sono minori.
Intorno a queste domande si è formato, a partire dagli anni 30’s un corpo di analisi e
interpretazioni definito “teoria delle località centrali” (central places theory).
In particolare W. Christaller, analizzando la distribuzione dei centri urbani e le loro
attività nella Germania meridionale alla fine degli anni 20’s, individua una gerarchia di
7 livelli dimensionali (rango) di centri (1°=borgo; 2°=grande borgo; 3°=città di
circondario; 4°=città di distretto; 5°=città di prefettura; 6°=città di provincia;
7°=capoluogo di regione) e costruisce un modello interpretativo della loro distribuzione
territoriale, della dimensione delle loro aree di mercato e del tipo di attività che essi
svolgono. Il modello è basato sui seguenti principi:
ogni centro produce il tipo di beni, o di servizi, relativo al proprio rango e tutti i beni o
servizi dei livelli inferiori;
per ogni centro esiste un determinato numero di centri di rango inferiore, fino a giungere
al centro più piccolo (il borgo) di cui esiste il numero più elevato.
Nel modello, percorrendo la gerarchia da un livello a quello inferiore, il numero dei
centri, e delle rispettive aree di mercato, si moltiplica per 3. Il modello si articola poi in
base ad altri tre principi, definiti come il principio di mercato (che ottimizza la
localizzazione dei centri in relazione alle rispettive aree di mercato); il principio del
trasporto (che ottimizza l’uso delle reti esistenti); il principio amministrativo (in base al
quale l’area di mercato di ogni livello di centri deve essere interna all’area del centro di
livello superiore).
Definito il modello con una elegante formulazione geometrica, il risultato del confronto
con la realtà empirica, in termini di numerosità dei centri è il seguente:
livello dimensionale (rango)
numero teorico di centri
numero osservato di centri
7°
1
1
6°
2
2
5°
6
10
4°
18
23
3°
54
60
2°
162
105
1°
486
462
Il risultato empirico, assai significativo, sarà ulteriormente migliorato pochi anni dopo,
da A. Losch, che affina il modello e lo applica ad alcune regioni degli USA.
3
Il principio di gerarchia, e la sua più importante traduzione teorica (central places
theory) sono stati assai fertili di applicazioni per circa mezzo secolo, fino, ad esempio,
alla redazione del celebre “Atlante SOMEA”, che ha descritto il sistema urbano italiano
secondo un criterio di gerarchia dimensionale dei centri e di natura dei tipi di servizi in
4
essi presenti. Negli anni più recenti alcune indagini hanno messo in evidenza il ridursi,
soprattutto nelle regioni a sviluppo più maturo, delle relazioni territoriali di natura
gerarchica, e il comparire di relazioni piuttosto interpretabili secondo modelli di tipo
“reticolare” (vedi Camagni pp136-141; vedi Dematteis cit. in Scheda B, “La transizione
nei processi di urbanizzazione: aspetti generali”).
-
Principio di competitività (come si sviluppano le città? ) “Da molto tempo si è
riconosciuta la necessità di distinguere in modo semplificato, all’interno delle funzioni
che si svolgono nella città, fra quelle che si rivolgono ad una domanda esterna e quelle
che, al contrario si rivolgono a soddisfare i bisogni della popolazione residente. Le prime
funzioni di base. . .plasmano le caratteristiche specifiche della città, la sua
specializzazione e il suo ruolo nella divisione spaziale del lavoro; le seconde funzioni
non di base . . .permettono il sostentamento della popolazione urbana impiegata nelle
prime”. (p. 147)
La città, considerata secondo questo principio, è paragonabile ad una grande macchina
per produrre, che entra in competizione con altre macchine (altre città) per collocare
sui grandi mercati aperti i propri prodotti: Il reddito che così si genera serve ad importare
ciò che occorre per il sostentamento della popolazione residente. E’ perciò evidente che
le attività “di base” sono quelle che configurano il profilo economico-funzionale della
città (city-funding), mentre le altre sono “di riempimento” (city-filling).
Perché una città prosperi, deve raggiungere livelli significativi di competitività esterna,
che possono essere conseguiti utilizzando la propria dimensione per ottenere particolari
economie di agglomerazione; valorizzando le “vocazioni produttive” che possono
derivare dalla sua storia più o meno recente; integrando in specifiche filiere produttive
attività industriali e relativi servizi, e così via. Si parla spesso dei vantaggi competitivi
di una città, o area metropolitana, rispetto ad altre, per indicare i fattori che le
permettono di produrre beni e/o servizi che si impongono nella competizione rispetto a
quelli prodotti da altre città o aree metropolitane
5
LA TEORIA DELLA BASE ECONOMICA
In base al principio di competitività tra città si è sviluppato, a partire dagli anni ’30 negli USA e poi
in Europa, un “corpus” analitico e teorico detto “teoria della base economica” urbana. Le prime,
pionieristiche formulazioni ed applicazioni della teoria avvennero nell’ambito degli studi
preliminari per il celebre master plan di New York and it’s environs, del 1931, e nell’ambito delle
elaborazioni di politiche abitative federali, articolate su base urbana,. Il problema di fronte al quale
si trovavano H. Hoyt ed altri economisti urbani ed urbanisti alla fine degli anni ’20, era quello di
trovare un metodo di stima del prevedibile sviluppo della città, della sua occupazione e della sua
popolazione, per poter stabilire quindi gli obiettivi per la realizzazione di nuove residenze, di nuovi
servizi, infrastrutture ed attrezzature urbane. Il metodo si sarebbe dovuto fondare su una forte
relazione tra dinamiche economiche nazionali e dinamiche locali: il clima sociale e culturale era
dominato dagli effetti della Grande Crisi del ’29 e dalle politiche keynesiane.
Il metodo elaborato, assai chiaro e di facile applicazione, partiva dalla distinzione della
occupazione urbana totale in occupazione di base e (quella nei settori che producono per la
domanda esterna) occupazione non-di-base, o di servizio (quella nei settori che producono per la
domanda interna alla città). Assumeva poi che le attività di base, generando una domanda di servizi
non-di-base per sé e per le forze di lavoro impiegate, dessero luogo ad un moltiplicatore della
occupazione urbana. Una volta definiti
- il valore del moltiplicatore (attraverso valutazioni empiriche econometriche), assunto
stabile nel tempo
- la previsione macro-economica degli andamenti dei settori “di base”
è possibile ottenere una previsione della occupazione urbana totale. Applicando a tale occupazione i
tassi di attività rilevabili, si ottiene facilmente anche la previsione della popolazione urbana.
Il metodo, dopo alcune applicazioni ai temi per affrontare i quali era nato, è stato progressivamente
superato da procedimenti più sofisticati, quali le tavole “input/output” di Leontiev, o, più tardi, il
metodo dello “shift-share”. Sono poi emerse alcune difficoltà concettuali (Camagni pp. 161 sgg)
che hanno messo in discussione il valore “previsivo “ del metodo della base economica urbana. In
particolare si è verificato che in molti casi l’offerta locale urbana presenta strozzature che non le
permettono di rispondere con elasticità alla domanda crescente espressa dalle attività di base; che i
moltiplicatori di occupazione possono variare in modo significativo (in conseguenza di innovazioni
tecnologiche, di cambiamenti nella organizzazione del lavoro ecc.); che le dinamiche economiche
sovra-locali possono dar luogo, in modo anche drammaticamente rapido, a cambiamenti nella base
economica urbana (si pensi, nella fase iniziale della terza rivoluzione industriale, alla crisi delle città
“monofunzionali” quali le città dell’automobile, le città dell’acciaio ecc.).
Dunque il valore “previsivo” della teoria è apparso piuttosto debole. Significativo, viceversa, è
stato, il contributo che la teoria della base economica ha dato ad approcci più comprensivi per
lo studio delle funzioni urbane, ed assai utili e diffusi si sono rivelati alcuni semplici procedimenti
di calcolo elaborati a questo scopo. In particolare i Quozienti di Localizzazione (QL) sono stati
utilizzati spesso per analizzare le specializzazioni delle città (o delle regioni). Negli ultimi 10-15
anni si sono rivelati uno strumento appropriato per lo studio non previsivo ma analitico ex-post
delle trasformazioni nelle basi economiche urbane e metropolitane.
La formula di calcolo dei QL, che rappresenta un semplice “rapporto di rapporti”, è la seguente:
6
dove X è una variabile disaggregata settorialmente e territorialmente (in genere si usa l’occupazione
rilevata dai censimenti); i indica il settore di attività; c l’unità territoriale che si prende in esame
(quartiere o città o area metropolitana, o regione); n indica l’area di riferimento (in genere la
nazione se si analizzano città o aree metropolitane o regioni; la città se si analizza un quartiere).
I Quozienti permettono di confrontare la quota di ogni settore di attività sul totale delle attività
urbane con la stessa quota nell’area di riferimento: allorché il rapporto supera l’unità si considera la
porzione eccedente come “espressiva di un surplus netto rispetto alle esigenze della domanda
locale, e quindi di esportazioni nette” (p.160). Quanto più il quoziente di un settore supera l’unità,
tanto più alta è la “specializzazione” della città in quelle attività.
Una analisi delle trasformazioni delle basi economiche delle città centrali e delle aree urbane
italiane fondata sull’uso dei QL è in D. Cecchini e G. Goffredo, “Dinamiche delle funzioni urbane
e Mezzogiorno”, 1990 (v. punto 1.4 del Programma)
IL MODELLO DEL “CICLO DI VITA URBANO”
Il modello noto come «degli stadi di sviluppo» o del «ciclo di vita urbano», è stato formulato alla
fine degli anni '70 negli USA per spiegare l'arresto della crescita demografica e manifatturiera delle
grandi aree urbane. Nella sua prima formulazione 1[1] un gran numero di evidenze empiriche relative
all’arresto della crescita urbana è messo in relazione al ciclo di vita dei prodotti industriali
secondo la descrizione classica elaborata negli anni ’30, in base alla quale le singole industrie, o i
singoli prodotti industriali, passano attraverso: “a period of experimentation, a period of rapid
growth, a period of diminished growth, and a period of stability or decline” 2[2]. Il declino
manifatturiero (e quindi demografico) di molte aree urbane è spiegato con l’ingresso delle loro
attività “di base” nel quarto periodo del ciclo industriale (stability or decline). Le città, e le loro
“aree urbane”, sono viste, all’interno del “principio di competitività”, come grandi macchine per
produrre: la loro sorte è strettamente legata a quella delle loro “industrie di base”.
Negli anni seguenti il modello è stato messo a punto in Europa in celebri ricerche condotte da alcuni
urbanisti ed economisti urbani inglesi, e dal “gruppo di Vienna” 3[3]. Queste ricerche riducono
l’enfasi con la quale il “ciclo di vita urbano” era stato assimilato al “ciclo di vita del prodotto”, ed
elaborano un paradigma interpretativo più complesso e generale che pone in relazione i successivi
stadi di urbanizzazione - definiti in termini di tassi di variazione demografica delle città centrali e
delle rispettive periferie (hinterland) - con le successive fasi dello sviluppo industriale generale.
Secondo tale paradigma a ciascuno dei tre stadi di urbanizzazione finora succedutisi nelle economie
industrializzate, e cioè il primo della «concentrazione urbana», il secondo della «crescita sub urbana», il terzo della «de - urbanizzazione», corrisponde una specifica fase della
industrializzazione e del progresso tecnico (v. punti 1.2 e 1.4 del Programma e relative letture).
7
8
Il modello elaborato sulla base di tale paradigma può essere così schematicamente descritto.
Al primo stadio, della «concentrazione urbana», corrisponde una fase di industrializzazione
fondata sull'utilizzo di grandi quantità di materie prime, energia e forza di lavoro per unità di
prodotto; gli elevati costi di trasporto richiedono la contiguità di tali fattori, e ciò dà luogo alla
agglomerazione urbana di impianti, servizi e residenze. Nello schema teorico in questo stadio si
distinguono una 1° fase (concentrazione assoluta) in cui alla crescita della città centrale concorrono
anche le periferie che perdono popolazione, ed una 2° fase (concentrazione relativa) in cui
l'intensificarsi delle spinte agglomerative e della emigrazione dalle campagne induce un aumento
della popolazione anche nelle periferie, seppure ad un tasso inferiore a quello della città centrale.
Al secondo stadio, della «sub-urbanizzazione» corrisponde la fase Tayloristica della
industrializzazione, caratterizzata da nuovi processi e nuovi prodotti (catena di montaggio,
produzione di serie, beni di consumo durevoli ecc.) per i quali sussistono o addirittura si accrescono
le convenienze agglomerative, ma che richiedono quote crescenti di suoli per la produzione e lo
stoccaggio. Lo sviluppo delle reti e delle tecniche di trasporto (dalle prime metropolitane in
elevazione alla motorizzazione privata) rendono convenienti localizzazioni sia produttive che
residenziali in aree periferiche, ove si cumulano i vantaggi della prossimità al centro e della
disponibilità di spazi. In questo stadio la popolazione delle aree urbane continua a crescere: molto
intensamente nella 3° fase (decentramento relativo) durante la quale alla forte crescita periferica si
aggiunge quella, seppure in progressiva riduzione, delle città centrali; meno intensamente nella 4°
fase (decentramento assoluto) durante la quale la crescita periferica compensa la riduzione assoluta
delle residenze nelle città centrali.
Al terzo stadio, della «de-urbanizzazione», corrisponde la «terza rivoluzione industriale», i cui
effetti di decentramento degli insediamenti industriali e delle residenze, e di conversione delle
funzioni urbane, sono ben noti. In questo stadio la popolazione delle aree urbane diminuisce ad un
tasso contenuto nella 5° fase («decentramento assoluto») quando la ridotta crescita periferica non
compensa più le perdite di popolazione delle città centrali, e ad un ritmo più sostenuto nella 6° fase
(“decentramento relativo”) durante la quale anche le periferie perdono popolazione.
Nelle ricerche europee il connotato ciclico del modello deriva non tanto dai riferimenti originari alla
teoria del “ciclo del prodotto”, quanto dal fatto che nella sua più compiuta formulazione esso
prevede che al terzo stadio, quello della de-urbanzzazione, faccia seguito uno stadio di riurbanizzazione. Quest'ultimo sarebbe caratterizzato, pur in un quadro di stabilità o addirittura di
lieve riduzione della popolazione urbana complessiva, da un aumento del peso demografico delle
città centrali rispetto alle periferie analogo, a quello verificatosi nel primo stadio di concentrazione
urbana.
Altra proposizione essenziale del modello è che i passaggi da uno stadio al successivo - ovvero
dalla prima alla seconda delle fasi in cui ciascuno stadio è suddivisibile - pur potendo avvenire in
tempi e con velocità diverse in relazione alle diverse caratteristiche ed evoluzioni delle specifiche
basi economiche urbane, seguono di norma l'ordine stabilito: un'area urbana può passare dallo
stadio della concentrazione a quello della de - urbanizzazione anche saltando, o percorrendo in
tempi rapidi, lo stadio della sub - urbanizzazione ma non può percorrere un cammino inverso.
Tuttavia ricerche successive 4[4]hanno chiarito la natura descrittiva, piuttosto che previsiva, del
modello, cioè il fatto che esso descrive, con un elevato grado di generalità, le tendenze prevalenti
nella organizzazione spaziale dei sistemi urbani dei paesi industrializzati, ma non fornisce
indicazioni univoche sulle performances delle loro basi economiche. Sulla scorta di successive ed
ulteriori risultanze empiriche (tra le quali i censimenti degli anni ’90) sono state poi avanzate
motivate perplessità sull'effettivo carattere ciclico della evoluzione descritta dal modello. I casi reali
9
di ri-urbanizzazione appaiono così limitati, ed il fenomeno della gentrification (cioè del ritorno di
residenti di redditi medi ed alti nelle aree centrali delle “città centrali”) di dimensioni così contenute
e così legate alle dinamiche dei valori immobiliari, da rendere molto incerta la previsione del
passaggio dal terzo stadio della de - urbanizzazione al quarto della ri – urbanizzazione. Il contributo
che il modello del ciclo di vita ha dato alla conoscenza dei fenomeni urbani è stato rilevante, ma
limitato alla interpretazione sintetica della storia recente dei processi di urbanizzazione nei paesi
industrializzati, piuttosto che alla previsione delle dinamiche future.
Dunque, analogamente a quanto è avvenuto per la teoria della base economica urbana, anche
il modello degli stadi di sviluppo se depurato da contenuti previsivi, può essere considerato
come un modello sintetico di descrizione e comparazione delle fasi evolutive nelle dinamiche
spaziali dei sistemi urbani di diversi paesi e di diverse regioni. Entro questi limiti esso si è
mostrato di notevole utilità.
5[1]
Norton, R.D., City Life-Cycles and American Urban Policy, Academic Press - New York, S. Francisco, London,
1979.
6[2]
Norton, cit, p.125
7[3]
Hall, P., Hay, D., Growth Centers in the European Urban System, London,1980. Berg, L. van den, et al., Urban
Europe, a Study of Growth and Decline, London,1982,
8[4]
Chesire, P. C., Hay, D.G., Urban problems in Western Europe, an economic analysis, London, 1989.
10