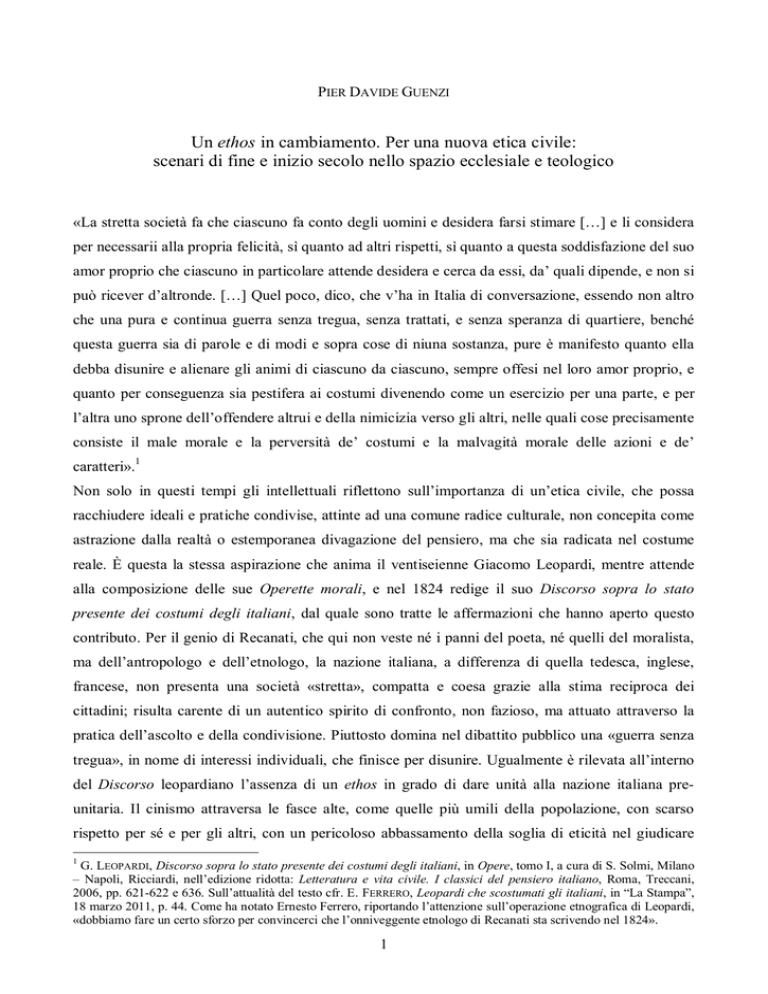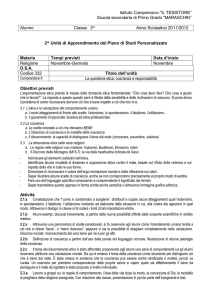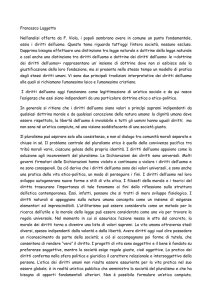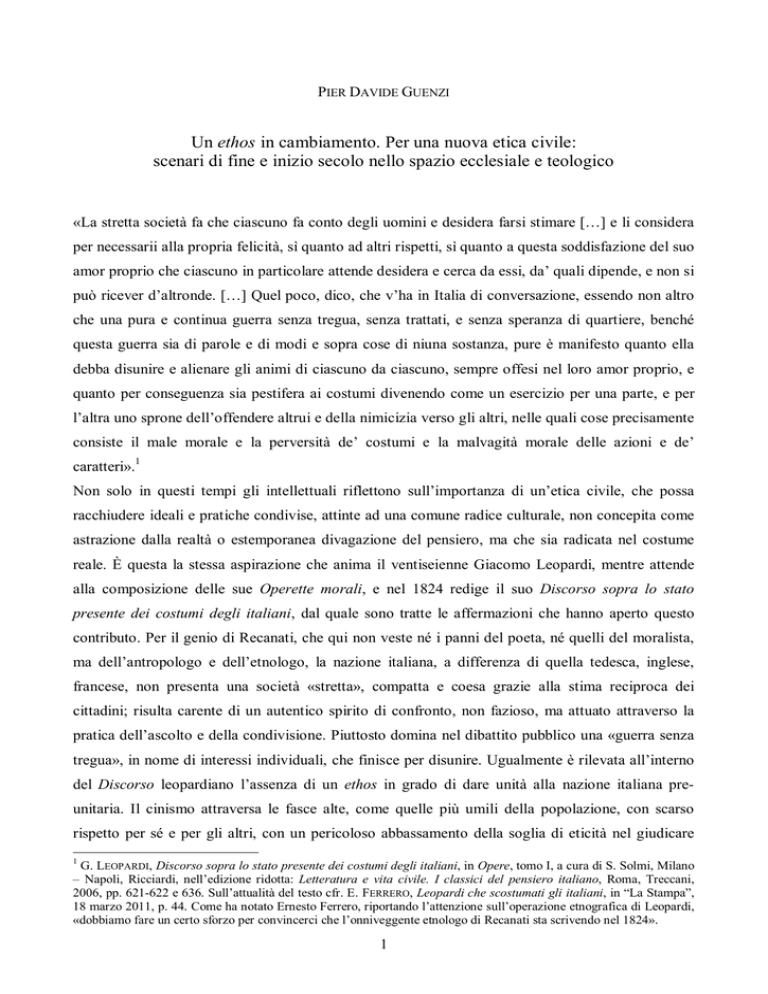
PIER DAVIDE GUENZI
Un ethos in cambiamento. Per una nuova etica civile:
scenari di fine e inizio secolo nello spazio ecclesiale e teologico
«La stretta società fa che ciascuno fa conto degli uomini e desidera farsi stimare […] e li considera
per necessarii alla propria felicità, sì quanto ad altri rispetti, sì quanto a questa soddisfazione del suo
amor proprio che ciascuno in particolare attende desidera e cerca da essi, da’ quali dipende, e non si
può ricever d’altronde. […] Quel poco, dico, che v’ha in Italia di conversazione, essendo non altro
che una pura e continua guerra senza tregua, senza trattati, e senza speranza di quartiere, benché
questa guerra sia di parole e di modi e sopra cose di niuna sostanza, pure è manifesto quanto ella
debba disunire e alienare gli animi di ciascuno da ciascuno, sempre offesi nel loro amor proprio, e
quanto per conseguenza sia pestifera ai costumi divenendo come un esercizio per una parte, e per
l’altra uno sprone dell’offendere altrui e della nimicizia verso gli altri, nelle quali cose precisamente
consiste il male morale e la perversità de’ costumi e la malvagità morale delle azioni e de’
caratteri».1
Non solo in questi tempi gli intellettuali riflettono sull’importanza di un’etica civile, che possa
racchiudere ideali e pratiche condivise, attinte ad una comune radice culturale, non concepita come
astrazione dalla realtà o estemporanea divagazione del pensiero, ma che sia radicata nel costume
reale. È questa la stessa aspirazione che anima il ventiseienne Giacomo Leopardi, mentre attende
alla composizione delle sue Operette morali, e nel 1824 redige il suo Discorso sopra lo stato
presente dei costumi degli italiani, dal quale sono tratte le affermazioni che hanno aperto questo
contributo. Per il genio di Recanati, che qui non veste né i panni del poeta, né quelli del moralista,
ma dell’antropologo e dell’etnologo, la nazione italiana, a differenza di quella tedesca, inglese,
francese, non presenta una società «stretta», compatta e coesa grazie alla stima reciproca dei
cittadini; risulta carente di un autentico spirito di confronto, non fazioso, ma attuato attraverso la
pratica dell’ascolto e della condivisione. Piuttosto domina nel dibattito pubblico una «guerra senza
tregua», in nome di interessi individuali, che finisce per disunire. Ugualmente è rilevata all’interno
del Discorso leopardiano l’assenza di un ethos in grado di dare unità alla nazione italiana preunitaria. Il cinismo attraversa le fasce alte, come quelle più umili della popolazione, con scarso
rispetto per sé e per gli altri, con un pericoloso abbassamento della soglia di eticità nel giudicare
1
G. LEOPARDI, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, in Opere, tomo I, a cura di S. Solmi, Milano
– Napoli, Ricciardi, nell’edizione ridotta: Letteratura e vita civile. I classici del pensiero italiano, Roma, Treccani,
2006, pp. 621-622 e 636. Sull’attualità del testo cfr. E. FERRERO, Leopardi che scostumati gli italiani, in “La Stampa”,
18 marzo 2011, p. 44. Come ha notato Ernesto Ferrero, riportando l’attenzione sull’operazione etnografica di Leopardi,
«dobbiamo fare un certo sforzo per convincerci che l’onniveggente etnologo di Recanati sta scrivendo nel 1824».
1
comportamenti difformi e trasgressioni come negativi, anzi piuttosto mostrando per essi indulgenza,
forse anche segreta ammirazione e invidia.
Non è certamente impresa facile, né consigliabile, condensare in un breve intervento, una compiuta
analisi del bisogno di una rinnovata etica civile per come è maturata in questi due ultimi decenni,
mantenendo quale angolo prospettico la cultura intra-ecclesiale italiana o in senso più ristretto la
riflessione teologica. Più modestamente è possibile disegnare qualche scenario per delineare almeno
alcune prospettive di fondo, prendendo atto dei principali cambiamenti sociali, particolarmente
avvertiti in questo ultimo ventennio e sinteticamente censiti nella “complessificazione sociale” e
nella “soggettivizzazione degli stili di vita”.2
1. Complessificazione della società e pluralità di sistemi etici
Il difetto di ethos civile è stato più volte denunciato. Con esso si intende suggerire che «stenta a
realizzarsi in qualsiasi forma la oggettivazione sociale delle forme della vita buona», quella
meritevole non solo dell’apprezzamento di tutti, ma della dedizione di ciascuno.3 A rendere arduo il
compito, oltre alle resistenze di sempre, come quelle abbozzate da Giacomo Leopardi, è
indubbiamente il consolidarsi del profilo sociale della complessità. Emersa dal riflusso di passati
decenni, quelli degli anni ’60-70 del XX secolo, attraversati da forti spinte ideologiche e dialettiche,
la società complessa è contrassegnata, come noto, da una frantumazione del tessuto sociale con
l’emergenza di dispersi gruppi che ambiscono a precise garanzie e tutele nel perseguimento dei
propri interessi, ma in cui non sembra manifestarsi con chiarezza il contributo costrutttivo al bene
collettivo. La presa d’atto della pluralità dei sistemi sociali non di rado si coniuga con la percezione
di una certa autoreferenzialità di ciascuno di essi. La più vistosa conseguenza in ambito etico è una
comprensione solo marginale (o forse residuale) dell’idea dell’etica come scienza del bene umano
complessivo e l’emergere di etiche settoriali, con logiche discorsive ugualmente auto-referenziali,
orientate prevalentemente in chiave pragmatica e impegnate a definire, attraverso procedure
formali, regole strategiche di tipo immediatamente tecnico-operativo. Ciò può essere inevitabile
2
La categoria “etica civile” è giocata, nel dibattito odierno, non solo in chiave costruttiva e dialogica, ma anche come
via alternativa ad un modello ritenuto fortemente condizionato dalla prospettiva confessionale. Sul versante di un
pensiero che si intende rigorosamente laico cfr. la rivista “LucidaMente – Risita di cultura ed etica civile”. Inoltre
andrebbe discusso lo stilema per come compreso, forse un po’ superficialmente da Marciano Vidal. Secondo il
moralista cattolico spagnolo i tre presupposti dell’etica civile sono: 1. la “non confessionalità della vita sociale” (cioè la
difficile accezione di “laicità” sospesa prima della sua precipitazione ideologica o della sua apologetica contestazione
quale “laicismo”); 2. il “pluralismo dei progetti umani” (come tratto caratterizzante la complessità sociale); 3. la
“possibilità teorica e pratica dell’etica laica”. Tuttavia in una forma compresa non come rifiuto della religione, «bensì
dall’accettazione della razionalità condivisa e dal rifiuto dell’intransigenza esclusivista» (M. VIDAL, Etica civile e
società democratica, Torino, S.E.I., 1992 [ed. or. 1988], p. 7, ma cfr. pp. 5-7) Cfr. G. ACOCELLA, Etica sociale, Napoli,
Guida, 2003.
3
G. ANGELINI, La morale. Il silenzio della filosofia (e della teologia), in «Teologia», 24 (1999), p. 372, ma cfr. l’intero
contributo alle pp. 369-375). Anche la successiva riflessione sulla morale “provvisoria” di Cartesio ha come impulso
iniziale questo e altri contributi di Angelini.
2
come non ha mancato di notare lucidamente il teologo-morale Klaus Demmer, poiché «quanto più è
complessa la struttura di una singola società tanto più spezzata la prassi morale delle persone».
Pertanto ciascuno valuta e agisce appartenendo simultaneamente a piani diversi della società
(pubblico-privato, religioso confessionale, civile, politico, economico), adattandosi alle logiche
differenti che sono proprie di ciascun sistema sociale, rendendo esistenzialmente arduo il
coordinamento sintattico e sensatamente complessivo del proprio agire. Inoltre, accanto ai
molteplici segmenti delle etiche applicate, la complessità sociale, è chiamata ad affrontare come
presupposto ad una morale condivisa, l’impegno dialogico tra i differenti modelli etici, alla luce di
quella caratteristica pluralizzazione del pensiero da integrare, anche per gli inevitabili aspetti di
conflittualità, all’interno del confronto sociale. La complessità e l’arcipelago dei sistemi sociali
sembra così introdurre come unica via possibile alla morale quella della normazione tecnologicoburocratica, con il rischio di produrre prescrizioni di comportamenti i quali, più che radicati in un
sistema di intime convizioni da parte degli attori morali, appaiono piuttosto posti di fronte alla loro
coscienza e irrelati da più convincenti percorsi fondativi. Anzi, presupponendo l’intangibilità stessa
delle convinzioni individuali e private, si sanziona l’impossibilità di ancorare ad una fondazione
unica e condivisibile il sistema della morale.
La ricerca di accordi e procedure, più pensate sul modello della strategia politica del compromesso,
che sulla deliberazione secondo prudenza e giustizia, espressione caratteristica dell’etica classica,
sembra apparire la declinazione post-moderna di una figura morale ben nota già alle soglie della
modernità. «La nascita dell’Io moderno – ha scritto Elena Pulcini – appare caratterizzata da una
costitutiva ambivalenza […] L’individuo si scopre libero, autorizzato a inventare il proprio
programma di vita, a esplorare una realtà senza confini su cui dirigere il proprio sguardo “curioso” e
carico di aspettative ma allo stesso tempo avverte il proprio smarrimento e la propria debolezza di
fronte alla crisi di ogni aprioristica certezza che non solo gli impone nuovi oneri, ma lo espone al
caos inquietante di nuovi desideri, inclinazioni, passioni».4 Il dubbio mai revocato sulla reale entità
del bene e del male, nelle pratiche sociali, come nell’etica individuale, porta a configurare la
contemporanea aspirazione ad un’etica civile in una forma che può ricordare assai da vicino la
morale cartesiana «par provision» (cfr. Discorso sul metodo, parte III). L’approccio alle norme di
tradizione da parte dell’uomo critico, abituato al sistema logico e razionale della scienza, è quello di
chi sospende la questione della ricerca della loro verità, bastando, per il momento, che esse siano
accettate “come se” fossero vere. In ogni caso necessarie, per l’oggi, in assenza di più convincenti
sistemi valoriali. Non diversamente anche Henri Bergson, già negli anni ’30 del Novecento faceva
notare che «in mancanza di un riforma morale completa, bisognerà ricorrere a degli espedienti,
4
E. PULCINI, L’individuo senza passioni, Torino, Einaudi, 2001, p. 21.
3
sottomettersi a una “regolamentazione” sempre più invadente, aggirare uno ad uno gli ostacoli
drizzati dalla nostra natura contro la nostra civilizzazione. Ma sia che si opti per i grandi mezzi, sia
che si opti per i piccoli, una decisione si impone. L’umanità geme, è quasi schiacciata dal peso del
progresso compiuto. Non sa abbastanza che il suo avvenire dipende da lei» (Le due fonti della
morale e della religione, 1932, cap. IV, § 7). La provvisorietà della morale mostra come sia
pragmaticamente irrinunciabile e urgente mantenere almeno una cornice di principi morali per
contenere la complessità, un inquadramento precettistico per comprendere i fatti, non
semplicemente limitandosi a descriverli e riprodurli, ma guidati dall’impegno per una seppur
generica intuizione di “preservazione dell’umano”. Non diversamente possiamo leggere la nascita e
l’iniziale impulso della stessa bioetica nel contesto americano degli anni ‘70 come “scienza della
sopravvivenza” in cui includere al sapere della scienza alcuni criteri valoriali a tutela della vita
umana per il presente e per il futuro. Così la “provvisorietà” può diventare la normalità o addirittura
tout court la forma di quel meglio, attualmente disponibile alla riflessione umana, che possa fungere
da contorno di riferimento desiderabile per un’etica civile. Il “come se fosse vero” della morale par
provision di Cartesio, il quale era ugualmente figlio di una logica del discorso etico ben conosciuta
dai teologi morali, cioè il sistema del probabilismo, può diventare per l’oggi più che il presupposto
per una rinnovata opzione fondativa, come stava ancora davanti ancora a Bergson, piuttosto l’esito
migliore (o minimale) che scaturisce dal confronto democratico tra prospettive morali
irriducibilmente diverse.
Anche quando, come nella nota proposta della Diskursethik di Jürgen Habermas, la ricerca del
consenso attraverso la pratica dialogica sembra l’unica strada percorribile per definire, attraverso
una via procedurale più che fondativa, è ancora il caso di ricordarlo, le necessarie regole morali che
possano vantare un carattere di universalità per una società post-metafisica, nonostante essa non sia
pensata in opposizione al particolarismo etico elaborato nei differenti contesti vitali della società
pluralista, non può fare a meno di far emergere una empasse che si rivela come preziosa spia per
l’ipotesi di un’etica civile. La specializzazione deontologica della morale riesce a dare ragione della
“doverosità” dell’agire morale, ma appare debole in chiave motivazionale, cioè della “volontà di
essere morali”.5 La conclusione sospensiva con cui si congeda il saggio habermasiano dedicato ai
rischi della genetica liberale ne è una significativa attestazione, limitandosi a riconoscere, o forse,
sforzandosi di voler riconoscere, nella società umana una residua e irriducibile riserva etica di
5
Su questo aspetto si appuntata la riserva critica radicale posta da Spaemann in senso generale alle morali
contemporanee le quali non farebbero che trasferire su un piano sempre più elevato l’insanabile dualismo tra
eudemonismo (attribuito alle “etiche di prima persona”) e universalismo (proprio delle “etiche di terza persona”). Un
possibile fondamento al di là di tale stallo del pensiero, per Spaemann, può essere mostrato, ma non spiegato in quanto
«la domanda “why to be moral?” non ammette risposta perché è già essa stessa una domanda immorale. Essa non si
poggia su un fondamento ma, oltre ogni fondamento, lancia il suo messaggio nel vuoto: non è possibile esigere ragione
dell’esigenza di una ragione» (R. SPAEMANN, Felicità e benevolenza, Milano, Vita e Pensiero, 1998, p. 7).
4
fronte al rischio del vuoto morale o di una semplice strategia dell’agire lasciata in balia alle
proteiformi preferenze soggettive.6 Nonostante ciò, la riflessione di Habermas ha il merito di
rintracciare almeno un indice minimale per un ethos civile dove in primo piano sia messa la
salvaguardia della libertà di tutti gli attori implicati nella pratica sociale del dialogo, da articolare
con la verità propria delle argomentazioni razionali della morale, la disponibilità all’ascolto
dell’altro, l’esercizio riflessivo sulle forme di agire per garantire la tutela della soggettività umana, a
fronte del suo riduzionismo strumentale, la costante critica a ogni forma riemergente di pensiero
unico, potenzialmente totalitario.7
Non deve sembrare una divagazione rispetto al compito fissato l’indugio sulle tesi del filosofo
francofortese, soprattutto se si considera l’importanza riservata alle sue argomentazioni nel dialogo
da lui avuto nel 2004 con il teologo Joseph Ratzinger sui fondamenti pre-politici dello stato liberale
a commento e verifica del cosiddetto Böckenförde-Diktum: «lo stato “libertario” [freiheitlich]
secolarizzato vive di presupposti che non può garantire». Il dibattito tra i due prestigiosi
intelllettuali sembra però smarcarsi dal limitato fuoco di interesse manifestato a suo tempo dal
costituzionalista tedesco, il quale, se pure indendeva porre con consapevolezza i limiti del moderno
Stato liberale, nei confronti proprio di quell’ethos cui ha portato linfa, accanto ad altre radici, il
cristianesimo, d’altra parte si proponeva, all’interno del contesto tedesco degli anni ‘60, di stimolare
i cristiani a comprendere «questo Stato, nella sua laicità, non più come qualcosa di estraneo e
nemico della loro fede, bensì come l’opportunità della libertà, che è anche loro compito preservare e
realizzare». 8 Piuttosto l’intento si definisce attorno ai percorsi di universalizzazione di alcuni
contenuti etici ritenuti imprescindibili alla vita comune. In quel contesto Ratzinger riproponeva il
valore in seno al cattolicesimo della “legge naturale”, nella sua duplice potenzialità di fondazione di
un auspicabile universalismo, a partire dalla capacità euristica della ratio umana, ma anche nella sua
possibilità di indicare un iniziale tracciato contenutistico sui beni umani oggetto di tutela e cura. Pur
riconoscendo, in quella sede, che lo stumento della legge naturale appare nel contesto odierno
“spuntato” per incidere adeguatamente sulle evidenze etiche condivise, l’intervento del prossimo
6
«Il fatto che noi dovremmo agire moralmente è cosa implicita alla struttura deontologica della morale in quanto tale.
Ma perché mai dovremmo anche volere essere morali, nel momento in cui l’ingegneria genetica scalza silenziosamente
la nostra identità come esseri di genere? […] Non varrebbe più la pena di vivere in una sorta di vuoto morale, in una
forma-di-vita in cui nemmeno il cinismo morale sarebbe più immaginabile. In questo giudizio si esprime semplicemente
l’impulso a preferire un’esistenza che sia degna dell’uomo rispetto alla freddezza di forme-di-vita impermeabili agli
scrupoli morali» (HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Torino, Einaudi, 2002 p.
73).
7
Su questi aspetti cfr. P.D. GUENZI, Percorsi moralfilosofici di un’etica della vita. Sui sentieri di Jürgen Habermas ed
Evandro Agazzi, in La casa della vita, a cura di R. Altobelli, S. Privitera, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo, 2006,
pp. 143-218.
8
E.-W. BÖCKENFÖRDE, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, Brerscia, Morcelliana, 2006, p.
68 e 70. Lo studio fu pubblicato la prima volta nel 1967. Su questo aspetto cfr. P.D. GUENZI, Ricercare il bene comune.
Prospettive teologico-morali per definire il contributo della comunità cristiana, in «Archivio teologico torinese», 14
(2008), pp. 423-452.
5
papa Benedetto XVI indicava un compito alla ricerca teologica. Quello di rinnovare il pensiero a
partire da tale categoria, in grado di preservare la verità dell’humanum, con una spiccata tendenza
alla possibilità di reciproca comprensione attorno ad un nucleo irrinunciabile di evidenze etiche, al
di là del “politeismo dei valori”, secondo la fortunata formula di Max Weber, che contrassegna le
moderne società evolute. Questo perché l’accettazione delle differenze non finisca per sanzionare
semplicemente i confini insuperabili delle convinzioni personali, ma sia possibile un linguaggio
comune in cui riconoscersi universalmente. Con l’appello a questo dato di tradizione si intendeva
così rilanciare anche il ruolo della Chiesa quale autorità morale, con un suo peculiare contributo di
pensiero per tracciare rotte all’interno dell’arcipelago della complessità e della frammentazione
delle etiche.
Risulta così posto il nodo fondativo anche per l’auspicato ethos civile, non per distillazione dai
sedimenti dei differenti particolarismi morali per giungere ad un prodotto “purificato” che ambisca
al requisito di universalità, ma attraverso una continua circolarità dei suoi possibili asserti normativi
e contenuti etici attorno ad un asse di senso già disponibile a partire dalle risorse della tradizione,
appunto a partire da un’operazione di ripulitura e rigenerazione della categoria di legge naturale. La
proposta di ridare vigore alla tradizione della lex naturalis ha comportato un sobrio dibattito
all’interno delle scuole teologiche, anche quelle presenti sullo scenario italiano, e ha riscontrato un
punto di riferimento nel documento della Commissione Teologica Internazionale Alla ricerca di
un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale del 2009. L’autorevole testo è consapevole
della necessità di superare quello che è definito il modello “razionalista moderno” della legge
naturale, come emerso nella seconda scolastica dal XVII secolo, soprattutto per quel tratto di
essenzialismo e a-storicità con cui si definivano le caratteristiche antropologiche da cui dedurre
normativamente, attraverso la ragione, le regole morali congruenti con l’essenza metafisica
dell’uomo (cfr. CTI, 2009, n° 33). Conseguenza di tale modello è la separazione non solo dell’idea
di natura da quella di cultura, ma anche l’occultamento del debito che la legge naturale viene ad
avere nel pensiero cattolico da un orizzonte di riferimento di tipo teologico, quando è compresa
come rigida proposta di regole perfettamente razionali e universalmente evidenti. Di una visione in
grado di superare i limiti concettuali emersi nel pensiero cattolico moderno è custode la tradizione
facente capo al pensiero di Tommaso d’Aquino, per il quale la caratterizzazione principale della
legge naturale risulta essere la modalità tipicamente umana, attraverso la ragione, di partecipazione
alla legge eterna, espressione superiore del governo di Dio sulla realtà, grazie alla quale, per il suo
particolare statuto ontologico, l’uomo è reso partecipe della provvidenza divina, provvedendo a sé
stesso e nella forma di responsabilità attiva nei confronti delle altre creature (cfr. Summa theologiae
I-IIae, q. 91, art. 2). Va comunque riconosciuto che il teorema della legge naturale consente di
6
individuare alcuni tratti caratteristici della peculiare comprensione dell’essere umano i quali, più
che organizzati in una forma di rigorosa sistematizzazione, sono piuttosto elementi indicatori e
rivelatori di un compito che mantiene aperto il pensiero. A partire da essi risulta possibile delineare
un senso positivo per un riconoscimento comune dell’umano. Tale operazione di significazione,
tuttavia, non può dirsi se non attraverso forme culturali, anche se può rappresentare una grammatica
e una sintassi elementare che si pone al di sotto di ogni cultura e permette di tracciare precise
convergenze tra la culture. Inoltre non può essere occultato un altro elemento proprio della
tradizione cattolica sulla legge naturale, che ha sempre considerato in chiave evolutiva, e dunque
storicamente condizionata, le sue ulteriori determinazioni dai primi principi, di tipo formale. Tale
operazione di ragione non si sottrae da una decrescente certezza nella loro espressione
contenutistica e dunque da una conseguente possibilità di errore, comunque mai da presumere, ma
da mostrare attraverso migliori argomentazioni. Un passaggio, quello dai principi primi alle loro
conseguenze inoltre, che ingloba in sé non il semplice rispecchiamento di evidenze indiscutibili o di
principi non negoziabili, ma anche una riconosciuta base pattizia e consensuale della loro
chiarificazione. Inoltre il rilancio della teoria della legge naturale, come base per un etica a pretesa
universale, nelle riflessioni della Commissione Teologica Internazionale non sembra tener conto in
modo adeguato che essa è pienamente comprensibile solo a partire da una tradizione inquadrata in
chiave teologica. Nella prospettiva della fede cristiana, conserva il suo carattere dinamico e
drammatico per indirizzare alla verità escatologica propria della creatura e funge da elemento
critico per il discernimento di quanto nelle tradizioni umane consenta o meno l’apertura al
compimento integrale e definitivo dell’uomo. A partire dalla coscienza di una verità circa se stesso,
che risulta sottratta alla pura disponibilità soggettiva, ma anche dalla traiettoria verso un
compimento ancora in fieri, si apre lo spazio della conoscenza e della responsabilità umana nel dar
forma storica a tale verità, attraverso la propria libertà. Anche questo aspetto è parte integrante della
tradizionale interpretazione della legge naturale che assegna alla ragione (e correlativamente alla
libertà umana) un ruolo importante nella inventio (non nella creazione ex nihilo) di tutte quelle
determinazioni contenutistiche, forse maggiormente assegnabili allo jus gentium, per le quali il
confronto condiviso risulta inevitabile.
Nell’apologia della legge naturale uno dei punti delicati, soprattutto in alcune reintreprazioni della
teologia cattolica, risulta essere l’idea che essa traduca un sistema di verità morali disperse nelle
differenti espressioni del raziocinio umano, le quali tendono verso la lex nova evangelica quale suo
suo punto terminale. Per questo, al di là di legittime comprensioni dello strumento della lex
naturalis come grammatica basilare di un ethos civile, non dovrebbe essere dimenticata la sua
appartenenza ad un codice etico particolare teologicamente connotato. Il dibattito, almeno
7
all’interno del pensiero cattolico, ha indubbiamente segnalato l’istanza costruttiva di un ethos civile
per il quale si è suggerito il ricorso ad un sapere di tradizione, che si ponga al di sopra della
pluralizzazione dell’etica contemporanea. Si può comunque obiettare che la questione forse più
corretta sarebbe, più che quella di una evidenza etica indisponibile ad essere scalfita, pena la perdita
di una consistente possibilità di comprensione dell’umano, e anteriore alla pluralità delle etiche,
quella piuttosto di un’etica al plurale, cioè pienamente sensibile alla e gelosa della cura per le
differenze particolari, comunque impegnata, accanto ad una continua tradizione e rilettura delle
proprie radici, a lavorare nella direzione di un universalismo morale pensato come opus in fieri.
È questo, pur con i doverosi distinguo, il progetto convergente a partire dall’ultimo decennio del
XX secolo, ma iniziato già molto prima, di un Weltethos, suggerito da Hans Küng. Come noto la
proposta del teologo svizzero si muove perfettamente nei parametri di una società post-moderna,
assumendo in senso positivo la differenza di sistemi fondativi e insieme l’urgenza di un pensiero
comune di fronte anche ai drammi della sopravvivenza umana. Il suo “ecumenismo morale”,
tuttavia, non si sottrae dall’essere un modello auspicabile di ricerca di intese, attraverso l’adesione
dei differenti pensieri religiosi e secolari, in cui l’effetto finale assume i tratti di una sorta di
“sincretismo” etico. In esso le differenze si trascendono, annullando le specifiche potenzialità
conflittuali manifestate nei tempi passati, ma anche appiattendo la ricchezza che ciascuna di esse
può apportare, giungendo ad una sorta di prodotto “ibrido”. Inoltre sembrerebbe che ciascuno dei
soggetti e degli attori morali del Weltethos possa trovare la propria identità solo andando al di là del
proprio particolare mondo di tradizione, individuando così la matrice dell’humanum oltre a tale
mondo, quasi azzerando le interpretazioni storiche in cui è stato espresso attraverso molteplici
narrazioni interpretanti. 9
Una via più costruttiva all’impegno teologico di pensare all’ethos civile può invece giungere da una
proposta, quella di Pier Cesare Bori, esplicitamente tesa ad una forma di etica al plurale, condotta a
partire da un atto di lettura delle scritture ebraico-cristiane. Il compito di assumere per questa
operazione il paradigma biblico, accanto all’integrale accostamento di altri patrimoni scritturistici di
altre tradizioni umane, ha il merito di un’opzione metodologica differente rispetto a quella di una
produzione di un metalinguaggio che assimili e unifichi ciò che invece dovrebbe restare
ineliminabile, in quanto espressione di una indubbia ricchezza dell’umano: la pluralità delle lingue e
delle culture. Il paradigma biblico è così compreso nella sua traducibilità in chiave uniersalistica nel
rispetto di una mutua accoglienza critica e consapevole delle tradizioni. In particolare il
particolarismo etico non è condizione per affermare l’impossibilità di un confronto, ma è compreso
come il linguaggio nativo in cui ciascun soggetto umano ha imparato a leggere e a declinare in
9
Su questo aspetto concordo con quanto espresso in S. MORANDINI, Da credenti nella globalizzazione. Teologia ed
etica in orizzonte ecumenico, Bologna, EDB, 2008, pp. 89-97 con utili osservazioni per ampliare la riflessione.
8
comportamenti responsabili la propria umanità. L’operazione di consenso, così, non si produce,
come in una rigida riproposizione della legge naturale, su una discutibile separazione nella stessa
persona tra il piano soprannaturale della fede e quello naturale della ragione. Né nella forma di
Küng attraverso un’operazione di risalita verso i contenuti etici dell’umano al di là dei diversi
modelli etici e delle fedi. Bensì attraverso l’immagine della “traduzione” operabile su una lingua
nativa particolare, come quella del cristianesimo, operazione possibile solo a partire dal fatto di una
radice linguistica profonda e comune, nella convinzione secondo cui «i grandi testi siano
“traducibili per definizione” giacché ad essi soggiace un metatesto comune, una “pura lingua” non
esplicitabile tuttavia se non nelle diverse lingue umane». 10 Ogni proposta particolare, come quella
propria delle scritture ebraico-cristiane, nell’orizzonte della traducibilità, è assunta non come una
verità in sé chiusa dall’interpretazione dell’autorità deputata alla sua trasmissione, ma come
rivelatrice di potenzialità espressive al di là della sua semplice affermazione. Potenzialità non
altrimenti dette che in una lingua particolare e definita, ma rintracciabili da un analogo atto di
lettura di tradizioni diverse. Proprio da tale confronto scaturirebbe l’opportunità di portare a galla
quello che può restare implicito (e pure è fondante) in una singola sapienza ed è in grado di
contribure a dare forma ad un ethos condiviso, che non si limiti a una forma di consenso di tipo pregiuridico, come nel caso della Dichiarazione universale dei diritti umani, senza per questo
annullarne il pregio, ma organizzato attorno a «percezioni etiche essenziali» e al loro aggregarsi
attorno ad alcuni «convincimenti etici fondamentali». Essi non sarebbero, infine, solo esplicitati
intellettualmente, ma anche affettivamente vissuti, radicati sul «sentimento dell’obbligo verso ogni
essere umano».
Di passaggio tale proposta di lettura appare assai più urgente di ogni tentativo, seppur lodevole, di
ridescrivere unicamente l’agire del cristiano a partire dalla Parola di Dio, come se esso possa
prescindere da una sua dimensione secolare, e trova la sua verifica intratestuale già all’interno del
Nuovo Testamento, soprattutto in quel documento che potrebbe costituire la matrice originaria per
un ethos mondano, che è il capitolo 13 della Lettera ai Romani. Paolo non rinuncia ad affermare il
differenziale dell’amore-agape, non solo quale regola interna alla comunità, ma anche nella forma
radicale di antidoto all’inimicizia nei rapporti inter-soggettivi, eppure riesce a motivare il fatto che
esso debba essere tradotto, a partire dalla pratica dei cristiani, in una forma che risulti apprezzabile,
cioè leggibile, a partire dai presupposti dell’etica umana. In questo senso l’invito a «fare il bene»,
così come la lealtà istituzionale oppure la stima da parte degli altri cives, evocati nella pericope (cfr.
Rm 13, 1-7), non sono da valutare come una semplice parenesi moralistica, bensì come “traduzione”
10
P.C. BORI, Per un consenso etico tra culture. Tesi sulla lettura secolare delle scritture ebraico-cristiane, Genova,
Marietti, 1991, p. 35.
9
secondo la lingua e il codice etico dell’aristotelismo e dello stoicismo, delle potenzialità secolari del
particolarismo etico dell’amore cristiano, in una forma di universale comprensibilità.
Inoltre l’esercizio riflessivo sulla cosiddetta “regola d’oro”, al di là della sua semplificante
riconduzione ad una mera sentenza di saggezza popolare, quella stessa valutazione che ritroviamo
nella Fondazione della metafisica dei costumi di Kant e nella critica ad essa come forma imperfetta
di un’auspicabile principio etico fondamentale, in quanto vistosamente dipendente dalla patologica
contaminazione del desiderio soggettivo, potrebbe evidenziare una sua potenzialità aperta sia alla
sua particolarizzazione in chiave teologica, così come esemplarmente espressa nei testi evangelici,
sia alla sua universalizzazione nell’ottica di quelle «percezioni etiche universali» presagita da Bori.
Erede già di un’operazione ripropositiva basata sulla “sapienzializzazione” della Torah, la “regola
d’oro”, compresa all’interno di una specifica tradizione teologica, anzi di due, quella ebraica e
quella cristiana, conserva un linguaggio di alta densità simbolica in grado di abbracciare per intero
lo spettro dell’etica tout court, tuttavia non senza una precisa opzione che, ancora nel solco di Bori,
è indice di quell’obbligazione reciproca che non solo definisce le giuste relazioni istituzionali, ma
indirizza ad un codice di prossimità radicato nell’identità stessa della persona e del suo desiderio.
«Fare agli altri quello che vorresti sia fatto a te» interfaccia due livelli in cui ritroviamo sia la chiave
teologica della buona circolazione della sovrabbondanza dell’amore del Padre e della sua
misericordia (così nella sua contestualizzazione evangelica di Mt 7, 12 e Lc 6, 31), sia l’invito a
scoprire, prima ancora della socialità, la radice della prossimità come costitutiva dell’umano.11
Nella prospettiva dischiusa da tale lettura intensiva della “regola d’oro”, le auspicabili forme
condivise della vita buona, non sarebbero da rintracciare rimanendo semplicemente sul livello della
società, o della socialità, riscontrando in questa categoria già una deviazione rispetto all’idea della
communitas soggiacente alla tradizione filosofico-teologica di Aristotele e Tommaso d’Aquino. La
11
Questo impegno per una lettura intensiva della “regola d’oro”, cioè consapevole di tutte le sue possibilità
interpretative per un’etica condivisa, deve salvaguardare parimenti anche la conservazione della sua matrice teologica,
per come espressa nelle scritture ebraico-cristiane. Punto di partenza è la considerazione della Regola come
formulazione di “convinzione comune” (endoxon). Essa può condurre, tuttavia a un modello etico di riferimento, che
integri il rispetto per l’altro con la promozione dell’altro; o per cui il rispetto si protende alla responsabilità. La Regola
aurea introduce già a partire dalla sua formazione un’intenzionalità buona verso l’altro che è la forma a partire dalla
quale articolare la direzione del desiderio non in una forma di colonozzazione o manipolazione dell’altro, ma di
sollecitudine per l’altro. Tale orizzonte di intenzionalità non è solo un orientamento generale, ma fa della Regola un
principio per l’autoformazione soggettiva e dunque per la costruzione, secondo saggezza, dell’identità personale. La
Regola acquista così un significativo profilo “intra-soggettivo”, particolarmente evidenziato nel contesto dell’etica
contemporanea dal filone delle etiche neo-aristoteliche e della “virtù”. Tale profilo intra-soggettivo, raggiunto dalla
Regola, si distende nello spazio di una soggettività ospitale e accogliente nei confronti dell’altro. Perciò la Regola
raggiunge la polarità inter-soggettiva, che si segnala nella tematica della “reciprocità relazionale” e del
“riconoscimento” (Io-Altro), ma anche si estende alle relazioni regolabili secondo giustizia, toccando così la polarità
delle etiche deontologiche di matrice kantiana o neo-contrattualiste. La Regola d’oro acquista anche una valenza
politica, nel delineare rapporti istituzionali, in cui però è necessario integrare la logica del potere (fautrice anche di una
politica intesa come “ostilità”) ad una forma includente la dimensione classica dell’amicizia politica (cfr. Aristotele e
Tommaso).
10
caratterizzazione attuale della società, come noto, porta i tratti della moderna comprensione di un
“vivere insieme” sotto l’ombra del Leviathan di stampo hobbesiano o in cui la forma primaziale per
intendere la relazione tra i soggetti umani sembra essere quella dello scambio mercantile di tipo
lockiano. Secondo tale forma moderna di comprensione il profilo delle relazioni intersoggettive e di
quelle istituzionali appare attraversato da una mai pacificata logica competitiva, da limitare nelle
sue forme estreme, o di rapporti strutturati secondo la logica dell’utile soggettivo. Più originaria
della società, e dunque maggiormente traducibile a livello di ethos, è la prospettiva della prossimità
umana, come codice anteriore ad ogni costruzione societaria di strategie di consenso e di
cooperazione. Tale prossimità, nella logica della regola d’oro, allora può comprendere alcune
nervature di un ethos in cui si riconosca e si preservi l’umano che è comune: il superamento della
logica dell’investimento di sé secondo la dinamica dell’utile; la denuncia di forme più o meno
larvate di onnipotenza e di accumulo illusorio di forza; l’attenzione a pensare alla propria vita in
una prospettiva più ampia che includa la cura per il bene comune e da condividere secondo criteri di
fratellanza, oltre che attraverso le forme del contratto o della giustizia distributiva.
È innegabile che l’etica cristiana abbia una certa dimestichezza con la questione della prossimità. E
che abbia una pratica effettiva di essa radicata nel tempo, visibilizzata nelle istituzioni ecclesiali e
nella testimonianza dei fedeli. Ciò costituisce una ricchezza, a patto che non resti (e che non venga)
marginalizzata in una risorsa utilizzata unicamente a correzione delle inevitabili brutture e
ingiustizie del mondo. Occorre tradurre la cultura della prossimità ospitale, che sa creare familiarità,
là dove la cultura separa irremediabilmente o confina in una anonima indifferenza. È questo anche il
senso dell’agape divina, in un linguaggio politicamente costruttivo. L’amore non ha come
destinatario un altro, che la convenzionalità del discorso cristiano chiama “prossimo” e l’efficienza
sistemica dell’assistenza sociale tende a denominare come “utente di servizi”. L’amore riconosce e
costituisce la prossimità, là dove la società continua ad elaborare strategie di anonimizzazione di chi
è costretto ai suoi margini e là dove la cultura diffusa spinge alla rimozione di ciò che tende ad
essere percepito come destabilizzante per la sua sopravvivenza. Nella cura del povero si annuncia
l’estensione massima della prossimità, che, tuttavia, si costituisce e segna quei legami culturalmente
già disponibili per dare senso al vivere comune, quelli che si riportano ai “rapporti elementari della
vita”: uomo-donna; genitori-figli, fratelli. In riferimento a tali rapporti si delinea un ethos di fondo,
cioè una «legge non scritta che sta a fondamento dell’alleanza sociale», nonostante la riflessione
politica moderna persista nel negare «il rilievo dell’ethos in ordine alle forme giuridiche della
giustizia». Si tratta allora, come opportunamente si esprime Giuseppe Angelini, di «pensare la
responsabilità politica della carità cristiana». Questa via diversa passa attraverso la considerazione
11
del «nesso originario che lega amore cristiano e quelle forme elementari della prossimità umana,
che trovano la loro prima definizione esattamente attraverso le forme della cultura». 12
Non diversamente va accolta tutta la capacità costruttiva per l’ethos sociale di una proposta come
quella continuamente rielaborata da J.B. Metz nel solco della sua quasi cinquantennale “teologia
politica”. Certo siamo più consapevoli dei distinguo prodotti dai molteplici versanti della critica
teologica sulla sua proposta. Non di meno resta il valore del suo nucleo generatore, riespresso
ultimativamente anche con attenzione ad un possibile ethos globale: la rammemorazione
dell’autorità dei sofferenti, «di coloro che soffrono innocentemente e ingiustamente».13 Ritroviamo
nella sintetica formula del teologo tedesco una esplicita riserva critica nei confronti di una via
meramente «contrattuale» o basata su una riduttiva interpretazione del criterio democratico della
«votazione a maggioranza» come procedura tecnica di definizione del consenso sui valori e sulle
regole del vivere insieme. Tale operazione di memoria passionis svolge una salutare presa di
distanza da uno dei rischi riscontrati nell’ambito pubblico, «tanto pluralista quanto diffuso in modo
disordinato e che, perciò, è frequentemente generatore di apatia». La società laica, pluralista e
democratica, se da una parte è formalmente strutturata per essere spazio per un confronto aperto e
dialogico, può ugualmente, in nome della sua equidistanza esibita da qualsiasi particolarità e per i
noti meccanismi di dismissione dei singoli cittadini dalla responsabilità partecipativa loro propria,
generare situazioni di “indifferenza” e “apatia” nella più vasta parte del corpo sociale, proprio
mentre ne afferma l’“uguaglianza” dei singoli membri.
All’interno di questo contesto, così tipico dell’Occidente, la chiesa, come custode della memoria
passionis al centro della propria fede, può prodursi in un impiego pubblico non solo delle sue
ragioni, spesso prigioniere di inevitabili astrazioni, ma dello stesso profilo “passionale” alimentato
da una «razionalità anamnestica». La via privilegiata per un ethos condiviso da parte della comunità
cristiana passa non attraverso il semplice allestimento di un “discorso pubblico” che ambisca ad
essere autorità morale per la moderna società secolarizzata, ma attraverso un’operazione di continua
narrazione del nucleo fondante la fede ecclesiale, cioè nella fedeltà alla sua «storia di fondazione».
Così accanto al permanere di una tipicità cristiana, e intra-ecclesiale, di intendere l’esistenza e
l’agire, si può aprire un ethos comune tra i soggetti della moderna società complessa, a partire dal
«riconoscimento dell’autorità dei sofferenti». Ciò comporta anche la consapevolezza di una qualità
che deve sempre essere mantenuta nella parola pubblica eccesiale: la capacità di correlare la
parresia con la phronesis. Cioè l’arte di trovare la via giusta, senza annullare il potenziale
12
G. ANGELINI, Eros e Agape. Oltre l’alternativa, Milano, Glossa, 2006, p. 145 e 162.
Si limita la riflessione su J.B. METZ solo al suo saggio: Memoria passionis. Un ricordo provocatorio nella società
pluralista, Brescia, Queriniana, 2009 [ed. or. 2006], qui p. 161. Per gli altri richiami nelle righe seguenti del testo cfr.
pp. 161-162; 195-204; 223-226.
13
12
differenziale che l’evangelo riveste per il credente, appiattendolo alla pura ripetizione dei valori
comuni, ma con l’attenzione prudente a non comprendere l’universalismo cristiano in una forma
ideologica, tentata dalla nostalgia della cristianità perduta. «Se interrogato nel suo centro delicato e
più intimo, - ha scritto Giuseppe Ruggieri – il messaggio cristiano manifesta una sua universalità
originale che non è quella del comune riconoscimento dei valori della convivenza, ma sta piuttosto
nell’energia, nella dynamis dell’evento predicato […]. La laicità, come principio regolativo dei
rapporti fra i diversi, in quanto garanzia esterna al libero esprimersi delle diversità, al fondo resta
pur sempre limitata, incapace di garantire quell’accoglienza assoluta che definisce l’universalità del
messaggio cristiano». 14 La valorizzazione di questa “laicità”, soprattutto nella forma del confronto
aperto, non rappresenta così un “male minore” rispetto ad altri quadri futuribili o nostalgicamente
rievocabili, quanto piuttosto, la chance per una maggiore chiarificazione della stessa originalità del
messaggio cristiano ed un invito ad una sua ricomprensione sempre più profonda. Parimenti – e qui
ritroviamo la lezione habermasiana evocata in apertura – andrà maggiormente apprezzata la
disponibilità ad apprendere del “laico” cittadino dello Stato liberale da persone che «attingono la
loro integrità e la loro autenticità da convinzioni religiose» e con gelosia ne sanno conservare la loro
qualità, ma anche sono disponibili, ad una paziente opera di “traduzione” che dischiuda «il
contenuto dei concetti biblici al di là dei confini di una comunità religiosa, fino al pubblico generale
di coloro che hanno altre fedi o che non credono».15
Intermezzo: inevitabili questioni di etica pratica
Certamente questo potenziale – qui semplicemente approcciato in una prospettiva generale –
domanda di essere sviluppato anche nelle questioni di etica pratica. Di questa applicazione non
mancano significativi esempi all’interno della recente produzione teologico-morale e anche da parte
14
G. RUGGIERI, Alcune considerazioni teologiche in margine alla concezione contemporanea della laicità, in «Filosofia
e teologia», 21 (2007), pp. 297-311, qui p. 311. Possono essere accostate anche le osservazioni di Dietrich BONHOEFFER
nel frammento Sulla possibilità della chiesa di rivolgere la parola al mondo: in Etica, a cura di I. TÖDT, H.E. TÖDT, E.
FEIL, C. GREEN, Brescia, Queriniana, 1995 (Opere di Dietrich Bonhoeffer, 6), pp. 310-319. Pur nell’accentuazione,
tipica della prospettiva evangelica, della separazione tra Vangelo e legge (civile) e sottolineando la differenza rispetto
alla prospettiva cattolica che tenderebbe ad impegnarsi nella parola rivolta al mondo «sulla base di qualche conoscenza
razionale o di diritto naturale […] astraendo temporaneamente dal vangelo» (ivi, p. 315), il teologo tedesco afferma: «se
si pensa che il cristianesimo abbia una risposta per tutte le questioni sociali e politiche del mondo, cosicché basterebbe
prestare ascolto a tali risposte cristiane per mettere il mondo in ordine, questo è chiaramente un errore. Se invece si
pensa che, alla luce del cristianesimo, ci sia qualcosa di ben preciso da dire a proposito delle cose mondane questo è
vero» (ivi, p. 311). Va raccolta a proposito di Bonhoeffer l’attenzione a salvaguardare la qualità evangelica del discorso
ecclesiale, che pure non può essere separata da una intelligenza responsabile dei processi storico-civili e politici per le
quali si appella alla competenza dei cristiani (cfr. anche PRODI, Una storia della giustizia, cit., pp. 466-469; sul pensiero
etico di Bonhoeffer: S. ROSTAGNO, Etica protestante. Un percorso, Assisi, Cittadella, 2008, pp. 148-152).
15
J. HABERMAS, I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale, in J. RATZINGER, J. HABERMAS, Etica, religione e
Stato liberale, Brescia, Morcelliana, 2005, pp. 35-36. Cfr. anche ID., Tempo di passaggi, Feltrinelli, Milano 2004, pp.
140-141. Osservazioni analoghe sono proposte in J.-M. FERRY, Face à la tension entre droits de l’homme et religion,
quelle étique universelle? Reflexions sur un au-delà problématique de la läicité, in «Recherches de science
religiueuse», 95 (2007), pp. 61-74.
13
dello stesso magistero cattolico. Restando all’interno una semplice ricostruzione – certamente
perfettibile – ne emergono alcuni capitoli certamente già percorsi, ma ugualmente espressivi di un
indice di un ethos civile. Un primo campo applicativo va certamente nella riflessione sulla forma
politica della democrazia. Al di là dell’affermazione di essa, pur non di rado risolta solo ad un
livello formale o nella sua degenerazione di dispotismo della maggioranza, si richiede una sua
significativa evoluzione in una forma più esplicitamente deliberativa e partecipativa da parte delle
forze vive della società civile. La “democrazia rappresentativa”, che ha costituito il punto di svolta
della modernità politica, domanda di essere profondamente ripensata in quanto non può essere
assunta quale unico punto di riferimento per la definizione della modalità del “vivere bene” in
società. La sua possibile entropia, come noto, era stata lucidamente denunciata già nel XIX secolo,
con riferimento alla società nordamericana, da Tocqueville nella forma di un “mite dispotismo”,
alimentato dal bisogno dei singoli di sentirsi esonerati da una diretta responsabilità gestionale alla
cosa pubblica, delegata ai propri “rappresentanti”, per poter perseguire quei “piccoli affari”che
ammansiscono la “passione acquisitiva” di benessere materiale di ciascun individuo.16 Il rischio è la
formalizzazione di una procedura con cui può disimpegnarsi la ricerca sostanziale di ciò che
rappresenta la convivenza democratica, soprattutto nell’istanza partecipativa alla struttura di
governo e nella capitalizzazione in chiave solidale, per l’intero organismo, del bene relazionale
proprio della società civile. Che la procedura democratica possa comprendersi non in vista della
ricompattazione della società su fini comuni, ma costituire una potente spinta alla frammentazione
atomistica, concepibile sia nel suo profilo più dimesso del disimpegno e della delega al nume
tutelare e di controllo degli organi di rappresentanza come in un decisionistico e tecnico potere
“della maggioranza” gestito per fini corporativistici, è storia di oggi e domanda una profonda
attenzione in vista, come afferma Charles Taylor, di una «vigorosa vita democratica» da ristabilire
in modo più evidente. Sotto questo profilo si è introdotta la concezione di “democrazia
deliberativa”, tesa a ridefinire la partecipazione, come costitutiva del progetto politico, contribuendo
a costruire “dal basso” lo stesso bene comune, attraverso una più trasparente comunicazione in
grado di rafforzare il rapporto tra i membri della società e chi ha cura del bene della polis,
trasferendo una maggiore quota del potere decisionale ai cittadini secondo modalità inclusive dei
molteplici soggetti sociali, con particolare riferimento a quelli più deboli.17 Va da sé che questa
16
Charles TAYLOR parla di questo aspetto come uno dei “disagi” della modernità, cioè «quei tratti della nostra cultura e
società contemporanee che gli uomini sperimentano come una perdita o un declino, anche se la nostra civiltà ‘si
sviluppa’»: Il disagio della modernità, Laterza, Roma-Bari 1999 (ed. or. 1991), p. 3 (ma cfr. anche pp. 127-141). Il
riferimento è all’opera di A. de Tocqueville, La democrazia in America (1835 e 1840). Una suggestiva ricostruzione
della figura dell’homo democraticus secondo Tocqueville in PULCINI, L’individuo senza passioni, cit., pp. 127-175.
17
Cfr. R. LEWANSKI, La democrazia deliberativa. Nuovi orizzonti per la politica, in «Aggiornamenti sociali», 58
(2007), pp. 743-754.
14
espressione della democrazia si unisce non semplicemente ad una proclamazione dei diritti, ma a
forme più convinte e visibili di “pratica sociale dei diritti”.18
Questo rinvigorimento in chiave partecipativa dell’ethos democratico non può non ricadere su altri
segmenti della vita sociale, anche su una scala planetaria. Tali sono ad esempio una più convinta
attenzione alla vita economica, per indirizzare in chiave democratica una migliore govenance
politica dei processi di globalizzazione economica e dei suoi poteri estesi su scala planetaria e transnazionale. Vittorio Emanuele Parsi individua in tale esigenza di governance la richiesta per cui
«funzioni di governo del sistema internazionale stesso vengano in qualche modo esercitate, a
prescindere dall’esistenza o meno di specifiche istituzioni a un tale scopo espressamente create e/o
dedicate».19 L’agenda minimale dei contenuti di una governabilità dell’assetto internazionale,
incrocerebbe i seguenti aspetti: la capacità di prevenire conflitti su scala allargata, la limitazione
della violenza illegale (come nel caso del terrorismo) operante a livello internazionale, le strategie
umanitarie di peacekeeping, a fronte del ritorno ad un più diffuso utilizzo della forza militare,
legalmente accreditata anche attraverso il problematico stilema di “guerra giusta”, ma forse troppo
precipitosamente invocata come unica via risolutiva dei conflitti o dell’evoluzione democratica di
regimi dittatoriali.20 Tale agenda non può che intrecciare anche la questione dell’utilizzo delle
risorse planetarie secondo un modello perseguibile di sostenibilità, con l’impegno a ridurre lo scarto
tra ricchezza e povertà tra le nazioni senza l’imposizione di forme neo-colonialistiche, e dunque con
una più convinta attenzione alle problematiche dell’ambiente come connesse al riconoscimento di
una più estesa comprensione del bene comune per la presente e le future generazioni.
In senso più ampio l’auspicabile ethos globale comporta la possibilità di ridefinire la cittadinanza su
una scala sopranazionale e in chiave democratica, in cui far convivere accanto agli ideali
illuministici e liberali dell’uguaglianza e della libertà, il codice della “fraternità”. Benedetto XVI
nella sua recente enciclica Caritas in veritate vi ha fatto riferimento per indicare come la
costruzione della città dell’uomo si regga non semplicemente sulla giustizia formale, ma anche su
18
Cfr. F. VIOLA, Identità e comunità. Il senso morale della politica, Milano, Vita e Pensiero, p. 58
V.E. PARSI, ‘Governance’ e libertà: la prospettiva dei diritti di cittadinanza, in Globalizzazione: nuove ricchezze
nuove povertà, a cura di L. Ornaghi, Milano, vita e Pensiero, 2001, p. 104. Per le osservazioni seguenti cfr. tutto questo
contributo.
20
Sulla questione della “guerra giusta” illuminanti le riflessioni di D. MIETH, Il ritorno della guerra giusta, in
«Concilium», 37 (2001), pp. 215-219. La ripresa (per certi versi necessaria) dell’impiego della criteriologia della
“guerra giusta”, «che di fronte alle armi scientifiche sembrava aver perso valore come legittimazione della guerra tra le
nazioni», per affrontare le nuove situazioni rende il giudizio etico più complesso e incerto. Resta elusa la modalità
adeguata di affrontare «la guerra quotidiana e incessante della violenza di sistemi globali di dominio […] dove la guerra
viene cotta a fuoco lento e uccide attraverso la negazione di beni vitali o attraverso la mancanza di solidarietà» Il ritorno
alla guerra giusta, non può ritenersi «un mascheramento sofistico della violenza di sistemi globali di dominio?» O, nella
forma di “intervento umanitario” può ambiguamente celare «un’azione selettiva, che sceglie secondo i propri interessi
dove – tra analoghi casi di genocidio – intervenire» O ancora, non potrebbe essere un alibi per una lotta ad effetti e
sintomi, senza affrontare seriamente le cause e i fattori scatenanti la violenza?
19
15
modalità relazionali che mettano in circolazione il bene della gratuità e della solidarietà, superando
il semplice scambio secondo il principio di utilità. Il sapere della fede così può contribuire ad aprire
la prospettiva del senso del vivere sociale alla costruzione di un orizzonte fraterno, là dove le
situazioni della storia o le logiche proprie della civiltà e delle sue forme organizzative tendono a
privilegiare un’asettica equivalenza tra soggetti estranei e autoreferenziali che si rivendicano i
propri spazi di libertà. Questa intuizione, come noto, è una delle chiavi di lettura fondamentali
sottostanti alla Caritas in veritate, là dove si sottolinea l’imprescindibile orizzonte della fraternità,
accanto a quello razionalmente deducibile della libertà e dell’uguaglianza, come modalità
realizzativa della qualità tipicamente umana delle interazioni sociali di cui la fede cristiana conserva
una permanente traccia: «la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli.
La ragione, da sola, è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza
civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità. Questa ha origine da una vocazione
trascendente di Dio Padre, che ci ha amati per primo, insegnandoci per mezzo del Figlio che cosa
sia la carità fraterna» (n° 19). Il punto di accesso fenomenologico – universalizzabile – a questa
forma della relazione risiede nella considerazione del dono che è alla base dell’esistenza di
ciascuno, nella percezione che l’origine di sé risiede dal dono di altri (cfr. Caritas in veritate, n°
34). Questa citazione risulta preziosa sia nella direzione di quella operazione di “traduzione” e
“riconoscimento” di alcune “percezioni etiche essenziali” in vista dell’elaborazione di un consenso
attrono a “convincimenti etici fondamentali”, così come auspicato da Bori, come in quella ricercata
esigenza di costante “rammemorazione” da parte del cristiano di ciò che è al cuore della sua fede e
pure ha decisa importanza nella definizione del bene umano integrale. In questi ambiti domanda di
essere studiata e verificata la capacità di generare un ethos condiviso da parte della “regola d’oro”,
almeno nei termini che si è cercato di mettere in luce nelle note precedenti.
2. La soggettivizzazione degli stili di vita
C’è un altro versante da esplorare, complementare alla complessificazione sociale, riassumibile in
un processo di forte soggettivizzazione degli stili di vita. Le sue radici affondano ugualmente nella
reazione alla cultura degli anni '60, con la sua enfasi sul pubblico che ha contraddistinto un tempo
di forte spinta alla politicizzazione come chiave interpretativa dell’umano e del suo senso nella
storia. In positivo la cultura della soggettività è dunque reazione all’invadenza dei modelli di
costruzione del sé improntati da una logica alla cultura del pubblico, ma anche da tutte le dinamiche
omologanti concepite come limitazioni esterne alla libera espressione dell’io. L’enfasi sul soggetto
antepone al problema del fare e del dovere, la questione della identità, della ricerca di una immagine
di sé cui affidarsi e da tutelare da tutte le forme di interferenza esterna percepite come potenziali
16
minacce alla propria autonomia. L’inevitabile problema che si riversa sull’etica sarà pertanto quello
di una sua comprensione minimale come “arte del vivere”.21 L’espressione è di per sé nobile e
caratterizza un importante filone del pensiero occidentale che si riallaccia direttamente al modello
eudaimonistico della classicità, ma che nell’attuale contesto appare fortemente modulata in una
declinazione che, mettendo da parte ancora una volta la questione del bene, si ripiega al traguardo
più modesto della strategia tesa ad assicurare il benessere e l’equilibrio psico-emotivo del soggetto.
È questo il profilo problematico della cultura della soggettività, là dove si connota nei termini di
un’eccessiva privatizzazione narcisistica e di una lettura spontaneistica del bene. Se la figura ideale
dell’uomo della modernità era Prometeo, attraverso il perseguimento di mete ardite, oggi l’uomo
contemporaneo tende a riflettersi sull’immagine di Narciso: a quello della progettualità incarnata
nell’ideale dell’uomo maturo e adulto succede il profilo adolescenziale dell’io in perenne ricerca di
conferme su di sé. La questione del soggetto ripiegato su di sé, teso alla sua sopravvivenza ha
portato ad una rilettura della questione dell’identità individuale incline ad un tratto autoreferenziale.
Tale lettura condiziona molti aspetti dell’etica della vita affettiva e sessuale, ma anche è operante
nel dibattito bioetico. La diffusa (e preoccupata) attenzione alla soggettività individuale si regge
sull’imperativo “vivi la tua vita”, ma con esso sottintende, più che la ricerca del senso obiettivo che
merita dedizione, il suo darsi e ricercarsi dentro forme di spasmodica attenzione alla qualità dei
processi affettivi. L’auspicio per una vita bella, piena di fascino, interessante, ossessivamente
ripetuto dalla cultura ambiente, finisce così per esporre con maggiore facilità di un tempo
l’individuo ai meccanismi ansiogeni e alle patologie depressive. La ricetta ampiamente divulgata
individua i canoni di una vita riuscità nella possibilità di moltiplicare le esperienze e con esse gli
esperimenti su di sé, pensati come successione paratattica di momenti di vita ad alto tenore emotivo.
La loro riuscita, più che posta a confronto con un idea etica di bene, resta prigioniera di un
superficiale apprezzamento estetico, quello cioè di sensazioni gradevoli e appaganti per il soggetto.
Una descrizione efficate di tale modello è quella offerta da Armido Rizzi: «il riferimento decisivo e
definitorio è dato dall’autoreferenzialità dell’individuo, in tutto l’arco costitutivo della soggettività,
che va dal desiderio come movente all’azione come sua esecuzione. Obiettivo del soggetto
desiderante e agente non è più la creazione di condizioni necessarie di vita, come è stato per
millenni, né il miglioramento di queste condizioni, come nei primi decenni del dopoguerra: è il
progetto di una vita bella, dove situazioni e oggetti e incontri alimentino con continuità l’esistenza
come riuscita e fruizione».22
21
Cfr. a questo proposito anche i recenti contributi di Bauman, sul versante sociologico, e di Hadot su quello filosofico.
Rispettivamente: Z. BAUMAN, L’arte della vita, Roma-Bari, Laterza, 2009; P. HADOT, Ricordati di vivere. Goethe e la
tradizione degli esercizi spirituali, Milano, Raffaello Cortina, 2009.
22
A. RIZZI, L’erba voglio. Dal narcisimo postmoderno al soggetto responsabile, Assisi, Cittadella, 2003, pp. 24-25.
17
Il sostegno antropologico a questa ricerca esperienziale risiede nella dilatazione del desiderio in uno
spazio tuttavia che resta interno all’io e che nella relazione inter-personale finisce per attirare
l’interesse per l’altro ugualmente nel circuito del proprio sé. In questo senso l’evocazione di
Narciso come eroe post-moderno della ricerca di sé risulta particolarmente riuscita. «Nei
comportamenti il singolo soprattutto si cerca, non si spende; attraverso quello che fa cerca, in forme
quasi ossessive, conferme per la propria immagine» (G. Angelini). Nel cercare l’altro da sé, con cui
intessere un dialogo che dà forma all’esistenza, il soggetto continua a cercare se stesso. Questa
ricerca su di sé porta a sperimentarsi ancora di più come un soggetto “precario”. La conferma
spasmodica su di sé contribuisce a rafforzare, mettendola continuamente in circolo, non la propria
identità, ma il simulacro riflesso della propria precarietà psicologica.23 La via per la ricerca della
propria autorealizzazione, “sii te stesso” come vero imperativo categorico del tempo presente, passa
attraverso la ricerca di una identità performativa, cioè rappresentata a partire dagli instabili desideri
soggettivi e dunque componibile, decomponibile e ricomponibile in un gioco adolescenziale che
vuole lasciare aperto davanti a sé indefinite (e dunque mai chiarite) scelte di possibilità, sempre
ritrattabili. Si considera degno di investimento ciò che si connota immediatamente come utile e
soddisfacente il proprio bisogno di autorealizzazione. «Il singolo, per valutare le ragioni di
vantaggio di tutto quello che fa, si affida al criterio del guadagno che quei comportamenti
consentono di realizzare sotto il profilo della soddisfazione emotiva; o come anche si dice con
formula enfatica, sotto il profilo dell’autorealizzazione» (G. Angelini).24 Così sulla base psicologica
del desiderio soggettivo come radice di potere, cioè della possibilità di disporre delle cose, delle
relazioni, delle persone, del potere di scelta, che non deve essere limitato, si salda anche
l’emancipazione dalla tradizione, compresa come fastidiosa interferenza sulla autonomia della
persona e insostenibile eternomia.
Per l’ethos civile risulta importante registrare l’ulteriore evoluzione di questa dinamica. Essa
consiste nell’esasperazione del ricorso alla questione dei “diritti individuali” come via politica e
sociale per il riconoscimento, prevalentemente in chiave rivendicativa, della legittimazione del
proprio desiderio e delle proprie preferenze soggettive. Tale espressione risulta particolarmente viva
nell’ambito delle più delicate questioni bioetiche che attraversano il dibattito contemporaneo che
possono essere accumunate da questa unica matrice che conferisce un assoluto rilievo morale
all’affermazione del diritto di libertà dei soggetti e della loro autodeterminazione.25 Resta da
23
Fratello del mitico Narciso, icona quasi profetica di un modello di esistenza, può anche essere la figura di Peer Gynt,
come nell’omonima piéce teatrale di Henrik Ibsen, con la sua spamodica ricerca di identità e della propria
autorealizzazione condensata nel programma di “essere se stesso”.
24
Cfr. G. ANGELINI, Educare si deve ma si può?, Milano, Vita e Pensiero, 2002.
25
Un altro campo, particolarmente vivo nel dibattito filosofico e sociale, è costituito dalla legittimazione di forme
plurime di identità di genere. Si rimanda P.D. GUENZI, Sesso/genere. Oltre l’alternativa, Assisi, Cittadella, 2011.
18
dubitare se un eventuale etica civile debba sposare in toto questo tipo di rivendicazione in cui
l’enfasi è posta su una forte soggettivizzazione dei diritti, fino a snaturare la loro originaria matrice
implicante non la frammentazione del tessuto sociale nella autorizzazione alla pura realizzazione
delle legittime preferenze individuali, bensì in chiave di tutela di ciò che è risulta essere degno per
ogni uomo e per le giuste relazioni tra i differenti soggetti umani. Nella accentuazione della
condivisione dell’umano che è in comune, come base auspicabile per un etica civile, i diritti non
sono da comprendere come espressione di rivendicazione dell’individuo nei confronti di altri e della
società, esasperando la chiave della conflituttalità, ma alla luce di quel riconoscimento reciproco
che lega i soggetti umani nella forma originaria di una responsabilità condivisa. Ugualmente non
può essere taciuta una particolare deriva conseguente all’esasperazione della risoluzione dei
problemi posti dalle relazioni interpersonali e societarie nella chiave dei puri diritti pensati in chiave
individuale. A ragione Armido Rizzi parla di una dinamica “implosiva” connessa all’affermazione e
all’allargamento della mediazione dei diritti individuali come unica e risolutiva chiave dei rapporti
sociali, palesando così la manifestazione di interne contraddizioni e difficile compatibilità tra
diversi ambiti applicativi e normativi. 26 Non è secondario rileggere la stessa evoluzione dei diritti
umani come un processo ugualmente involutivo, ben vivo negli accesi dibattiti pubblici, che ne
muta la consistenza profonda in “diritti delle differenze” e non più quali elementi di tutela della
dignità dell’umano che è comune. Come riferisce opportunamente Antonio Pieretti «così concepito,
il riconoscimento dei diritti inalienabili dell’uomo assume la forma inquietante della legittimazione
dei suoi bisogni e dei suoi desideri, senza alcuna mediazione sociale e con la conseguenza di
rendere assai problematica la convivenza civile» o una stessa convergenza condivisa
comunitariamente su un “bene comune”.27
Sul versante della riflessione teologica, che nell’elaborazione del suo discorso non può non tener
conto della rapida assimilazione a livello di “sentire comune” di stili di vita e comportamenti
difformi rispetto alle indicazioni normative proposte dal magistero, come vistosamente percepibile
nell’ambito della sessualità, della vita affettiva e famigliare, ma ormai in modo più diffuso a
riguardo delle stesse indicazioni legate alla bioetica, l’auspicato contributo di questo sapere ad un
ethos civile raccomanda una previa chiarificazione della qualità della propria parola. L’impressione
è, a riguardo, di una accentuazione unilaterale sul codice normativo, ulteriormente allargata ad un
ritorno al gusto casistico impegnato ad una capillare declinazione dell’imperativo morale all’interno
di sempre nuove situazioni legate allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni
tecnologiche. Questo andamento è chiaramente riscontrabile nell’ultimo documento emanato dalla
26
Cfr. RIZZI, Oltre l’erba voglio, p. 78.
A. PIERETTI, Per un nuovo paradigma della convivenza civile. Il bene oltre la giustizia, in «Humanitas», 61 (2006),
pp. 628-629.
27
19
Congregazione per la dottrina della fede, l’istruzione Dignitatis personae del 2009, predisposto
come aggiornamento del primo autorevole documento in materia di procreazione assisitita di
vent’anni prima, la Donum vitae, e alla luce della enciclica Evangelium vitae del 1995. Il
documento si sofferma, ripetendo un lessico normativo già ampiamente conosciuto, ma non
ulteriormente argomentato, su alcune pratiche meritevoli di valutazione emergenti dall’evoluzione
delle scienze medico-biologiche. Pressoché assente risulta l’attenzione ad una riflessione di fondo,
soprattutto di fattura teologica, mentre il piano discorsivo cerca un andamento prevalentemente
ritagliato su condivisibili “argomenti di ragione”, con la costante applicazione degli asserti
normativi ai nuovi “casi”. Così congegnato il documento vaticano non contribuisce certo ad
riavviare la riflessione e il confronto con altre prospettive di pensiero. Piuttosto a rinforzare
l’opinione dell’invetibaile scarto, non ricomponibile, tra la morale cattolica e quella “laica”. Non ci
si doveva aspettare certo, questa è piuttosto la prospettiva di analisi mass-mediatica, aperture
rispetto alla precisione definitoria già chiaramente delineata da Donum vitae. Piuttosto
l’impostazione di un discorso che potesse introdurre una nuova forma discorsiva, maggiormente
tesa ad esplicitare il logos, cioè il senso degli eventi umani connessi alle pratiche rese disponibili
dagli sviluppi delle tecno-scienze, rispetto ad una semplice ripetizione del nomos. Questo nella
convinzione che ogni buon discorso normativo, anche quello più raffinato operato sulle questioni
bioetiche, deve continuamente ricollegare situazioni estremamente sofisticate, quelle generate dalle
possibilità aperte dallo sviluppo della scienza, all’evidenza del mondo della vita, riportando a livello
fenomenologico ed esistenziale quello che attraverso il linguaggio e l’operazione tecnica,
inevitabilmente, è compreso all’interno dei parametri di una specifica razionalità e operatività. Un
buon contributo ad un’etica civile, da parte del pensiero cristiano, nell’ambito bioetico, si situa
allora nella capacità di ridare spessore ad un discorso che sappia dire o delineare il senso buono di
quegli eventi umani ormai inevitabilmente connessi alla modificazione tecnologica della vita.
Quell’evidenza originaria di senso che richiede di essere riespressa per non essere annullata, bensì
da ritrovare anche nella logica e nella pratica della ragione tecno-scientifica.28 In sostanza, anche
grazie alla sapienza attingibile dalle scritture ebraico-cristiane, è possibile introdurre in modo più
convinto a percorsi di “significazione” che appaiono oggi necessari e previ ad ogni sforzo di
“normazione” nella ambito della vita umana.
Questa operazione corrisponde certamente al codice nativo dello stesso discorso teologico, e
dunque tipicamente cristiano, là dove non è sottoposto immediatamente alla pressione quasi ansiosa
di riempire un vuoto legislativo, cui comunque occorre dare risposta. Una riflessione che percorra
28
Uno sforzo in tal senso è abbozzato, a partire dalla riflessione epistemologica di E. Agazzi, in P.D. GUENZI, Appunti
per un ripensamento della categoria di limite alla luce del pensiero di Evandro Agazzi, in Quale uomo per quale cura?
Argomenti per una clinica etica, a cura di A. Filiberti, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 119-142.
20
con maggiore evidenza e pertinenza la via lunga di un più ponderato e profondo ancoraggio del
nomos al logos. Ciò inoltre potrà permettere anche di comprendere come la parola evangelica riesca
non solo a ritornare sul senso buono e ovvio della vita umana, dal nascere al morire, ma consenta
anche di essere parola critica, perché illuminante e non semplicemente giudicante, cioè capace di
de-situarsi rispetto alla cultura ambiente per introdurre un punto di vista altro che possa consentire
di cogliere con maggiore profondità quanto, relativamente a tali eventi e al loro senso, può correre il
rischio di essere soffocato dal continuo riproporsi di discorsi ben conosciuti e inevitabilmente precompresi. L’accesso alla norma deve procedere a partire dalle forme effettive del costume e della
cultura, anche se il logos che le fonda, e dunque conferisce loro una particolare forza espressiva,
supera le evidenze accreditate da ogni interpretazione culturale. Anzi il logos si pone come
elemento di permanente valutazione critica di una normativa che possa accreditare culturalmente
interpretazioni discostanti sensibilmente dall’evidenza del “principio”. La correlazione da rendere
maggiormente visibile tra logos e nomos, a fronte del possibile rischio di enfatizzazione della
dimensione normativa, oltre che apparire un utile servizio di tipo sapienziale e riflessivo
raccomandato dallo stesso bisogno di etica civile, mi sembra anche riesca a interpretare con
maggiore fedeltà l’attenzione dovuta dal discorso teologico alle sue fonti specifiche, con un atto di
lettura della Parola di Dio in grado di rispettarne l’indole profonda.
Per un epilogo narrativo…
Ragionando sul contributo della teologia ad un etica civile, pur rimanendo semplicemente alla
periferia di un discorso che merità ben altra acutezza, ci siamo imbattutti nella complessità sociale e
nella soggetivizzazione degli stili di vita, nella necessità di riattivare percorsi di memoria condivisa,
nella capacità di accedere a ciò che accumuna l’umano prima e in modo più profondo rispetto ad
ogni attribuzione consensualmente stabilita, nella capacità di lettura di convincimenti etici
fondamentali, nella loro traducibilità e dunque comprensione a partire da differenti tradizioni, di
una forma plurale dell’etica che non si limiti a registrare come insuperabile il pluralismo delle
etiche, in percorsi di “significazione” su cui impegnarsi senza cadere nell’illusione casuistica di una
capacità di “normazione” integrale della vita. Il tutto a partire da quell’esigenza di una società
“stretta”, per riprendere Leopardi, cioè coesa dalla stima reciproca dei suoi membri, che deponga
l’inevitabile profilo di conflittualità, quella che ancora attraversa gli inconcludenti dibattiti pubblici
su ciò che è bene e su ciò che male, su ciò che è giusto e su ciò che ingiusto.
Mi sono reso conto che tutto il discorso è stato solo un ampliamento di ciò che nella sua
insuperabile capacità evocativa, Italo Calvino aveva attribuito come profilo caratteristico di una
delle sue “città invisibili”: la sottile Zenobia, intrico di palafitte e di scale sospese a collegamento
21
tra gli edifici, proiezione assai suggestiva della complessità contemporanea. La visibilizzazione di
questo profilo urbano nella limpida prosa calviniana è un invito ad abitare una città complessa.
Quella complessità che ha portato a continue rielaborazioni del disegno iniziale, fino a rendere
estremamente difficile distinguere un orizzonte di significati condivisi e un progetto comune o che
può correre il rischio di dimenticarlo per sempre. Eppure sempre una “città”: una forma umana di
vita ancora in grado di poter abbracciare un senso che motivi la vita di ciascuno e quella di tutti.
Una città in cui sia tuttora meritevole di dedizione l’impegno di definire criteri per misurare una
esistenza ad altezza della dignità delle persone. Così come nel profondo di Zenobia continua a
pulsare l’intuito originario, nonostante la città ormai si sia elevata molto dal suolo e si sorregga su
equilibri affidati a disparate tecniche costruttive, che ne mettono sempre alla prova la sua stabilità.
Nella speranza che tale “città invisibile”, eppure presente, non diventi una “città invivibile”. Perché,
ricorda Calvino, i nostri desideri possono arrivare a distruggere la città e la vita. Ma anche perché il
nostro modo di vivere nella cità può portarci a cancellare i nostri desideri profondi e quella verità di
cui ancora portiamo le tracce. In fondo ogni abitante di Zenobia, quando indica in cosa consista il
buon vivere umano, non potrà che richiamarsi a questa città, pur agognando alla sua perfezione:
«Ora dirò della città di Zenobia, che ha questo di mirabile: benché posta su terreno asciutto essa
sorge su altissime palafitte, e le case sono di bambù e di zinco, con molti ballatoi e balconi, poste a
diversa altezza, su trampoli che si scavalcano l’un l’altro, collegate da scale a pioli e marciapiedi
pensili, sormontate da belvederi coperti da tettoie a cono, barili di serbatoi d’acqua, girandole
marcavento, e ne sporgono carrucole, lenze e gru. Quale bisogno o comandamento o desiderio abbia
spinto i fondatori di Zenobia a dare questa forma alla loro città, non si ricorda, e perciò non si può
dire se esso sia stato soddisfatto dalla città quale noi oggi la vediamo, cresciuta forse per
sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno. Ma quel che è certo è che chi
abita Zenobia e gli si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre una città come
Zenobia che egli immagina, con le sue palafitte e le sue scale sospese, una Zenobia forse tutta
diversa, sventolante di stendardi e di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo
modello. Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle
infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, ma in altre due: quelle che
continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i
desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati».29
29
I. CALVINO, Le città invisibili, 1972: Milano, Mondadori, 2009, pp. 34-35.
22