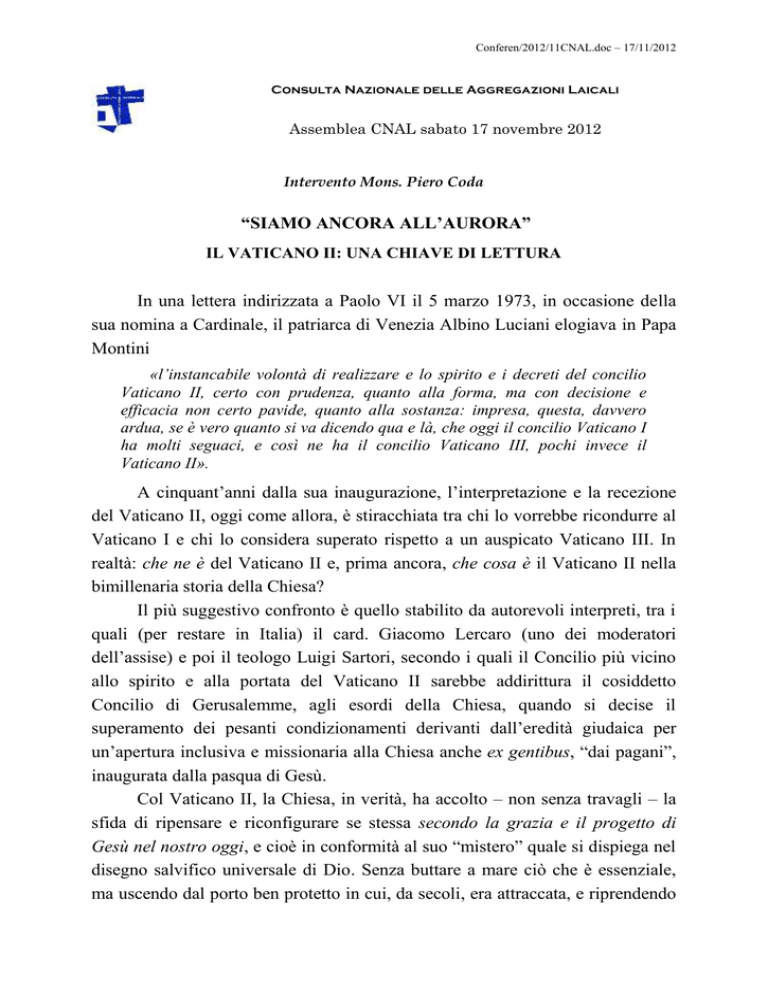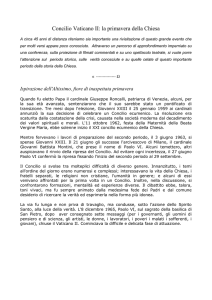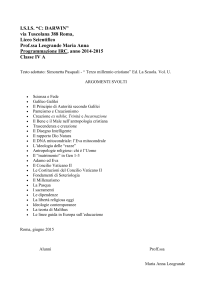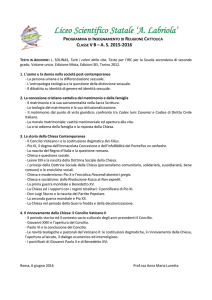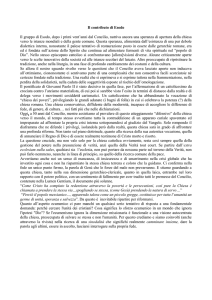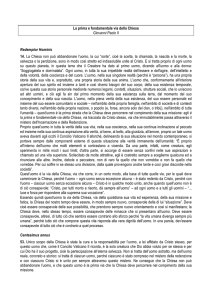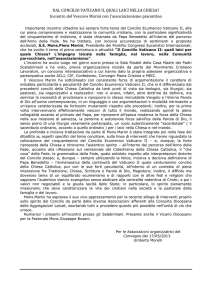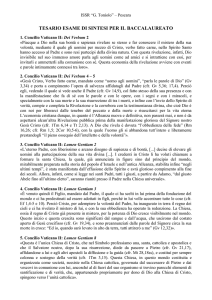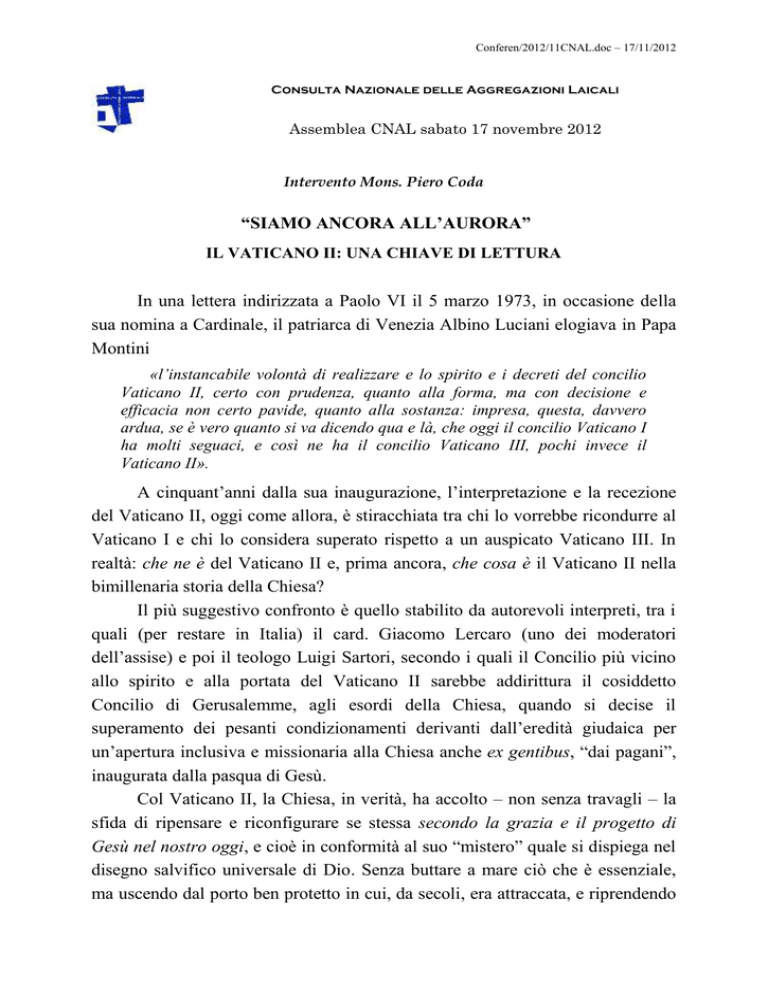
Conferen/2012/11CNAL.doc – 17/11/2012
Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali
Assemblea CNAL sabato 17 novembre 2012
Intervento Mons. Piero Coda
“SIAMO ANCORA ALL’AURORA”
IL VATICANO II: UNA CHIAVE DI LETTURA
In una lettera indirizzata a Paolo VI il 5 marzo 1973, in occasione della
sua nomina a Cardinale, il patriarca di Venezia Albino Luciani elogiava in Papa
Montini
«l’instancabile volontà di realizzare e lo spirito e i decreti del concilio
Vaticano II, certo con prudenza, quanto alla forma, ma con decisione e
efficacia non certo pavide, quanto alla sostanza: impresa, questa, davvero
ardua, se è vero quanto si va dicendo qua e là, che oggi il concilio Vaticano I
ha molti seguaci, e così ne ha il concilio Vaticano III, pochi invece il
Vaticano II».
A cinquant’anni dalla sua inaugurazione, l’interpretazione e la recezione
del Vaticano II, oggi come allora, è stiracchiata tra chi lo vorrebbe ricondurre al
Vaticano I e chi lo considera superato rispetto a un auspicato Vaticano III. In
realtà: che ne è del Vaticano II e, prima ancora, che cosa è il Vaticano II nella
bimillenaria storia della Chiesa?
Il più suggestivo confronto è quello stabilito da autorevoli interpreti, tra i
quali (per restare in Italia) il card. Giacomo Lercaro (uno dei moderatori
dell’assise) e poi il teologo Luigi Sartori, secondo i quali il Concilio più vicino
allo spirito e alla portata del Vaticano II sarebbe addirittura il cosiddetto
Concilio di Gerusalemme, agli esordi della Chiesa, quando si decise il
superamento dei pesanti condizionamenti derivanti dall’eredità giudaica per
un’apertura inclusiva e missionaria alla Chiesa anche ex gentibus, “dai pagani”,
inaugurata dalla pasqua di Gesù.
Col Vaticano II, la Chiesa, in verità, ha accolto – non senza travagli – la
sfida di ripensare e riconfigurare se stessa secondo la grazia e il progetto di
Gesù nel nostro oggi, e cioè in conformità al suo “mistero” quale si dispiega nel
disegno salvifico universale di Dio. Senza buttare a mare ciò che è essenziale,
ma uscendo dal porto ben protetto in cui, da secoli, era attraccata, e riprendendo
2
con coraggio – e rischio – il mare aperto, le vele spiegato al soffio dello Spirito:
“Duc in altum!”, come esorta Giovanni Paolo II nella Novo millennio ineunte.
Nonostante l’impressione prevalente di stanchezza e disillusione che, almeno nei
paesi di antica cristianità, sembra oggi la prevalente.
Ma occorre guardare a ciò che pulsa nel profondo, sotto la superficie delle
apparenze, e che attesta anche oggi l’agire il più delle volte nascosto e in ogni
caso sempre discreto, ma efficace e tempestivo dello Spirito Santo. Davvero – lo
intuiva Giovanni XIII – il Vaticano II segna l’annuncio di una primavera: anzi di
una “nuova Pentecoste”. Una definizione grossa: quanto mai promettente (da
Dio) e impegnativa (per noi)
1. La domanda da cui partire, forse – anche perché si tratta ancor oggi di
vexata quaestio con evidenti e rilevanti conseguenze, a tutti i livelli –, è la
seguente: il Vaticano II è un Concilio teologico?
Rispondo con forza e convinzione di sì. Penso infatti che la difficile e
contrastata vicenda – tuttora in corso – della recezione del suo slancio ispiratore
e delle sue concrete direttrici di marcia lo stia a testimoniare.
Il Vaticano II è, dunque, Concilio teologico e lo è in sommo grado: non
tanto perché definisce delle verità teologiche prima non definite (cosa che non
fa), ma perché invita a una conversione complessiva dello sguardo e dell’azione.
Più teologico di così!
Si tratta di conversione – nell’essere Chiesa e nell’essere cristiani – che
nasce dal puntare dritti gli occhi del cuore e della mente verso il centro sempre
vivo della rivelazione di Dio in Cristo Gesù. Conversione, dunque, nel senso
originario del termine: quello per cui l’impatto col vangelo di Gesù trasforma
appunto il cuore e la mente, e l’indirizza altrimenti. Segnando un nuovo inizio.
Non perché interrompa o tradisca la tradizione da cui viene e di cui si alimenta.
Ma perché proprio così, facendo vivere il nucleo vivo e perenne della tradizione
oggi qui, per noi, ne attualizza la verità e la virtualità evangelica.
Quando Giovanni XXIII paragonava l’evento conciliare a una “nuova
Pentecoste”, penso, intuiva proprio questo. Con tutta probabilità non rendendosi
conto in tutto di ciò che lo Spirito Santo, grazie al gesto imprevisto della
convocazione del concilio che gli aveva suggerito, stava per mettere in moto.
3
Tanto che, considerando la portata dell’avvenimento e delle sue
conseguenze, pur essendo già stato fatto molto, vien da dire che il più, con
probabilità, ancora resta da accogliere (da Dio) e da fare (per noi).
2. Certo, il Concilio, nell’intenzione impressagli da Giovanni XXIII e poi
nella sapiente, difficile e persino tormentata guida esercitata nella sua fedele e
perseverante esecuzione da Paolo VI, in prima battuta, aveva una finalità che, in
senso lato, era stata definita – per esprimerne l’originalità – pastorale. Si
trattava, per Giovanni XXIII, di “aggiornare” il “linguaggio” della vita e della
dottrina della Chiesa al mutato contesto sociale e culturale, sapendovi cogliere le
provocazioni di Dio stesso, i “segni dei tempi”. Paolo VI precisò il tiro,
focalizzando il discorso sulla identità, ad intra, e sulla missione, ad extra, della
Chiesa.
Ma basta leggere con attenzione l’enciclica programmatica del suo
pontificato, l’Ecclesiam suam (1964), per rendersi conto dell’ispirazione più
profonda che Papa Montini ha avuto la grazia di cogliere e incanalare
nell’evento conciliare.
Si trattava di risvegliare, in disarmato ascolto del soffio dello Spirito e in
attento discernimento dei segni dei tempi, la coscienza stessa della Chiesa al
dono e alla vocazione da cui è nata, e sempre di nuovo nasce, al cuore del
mondo, per rendervi presente il Vangelo di Gesù in quanto fermento destinato a
lievitare tutta la pasta. Offrendo la sua riflessione ai Padri del Concilio, che
ormai si avviava verso la conclusione, Paolo VI cercava così d’interpretare
l’anima e la direzione che lo Spirito Santo aveva impresso ai lavori.
Il fatto è che il Concilio, volendo tener conto, da un lato, del significato
originario e permanente dell’evento di Gesù e riandando perciò alle sue “fonti”;
e, dall’altro, della situazione inedita in cui si trova, nell’oggi, la storia, si è visto
spinto a reimpaginare la comprensione e la proposta dell’esperienza e
dell’annuncio della Chiesa. Cosa che, senz’altro, è qualcosa di molto più
radicale e impegnativo di un semplice aggiornamento del linguaggio.
Lo dice, quasi en passant, il n. 11 del decreto Unitatis redintegratio, con
un’affermazione che è tanto importante da essere stata poi riconosciuta come
uno, se non “il” principio architettonico del Catechismo della Chiesa Cattolica:
«Nel mettere a confronto le dottrine si ricordino (i teologi cattolici) che esiste un
4
ordine o “gerarchia” nelle verità della dottrina cattolica, in ragione del loro
differente rapporto col fondamento della fede cristiana».
Il senso di quest’affermazione va ben compreso. Perché dire che si dà un
centro generatore e irradiante della verità della fede – che è Gesù Cristo stesso,
in quanto rivelatore e comunicatore, nel suo Spirito, del Padre/Amore, come
lapidariamente afferma la Dei Verbum ai nn. 2 e 7 –, significa, di concerto,
rimarcare che la coscienza credente, come tale, ha da essere investita e plasmata,
sin nelle fibre più profonde del suo essere, pensare ed agire, da questo centro.
Così da diventarne in tutto e solo veritiera ed incisiva testimone.
Il che, appunto, postula e propizia un nuovo inizio.
3. Di che si tratta? In sintesi direi così: del passaggio da un accesso alla
verità della fede come dato prevalentemente oggettivo, come verità da
accogliere, a un’assunzione e valutazione della stessa nella sua rilevanza anche
soggettiva e cioè antropologicamente rilevante e incisiva, e cioè come verità “da
fare” nella carità (cf. Ef 4,15).
Non che in passato questo non fosse presente. Tutt’altro. Il Vangelo di
Gesù, il Vangelo che è Gesù, anzi, è accaduto come eccedente e straordinaria
accensione della libertà dell’uomo che intero si consegna, nel Figlio, all’Abbà
per vivere l’amore ai fratelli secondo la forma e la vocazione dell’avvento del
Regno come koinonia dei molti in Cristo Gesù. E ciò grazie all’elargizione smisurata dello Spirito di Dio, nel cuore degli uomini, come principio sempre
nuovo, della loro libertà e della loro dedizione.
Il corso della storia ha poi esigito – e necessariamente o, meglio,
provvidenzialmente – che venissero sanciti i segni sacramentali, le formule
dottrinali e le strutture istituzionali capaci di veicolare il verbo cristiano. Ecco
il frutto dei Concili a contenuto trinitario e cristologico del primo millennio ed
ecco ciò che, nel secondo millennio, soprattutto il Concilio di Trento e il
Concilio Vaticano I hanno evidenziato a proposito della natura sacramentale e
del profilo gerarchico della Chiesa. Con risultati senz’altro preziosi e
irrinunciabili. Ma anche col rischio d’irrigidire i guadagni così acquisiti,
sottovalutando o persino obliando la loro natura di mezzo e non di fine.
Tanto che la modernità si configura, almeno in uno dei suoi filoni
qualificanti, come l’invocazione tormentata, a fronte di questa esibizione netta
5
dell’oggettività, della dignità e dei diritti del soggetto. Che, peraltro, erano
impliciti nel deposito così gelosamente formulato e custodito dalla Chiesa: ma
che era necessario esprimere e declinare esplicitamente in prospettiva
antropologica e storica.
È questa, a ben vedere, l’istanza della modernità: in essa instillata dal
cristianesimo stesso, al di là della sistemazione luminosa ma provvisoria della
cristianità medioevale. Risultando però tale istanza genuinamente cristiana
sganciata – a motivo dell’aspra conflittualità innescatasi tra la cultura moderna e
la Chiesa cattolica – dalla sua vera sorgente, Gesù Cristo era inevitabile la sua
esiziale deriva nell’assolutizzazione della soggettività, la quale, privata del vitale
riferimento all’oggettività della verità e della giustizia, non poteva non sfociare
nel totalitarismo e nel nichilismo.
A livello culturale e prima spirituale, e di conseguenza anche sociale, è
questo l’enorme compito che attendeva al varco la Chiesa cattolica e che, già
nell’’800, uomini specchiati di Chiesa e acuti e profetici intellettuali cristiani del
calibro di Antonio Rosmini e John Henry Newman avevano messo in conto,
offrendo prospettive preziose per una sua pertinente e coraggiosa esecuzione.
Ma i tempi non erano maturi.
Nel ’900, nell’alveo del vasto e pluriforme movimento di ritorno alle fonti
e di dialogo – nel discernimento critico – con la modernità, che ha interessato
tutto il mondo cristiano, è stato probabilmente Karl Rahner ad aver più
acutamente avvertito questa esigenza, offrendo in proposito anche delle precise
direttrici di marcia. Ma non bisogna dimenticare, tra i teologi, Karl Barth e Hans
Urs von Balthasar, Pavel Florenskij e Sergej Bulgakov, Dietrich Bonhoeffer,
Henri de Lubac, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu... Senza dire di Teresa
di Lisieux, l’unico Dottore della Chiesa della contemporaneità, e di testimoni
grandi dello spirito come Edith Stein e Simone Weil – tutte donne! A proposito
del Concilio, ad esempio, Rahner ha affermato:
«Questo Concilio si può chiamare pastorale in quanto non si è
accontentato solamente di formulare o presentare principi fondamentali e
perenni della Chiesa, il suo dogma, la sua morale e, su questa base, le norme
giuridiche per la vita della Chiesa, ma ha avuto anche il coraggio di dare le
sue direttive in vista di una situazione concreta: direttive che hanno quasi un
carattere carismatico, che non sono avulse dai principi e dalle norme
generali, ma che si impongono per un certo imperativo concreto in situazioni
concrete e che quindi impegnano la libertà e le responsabilità degli uomini di
6
Chiesa. (...) Il Concilio è il Concilio dell’inizio dei tempi nuovi e in questo
modo è “l’inizio dell’inizio” che deve essere attuato nella Chiesa
postconciliare»1.
4. In realtà, il Vaticano II o, meglio, l’azione dello Spirito Santo in esso è
andato al di là della percezione e della messa sul tappeto di questa decisiva
istanza.
Perché – lo dico con una formula breve, di cui cercherò di esibire la
fondatezza – la coniugazione organica e profonda, nella luce dell’evento di Gesù
Cristo, dell’oggettività e della soggettività della verità chiedeva di rinvenire, per
essere realizzata, un adeguato spazio di mediazione: l’intersoggettività o se
vogliamo, in senso più ampio e dispiegato, l’ecclesialità e la socialità come vita
dispiegata dei molti in Cristo Gesù nello spazio di luce della vita della
Santissima Trinità.
Ecco la tesi interpretativa che intendo proporre. Ma andiamo per ordine,
compiendo due passi.
a) Primo passo. Il tornante decisivo che descrive il significato teologico
del Vaticano II è quello guadagnato col concetto specificamente teologico di
rivelazione descritto dalla Dei Verbum che, al suo proprio livello, trova
riscontro nel “senso teologico della liturgia” disegnato nella Sacrosanctum
Concilium. In tale concetto, infatti, il disegno e l’avvenimento della salvezza
sono proposti nell’ottica della comunicazione trinitaria che Dio fa di se stesso –
niente di meno che Se stesso! – all’uomo e alla sua storia. Il che significa, in
buona sostanza, che Dio mostra il suo volto di Abbà nel Figlio fatto carne, il
quale partecipa così la grazia e la responsabilità della sua stessa vita filiale – non
di meno – nella gratuita e sovrabbondante elargizione a noi del suo Spirito di
verità e giustizia nell’amore.
Non dobbiamo sottovalutare il decisivo portato teologico e antropologico
che è veicolato dal linguaggio scelto con cognizione di causa dal Concilio per
esprimere questa verità. Dio – dice la Dei Verbum –, per realizzare il suo
disegno di salvezza propter nos homines et propter nostram salutem,
s’intrattiene con noi come amici per invitarci alla piena comunione con sé (cfr.
Dei Verbum, 2). Quest’affermazione, a livello teologico, è il principio che
K. Rahner, Il Concilio Vaticano II, in I Documenti del Concilio Vaticano II (Testo latino – italiano),
Edizioni Paoline, Roma 1967, pp. i-xxiv, qui pp. xv-xvi.
1
7
permette di eseguire la corrispondente e necessaria affermazione, a livello
antropologico, che troviamo enunciata nel documento forse più importante (a
parere di Papa Ratzinger) del Concilio, la Dichiarazione Dignitatis humanae
sulla libertà religiosa: che tratta della vocazione originaria e, di conseguenza,
del diritto inalienabile della persona ad autodeterminarsi in libertà nella sua
relazione a Dio e alla sua rivelazione. Se non si coglie questa precisa
corrispondenza, non si esplicita l’intrinseca implicazione soggettiva
dell’oggettività della rivelazione.
Per richiamare il linguaggio usato da Giovanni Paolo II nella Dives in
misericordia, il principio teologico più importante del Vaticano II sta, a partire
di qui, nella coniugazione tra i “diritti” di Dio e i “diritti” dell’uomo, tra il
teocentrismo medioevale e l’antropocentrismo moderno (cfr. n. 1). Ciò diventa
possibile perché il Concilio guarda a Gesù Cristo come al “mediatore” e alla
“pienezza” di tutta la rivelazione (cfr. Dei Verbum, 2), descrivendolo come colui
che, vero Dio e vero uomo, «rivelando il mistero del Padre e del suo Amore,
svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima
vocazione» (Gaudium et spes, 22). È così aperto, e in una chiave cristologica
trinitariamente eseguita, il compito di dare il via all’articolazione pertinente
dell’oggettività della verità con la libertà della sua corrispondenza soggettiva.
Dio e l’uomo uniti e distinti in Cristo e, per e in lui, nella storia umana e nel
destino della creazione.
b) Ma, secondo passo, – come anticipavo – ciò non sarebbe sufficiente se
così non si desse un adeguato fondamento teologico, nella medesima prospettiva
cristologica, alla relazione tra le persone in Cristo e al convergente loro
impegno nel sociale. Secondo il Concilio, in effetti, un’adeguata esposizione del
significato redentivo e plenificante dell’evento di Gesù Cristo implica che non
sia salvato solo l’individuo ma, insieme a lui e grazie a lui, anche la relazione
sociale.
Ecco dunque, in Cristo, la verità trinitaria e cioè agapica della persona
non solo in divinis ma anche in humanis. In questo senso preciso e
discriminante, trova esecuzione (principiale), nel Vaticano II, la delineazione di
un’antropologia trinitaria che intende programmaticamente corrispondere alla
cristologia e alla dottrina trinitaria definita dai Concili del primo millennio.
Basti ricordare, in proposito, quanto affermato da Gaudium et spes, 24, un testo
8
che, al dire di Giovanni Paolo II (cfr. Dominum et vivificantem, 59), sintetizza il
profilo dell’antropologia cristiana come compito determinante del nostro tempo:
«Il Signore Gesù, quando prega il Padre perché “tutti siano una cosa
sola, come io e tu siamo una cosa sola” (Gv17,21), aprendoci prospettive
inaccessibili alla ragione umana, ci ha suggerito una certa similitudine tra
l'unione delle Persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e
nell'amore. Questa similitudine manifesta che l'uomo, il quale in terra è la
sola creatura che Iddio abbia voluto per se stesso, non possa ritrovarsi
pienamente se non attraverso un dono sincero di sé».
Con ciò, in effetti, la relazione sociale, in quanto costitutiva e perciò
espressiva dell’essere persona in Cristo, assume definitivamente consistenza
teologica e salvifica. Ed essendo mediata, antropologicamente, dalla libertà, e,
teologicamente, dallo Spirito Santo, destituisce di ogni fondamento tanto
l’attitudine della fuga mundi quanto quella d’ogni integrismo presuntivamente
cristiano.
Ecco, dunque, lo straordinario e provvidenziale posto del Vaticano II nella
bimillenaria storia della Chiesa. Nei primi secoli essa è riuscita a esprimere
dottrinalmente, con l’assistenza dello Spirito Santo, i grandi dogmi che
concernano il Cristo e la Trinità, i due pilastri della fede cristiana. Ma queste
verità di fede non erano ancora riuscite a diventare ciò che sono: e cioè delle
verità anche antropologiche e di prassi. Delle verità anche storiche e sociali,
dunque, delle verità “da fare” nella carità. È questo il compito che lo Spirito
Santo, attraverso il Vaticano II, affida alla Chiesa oggi.
5. Quali, in sintesi, le direttive di marcia, per la Chiesa, a partire da questa
conversione teologica dello sguardo su Dio e sull’uomo?
Benedetto XVI parla di “riforma nella continuità”: dove “continuità”
sottolinea il radicamento vivo nella traditio, secondo la prospettiva più sopra
esplicitata, e “riforma” dice la necessità ineludibile e rischiosa dell’apertura al
novum chiesto dallo Spirito Santo e dalla sua presenza alla storia dell’uomo. Mi
limito a richiamare appena tre linee maestre di questo impegno di rinnovamento
messo in moto dal Concilio e che, a cinquant’anni dal suo esordio, chiede un
consapevole e lungimirante rilancio.
9
a) La prima linea maestra concerne la comprensione del significato
evangelico e l’esercizio dello stile evangelico nella presenza e nell’azione dei
cristiani nel mondo.
Può sembrare strano mettere l’accento, innanzi tutto, su questo fatto: ma,
in verità, il primo obiettivo verso il quale lo Spirito Santo ha spinto il Concilio è
stato quello di far riguadagnare ai cattolici l’apprezzamento e il gusto della loro
azione di trasformazione della storia nella luce, appunto, di Gesù Cristo “uomo
nuovo”.
Ciò, del resto, è in sintonia con l’atto di autocoscienza cui la Chiesa di
Cristo è sollecitata, con urgenza, dallo Spirito Santo in rapporto alla “nuova età
della sua storia” che oggi vive l’umanità (cfr. GS 4). Il che provoca a un
consapevole e responsabile riposizionamento della Chiesa in questa inedita
situazione.
In quest’ottica è dato di apprezzare, nella sua effettiva portata profetica e
insieme nella sua auspicabile incidenza pratica, la descrizione della Chiesa
offerta al n. 1 della Lumen gentium, secondo cui «la Chiesa è in Cristo come un
sacramento, e cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di
tutto il genere umano». Descrizione non a caso ripresa dalla Gaudium et spes nel
contesto dell’illustrazione della missione della Chiesa nel mondo
contemporaneo: «la forza che la Chiesa riesce a immettere nella società umana
contemporanea consiste in quella fede e carità portate ad efficacia di vita, e non
esercitando con mezzi puramente umani un qualche dominio esteriore» (n. 42).
Ciò che discende da questa prospettiva, in ordine al rapporto tra comunità
ecclesiale e società civile, in ordine al significato dell’impegno storico dei
credenti, e in ordine a una pertinente comprensione e gestione dell’autonomia
delle realtà terrene è troppo evidente per essere qui richiamato in dettaglio.
Resta da rimarcare che questa, e non altra, è la misura di una matura ed incisiva
valutazione della qualità dell’impegno ecclesiale in questo decisivo ambito della
sua missione.
b) La seconda linea maestra concerne la riforma nella Chiesa. E sì: perché
il riposizionamento della Chiesa nella storia, in ascolto del dipanarsi nell’oggi
del mistero della salvezza nel senso paolino del termine, chiede che la Chiesa ad
10
intra sia per prima plasmata, nella fedeltà a Gesù Cristo, dal soffio rinnovatore
dello Spirito.
Dopo il Concilio, in effetti, se, da un lato, non è mancata la tentazione di
gettar via con l’acqua sporca anche il bambino, e cioè di mettere tra parentesi,
nella furia del rinnovamento, non solo ciò che è accidentale e mutevole ma
anche ciò che è essenziale e permanente; dall’altro, non è mancato lo strabismo
di chi ha teorizzato come possibile il rinnovamento della missione della Chiesa
senza il corrispondente rinnovamento della sua vita.
Tale strabismo è lungi dall’essere archiviato. E invece, nell’intenzione,
nello spirito e nel dettato del magistero conciliare, il rinnovamento evangelico
della Chiesa essenziale e irrinunciabile e chiede d’essere attuato, con equilibrio e
determinazione. In caso contrario, quale significato concreto può ancora avere,
ad esempio, la discriminante scelta conciliare dell’ecclesiologia del popolo di
Dio e della comunione, della dignità e del ruolo specifico dei laici e delle donne
in particolare, del valore ecclesificante della dimensione carismatica nella sua
efficacia spirituale e storica?
Vi sono stati, certo, segnali importanti, ma siamo lungi dall’aver aperto i
cantieri della sperimentazione ecclesiale e della verifica teologica in queste
direzioni. Per un esempio soltanto, la categoria della sinodalità che, pur non
trovando posto nel dettato conciliare, ne esprime al meglio l’impulso nel senso
della corresponsabilità e della partecipazione, a tutti livelli di governo e di
esercizio della vita ecclesiale, si mostra a tutt’oggi come la decisiva cruna
dell’ago attraverso cui deve passare la riforma della Chiesa in una prospettiva
che sia, al tempo stesso, sinceramente e irrinunciabilmente ecumenica.
Ciò che teologicamente risulta decisivo è la necessità d’interpretare in
modo coerente all’avvento escatologico del Regno di Dio in Cristo la qualifica
di hierarchica che è stata riconosciuta come propria della communio, in quanto
evento specificante la vita e la missione del Popolo di Dio nella storia. Per
fedeltà all’attestazione biblica e alla sostanza profonda della tradizione
ecclesiale è indispensabile, a tal fine, una duplice operazione d’intelligenza
teologica e di esperienza pratica. Si tratta, infatti, in primo luogo, di connettere
più esplicitamente e più decisamente il principio verticale che garantisce e
promuove la communio alla presenza viva e attuale del Kýrios risorto alla sua
Chiesa; e, in secondo luogo, di esprimere secondo una logica non piramidale e
11
monocratica ma, appunto, comunionale e sinodale, l’esercizio, in seno alla
communio stessa, di quei ministeri sacramentalmente qualificati che ne
garantiscono l’apostolicità e l’unità in relazione con tutti gli altri carismi e
ministeri.
c) Infine, tornando all’Ecclesiam suam di Paolo VI, la linea maestra del
dialogo e della diakonia nella grande impresa della nuova evangelizzazione.
Dialogo e diakonia che, se ben intesi, scaturiscono coerentemente e senza
sbavature dal concetto di rivelazione proposto dalla Dei Verbum e dalla figura di
Chiesa tratteggiata dalla Lumen gentium.
Fa dunque specie che ancora vi sia chi, di tempo in tempo, prende le
distanze dall’istanza dialogica documentata dal Vaticano II: sia nella
declinazione della vita della communio che la qualifica, sia nella proposizione
della missione evangelizzatrice che ne esprime l’intenzionalità vera e prima.
Dialogo, in effetti, è – nell’ottica del Concilio e, se possibile, più ancora di Paolo
VI – concetto propriamente teologico che descrive il significato del
rinnovamento profondo innescato dal Vaticano II. Tanto che non afferrarne il
senso e non assumersene la fatica e la gioia è, in fin dei conti, misconoscere il
valore teologico del Concilio Vaticano II.
Siamo solo agl’inizi dello scavo vitale di questa intuizione. Essa implica il
compito esigente d’introiettare nella maturazione dell’autocomprensione e
autoconfigurazione ecclesiale la forma del dialogo e della diakonia
nell’attestazione e nell’annuncio della Parola di Cristo, in cui per sé essa è
originariamente inscritta: non, dunque, come un elemento che dall’esterno viene
a determinarne la proposizione, bensì come l’esplicarsi dall’interno della sua
verità ed efficacia. Qui sta l’intuizione dell’Ecclesiam suam: “oggi la Chiesa ha
da farsi parola, colloquio, dialogo”.
Perchè il dialogo (e la diakonia che esso esprime e veicola) definisce la
misura alta – esibita da Colui che, nell’agápe, dona la vita per i suoi amici (cfr.
Gv 15,13) – della coerenza del testimone – martyría – con la Parola che
testimonia; e, in radice, di questa stessa Parola esibisce con ciò l’intima coerenza
e la vitale efficacia.
12
6. Guardando in avanti, mi sembra di poter dire che oggi ci troviamo di
fronte a questa sfida: declinare la verità del Dio Trinità d’amore rivelato in
Gesù come principio, forma e meta della vita della Chiesa nelle sue concrete
espressioni antropologiche, sociali, istituzionali, evangelizzatrici. Altrimenti, la
novità che la contemplazione della Chiesa alla luce della Trinità ci ha fatto
pregustare nel Concilio, resta mera retorica e rischia di dissolversi come un bel
sogno. In un’intervista pubblicata su “Il Regno”, Luigi Sartori, pochi mesi prima
di morire, mi ha consegnato questa riflessione:
«I principi teologici, trinitari soprattutto, che abbiamo imparato dal
Concilio, debbono non solo essere collocati prima – per attuare una sorta di
logica deduttiva – ma anche riscoperti dopo. Nella Chiesa di oggi manca la
seconda parte: far riscoprire il mistero, i fondamenti, tramite la
valorizzazione dei passi compiuti con l’uomo. Come dire: il regno di Dio lo
devi sentire prima (“il regno è venuto” – dice Gesù), ma lo devi anche
scoprire dopo, impegnandoti in quelle piccole, miserabili operazioni in cui
cerchi di attuarlo, per poi alla fine farlo riapparire. Questo sforzo di
riconquistare la vetta del mistero è mancato»2.
C’è in queste parole un’indicazione importante, che aprirei in due
direzioni. La prima: occorre coniugare il mistero con la mistagogia, la
contemplazione del mistero di Dio in Gesù, e dell’uomo in Lui, con
l’introduzione esperienziale in esso. La seconda: occorre passare dalla
declamazione del mistero trinitario alla trinitizzazione in atto della vita
ecclesiale e sociale, e cioè alla trasformazione nel segno della fraternità, della
giustizia e della pace, delle relazioni umane.
Il sociale non va gestito: va gestato nella luce e nella forza perseverante
dell’amore vero e sincero. Per questo, oggi, sulla scia del Concilio, è l’ora dei
laici: l’ora di penetrare nella più alta contemplazione di Dio condividendo sino
in fondo le ferite e le invocazioni degli uomini, per versare su di esse – come
preghiamo nella liturgia – l’olio della consolazione e il vino della speranza.
Piero Coda
2
705-711.
P. Coda, Ontologia della carità. Intervista a L. Sartori, in "Il Regno - attualità", XLIX (2004), n. 20,