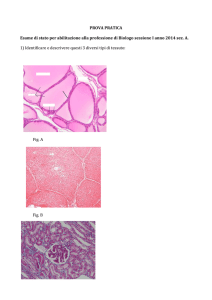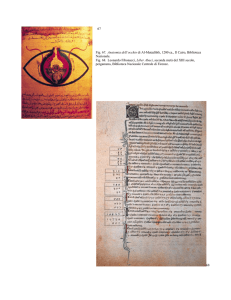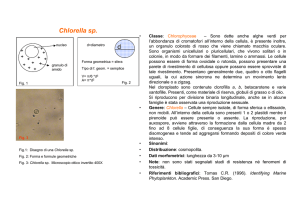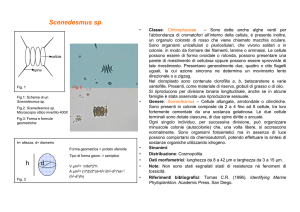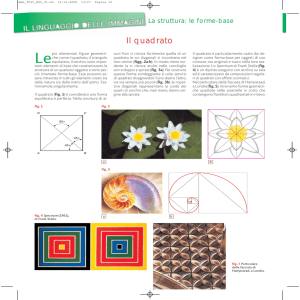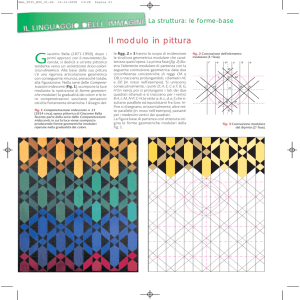MittelFest
musica e arti visive
Cividale del Friuli
Scuola Normale Superiore
Pisa
Grecia
atti del convegno
MittelFest 2001 · inaugurazione
MittelFest
MittelFest · Settore Musica e Arti Visive
Scuola Normale Superiore di Pisa
AT T I D E L C O N V E G N O
MITTELFEST 2001 · INAUGURAZIONE
M IT TEL F EST
Gustav Klimt, Musik, in “Ver Sacrum”, 1901
6
Grecia
C IVIDALE
DEL
F RIULI , VENERDÌ 20 LUGLIO 2001
C HIESA DI S AN F RANCESCO
MITTELFEST IN COPRODUZIONE CON LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Relazioni di:
Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale
Introduzione
Chiara Martinelli, ricercatrice della Scuola Normale
Musica e poesia in Grecia
Carlo Pernigotti e Luisa Prauscello, dottorandi di ricerca della Scuola Normale
‘Spartiti musicali’ nella Grecia ellenistica: pluralità delle occasioni del canto
e discontinuità della tradizione
François Lissarrague, centre Louis Gernet, Parigi
Iconografia musicale
Michael Stüve, direttore Musica Ricercata
Gli strumenti musicali dell’antica Grecia
Eugenio Lo Sardo, Ministero Beni Culturali
Vincenzo Galilei, Athanasius Kircher e la musica greca
Concerto:
Dialogo della musica antica et della moderna
IACOPO PERI (1561-1633)
Euridice (1600): Finale “Biond’arcier”
JACOPO CORSI (1561-1604)
Dafne (1596-1597): Aria di Apollo “Non curi la mia piant”
7
MICHAEL STÜVE (1953)
Hellenika:
EURIPIDE
Frammento dell’Oreste , 408 a.C.
(Pap. Vienna G 2315)
ANONIMO
Peana “Keklyth’, Helikôna bathydendron”, 138 a.C.
(Delfi Inv. N. 515, 526, 494, 499)
ANONIMO
Interludio, IV sec. d. C.
(Anonimo Bellermann § 104)
SEIKILOS
Epigramma e scolion “Hóson zês”, I sec. a.C.
(“Epitafio di Sicilo”, Copenaghen Inv. n. 14897
MESOMEDE DI CRETA
Proemio alla Musa “Áeide mûsá moi phíle” , 117-138 d.C.
(pubblicato da Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della
moderna, Firenze 1581)
MESOMEDE DI CRETA
Proemio a Calliope “Kalliópeia sophá”, 117-138 d.C.
(pubblicato da Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della
moderna, Firenze 1581)
ANONIMO
Interludio, IV sec. d. C.
(Anonimi Bellermann § 100 e 97)
ANONIMO
Lamento sulla morte di Aiace “Autophóno cherí”, II sec. d.C.
(Pap. Berlino 6870)
ANONIMO
“Chryséa phórminx” (Contraffazione del preludio della prima ode pitica di
Pindaro, Athanasius Kircher, Musurgia universalis...., Roma 1650)
LIMENIO
Prosodion del peana, 128 a.C. (Delfi Inv. 214)
8
MESOMEDE DI CRETA
Inno a Nemesi “Némesi pteróessa”, 117-138 d.C.
(pubblicato da Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della
moderna, Firenze 1581)
ANONIMO
Frammento strumentale di Contrapollinopolis, II sec. d.C.
(Pap. Berlino 6870)
ANONIMO
Inno paleocristiano, Ossirinco , III sec. d.C.
(Pap. Oxy. 1786)
MESOMEDE DI CRETA
Inno al Sole “Chionoblephárou pater Aûs”, 117-138 d.C.
(pubblicato da Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della
moderna, Firenze 1581)
GIULIO CACCINI (1550-1618)
Il rapimento di Cefalo (1600)
coro finale:
Ineffabile ardore
Muove sì dolce
Quand il bell’anno
EMILIO DE’ CAVALIERI (1550-1602)
La Pellegrina (1589)
VI Intermedio
Ballo del Granduca “O che nuovo miracolo”
Musica Ricercata
Michael Stüve, direttore
9
S ALVATORE S ET TIS
Introduzione
Il mº Carlo de Incontrera, che ha invitato la Scuola Normale Superiore di Pisa
a presentare, nel quadro di questo Mittelfest, qualche riflessione sulla musica
degli antichi Greci, conosce benissimo i rischi che correva se noi avessimo accettato di venire a parlare qui a Cividale. Sono due rischi in qualche modo opposti, e legati a quello che la Normale è e a quello che essa non è. La Normale ‘non
è’ un istituto di studi musicali, e pertanto parlare davanti a un pubblico con forte e marcata cultura musicologica come quello di Cividale è un rischio, specialmente per me che di musica non so proprio nulla. D’altra parte, la Normale è
un luogo di segnalata e alta tradizione in molti campi del sapere, fra cui proprio
gli studi sul mondo antico, greco e romano: e pertanto c’è il rischio che quello
che vi presenteremo possa eccedere in specialismo. Ma il mº de Incontrera sa
anche che la Normale ha un fortissimo interesse per la musica e la sua storia, e
infatti organizza da trent’anni la serie “I concerti della Normale”, offerti non
solo ai normalisti ma alla città di Pisa, e organizzati prima con la consulenza del
mº Piero Farulli e da alcuni anni proprio con l’aiuto di Carlo de Incontrera. Il
quale sa anche che proprio in Normale è stato progettato e diretto l’ultimo
grande sforzo di sintesi interpretativa della cultura greca, un’opera in cinque
volumi pubblicata da Einaudi col titolo “I Greci. Storia Arte Cultura Società”
(il quinto volume uscirà in novembre di quest’anno); un’opera il cui successo si
misura dal solo fatto che a partire dall’anno prossimo verrà integralmente tradotta in tedesco, e subito dopo in inglese.
Se abbiamo accettato di partecipare, è stato dunque non solo per la gioia di essere qui con voi oggi, ma anche per l’interesse che abbiamo al confronto fra le
nostre ricerche specialistiche e un pubblico più vasto, il cui profilo culturale è
tale da garantire non solo e non tanto l’attenzione al messaggio che intendiamo
dare, quanto il controllo della sua qualità.
Di tutti, quello che meno conosce il tema proposto sono proprio io: tutto ciò
che potrò fare sarà dunque introdurre gli altri relatori con qualche riflessione su
due punti diversi e convergenti: da un lato, sul ruolo della civiltà greca nella storia recente dell’Europa e nella stessa idea di una civiltà comune europea; dall’altro, sul ruolo della musica nella cultura greca antica.
< Delfi, le rovine del santuario di Atena Pronaia
11
Cominciamo dal primo punto. Vorrei affrontarlo partendo da una piccola serie
di citazioni, scelte a caso fra migliaia (letteralmente) di testi simili, che rivendicano una discendenza dai Greci delle nostre coordinate culturali. Cominciamo
dalla famosa sentenza di Hegel, secondo cui “Al nome Grecia l’uomo colto europeo subito si sente in patria”. Con spirito non troppo diverso, Hannah Arendt
poteva sostenere che nè la rivoluzione americana nè quella francese sarebbero
mai state possibili senza l’esempio che veniva dall’antichità classica, e Popper
richiamava i filosofi presocratici come modello della dinamica moderna del pensiero scientifico fra congettura e confutazione. John Stuart Mill scrisse che “la
battaglia di Maratona, anche come evento della storia inglese, è più importante della battaglia di Hastings. Se in quel remoto giorno il risultato dello scontro
fosse stato diverso (se i Greci non avessero vinto), Britanni e Sassoni forse
vagherebbero ancora per le selve”. In queste e mille altre citazioni, i Greci compaiono con significato ‘fondante’: e non solo di risultati o di azioni o di memorie, ma di ‘valori’ ancora attuali. Lo vediamo ancor meglio nel contrasto fra due
altre citazioni, le ultime: da un lato Gilbert Murray, Regius Professor di greco a
Oxford, che assegnava ai Greci “la ricerca di Verità, Libertà, Bellezza, Ragione
ed Eccellenza nella vita individuale, e di fratellanza nella vita internazionale”, e
più in generale l’origine stessa del “Pensiero Equilibrato”; dall’altro lato, Albert
Hofmann (noto come “il padre dell’LSD”, che proprio in questi anni ha argomentato in favore degli stimolatori della psiche sostenendo che anche i Greci,
nei misteri di Eleusi, usassero un allucinogeno simile all’LSD.
Tutti questi esempi sono accomunati da una tendenza implicita, tanto più
potentemente operativa quanto più essa vien data per scontata: la tendenza a
considerare i Greci come la radice ultima e unica di tutta la civiltà “occidentale”, e ‘dunque’ aventi titolo a legittimare valori e pratiche del nostro tempo,
anche opposte fra loro quanto lo sono il “pensiero equilibrato” e gli “stati alterati di coscienza”. Si dà così per dimostrato il valore preternazionale e fondativo della cultura greca, e la storia dei Greci (come nella citazione di Stuart Mill
sulla battaglia di Maratona) assume lo status di storia universale, non solo necessaria a intendere il mondo moderno, ma anche fonte di legittimazione e di ispirazione per il suo (per il nostro) futuro. I Greci, come “primi inventori” della
filosofia e dell’arte, della scienza e della bellezza; i Greci, che seppero sperimentare sopra di sé in forma originaria tutte le passioni del mondo e dell’uomo,
quelle di Edipo e di Medea, di Antigone e di Odisseo. Un paesaggio culturale
fatto di sentenze arcane e pregnanti pronunciate una volta per tutte, d’impeccabili monumenti contro un cielo sempre azzurro dietro il quale s’indovinano
dèi benigni pronti a incarnarsi in bronzi e in marmi di bellezza irraggiungibile.
Una civiltà popolata di modelli e di archetipi, di pietre di fondazione e di cifre
universali, di motti delfici e di colonne doriche, di atleti che s’incoronano e di
artisti dediti alla Bellezza, di passioni politiche da cui emerge una polis cristalli-
12
na e una democrazia che dà spazio alla libertà e all’individuo, di filosofi che tracciano con stilo implacabile l’agenda di tutte le filosofie possibili.
Paradossalmente, una tale immagine dei Greci resiste, e anzi si consolida, proprio mentre il posto della cultura classica nei percorsi educativi e nella cultura
generale sembra restringersi ogni giorno di più. Meno sappiamo il greco, più
parliamo dei Greci. Quanto più filosofi e saggisti perdono la capacità di controllare criticamente in prima persona lo spessore e il senso originario dei testi
della cultura greca, tanto più marcatamente essa diventa, in uno spirito tutto
“postmoderno”, il serbatoio ideale a cui attingere elementi staccati, da rimontare poi ad arbitrio in più o meno gratuiti collages. La patria di quello che con linguaggio degno di un mito di fondazione si volle chiamare “miracolo greco” è
diventata così come un retrobottega da cui prelevare a piacimento questo o
quell’arnese, quasi fosse attrezzeria di teatro da riciclare di continuo. Ma quanto più arbitrari e meno colti sono questi esercizi di accanito citazionismo, tanto più essi innalzano la cultura greca sopra un piedistallo irraggiungibile, estirpandola dalla storia per proiettarla su un piano che si pretende “universale”.
Non è questa l’immagine dei Greci che vogliamo oggi proporvi. Come un
monumento provato dagli anni, essa è infatti attraversata da crepe numerose e
profonde. Per esempio, se vogliamo simboleggiare il carattere fondante della
civiltà greca nella giornata di Maratona, lo identifichiamo implicitamente con
una vittoria dei Greci (leggi: degli Europei) sui Persiani, che stanno qui per un
Oriente indeterminato e statico, l’ “altro” -perennemente uguale a se stessorispetto a un’Europa caratterizzata, a partire dalla grecità, da un accentuato
dinamismo e da un continuo progresso; e per questo radice e madre della modernità. Formulazioni come queste ci appaiono oggi non solo strettamente eurocentriche, ma anche limitative e “datate”; “datate”, intendo, in quanto coestensive a una concezione della civiltà europea come culminazione d’ogni altra, e
pertanto legittimata al colonialismo, all’annessione, alla “missione civilizzatrice”. L’opposizione Greci/barbari veniva in tal modo a tradursi in quella Europa/”altri”, riattualizzata e proiettata ora verso le Americhe, ora in Asia o in Africa, ribadendo l’identità fra un “noi” orgogliosamente europeo e i Greci, padri e
maestri di una stessa civiltà.
Proprio questa identificazione, che sembrò garantire alla cultura greca un ruolo
perpetuamente vitale nel mondo moderno -quasi dovesse diffondervisi con le
armi, le merci e le tecniche dell’Occidente-, suona oggi al contrario come un
canto funebre. Quale può essere il posto dei Greci in un mondo caratterizzato
sempre di più dalla mescolanza dei popoli e delle culture, dalla condanna dell’imperialismo e dalla fine delle ideologie, dalla fiera rivendicazione delle identità etniche e nazionali e delle tradizioni locali contro ogni tentazione “annessionistica”? Che senso ha cercare radici “comuni”, quando tutti sembrano piuttosto impegnati a distinguere le proprie da quelle del vicino? Come possiamo
13
vantarci di aver vinto sugli “altri” a Maratona senza pensare all’Algeria o al Vietnam? Con quale ostinata presunzione potremmo mai chiedere ai Cinesi o agli
Indiani di riconoscersi nei Greci, implicandone l’identità con un “noi” tutto
europeo, senza offrire in cambio il desiderio di identificarci, noi, nella loro antichità? Se quella è la nostra immagine dei Greci, se quello è il loro ruolo nella
“storia universale” che vogliamo costruire, riducendo la storia universale a storia dell’Europa e dell’espansione europea, allora davvero i Greci sono destinati
a diventare il primo bersaglio di una cultura vicina a soccombere, il prototipo
dei dead white males da uccidere domani.
Dobbiamo ricordarci, al contrario, che i Greci (i “Greci senza miracolo” di
Louis Gernet) non sempre innalzarono monumenti e pronunciarono detti
memorabili, nè furono indaffarati a fondare la coscienza dell’Europa moderna
per distinzione dall’Oriente, ma anzi nell’Oriente si mossero con gioia e disinvoltura e ansia di scoperta, cercandovi merci e miti e saggezza, imparando e
insegnando. Li troviamo sulle coste del Mar Nero o della Spagna, in Sicilia o in
India, a costruire un’infinita varietà di culture locali, o a immaginare viaggi dei
loro eroi oltre le colonne d’Ercole; sempre curiosi di vedere e di conoscere, con
quello spirito che un sacerdote egizio, parlando con Solone, riconobbe come
una loro caratteristica: “un Greco vecchio non esiste, voi Greci siete sempre fanciulli” (lo racconta Platone nel Timeo ). Li troveremo sempre pronti a “ibridizzarsi” con le civiltà e i popoli che incontravano, ponendo e ricevendone domande, creando oggetti culturali a volte davvero assai poco “classici”. Potremo, per
questa strada, apprezzarli di più e meglio proprio sentendoli meno “uguali a
noi”, più “altri”, più “stranieri”. Questo nuovo processo di comprensione, quale è in corso ai livelli più alti degli studi specialistici, significa relativizzare la
compattezza della civiltà greca, significa evidenziarne i debiti e i contatti con
altre culture e le numerose varianti regionali; significa, in ultimo, incrinare
profondamente, fino a distruggerla, quella “rotonda” classicità a cui pure si
ancorarono tanti discorsi e tanti progetti della storia e della cultura moderna.
Dovremo porre in rilievo l’‘alterità’ dei Greci rispetto alla nostra cultura (quanto sia diversa la loro dalla nostra libertà, la loro dalla nostra politica, la loro dalla nostra uguaglianza), ma anche analizzare di volta in volta le ragioni per cui,
anzichè riconoscerne l’alterità, si è preferito così spesso costruirne un’identità
fittizia con “noi”. Ogni volta che lo si è fatto non è stato mai per caso, bensì
rispetto a una posta in gioco estranea, come è ovvio, ai Greci, alle loro preoccupazioni e pensieri; e costantemente propria, invece, di questo o di quell’altro
“noi”: perciò è stato ed è possibile invocare l’esempio greco per ragioni assolutamente opposte fra loro. Perciò le ragioni di quelle identificazioni aiuteranno
anche a intendere l’uno o l’altro “noi” di volta in volta in azione, che sia in Germania, in Italia o in America: identità e alterità entreranno in gioco quasi a ogni
passo, in perpetua tensione fra loro. Insomma, i Greci senza miracolo saranno
14
molto più interessanti dei Greci del “miracolo”. Forse anche la loro musica ci
apparirà più interessante e ricca di spunti se non la vedremo come una proiezione all’indietro della musica europea, ma nel contesto delle pratiche musicali
del Mediterraneo orientale, greco e non-greco.
Vengo così al mio secondo punto. Quale era il ruolo della musica nella civiltà
greca? Una premessa è necessaria: ‘tutto’ quello che sappiamo dei Greci è filtrato
attraverso il gigantesco naufragio della maggior parte della loro “produzione culturale”. I testi letterari che abbiamo sono forse il 5, forse il 10 per cento di quelli che si potevano trovare nelle biblioteche di Pergamo o di Alessandria; se passiamo alle arti figurative, la pittura, che vi aveva un ruolo centralissimo (basti
pensare ai nomi di Apelle o di Parrasio), è interamente perduta; quanto alla scultura, i Greci avevano ben chiara una gerarchia dei materiali secondo cui la scultura in bronzo era considerata più “nobile” e pregiata di quella in marmo, ma di
bronzi greci ne abbiamo pochissimi, meno di cento, quando sappiamo che nella sola Olimpia ce n’erano molte migliaia; quanto alle sculture in marmo, non ne
abbiamo che una minima parte. Dell’intero patrimonio figurativo dell’antichità,
in altri termini, abbiamo oggi probabilmente meno dell’1-2 per cento. Con la
musica, le cose stanno ancora peggio: i resti che ne abbiamo sono certamente
molto, molto meno dell’1 per mille. È per porre rimedio a questa documentazione così drammaticamente lacunosa che gli studiosi del mondo antico hanno
elaborato negli ultimi secoli le sofisticate tecniche e metodologie della filologia
testuale e dell’archeologia, finalizzate a ricostituire un quadro meno incompleto
della civiltà antica, della sua cultura letteraria e artistica come della sua storia
politica ed economica e della sua cultura “materiale” (gli oggetti della vita quotidiana). Si può anche dire che l’estrema lacunosità della documentazione ha giocato come un potente stimolo all’interpretazione, obbligando a mettere a punto
strategie interpretative non solo diverse, ma talora opposte fra loro.
Ma è importante osservare che, al di là delle perdite e delle lacune, quello che
più si è modificato con l’inesorabile trascorrere del tempo è proprio l’immagine generale della cultura greca. Le enormi perdite di documentazione hanno
infatti provocato una ‘dislocazione della percezione’ dei Greci in aree estremamente significative. Farò solo due esempi. Se c’è qualcosa che a tutti viene in
mente parlando dei Greci, è l’immagine di un tempio (come il Partenone o i
templi di Paestum o di Agrigento), o di una scultura, come i marmi del Partenone al British Museum, o il Laocoonte in Vaticano. Sono immagini ‘monocrome’, dominate dal candore del marmo delle qualità più pregiate: eppure, l’architettura e la scultura greca erano coloratissime, arricchite di una policromia
vivace e multiforme, di cui solo un limitato numero di sculture reca una qualche pallida traccia. Immaginiamo di entrare in un grande museo di scultura
antica, per esempio ai Musei Vaticani, e di trovarci in una grande sala con centinaia di sculture bianchissime, di quel bianco abbagliante che tanto appartiene
15
alla più comune immagine della classicità. Chiudiamo gli occhi per un istante,
immaginiamo le carni degli Apolli e delle Veneri colorarsi come d’incanto, colorarsi i loro panneggi, i loro capelli, i tronchi d’albero a cui a volte si appoggiano, i serpenti che stringono fra le loro spire Laocoonte e i suoi figli. Ci parrà, se
riapriamo gli occhi davanti a uno spettacolo tanto mutato, di essere in un’altra
dimensione, “non-classica”: ebbene, è solo in questa dimensione sorprendentemente, quasi fastidiosamente estranea, che possiamo riconoscere l’autentico
“colore” della grecità. Lo stesso accade coi bronzi: siamo così abituati a vedere i
bronzi antichi con la patina verdastra creata dai secoli di abbandono, che tutta
la scultura in bronzo europea, dal Rinascimento in qua, ha adottato ‘quel’ verde come il colore del bronzo. Eppure, sappiamo che i bronzi antichi erano, invece, lucidi e splendenti, di un colore dorato quasi più vicino all’oro che alla
‘nostra’ immagine del bronzo; che quelle statue sorridevano da labbra di rame
rossastro, mostrando denti d’argento; che i loro occhi erano di pietre e vetri
colorati. Un’immagine, per la sua violenta policromia, che ci appare quasi “barbarica”, per contrasto alla monocroma compostezza dei bronzi come li vediamo
nei musei: ma quell’immagine violenta ed estranea, così difficile da accettare, è
la sola immagine autentica dell’arte greca.
Non diversamente stanno le cose nella musica greca. Qui, come ho detto, la
perdita della documentazione è tanto vasta e radicale da farcene dimenticare
perfino l’esistenza. Quasi non sappiamo più quanto profondamente la musica
permeasse ogni aspetto della vita pubblica e privata dei Greci; quasi abbiamo
dimenticato che le tragedie di Eschilo Sofocle Euripide erano drammi in musica, e che quando leggiamo Pindaro e gli altri poeti lirici dobbiamo immaginare i loro testi non “accompagnati” dalla musica, ma ‘intrisi’ di musica, pensati
con la musica e per la musica (visto che l’autore della musica, dei testi e delle
danze era di solito la stessa persona, quasi in un grandioso e originario
Gesamtkunstwerk). È un’immagine drammaticamente perduta per sempre:
come la scultura greca, nata policroma, è “diventata” monocroma, così la parola poetica greca, nata come squisitamente e intimamente musicale, ha perduto
per sempre la propria “colonna sonora”. Il potere della musica nella città greca
era ritenuto così grande, che i diversi generi della musica furono non solo codificati, ma anche associati a valori etici e civici che si ritennero ‘costitutivi’ della
natura stessa del cittadino, della vita associata nella polis, del rapporto fra le varie
generazioni all’interno della società. Si spiega così come Platone abbia tanto
insistito (in particolare nella Repubblica e nelle Leggi ) sulla necessità di codificare la musica e la danza, e di impedire e punire le innovazioni troppo audaci,
considerandole distruttive per la vita politica della città. Si spiega così come la
musica non vi fosse intesa come qualcosa di aggiuntivo, un’arte fra le altre, ma
come quella che, coinvolgendo emotivamente più di ogni altra, doveva aiutare
a comprendere le altre; e come nei testi antichi è molto più facile trovare il lin-
16
guaggio musicale, o metafore tratte dalla pratica musicale, per spiegare le arti
figurative, piuttosto che il contrario.
Un quadro come questo, del quale le relazioni che seguiranno vi offriranno altri
e più ricchi elementi, ha un’enorme potenza evocativa, in nulla diminuita dalla
quasi totale assenza di documentazione. Basta a dimostrarlo il fatto stesso che
un genere musicale centrale nella tradizione europea, l’opera, sia nato all’origine proprio come un tentativo di “ricreare” la tragedia greca nella sua intima
commistione di parola e musica. Se riflettiamo a questa origine dell’opera, possiamo ben comprendere quanto anche le assenze nella documentazione, le perdite anche dolorose, possano alla fine provocare una vitale tensione creativa;
quanto persino i processi di distruzione possano, in una storia delle civiltà vista
nel lungo periodo, innescare un opposto e fecondo processo produttivo. Ma che
cosa può darci, ‘oggi’, la memoria della musica greca antica? Era, essa, più simile alla “nostra”, o a musiche “altre” (per esempio “orientali”)? Come possiamo
interpretare, in senso non solo filologico, ma propriamente musicale, le pochissime tracce di partiture musicali che ci sono rimaste? Torna qui la tensione che
abbiamo visto fra “identità” e “alterità” dei Greci, e lo si potrebbe mostrare mettendo a confronto le rare esecuzioni della musica greca antica conservata, che
ora cercano di rendercela più accettabile col farla più simile a musica a noi già
familiare, e ora invece puntano sulla sua totale diversità.
Di questi ed altri temi altri parleranno meglio di me. Vorrei concludere con
un’ultima citazione, che ‘non’ riguarda i Greci, ma riguarda la musica. La prima
registrazione fonografica di un’esecuzione musicale (il pianista era un bambino
di undici anni) fu fatta nello studio di Thomas Edison nel 1887, e tutti sappiamo quanta strada si sia fatta da allora ai nostri CD. Ma già nel 1888, l’editoriale (non firmato) dello Spectator si preoccupava del fatto che ascoltare le esecuzioni degli altri potesse limitare la creatività dei musicisti del futuro. “L’ingegnosità scientifica del nostro tempo -scrive l’editorialista- finirà col creare nel
mondo che ci lasceremo dietro un “troppo pieno”: forse lasceremo di noi ‘troppo’, e con ciò finiremo col limitare la libera crescita della nostra posterità”. Non
intendo, concludendo con questa citazione, implicare che è meglio che la musica greca antica sia andata perduta nei gorghi della storia; ma solo suggerirvi di
riflettere alla tensione drammatica fra quello che sappiamo del nostro passato e
quello che ne ignoriamo (la più gran parte); a quanto possa essere fecondo e
creativo il nostro desiderio di riempire le lacune della documentazione, l’impulso irresistibile a interrogarci su quello che abbiamo perduto per sempre.
17
M ARIA C HIARA M ARTINELLI
Musica e poesia in Grecia
Della musica della civiltà greca antica ci sono giunti pochissimi documenti, e
del periodo in cui essa fu indissolubilmente legata alla grande produzione letteraria non ci è arrivato praticamente niente1. Eppure il significato che essa aveva
nella vita dei Greci dei più vari livelli sociali, a partire dal momento della loro
formazione culturale e, via via, nelle diverse occasioni della vita quotidiana, lo
possiamo ricavare da una serie molteplice di testimonianze dall’arte figurativa,
dalla riflessione filosofica, e, in modo particolare, dalla letteratura.
Più di una volta nelle parole dei poeti per connotare qualcosa di negativo, la
discordia, la guerra, la morte, lo si associa alla mancanza di musica: così, ad
esempio, Sofocle, nell’Edipo a Colono2, definisce il destino di morte “senza danze, senza lira, senza canti” e nelle Fenicie di Euripide3 si rimprovera ad Ares, la
divinità della guerra che causa enormi sofferenze, di contrapporsi alle feste in
cui i giovani danzano accompagnati dal canto, guidando invece una processione dove la musica non ha posto. La gioia e la festa sono, al contrario, indissolubilmente legate alla musica; così i vecchi che formano il coro di un’altra tragedia di Euripide, l’Eracle, si augurano (v. 676) di non dover mai vivere senza i
doni delle Muse, appunto la musica, il canto, la danza.
Nei più vari tipi di celebrazione i Greci di ogni classe sociale godevano della musica, non solo e non tanto ascoltando l’esibizione di artisti ‘professionali’, ma suonando, cantando e danzando. Il termine da cui è derivato lo stesso nome di “musica”, mouçikhv (sott. tevcnh, “l’arte delle Muse”) definiva infatti non solo l’arte dei
suoni, ma anche la poesia e la danza: il giovane, che doveva diventare un mouçiko;ç
ajnhvr, veniva formato dunque a saper praticare quest’arte e allo stesso tempo ad
essere in grado di recepire il messaggio di una cultura che veniva proposta dai poeti, nei canti per le feste come nelle opere drammatiche, attraverso la parola, che si
univa più volte strettamente alla musica e talora all’azione gestuale.
Il periodo della grande fioritura della poesia legata al canto e spesso alla danza
è quello arcaico e tardo-arcaico della grande lirica (che va dal VII secolo a.C.
all’inizio del V secolo) e quello ‘classico’ del dramma attico (V secolo). Si tratta
in entrambi i casi di un tipo di poesia che non riusciremmo a capire senza tener
< Fig. 1, anfora attica a figure rosse del pittore Brygos, 430 a.C. ca.: citarodo (particolare)
(Boston, Museum of Fine Arts 26.61).
19
presente che essa venne composta e “pubblicata”, a differenza di quelle moderne (dove l’occasione è un evento interiore e il destinatario è per lo più l’indefinibile lettore che l’autore immagina o desidera, ma non vede), per una ben individuabile occasione sociale, con precisi committenti, e fece per lo più parte integrante di un cerimoniale.
La lirica, che si sviluppa in un contesto storico del tutto rinnovato rispetto a
quello dell’epica,4 è composta ed eseguita per particolari occasioni, che la distinguono chiaramente in generi, già chiari alla coscienza degli antichi.
Così la lirica corale si rivolge ad un pubblico vasto, riunito in occasione di particolari cerimonie (ad esempio grandi feste pubbliche legate al culto degli dei e agli agoni sportivi). Conosciamo, in parte anche grazie alle testimonianze dirette di quanto
ci è arrivato dell’opera di grandi poeti come Pindaro e Bacchilide, diversi generi di
canti, alcuni dei quali dovevano affondare le loro radici in epoche precedenti.
Così, ad esempio, il peana, per lo più legato al culto di Apollo (con il quale veniva comunemente identificata la divinità “salvifica” Peana o Peone, originariamente indipendente), con la funzione fondamentale di invocare la salvezza da
un male o esprimere gratitudine per uno scampato pericolo (nel primo libro
dell’Iliade ci viene riferito che lo intonano gli Achei, dopo aver restituito al
sacerdote Crise la figlia, fonte dell’ira di Apollo, con il quale si vuole attraverso
il canto ribadire appunto la riconciliazione).5
Canti di invocazione o ringraziamento alla divinità, i prosodi, venivano intonati durante solenni processioni ai templi e agli altari degli dei, ad accompagnare
dunque le parti introduttive dei riti (ne abbiamo, con ogni probabilità, diverse
testimonianze figurative, che mostrano processioni o danze processionali
accompagnate da strumenti musicali).
Del ditirambo, dedicato a Dioniso, sappiamo che conobbe un’evoluzione in
senso fortemente spettacolare: nelle Grandi Dionisie celebrate ad Atene, almeno dalla fine del VI secolo si svolgevano gare6 in cui dieci cori di cinquanta
ragazzi e altrettanti di cinquanta uomini, tratti da ciascuna delle tribù in cui era
articolata la polis (quindi 20 cori, in tutto un migliaio di cittadini), si esibivano
cantando e danzando.
Cori entravano in azione anche in vari momenti della cerimonia nuziale: nel
corteo di amici che accompagnava la sposa dalla casa di suo padre alla sua nuova casa (l’imeneo: già nell’Iliade 7 ne troviamo una descrizione fra le raffigurazioni dello scudo di Achille, e Saffo ce ne dà un’altra, relativa alle nozze di Ettore e Andromaca8) e, più avanti, durante la notte di nozze, davanti alla camera
degli sposi (l’epitalamio).
Cori cantano e danzano anche per festeggiare i vincitori delle grandi gare panelleniche (i giochi Olimpici, Pitici, Nemei ed Istmici) e non: ciò avviene con le
composizioni dette epinici, di cui abbiamo notevoli esempi soprattutto da Bacchilide e Pindaro, che ci testimoniano quale livello di raffinatezza e anche di
20
magnificenza nell’allestimento un ricco committente poteva aspettarsi.
Il coro era in genere formato da individui della
stessa classe di età e dello stesso sesso, in numero variabile: dei cori maschili del ditirambo si è
già detto, e si possono ricordare anche canti
riservati a cori di fanciulle, i cosiddetti parteni,
di cui abbiamo testimonianze in alcune odi di
Alcmane e di Pindaro. Per alcuni ambiti, ad
esempio la Sparta di Alcmane, dove l’istruzione
dei cori doveva essere istituzionalizzata, siamo
informati che essi erano guidati da un corego
(che si distingueva in genere per un abbigliamento più ricco ed era scelto in base a caratteristiche di eccellenza fisica e tecnica). Nei cori che
venivano formati di volta in volta per le varie
occasioni (come accadeva di solito ad Atene),
normalmente erano i poeti-musicisti ad occuparsi dell’addestramento dei cantanti. E in
genere i poeti curavano anche l’istruzione
coreografica del coro.
L’accompagnamento era eseguito precipuamente, a quanto sembra, con la kiqavra [fig. 1, vedi p.
18], uno strumento della famiglia delle lire9, talvolta invece con l’aujlovç [fig. 2]10 (così ad esempio nel ditirambo eseguito alle Grandi Dionisie)
e probabilmente, qualche volta, con entrambi11.
Ad un ambito più ristretto si rivolgeva la lirica
monodica: suo luogo era soprattutto il simposio
[fig. 3], dove si riunivano e si intrattenevano
dopo un pasto comune persone della stessa cerchia. Si tratta di una vera e propria istituzione,
dove, insieme alle varie occupazioni ritualizzate
per l’occasione (la preghiera, lo stesso bere
secondo precise regole, il gioco, l’amore), si eseguivano canti ora con l’accompagnamento di
strumenti a corde, in particolar modo la luvra
[fig. 4]12 e il bavrbitoç [fig. 5, vedi p. 27]13, ora
al suono dell’ aujlovç. Spesso il simposio aveva
un carattere marcatamente politico: in questo
caso allora costituiva il momento d’incontro dei
21
Fig. 2, anfora attica a figure rosse del
pittore Kleophrades, 480 a.C., auleta
(particolare).
(London, British Museum E 270).
Fig. 3, coppa attica a figure rosse di
Douris (?), 480 a.C. ca.: scena
simposiale.
(München, Staatliche
Antikensammlung inv. nr. 2361).
Fig. 4, cratere attico a figure rosse da
Gela, 440 a.C. ca.: Orfeo suona la lira
fra i Traci.
(Berlin, Staatliche Museen 3172).
partecipanti ad una fazione dove si deliberavano decisioni comuni e venivano
eseguite composizioni legate all’hic et nunc della situazione politica: una testimonianza di questo tipo di produzione l’abbiamo nelle odi di Alceo. Ma nel
simposio si agitavano anche altre tematiche e così altrove troviamo dominanti i
temi dell’amore o della riflessione etica più generale, temi cari soprattutto all’elegia (che pure non disdegnava anche argomenti politici), in epoca arcaica
anch’essa cantata con l’accompagnamento dell’aujlovç, mentre in una sorta di
recitativo accompagnato ancora dell’aujlovç era eseguita la poesia giambica, che
si incentrava sui temi dell’invettiva e della beffa, forse mezzo per risolvere le tensioni interne alla comunità. Se poeti creativi in queste occasioni eseguivano odi
di loro composizione, altri partecipanti al simposio ne potevano ripetere di vecchie: così Teognide promette al suo amico Cirno che i canti in suo onore da lui
composti avranno un’ampia circolazione nei simposi futuri.14
Ad un ambiente ristretto, che non è il simposio, si rivolgeva anche la produzione di un altro fra i grandi lirici monodici, Saffo: educatrice in una cerchia religiosa, detta tiaso, dove, nel culto reso ad Afrodite, alle Muse e alle Cariti, venivano formate le ragazze in vista dell’unica funzione che la civiltà del tempo
riservava alle donne libere, cioè il matrimonio e la vita coniugale.
La musica ha un ruolo importante anche nelle rappresentazioni teatrali dell’Atene del V secolo, tragedia -momento di aggregazione della comunità cittadina
e insieme sede di un dibattito appassionato al quale la stessa comunità partecipava con profonda adesione- e commedia, dove si rispecchiavano fatti contemporanei, dibattiti politici e culturali, tensioni sociali e civili. In entrambe si
alternavano brani puramente recitati a brani eseguiti in recitativo e a canti corali, al suono dell’aujlovç, accompagnati da movenze di danza, oltre a canti solistici degli attori e a dialoghi lirici fra attori e coro. Anche qui l’elemento musicale non era qualcosa di accidentale, ma costituiva un fattore importante nell’impatto che ci si aspettava che lo spettacolo avesse sul pubblico. Quando Aristofane, nelle Rane, sottopone a critica due diversi modi di comporre tragedie quali quello di Eschilo e quello di Euripide, dedica particolare attenzione anche alla
loro musica; e, d’altra parte, sappiamo da più di una testimonianza che i brani
lirici di maggior impatto rimanevano nella memoria degli Ateniesi, che erano
in grado di eseguirli in vari tipi di occasioni.15
In questa unione fra parola, musica e talora danza, dominante fu, nella cultura
della Grecia arcaica e classica, il valore della parola, spesso in testi poetici altamente sofisticati e complessi. Era la parola che, come ci risulta da esplicite testimonianze degli stessi poeti (gli inni, dice Pindaro all’inizio della seconda Olimpica, sono “signori della cetra”), doveva condizionare alle sue esigenze l’espressione ritmica e melodica. E così possiamo, pur nella mancanza di documenti di
cui si diceva, farci un’idea almeno del ritmo della poesia, che si basava sulla successione ordinata di sillabe brevi e lunghe: fino al V sec. a.C. l’andamento rit-
22
mico era conforme allo schema metrico del testo.
La musica che accompagnava questi testi doveva essere molto semplice, consistendo in un accompagnamento monodico che non doveva oscurare la comprensione delle parole. Sembra inoltre che ciascun tipo di pezzo avesse una sua
forma e un suo ethos, anche musicale, distinto, con caratteristiche volte a provocare reazioni diverse negli ascoltatori: la fruizione musicale non era infatti
qualcosa di meramente estetico, ma, come risulta dall’elaborazione dei filosofi,
era considerata avere vere e proprie capacità psicagogiche. Delle caratteristiche
musicali più tecniche legate ai tipi di composizione sentiamo parlare dai poeti
stessi: fra le aJrmonivai (disposizioni degli intervalli in una determinata successione di suoni) si distingueva ad esempio quella dorica, austera e nobile, da
quella frigia, tipica dell’entusiasmo dionisiaco e del ditirambo. Usare una al
posto dell’altra, come ci dicono i filosofi, sarebbe stato considerato non solo
esteticamente sconveniente, ma deleterio sul piano etico.
E inoltre sembra di poter affermare che fino al V secolo i poeti-musicisti non
componessero i loro brani con criteri di originalità assoluta, ma per lo più rielaborassero e variassero motivi tradizionali ormai impostisi e definiti con una
certa regolarità, secondo un procedimento che ci è noto anche per altre culture
musicali come ad esempio quella dell’India: a questo probabilmente tali motivi
musicali dovrebbero il nome di novmoi (cioè “leggi” oppure “modi usuali”). I
poeti stessi attestano talvolta esplicitamente nelle loro composizioni questo procedimento: così più di una volta Pindaro, ad esempio nella Olimpica I (novmoç
i{ppioç)16 e nella Pitica II (Kaçtovreion).17
Anche l’articolazione delle composizioni rispondeva a criteri di regolarità: essa
avveniva di solito attraverso la ripetizione (sia nel ritmo che nella melodia) di
una struttura più o meno ampia fatta di versi anche differenti fra loro (la strofe); le composizioni più complesse (come alcune odi dei grandi lirici corali)
vedevano la ripetizione di una struttura detta triade in cui due strofe uguali tra
loro erano seguite da una struttura ritmicamente diversa (l’epodo); il dramma
sviluppa soprattutto un tipo di articolazione in cui si susseguono coppie strofiche l’una diversa dall’altra, forse legato alle esigenze del teatro (ad esempio la
necessità di introdurre cambiamenti ritmici e melodici in un testo in cui si agitano tematiche e finalità di vario genere in rapporto agli avvenimenti scenici).
Ma nella seconda metà del V secolo nasce e si va imponendo, grazie all’azione
in Atene di alcuni musicisti, la ‘scuola del Nuovo Ditirambo’, il cui esponente
più noto è Timoteo di Mileto,18 un nuovo modo di intendere i rapporti fra
musica e poesia: il ritmo e anche il senso del testo sono progressivamente subordinati alle nuove idee musicali che vengono ad essere sviluppate di per se stesse. Nell’ambito di una concezione poetica e musicale tesa soprattutto al mimetismo, dove testo e musica dovevano corrispondere alla varietà delle situazioni
e dei sentimenti descritti, la struttura generale tendeva a svincolarsi dall’ordina-
23
ta ripetizione di strutture uguali tra loro a favore di forme libere, con continui
cambiamenti di ritmo. Le melodie, prima semplici, venivano ad essere arricchite da abbellimenti, che snaturavano il ritmo verbale, e modulazioni, sia nella
linea vocale che, anche indipendentemente, nel suo accompagnamento. Le
accresciute potenzialità degli strumenti musicali (un maggior numero di fori
negli aujloiv e di corde nella kiqavra) facilitavano la possibilità di modulazioni,
in conformità con i mutamenti di carattere delle situazioni descritte. I generi
poetici, prima rigorosamente distinti nelle modalità del loro accompagnamento e delle loro caratteristiche musicali, venivano a confondersi in forme nuove
e indeterminate. Diventata sempre più complessa, la partitura musicale non
poteva in questi casi essere affidata ai ‘dilettanti’ della tradizione, richiedendo il
virtuosismo vocale e strumentale di un professionista: così decade la funzione e
l’importanza del coro negli spettacoli drammatici, mentre si impongono figure
di virtuosi idolatrati dal pubblico.
Questa evoluzione, che, insieme alle nuove strutture, individualistiche, di pensiero portate avanti dai sofisti e da Socrate, andò di pari passo con i radicali
mutamenti politici e sociali della fine del V secolo, fin dai suoi momenti iniziali
non poté che destare scandalo ed esecrazione in chi vedeva da essa minacciata
un’arte profondamente integrata in sé e strettamente funzionale alla tradizione
religiosa e civile. Ne sappiamo qualcosa dalle feroci parodie dedicate dalla commedia di Aristofane ai nuovi poeti (ma già ad Euripide)19: non è casuale,
comunque, che lo stesso Aristofane si trovi a ridurre, nel corso della sua carriera, numero e ampiezza delle parti affidate al coro, per dare maggior spazio ai
canti degli attori, evidentemente preferiti dal pubblico. Più tardi, quando ormai
la “nuova musica” si è affermata, arriverà la decisa condanna di Platone, che giudica la nuova arte assolutamente pericolosa, visto che essa suscita nell’uomo
emozioni e passioni tali da turbarne l’equilibrio.20
Ma, come si è detto, le nuove tendenze si erano ormai affermate. La rivoluzione
musicale aveva iniziato un processo che comportò alla fine l’emancipazione della
musica pura dalla poesia, che, gradualmente venne ad essere vista come un’arte a
sé stante: così è la grande produzione poetica a partire dall’Ellenismo. Il legame
parola-musica sopravvisse comunque fino in età romana, soprattutto nella tradizione cultuale, solitamente conservativa, ma anche in vari tipi di composizioni
destinate allo spettacolo. Continuavano ad essere eseguiti, almeno nell’epoca ellenistica, brani che passavano per essere (e forse erano veramente) musica dei grandi del passato come Euripide, comunque per lo più destinati ad una esecuzione
ben diversa da quella originaria, e cioè come ‘estratti’, arie da concerto per cantanti che si esibivano in poutpourri di composizioni. Ormai le personalità che si
affermano nell’ammirazione del pubblico sono gli esecutori, mentre non emergono più grandi personalità di poeti-musicisti paragonabili a quelle del passato.
24
Note:
1. Fino alla metà dell’800 erano noti solo gli inni attribuiti a Mesomede, musico greco vissuto al tempo di Adriano (II sec. d.C.), che erano stati pubblicati da Vincenzo Galilei nel
1581, e i sei brevi brani strumentali posti alla fine di una raccolta di scritti teorici anonimi di età tarda pubblicata nel 1841 da F.Bellermann (Anonyma de musica scripta Bellermanniana); altre composizioni, che erano fatte risalire all’antichità, sono oggi per lo più
considerate spurie (il più noto è il frammento della prima Pitica di Pindaro, vv. 1-8, che il
gesuita Athanasius Kircher pubblicò nel 1650, dichiarando di averlo scoperto in un manoscritto nella biblioteca di un convento a Messina, manoscritto la cui esistenza non è stata
più segnalata, anche perché negli anni successivi la biblioteca venne distrutta da un incendio). A partire dagli ultimi decenni del XIX secolo il patrimonio dei testi a noi noti si è relativamente arricchito grazie alla scoperta di alcune iscrizioni (fra cui, particolarmente notevoli, due inni, eseguiti a Delfi nel 128 a.C., di musicisti attici, di nome rispettivamente Ateneo e Limenio, testimonianza del successo ottenuto da compositore ed esecutori; un canto che il musico Sicilo fece incidere sulla propria pietra tombale nel II sec. d.C.; il frammento di un inno ad Asclepio trovato ad Epidauro su una pietra incisa probabilmente alla
fine del III secolo d.C., ma più vecchio, forse, di alcuni secoli), e un certo numero di brevi
frammenti papiracei, il più antico dei quali (P. Leid. inv. 510), contenente una selezione di
brani dall’Ifigenia in Aulide di Euripide, risale al III sec. a.C. Dei documenti musicali greci
in nostro possesso esiste una recentissima raccolta con edizione critica e commento
(Documents of Ancient Greek Music, edited by E.Pöhlmann and M.L. West, Oxford 2001).
2. Vv. 1221 s.
3. Vv. 784 ss.
4. Lo sviluppo della vita associata a livello aristocratico e- in particolare nella polis democratica- a livello popolare offre ai cittadini motivi sempre più frequenti di partecipare,
come spettatori o esecutori, a diverse forme di vita sociale che includevano uno ‘spettacolo’: nuove feste religiose, cerimonie di associazioni di devoti a particolari divinità, banchetti a cui partecipavano gli appartenenti alla stessa fazione politica.
5. Iliade I, vv. 472-474:“Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto, intonando un
peana bellissimo in onore del dio arciere, che si rallegrava ad udirli” [trad. G. Paduano,
Torino 1997].
6. La competizione è una caratteristica strutturale dell’agire dei Greci. E così nelle feste come
quelle ora descritte si affrontavano non solo cori, ma anche cantanti solisti e strumentisti,
quali suonatori di aujlovç e di kiqavra (che eseguivano brani puramente strumentali).
7. Iliade XVIII, 490-496: “Vi fece poi due città di uomini, bellissime: in una erano nozze e
banchetti; conducevano spose dalle loro stanze alla luce di fiaccole splendenti, in corteo
per la città; si levava alto l’imeneo, e giovani danzatori volteggiavano; fra di loro suonavano flauti e cetre: le donne in piedi, ognuna sulla sua porta, guardavano con stupore”
[trad. G.Paduano, cit.].
8. Fr. 44 Voigt.
9. È questo un gruppo di strumenti a corda (per il quale v. M.L.West, Ancient Greek Music,
Oxford 1992, 48 ss.), la cui struttura essenziale consisteva in una cassa armonica e in due
bracci che, partendo da essa, erano collegati da una traversina su cui si fissavano -in
numero variabile- corde di uguale lunghezza, collegate dall’altro capo alla parte inferiore
della cassa. Di questi strumenti la kiqavra rappresenta lo stadio più evoluto: la sua grande
cassa di risonanza, che continuava anche nelle basi dei due bracci, consentiva un ampio
volume di suono e fece sì che essa diventasse lo strumento professionistico per eccellenza. Per il suo impiego nella lirica corale cfr. West, Ancient Greek Music, cit., 336, 346;
M.Maas-J.McIntosh Snyder, Stringed Instruments of Ancient Greece, New Haven and
London 1989, 31, 60.
25
10. Di solito tradotto come “flauto”, il termine indica invece uno strumento ad ancia
(semplice o doppia); fra gli strumenti moderni il più vicino ad esso nella struttura essenziale è l’oboe. Aveva in genere due canne, ciascuna con un certo numero di fori.
11. Si veda ad esempio Pindaro, Olimpica III, 6 ss.: “Ora da me le ghirlande annodate
alla chioma reclamano un debito eretto dal dio: che io fonda in giusta misura il vario tono
di cetra e clamore di flauti e una trama di voci per il figlio di Ainesídamos [trad. L.Lehnus,
Milano 1981].
12. Lo strumento a corda di uso più comune (normalmente adoperato nell’educazione dei
giovani), che consisteva in una cassa armonica costituita in origine da un guscio di tartaruga e in due bracci che, a differeza della kiqavra, non costituivano un prolungamento
della cassa ma erano a questa applicati.
13. Amato in particolare dai poeti di Lesbo, era uno strumento la cui maggiore differenza con la luvra consisteva nella presenza di due lunghi bracci ricurvi. Le dimensioni molto ridotte della cassa di risonanza e la lunghezza delle corde dovevano produrre un suono di volume non ampio e di intonazione grave.
14. Teognide, vv. 239-243: “Sarai presente a tutte le feste e a tutti i banchetti posando sulle labbra di molti: te celebreranno al suono degli auli brevi d’acuta nota giovani seducenti
nell’armonia di melodiose canzoni” [trad. F.Ferrari, Milano 1989].
15. Plutarco, ad esempio, racconta (Vita di Nicia, 29, 4) come alcuni Ateniesi sopravvissuti al disastro militare di Siracusa (413 a.C.) nel corso della guerra del Peloponneso,
ottennero cibo e acqua grazie alla loro capacità di cantare brani di Euripide.
16. V. 101.
17. V. 69.
18. Insieme a frammenti minori, di lui ci è giunta una parte piuttosto ampia di una estesa composizione incentrata sulla battaglia di Salamina (fr. 15 Page).
19. Euripide, almeno nell’ultimo periodo della sua attività, sembra partecipe di alcune
delle nuove tendenze: così si potrebbe interpretare il maggior ricorrere di canti astrofici,
per lo più affidati agli attori. Aristofane, d’altro canto, gli rimproverava, non sappiamo
quanto a ragione, l’uso di una ridondante aggettivazione e di frequenti anadiplosi come
semplici pretesti per modulazioni musicali. E ancora, ne deprecava la mescolanza di
motivi provenienti da generi musicali diversi (Rane, vv. 1301 ss.: “lui prende il suo miele
dappertutto: canti di puttane, canzoni di Meleto, motivetti per l’aulo della Caria, compianti funebri, arie di danza”[trad. D.Del Corno, Milano 1985]). D’altra parte variazioni di
ritmo compaiono in particolare nelle virtuosistiche monodie tardo-euripidee; ed è ancora Euripide a introdurre in alcune delle sue ultime tragedie canti corali che sembrano
scorrelati dall’azione, basati come sono sulla narrazione di vicende mitiche e sul rincorrersi di belle immagini, forse precorrendo o rifacendosi al procedimento, che ci viene
attestato per il tragico Agatone, di introdurre al posto degli stasimi della tragedia canti
corali privi di aggancio con la situazione scenica, che si configurano come veri e propri
riempitivi.
20. Ciò si basa sulla concezione diffusa, attestata tra l’altro dai Pitagorici e da Damone,
secondo la quale la musica poteva alterare lo stato d’animo di chi la ascoltava, e che
quindi collegava a diversi effetti emozionali ed etici ritmi o modi musicali diversi.
> Fig. 5, vaso attico, 470 a.C. ca.: Alceo e Saffo con barbitoi. (München, Staatliche
Antikensammlung inv. nr. 2416).
26
27
28
‘Spartiti musicali’ nella Grecia ellenistica:
pluralità delle occasioni del canto e
discontinuità della tradizione
L UCIA P RAUSCELLO
C ARLO P ERNIGOT TI
Nonostante le più antiche testimonianze a noi pervenute, figurative e letterarie,
documentino un indissolubile e precoce legame fra elemento musicale, orchestico e testuale, deponendo così a favore di una diffusione generalizzata di una
profonda cultura musicale nella società greca fin dai tempi più remoti, il principale ostacolo per chi voglia tentare di ricostruire gli aspetti più propriamente
tecnici di questa intensa attività, come ad es. la tecnica di composizione, le
modalità di diffusione e trasmissione dei testi musicali, è dato, paradossalmente, proprio dall’esiguità e parzialità dell’evidenza documentaria. Attualmente
infatti, sebbene si tratti di un corpus suscettibile di aumentare nel corso degli
anni grazie a nuove scoperte papirologiche ed epigrafiche, per fare luce sul sistema notazionale della musica greca1 non possediamo più di una quarantina di
scarni frammenti di tradizione diretta, tutti databili in un periodo compreso fra
il III sec. a.C. e il IV/V d.C.2 Ci si trova dinanzi ad una selettività della testimonianza che investe in primo luogo l’asse cronologico: si tratta cioé di documenti posteriori almeno di due secoli alla grande stagione della lirica corale e
del teatro attico del V sec. a.C.
Perché dunque un tale vacat temporale nella nostra evidenza documentaria? Una
prima ragione va sicuramente ricercata nel fatto che sino alla fine del V/inizi del
IV sec. a.C. il principale veicolo di conoscenza e diffusione del patrimonio musicale era la performance orale, strettamente legata all’hinc et nunc della singola
occasione del canto, capace di condizionarne l’esecuzione non solo a livello
testuale ma anche ritmico e melodico, rapportandosi in prima istanza all’orizzonte di attesa del pubblico di volta in volta presupposto. Questo complesso
intreccio di improvvisazione secondo le singole istanze performative e di osservanza dei novmoi ereditati, unitamente alla conseguente semplicità/ripetitività
della linea melodica tradizionale presupposta da una tale realtà, non doveva verosimilmente comportare l’esigenza di un complesso sistema notazionale,3 supporto necessario per le fioriture, i melismi e le barocche modulazioni (kampaiv) della musica del ‘nuovo ditirambo’.
Tale ricostruzione, pur nella sua riconosciuta problematicità per quanto riguarda la
possibilità di stabilire con esattezza i limiti temporali della comparsa degli spartiti,4
< Fig. 3, Neapolitanus Gr. III C 4, 83r, XV saec. = Mesomede, Inni 4-5.
29
sembra comunque confortata, nelle sue linee generali, dall’evidenza iconografica
(questa volta fortunatamente già di epoca classica). Infatti varie raffigurazioni
vascolari del VI/V sec. a.C rappresentanti scene di scuola5 mostrano con chiarezza
come l’insegnamento del canto e della pratica strumentale, nei suoi vari livelli
(dilettantesco e professionale), fosse, a quanto sembra, interamente orale: l’allievo
apprendeva la tecnica per via mimetica, tentando di riprodurre il più fedelmente
possibile la gestualità e prassi esecutiva del maestro. All’evidenza iconografica si
affiancano inoltre significative testimonianze letterarie che, sebbene più tarde, sembrano confermare la relativa stabilità e continuità6 del sistema educativo musicale
nei suoi vari gradi di specializzazione. In tal senso, per un livello di istruzione musicale di base (come sembra suggerire l’associazione con la figura del grammatodidavvçkaloç), una delle testimonianze più esplicite è Plut. Mor. 790 e 7- f 2:
wJç ga;r oiJ gravmmata kai; mouçikh;n didavçkonteç aujtoi; proanakrouvontai
kai; proanaginwvçkouçin uJfhgouvmenoi toi'ç manqavnouçin, ou{twç oJ
politiko;ç ouj levgwn movnon oujd uj p
J agoreuvwn e[xwqen, ajlla; pravttwn
ta; koina; kai; dioikw'n ejpeuquvnei to;n nevon, e[rgoiç a{ma kai; lovgoiç
plattovmenon ejmyuvcwç kai; kataçchmatizovmenon.
“I maestri di grammatica e di musica guidano gli allievi eseguendo loro per
primi il pezzo o dando lettura del testo: così non è solo parlando o dando suggerimenti dall’esterno, ma impegnandosi di persona nell’amministrazione
della cosa pubblica, che un politico indirizza sulla giusta via i giovani, che
vengono plasmati e formati dall’insegnamento vivo e combinato delle azioni
e delle parole” (traduz. di G. Pisani, Plutarco, Moralia III, Pordenone 1992).
L’intero passo plutarcheo, istituendo una ben precisa equiparazione tra la figura del maestro (didavçkaloç) e quella dell’uomo pubblico (politikovç), evidenzia in entrambi i casi la priorità, educativa e maieutica, dell’exemplum pratico:
compito del grammatodidavvçkaloç (colui che impartiva i primi rudimenti dell’istruzione: leggere e scrivere), così come del maestro di musica strumentale
(kroumatopoiovç), era quello di guidare l’allievo mostrandogli per primo le
varie tecniche esecutive.7 Una distinzione così netta, quella greca, fra teoria e
prassi esecutiva, che la tecnica della notazione, in altre parole l’atto stesso di trasferire per iscritto il dettato musicale, non veniva considerata come specifica sfera di competenza del futuro compositore-esecutore: la composizione e la notazione erano percepite e praticate come due distinte attività professionali (da qui
la difficoltà di noi moderni a dissociare due pratiche attualmente coincidenti),8
per cui non era sorprendente il caso di un compositore (melopoiovç: letteralmente “autore di canti”) che non fosse in grado di notare i segni musicali o di
decifrare a prima vista uno spartito.9
30
Una dimensione ‘educativa’, scolastica, profondamente diversa, dunque, dalla
nostra, che richiede una progressiva e parallela acquisizione di un bagaglio di
informazioni sia teoriche sia pratiche da parte dell’allievo. Allo stesso modo, l’aspetto più propriamente teorico come la riflessione matematica sull’ampiezza
degli intervalli, la loro divisibilità interna e scomposizione numerica sono riservati, nell’universo culturale greco, esclusivamente all’ambito della speculazione
filosofico-matematica.
A questa prima ‘strozzatura’ diacronica si sovrappone un ulteriore ‘filtro’ interpretativo: l’estrema settorialità del destinatario di questi scritti. La quasi totalità
dei testi con notazioni musicali a noi pervenuti è costituita infatti da ‘copioni’
annotati degli stessi cantanti, strumentisti o maestri: in altri termini da quelli
che potremmo chiamare i ‘professionisti della musica’. L’evoluzione del gusto
musicale, precorsa e nel contempo testimoniata dalla scuola del ‘nuovo ditirambo’ (aspramente criticata, sul versante filosofico, da Platone e Aristotele, e
ridicolizzata, su quello letterario, dal conservatore Aristofane), con il progressivo affermarsi della monodia astrofica, dotata di maggiori possibilità espressionistiche e mimetiche rispetto alla struttura strofica corale, garante, con la sua
uniformità ritmico-melodica, anche dell’uniformità dell’ethos, portava con sé,
come naturale conseguenza, l’esigenza di un nuovo tipo di virtuoso del canto,
di attore professionista (tragwidovç), che, grazie a numerose fonti epigrafiche
di età ellenistica, sappiamo facente parte, a partire dal III sec. a.C., di vere e proprie compagnie teatrali istituzionalizzate (çuvnodoi o koina; tw'n Dionuçiakw'n
tecnitw'n), legalmente riconosciute e articolate secondo una precisa gerarchia
interna.
La tecnicità del destinatario presupposta da questi spartiti è per noi estremamente interessante sia in quanto strumento privilegiato per ricostruire la complessa realtà sociale ed artistica sottesa a nuove forme di spettacolo teatrale
proprie dell’età ellenistica (il teatro ormai divenuto luogo di ejpideivxeiç o ajkroavçeiç, esibizioni pubbliche in cui i virtuosi cantavano, accompagnati dalla
kiqavra o dall’aujlovç, qualsiasi testo sia lirico sia drammatico),10 sia come prezioso elemento di confronto/verifica testuale con quello che per noi è il principale ‘bacino collettore’ della nostra tradizione manoscritta per i testi classici: la
prassi editoriale alessandrina.11
Gran parte di questi testi con notazioni musicali rientrano infatti in una omogenea e ben precisa categoria tipologica: selezioni antologiche di brani tragici
(monodie, excerpta corali ma anche sezioni in metri originariamente destinati
alla sola recitazione o, tutt’al più, al recitativo: trimetri giambici e sistemi anapestici) e non (peani, prosodi, nomoi, accanto a interludi puramente strumentali), destinate non tanto ad essere adoperate come testi di lettura ad uso della
scuola, quanto all’ampio spettro di soluzioni esecutive in cui si articolava il
macrocosmo musicale greco, pubblico e privato, in età ellenistica. Si tratta
31
Fig. 7, P. Leid. inv. 510 = Eur. I. A.
1499 (?)-1509, 784-792, III a.C.
Fig. 8, P. Vind. G 2315 = Eur. Or. 338344, III a.C.
infatti di una tipologia di documenti che presuppone una pratica profondamente diversa da
quella attuale: la trascrizione fisica della partitura non serviva unicamente a garantirne la diffusione e riproducibilità ad opera di ogni potenziale fruitore e/o esecutore come avviene oggi,
ma rispondeva soprattutto all’esigenza della singola performance puntualmente circoscritta nella sua dimensione temporale e spaziale. Da questo punto di vista l’alta frequenza di papiri
musicali che presentano una successione contigua di componimenti di natura spesso molto
diversa, come ad es. il già citato P.Berol. 6870,
sembra deporre a favore di un utilizzo del supporto scrittorio essenzialmente come promemoria specifico del programma da eseguire: più che
di antologia in questo caso sarebbe forse preferibile parlare pertanto di vere e proprie suites di
brani di volta in volta apprestate dal musicista.
Tutto questo in un universo estremamente
diversificato e pluralista, che comprendeva dunque non solo ejpideivxeiç teatrali, cavallo di battaglia di richiestissimi virtuosi che radunavano
folle oceaniche per i loro recitals,12 così come di
più umili e periferici mestieranti radunati in
associazioni minori (çumfwnivai) che percorrevano la cwvra egiziana guadagnandosi a mala
pena di che vivere,13 ma anche singole esibizioni simposiali, in occasione di occorrenze più o
meno ufficiali o private che abbracciavano così
gran parte della vita quotidiana greca,14 cerimonie festive e religiose,15 sino a sconfinare in
performances ecletticamente eterodosse.16
Inoltre, come si è già sopra accennato, alcuni di
questi papiri musicali rappresentano per noi la
più antica fase della tradizione del testo di Euripide: si tratta di P.Leid. inv. 510, antologia euripidea con excerpta dell’Ifigenia in Aulide della
metà del III sec. a.C. [fig. 7] e P.Vind. G 2315,
recante parte del I stasimo dell’Oreste, anch’esso
testimone della fine del III sec. a.C [fig. 8].
32
Entrambi i testi ci consegnano infatti significative varianti testuali rispetto al
resto della tradizione medievale, lasciandoci nel contempo gettare uno sguardo
su quello che doveva essere un filone di tradizione tendenzialmente distinto ed
indipendente da quello testimoniatoci dall’ecdotica alessandrina, strettamente
legato agli aspetti performativi dei testi eseguiti e vincolato a sistemi di organizzazione interna (ritmizzazione e articolazione metrica) più fluidi ed ‘altri’
rispetto a quelli codificati dalla moderna prassi colometrica. Nel III sec. a.C. si
possono così osservare già operanti le linee di un graduale, profondo mutamento culturale che ha di fatto determinato la perdita di gran parte del patrimonio musicale scritto: già per i dotti filologi alessandrini la produzione poetica arcaica e classica (lirica corale, monodica e poesia drammatica) doveva essere percepita come destinata esclusivamente alla lettura, con conseguente disinteresse agli aspetti più propriamente performativi. Lo stretto legame che i testi
musicali a noi giunti mostrano con l’alta professionalità e specializzazione presupposte devono presumibilmente già da prima avere contribuito ad una precoce separazione fra tradizione della musica e tradizione del testo.
Un insieme di testimonianze, dunque, quelle offerte dai papiri musicali, che
lasciano problematicamente aperte molteplici prospettive di ricerca, che
dovranno essere affrontate non solo dagli specialisti dello studio della musica
nell’antichità ma da chiunque voglia tentare di avere una visione globale e onnicomprensiva della civiltà greca.
Note:
1. La notazione greca comprendeva due diversi
sistemi semiografici: uno destinato alla musica strumentale, presumibilmente più antico, forse derivato
da un alfabeto epicorico argivo, ed un secondo
destinato alla musica vocale (tale distinzione, netta
nei trattati teorici, sembra in parte sfumare negli
spartiti a noi giunti). Entrambi utilizzavano le lettere
dell’alfabeto ionico classico o nella forma normale
(ojrqovn), o disposte orizzontalmente (ajneçtrammevnon:
suono innalzato di una diesis enarmonica o cromatica) o rovesciate (ajpeçtrammevnon: ulteriore innalzamento di una seconda diesis enarmonica o cromatica) o con l’aggiunta di un apex o modificate nella
figura. A ciò va aggiunta la presenza di segni chironomici (indicanti effetti di pausazione, superallungamento della sillaba - anche attraverso la reduplicazione vocale -, legatura etc.) che dovevano servire ad interpretare ritmicamente il dettato, spesso
andando a modificare la maglia metrica sottostante.
Tutti questi çhvmata (segni) venivano solitamente
apposti supra lineam rispetto al testo del mevloç a cui
33
Fig. 1, Kopenhagen inv. nr. 14897 =
epitafio di Sicilo, II d.C.
si riferivano, cfr. M.L. West, Ancient Greek Music,
Oxford 1992, pp. 254-276.
2. Si tratta per lo più di frammenti papiracei, a cui va
aggiunta qualche iscrizione - i peani delfici (128 a.C.),
un inno esametrico ad Asclepio (SEG 30. 390) e uno
a Sinuri (Mylasa inv. 3) di età ellenistica, l’epitafio di
Sicilo (II d.C., vd. fig. 1): tutti documenti conosciuti
solo a partire dalla metà dell’800 - unitamente alla
testimonianza della tradizione manoscritta (gli inni
citarodici di Mesomede di Creta, di età adrianea - vd.
figg. 2-3 (fig. 3, vedi p. 28) - e numerosi scritti teorici
di tarda età imperiale). L’edizione più recente di tali
documenti è quella di E. Pöhlmann-M.L. West, Documents of Ancient Greek Music, Oxford 2001.
3. Basti pensare all’importanza dell’elemento estemporaneo nella prassi simposiale e, conseguentemente,
alla scarsa rilevanza ed utilità del testo scritto: eseguire era molto spesso un ricreare, un rifare ogni volta.
Fig. 2, Neapolitanus Gr. III C 4, 82v,
XV saec. = Mesomede, Inni 1-4.
4. L’altezza cronologica in cui sarebbe stata introdotta e si sarebbe diffusa l’adozione del sistema notazionale è uno dei problemi tuttora più dibattuti e su cui
manca un consenso generale da parte degli studiosi,
fondamentalmente divisi tra metà V (notazione strumentale)/fine V (notazione vocale) e tardo IV sec. a.C.,
cfr. e.g. rispettivamente West, op. cit., pp. 269-273 e
G. Comotti, La musica nella cultura greca e romana,
Torino 19912, p. 9. Per i tentativi di E. Pöhlmann, Beiträge zur antiken und neueren Musikgeschichte,
Frankfurt am Main 1988, pp. 61-69, di individuare
traccia di spartiti musicali in raffigurazioni vascolari
antecedenti alla fine del V sec. a.C., rappresentanti
scene di canto e di lettura (probabilmente si tratta in
realtà di semplici “libretti”), cfr. le giuste obiezioni
mosse da A. Bélis, La trasmissione della musica nell’antichità, in F. Berti-D. Restani, Lo specchio della
musica. Iconografia musicale nella ceramica attica di
Spina, Bologna 1988, pp. 34-35, West, op. cit., pp.
263-264 n. 23 e L.P.E. Parker, Consilium et ratio? Papyrus A of Bacchylides and Alexandrian Metrical Scholarship, «CQ» 51 (2001), p. 36 n. 19. Sull’ipotetica esistenza, già nel V sec. a.C., di una rudimentale semiografia per il solfeggio concorrente a quella “savant”,
cfr. Pöhlmann-West, op. cit., p. 8.
5. Cfr. e.g. hydria di Phintias, 500 a.C. ca.: lezione di
lira (München, Staatliche Antikensammlung, n. inv.
2421); skyphos attico a figure rosse di Pistoxenos,
datato al 475 a.C.: Ificle a lezione di lira da Lino
(Schwerin, Landesmuseum, n. inv. 708), vd. fig. 4;
skyphos attico a figure rosse di Douris, 480 a.C. ca.:
lezione di lira ed aulo (Berlin, Staatliche Museen, n.
inv. F 2285), vd. fig. 5-6.
6. H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’anti-
34
quité, Paris 1965 6, p. 553 n. 7 ribadisce l’aspetto eminentemente orale dell’insegnamento musicale anche
per epoche successive a quella classica.
7. Un livello sempre elementare dell’insegnamento
musicale è testimoniato anche da Ael. V.H. 3. 32
(Alessandro Magno impara a suonare la kiqavra): la
dinamica del racconto, con il maestro che dice, al
cospetto dell’alunno, quale corda pizzicare e l’alunno
che ne indica (deivxaç) un’altra, lascia presupporre una
modalità di apprendimento ugualmente mimetica.
Sul versante dell’istruzione professionistica cfr. invece Plut. Demet. 1. 6 (i maestri in questo caso sono i
tebani Ismenia ed Antigenida, acclamati virtuosi dell’auletica fra il V/IV sec. a.C.).
8. Cfr. A. Bélis, Les Musiciens dans l’Antiquité, Paris
1999, pp. 159 e 163.
9. Conosciamo comunque delle eccezioni significative, vd. ad es. P.Berol. 6870 (antologia musicale del IIIII sec. d.C., contenente, nell’ordine, un peana, un
interludio strumentale, un excerptum tragico: anche
questa sola contiguità esecutiva di ‘occasioni’ del
canto così statutariamente diverse in epoca classica
traduce bene la profonda modificazione della percezione della dimensione spettacolare in età imperiale).
In questo importante papiro infatti la mano che ha
vergato il pezzo strumentale è la medesima che ha
redatto il testo, e l’interludio strumentale stesso presenta tante e tali correzioni, così profondamente
diverse dalla prima versione, da fare pensare non ad
un semplice errore di copiatura ma alle tracce materiali di un compositore al lavoro: ci troveremmo dunque dinanzi addirittura ad un esemplare autografo di
una partitura originale. Il medesimo problema si
ripresenta anche per P. Mich. 2958 (II d.C.); cfr. Bélis,
op. cit., p. 177.
10. Talora con interventi episodici di un coro, quasi a
riprodurre, mimeticamente e visivamente, l’integrità
dello spazio orchestico del teatro classico del V sec.
a.C. L’esempio più noto è quello di S.I.G. 648 B: l’auleta Satiro di Samo nel 194 a.C., nello stadio di Delfi,
si esibì in uno spettacolo comprendente il canto delle
parti di Dioniso nelle Baccanti di Euripide, con l’accompagnamento della cetra e con l’intervento amebeo del coro (a\içma meta; corou' Diovnuçon kai; kiqavriçma
ejk Bakcw'n Eujripivdou; cfr. B. Gentili, Lo spettacolo nel
mondo antico, Roma-Bari 1977, pp. 17-18 n. 39): un’abile operazione di antologizzazione musicale, con
conversione in canto anche di metri originariamente
recitati (trimetri giambici). Un altro esempio di canto
amebeo fra coro e attore, questa volta nel I sec. a.C.,
sempre nell’ambito di una performance che prevedeva selezioni tragiche, ancora una volta dalle Baccanti
35
Fig. 4, skyphos attico a figure rosse
di Pistoxenos, da Cerveteri, 475 a.C.
ca.: Ificle a lezione di lyra da Lino.
(Schwerin, Landesmuseum n. inv.
708).
Fig. 5, coppa attica a figure rosse di
Douris, 480 a.C. ca.: lezione di
musica (lyra).
(Berlin, Staatliche Museen F 2285).
Fig. 6, coppa attica a figure rosse di
Douris, 480 a.C. ca.: lezione di
musica (aulos).
(Berlin, Staatliche Museen F 2285).
di Euripide, è testimoniato da Plut. Crass. 33. 6, sebbene in un contesto significativamente diverso (simposiale): quando la testa di Crasso venne portata al cospetto di Orode, re dei Parti, durante un banchetto (eJçtiavçeiç kai; povtoi) che comprendeva la rappresentazione di molti spettacoli provenienti dalla Grecia (kai; polla; pareiçhvgeto tw'n ajpo;
th'ç JEllavdoç ajkouçmavtwn), l’uJpokrithvç (attore) Giasone di Tralle stava per l’appunto intrattenendo i convitati con una selezione tragica comprendente parti di Agave che includevano anche l’intervento del coro: ∆Iavçwn o[noma Tralliano;ç h\iden Eujripivdou Bakcw'n ta; peri;
th;n A
j gauvhn [...] ajidomevnwn de; tw'n ejfexh'ç ajmoibaivwn pro;ç corovn ktl. (“un attore tragico, di
nome Giasone, di Tralle, stava cantando il brano delle Baccanti di Euripide che riguardava Agave [...] quando poi fu cantato il dialogo seguente col coro...”, trad. di C. Carena,
Plutarco. Le vite di Nicia e di Crasso, Milano 1993).
11. Contro il tentativo di T.J. Fleming-E.C. Kopff, Colometry of Greek Lyric Verses in Tragic Texts, «SIFC» s. III 10 (1992), pp. 758-770, e T.J. Fleming, The Survival of Greek Dramatic Music from the Fifth Century to the Roman Period, in B. Gentili- F. Perusino, La
colometria antica dei testi poetici greci, Roma 1999, pp. 17-29, di istituire un legame diretto fra filologia alessandrina e testi con notazioni musicali, cfr. da ultimo le obiezioni della Parker, art. cit., pp. 35-36 n. 16.
12. Uno degli elementi più appariscenti della vita culturale ellenistica è proprio una più
accentuata spettacolarità, insieme con la creazione di nuovi contesti performativi. L’esibizione di questi tragwidoiv era vissuta come un momento di puro intrattenimento che
godeva di grande popolarità: è in contesti come questo che il testo poetico continuò ad
essere espresso in stretto legame con l’elemento musicale, diversamente da quanto
avveniva nella cultura ‘alta’, erudita e scritta delle corti ellenistiche, cfr. R. Pretagostini,
«Mousike»: poesia e «performance», in S. Settis, I Greci. Storia Cultura Arte Società. 2.
III, Torino 1998, p. 626.
13. Il mondo sommerso di questi spesso mediocri ‘artisti di provincia’, secondo la felice
definizione di P. Collart, Réjouissances, divertissements et artistes de province dans
l’Egypte romaine, «RPh» 18 (1944), pp. 132-155, ci è noto soprattutto grazie a papiri egiziani di età tolemaica e romana: statutariamente inferiori rispetto alla potente corporazione dei tecni'tai dionisiaci, le loro associazioni, interamente profane, erano costituite da
effettivi variabili (essenzialmente strumentisti, danzatori e qualche cantante: da un minimo di due a dieci e più elementi) solitamente ingaggiati da committenze private per un
periodo limitato di tempo, cfr. Bélis, op. cit., pp. 61 ss.
14. Si pensi al già citato episodio narrato da Plut. Crass. 33. 2 ss., ancora più significativo in quanto attesta il persistere di tale prassi simposiale in zone periferiche della cultura mediterranea del I sec. a.C. Un’altra testimonianza, sempre in un contesto di banchetto e brindisi privato, è Plut. Lys. 15. 4 ss., in cui si narra della commovente esibizione
‘estemporanea’ di un vecchio focese che, per impedire la distruzione di Atene (404 a.C.)
dinanzi ai generali spartani brindanti alla sconfitta del nemico, intona un brano euripideo
(celebre episodio immortalato anche da J. Milton, Sonn. VIII, 12-14): ei\ta mevntoi çunouçivaç
genomevnhç tw'n hJgemovnwn kai; para; povton tino;ç Fwkevwç a[içantoç ejk th'ç Eujripivdou H
j levktraç
th;n pavrodon, [...] pavntaç ejpiklaçqh'nai, kai; fanh'nai çcevtlion e[rgon th;n ou{twç eujklea' kai;
toiouvtouç a[ndraç fevrouçan ajnelei'n kai; diergavçaçqai povlin (“I capi si riunirono allora per
decidere, ma quando, nel corso di una bevuta, un Focese intonò l’inizio della parodo dell’Elettra di Euripide [...] tutti furono presi da un moto di pietà e compresero l’assurdità di
voler distruggere e cancellare dalla faccia della terra una città tanto gloriosa e che dava i
natali a uomini di tanto valore”, trad. di G. Pisani, Plutarco, Le vite di Lisandro e di Silla,
Milano 1997).
15. Cfr. la celebrazione della panhvguriç tw'n Nemeivwn nel 205 a.C. descritta in Plut. Philop.
11. Qui Pilade, rinomato kiqarwidovç del suo tempo, intona casualmente l’incipit dei Persiani di Timoteo proprio durante l’ingresso nel teatro di Filopemene, vincitore di Mantinea:
a[rti d j aujtw'n eijçelhluqovtwn, kata; tuvchn Pulavdhn to;n kiqarwido;n a[idonta tou;ç Timoqevou
36
Pevrçaç ejnarxavçqai ktl. (“Essi erano appena entrati quando per un caso fortuito il citaredo Pilade, eseguendo i Persiani di Timoteo, cominciò a cantare”, trad. di E. Melandri, Plutarco, Vite parallele. Filopemene. Tito Flaminio, Milano 1997).
16. Si pensi soprattutto all’episodio dei prigionieri ateniesi nelle latomie quale descritto
da Plut. Nic. 29. 2 ss., parte dei quali ebbe salva la vita sia per avere insegnato ciò che
essi ricordavano delle tragedie di Euripide (ejkdidavxanteç o{ça tw'n ejkeivnou poihmavtwn
ejmevmnhto: dunque presumibilmente i pezzi più famosi - quelli che chiameremmo highlights) sulla base della loro esperienza di spettatori tragici e occasionali coreuti, sia intonando i canti in prima persona (tw'n melw'n a[içanteç). Questo passo plutarcheo è inoltre
particolarmente importante perché testimonia non solo la consolidata fama di Euripide
nella Magna Grecia dell’ ultimo squarcio del V sec. a.C., ma sembra anche prevedere
come modalità di diffusione della poesia euripidea una qualche forma di operazione
antologizzante: mavliçta ga;r wJç e[oike tw'n ejkto;ç E
J llhvnwn ejpovqhçan aujtou' th;n mou'çan oiJ
peri; Sikelivan kai; mikra; tw'n ajfiknoumevnwn eJkavçtote deivgmata kai; geuvmata komizovntwn
ejkmanqavnonteç ajgaphtw'ç metedivdoçan ajllhvloiç (“Infatti pare che quelli di Sicilia amassero la poesia di Euripide più di tutti gli altri Greci abitanti fuori della Grecia, studiavano a
memoria con amore i brevi brani e saggi che via via giungevano fino a loro, portati da
qualcuno, e se li scambiavano a vicenda”, trad. di C. Carena, op. cit., corsivi nostri).
37
Iconografia musicale
F RANÇOIS L ISSARRAGUE
Non è facile intervenire dopo queste relazioni,
oltretutto parlo in italiano da francese e vi chiedo scusa per i miei errori. Vorrei fare un discorso un po’ diverso da quelli fatti fino ad ora:
anch’io mi lamento della perdita della musica
antica, non voglio però farvi piangere di più,
basta così! È però vero, siamo quasi nella condizione degli affreschi che si intravedono in questa chiesa: qualcosa che c’era, ma che è andata
perduta.
Quello che abbiamo sulla musica greca sono in
primo luogo i discorsi dei Greci - ovvero i trattati teorici -, secondariamente gli elenchi dei
vincitori nelle competizioni e, infine, bellissimo
materiale visivo. Possediamo un intero percorso
visivo sulla musica, che non posso esplorare in
tutti i particolari in questa mezz’ora; voglio solo
sceglierne un aspetto: quello dell’inquadramento religioso e mitologico. Consideriamo i vasi che abbiamo già esaminato come ‘documenti’,
in quanto permettono di vedere aspetti tecnici
degli strumenti - come ‘monumenti’. Qui [fig.
1] abbiamo Apollo con la lyra, raffigurata in
modo molto preciso, che ci aiuta a capire la
struttura degli strumenti; ma questo oggetto è
anche un vaso per bere, che viene utilizzato per
il simposio. Il simposio è il momento in cui si
beve tra amici, è una attività maschile, prettamente maschile, senza la presenza di donne
(aspetto di cui bisognerà forse parlare in seguito); è una attività collettiva in cui la memoria
comune della poesia e della musica viene attivata nei bevitori dagli oggetti d’uso, dai vasi illu-
39
Fig. 1, coppa attica a fondo bianco,
da Delfi, 470 a. C., Apollo
(Delfi, Museo archeologico)
< Fig. 1a, lyra. Ricostruzione
di Giorgos Polyzos, 1991.
Fig. 2, cratere attico a figure nere,
firmato da Kleitias, 570 a. C., la Musa
Calliope (Firenze, Museo
archeologico 4209)
Fig. 3, anfora attica a figure rosse,
pittore di Berlino, 490 a. C.,
suonatore di kitara
(New York MMA 56. 171.38)
Fig. 4, cratere attico a figure rosse,
firmato da Euphronios, 510 a. C.,
concorso musicale
(Parigi, Louvre G 103)
strati con i più vari argomenti, comprese le raffigurazioni della pratica musicale, della didattica, come abbiamo visto, ma anche dei grandi
miti e delle divinità legate alla musica, tra le quali Apollo, chiaramente, è la figura più cospicua.
Faccio un brevissimo elenco di questi casi.
Su questo particolare del vaso François a Firenze
[fig. 2] c’è una lunga processione di divinità tra
le quali le Muse. Calliope è vista di fronte, sta
suonando la syrinx inventata da Pan, uno strumento che nella pratica musicale trasforma il
viso, deformandolo. La Musa, invece, ha un
nome molto preciso “colei che ha un bel viso”,
che non viene deformata e che quindi controlla
lo strumento. Altro è la cetra ovvero la kithara non ne parlerò a lungo perché lo farò in seguito - che è lo strumento del concertista, del vero
virtuoso. Qui [fig. 3] abbiamo un bellissimo
disegno del Pittore di Berlino, siamo intorno al
500 a. C., che fa vedere la vivacità, la forza della musica dalla quale il suonatore è preso. Ultimo in questa brevissima lista di strumenti è
l’aulos, di cui si è già parlato. Alla figura 4 abbiamo l’esempio di un cratere per mescolare il
vino, su cui si vede un giovane suonatore che sta
salendo su una piccola tribuna, forse una piccola scena, per un concorso. Queste raffigurazioni, dunque, non sono da parte dei Greci frutto
di un interesse da musicologi, ma da bevitori al
simposio, che amano il connubio della musica
col vino. Un secondo scopo delle rappresentazioni può essere il voler tramandare il ricordo
della vittoria ad un bel concorso, un successo:
pertanto è questo che abbiamo, non “documenti” ma “monumenti”, che mantengono in circolo la memoria di un evento tra i bevitori.
Non posso prendere in esame tutte le storie
mitiche che circolano sulla musica, poiché ce ne
sono moltissime; ne ho scelte due: quella di
Orfeo e quella di Marsia, giacché tutte e due
mettono in questione, problematizzano lo sta-
40
tuto della musica nella cultura, oppure lo statuto degli strumenti.
Nella cultura moderna noi conosciamo la storia
di Orfeo come legata ad Euridice, al tema della
vittoria sulla morte, della forza superiore dell’amore, ma nella versione in cui lui la guarda e lei
sparisce negli Inferi: una storia tristissima sulla
quale non voglio insistere anche perché i Greci
non lo fanno. I Greci, o meglio, quelli che hanno prodotto questi vasi, gli Ateniesi del V secolo a. C., non hanno creato alcuna iconografia di
Euridice; ciò che abbiamo nei vasi del V sec. è
la storia di Orfeo divisa in due momenti, quello del potere della sua musica e quello della sua
morte. Parto da questo vaso [fig. 5] sul quale è
raffigurato un suonatore di kithara in un concorso, che sta per salire sul bema (piedistallo).
C’è una iscrizione “chaire Orpheus” che è un
saluto: “Salve Orfeo”. Non credo che questo sia
il nome del musicista; lo interpreto come un
saluto, un paragone, una metafora della bravura del musicista paragonabile a quella di Orfeo,
ma sono sicuro che questa non sia la raffigurazione di Orfeo stesso, perché l’iconografia che
lo riguarda è diversa: non suonando lui la kithara, come questo musicista, ma la lyra. Un filone
iconografico relativo ad Orfeo è di questo tipo
[fig. 6]: un suonatore dall’aspetto perfettamente greco, seduto, con la lyra, è attorniato da
uomini che lo ascoltano, vestiti da barbari, da
Traci: ne hanno i capelli, gli animali, la zeira, il
vestito che li caratterizza come barbari; siamo
dunque nella Tracia, cioè “fuori” dalla Grecia,
luogo in cui Orfeo suona e incanta il mondo
intorno a lui. Una osservazione va fatta anche
riguardo a questo aspetto: nella pittura moderna noi siamo abituati a vedere Orfeo che incanta gli animali, non i guerrieri, ma l’iconografia
del V secolo non conosce questa rappresentazione e al contrario è veramente specifica: mette in scena Orfeo che immobilizza i cavalieri.
41
Fig. 5, oinochoe a figure nere, classe
di Briachos, 500 a. C., concorso
musicale (Roma Villa Giulia, M 534)
Fig. 6, cratere attico a figure rosse,
pittore di Orfeo, 440 a. C., Orfeo fra i
Traci
(Berlino Staatliche Museen 3172)
Fig. 7, cratere attico a figure rosse,
pittore di Napoli, 440 a. C., Orfeo fra
i Traci (Hamburgo 1968. 79)
Fig. 8, stamnos attico a figure rosse,
pittore della Dokimasia, 490 a. C., la
morte di Orfeo (Basilea, ex
collezione Bolla, in deposito all’
Antikensammlung)
Fig. 9 e 9a, id, particolare
Fig. 9a.
Che siano cavalieri lo si vede dal vestito: di solito il guerriero si muove, ma in queste raffigurazioni essi sono completamente immobilizzati.
Osservate come il secondo a sinistra, che vediamo frontalmente, tenga gli occhi chiusi, totalmente assorbito nell’ascoltare la musica: è quasi
pietrificato, immobilizzato, come se il potere
della musica fosse capace di bloccare l’attività
dei guerrieri. Ci sono molti altri esempi dello
stesso periodo (460 a. C.), in cui vediamo alcuni guerrieri con il cavallo alla loro destra, dunque cavalieri che non si muovono.
Su questa immagine [fig. 7] c’è un particolare
molto interessante: vediamo Orfeo seduto, con
una corona d’alloro - raffigurato in modo molto apollineo, dunque - e sotto di lui ci sono una
tartaruga e una pietra. La tartaruga, l’animale
che serve a creare la lyra - e sappiamo da un
Inno omerico che è stato Ermes a inventare lo
strumento - finché è viva non ha voce, ma
appena muore suona, prende voce. L’oggetto
stesso, inoltre, è duro come una pietra. Il simbolo, però, è più profondo, giacché per i Greci
la pietra è simbolo della morte, e pietrificare
qualcuno (come nel mito della Gorgone che
pietrifica gli uomini) è un tipo di morte. Nuovamente dunque le immagini giocano sul concetto di “vivo” e sul simbolo della “pietra”, sulla capacità di immobilizzare gli uomini, su un
mondo che si blocca.
L’altro aspetto del mito di Orfeo compare quasi contemporaneamente nell’iconografia. Le
prime immagini che abbiamo raccontano la
morte di Orfeo e qui [fig. 8] lo si vede a terra
ammazzato dalle donne. La forza di Orfeo è
capace di bloccare tutte le attività maschili; per
questa ragione sono le donne ad ammazzarlo e
in modo molto violento: a sinistra una tiene un
sasso enorme, un’altra ha una pietra, altre hanno dei pestelli e nella coscia di Orfeo c’è uno
spiedo. Non usano, pertanto, delle armi da
42
guerra, ma oggetti, sia naturali (pietre, sassi) sia
della vita quotidiana, della cucina, del lavoro,
che vengono utilizzati nella violenza istantanea
di questo scatenamento da parte delle donne
tracie. Vediamo nei particolari (figg. 9, 9a) i sassi e il pestello - strumento che serve per lavorare il grano - diventare un bastone, un’arma violentissima. C’è una distorsione tra l’uso normale degli oggetti e quello che accade. Se mettiamo assieme queste immagini con quelle analizzate poco fa, concludiamo che abbiamo da una
parte gli uomini che non fanno più nulla, dall’altra le donne che si scatenano: c’è quindi un
contrasto molto forte tra la percezione della
musica da parte degli uomini e delle donne.
Quello che le donne fanno, però, è solo salvare
l’oikos e la vita di famiglia, giacché gli uomini
sono bloccati. In questo racconto - non sono io
a inventarlo, è così che viene raccontato dalle
immagini - l’unico modo per sbloccare questa
situazione è sopprimere Orfeo, ammazzarlo. Su
questo vaso [fig. 10], una hydria - un vaso attico della metà del V secolo, utilizzato dalle donne per prendere l’acqua alla fontana e portarla a
casa - vediamo due disegni [figg. 11 e 12] che
fanno capire meglio lo svolgersi dell’azione:
abbiamo Orfeo al centro, che compare nuovamente a destra mentre sta cadendo, cercando di
difendersi con la lyra - diventata un’arma, in
questo caso - mentre le donne lo aggrediscono
con degli spiedi. Dietro un albero c’è un uomo
che si nasconde, quindi ne deduco che l’episodio non riguardi una lotta tra uomini e donne giacché gli uomini non fanno nulla, sono ancora bloccati - e che il motivo del conflitto sia lo
statuto stranissimo della musica nel mondo dei
barbari. C’è un eccesso da parte degli uomini
che ascoltano e non fanno più nulla e c’è un
eccesso da parte delle donne che al posto di
ascoltarla la distruggono. Ci troviamo, credo,
davanti ad una visione del “cattivo uso della
43
Fig. 10, idria attica a figure rosse,
pittore delle Niobidi, 460 a. C., morte
di Orfeo (Boston MFA 90.156)
Fig. 11 e 12 (sotto), id, disegno
Fig. 13, cratere attico a figure rosse,
pittore della Centauromachia del
Louvre, 440 a. C., Orfeo i Traci e le
donne trace (Napoli, Museo
Archeologico H 2889, inv. 81 868)
Fig. 14, id, particolare
musica”. È di questo che parlano le immagini
relative al “non ascoltare bene”. Sull’altra parte
dello stesso vaso [fig. 12]: compaiono di nuovo
Orfeo, una donna con una spada, poi un’altra
con una falce - utensile per il lavoro dei campi
ma anche strumento che serve a tagliare la testa
e altre… “parti”, pensate a Urano che fu castrato - poi di nuovo un uomo che non si muove:
dunque è veramente insistente la descrizione di
questo contrasto tra il movimento delle donne e
l’immobilità degli uomini.
In un altro vaso [fig. 13], al Museo di Napoli,
abbiamo una soluzione grafica un po’ diversa. Si
tratta di un cratere in cui l’immagine viene divisa su due livelli. Al livello superiore c’è Orfeo,
nello stesso schema iconografico, seduto con la
lyra e intorno a lui uomini che non si muovono
tra i quali uno è un Tracio, con un bel vestito
ornato di bende nere e il cappello da cavaliere;
al livello inferiore ci sono già le donne che arrivano correndo di nuovo con un’ascia, una lancia e altri strumenti. L’ascia non è un’arma di
guerra, chiaramente: veniva usata per tagliare il
legno, ma serve anche per il sacrificio e si evidenziano, dunque, dietro questa storia, anche
delle connotazioni sacrificali.
Esaminiamo un altro particolare [fig. 14] dello
stesso vaso, con il contrasto già descritto con
Orfeo ascoltato da uomini e ammazzato da
donne: versione stranissima per noi. Noi siamo
abituati a una mitologia organizzata, da dizionario, da libri scolastici, ma di fatto non c’è
mitologia al di fuori dei testi o delle immagini
che la fanno funzionare: non c’è nel mondo greco una mitologia teorica come la Bibbia, un
libro chiuso, completo, intoccabile; la mitologia
greca è sempre aperta alle trasformazioni, un
mito agisce sull’altro, è molto malleabile. Anche
la musica funzionava così: si parlava di improvvisare, di ricreare, non di conservare e bloccare,
ma di far giocare le possibilità significative di
44
ognuna di queste storie. Il caso di Orfeo è interessante perché vediamo che le storie per noi
prestabilite - Euridice, gli animali - in realtà non
appaiono; sappiamo altresì che c’è una tragedia,
quasi contemporanea a questi vasi, perduta per
noi, di Eschilo, nella quale le donne che uccidono Orfeo sono delle Menadi, cioè delle donne della cerchia di Dioniso. In questa raffigurazione, da quello che vediamo, nessuna delle
donne ha il tirso, né gli elementi dionisiaci,
quindi i pittori hanno scelto di rappresentarla
come ho cercato di descriverla: con donne e
uomini “barbari” dal punto di vista greco, e
anche se le donne hanno dei tatuaggi, questi le
possono caratterizzare come barbare o come
schiave, ma certamente non come seguaci di
Dioniso. Poi con il tempo compaiono altri miti
che raccontano la versione eschilea: Orfeo, che
voleva onorare solo Apollo e non aveva alcun
interesse per Dioniso, viene ammazzato dalla
donne che sono, in questo caso, delle Menadi.
La versione dei vasi, ripeto, è un contrasto tra
uomini e donne e in questo conflitto ciascuno
non usa bene la musica, non la sa “sentire” e
“utilizzare” adeguatamente.
Ci sono, poi, altri miti attorno ad Orfeo: le donne lo ammazzano, lo fanno a pezzi e la testa di
Orfeo ha vita sua propria, viene trasportata dal
mare e finisce a Lesbo, luogo ove sorge un oracolo di Orfeo. Abbiamo pochissime immagini della fine del V secolo, tra le quali questa [fig. 15] su
cui vediamo alcune delle Muse con gli strumenti, una a sinistra con l’aulos, l’altra a destra con la
lyra; la testa di Orfeo è al suolo, l’uomo che la sta
guardando forse è Eumolpo, ma l’identificazione
non è sicura. La testa [fig. 16] è interessantissima: è una testa viva, ha occhi aperti che parlano. Si è anche insistito sullo statuto della parola nella pratica musicale greca e quanto descritto è un caso limite, perché riguarda la parola
“oracolare”, che profetizza dicendo cose che
45
Fig. 15, idria attica a figure rosse,
Gruppo di polignoto, 440 a. C.,
scoperta della testa di Orfeo (Basilea,
in deposito all’ Antikensammlung)
Fig. 16, id, particolare
Fig. 17, coppa attica a figure rosse,
pittore della testa di Orfeo, 400 a.C.,
la testa oracolare di Orfeo
(Cambrige, Corpus Christi College)
Fig. 18, oinochoe attica a figure
rosse, 450 a. C., Atena butta l’aulos
di fronte a un satiro (Berlino, F 2418)
acquistano senso tramite un’interpretazione
specifica. È proprio ciò che si vede su questo
vaso [fig. 17] della fine del V secolo, sul quale
vediamo la testa “viva”, con occhi e bocca aperti e un giovane seduto che scrive le parole dell’oracolo; a destra il dio Apollo, con un ramo
d’alloro, indica la testa e lo scrittore. Il potere
della musica di Orfeo diventa, in questo episodio, il potere oracolare della parola, sotto il controllo di Apollo.
Un’altra storia importante nell’iconografia musicale e mitologica è quella di Marsia e dell’aulos.
L’aulos è uno strumento inventato da Atena al
momento della morte di Medusa: quando la
Gorgone viene decapitata da Perseo, le sorelle
piangono, emettendo grida stridenti che Atena
cerca di imitare usando una canna e inventando
così uno strumento simile all’aulos. Suonando
questo strumento mimetico, che imita un grido
naturale - o quasi naturale - si accorge però che
il suo viso ne viene deformato e quindi lo getta
via, perché, ovviamente, vuole essere una dea
con un bel viso - capite adesso perché in precedenza avevo insistito sull’importanza del significato del nome della musa Calliope. Gettato da
Atena, lo strumento viene raccolto da Marsia il
satiro, già brutto di viso e che quindi non si
preoccupa della propria bellezza ma solo del suono dell’aulos. Qui [fig. 18] abbiamo una delle
poche immagini con Atena che ha da poco gettato via l’aulos: si vedono i due tubi e il satiro che
sembra accorgersi in questo stesso momento di
questo bellissimo strumento.
La storia prosegue: Marsia suona l’aulos, diventa un suonatore perfetto, eccezionale, e si vanta
di poter suonare meglio di Apollo, commettendo il peccato di hybris, d’orgoglio, nel paragonarsi alla divinità: atto insopportabile, poiché
non si deve gareggiare con gli dei (e credo proprio che Apollo sia una delle divinità più suscettibili). Abbiamo una iconografia specifica sulla
46
gara tra Apollo e Marsia. Questa [fig. 19] è l’unica scultura che in questa occasione prendo in
esame: è un rilievo di Mantinea della fine del IV
sec. a. C., dunque più tardo dei vasi esaminati
fino ad ora. Lo faccio vedere perché il disegno
con Marsia che suona somiglia molto allo schema del Marsia che scopre l’aulos, iconografia
che sarà probabilmente una citazione, forse da
Mirone, ma non voglio discutere questo. In
questo rilievo si vede a sinistra, seduto sulla roccia, Apollo con la kithara, il grande strumento,
e a destra Marsia, che suona; al centro, infine,
uno schiavo in costume barbaro con un coltello
in mano, particolare molto importante, perché
- vi ricordate la storia? - Marsia perderà la gara
e verrà scorticato da Apollo, con una violenza
spaventosa. Non ho portato il quadro di Tiziano su questo argomento, una delle cose più spaventose nella storia dell’arte, una vera e propria
macelleria. Dietro anche a questa pratica musicale, pertanto, c’è una violenza pari a quella delle donne tracie che ho fatto vedere prima: un
vero e proprio delirio, lo scatenamento di un
furore incredibile. Non credo, dunque, che la
musica serva sempre ad “adoucir les mœurs”: c’è
di più, dietro a questo semplicistico assunto.
Il concorso, dunque, si svolge così: Marsia suona, il giudice re Mida stabilisce che lui è più
bravo di Apollo, ma a questo punto il dio gli
tende un tranello e chiede a Marsia di suonare
rovesciando lo strumento, cosa che con la lyra si
può fare, mentre con l’aulos è impossibile.
Un’altra versione dice che Apollo decide di cantare mentre suona, altra cosa che con l’aulos non
si può fare. Questo aspetto è molto importante:
di nuovo il mito tratta di una riflessione sulla
parola del canto legata allo strumento, evidenziando come questo sia il limite dell’aulos, col
quale non si può cantare e suonare assieme, possibilità che, al contrario, la lyra si ha. Questa
considerazione ha delle conseguenze rilevanti
47
Fig. 19, rilievo attico, da Mantinea,
350 a. C, Apollo e Marsia (Atene,
Museo Archeologico 215)
Fig. 20, cratere attico a figure rosse,
pittore di Cadmos, 430 a. C., satiro
auleta e Apollo con la lira (Bologna,
Museo Civico, Pell. 301)
Fig. 21, cratere attico a figure rosse,
430 A. C., satiro suonatore e Apollo
(mercato antiquario, New York,
Sotheby’s 11.XII.1989 n°125)
Fig. 22, cratere attico a figure rosse,
pittore di Cadmos, 430 a. C.,
particolare del collo con satiro auleta
e Apollo (Ruvo, Museo Jatta 1093)
nella pratica musicale: attorno alla fine del V e
inizio del IV secolo c’è una forte critica all’aulos,
coerentemente con quanto indicato; Alcibiade,
ad esempio, dice di non voler suonare l’aulos
perché è brutto e rende brutto il viso e, in
secondo luogo, impedisce di cantare, mentre la
parola è più importante della musica.
Dunque, nel mito di Marsia c’è tutto questo,
però, se esaminiamo come alla fine del V secolo
a. C. i pittori attici hanno trattato l’argomento,
facciamo nuovamente alcune scoperte interessanti. Anche se questa versione del mito è conosciuta da tutti, perché già Erodoto nella sua Storia parla di un posto in Frigia in cui si vede, sulla piazza, appesa ad un albero, la pelle di Marsia, testimoniando la diffusione del racconto,
l’interesse dei pittori nelle raffigurazioni non
riguarda il momento del castigo, l’aspetto violento della vicenda, ma il mettere insieme, come
in questa immagine [fig. 20], un satiro che suona l’aulos - che potrebbe essere Marsia - e Apollo con l’alloro che tiene la lyra. Viene evidenziata la competizione tra i due strumenti, affiancati, però, in una sfida che non finisce in modo
violento. La stessa cosa qui [fig. 21]: siamo
intorno al 440, 430 a. C.: l’iconografia di Marsia viene organizzata in un modo che definirei
“pacifico”, con Apollo di fronte ad un satiro e la
lyra sotto di esso, dunque non in contrapposizione conflittuale, o che addirittura escluda l’uno o l’altro dei due strumenti, ma in una combinazione degli stessi. Poi abbiamo alcune donne con strumenti musicali, probabilmente le
Muse e direi, quindi, che secondo la logica di
queste immagini Marsia risulta essere uno degli
esseri della cerchia di Dioniso che viene integrato nel mondo di Apollo.
Abbiamo un disegno molto bello [fig. 22] - vi
do forse l’impressione di inventare tutto, ma, al
contrario, è tutto chiaramente espresso - su un
grande cratere del Museo Jatta di Ruvo. Sul col-
48
lo abbiamo un satiro seduto che suona, Apollo
che l’ascolta, un altro satiro che danza e probabilmente una Musa a sinistra. Esaminando l’insieme del vaso [fig. 23] - un cratere per mescolare il vino del banchetto e ribadisco che il contesto è importantissimo, poiché il vino è Dioniso e le raffigurazioni di satiri sono legate anche
a questo aspetto - al centro abbiamo un satiro,
posto di fronte ad Atena, l’inventrice dell’aulos
e ad Apollo seduto un po’ a destra. Forse il disegno è più chiaro [fig. 24]: c’è il satiro Marsia
che suona la kithara accanto ad un albero di palma, l’albero di Apollo, poi Atena in piedi, quindi Apollo - i nomi sono scritti: la cosa notevole
è che Marsia suona lo strumento di Apollo,
dunque non è rappresentato alcun conflitto,
quanto piuttosto uno scambio. Il pittore ha
scelto di non far vedere la violenza e la contrapposizione tra Dioniso e Apollo, ma piuttosto di
integrarli in modo pacificato. C’è poi un tripode accanto al satiro, forse è il premio ad un concorso o una offerta al dio Apollo. Abbiamo moltissimi di questi tripodi ad Atene o a Delfi. In
questa raffigurazione c’è forse l’accenno ad un
concorso musicale, il ditirambo - è una delle
possibilità che possono essere prese in esame ma la cosa che mi interessa è farvi vedere il gioco tra Dioniso, Apollo e Marsia, secondo modalità che sembrano abbastanza pacifiche.
Andando avanti nel tempo ritroviamo nella
ceramica italiota, campana e lucana la raffigurazione del coltello già vista sul rilievo di Mantinea. In questo vaso [fig. 25], oggi perduto, c’è il
satiro inginocchiato e Apollo stesso che tiene il
coltello: è evidente che non è più il momento
della gara ma quello del castigo. Inequivocabilmente si sta suggerendo il momento dello scorticare, che, però, non si fa esplicitamente vedere (l’esplicitazione avverrà solo nella scultura
romana, mai nella pittura vascolare). Consideriamo ancora questo cratere per il vino [fig. 26],
49
Fig. 23, id, insieme del vaso
Fig. 24, id, disegno
Fig. 25, cratere campano a figure
rosse, 360 a. C., Apollo con il
coltello, (vaso perduto, ex collezione
Hope)
Fig. 26, cratere campano a figure
rosse, 350 a. C., Apollo con la harpe
(mercato antiquario, New York, NFA
11.XII.1991)
Fig. 27, oinochoe lucana a figure
rosse, 360 a. C., Apollo con la lira e
satiro con il coltello (Taranto, Museo
Nazionale 20305)
di provenienza campana, con evidenziata non la
qualità musicale del satiro o di Apollo, ma la
forza del dio che è in grado di castigare ogni
essere umano che pretenda di essere più bravo
di lui. Questo significato del mito, dunque, è
differente da quelli precedentemente esaminati:
il dio tiene uno strumento che è un tipo di harpe, di falce, lo stesso strumento che Perseo utilizza per tagliare la testa della Gorgone. Il punto notevole è che, come scrive Erodoto quando
parla della pelle del satiro nella città di Frigia
dove è stato scorticato Marsia, questa pelle viene chiamata askos, parola greca molto interessante. Askos può essere la pelle di Marsia come
in questo caso, oppure può essere la pelle di
capra che serve per fare un otre per il vino, ma
può essere anche la parte che nel sacrificio greco viene data al sacerdote, può essere vocabolo
specifico legato al rito del sacrificio. Su questa
immagine [fig. 27], infine, di una piccola brocca per il vino, abbiamo una donna, Apollo con
la lyra e un satiro che tiene egli stesso il coltello
del sacrificio, quasi anticipando il suo castigo.
Non c’è più alcuno strumento musicale, solo il
coltello; il satiro ha un piede su una roccia e di
fronte a lui, sulla linea del sole, c’è un oggetto
che può sembrare due cose: può essere un askos,
un otre, ma assomiglia anche molto alla custodia di un flauto. È chiaro che il pittore fa una
specie di anticipazione della conclusione della
vicenda, che acquista senso solo conoscendo il
mito, ovvero è necessario che ci sia qualcuno in
grado di narrarlo, come sto facendo io, o forse,
ancora meglio, in grado di cantare questa storia
al simposio. Dunque sono le immagini che
creano le possibilità di espressione musicale,
poetica o narrativa, e queste possibilità possono
venire o no utilizzate, a seconda della voglia dei
bevitori: ne traggono ispirazione se lo desiderano, altrimenti discorrono d’altro.
Per non lasciarvi con queste storie così violente
50
e tristi, torniamo ora ad occuparci di satiri e
musica esaminando alcune immagini in cui gli
strumenti musicali sono diversamente utilizzati.
Su questa scena di simposio [fig. 28] il satiro
porta sulla spalla un otre pieno di vino; regge un
tipo di lyra lunga, tipo barbitos, per cantare al
simposio, ma dal suo braccio pende anche una
custodia, la sybene, che serve per custodire l’aulos; porta infine un cestino con gli oggetti e la
coppa necessari al banchetto. Il satiro è una
figura centrale nell’immaginario del simposio
(credo che nella realtà non ce ne siano molti,
forse alcuni, ma non molti…); questo immaginario animale-umano, questo simbolo del
bestializzarsi nel bere e nel cantare, viene, molto spesso, nell’iconografia del banchetto, collegato ad un tipo di musica che combina la lyra e
l’aulos, ricordando però che l’aulos è uno degli
strumenti più influenti sull’animo umano e che
provoca la mania dionisiaca più della lyra.
Abbiamo anche dei satiri come questo [fig. 29],
vestito da concertista, che suona la grande
kithara tra Ermes a sinistra e Dionisio a destra:
non so se questa sia una versione comica o no,
ma chiaramente è un décalage, uno slittamento
tra l’iconografia standard del concorso musicale
di cui si è parlato e una versione divina e satiresca assieme, con molto garbo ed eleganza.
Abbiamo altre situazioni musicali di satiri che
giungono all’oscenità, raffigurati nel denudarsi
e nell’esibire il sesso [fig. 30, vedi p. 49], oppure giocate con analogie, sulle quali vi lascio
meditare, tra l’aulos e il sesso [fig. 31]. In questo caso la scena è rappresentata con un po’ di
discrezione: la custodia viene appesa al sesso del
satiro che tiene l’aulos in mano... Stiamo esaminando raffigurazioni antecedenti all’iconografia
di Marsia che abbiamo già visto, ma il mito
completo esiste già nella cultura greca, perché
Erodoto scrive poco dopo questo periodo.
Per concludere brevemente: vi ho fatto vedere,
51
Fig. 28, idria attica a figure rosse,
500 a. C., il satiro sulla strada del
symposio (Monaco,
Antikensammlung 2424)
Fig. 29, cratere attico a figure rosse,
da Spina, 460 a. C., satiro concertista
tra Ermes e Dionisos (Ferrara, Museo
Archeologico, inv. 4110, T55A VP)
Fig. 31, piatto attico a figure rosse,
firmato da Epictetos, 510 a. C.
(Parigi, Cabinet des Médailles)
passando da Orfeo a Marsia, diverse cose; credo che ci sia una poesia grafica in
queste storie musicali. Altri miti sono più gradevoli, io ho scelto questi due che
sono violentissimi, ma legati ai confini del mondo greco, alla Frigia e al mondo
tracio. Non una Frigia storica, quanto una “Frigia per gli Ateniesi”: è il punto
di vista degli Ateniesi sul mondo estero e quindi sul loro stesso. All’interno di
questo mondo si descrive, destinando la riflessione all’ambito del simposio, il
cattivo uso della musica, ma anche il buon ascolto senza esagerazioni e con l’attento controllo della parola, del canto e del gioco con il vino e la musica.
>
Fig. 30, coppa attica a figure nere, 520 a.C., Satiro con l’aulos
(Monaco, Antikensammlung WAF 2088)
52
53
Gli strumenti musicali dell’antica Grecia
M ICHAEL S TÜVE
Assai poco sappiamo degli strumenti musicali dell’antica Grecia, come del resto
del suono e della musica da essi prodotti. Il turbamento che suscita la consapevolezza che le nostre conoscenze sull’antico stile musicale sono talmente insufficienti da non permetterci neppure di giudicare se la melodia della prima ode
pitica di Pindaro tramandataci da Athanasius Kircher sia autentica oppure sia
solo una contraffazione (anche se indubbiamente molto suggestiva), è paragonabile al disagio che proverebbe un musicista di oggi, se dovesse spiegare ad
esempio, come erano fissate le corde dell’antica lyra allo zygon, la traversa fra i
due bracci dello strumento, per non parlare del problema della loro accordatura. Gli scarsi reperti archeologici, le tante raffigurazioni e le descrizioni riportate in letteratura da Omero (VIII sec. a. C.) a Polluce (II sec. d. C.) ci danno un
quadro di grande vivacità musicale, ma dal punto di vista organologico rimangono aperti molti problemi. Mi limiterò dunque a presentare a grandi linee gli
strumenti dei quali esiste maggiore documentazione, suddivisi in tre gruppi in
accordo con la maggior parte dei testi: i cordofoni, gli strumenti a fiato e quelli a percussione. Occorre precisare che essi erano già noti da molto tempo in
Medio-Oriente e che i Greci quindi hanno copiato semplicemente strumenti
già in uso fin dai tempi dei Sumeri e degli Assiri (come l’arpa, le lyre a undici e
a dodici corde, il liuto, cioè la cosidetta pandoura). Vorrei ricordare anche che
l’interesse per la musica greca antica è dovuto alla grande influenza che essa ha
esercitato sulla nostra musica, la musica dell’Abendland, ed il fatto che a sua volta abbia risentito di numerosi influssi esterni non diminuisce l’importanza che
ha avuto per la nostra cultura.
I. Strumenti a corda
La lyra, con le sue numerose varianti, è lo strumento più antico e rappresentativo dell’antica Grecia. Nelle raffigurazioni vascolari l’arpa è rappresentata
soltanto una volta prima della fine del V sec a. C., mentre il liuto vi compare dalla metà del IV sec. a. C. Questi strumenti tuttavia erano già presenti in
Mesopotamia nel 2000 a. C. e venivano suonati con le dita o con il plettro,
mai con l’arco.
<
Fig. 2a, kithara, ricostruzione di Giorgos Polyzos, 1989.
55
La lyra era costituita da una cassa di
risonanza con due bracci uniti all’apice mediante una traversa; ad essa venivano assicurate le
corde, tese in mezzo ai bracci, poggiate su un
ponticello (magas) e fissate ad una cordiera
situata alla base della cassa di risonanza. Lo strumento veniva sostenuto dal braccio sinistro del
suonatore, infilato in una fascia dello strumento stesso; il plettro - come dimostrano molte
raffigurazioni - di solito era legato allo strumento mediante una cordicella.
La parola chelys, tartaruga, nell’antichità significava anche ‘lyra’. Martin Litchfield West distingue fra ‘box lyres’ (lyre a cassa) e ‘bowl lyres’ (lyre
a scodella) [vedi fig. 1a, p. 34] e fa rientrare la
chelys tra queste ultime: essa consisteva in un
guscio di tartaruga chiuso da una pelle, al quale
venivano legate le corna di un animale. Un altro
tipo di lyra a scodella era il barbitos [fig. 1 e 1a],
con lunghi bracci, quindi con lunghe corde, che
emetteva un suono piuttosto grave. È possibile
vederlo raffigutato sul famoso vaso 2416 di
Monaco [vedi fig. 5, p. 23] in mano a Saffo ed
Alceo vissuti tra il VII ed il VI sec. a. C. I poeti
di Lesbo lo chiamavano barmos. La chelys appare nell’iconografia solo verso la fine dell’VIII
secolo a. C., il barbitos ancora più tardi. Erano
strumenti suonati per lo più dai dilettanti ed in
occasioni conviviali.
Già nelle culture minoica e micenea (dopo il
1600 a. C.) era in uso una lyra appartenente alla
famiglia delle ‘lyre a cassa’, con una cassa di
legno il cui fondo era di forma rotonda. Di solito veniva raffigurata con sette corde. Più tardi,
invece, nell’ VIII sec., essa stranamente si presentava con solo tre o quattro corde: si tratta
della lyra che Omero chiama phorminx, lo strumento dell’aedo, del poeta cantore-narratore
che raccontava le gesta divine degli dei e degli
eroi. Certo, il fatto che vi fossero ora tre, ora
quattro corde ci fa pensare al tetracordo, all’in1. La lyra.
Fig. 1, Barbitos e doppio aulos.
Pelike a figure rosse
Pittore dell'Angelo Volante
Provenienza: Chiusi (480 a.C. ca)
Museo Archeologico di Firenze
Fig. 1a, Barbitos, ricostruzione
Giorgos Polyzos, 1989.
56
tervallo di quarta, diviso in un primo momento
da una sola nota, più tardi da due. Ma c’è chi
sostiene, che le quattro corde della phorminx
non si limitassero all’intervallo di quarta, ma
fossero accordate in re-la-fa-mi; altri ancora
ritengono che l’accordatura fosse estremamente
variabile. In verità non ne sappiamo nulla. A
Terpandro (VIII - VII sec. a. C.) viene attribuito il merito di aver riportato le corde a sette.
Siamo nel periodo di transizione dalla musica
pentatonica a quella eptatonica.
Terpandro viene considerato il padre della citarodia, del canto accompagnato dalla kithara. Si
ritiene che i termini kitharis o kithara appartenessero ad una lingua diversa dal greco, ma non
sappiamo a quale. La kithara [fig. 2a, p. 50], la
lyra più grande e pesante dell’antichità, era lo
strumento del virtuoso che si esibiva durante i
giochi panellenici. I bracci dello strumento erano formati da un prolungamento della cassa di
legno. Le volute ed i meccanismi a zig-zag [fig.
2], simili a quelli degli strumenti egiziani e
minoici, fanno supporre che lo strumento avesse un sistema di accordatura molto sofisticato. Il
loro funzionamento tuttavia non è tuttora noto.
Il dorso della kithara non era piatto, ma alquanto convesso, come evidenziano alcune raffigurazioni che mostrano lo strumento di lato. Il fondo invece era piatto.
Vi era anche una lyra più piccola con una cassa
armonica il cui fondo era simile ad una culla
vista di lato, che viene perciò chiamata dagli
organologi tedeschi ‘Wiegen-Kithara’. Era lo
strumento delle Muse e delle donne.
La kithara, contrariamente al più leggero barbitos ed alla chelys, veniva tenuta in posizione retta, parallela al corpo. La corda più vicina al corpo era quella più grave, chiamata hypate: ‘la più
alta’. Le corde successive - salendo la scala - erano denominate:
Parhypate: ‘la corda accanto alla più alta’
57
Fig. 2, Kithara.
Anfora a collo distinto a figure nere
Produzione attica (510-500 a.C.)
Museo Archeologico di Firenze
Fig. 3, Trigonon (arpa).
Ricostruzione di Giorgos Polyzos,
1990.
Fig. 4, Trichordon (Pandoura).
Ricostruzione di Giorgos Polyzos,
1991.
Lichanos: ‘dito indice’
Mese: ‘la media’
Trite: ‘la terza’
Paranete: ‘la corda accanto alla più bassa’
Nete: ‘la più bassa’
La nete, ‘la più bassa’, produceva il suono più
acuto. Tale nomenclatura fu poi utilizzata per
indicare i suoni della scala eptatonica.
Nel periodo classico nel quale Frinide e Timoteo invocavano la ‘nuova Musa’, le corde della
kithara vennero aumentate fino ad un massimo
di dodici.
Nell’antichità esistevano molti altri tipi di lyra e
di alcuni conosciamo anche i nomi: la phoinix o
phoinikion proveniva probabilmente dalla Fenicia; il pythikon o daktylikon veniva suonato in
occasione dei giochi pitici, forse con tutte le
dita, senza plettro; il pentachordon era una lyra
molto antica proveniente dalla Scizia; altri nomi
noti sono: skindapsos o kindapsos, lyrophoinix o
lyrophoinikion, spadix, byrte, psaltinx ecc.
Mentre di questi tipi di lyra non sappiamo molto, conosciamo invece molto bene la forma di
una lyra proveniente dalla Tracia e raffigurata
molte volte: uno strumento simile al barbitos,
ma più corto. Di esso tuttavia non conosciamo
il nome.
2. L’arpa. L’arpa [fig. 3], sicuramente uno degli
strumenti più antichi, si trova rappresentata in
Grecia solo a partire dal V secolo. Tuttavia Saffo
ed Alceo conoscevano già questo strumento e lo
chiamavano paktis (pektis nel dialetto ionicoattico). Lo consideravano lo strumento dell’amore e del piacere. Lo si vede di solito in mano
alle Muse o a donne sedute, appoggiato sul loro
ginocchio sinistro. Il numero delle corde variava da nove a venti. Spesso la cassa di risonanza
era appoggiata al seno della suonatrice; le corde
erano tese tra la cassa ed una base sottile che
poggiava sul ginocchio.
58
Il trigonos era un’arpa di forma triangolare e con la cassa di risonanza situata al
lato opposto della suonatrice. La sambyke (latino sambuca) era invece un’arpa
dal registro acuto e dal “suono ignobile” (Quintiliano), simile all’omonima
macchina da guerra costituita da due navi sulle quali poggiava una scala inclinata verso le mura della città assediata.
Non sappiamo quale forma avessero le arpe denominate klepsiambos, enneachordon, cioè arpa a nove corde, nablas e heptagonon che Aristotele definisce
“strumento edonistico”.
Alla fine del IV secolo tutti i tipi di arpa erano denominati psalterion, cioè
‘strumento pizzicato’. Nel medioevo il termine salterio venne poi attribuito ad
un tipo di cetra con corde tese su una cassa di risonanza. Strumenti simili, forse usati soprattutto per impartire lezioni di musica, nell’antichità furono l’epigoneion con quaranta corde e il simikon con trentacinque. Il termine simikon
probabilmente deriva da Simos, teorico vissuto nel V secolo a. C., mentre l’epigoneion indicherebbe la posizione dello strumento, che veniva tenuto sulle
ginocchia, come nel mondo arabo, turco e greco ancora oggi viene suonato il
kanonaki, strumento il cui nome fa riferimento ai ‘canonisti’, gli antichi teorici della musica.
Il liuto antico è rappresentato in una dozzina di raffigurazioni fra il
330 ed il 200 a. C. Veniva suonato dalle Muse e dalle donne, con il plettro o
con le dita. Il liuto a tre corde era detto trichordon [fig. 4]. Dal III secolo in poi
il liuto venne chiamato pandoura. Nel Medioevo la pandoura fu detta mandora.
Il liuto bulgaro dal lungo manico viene ancora chiamato tanbura.
Nella Bibbia, verso nono del salmo 144 attribuito a Davide (1000-960 a. C.),
viene nominato uno strumento a dieci corde:
“O Dio, voglio cantare a te un nuovo canto, voglio inneggiare a te sul decacordo.”
Sulla base di questo verso durante la riforma cistercense del XII secolo, i monaci che codificavano il canto gregoriano costrinsero ogni melodia in un ambito
di decima. L’antico decacordo però era probabilmente uno strumento a cinque
corde doppie accordate in modo pentatonico
3. Il liuto.
II. Strumenti a fiato
Fin dall’antichità esistevano i tre tipi di strumenti a fiato che ritroviamo ancora oggi: gli strumenti ad ancia (cennamelle), i flauti e gli strumenti a bocchino
(trombe). Essi erano detti aulos, syrinx o iynx e salpinx.
L’ aulos (termine che inizialmente significava semplicemente ‘tubo’ o
‘condotto’) è la cennamella antica, non è quindi un flauto, come spesso viene erroneamente tradotto. Come la lyra tra gli strumenti a corda, era il più diffuso tra gli
strumenti a fiato. Veniva di solito suonato in coppia come doppio aulos [fig. 1,
1. L’aulos.
59
Fig. 1b, Aulos doppio.
Ricostruzione di Giorgos Polyzos,
1989.
vedi p. 52, e 1b]: il suonatore teneva in bocca le
ancie di due strumenti diversi. Per evitare una
fuga d’aria incontrollata (chiudere strettamente
le labbra attorno a due ancie non è affatto facile) e per sostenere la pressione che occorre per
soffiare dentro due strumenti nello stesso tempo,
i virtuosi di questo strumento indossavano spesso la phorbeia (lat. capistrum) [vedi fig. 2, p. 17],
una specie di bavaglio con due fori, il cui scopo
forse era anche quello di ridurre le inevitabili
smorfie. Si narra che l’ aulos fu gettato via dalla
sua inventrice, la dea Atena, quando si accorse
quanto esso deturpasse il suo bel viso; lo strumento - dice il mito - fu raccolto da Marsia che
come auleta entrò in competizione con Apollo,
virtuoso suonatore di lyra.
Come i nostri clarinetti ed i nostri oboi, anche
l’aulos è composto da più parti: il bocchino con
un ancia semplice o - più frequentemente - con
una doppia ancia che il suonatore teneva in
bocca, era inserito nella parte superiore della
canna ornata da un rigonfiamento (holmos), ben
visibile nella maggior parte delle raffigurazioni.
La canna cilindrica si inseriva all’interno di holmoi puramente ornamentali, senza cambiare
diametro, che di solito era di 8 - 10 mm. L’aulos poteva essere allungato mediante più holmoi
che separavano il bocchino dalla canna principale nella quale si trovavano cinque fori, uno
per ogni dito di una mano. In questo modo lo
strumento poteva essere allungato ed il suono
portato ad un registro più grave.
Con Pronomo di Tebe (circa 400 a. C.) i fori
dell’aulos vennero aumentati fino a 24 e, non
potendo più essere chiusi contemporaneamente
dalle dita, fu introdotto un meccanismo di chiavi (anelli e chiavistelli) per realizzare con un
unico strumento l’intera gamma dei modi e delle armonie. Tuttavia per i diversi registri erano
necessari più strumenti: secondo Aristosseno
(ca. 354 - 300 a. C.) la famiglia dell’ aulos era
60
formata da cinque tipi di strumenti:
parthenioi, l’ aulos delle fanciulle;
paidikoi, dei ragazzi;
kitharisterioi, dei suonatori di lyra;
teleioi, degli adulti;
hyperteleioi, dei più maturi.
La nomenclatura più moderna definisce tali registri come soprano, mezzosoprano, tenore, baritono e basso. L’intervallo fra la nota più grave dell’hyperteleion e quella più acuta del parthenion era di oltre tre ottave.
Gli auloi erano di canna, di osso (tibie di daino), di avorio, di legno o di metallo, oppure avevano parti di osso o di legno inserite in strutture metalliche.
Quando non veniva usato, lo strumento veniva custodito nella sybene, un sacco
di pelle, che spesso vediamo raffigurato, mentre il delicato bocchino era riposto
in una scatolina chiamata glottokomeion.
Come la lyra, anche l’aulos comprendeva numerose sottoclassi di strumenti
come gli elymoi di origine frigia, un doppio aulos con la canna sinistra allungata mediante l’aggiunta di un corno di bovino. Secondo Aristofane emetteva un
suono piuttosto rozzo, forse simile al ronzio delle vespe. Nato come strumento
di culto, nell’epoca romana venne impiegato nel teatro.
Gingros, gingras, gingrias o gingrainos era chiamato un aulos corto, dal registro
acuto e dal suono lamentoso, usato spesso per l’insegnamento della musica.
Ginglaros era invece il nome di un aulos singolo di provenienza egiziana, che per
la sua lunghezza impegnava entrambe le mani. Nell’Italia meridionale fu chiamato tityrinos.
I pythikoi erano auloi dal registro di baritono (teleioi) e venivano suonati durante i giochi pitici. Tecnicamente molto elaborati, permettevano di suonare molti modi diversi su una larga scala di registri. In questo si distinguevano dagli
auloi dal registro acuto, usati per accompagnare i cori e la poesia ditirambica. I
paroinioi erano auloi con una canna piuttosto corta ed erano usati nei convivi.
Gli auloi suonati nello spondeion, la parte più solenne del nomos pitico, erano
strumenti lunghi, dal suono cupo e dal registro grave. Accompagnavano anche
gli inni. Nelle processioni invece si suonavano gli embaterioi, mentre la musica
da danza era accompagnata dai daktylikoi, nome con il quale vengono indicati
sia un tipo di lyra che di aulos.
Alcuni auloi avevano il bocchino in posizione laterale. Forse venivano anch’essi
chiamati plagiauloi, benchè questo termine si riferisse soprattutto al flauto.
Tra le cennamelle si può annoverare anche la zampogna, raffigurata per la prima
volta su un cammeo del periodo ellenistico. Si dice che fosse lo strumento suonato dall’imperatore Nerone.
2. Il flauto.
Il flauto dell’antichità era costituito da un’unica canna forata o
61
da più canne di diversa lunghezza. La syrinx, il flauto di Pan, è un flauto con
canne di diversa lunghezza. Nell’antica Grecia erano di uguale lunghezza all’esterno, ma accorciate all’interno mediante tappi di cera. Era lo strumento dei
pastori e non ha avuto grande importanza nell’antichità, se non come base di
partenza per la costruzione dell’organo. La Musa Calliope rappresentata sul
vaso François di Firenze suona proprio la syrinx utilizzata anche in ambito cultuale ad Efeso e Delo.
Iynx era il nome di un flauto formato da un’unica canna forata. Veniva suonato come la syrinx, soffiando l’aria attraverso il taglio apicale, oppure - come
nei nostri flauti traversi - attraverso un foro laterale (plagiaulos). Il suono dell’iynx era dolce ed assomigliava al fruscio del vento.
L’epitonion era un piccolo flauto usato dal maestro del coro per indicare ai cantanti la nota con la quale iniziare.
Parlando dei flauti non possiamo non citare l’organo (tyrrhenos
aulos), inventato dall’ingegnere Ctesibio di Alessandria (III sec. a. C.), chiamato anche hydraulis, perché inizialmente funzionava mediante un meccanismo
idraulico tramite il quale l’aria veniva forzata in una galleria sottostante ad una
serie di canne di bronzo fissate ad una tastiera. Ogni canna aveva un tappo
comunicante con la galleria, che poteva essere aperto attraverso la tastiera, permettendo così all’aria di entrare nella canna. Filone di Bisanzio, allievo di Ctesibio, descrive l’organo come “una syrinx suonata con le mani, detta hydraulis”.
Sembra che l’organo fosse lo strumento preferito da Nerone e forse è stata proprio sua l’idea di sostituire il meccanismo idraulico con quello pneumatico per
diminuirne le dimensioni. Certo, si parla anche di un organo il cui polmone
venne realizzato con la pelle di due elefanti e che suonava grazie a 12 mantici.
Il suo suono poteva essere sentito a distanza di un miglio. Nel VIII secolo l’organo pneumatico da Bisanzio si diffuse anche nell’Europa del Nord.
L’organo.
La salpinx era la tromba dell’antica Grecia. Non era un vero e
proprio strumento musicale come sembra fosse per gli etruschi, ma serviva piuttosto per fare segnalazioni durante i combattimenti, nei concorsi sportivi come
le corse dei cavalli, nel lavoro, in occasione di riunioni ed anche durante le cerimonie religiose. La salpinx (latino tuba) consiste, appunto, di un tubo cilindrico di bronzo di lunghezza compresa fra gli 80 ed i 120 cm. Il fondo dello strumento, la campana, aveva la forma di un tulipano. Il bocchino era di osso. La
tromba era già conosciuta da Omero che la menziona nell’Iliade (XVIII, 219;
XXI, 388), ma sembra non fosse nota ai suoi eroi che non la suonano mai.
Dopo il IV secolo a. C. vennero istituiti concorsi di salpinx e si dice che alcuni virtuosi di questo strumento fossero in grado di farlo sentire dalla distanza
di sei miglia.
3. La salpinx.
62
Gli strumenti più comuni per le segnalazioni
erano tuttavia le conchiglie ed i corni ai quali
veniva aggiunto un bocchino.
Il Museo Nazionale degli Strumenti musicali di
Roma possiede una bellissima raccolta di strumenti antichi tra i quali vi sono anche dei
fischietti in terracotta a forma di cinghiale e di
gallo, di epoca ellenistica. Passando dagli strumenti a fiato agli aerofoni in generale, dobbiamo nominare il rhombos, un pezzo di legno
legato ad una corda che, fatto roteare nell’aria,
emetteva un suono simile al muggito del bue.
Veniva suonato nel culto di Dioniso assieme al
tamburo ed ai piatti a sonagli.
Fig. 5, Krotala.
Coppa attica a figure rosse
Pittore di Antiphon (intorno a 480 a.C.)
Museo Archeologico di Firenze
III.Strumenti a percussione
Gli strumenti a percussione nell’antichità avevano
due diverse funzioni: evidenziare il ritmo e produrre suoni chiassosi durante il culto orgiastico.
1. Gli strumenti ritmici. Le melodie dell’aulos
o della lyra potevano essere accentuate dal battito delle mani o dei piedi (specialmente nelle
danze, come riportato nell’Odissea, VIII, 256),
ma spesso si vedono raffigurate donne che danzano accompagnandosi con i krotala [fig. 5a],
strumenti simili alle castagnette o nacchere, formati da due pezzi di legno uniti da un lato, che
venivano battuti l’uno contro l’altro dalle dita
di una mano [fig. 5]. Erano lunghe circa 12-15
cm, quindi il loro ritmo doveva essere più lento
di quello delle castagnette spagnole che sono
più corte.
L’auleta, quando accompagnava il coro, spesso
indicava il ritmo battendo per terra il kroupalon
(denominato anche kroupeza, lat. scabellum),
una calzatura dalla doppia suola di legno.
2. Gli strumenti di culto. Tra gli strumenti a
percussione maggiormente usati nelle cerimonie
in onore di Dioniso e di Cibele vi era il tympanon
63
Fig. 5a, Krotala.
Ricostruzione di Giorgos Polyzos,
1989.
Fig. 6, Tympanon.
Hydria greca a figure rosse
Pittore di Meidias (420-410 a.C.)
Museo Archeologico di Firenze
Fig. 6a, Tympanon.
Ricostruzione di Giorgos Polyzos,
1989.
Fig. 7, Kymbala.
Ricostruzione di Giorgos Polyzos,
1989.
>
(il nostro tamburello), spesso suonato da donne.
Il suo diametro era di 30 - 50 cm ed ambedue i
lati erano ricoperti di pelle [fig. 6 e 6a].
I kymbala [fig. 7] erano una tipica coppia di
piatti a sonagli di bronzo, di circa 18 cm. di diametro, che venivano impugnati tramite un
anello situato sul dorso. Sono ancora in uso in
Medio Oriente.
I rhoptra erano strumenti di metallo simili ai
krotala di legno.
Nel culto di Iside, che dall’antico Egitto si era
diffuso anche a Roma, venivano suonati i sistri
[seistron, fig. 8] dei quali esiste una grande collezione nel Museo nazionale di Strumenti musicali di Roma. Erano formati da una staffa sorretta da un manico, alla quale erano fissati dei
cavetti ricoperti da una spirale di filo di bronzo.
Lo strumento produceva un piacevole suono
quando veniva agitato.
Alcune raffigurazioni mostrano donne che tengono nella mano sinistra uno strumento particolare a forma di scala e lo toccano con la mano
destra. Si presume che si tratti della psithyra
analoga ai sistri.
Bibliografia:
L. Cervelli, (ed.), La Galleria armonica, Catalogo del
Museo degli strumenti musicali di Roma, Roma 1994.
G. Comotti, La musica nella cultura greca e romana,
Torino 19912.
R.H. Hoppin, Medieval Music, New York, London 1978.
D. Minrow, Instruments of the Middle Ages and the
Renaissance, London 1976.
Soc. Biblica Italiana, La Bibbia concordata, IV, Antico
Testamento, Libri poetici, Milano 1982.
M. West, Ancient Greek Music, Oxford 1992.
Le illustrazioni 1, 2, 5, 6, sono qui riprodotte per gentile concessione della Soprintendenza Archeologica
della Toscana.
Fig. 8, Seistron. Ricostruzione di Giorgos Polyzos, 1990.
64
65
Vincenzo Galilei, Athanasius Kircher
e la musica greca
E UGENIO L O S ARDO
Devo concludere questa bellissima serata e trascinarvi via a malincuore dal
mondo greco. L’argomento di cui parlerò è ben lontano dagli eroi di Maratona
e dalla splendida armonia dei vasi antichi. Sposterò la leva del tempo di due millenni in una Italia snervata, post-michelangiolesca, con due figure che, a distanza di tempo, si fronteggiano: Vincenzo Galilei (1520-1591), da un lato, grande teorico della musica, fiorentino, padre di Galileo e, dall’altro, Athanasius
Kircher, gesuita nato in Germania nel 1602 e vissuto a Roma dove fondò un
famoso Museo e scrisse moltissime opere, di cui una sulla musica, intitolata
Musurgia universalis.1 Quella in cui ci troviamo non è più l’Italia dell’alto Rinascimento percorsa da geni universali, ma è ancora un paese pieno di fermenti,
di accademie e di fornitissime biblioteche, tanto che i primi ritrovamenti di
musica greca avvennero proprio nelle nostre collezioni.
Vincenzo Galilei e Athanasius Kircher furono i primi a pubblicare i brevi frammenti di musica antica2 che per secoli restarono le uniche testimonianze di una
grande tradizione artistica, rimasta inesplorata e difficilmente studiabile per la
scarsità delle fonti. Nelle loro opere narrano come questi ritrovamenti avvennero e giustificano e teorizzano il motivo per cui hanno ricercato e pubblicato le
antiche melodie. Ma, mentre gli Inni attribuiti a Mesomede - pubblicati da
Vincenzo Galilei - sono in genere ritenuti autentici, poiché esistono più codici che riportano le stesse trascrizioni, diverso è il caso della melodia della Prima
ode pitica di Pindaro - pubblicata da Kircher - che i filologi per lo più ritengono un intelligente falso d’autore.
Su tale giudizio pesano dei preconcetti basati su una valutazione poco lusinghiera dei lavori del grande gesuita tedesco, spesso accusato di essere un geniale millantatore per aver propugnato una teoria interpretativa dei geroglifici
egizi dimostratasi infondata. In realtà gli egittologi riconoscono a Kircher il
merito innegabile di essere stato il vero iniziatore della loro disciplina. Il tentativo fallito di leggere l’antica scrittura va per loro inquadrato in un preciso
ambito cronologico, come ha chiarito Sergio Donadoni in un recente articolo, per cui il codice di lettura del gesuita non poteva non essere che quello del< Athanasius Kircher, Musurgia universalis, Lib. VII, p. 541, Romae,
Typis Ludovici Grignani, 1650.
67
la sapientia aegyptia, tramandata da Orfeo, Pitagora e Platone e poi dai neoplatonici come Proclo e Giamblico e tradotta da grandi umanisti, della levatura di Marsilio Ficino.3
Ritengo, tra l’altro, che nel confronto tra le figure di Athanasius Kircher e di
Vincenzo Galilei pesi - almeno dal punto di vista di chi si occupa della storia
moderna dell’Italia - un antico discrimine. La definitiva chiusura e la dispersione delle collezioni del museo kircheriano, uno dei più grandi musei scientifici
d’Europa, furono in parte dovute alla volontà dei liberali italiani di cancellare la
memoria degli studi compiuti nello Stato della Chiesa da insigni ecclesiastici.
Chiesa e oscurantismo nella Nuova Italia, dovevano coincidere, Chiesa e condanna di Galilei, Chiesa e rogo di Giordano Bruno. I Gesuiti erano il simbolo
più evidente della politica controriformista e Kircher ne era stato uno dei maggiori ideologi nella seconda metà del Seicento. È una disputa antica che non è
qui il caso di affrontare, perché molte posizioni che, sentimentalmente o politicamente, si possono condividere, da un punto di vista storiografico andrebbero almeno riviste. Il gesuita di Fulda, che fu una figura centrale del mondo intellettuale del secondo Seicento, successore di Clavio e di Scheiner alla cattedra di
matematiche del Collegio Romano, come risulta da una lettera all’amico e protettore Fabri de Peiresc, era ad esempio convinto della fondatezza dell’eliocentrismo galileiano, teoria che non poteva abbracciare pubblicamente.
Galilei e Kircher, quindi, due nomi e due simboli di un radicato dilemma italiano, della profonda frattura che attraversa la società civile e che emerge ogniqualvolta si parla di scuola e di sistema educativo: Galilei da un lato (anche se
si tratta di Vincenzo) e Kircher dall’altro, ragione e oscurantismo, nuova scienza e aristotelismo. Vedremo come anche in questo caso le generalizzazioni non
aiutino a comprendere la complessità del tema, anche se i pregiudizi continuano ad avere il loro peso.
Da un punto di vista cronologico Vincenzo Galilei fu il primo a pubblicare dei
testi musicali greci nell’Occidente europeo. Erano testi trascritti in diversi codici,
conservati in biblioteche italiane e straniere. Ma la pubblicazione avvenne nell’ambito di una riforma della tradizione musicale, per rafforzare le basi teoriche
delle nuove tendenze che la Camerata dei Bardi, di cui Galilei era un importante
esponente, intendeva imporre nel panorama fiorentino del tardo Rinascimento.
Vincenzo, liutista e grande virtuoso, era nato a Santa Maria del Monte nel
1520, e aveva compiuto i suoi studi musicali a Firenze. Risiedè per un lungo
periodo a Venezia e a Pisa dove sposò Giulia, figlia di Cosimo Ammanati. Nel
1568 pubblicò la sua prima opera teorica, il Fronimo, un dialogo Sopra l’arte di
ben intavolare la musica negli strumenti artificiali sia di corde come di fiato, et in
particolare nel liuto (ripubblicato a Venezia nel 1584) e lì affermava che i Greci erano stati i veri inventori di quell’arte, di cui avevano studiato scientificamente gli effetti sull’ascoltatore. Essi pensavano, egli scriveva, che “gli animi
68
umani fossero armonia” e “ credeano che da dolci et soavi concenti fossero eccitati a temperare i discordanti affetti”. Alcuni anni dopo, nel 1581, dette alle
stampe il Dialogo sopra la musica antica et moderna, dedicato a Giovanni Bardi,
uno dei maggiori esponenti di quella Camerata fiorentina di cui si è detto.
Nell’opera, in cui gli interlocutori sono lo stesso Bardi e Pietro Strozzi, Galilei
riafferma quanto accennato nel primo dialogo. I Greci sono per lui i veri maestri
ed inventori della musica e presso di loro quell’arte era tenuta in altissima considerazione. Nel Dialogo l’autore si soffermava particolarmente sulla riscoperta della monodia antica e sulla sua possibile applicazione al panorama musicale contemporaneo. Esprimeva in tal modo l’avversione “al contrappunto esasperato” e
auspicava il ritorno alla presunta semplicità della scuola musicale greca. Citando
Platone ribadiva la superiorità della parola sulla musica. Questa evoluzione dette luogo alla nascita degli “intermedi” (messi in scena durante le nozze di Francesco de’ Medici con Bianca Capello nel 1579) e da questo si giunse al melodramma. Scrive al riguardo Mario Baroni che il proposito degli intellettuali che
dettero vita alla Camerata fiorentina aveva le sue radici nell’idea tipicamente
umanistica di studiare e di ridare circolazione moderna non solo alla concezione
musicale degli antichi greci, ma all’uso che della musica essi avevano fatto nello
spettacolo tragico. Ebbe pertanto origine uno stile adatto a sottolineare le situazioni emotive, e a studiare gli “affetti” indotti nell’animo di chi ascolta dalla
musica. Vedremo come questa linea di sviluppo musicale incontrò tra i suoi maggiori interpreti personaggi come Marin Mersenne, lo stesso Kircher e Cartesio,
nel Seicento, per giungere, nel Settecento a Rameau, a Matheson ecc. Non si
trattava, come avevano teorizzato i primi musicisti e umanisti della Camerata fiorentina, di una subordinazione della musica alla parola o meglio all’orazione, ma
piuttosto di una subordinazione di parola e musica insieme a questo ideale pervasivo di tutta la civiltà artistica barocca: esprimere o imitare gli affetti al fine di
soggiogare il pubblico, per commuoverlo ed emozionarlo.4
Le opere di Vincenzo Galilei, il “lamento del conte Ugolino” e le “lamentazioni di Geremia” sono andate perdute, ma ci sono rimaste varie testimonianze della produzione della Camerata.
Galilei, oltre che sugli strumenti musicali greci, dissertava nel suo dialogo sul
sistema di notazione musicale degli antichi. In un volume della seconda metà
del IV secolo dopo Cristo, conservato nella biblioteca del “Cardinal Sant’Angiolo” (ora alla Vaticana), intitolato delle note degli antichi musici greci opera di
un autore noto come Alypio, egli trovava i differenti segni che usavano gli “antichi per dinotare le corde dello strumento, a differenza”, come egli stesso scriveva, “di quelli che significavano il suono della voce”.5 In altri termini Galilei riferiva come nell’antichità si usassero due sistemi di notazione alfabetica: quella
strumentale con le lettere dell’alfabeto fenicio e quella vocale con le lettere dell’alfabeto attico. Cosa confermata dagli scritti di Boezio.
69
Troppo complesso e superiore alle mie capacità sarebbe ora, senza l’aiuto di supporti grafici addentrarsi, nell’intricatissimo mondo della musica classica e della
sua notazione. Basta qui ricordare che il sistema descritto da Alypio era noto ai
musicisti bizantini e che alcuni dei frammenti di cui trattiamo, tramandati
attraverso Bisanzio, ne rispettavano l’impostazione.
Operazione simile a quella di Galilei compì Kircher che, dopo aver già trattato
di musica greca nel suo excursus storico e in particolare alle pagine 212 e 213
della Musurgia, pubblicava nel libro VII della stessa opera (iconismo XIII) una
tabella tratta dall’Alypio.
Alla suddetta tabella aggiungeva un esempio, Musicae veteris Specimen,6 dove,
trascritta con la notazione antica, diciamo Alypiana, apparivano i primi versi
dell’ode pitica di Pindaro: “o aurea cetra d’Apollo”. Stranamente Kircher, che
aveva citato l’opera di Galilei (ma molte sono le lacune e gli errori delle opere
del gesuita!) affermava che quello, per quanto se ne sapeva, era l’unico esempio
rimasto di musica antica. L’aveva trovato nella famosa biblioteca del monastero
del S. Salvatore di Messina, durante il viaggio che aveva compiuto da Roma a
Malta tra il 1637 e il 1638, viaggio che gli permise di osservare i vulcani siciliani e di sollevare fondamentali ipotesi sul nucleo ardente della terra e sulla
deriva dei continenti. Anche in questo caso è necessario controllare quanto egli
afferma, perché di quel frammento da lui pubblicato si è successivamente persa
ogni traccia. Ciò che scrive appare però, alla luce delle ricerche compiute, quanto meno verosimile. Il monastero del San Salvatore al Faro era infatti uno dei
più antichi monasteri basiliani della città dello stretto. Nel 1546 Carlo V ne
ordinò lo spostamento per permettere la costruzione di una fortezza che dominava il fondamentale specchio d’acqua. Il S. Salvatore trovò una nuova sede
presso il porto di Messina, iuxta portum, come scrive il Kircher nella Musurgia.
È proprio lì che i monaci gli avrebbero mostrato questo libro di inni tra le cui
pagine era trascritta la prima ode pitica e la relativa melodia.
Molti manoscritti provenienti dal S. Salvatore, anche musicali si conservano
oggi nel mondo. Alcuni sono alla biblioteca dell’Università di Messina7 altri nel
monastero di San Nilo di Grottaferrata presso Roma, altri ancora in Spagna alla
Biblioteca dell’Escurial e alla Biblioteca Reale di Madrid, altri forse si conservano, come è avvenuto per le pergamene della città dello stretto, in chissà quale
biblioteca privata. La dispersione di questo ingente patrimonio è dovuta agli
eventi connessi alla ribellione anti-spagnola di Messina del 1674 e alla riconquista della città nel 1678. Gravissimi furono le distruzioni e i saccheggi. Fu
raso al suolo il palazzo civico (i cui archivi si sono ritrovati solo di recente) e la
popolazione si ridusse drasticamente da 120.000 a 15.000 abitanti. Kircher
> Organo idraulico da Musurgia universalis, 1650.
70
71
morì nel 1680, due anni dopo lo svolgersi di questi drammatici eventi, e fino
a quel momento nessuno dei suoi tanti acerrimi critici smentì quanto egli aveva scritto nella Musurgia Universalis, pubblicata nel 1650, trenta anni prima
quindi. Il fatto che egli avesse visto un codice di inni risalente al nono secolo
dopo Cristo a Messina - città di grandi tradizioni greche, dove trovò rifugio nel
’400 anche Costantino Lascaris, profugo da Costantinopoli, che vi fondò una
scuola - appare assolutamente verosimile. Nella stessa Musurgia,8 affrontando il
tema della musica greca nel capitolo dedicato alla polifonia antica, egli riferiva
che i bibliotecari messinesi, appartenenti all’ordine basiliano presso cui è ancora viva la tradizione del canto bizantino, avevano voluto mostrargli quel manoscritto redatto, egli dice, circa settecento anni prima del momento dell’incontro (ergo nel nono-decimo secolo d.C.) e in cui erano trascritti molti inni su
otto linee, non su cinque.
Con Galilei e con Kircher ci troviamo quindi dinanzi a due casi simili: trascrizioni certamente bizantine d’antiche musiche greche e sappiamo quanto la cultura contemporanea sia in debito per gli accurati lavori compiuti nel “Greco
impero”.9 Sta di fatto che molti filologi e grecisti, per giusta prudenza, usano
due pesi e due misure perché nel caso di Kircher, non essendosi trovato l’originale, parlano apertamente di contraffazione.
Personalmente non ne sarei tanto sicuro. Credo che il gesuita abbia effettivamente avuto tra le mani un libro di inni, quello su cui dubiterei è la datazione,
sapendo quanto egli fosse poco attento al riguardo, come dimostra il caso dell’Asclepio e degli Hermetica che egli faceva risalire al mitico Ermete Trismegisto,
mentre il Casaubon aveva già dimostrato l’inconsistenza di tale attribuzione.
Ma di Kircher non ci si libera facilmente perché l’uomo, con le sue contraddizioni, ha dei tratti d’altissimo genio e le sue luci e le sue ombre non sono esclusivamente personali. Nei suoi libri la difformità dello stile latino lascia intravedere più mani all’opera. Le sue erano posizioni largamente dibattute all’interno
della Compagnia di Gesù, che sottoponeva ad attenta verifica i libri dei propri
membri.
Abbiamo parlato dei meriti di Kircher nell’egittologia e nella vulcanologia e,
senza voler cadere nell’errore dei suoi fautori - di affermare con Antonio “For
Brutus is an honourable man, So are they all, all honourable men”10 - bisogna
dire che anche in campo musicale molti riconoscono al sapiente gesuita grandi
virtù, non ultima quella di altissima testimonianza della scuola musicale romana e della pubblicazione filologicamente corretta, riscontrata su altri manoscritti esistenti, di un famoso oratorio di Giacomo Carissimi, lo Jephte. Ciò non
basterebbe a stabilire l’autenticità della melodia dell’ode pitica, ma rende meno
aprioristicamente scettici su quanto da lui pubblicato.
Marchingegni e artifizi ad esempio, da lui inventati, che oggi potrebbero sembrare vacui sogni barocchi, come le cassette matematiche, hanno una invece
72
loro perfetta utilità. Mara Miniati, del Museo della scienza di Firenze, descrive
nei dettagli l’uso dell’unico originale a noi pervenuto. Si trattava di uno strumento da consultare con l’aiuto di un manuale di riferimento, un po’ come il
sestante e le tavole delle effemeridi. Permetteva di compiere una serie di operazioni complesse: matematiche, algebriche, astronomiche … musicali. Spostando delle barrette inserite in nove differenti alloggiamenti, con un funzionamento simile a quello di un regolo matematico, si ottenevano le relative risposte. L’ultima fila della cassetta, ideata per soddisfare le necessità di un sovrano e
il poco tempo a lui riservato per apprendere, concerneva la musica. Grazie alla
combinazione corretta dei “bacoli musurgici” tutti avrebbero potuto scrivere e
apprendere differenti stili, anche in quelli dell’antica Grecia.
Giancarlo Bizzi, in Enciclopedismo e Roma barocca11 definisce la Musurgia universalis uno straordinario viaggio nell’universo dei suoni e delle macchine
sonanti e dedica un interessante articolo alla tabula mirifica, omnia contrapunctisticae artis arcana rivelans. Bizzi dimostra come questa Tabula mirifica sia uno
schema logico-assiomatico che contiene in sé la rete delle relazioni possibili tra
i suoni. Non sono in grado di seguire le sue dimostrazioni ma so che Pierre Boulez era fortemente attratto da questo aspetto della musicologia kircheriana.
Come dimostrano questi due esempi egli comunque aveva una tale padronanza della tecnica musicale e delle matematiche combinatorie da poter proporre e
produrre musiche derivanti da algoritmi o da schemi logico-assiomatici, procedura mutuata in seguito dal grande Bach.
Vediamo quindi quasi due partiti contrapporsi: da un lato i grecisti, come il
grande Bruno Gentili che negli atti del convegno internazionale sulla musica
antica tenuto ad Urbino nel 1985, dichiara che la melodia dell’ode pitica è un
falso12, dall’altro i musicisti. Gentili poi nell’edizione valliana delle Pitiche di
Pindaro, nel vasto apparato di note di corredo, non ritiene neanche necessario
citare l’esistenza di questo falso che, comunque viene sempre riproposto nelle
edizioni di musica greca, almeno nelle due che sono riuscito a trovare.
Diversi i giudizi dei musicisti13 che, più attenti all’aspetto estetico, restano affascinati dal frammento edito da Kircher. Carlo Del Grande nel suo Dizionario
della musica e dei musicisti ritiene che il brano edito dal gesuita “in quanto melodia è bella e degna di Pindaro”14. Potremmo concludere con queste parole e con
quello che dice Vlad al riguardo. “La melodia in questione è davvero bellissima
ed essere stato capace di inventare una melodia degna di Pindaro è di per sé un
titolo di gloria tale da compensare ogni accusa di falso”.
Non sapremo mai se Kircher veramente vide quest’antica testimonianza della
musica greca nel convento di Messina. Forse la famosa ode pitica non è che una
delle tante applicazioni della sua tabula mirifica, un geniale esperimento di arte
combinatoria. Ma saremmo oggi, con tutti i nostri strumenti elettronici, capaci di padroneggiare con eguale maestria lo sterminato universo dei suoni?
73
74
Note:
1. Musurgia universalis, sive Ars magna consoni et dissoni in X. Libros digesta. Qua universa Sonorum doctrina, et Philosophia, Musicaeque tam theoricae, quam practicae
scientia, summa varietate traditur, admirandae Consoni, et Dissoni in mundo, adeòque
universâ naturâ vires effectusque, uti noua, ita peregrina variorum speciminum exhibitione ad singulares usus, tum in omnipoenè facultate, tum potissimùm in Philologià,
Mathematicà, Physicà, Mechanicà, Medecinà, Politicà, Metaphysicà, Theologià, aperiuntur et demonstrantur. Tomus I. Romae, ex typographia haeredum F. Corbelletti, Anno
Jubilaei 1650. 2 vol. In-fol. , 690 pp. tavv., ill..-Tomus II. Qui continet In Lib. VII. Musicam
Mirificam. In Lib. IX Magiam Consoni et Dissoni, in Lib X. Harmoniam Mundi, Romae,
Typis Ludovici Grignani, 1650. In-fol.,462 pp
2. Le opere edite di Vincenzo Galilei sono le seguenti: Intavolatura del liuto, 1563, Fronimo,
I ed. 1568, Primo libro di Madrigali a quattro e cinque voci, 1574, Dialogo della musica antica e moderna, 1581 Firenze. Nel Dialogo della musica antica et della moderna alle pp.96-97
editò gli inni attribuiti al musicista cretese Mesomede, musicista alla corte di Adriano (II sec.
d.C), ritrovati in un codice della “libreria del cardinal Sant’Angiolo a Roma”.
Le maggiori opere di storia della musica che trattano del periodo greco, come la New
Oxford History of Music, a cura di Egon Wellesz (la sezione dedicata alla musica greca è
a firma di Isobel Henderson), annoverano tra i frammenti di musica ellenica anche questi testé citati. Kircher compì nella Musurgia universalis (Roma 1650) un’operazione non
dissimile stampando il testo e la melodia della prima ode pitica di Pindaro, dando luogo
però ad una infinità di diversi pareri, a tal punto divergenti che un famoso musicologo,
R.P. Winnington-Ingram in un articolo uscito nel 1958 su “Lustrum” elencava una pagina
intera di studiosi che dibattevano sull’autenticità o meno del frammento musicale edito
dal gesuita.
3. Sergio Donadoni, I geroglifici di Athanasius Kircher, pp.101-110, p. 104, in Athanasius
Kircher. Il Museo del Mondo. Macchine, esoterismo, arte, catalogo a cura di E. Lo Sardo,
Edizioni De Luca, Roma 2001, della mostra tenuta a Roma, Palazzo di Venezia, nel feb.apr. 2001. Del resto con il suo dizionario arabo-copto-latino è considerato oggi dagli egittologi l’iniziatore della loro disciplina e il nostro Sergio Donadoni scrive al riguardo che
il Kircher nella sua grandiosa opulenza barocca tentò di “dar voce all’ineffabile, di cogliere nel passato la potenzialità di un futuro”.
4. Mario Baroni, Enrico Fubini, Paolo Petazzi, Piero Santi, Gianfranco Vinay, Storia della
musica, Torino, Einaudi 1988, testo di Baroni, p. 119.
5. Dialogo, cit. ed. 1581, pp. 96-97. Scrive al riguardo Kircher: “Duplicemque signorum
characterum, notarumque ordinem servat: primus ordo significat characteres, qui cantui
voce perficiendo servirent; secundus ordo instrumentis competit, ea fere ratione, qua
etiamnum, notae musicae vocalis distinctae sunt a notis, quas tabulaturas vulgo vocant
musicae instrumentali servientibus, quem ordinem Alipij multi non intelligentes binas
hasce notas pro una sumentes, uti Liardus, et ex eo salomon Caus specimina, quae mundo exhibere voluerunt, antiquae musicae vitiosissime et falsissime reddiderunt”. Musurgia univeralis, cit., p. 540.
6. “Inveni autem hoc musicae specimen, ut alias memini in celeberrima illa totius Siciliae
Bibliotheca monasterij S. Salvatoris iuxta Portum Messanensem in fragmento Pindari
antiquissimo, notis musicis veterum Graecorum insignito, quae quidem notae, sive characteres musici cum iis, quos Alypius in tono Lydio exhibet sunt iidem; verba odes Pindaricae notis musicis veteribus usitatis expressa sequuntur; tempus non notae; sed
quantitas syllabarum dabant “, Musurgia universalis, cit. p. 541.
< Athanasius Kircher, antiporta da De Sepi, Romani Collegii, 1678.
75
7. Maria Bianca Foti, in particolare in I codici basiliani del Fondo del SS. Salvatore. Catalogo della Mostra, Messina 1979.
8. Pp. 212-213.
9. Raffaele Cantarella scrive nell’edizione da lui curata dei Tragici greci edita da Mondadori a proposito dei ritrovamenti papiracei e delle trascrizioni medievali :”E tuttavia, dopo
i comprensibili entusiasmi dei primi ritrovamenti, abbiamo avuto conferma che la qualità
dei testi medievalli più autorevoli non è, in generale, inferiore a quella dei papiri: ciò che
testimonia gli alti meriti filologici dei dotti bizantini”. P. LIII.
10. W. Shakespeare, Julius Caesar, atto III, scena II, l. 79.
11. In Enciclopedismo e Roma barocca: Athanasius Kircher e il Museo del Collegio Romano tra Wunderkammer e Museo scientifico, a cura di Mariastella Casciato, Maria Grazia
Ianniello e Maria Vitale, Venezia, Marsilio 1986.
12. Come dimostrato da A. Rome, secondo Gentili (in La musica in Grecia, a c. di B. Gentili e R. Pretagostini, Roma - Bari, 1988, p. VI n 1), nel 1932 in Les études classiques, I,
1932, pp.3-11 e IV, 1935, pp. 337-350, cfr. Vlad, infra.
13. Vedi al riguardo gli articoli apparsi di recente in due opere a cura di chi scrive: R. Zarpellon, La musica degli affetti, in Il Museo del Mondo, cit., pp. 261-276 e R. Vlad, Kircher
sapiente musicologo, in Iconismi e Mirabilia da Athanasius Kircher, Edizioni dell’Elefante, Roma 1999, pp. 63-67. All’articolo di Vlad devo molte delle informazioni sulle opinioni di musicologi e musicisti sull’Ode pitica di Kircher.
14. Cit. in Vlad, p. 65, vedi supra.
76
77
78
Indice
Grecia · Cividale del Friuli, 20 luglio 2001
Introduzione · Salvatore Settis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Musica e poesia in Grecia · Maria Chiara Martinelli
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Spartiti musicali’ nella Grecia ellenistica:
pluralità delle occasioni del canto · Carlo Pernigotti e Luisa Prauscello
Iconografia musicale · François Lissarrague
11
19
. . . . . . . .
29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Gli strumenti musicali dell’antica Grecia · Michael Stüve
Vincenzo Galilei, Athanasius Kircher
e la musica greca · Eugenio Lo Sardo .
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
79
Finito di stampare
nel mese di febbraio dell’anno 2002
dalla Stella Arti Grafiche di Trieste