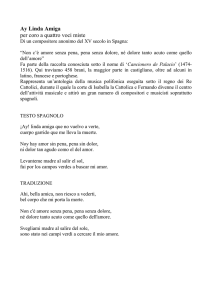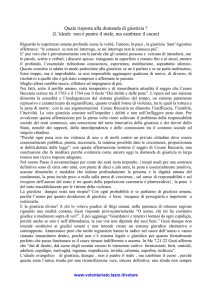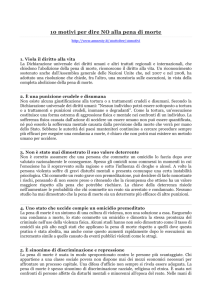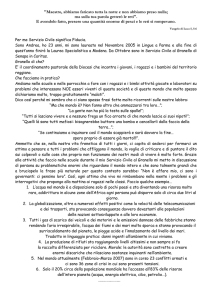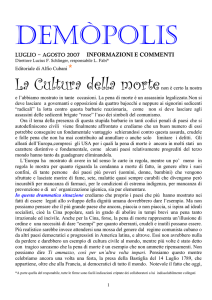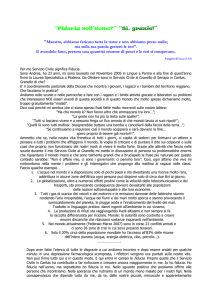![Col cappio al collo [pena di morte] 3-2007](//s1.studylibit.com/store/data/001021223_1-3659f2e972b7f952df6040504f496ef3-768x994.png)
Pubblicato da “Città nuova” n° 3 10/02/2007
Fino a quando?
Col cappio al collo
L’esecuzione di Saddam Hussein e di altri dirigenti del passato regime irakeno ha messo
sotto gli occhi del mondo l’orrore della pena di morte. Mentre aumentano le adesioni alla proposta
italiana di una moratoria internazionale, si approfondisce il dibattito sulle radici culturali della pena
capitale
L’immagine di Saddam Hussein col cappio al collo aveva chiuso il 2006. L’anno nuovo si è
aperto con altre esecuzioni.
L’Italia, attraverso il proprio ambasciatore alla Nazioni Unite, ha proposto al Consiglio di
sicurezza una moratoria universale delle esecuzioni, raccogliendo subito una significativa quantità
di adesioni da parte di altri Stati. L’iniziativa italiana, anche per il luogo nel quale viene portata
avanti, ha il merito di porre sotto i riflettori un aspetto determinante del problema, ulteriormente
sottolineato dalla reazione del neo-segretario generale dell’Onu, Ban Ki-Moon, che il 2 gennaio ha
accolto l’iniziativa italiana commentando che la pena di morte è una scelta riguardante i singoli
Stati sovrani.
Si è corretto, il giorno dopo, ricordando che tra i principi fondamentali sui quali si regge
l’Onu c’è anche il riconoscimento del diritto alla vita di ogni uomo: e a noi sembra che davanti a
tale principio la sovranità degli Stati, precedentemente invocata, non sia la soluzione ma, al
contrario, il problema, che può venire espresso in questo modo: si può riconoscere agli stati il potere
di infliggere la pena di morte? O non si dovrebbe invece stabilire che anche il potere sovrano deve
deporre le armi davanti al rispetto assoluto che la vita esige? La domanda mette in causa
direttamente la concezione che ognuno di noi ha dello Stato e, dunque, della vita politica. Una
domanda pesante, che, per la verità, la richiesta di moratoria non affronta direttamente; essa infatti
non mette in questione il potere degli Stati di decidere e infliggere la pena capitale, ma si limita a
chiedere – in attesa di giungere alla vera e propria abolizione - che tali pene non vengano eseguite.
La tradizione religiosa
Un aspetto interessante nel quadro attuale è dato dalla variegata risposta che alla nostra
domanda viene dai diversi ambienti religiosi. La stessa esecuzione di Saddam Hussein ha dovuto
tenere conto dell’elemento religioso – e non solo politico -, della contrapposizione tra sciiti, che
hanno fornito i boia, e i sunniti, ai quali è stato restituito il corpo.
E in ambito cristiano, con quale sensibilità si guarda alla pena di morte?
Per George Bush, presidente cristiano degli Stati Uniti - una nazione che si autodefinisce
come religiosa -, la pena capitale non fa problema: ha dichiarato, dopo l’impiccagione di Saddam,
che «egli è stato giustiziato dopo essere stato sottoposto ad un processo equo, ossia quel tipo di
giustizia negata alle vittime del suo brutale regime». Che quel regime fosse brutale e che il dittatore
dovesse venire giudicato, nessuno lo dubita; ma Bush, anche in questo caso, non rappresenta affatto
l’insieme degli Stati Uniti per quanto riguarda la pena di morte, che negli Usa ha avuto una storia
tormentata. Abolita dalla Corte Suprema nel 1972, reintrodotta nel 1976, è prevista in 38 Stati su
50. E la battaglia, culturale e politica, infuria. Nelle scorse settimane una commissione parlamentare
del New Jersey ha pubblicato un rapporto nel quale mette in dubbio sia che la pena capitale sia
legittima, sia che serva come deterrente contro i delitti.
Ci si aspetterebbe, da un movimento storico qual è il cristianesimo, che comincia proprio
con la crocifissione del suo fondatore, cioè con la condanna a morte di un innocente, una estrema
prudenza nei confronti del patibolo, se non altro per la consapevolezza della reale possibilità
dell’errore giudiziario. Ma se guardiamo alla tradizione prevalente dei duemila anni della sua storia,
1
ci accorgiamo che, per la maggior parte, i pronunciamenti delle grandi personalità ecclesiali sono
stati, a lungo, più vicini alla sensibilità di Bush che a quella di chi non accetta la pena di morte.
Il tema, comunque, è controverso da sempre. Nella chiesa antica Atenagora, Tertulliano,
Origene e Lattanzio hanno espresso contrarietà. Agostino invece la ammetteva, basandosi su un
brano della Lettera ai Romani (Rm 13,4) che fa riferimento all’autorità temporale e al suo potere di
usare la spada. Finché domina la visione “organica” della società – e questo avviene fin dentro
l’epoca moderna -, che vede il singolo semplicemente come una parte dipendente dall’insieme, la
conclusione logica di chi riflette sulla pena di morte è quella di tagliare la parte infetta (il
criminale), per proteggere il resto del corpo. In questi termini si esprime anche Tommaso d’Aquino,
che arriva ad affermare una teoria di “perdita del diritto” a causa della colpevolezza: «Col peccato
l’uomo abbandona l’ordine della ragione: egli perciò decade dalla dignità umana, che consiste
nell’esser liberi e nell’esistere per se stessi, degenerando in qualche modo nell’asservimento delle
bestie, che implica la subordinazione all’altrui vantaggio […] Perciò sebbene uccidere un uomo che
rispetta la propria dignità sia cosa essenzialmente peccaminosa, uccidere un uomo che pecca può
essere un bene, come uccidere una bestia: infatti un uomo cattivo, come insiste a dire il Filosofo, è
peggiore e più nocivo di una bestia»1.
Il potere di comminare la pena di morte da parte dell’autorità legittima viene ribadito con
continuità e in maniera formale sia dal Catechismo di Trento, sia da quello di Pio X, e da Pio XII
ancora nel 19522.
Una svolta importante inizia col Concilio Vaticano II, che si esprime in modo molto diverso:
la Gaudium et Spes (27, 28, 51) condanna «ogni specie di omicidio», sostenendo che Dio ha
affidato agli uomini il compito di proteggere la vita, e sottolineando che anche l'autore di delitti
conserva la propria dignità di essere umano. Paolo VI non si è pronunciato direttamente sulla
questione, ma - pur non contestando formalmente il diritto degli stati di infliggere la pena capitale è intervenuto, nel 1970, chiedendo di non uccidere i condannati nei processi di Burgos e
Leningrado. Per quanto riguarda poi Giovanni Paolo II, numerosissimi sono i suoi interventi che
affermano l'inviolabilità della vita umana e tale è anche la posizione di Benedetto XVI.
L’ultimo passo della chiesa
Come spiegare questa evoluzione del magistero cattolico? Con il fatto che i contenuti della
fede, compresi quelli che riguardano la verità sull’uomo, vengono compresi nel tempo, e in maniera
sempre più profonda, grazie all’esperienza storica. La chiesa assorbe, almeno in parte, i contenuti
culturali dell'epoca in cui vive - e ci sono state epoche in cui la pena di morte era considerata del
tutto accettabile secondo la mentalità comune -, ma non li accoglie in maniera acritica; al contrario,
anche se con fatica e non senza errori, per l'azione dello Spirito purifica e rettifica i contenuti
culturali dell'epoca in cui vive, riconducendoli mano a mano al progetto di Dio; da una parte, riceve
aiuto da ciò che gli uomini, credenti e non credenti, sperimentano e comprendono; dall’altra, li
illumina sul significato profondo dei valori che essi, nel corso della storia, vengono scoprendo. Il
caso dell’attuale Catechismo della chiesa cattolica è interessante anche perché mostra questa
corrispondenza, questo cammino comune tra chiesa e umanità.
Il tema della dignità della vita è ad un tempo unitario e complesso: complesso, perché gli
attentati alla vita sono molteplici; unitario, perché contro ognuno di tali attentati si afferma lo stesso
principio: «Non uccidere». In questo senso, il Catechismo è davvero paradigmatico, costituisce cioè
un modello di come si debba ordinare ed affrontare la materia. Le affermazioni riguardanti la pena
di morte vengono infatti inserite sotto il titolo della «Legittima difesa», all’interno della parte
relativa al quinto comandamento («Non uccidere») e al corrispondente obbligo del «rispetto della
vita umana». La legittima difesa apre un approfondimento che tocca, successivamente, l’omicidio
volontario, l’aborto, l’eutanasia, il suicidio.
1
2
La Somma Teologica, II-II, q. 64, a. 2.
Allocuzione del 13 settembre 1952.
2
Ed è molto interessante costatare come una simile struttura di pensiero e di argomentazioni
sia presente in uno dei maggiori rappresentanti del “pensiero laico” del Novecento, Norberto
Bobbio: «Per dare un’idea anche soltanto approssimativa - egli scrive - dell’ampiezza e della
rilevanza di questo dibattito si consideri che esso comprende, oltre il tema del diritto alla vita, in
senso stretto, ovvero il diritto a non essere uccisi, il diritto a nascere o a essere lasciati venire alla
vita, il diritto a non essere lasciati morire e il diritto a essere mantenuti in vita o diritto alla
sopravvivenza. Poiché non vi è diritto di un individuo senza il corrispondente dovere di un altro, e
poiché ogni dovere presuppone una norma imperativa, il dibattito sulle quattro forme in cui si
esplica il diritto alla vita rinvia al dibattito sul fondamento di validità ed eventualmente sui limiti del
dovere di non uccidere, di non abortire (o di non procurare l’aborto), di soccorrere chi è in pericolo
di vita, di offrire i mezzi minimi di sostentamento a chi ne è privo»3.
Battersi per la difesa della vita, in sostanza, dev’essere chiaro a credenti e non credenti,
richiede un atteggiamento coerente che si impegni su tutti i fronti di applicazione di tale principio.
Che cosa dice dunque il nuovo Catechismo? Tra la prima edizione del 1992 e quella
successiva del 1997, attualmente in vigore, esso introduce una sostanziale variazione
nell’argomento che ci interessa. Nel 1992 esso sottolinea la legittimità della difesa della propria
vita, che va intesa non solo come un diritto, ma come «un grave dovere, per chi è responsabile della
vita di altri, del bene comune della famiglia o della comunità civile» (2265). D’altra parte, citando
Tommaso, sostiene che «se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario, il
suo atto è illecito» (2264).
Questo criterio della proporzionalità, che accompagna la legittima difesa quando è attuata da
un privato, va applicato anche nel caso della legittima difesa attuata dallo stato. Infatti il
Catechismo, pur riconoscendo, in accordo con «l’insegnamento tradizionale della chiesa», alla
«legittima autorità pubblica» il diritto e il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del
delitto, «senza escludere, in casi di estrema gravità, la pena di morte» (2266), aggiunge che
l’autorità deve limitarsi ad usare mezzi incruenti, se questi sono sufficienti a raggiungere lo scopo di
difendere le vite umana, proteggere l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone (2267).
Questa formulazione era già di per se sufficiente ad impedire il ricorso alla pena di morte da
parte degli attuali stati, che dispongono delle risorse per impedire al colpevole di rendersi ancora
pericoloso, pur senza ucciderlo. Ma il Catechismo, pur escludendo l’applicazione della pena
capitale nella pratica, continuava ad accettare il potere dello stato di erogare pene in proporzione
alla gravità del crimine fino ad arrivare alla pena di morte: ma così facendo, il Catechismo accettava
un criterio di giustizia retributiva che si radica nella legge del “occhio per occhio” e non ha nulla a
che fare col principio di difesa dell’aggredito e di contenimento dell’aggressore.
Il dibattito sorto in seno alla chiesa su questo punto ha portato, nel giro di pochissimi anni,
ad un sostanziale cambiamento: nell’edizione successiva del Catechismo, attualmente in vigore, non
si sostiene più che la proporzionalità della pena possa arrivare fino alla morte; e si ammette il
ricorso alla pena di morte solo per difendere con efficacia dall’aggressore ingiusto: è evidente che
tale necessità di difendersi è ammissibile sono in presenza di un pericolo grave, attuale, non
altrimenti superabile; e che tale necessità non sussiste più nel momento in cui l’aggressore è stato
fermato e viene sottoposto al giudizio; in tal modo, si applica allo stato, in maniera rigorosa, la
logica della legittima difesa: lo stato può uccidere solo per difendere la comunità nel corso di un
pericolo, mentre non possiede in sé il potere di dare la morte, con una sentenza, quando il pericolo è
stato superato.
Questo traguardo raggiunto dalla chiesa cattolica corrisponde ad una analoga
consapevolezza che sta crescendo anche nell’umanità. C’è dunque speranza, nonostante le attuali
difficoltà, di riuscire a togliere il cappio dal collo del nostro tempo.
3
Bobbio N., Il dibattito attuale sulla pena di morte, in La pena di morte nel mondo.
Convegno internazionale di Bologna (28-30 ottobre 1982), Marietti, Casale Monferrato 1983, pp.
20-21.
3
BOX 1
Che cosa dice il Nuovo Testamento?
Nel Nuovo Testamento tre testi in particolare, in passato, sono stati utilizzati per far dire loro
ciò che in effetti – da soli - non dicono, e cioè una accettazione o un rifiuto espliciti della pena di
morte.
Anzitutto, i due passi tra loro vicini della Lettera ai Romani: il primo, «Non fatevi giustizia
da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io
che ricambierò, dice il Signore» (Rm 12,19), non è tale da farne discendere un ripudio di principio
contro la pena di morte; mentre il secondo, che sottolinea la caratteristica da parte dello stato di
esercitare la giustizia anche attraverso la forza, non può venire inteso come una giustificazione di
principio della pena capitale: «Ma se fai il male allora temi, perché non invano essa [l’autorità]
porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male» (Rm 13,4).
E neppure l’ordine dato da Gesù a chi lo accompagnava, al momento del suo arresto, di
rimettere la spada nel fodero, può venire interpretato come una indicazione su come lo stato debba
comportarsi con la pena capitale, ma semplicemente come la sottolineatura da parte di Gesù che
quella delle armi non è la sua logica (Mt 26,52).
Ma il vangelo di Giovanni (Gv 8, 2-11) riporta un episodio che ha valore dirimente sulla
questione, quando Gesù interviene per sospendere l’esecuzione di una pena capitale nei confronti
dell’adultera. Con le parole: «Chi è senza peccato scagli la prima pietra», egli mette i giudiciesecutori che si apprestavano a lapidarla, di fronte alla realtà della propria condizione umana: voi
che siete peccatori, come potete pensare di disporre della vita umana? Col suo intervento Gesù
vuole chiarire, nella coscienza di ciascuno, la differenza tra il Creatore, che dispone della vita, ma
ne dispone creandola e donandola, e le creature, le quali, di fronte alla grandezza misteriosa della
vita ricevuta, devono ammettere di non avere potere su di essa. Gesù, in un primo momento, non
entra nel merito del giudizio sul criminale - la donna aveva certamente infranto la legge - , ma
contesta il principio del potere umano sulla vita umana, aprendo la legge mosaica, interprete della
volontà divina, ad una sua lettura secondo lo Spirito di un Dio che è Amore. Gesù rivela le
intenzioni originarie di Dio al di là della durezza dei cuori di cui la legge è denuncia.
La venuta di Gesù annuncia quella “pienezza dei tempi” in cui l'uomo può aprire il cuore
all'azione dello Spirito, che lo rende capace di una adesione sempre più perfetta al disegno di Dio.
Questa perfezione a cui l'uomo è chiamato è già vissuta da Gesù. Nell'episodio dell'adultera infatti,
dopo che tutti se ne sono andati senza scagliare la pietra, Gesù aggiunge: «Neppure io ti condanno».
Eppure Gesù, essendo senza peccato, avrebbe potuto condannarla: il suo perdono invece è
manifestazione del rispetto e dell'amore di Dio per la creatura, amore cui anche l'uomo deve
giungere.
BOX 2
Pena di morte e Islam
L’Islam può uscire da una tradizione profondamente contrassegnata dalla presenza della
pena di morte?
Maxime Rodinson sottolinea che il diritto musulmano tradizionale si sovrappone ad un
precedente sustrato arabo, che l’islamismo cerca di mitigare: «Il Corano stabilisce anche che
bisogna arrestare la catena delle vendette, affinché gli assassinii non c continuino all’infinito. E poi
c’è l’incoraggiamento ad accettare un’indennità in denaro invece del sacrifico umano»4.
4
Rodinson M., La pena di morte nella tradizione islamica, in La pena di morte nel mondo,
cit., p.63.
4
Questa possibilità – spiega Dalil Boubakeur - non è motivata soltanto ad esigenze di ordine
pubblico e di pacificazione, ma ha anche un fondamento religioso: «Così l’Islam in numerosi
versetti del Corano ricorda il comportamento di giustizia equa raccomandato da Dio, ossia sforzarsi
di non rispondere al male con il male; e che, anche se si tratta di un’offesa o di un delitto di sangue,
la riparazione o il perdono sono preferibili alla perpetuazione della vendetta e particolarmente
all’antica legge del taglione»5.
Il Profeta stesso ha più volte comminato la pena di morte; d’altra parte, ha anche esortato ad
aiutare il fratello, anche se oppressore, per ricondurlo alla giustizia. Perché non si potrebbe pensare
di arrivare, allora, ad applicare questo atteggiamento non solo ai rapporti interpersonali, ma anche
come limitazione al potere dello stato?
Boubakeur vuole appunto sottolineare la possibilità di una evoluzione del diritto, quando
ricorda che certe prescrizioni della shari’a, quali la lapidazione per l’adulterio e le punizioni
corporee per il furto, lo stupro e l’assassinio, appartengono al periodo medinese (dalla Hijira del
622): «Fu in questa seconda fase dell’Islam che quelle prescrizioni della shari’a vennero rivelate, in
circostanze storiche particolari che relativizzano quei versetti a quelle circostanze»6.
Antonio Maria Baggio
5
6
Boubakeur D., Colpevolezza e punizione nell’Islam, in “Humanitas”, LIX (2004), p. 288.
Ivi, p.293.
5
![Col cappio al collo [pena di morte] 3-2007](http://s1.studylibit.com/store/data/001021223_1-3659f2e972b7f952df6040504f496ef3-768x994.png)