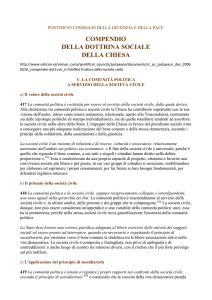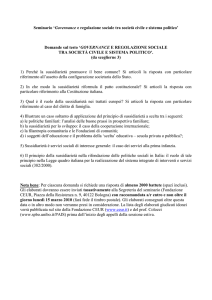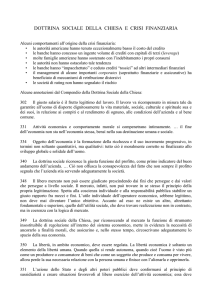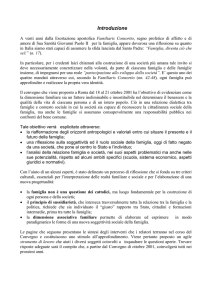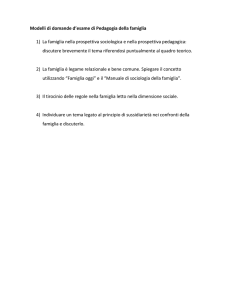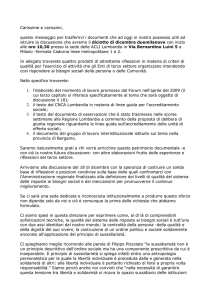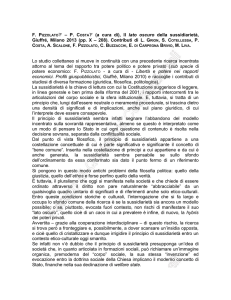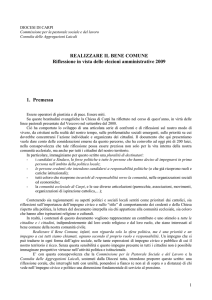Introduzione
A venti anni dalla Esortazione apostolica Familiaris Consortio, segno profetico di affetto e di
amore di Sua Santità Giovanni Paolo II per la famiglia, appare doverosa una riflessione su quanto
in Italia siamo stati capaci di assumere la sfida lanciata dal Santo Padre: “Famiglia, diventa ciò che
sei!” (n. 17).
In particolare, per i credenti laici chiamati alla costruzione di una società più umana tale invito si
deve necessariamente concretizzare nella volontà, da parte di ciascuna famiglia e delle famiglie
insieme, di impegnarsi per una reale “partecipazione allo sviluppo della società”. E’ questo uno dei
quattro mandati attraverso cui, secondo la Familiaris Consortio (nn. 42-48), ogni famiglia può
approfondire e realizzare la propria vera identità.
Il convegno che viene proposto a Roma dal 18 al 21 ottobre 2001 ha l’obiettivo di evidenziare come
la dimensione familiare sia un fattore ineliminabile e insostituibile nel determinare il benessere e la
qualità della vita di ciascuna persona e di un intero popolo. Ciò in una relazione dialettica tra
famiglie e contesto sociale in cui la società sia capace di riconoscere la cittadinanza sociale della
famiglia, ma anche le famiglie si assumano consapevolmente una responsabilità pubblica nei
confronti del bene comune.
Tale obiettivo verrà esplicitato attraverso:
la riaffermazione degli orizzonti antropologici e valoriali entro cui situare il presente e il futuro
della famiglia;
una riflessione sulla soggettività ed il ruolo sociale della famiglia, oggi di fatto negato da una
società, che pone al centro lo Stato e l’individuo;
l’analisi della relazione famiglia e società, nei suoi aspetti problematici ma anche nelle sue
potenzialità, rispetto ad alcuni ambiti specifici (scuola, sistema economico, aspetti giuridici e
normativi).
Con l’aiuto di un alcuni esperti, è stato delineato un percorso di riflessione che si fonda su tre criteri
culturali, essenziali per l’interpretazione delle realtà familiare e sociale e per l’elaborazione di una
nuova progettualità:
la famiglia non è una questione dei cattolici, ma luogo fondamentale per la costruzione di
ogni persona e della società;
il principio di sussidiarietà, che interseca trasversalmente tutta la relazione tra la famiglia e la
politica, richiede che sia individuato il “giusto” rapporto tra Stato, cittadini e formazioni
intermedie, prima tra tutte la famiglia;
la dimensione associativa familiare permette di elaborare ed esprimere
in modo
paradigmatico le forme di una nuova soggettività sociale della famiglia.
Le pagine che seguono presentano le sintesi degli interventi che i relatori terranno nel corso del
Convegno e costituiscono uno stimolo all’approfondimento. Viene pertanto proposto un agile
strumento di lavoro che aiuti i diversi soggetti coinvolti a inquadrare le questioni aperte. Trovare
risposte adeguate sarà il compito che, a partire dal Convegno di ottobre 2001, coinvolgerà tutti nei
prossimi anni.
La famiglia come soggetto sociale: ragioni, sfide, programmi
Pierpaolo Donati
1. La famiglia come “soggetto di mediazione sociale”
Le più recenti ricerche sul campo evidenziano che la famiglia media, in modo diverso dal passato,
una quantità di posizioni e di relazioni sociali che, ben lungi dall’essere meno rilevanti di un tempo,
sono anzi più decisive per il destino sociale dell’individuo e la qualità della sua vita. La mediazione
attiva della famiglia non si esplica soltanto verso i figli, ma riguarda tutti i soggetti individuali che
la compongono, poiché - volenti o nolenti - è la rete di relazioni che media il singolo con la società
più ampia.
Osservata dalla parte degli individui, la mediazione si presenta più o meno estesa in rapporto alle
risorse della famiglia, al suo sistema di valori e al contesto ambientale in cui è inserita; inoltre, è
nettamente diversa secondo lo strato sociale in cui si esplica.
Osservata dalla parte degli altri sottoinsiemi della società, la mediazione assume una diversa
coloritura. Queste istituzioni sociali - dalla scuola, ai servizi sociosanitari, alle aziende - sono
talmente pervase da tendenze autoreferenziali che, per loro, la mediazione familiare diventa sempre
più difficile da cogliere, comprendere e tenere in conto pratico quando si tratta di organizzare i
rapporti tra famiglia e scuola, tra famiglia e servizi, tra famiglia e azienda.
Negli ultimi anni, la mediazione-famiglia non è affatto venuta meno; piuttosto, si è diffusa e
accentuata la sua privatizzazione: la mediazione non è più istituzionale, ma tendenzialmente più
privatistica e soggettivizzata.
Come si generano queste nuove mediazioni? Sotto un certo aspetto, “dal basso anziché dall’alto”;
ma sarebbe più corretto dire: non più attraverso norme di controllo suggerite dal “centro” verso la
“periferia”, o dal “ vertice” verso la “base”, bensì come esigenza delle stesse relazioni del mondo
vitale della famiglia nel loro definirsi per differenza da ciò che familiare non è. Generalizzando,
potremmo affermare che le mediazioni familiari sono generate e rigenerate se e in quanto la
differenziazione della società richiede, per la formazione dell’identità dei singoli, una continua
rigenerazione delle appartenenze.
Dal punto di vista ermeneutico, dire mediazione familiare vuol dire essere richiamati all’ascolto
dell’altro. La mediazione familiare appare qui come bisogno di articolare, allo stesso tempo, la
fiducia e il contratto, il legame come vincolo e come discorso intersoggettivo, il bisogno interiore di
senso e la necessità di riferirsi ad altro da sé. La famiglia, infatti, proprio come relazione sociale, è
tutto questo, e senza tutto questo non sarebbe relazione: quella relazione sociale sui generis che di
fatto è.
Dal punto di vista sistemico, le mediazioni si configurano come nuove distinzioni che la società
deve operare riguardo alle appartenenze reciproche che le persone scelgono nel tempo. La domanda
con cui si trova confrontata è duplice: il far parte di una certa famiglia è più o meno rilevante a
determinati fini sociali? E che cosa ne deriva per la società? Porsi questi interrogativi significa, per
la società, chiedersi che cosa costi e quali vantaggi procuri il fatto che le persone siano “famiglia”
oppure no. Questi calcoli, tuttavia, non possono essere di tipo economico: sono innanzitutto di tipo
simbolico, perché le mediazioni, viste dal lato dell’individuo, aiutano a identificarsi - e con ciò a
trovare un proprio posto nel mondo (si pensi a quanto decisivo sia il compito delle mediazioni
familiari nel dare fiducia a un figlio che deve crescere; all’importanza, nell’esistenza personale, di
“avere una casa “, con tutto ciò che essa significa, e così via) - e, se viste dal lato della società,
aiutano a instaurare forme di convivenza civile nella sfera pubblica: il fatto che le persone vivano
relazioni familiari non è indifferente per le virtù civiche né per la qualità della cittadinanza.
La famiglia, come relazione di appartenenza scelta, ri-entra dunque nei ruoli della società.
L’appartenenza familiare ridiventa centrale nelle identità personali e sociali: per sentirsi ed essere
persone ci si deve ancora confrontare con la famiglia. E così per la società: se si vuole costruire una
convivenza civile umana occorre di nuovo guardare alla famiglia.
E’ però impossibile comprendere le nuove mediazioni se non si passa per il concetto di
“soggettività della famiglia”. Esso sta a significare che:
a) ogni azione/relazione è legata alle altre (per esempio, la mediazione della madre per un figlio è
meglio comprensibile e realizzabile tenendo presente la relazione con il padre);
b) il simbolo della (propria) famiglia media una quantità implicita (oltreché esplicita) di altri
simboli, senza i quali non può formarsi l’identità personale;
c) se è indiscutibilmente vero che la società moderna tende a separare l’individuale dal sociale, e
per questa via a mettere tendenzialmente in crisi la mediazione familiare, nel contesto postmoderno
emerge il bisogno e l’identità di una relazione fra individuale e sociale che assicuri nuove funzioni
sociali e nuovi conferimenti d’identità;
d) in tale contesto, la famiglia non emerge allora soltanto come nuova modalità e forma del
comunicare, ma anche e soprattutto come nuova soggettività sociale in un senso preciso, e cioè
come bene relazionale in sé.
Soggettività della famiglia, alla fine, significa che la famiglia, proprio in quanto mediazione,
diventa un nuovo “bene”, che è sentito, vissuto e perseguito con intenzionalità di senso proprio, non
subordinato né dipendente da altri contesti o variabili. Non sono più questi contesti che impongono
un certo modello di famiglia, ma sono i sentimenti e il modo autonomo di rappresentarsi le relazioni
familiari che vanno a poco a poco proiettando la loro influenza su tali contesti: così, la famiglia dà
una propria visione della scuola, dell’economia, della politica, e anche della Chiesa; addirittura,
elabora un nuovo senso dei diritti, non solo quelli privati, ma anche di quelli sociali e perfino
politici.
2. Le nuove mediazioni pongono l’esigenza di una nuova cittadinanza della famiglia
In termini culturali, civili e politici si apre allora il problema di vedere se le nuove identificazioni e
mediazioni che la famiglia attua come soggetto relazionale possano/debbano o meno essere tradotte
in una nuova cittadinanza della famiglia come tale (e non già come estensione o proiezione di diritti
individuali).
In questo nuovo contesto storico, che cosa significa “cittadinanza della famiglia”? Alla luce di
quanto sinora detto, a me sembra che tale espressione indichi almeno che:
a) la famiglia si rigenera come simbolo condiviso (nel senso di non privato, né privatizzabile) delle
relazioni primarie, un simbolo che per certi aspetti accentua il proprio carattere di “regola del
gioco” fondamentale - anche se non certo l’unica - nella società civile e politica, in quanto
mediazione di equità fra i sessi e fra le generazioni;
b) la famiglia si riorganizza come nodo di relazioni in cui si condensano diritti e doveri individuali e
collettivi; essa, anzi, diventa un nesso generativo di nuovi diritti e nuove obbligazioni (è importante,
a questo proposito, tenere ben presente che parlare di cittadinanza della famiglia non significa
affatto assumere a priori un certo modello di famiglia, tantomeno patriarcale, bensì orientarsi a
criteri relazionali secondo la pari dignità dei sessi e i fondamentali diritti della persona umana in
quanto tale, a cominciare dai figli, ovviamente anche minori);
c) la famiglia diventa uno di quei soggetti sociali a cui si attribuisce una nuova titolarità di diritti
secondo orientamenti di cittadinanza societaria, cioè come espressione di un’originarietà di diritti
generati in e da una welfare society in cui si manifestano esigenze di autoorganizzazione da parte
delle formazioni sociali primarie e secondarie verso una qualche fuoriuscita, almeno per certi
aspetti, da un’eccessiva “tutela” da parte dello Stato.
Affermare la cittadinanza della famiglia significa, dunque, riconoscere e valorizzare (cioè
promuovere) regole e comportamenti ispirati a criteri di solidarietà, ovvero di piena reciprocità: il
concetto di cittadinanza rivendica il valore positivo di queste mediazioni, anziché la legittimazione
di regole e comportamenti ispirati a criteri d’indifferenza o, peggio, di penalizzazione della
mediazione solidaristica esercitata dalla famiglia.
Promuovere la cittadinanza della famiglia significa, in altri termini, optare per scelte che si
muovono nella direzione di una reale, più compiuta democrazia: una democrazia fatta di solidarietà,
condivisione, partecipazione e autonomia delle persone come individui in relazione gli uni con gli
altri.
Nuova cittadinanza della famiglia significa che questa non è più una struttura di controllo, ma
neppure è considerata - di fatto o in potenza - una realtà frammentata; il far parte di una famiglia
diventa titolarità per l’accesso a diritti promozionali - e non solo di tutela - dei diritti individuali,
secondo criteri solidaristici.
Per arrivare a comprendere i vantaggi di un discorso pubblico e comune sulla famiglia bisogna
assumere un punto di vista non privatistico, cioè guardare a problemi e a interessi collettivi e
diffusi. Ne porterò due esempi:
a) Si può osservare che, di fatto, una quantità crescente di problemi sociali nasce dal mancato
riconoscimento e sostegno delle funzioni di mediazione sociale della famiglia. Lo testimonia
l’aumento del disagio, del malessere, delle malattie mentali, delle tossicodipendenze, dei suicidi fra
i giovani. La società non può illudersi di risolvere questi problemi ignorando la mediazione
familiare o pensando di affrontarla in maniera indiretta, attraverso misure rivolte a singoli bisogni e
a singoli destinatari: infatti, se la mediazione familiare dovesse essere ulteriormente negata, o
riconosciuta soltanto per via indiretta, e più o meno implicitamente penalizzata, è sociologicamente
certo che andremo incontro a problemi più seri e devastanti, poiché la famiglia dovrebbe
sobbarcarsi oneri ancora maggiori dei presenti - soprattutto nei rapporti tra le generazioni - dovendo
rimediare ai crescenti bisogni dell’infanzia, dei giovani e degli anziani senza essere riconosciuta in
tali funzioni. Si deve avere ben chiaro che della mediazione familiare abbiamo bisogno pressoché
tutti - non soltanto il bambino o l’anziano non autosufficiente - perché nessuno può fare a meno di
una relazione di fiducia, di aiuto e di sostegno primario nel corso della propria vita.
b) Si può anche osservare che, se fino a ieri vi era stata una correlazione inversa tra forza dello Stato
e forza della famiglia, tale correlazione storica non può essere valida oggi, in una società
postmoderna o complessa. Se infatti la costruzione dello stato-nazione moderno era avvenuta contro
la famiglia intesa come potentato d’interessi particolaristici - una costruzione, quella, necessaria
sotto molti aspetti - oggi la famiglia e lo Stato postmoderni sono più interdipendenti, e devono
trovare una correlazione positiva fra loro. La famiglia deve farsi “relazione comunitaria
d’intermediazione fra individuo e società”, cioè relazione che esprima una precisa sfera di diritti di
cittadinanza: i diritti di chi, per il fatto di vivere in una famiglia, deve essere riconosciuto e
sostenuto con adeguate intitolazioni (o “diritti di accesso” a garanzie e diritti sociali) nell’esercizio
delle mediazioni che questo fatto porta con sé.
In questi ultimi anni, nonostante le innumerevoli difficoltà che le si sono contrapposte, la famiglia
italiana si è dimostrata quanto mai vitale, estremamente adattativa e anche innovativa, nei confronti
della società. L’efficienza delle mediazioni che ha operato è stata naturalmente diversa a seconda
delle sue diverse configurazioni, opportunità e risorse, in rapporto allo status sociale dei suoi
membri e al contesto territoriale.
Che in tanti momenti, o in tanti casi, la famiglia non riesca più a essere sfera o soggetto di
mediazione, non meraviglia; nondimeno, attraverso tentativi ed errori, essa non smette di elaborare
nuove soluzioni. Forse, potrà anche arrivare a chiedere alla società politicamente organizzata da
quale parte sia: se da quella di un astratto individualismo, o da quella di un impegno per costruire
relazioni più umane. Dalla risposta che riceverà dipenderà quali e quante nuove mediazioni essa
dovrà attivare, per amore o per necessità.
Incrementare “il famigliare”:
il compito perenne della famiglia in un mondo che cambia
Eugenia Scabini
1. L’identità psico-antropologica della famiglia
Oggi, il rapido mutare dei costumi e dei comportamenti tra le generazioni passate ed attuali e la
presenza di stili e modalità diverse di fare famiglia, ci fa riproporre con forza l’interrogativo: qual' è
l'identità psico-antropologica della famiglia, la sua sostanza simbolica che la fa esistere come
soggetto e progredire pur nelle forme così diverse che ha assunto nel corso della storia e che
caratterizzano il tempo presente?
Per comprendere l’identità della famiglia dobbiamo cogliere il suo livello aggregativo primario. La
famiglia infatti è quella specifica ed unica organizzazione che lega e tiene insieme le differenze
originarie dell’umano, quella tra generi (maschile e femminile), tra generazioni (genitori e figli) e
tra stirpi (l’albero genealogico materno e paterno).
La famiglia è fatta di relazioni, di legami e genera legami. Possiamo distinguere legami interni alla
famiglia e alla sua storia e legami tra la famiglia e la comunità nella quale la famiglia vive.
I due tipi di legami sono connessi, perché legami deboli e frammentati all'interno, rendono la
famiglia soggetto sociale debole e viceversa una forte capacità relazionale tra i soggetti della
famiglia, rende la famiglia capace di relazioni "efficaci" con il suo intorno.
La mia relazione si focalizzerà tuttavia prevalentemente sul primo versante, quello cioè dei legami
intrafamiliari.
I legami familiari sono primari, vale a dire sono fondamentali per la costruzione della identità.
Agiscono e si esprimono nella concretezza dei comportamenti quotidiani ma sono lunghi, cioè ci
riportano al nostro passato, alla genealogia delle nostre stirpi di appartenenza e si proiettano nel
futuro, nella speranza di fecondità di nuove generazioni. La famiglia è una comunità di generazioni
che collega vivi e morti, generazioni presenti, passate e a venire.
Il suo obiettivo e progetto intrinseco è racchiuso nella parola generare. La famiglia non riproduce
ma genera, dà forma umana, umanizza ciò che da lei nasce e ciò che in lei si lega.
2. Il famigliare
Come la famiglia persegue questa sua funzione imprescindibile di dar vita all'umano che è il segno
e l'espressione del suo essere un soggetto?
La famiglia umanizza, genera l’umano, genera un bene relazionale, attraverso la sua struttura
simbolica. Chiamiamo “il famigliare” questa linfa simbolica che dà senso e valore ai legami
familiari. Il famigliare è l'identità profonda della famiglia, la radice psichica del suo essere
"soggetto".
Il famigliare è formato dalle qualità di base dei legami familiari. Essi vivono di aspetti affettivi ed
etici. La famiglia è il luogo sorgivo degli affetti più profondi ed anche il luogo della responsabilità
nei confronti dell’altro, sia il piccolo di cui ci si prende cura o l’uomo o la donna cui ci si lega. Le
relazioni familiari sono perciò costituite da una sostanza etico-affettiva.
L’espressione “prendersi cura” (tipica della semantica del famigliare) esprime entrambi i poli,
perché fa riferimento sia al nutrimento affettivo che a quello morale-valoriale (ciò per cui vale la
pena di vivere).
Il prototipo della qualità affettiva è la fiducia-speranza, ed il prototipo di quella etica è la lealtàgiustizia. Esse, in una certa misura, convivono con il loro opposto: nessuna famiglia è infatti
perfetta e una certa quota di mancanza di fiducia e di prevaricazione vive nelle nostre relazioni
familiari.
Il famigliare ha dunque una struttura drammatica: è la sede del benessere della persona, ma può
essere anche la sede della grave patologia e sofferenza psichica.
Se osserviamo le relazioni familiari dal punto di vista di ciò che si dà e si riceve, di ciò che ci si
scambia tra membri della famiglia, ritroviamo la stessa componente etica e affettiva, espressa dalla
polarità dono-debito.
Il dono è una caratteristica del legame familiare che ha alla sua origine un incontro, un’apertura di
credito, la fiducia nell’altro e nella vita. Il dono di sé fonda la relazione coniugale e il dono della
vita la relazione genitori-figli. Quando questo elemento di gratuità è assente infatti ci troviamo di
fronte alla patologia relazionale di chi non è in grado di donare o usa e sfrutta l'altro. Ma il dono
convive con l'altra faccia della medaglia, cioè il debito e l'obbligo.
Tutto ciò emerge chiaramente dalla dinamica dello scambio tra le generazioni che accompagna una
nuova nascita. Infatti la nascita è frutto di un dono, il dono della vita, ma il figlio che ha ricevuto la
vita dai suoi genitori si trova perciò stesso legato da un debito di riconoscenza per quello che da essi
ha ricevuto. Il debito può diventare un grande fardello psichico (e in questo caso il legame familiare
è “sofferente”, si ammala) o può liberamente e vitalmente trasformarsi in desiderio di restituzione (e
in questo caso il legame familiare si ri-genera). Mettere al mondo responsabilmente un figlio da
parte della generazione giovane è anche un modo significativo di restituire alla generazione
precedente quel che si è ricevuto, dimostrando nei fatti di averlo apprezzato.
3. Rafforzare la famiglia come soggetto
Queste qualità etico affettive (fiducia/lealtà; dono/debito) costituiscono l’anima della relazione tra
coniugi, tra genitori e figli, e tra stirpi.
Riuscire ad incrementare il famigliare, cioè questa linfa simbolica, e contrastarne i processi
degenerativi che ogni epoca e ogni famiglia conosce è il compito cui siamo chiamati.
Realizzare questo compito significa rafforzare la famiglia come soggetto e contrastarne la
frammentazione. In generale possiamo dire che, nella società odierna, vi è uno squilibrio tra aspetti
affettivi ed etici: i primi sono sovrainvestiti ed i secondi sottostimati. Gli affetti senza una direzione
si trasformano così in fluttuanti sentimenti e la incertezza sul “valore” ed il senso dell’appartenenza
e del compito familiare indebolisce ed impoverisce i legami che cercano stabilità in continui quanto
inefficaci appelli a regole di comportamento.
Possiamo brevemente cercare di capire cosa significa incrementare il famigliare e contrastare i
rischi tipici del mondo odierno per le varie relazioni, la relazione coniugale, la relazione genitorifigli, la relazioni tra stirpi. Possiamo cioè identificare degli specifici obiettivi di sviluppo,
mettendoci quindi in una prospettiva attiva, di superamento di ostacoli, di riappropriazione di un
bene (il famigliare) che ogni generazione deve ri-conquistare, ri-attualizzare, ri-generare a partire
dal patrimonio che le generazioni precedenti e le nostre singole storie familiari ci hanno consegnato.
Molto in sintesi: per la relazione coniugale l’obiettivo può essere riassunto nell’espressione
“costruire e rinnovare negli anni il patto di reciprocità”, per la relazione genitori/figli
nell’espressione “alimentare la cura responsabile” e per la relazione tra le stirpi di origine
“prendersi cura della duplice eredità”.
L'intervento si chiuderà con qualche specificazione sui nodi critici del "famigliare" oggi. In
particolare, verrà posto l'accento sulla relazione genitori/figli tardo adolescenti o giovani adulti. La
trasmissione generativa, che inizia con la nascita di una nuova generazione, rivela infatti tutto il suo
potenziale relazionale e al contempo le sue difficoltà quando la nuova generazione deve cimentarsi
con un nuovo progetto famigliare.
La famiglia italiana nel grande spazio europeo:
tra enfasi dell’innovazione e valore della tradizione
Gian Carlo Blangiardo
1. La grande trasformazione
Ancora alla fine degli anni '50, quando ormai si configurava anche nel nostro Paese, come quasi
ovunque in Europa, la fase conclusiva del processo noto come “(prima) transizione demografica”, il
termine “famiglia” richiamava, nel senso più usuale, “i legami naturali connessi col processo della
riproduzione”, principalmente nella misura in cui questi legami venivano “socialmente sanzionati
da strette norme legali o di costume”. In sostanza, una visione della famiglia saldamente fondata nel pensiero dominante della comunità scientifica e della cultura del tempo- “sul vincolo fra sposi
che ha origine nel matrimonio e sulla relazione che sussiste fra genitori - padre o madre - e i loro
figli”.
Da allora molte cose sono cambiate, sia da noi che altrove. Non solo in termini quantitativi, come
testimoniano i dati sulla crescita e sulla trasformazione dimensionale delle famiglie, ma soprattutto
riguardo alla tipologia delle diverse strutture familiari. Di fatto, il tradizionale modello di famiglia
fondata sul vincolo del matrimonio e usualmente orientata alla riproduzione ha via via trovato anche
in Italia significative eccezioni. Le così dette "nuove famiglie" sono andate affiorando da noi sulla
falsariga di un cambiamento che già da tempo ha interessato molti altri Paesi e che trova un
paradigma interpretativo in ciò che è stata definita “la seconda transizione demografica”. In essa si
richiamano i fattori strutturali, tecnologici e culturali che stanno alla base delle grandi
trasformazioni demografiche avviate nelle aree economicamente più sviluppate a partire dagli anni
’60 e se ne evidenziano gli effetti sul piano del comportamento sessuale e contraccettivo, delle
scelte nella sfera della fecondità e del ricambio generazionale, dei modelli di formazione e
dissoluzione della vita di coppia.
Teorizzando l’abbandono di un’epoca di altruismo nelle scelte familiari e riproduttive a favore di
una fase di crescente individualismo, i fautori della seconda transizione demografica ne identificano
i punti qualificanti sotto il profilo socio-demografico in quattro passaggi fondamentali:
- da quella che era stata da più parti definita come “l’epoca d’oro del matrimonio (la Golden Age of
Marriage tra la fine degli anni ’50 e primi anni ‘70), all’“alba della convivenza”;
- dalla centralità del modello “figli con genitori” al ruolo dominante della “coppia con figlio”;
- dal ricorso passivo alla contraccezione come strumento per scongiurare gravidanze indesiderate, al
suo impiego come supporto alla libertà di decidere “se” e “quando” soddisfare i progetti di
maternità;
- da una tipologia di famiglie uniforme e destinata ad accompagnare lo sviluppo naturale della
biografia di un individuo secondo la tradizionale sequenza coppia – genitori e figli - “nido vuoto” –
coniuge solo, ad una pluralità di forme familiari commisurate alle scelte organizzative, al contesto
socio-culturale e agli eventi che intervengono lungo le diverse fasi di un ciclo di vita individuale in
cui i progetti sono costantemente suscettibili di revisione.
2. I diversi modelli familiari
Tuttavia, se tali trasformazioni - largamente diffuse nel panorama europeo e puntualmente
documentate dall’analisi dei fenomeni che le determinano – rendono evidente la legittimità di una
rivisitazione al plurale del concetto classico di famiglia associata al binomio matrimonioriproduzione, non altrettanto legittima appare invece la prospettiva di un’automatica equiparazione
dei differenti modelli familiari che vanno emergendo, sia per il diverso ruolo che essi svolgono
Il contributo di Gian Carlo Blangiardo qui presentato fa parte del VII Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia. Identità e
varietà dell’essere famiglia: il fenomeno della “pluralizzazione” (a cura di P. Donati, Edizioni San Paolo), di prossima
pubblicazione, che sarà in vendita in tutte le librerie a partire dal 15 ottobre 2001.
nella società (rispetto al quale andrebbero graduati sostegni e riconoscimenti), sia riguardo al livello
di diffusione e di importanza che essi detengono nei diversi Paesi. Anche perché, nonostante la
generale condivisione delle tendenze demografiche in atto, ogni singola realtà nazionale manifesta
una sua specificità culturale economica e politica che si riflette nelle scelte e nei comportamenti
familiari, e che produce una varietà di situazioni locali o regionali ove tradizione ed innovazione, di
volta in volta, prevalgono e si combinano con modalità differenti.
L’analisi statistica delle forme di aggregazione familiare attraverso le quali le popolazioni europee
interagiscono - per scelta o per necessità - con gli eventi che accompagnano le diverse fasi del ciclo
di vita, se rispetto alla varietà delle tipologie offre valide argomentazioni ai teorici di un Europa in
cammino lungo la via della seconda transizione demografica, sul piano della loro diffusione
evidenzia significative distanze e forti resistenze nel processo di armonizzazione delle strutture e
degli stili di vita familiare.
Di fatto, persistono profonde differenze nella realtà sociale, culturale e politica tra (e spesso entro) i
Paesi europei. Condizioni che possono anche produrre manifestazioni dei fenomeni sociodemografici spesso incoerenti rispetto agli obiettivi e agli ideali, e talvolta diversificate anche là
dove sussiste un’identità di vedute. Eloquente in proposito è, alla luce dei risultati di alcune recenti
indagini, il confronto delle opinioni degli europei sul valore della scelta matrimoniale e sul
desiderio di maternità in assenza di una stabile relazione di coppia.
Sul primo punto, il rapporto tra la frequenza di chi si dichiara d’accordo nel ritenere il matrimonio
un’istituzione “obsoleta” e di chi dissente da tale affermazione è, in corrispondenza di popolazioni
che indubbiamente vivono una fase di forte contrazione della nuzialità, generalmente di 2 a 10
(benché talvolta in crescita tra le generazioni più giovani e moderatamente più elevato tra i maschi).
Al tempo stesso, la maternità senza partner fisso riscuote più legittimazione in Paesi come la
Polonia o la Spagna, contraddistinti da una quota di nati illegittimi nell’ordine dell’11%, che non in
Finlandia o in Ungheria, dove tale fenomeno raggiunge valori prossimi al 30-40%.
3. La situazione italiana
A tale riguardo, nella varietà di opinioni circa la condivisione di una scelta che chiama in causa un
importante fattore di garanzia della famiglia-nido – forse surrogata dal sistema di welfare nel
mondo nordico ma certamente più a rischio nelle società mediterranee – la posizione degli italiani, è
decisamente meno favorevole e segnala un recupero sul piano della coerenza. Ma è un accordo che
non trova conferma allorché si passa ad un successivo confronto tra realtà e ideali nell’area della
fecondità. Infatti, se al dato sull’attuale livello di riproduttività della popolazione italiana (1,2 figli
per donna) si affiancano: il diffuso giudizio negativo sulla rinuncia ai figli da parte di coppie
coniugate; l’ampia convergenza verso l’inizio della maternità in età relativamente giovane ed il suo
protrarsi oltre la soglia dei 40 anni; la forte condivisione del modello medio di (persino poco più di)
due figli per coppia; si ha la portata del divario tra ciò che si concepisce nell’ideale collettivo e ciò
che si concretizza come somma delle scelte e dei comportamenti individuali.
A ben vedere non si tratta di una peculiarità italiana, anche se da noi lo scostamento risulta più
esasperato che altrove. La media di (poco) più di due figli per donna è un modello ideale che
accomuna realtà profondamente diverse nel panorama europeo (prospetto 1). Mette insieme l’Italia
del Sud, la Spagna e il Portogallo a Paesi come la Francia, la Svezia, la Norvegia, l’Ungheria, la
Lettonia, e si dimostra relativamente stabile nel passare dalle donne nate negli anni ’50 alle
generazioni formatesi nel corso del ventennio successivo. La variabilità dei comportamenti
riproduttivi nello spazio europeo non sembra dunque spiegata né dalle diverse strutture familiari né
dai differenti modelli ideali di riferimento.
4. Le politiche familiari
Ecco allora affacciarsi, come chiave interpretativa, il tema delle politiche familiari e, più in
generale, del riconoscimento e del supporto che la famiglia è legittimata a richiedere alla società e
ai responsabili della politica. Non è casuale che tale istanza sia particolarmente sentita là dove gli
indicatori demografici (di nuzialità e di fecondità) più evidenziano il forte contrasto tra l’ampia
condivisione di modelli familiari “al singolare e nel segno della tradizione” e la reale possibilità di
una loro concreta attuazione da parte dei giovani e delle coppie.
In generale, si può affermare che anche nella molteplicità più o meno radicata delle forme, che
esprimono il pluralismo culturale della società di oggi, la famiglia europea resta delegata a svolgere
funzioni essenziali per il benessere degli individui che ne fanno parte, ma rivendica (in primo luogo
nel nostro Paese) più valorizzazione e sostegno per l’attività di “produzione “ e di formazione del
capitale umano. Compiti che essa continua ad interpretare ovunque all’insegna di un altruismo e di
una disponibilità al sacrificio che, quand’anche in forma meno accentuata nel susseguirsi delle
generazioni, raggiungono i livelli più elevati proprio in corrispondenza dei giovani italiani.
In conclusione, se anche l’abito della famiglia “coniugale e riproduttiva” dell’Italia degli anni ‘50 si
è ammodernato e può assumere oggi fogge differenti, le analisi dei dati statistici e le relative
valutazioni fanno ritenere che poco sia cambiato sotto il profilo del ruolo e dei valori
dell’istituzione familiare. La famiglia made in Italy ha in genere saputo resistere al richiamo della
concorrenza di modelli alternativi e si avvia ad affrontare il nuovo millennio nel segno di una
tradizione ancorata ad un solido sistema di valori. Ciò che essa sembra chiedere oggigiorno alla
società e alla politica è solo la possibilità di adattarsi al cambiamento e alle nuove problematiche di
un mondo sempre più ricco di trasformazioni, senza per questo snaturarsi o doversi omologare a
modelli che (almeno per ora) non sono propri della vita e della cultura del nostro Paese.
Prospetto 1- Numero medio di figli attesi in corrispondenza di alcuni Paesi europei (a)
Paesi/aree
Anni ‘50
Tra le donne nate negli:
Anni ‘60
Anni ‘70
Italia
2,00
2,10
2,10
Italia N
1,75
1,90
2,00
Italia C
1,85
2,10
2,00
Italia S
2,40
2,30
2,20
Spagna
2,25
2,20
2,20
Svizzera
1,80
2,25
2,20
Austria
1,90
1,95
1,90
Francia
2,35
2,30
2,10
Belgio
2,10
1,90
Olanda
1,97
2,15
2,27
Svezia
2,40
2,50
Norvegia
2,20
2,46
Finlandia
2,15
2,30
Polonia
2,25
1,90
Ungheria
2,05
2,10
2,15
Lettonia
2,15
2,25
2,15
Portogal
2,10
2,15
2,10
(a) Indagini condotte negli anni ’90 su popolazione in età feconda
Anni ‘50
2,00
1,70
2,00
2,35
2,25
2,15
2,00
2,20
2,00
2,02
2,40
2,30
2,10
2,15
1,90
2,15
2,10
Tra gli uomini nati negli:
Anni ‘60
Anni ‘70
2,00
1,95
1,95
2,20
2,10
2,20
1,95
2,30
1,70
2,14
2,30
2,30
2,10
1,75
2,00
2,20
2,10
Fonte: nostre elaborazioni su dati UN/ECE-UNFPA, Fertility and Family Surveys (FFS) in Countries of the ECE Region
2,00
2,00
1,90
2,10
2,10
1,90
1,90
2,10
2,13
2,00
2,10
2,05
La famiglia come soggetto economico
Stefano Zamagni
1. Le “esternalità” positive della famiglia
Un paradosso, tra i tanti, caratterizza la società italiana di questa fase storica. Mentre si va
diffondendo la consapevolezza del ruolo decisivo che la famiglia svolge come soggetto di scelte
economiche, non procede allo stesso ritmo la messa in cantiere di provvedimenti – legislativi e
amministrativi – volti alla attuazione di una vera e propria politica della famiglia in sostituzione
delle ormai obsolete politiche per la famiglia.
Allo scopo di farsi un’idea dell’ampiezza del divario di cui sopra, si consideri che, ancor’oggi,
l’Italia destina alla spesa per maternità e famiglia poco più dell’1% del PIL, la quota più bassa tra
tutti i paesi dell’Unione Europea. Come a dire che la famiglia, in quanto tale, non è un soggetto
destinatario di politiche e dunque di risorse nel nostro modello di welfare.
A fronte di ciò, proviamo a considerare cosa “rende” alla società la famiglia intesa quale soggetto
economico. La proposizione generale che va ribadita e sostenuta con forza è che la famiglia è il
primo produttore di esternalità positive, di quegli effetti positivi cioè che, non essendo internalizzati
dal meccanismo dei prezzi, sfuggono alle usuali rilevazioni statistiche, con il che essi finiscono con
il non esistere (esiste, infatti, solo ciò che è quantificabile e misurabile). Proviamo ad elencare le
principali fattispecie di esternalità positive associate alla famiglia.
Primo, la riproduzione della società. La decisione di mettere al mondo figli è bensì un fatto privato
che, tuttavia, produce conseguenze di grande momento sul piano collettivo – come sanno tutti
coloro che si occupano di transizione demografica e di equilibri economico–finanziari fra le
generazioni. Eppure, la mentalità ancora dominante è tale che mentre i costi della procreazione
vengono addossati alla famiglia, come se la decisione di fare figli fosse assimilabile ad una usuale
scelta di consumo, i benefici di quella decisione vanno a vantaggio di tutta la società.
Secondo, l’integrazione e la redistribuzione dei redditi da lavoro. E’ a tutti nota la capacità della
famiglia di riequilibrare la distribuzione personale del reddito, la quale diventa più egualitaria
quando si passa dalla distribuzione personale a quella familiare. In questo senso, la famiglia si
configura come un potente ammortizzatore sociale, fungendo da punto di smistamento e di raccolta
dei redditi dei propri membri e positivamente influenzando, per questa via, la coesione sociale.
Terzo, la flessibilizzazione della partecipazione lavorativa dei soggetti femminili e dei giovani. Si
tratta di un tema ormai classico e che sarà oggetto di specifica attenzione nella relazione
appositamente dedicata al binomio famiglia e lavoro.
A questi casi, per così dire canonici, di esternalità positive generate dalla famiglia, penso sia
opportuno richiamare l’attenzione su altri tre casi, altrettanto se non più importanti dei precedenti
ma quasi sempre trascurati nel dibattito politico-culturale.
In primo luogo, la famiglia è l’istituzione che più di ogni altra sostiene e tutela i soggetti deboli –
dai bambini in età prescolare agli anziani non autosufficienti; dalla cura dei disabili all’assistenza
dei malati. E’ accertato che se la famiglia italiana non svolgesse quelle funzioni di tipo sia socioassistenziale sia socio-sanitario che da sempre svolge, il nostro paese non potrebbe certo occupare –
date le caratteristiche strutturali dei suoi servizi pubblici – il posto (secondo) nella graduatoria
mondiale che l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli riserva per quanto attiene gli indici di
morbilità e di mortalità. Eppure, su 100 lire di reddito redistribuito (trasferimenti) solo 21 lire vanno
in Italia a famiglie nei tre decili più poveri (negli USA, queste cifre sono, rispettivamente, 100$ e
37$).
Secondariamente, la famiglia è il luogo ideal–tipico della creazione di capitale umano degli
individui. E’ noto che il capitale umano non dipende solamente dall’investimento in istruzione e
formazione da parte degli individui (o da chi per loro) e dall’ambiente sociale, ma anche e, in certi
contesti, soprattutto dall’ambiente familiare. Le interazioni tra soggetti, per il tramite di effetti di
spillover, consentono la trasmissione reciproca di conoscenze e questo accresce, di per sé, lo stock
di capitale umano. Ebbene, la famiglia è il luogo in cui le interazioni sono più intense e meno
soggette a fenomeni di tipo opportunistico: al suo interno avvengono trasferimenti sistematici di
conoscenze tra i componenti, trasferimenti favoriti dalla stretta vicinanza e dai legami parentali.
Ecco perché, là dove la famiglia tiene e fiorisce, è più elevato, coeteris paribus, lo stock effettivo di
abilità acquisite da un individuo e quindi è più alta la produttività media del sistema.
Infine, la famiglia funge da filtro tra individuo e mercato per quanto concerne le scelte di consumo.
E’ risaputo che queste ultime non sono quasi mai il frutto di processi decisionali di tipo atomistico,
ma risentono piuttosto dell’insieme di valori, delle prassi e degli stili di vita che il singolo trae dalla
famiglia di cui è parte. Ad esempio, l’edizione 2000 dell’Osservatorio Findomestic mostra, a tutto
tondo, come ancor’oggi resti prevalente in Italia il ruolo della famiglia nella programmazione degli
acquisti. Quanto a dire che è la famiglia il consumatore tipico. Quale la rilevanza pratica di tale
constatazione? Quella di suggerire che se si vogliono modificare o trasformare gli attuali modelli di
consumo – vuoi per ragioni di sostenibilità ambientale vuoi per considerazioni di natura etica – a
poco valgono le costose campagne di educazione del consumatore – individuo, campagne che
troppo spesso acquistano il vago sapore del moralismo. Molto meglio agire sulla famiglia mediante
l’implementazione di strategie di empowerment della stessa.
2. Da una politica per la famiglia a una politica della famiglia
Se le cose stanno nei termini sopra descritti, l’obiettivo da perseguire non può essere quello di
reclamare maggiori risorse per la famiglia. Non è più credibile un’azione politica che si limiti ad
assicurare più elevati assegni familiari, un numero maggiore di posti negli asili nido e cosi via. Si
tratta piuttosto di passare da una politica per la famiglia fondata su una logica di tipo risarcitorio – e
quindi, tanto o poco, paternalistica – ad una politica della famiglia il cui principio regolativo ha da
essere quello del welfare abilitante, un welfare cioè che ponga la famiglia nelle condizioni di
sviluppare il proprio potenziale di crescita.
Quali proposte il Forum delle Associazioni Famigliari è in grado di avanzare e di sostenere con la
necessaria fermezza a quelle autorità dalle quali ci si attende un mutamento dell’attuale assetto
istituzionale? Prescindendo dalle proposte in materia sia giuslavoristica sia fiscali – in merito alle
quali altri dirà – sono dell’avviso che si possa operare in tre ambiti specifici di intervento.
Il primo concerne il credito al consumo. La famiglia in quanto tale non è considerata, in Italia, un
soggetto bancabile. Di qui le forme di razionamento del credito cui essa va soggetta (molto spesso
implicitamente) e quindi la diffusione, soprattutto in certe aree del paese, di pratiche endemiche di
usura. Occorre allora intervenire sul sistema bancario perché vengano aperte linee di credito
specificamente rivolte alla famiglia – un po’ come già avviene in Paesi civilmente più avanzati del
nostro.
Un secondo ambito di intervento è quello che concerne la messa in opera di forme innovative di
sanità integrativa che vedano la famiglia come soggetto, ad un tempo, di domanda e di offerta di
certe tipologie di prestazioni. Si pensi alla cosiddetta ospedalizzazione domiciliare; alle terapie
riabilitative per i malati psichiatrici (in numero spaventosamente crescente); alle varie pratiche
socio-sanitarie.
Infine, una terza linea di azione è quella che vede la creazione di “fondazioni di comunità”
(Community Foundations) centrate sulle associazioni familiari. Come si sa, si tratta di uno
strumento operativo che solo da poco è stato preso in considerazione nel nostro Paese. Al momento,
unicamente la Fondazione Cariplo ha dato vita, in Lombardia, ad alcune fondazioni di comunità
che, tuttavia, non hanno come baricentro la rete delle famiglie presenti sul territorio. La
realizzazione di un modello familiare di “fondazione di comunità” servirebbe ad avviare a
soluzione, ad esempio, il problema di una scuola libera e partecipata, e, più in generale, quello di
dare ali al principio di sussidiarietà (in senso orizzontale).
Famiglia e lavoro: una difficile conciliazione
Lorenzo Caselli
1. La valenza antropologica del lavoro
L’esperienza lavorativa ha una profondità antropologica di grande rilevanza; attraverso il lavoro
infatti la persona non entra semplicemente in contatto con la realtà sociale esterna, assumendo ruoli,
compiti e funzioni socialmente visibili, riconoscibili (e riconosciuti fino al punto da essere
retribuiti), ma costruisce la propria identità di persona, impastandosi con la realtà, mettendosi in
gioco, cambiandola e facendosi cambiare da essa; non esiste un lavoro “esterno” al soggetto, per
quanto ripetitivo, alienato e “senza significato” possa esso sembrare, ma sempre, in ogni attività, è
l’umanità di ogni persona che entra in gioco.
Questa ineliminabile valenza antropologica del lavoro chiama direttamente in causa la famiglia,
sfera dell’esistenza indubbiamente decisiva per l’identità della persona; ma proprio nell’interazione
tra lavoro e famiglia, nella vita di ogni persona, si sperimenta la difficoltà di contemperare ambiti
così diversi, governati da regole, valori e norme spesso in aperta contrapposizione, anche se tale
contrapposizione non è “iscritta nelle ferree leggi della natura”.
Gli intrecci tra lavoro e famiglia sono innumerevoli, e rimandano a numerosi e differenziati aspetti
dell’esperienza lavorativa e familiare: dall’uso del tempo al tema del reddito, dalle modalità
organizzative del lavoro alla cura dei figli, dalle differenze di genere sul posto di lavoro alle
modalità di suddivisione degli impegni familiari tra marito e moglie, dai rapporti tra le generazioni
in ambito familiare fino al nodo sociale del futuro del sistema pensionistico nel suo complesso.
Come si vede anche da questa semplice ed incompleta lista, problemi diversi per origine, luogo e
dinamiche, che esigono risposte molto puntuali e differenziate.
2. Il posto della donna
In questo contesto, si intende ora affrontare il tema delle differenze di genere in ambito lavorativo, e
in particolare i cambiamenti attivati e richiesti dalla crescente - e ormai irreversibile partecipazione femminile al mercato del lavoro. Chiediamoci: qual è, quale può essere il posto della
donna nella società del lavoro, di un lavoro che deve potersi inscrivere in un sostanziale quadro di
libertà?
Allo stato attuale la donna paga il prezzo di squilibri e contraddizioni insiti nell’organizzazione
sociale e produttiva. Paga altresì il prezzo di visioni semplificate, di banalizzazioni ricorrenti, di
acritici stereotipi. Se la famiglia funziona male è perché la donna è impegnata nel lavoro
extradomestico, se la donna sul posto di lavoro non “rende” come si vorrebbe è perché pensa alla
famiglia. La conclusione implicita o esplicita a siffatto modo di argomentare è inequivoca: è bene
che la donna ritorni a casa.
Ma la donna a casa non intende ritornare. La sua crescente partecipazione all’attività lavorativa
extra-domestica è un dato di fatto sia a livello effettivo che di aspirazione e l’aspirazione si collega
a un mix di motivazioni che vanno dalla necessità contingente, alla ricerca dell’indipendenza
economica di fronte al futuro, alle esigenze di socializzazione e di piena realizzazione di sé.
Ma in quale modello di lavoro le donne vanno ad inserirsi? In molti casi esso è quello di un lavoro
ritenuto dall’azienda costoso e rischioso (la maternità “interrompe” la produzione; a livello di
stereotipo la donna è ritenuta meno affidabile dell’uomo) e per il quale è necessario chiedere
sostegni, agevolazioni, indennizzi. Conseguentemente le donne vengono concentrate su posizioni
lavorative marginali, di non elevata qualificazione, sottoposte ad una flessibilizzazione verso il
basso, con scarse possibilità di carriera. In questo modello di lavoro le donne hanno maggiori
difficoltà di entrata rispetto agli uomini (i tassi di disoccupazione sono più che doppi) e, per
converso, maggiori probabilità di uscita in conseguenza di ristrutturazioni e ridimensionamenti
aziendali.
A livello di cultura organizzativa e gestionale corrente, le donne devono poi fare i conti con contesti
scarsamente attenti al problema dei rapporti tra tempi di lavoro e tempi di vita, alla valorizzazione
delle loro capacità professionali, allo sviluppo delle carriere, ecc. L’ottica ancora dominante è di
tipo industrialista-fordista (anche quando non ce ne sarebbe bisogno), poggiante — più o meno
esplicitamente — su presupposti assunti e conservati in maniera acritica: la sfera della produzione è
dell’uomo; quella personale delle donne; la divisione tecnica del lavoro non può fare a meno della
segregazione sessuale; tra economia da un lato e sentimenti e valori dall’altro non può che esserci
una soluzione di continuità.
L’evidenza empirica ci dice che il modello di lavoro femminile qui sommariamente tratteggiato, è
ancora largamente radicato nella realtà del nostro Paese. Purtuttavia non va sottovalutato l’emergere
di segnali nuovi, di opportunità che si aprono nel quadro di cambiamenti capaci di coinvolgere nel
contempo la donna e l’uomo, la vita delle famiglie e l’organizzazione sociale. Si pensi ad esempio
agli elevati livelli di scolarizzazione raggiunti dalle giovani donne, all’aumento considerevole del
numero delle donne che occupano posizioni di responsabilità nella vita professionale e civile, allo
sviluppo dei processi di terziarizzazione e dei servizi legati alla persona, ecc.
3. Un nuovo patto di solidarietà
Ci sembra quindi di poter dire che dall’esperienza faticosa e sofferta delle donne, nel nostro Paese,
deriva un messaggio fondamentale che va colto in tutta la sua portata. Intendiamo riferirci alla
volontà di conciliare il ruolo di moglie e di madre con la valorizzazione piena dei propri talenti nel
più ampio contesto del lavoro extradomestico (che non è soltanto quello per il mercato). Tutto ciò è
segnaletico di una grande possibilità: quella di riavvicinare il lavoro e la casa, l’attività
professionale e l’attenzione al bisogno dell’altro, le dimensioni strumentali e quelle espressivocomunitarie.
Con altre parole attraverso l’esperienza e la cultura della donna è possibile una reinterpretazione del
lavoro in rapporto alla famiglia e alla società. Ci si rende conto che tematiche e valori ritenuti
“femminili” diventano strategici per tutti. Il mondo del lavoro richiede umanizzazione, ricomposizione di aspetti e dimensioni per lungo tempo separati, attenzione alle attese della gente e
dell’ambiente, sintonia con i valori della vita privata e sociale.
Emerge dunque la possibilità di un nuovo patto di solidarietà tra i sessi nella famiglia, nel lavoro,
nella società. Solo se si entra all’interno di questa logica è possibile valorizzare le specificità
maschili e femminili sullo stesso terreno culturale, sociale, economico dando a ciascun soggetto
l’opportunità di esprimersi al meglio, di scambiare cose diverse, di apprendere l’uno dall’altro
secondo una prospettiva di complementarietà e reciprocità.
Lavoro/casa, mercato/casa, privato/pubblico/sociale, aspetti micro/aspetti macro si rivelano sempre
meno alternative secche. Siamo piuttosto in presenza di processi che richiedono di essere letti,
interpretati e gestiti in un’ottica di interdipendenza. L’interdipendenza è una categoria morale che
va vissuta come il sistema determinante delle odierne relazioni economiche, sociali, culturali,
politiche e tradotta in vincoli di solidarietà. La solidarietà (tra pubblico e privato, mercato e cura,
lavoro e casa, ecc.) trasforma i giochi da “somma zero” a “somma positiva”; ai tiri alla fune si
sostituisce l’intrapresa della cooperazione.
Solo in un contesto di interdipendenza la famiglia può esprimere il proprio potenziale. Un
potenziale fatto di relazionalità (interna ed esterna), progettualità, partecipazione, capace di
innescare - nella saldatura tra responsabilità individuali e collettive - comportamenti più ricchi in
umanità. La Centesimus Annus parla a questo proposito di “soggettività della società” così come si
esprime in quel reticolo di solidarietà che lega famiglia e comunità intermedie innervando l’intero
tessuto sociale. Diventa pertanto preminente creare le condizioni affinché questa soggettività possa
pienamente esplicarsi nel vivere civile, nel lavoro, nel consumo, sul mercato stesso, fornendo ad
esso quelle coordinate morali e culturali di cui la mera logica economica (e politica) si rivela
totalmente incapace.
La negazione della famiglia come soggetto: l’iniquità del trattamento fiscale
Marco Martini
1. Prelievo fiscale e prestazioni alla famiglia: una anomalia italiana
Il sistema fiscale italiano da un lato, in coerenza con il dettato costituzionale, assume in linea di
principio che i costi per il mantenimento dei figli a carico devono essere riconosciuti; dall'altro, nel
fissare la misura delle detrazioni, sembra voler disincentivare le famiglie a generarli e a farsi carico
del loro mantenimento. Il riconoscimento dell’impegno economico costituito dalla presenza di
familiari a carico, che avviene in modo sensibile soltanto per i redditi più bassi con lo strumento
degli assegni al nucleo, è confinato in un’ottica di intervento assistenziale. Quasi completamente
trascurata è l’esigenza di equità orizzontale, nonostante la Carta Costituzionale sottolinei la
rilevanza sociale ed economica delle funzioni della famiglia. A differenza di quanto avviene nella
totalità dei Paesi europei, in Italia sistema fiscale sembra ritenere che la capacità contributiva delle
famiglie sia influenzata in misura irrilevante dalla presenza di figli a carico e dall’eventuale scelta
di uno dei coniugi di dedicare tempo a curare, mantenere ed educare i figli. Il costo del
mantenimento e della cura dei minori e degli adulti inoccupati è praticamente considerato alla
stregua di una mera “donazione” privata.
La pressione fiscale indiretta, che grava ultimamente sui consumatori finali, percuote tali costi nella
stessa proporzione di quelli per i consumi voluttuari: perciò il reddito è assoggettato alle imposte
indirette in proporzione (circa il 10%) delle spese per consumi, ivi compresi quelli necessari per il
mantenimento (obbligatorio) delle persone a carico, indipendentemente dai livelli di reddito.
Per quanto riguarda la imposizione diretta (IRPEF), mentre in tutti i Paesi europei, a parità di
reddito, la differenza tra l’imposta gravante su chi non ha figli e chi ha figli a carico è consistente,
in Italia è irrisoria. Ad esempio, la differenza di imposta diretta su un reddito di 60 milioni tra una
famiglia con due figli e un singolo o una coppia che dispone dello stesso reddito, ma non ha figli a
carico, è di meno di un milione in Italia, mentre è di circa 7 milioni Francia e di circa 12 milioni in
Germania..
D’altra parte, in Italia mentre la pressione fiscale ha subito il massimo incremento (circa 10% in
dieci anni contro la sostanziale stabilità negli altri Paesi) mentre le prestazioni sociali alle famiglie
(assegni familiari, indennità di maternità) sono drasticamente diminuite: tanto che la percentuale
delle prestazioni alle famiglie sul PIL nel nostro Paese è di gran lunga la più bassa in Europa (0,4%
contro il 3-4% degli altri). L’istituto degli assegni familiari si è trasformato in una misura
assistenziale a sostegno dei soli lavoratori dipendenti “poveri”.
Nell’ipotesi formulata da recenti studi econometrici che il costo minimo di mantenimento di un
minore o di un giovane inoccupato sia pari a circa 15 milioni annui, in una famiglia con un reddito
di 45 milioni la nascita di un figlio riduce di fatto del 30% il reddito disponibile per altri impieghi.
Lo Stato riconosce, come detrazione dall’imposta diretta, meno di 500mila lire, che non sono
neppure sufficienti a compensare le maggiori imposte indirette, che a parità degli altri consumi, la
famiglia paga sulle spese per il mantenimento del figlio (circa un milione e mezzo, cioè il dieci per
cento delle spese per il figlio).
L’iniquità di questa situazione è evidente: al trasferimento di reddito verso i minori e gli inoccupati
contribuisce esclusivamente chi li ha in carico, subendo altresì la maggior pressione delle imposte
indirette.
2. Gli strumenti per realizzare l’equità orizzontale del trattamento fiscale
La differenza di pressione fiscale, a parità di reddito spendibile per componente (tenore di vita),
oltre che un fattore di forte squilibrio nel sistema di riproduzione sociale, costituisce una
macroscopica violazione dello spirito e della lettera della Costituzione Repubblicana che, dopo aver
riconosciuto «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art.29), fissa il
«dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli» (art.30), dichiara che la
«Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglie
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose» (art.31) e
stabilisce che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva» e che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività» (art.53).
Il criterio di progressività in ragione della capacità contributiva, per essere effettivamente rispettato,
deve osservare sia il principio di equità verticale che quello di equità orizzontale. Il primo richiede
che, dati due livelli di capacità contributiva y1 maggiore di y 2 , l’imposta che grava su y1 debba
essere superiore a quella cui è sottoposto y 2 . Il principio di equità orizzontale richiede che, dato uno
stesso livello di reddito nominale di due diversi soggetti A e B, se gli oneri obbligatori che gravano
sul primo sono tali da ridurne la capacità contributiva rispetto al secondo, allora A deve pagare
un’imposta inferiore a quella di B.
Gli strumenti con cui si realizza la progressività sono due, diversamente combinati tra loro:
a) la deduzione dal reddito nominale di una parte non imponibile necessaria per la sopravvivenza
uguale per tutti i contribuenti che quindi favorisce i redditi più bassi;
b) la fissazione di aliquote crescenti per fasce di reddito.
Oggi la tendenza generale nei Paesi sviluppati è quella di privilegiare il primo strumento sul
secondo, fissando un significativo importo per la deduzione e riducendo il numero delle aliquote.
Gli strumenti con cui si può tenere conto dei carichi di famiglia nel determinare la capacità
contributiva sono: il quoziente familiare (o splitting), la detrazione e la deduzione. In uno stesso
sistema fiscale possono coesistere più metodi.
Con lo strumento del quoziente la somma dei redditi dei componenti della famiglia viene suddiviso
in due o più quote corrispondenti al numero di componenti (percettori o no di reddito) e non
necessariamente uguali fra di loro. A ciascuna quota si applica l’aliquota prevista per lo scaglione a
cui essa appartiene: la tassa totale dovuta dalla famiglia è data dalla somma delle imposte calcolate
per ciascuna quota. Il metodo del quoziente funziona solo in presenza di un sistema di più aliquote e
risulta tanto più efficace quanto maggiore è il loro numero: in presenza di una sola aliquota esso
non produrrebbe nessun effetto. Esso riconosce implicitamente costi con il reddito.
La detrazione, strumento tradizionalmente adottato dal sistema italiano, prevede che il calcolo
dell’imposta non tenga conto dei carichi di famiglia: dalla tassa lorda poi si detraggono
successivamente gli importi previsti per i familiari a carico. In un sistema ad aliquote crescenti, se la
detrazione non varia con il reddito, questo strumento assume implicitamente che i costi per i carichi
di famiglia diminuiscano al crescere del reddito. Naturalmente se, come avviene in Italia per il
coniuge a carico, le detrazioni addirittura diminuiscono con il reddito, si ipotizza che i costi
decrescano con velocità crescente!
Con la deduzione, l’importo per i carichi di famiglia è stabilito sulla base del numero dei
componenti e tenendo conto delle economie di scala, e dedotto dal reddito prima dell’applicazione
dell’aliquota dello scaglione: se le deduzioni sono fisse, l’assunzione implicita è che i costi siano
indipendenti dal reddito.
3. Le misure macroeconomiche dell’iniquità orizzontale
Numerosi studi hanno contribuito a misurare l’entità dell’iniquità orizzontale. Essi si fondano sulla
stima del reddito minimo di sopravvivenza, sull’adozione di opportune scale di equivalenza e sul
calcolo delle entrate totali del fisco secondo l’imposta attuale, al netto delle prestazioni in assegni
familiari e quelle corrispondenti al criterio di equità orizzontale attuato con il metodo della
deduzione, della detrazione o del quoziente. Le stime più prudenziali, fatte sulla base di un reddito
minimo dell’ordine di quello oggi riconosciuto come deducibile indicano in una cifra compresa tra i
10 e i 20 mila miliardi la somma necessaria per attuare il riequilibrio senza aumentare il carico
attuale dei contribuenti senza figli a carico. La somma è perfettamente compatibile con lo stato
attuale dei conti pubblici: l'obiezione di chi si dichiara d’accordo con il principio dell'equità
orizzontale a favore delle famiglie con figli, ma non la ritiene applicabile per motivi contabili è
priva di fondamento.
4. La negazione ideologica della famiglia come soggetto economico
E’ obiettivamente difficile riuscire a capire quali sono le cause di un trattamento fiscale così
sfavorevole ai carichi di famiglia in Italia. Se esiste una filosofia che ispira la legislazione italiana,
questa sembra essere chiara: la presenza di figli a carico di regola continua a non comportare una
diminuzione di capacità contributiva che non sia soltanto simbolica. Per la normativa fiscale è
pertanto praticamente irrilevante che una famiglia decida di allevare, istruire ed educare un figlio o
che scelga piuttosto di acquistare uno yacht o di fare una crociera attorno al mondo.
Il riconoscimento dell’impegno economico costituito dalla presenza di familiari a carico, che
avviene in modo sensibile soltanto per i redditi più bassi con lo strumento degli assegni al nucleo, è
confinato in un’ottica di intervento assistenziale ed è quasi completamente trascurata l’esigenza di
equità orizzontale.
A sostegno del disinteresse per l’equità orizzontale si invoca da parte di alcuni un’ideologia
assolutamente individualistica, che nega qualsiasi soggettività economica alla famiglia e qualsiasi
rilievo pubblico alla funzione di mantenimento e cura dei figli. Si afferma ad esempio che le scelte
riproduttive, appartenendo alla sfera delle decisioni private della persona, non devono essere
orientate dallo Stato: così si confonde la libertà di scelta prima della nascita o dell’adozione con
l’obbligo di mantenimento ad esse conseguenti. Altri, nello stesso solco ideologico, affermano che
chi decide di fare figli lo fa per realizzazione personale e che pertanto questa gioia, bastando essa a
se stessa, non deve avere riconoscimento fiscale. Sarebbero ammessi solo interventi a vantaggio
delle sole famiglie povere. Queste posizioni, contraddittorie con i principi costituzionali e con il
diffuso criterio di stabilire l’importo delle prestazioni sociali con riferimento al reddito e al numero
di componenti della famiglia, sono oggi curiosamente sostenute da una parte dei paladini che
contrappongono lo stato sociale al liberismo ma che, nello stesso tempo, adottano l’ideologia
riduttiva che identifica la famiglia come l’area privata degli affetti, negando ad essa qualsiasi
soggettività sociale e ai suoi figli qualsiasi rilevanza pubblica.
In proposito, una recente sentenza della Corte Costituzionale Tedesca afferma che i figli sono un
bene di tutti. L’Italia sta vivendo infatti una crisi demografica gravissima: numerose ricerche
sostengono che il debito pubblico italiano non sia sostenibile proprio a causa della proporzione
sempre più esigua di popolazione in età lavorativa, prevista nell’immediato futuro in conseguenza
della presente denatalità. In questa situazione è difficile sostenere che chi fa figli lo faccia soltanto
per sé. Difficile è infine sostenere che la normativa fiscale attualmente in vigore sia neutra e non
piuttosto disincentivante verso la procreazione di nuovi cittadini.
Il Governo e il Parlamento della Repubblica devono avere il coraggio di ridistribuire il carico
fiscale fra i contribuenti, tenendo conto delle ragioni dell’equità orizzontale che sono poi quelle che
permettono una vera equità verticale. Pur con la gradualità che è necessaria per realizzare un
intervento efficace, deve essere chiaro che ogni ulteriore rinvio a futuri e improbabili momenti di
«vacche più grasse» è pretestuoso, iniquo e dannoso in termini di politica del debito pubblico.
L’ipocrita prosecuzione di un trattamento riconosciuto come ingiusto troverebbe come unica
giustificazione il fatto che essendo la famiglia una componente debole le esigenze di giustizia che la
riguardano sono sacrificate per soddisfare l’interessi delle componenti più forti. In questo caso la
soggettività della famiglia viene negata di fatto dalle ragioni della forza: «Poiché è sempre difficile
rendere forte il giusto, si è fatto in modo che il forte diventasse giusto» (Pascal).
Famiglia e diritto
Giuseppe Dalla Torre
1. Un paradosso
L'esperienza della famiglia italiana sembra esprimere un paradosso. Da un lato, infatti, l'analisi
sociologica tende a dire che, sostanzialmente, essa ha saputo resistere all'impatto della modernità,
rimanendo in buona parte tuttora ancorata ad un solido sistema di valori, che sono poi i valori
tradizionali; dall'altro lato però il diritto, inteso sia come legislazione sia come "diritto vivente"
nell'interpretazione (specie quella giurisprudenziale), non pare avere (adeguatamente) aiutato la
famiglia a vivere ed a perseguire le finalità sue proprie.
In altre parole sembra di poter dire che se in Italia la famiglia ha in buona parte retto e se la sua crisi
è, nonostante tutto, abbastanza marginale nel sistema sociale, ciò non è dovuto certo al diritto
positivo, ma semmai ad altri apparati normativi (il costume, i valori etici, le norme religiose ecc.)
che l'hanno ampiamente sostenuta in situazioni oggettivamente avverse. Per certi aspetti le stesse
rivoluzioni avvenute nel mondo economico e del lavoro, che pure sono all'origine di situazioni di
sofferenza dell'istituto familiare, hanno per altri versi concorso ad un certo recupero di modelli e
valori tipicamente familiari (si pensi al ruolo dei nonni e, più in generale, di componenti della
"grande famiglia", nella vita della famiglia nucleare).
Questa osservazione preliminare consente di dire che, con un ordinamento giuridico più favorevole,
molto probabilmente l'area della crisi dell'istituto - che pure c'è - potrebbe essere ristretta;
soprattutto potrebbero acquisirsi notevoli benefici, per i singoli e per la comunità generale, a seguito
di un miglioramento delle condizioni giuridiche in cui la famiglia è chiamata a vivere e ad operare.
2. Un modello inattuato
La storia dimostra in maniera eloquente che, da due secoli a questa parte, gli interventi del
legislatore in materia familiare sembrano essere alternativamente incentrati o sulle ragioni
dell'individuo, ovvero su quelle dello Stato. In un caso l'ordinamento giuridico tutela gli interessi
personali; nel secondo caso quelli della collettività generale (peraltro così come individuati dal
politico e dal legislatore).
In altre parole da due secoli la famiglia sembra scomparire progressivamente come soggetto
portatore di interessi distinti da quelli dei suoi componenti, ancorché solidali con questi, e
meritevoli di considerazione e di tutela.
Soprattutto nell'ultimo cinquantennio, la legislazione sembra più rispondere alle esigenze di una
politica per individui facenti parte del gruppo familiare, specie nei casi di crisi per motivi relazionali
(si pensi alle patologie del rapporto coniugale), o per condizioni personali (si pensi ai portatori di
handicap, ai malati, agli anziani), che non alle logiche di una politica per la famiglia, volta a
promuovere, con gli interessi del gruppo familiare, la persona dei suoi singoli componenti. Laddove
interventi vi sono stati a favore della famiglia, questi sono stati concepiti piuttosto come forme di
sostituzione dell'istituzione pubblica in definite funzioni familiari, che non come interventi diretti a
precostituire le condizioni (giuridiche, economiche, sociali ecc.) grazie alle quali la famiglia può
essere in grado di provvedere autonomamente al perseguimento delle finalità sue proprie.
A fronte di siffatta fenomenologia è il modello di famiglia sotteso alle disposizioni costituzionali
(artt. 29-31) che appare chiaramente terzo rispetto ai due, opposti, che hanno caratterizzato gli
ultimi due secoli. Per la concezione costituzionale la natura propria della famiglia è di essere, nella
sua originarietà ed autonomia rispetto a qualsiasi altra formazione sociale (e rispetto allo stesso
Stato), strumento di mediazione e di collegamento fra individuo e collettività più ampia, nel quadro
di una coesistenzialità nella quale si esplicita la personalità di ciascuno dei suoi componenti. Il favor
familiae che si desume dall'ordinamento costituzionale, esprime un principio per il quale nella
famiglia viene individuata la struttura relazionale umana fondamentale.
Nel modello costituzionale, tra l'altro, è chiaramente e correttamente posto il principio di
sussidiarietà, nel senso di configurare un dovere dello Stato di creare le condizioni che permettano
alla famiglia di perseguire le proprie finalità e di prevedere un suo intervento sostitutivo della
famiglia solo nei casi di incapacità di quest'ultima a provvedere a se stessa.
Il modello costituzionale peraltro non ha trovato attuazione nella legislazione ordinaria o,
quantomeno, ha trovato un'attuazione debole e parziale.
3. La famiglia nel diritto privato
Le grandi riforme del diritto di famiglia, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si sono
compiute sostanzialmente in poco più di un decennio, tra il 1970 ed i primissimi anni '80. Divorzio,
riforma del diritto di famiglia, interruzione volontaria della gravidanza (per la parte in cui può
toccare il diritto privato), riforma della disciplina dell'adozione, sono i momenti essenziali di un
moto riformatore nell'insieme dominato da un modello individualistico, in cui gli interessi del
gruppo familiare e dei singoli suoi componenti sono piegati alle volizioni - non di rado arroganti o
addirittura irrazionali - dell'individuo.
La riforma del diritto di famiglia del 1975, in particolare, nonostante l'intento di armonizzare le
disposizioni del Codice Civile con i principi costituzionali in materia di famiglia, e nonostante il
raggiungimento dell'obbiettivo in alcuni ambiti della rinnovata disciplina, tuttavia rimane nel
complesso succube di una cultura individualistica. Una cultura che guarda sostanzialmente a
matrimonio e famiglia come fonti di utilità personali, da salvaguardarsi in concreto fin tanto che
continuino ad essere tali. Questa cultura appare, poi, evidentissima in leggi come quella sul divorzio
(1970) e sull'interruzione volontaria della gravidanza (1978).
Di segno assai diverso la legge sull'adozione speciale o adozione legittimante, tutta impregnata di
spirito solidaristico e strutturata secondo un sano principio di sussidiarietà, il cui fulcro è l'idea della
centralità della famiglia fondata sul matrimonio come luogo ideale per la crescita del minore in
stato di abbandono.
4. La famiglia nel diritto pubblico
Non si può parlare di famiglia e diritto senza tenere adeguatamente presenti anche i vari settori del
diritto pubblico, dove sono organizzate le garanzie pubbliche della famiglia; settori che appaiono
sempre più numerosi, dove sempre più ricca ed articolata è la normazione che, direttamente o
indirettamente, investe la famiglia. Le ragioni dell'ampliamento della sfera del diritto pubblico
anche sul terreno propriamente familiare sono molte. In particolare si deve ricordare l'espansione
del modello di Stato sociale che ha caratterizzato buona parte del Novecento. Ma si deve ricordare
anche una cultura post-sessantottina, per la quale la famiglia avrebbe dovuto essere liberata da tutte
le sue funzioni solidaristiche e socio-educative, tradizionalmente da essa svolte ma ritenute non sue
proprie, per essere ridotta alla sua essenza radicale di "luogo degli affetti".
I settori del diritto pubblico che incidono sulla famiglia sono vari: i servizi formativi e scolastici, i
servizi sociali, i servizi sanitari, gli stessi servizi anagrafici e di stato civile; ma si pensi anche al
settore tributario o a quello, delicatissimo, della tutela giurisdizionale.
C'è da dire che nonostante alcuni, peraltro limitati ed isolati, tentativi di sondare il trattamento
giuridico della famiglia nel diritto pubblico, il quadro generale risulta ancora ampiamente lacunoso.
Si vuol dire in altre parole che non è dato conoscere se dalla pluralità di interventi e microinterventi che, nell'ambito del diritto pubblico, toccano direttamente o indirettamente la famiglia,
questa esca in definitiva sostanzialmente rafforzata ovvero più o meno gravemente indebolita.
In altre parole allo stato dell'arte non è dato di individuare se e quale specifica rilevanza giuridica
venga riconosciuta alla famiglia, come formazione sociale unitariamente considerata, nel diritto
pubblico; se ed in quale misura il modello di famiglia desumibile dalla pluralità di dati normativi
che integrano il diritto pubblico sia conforme, o meno, con quello sotteso al diritto privato, nonché
il grado di compatibilità fra i due sistemi giuridici; quale sia comunque la sua conformità al modello
costituzionale.
L'impressione peraltro è che il sistema pubblico, se non favorisce la famiglia (ad esempio sul
terreno fiscale), propende per interventi individuali che prescindono dall'inserimento dell'utente nel
contesto familiare (ad esempio nei servizi socio-sanitari). A ciò si aggiungano gli ampi "vuoti
normativi" in ambiti di indubbia rilevanza per la famiglia, relativamente a trattamenti sanitari (come
nel caso della procreazione assistita).
5. La famiglia nel "diritto vivente"
E' ben noto il fenomeno dello scarto, più o meno ampio, che nell'esperienza giuridica si verifica tra
il diritto scritto ed il diritto "vivente", cioè il diritto positivo così come interpretato ed attuato nella
prassi amministrativa e nella giurisprudenza. Si tratta di un fenomeno che tocca tutti gli ambiti
materiali e relazionali, ma che pare incidere particolarmente anche su quelli relativi al matrimonio
ed alla famiglia.
Al riguardo basti pensare alle banalizzazioni che, nel concreto della vita giuridica, caratterizzano
l'applicazione di leggi come quella sul divorzio e sull'aborto, rispetto alla casistica che il legislatore
ha indicato, nell'un caso come nell'altro, per legittimare i relativi interventi. Ma si pensi anche alla
progressiva erosione da parte della giurisprudenza, ed in particolare della giurisprudenza
costituzionale, del pur chiaro quadro di principi che originariamente caratterizzava l'adozione
legittimante, diretta a dare una famiglia al minore abbandonato e non più a dare un figlio a chi non
aveva progenie.
Nell'ambito del diritto pubblico, si pensi ad esempio al vuoto ritualismo in cui sono rapidamente
caduti quegli organi collegiali della scuola, che erano stati pensati dal legislatore anche come luoghi
di partecipazione delle famiglie all'opera formativa ed educativa dell'istituzione scolastica; in un
settore, cioè, in cui le responsabilità primarie sono proprio della famiglia.
6. Prospettive e proposte
Da un punto di vista giuridico, le vie per una piena attuazione delle responsabilità familiari
sembrano passare innanzitutto per un ritorno alla Costituzione che, come s'è rilevato, è rimasta in
parte un progetto non realizzato. E ciò, sia con riferimento alla famiglia in quanto tale, sia più in
generale con riferimento al principio di sussidiarietà.
Si deve precisare che il richiamo alla Costituzione non ha carattere retorico o formalistico, se è
vero, come è vero, che nelle moderne democrazie pluralistiche le Costituzioni costituiscono il
"credo umano comune", il minimo etico condiviso, che permette di vivere insieme e di essere
solidali nonostante le differenti opzioni ideologiche, politiche, etiche, religiose ecc.
Vi è poi la necessità di una legislazione, di una prassi amministrativa e giurisprudenziale, che siano
concordemente più attente alla famiglia in quanto formazione sociale. Ma per raggiungere siffatto
obbiettivo è necessario preliminarmente ricostituire un'effettiva autonomia della famiglia e farne,
attraverso mezzi e modi adeguati, un soggetto politico. Da tempo si è segnalata l'esigenza di
progettare forme di partecipazione della famiglia ai processi di decisione politica, che liberino
dall'idea che l'istituzione familiare sia un "oggetto" da regolamentare ed a favore del quale operare
da parte dei soggetti pubblici, facendo invece della famiglia un soggetto capace di intervenire
efficacemente nelle determinazioni pubbliche che possono incidere sulla sua sfera di operatività.
La famiglia al centro del sistema formativo?
Luisa Ribolzi
1. Il nodo cruciale del rapporto famiglia/scuola
Se si accetta la considerazione che in genere il funzionamento dell’organizzazione scolastica deriva
dall’interazione fra Stato, struttura interna (i “professionisti”) e utenti (mercato del lavoro, comunità
locale, studenti e famiglie), bisogna partire dalla considerazione che nel nostro Paese il monopolio
statale ha ridotto il dialogo a due soli interlocutori, la scuola e lo Stato, e la marginalizzazione della
famiglia è una costante che ha trovato qualche eccezione solo nelle scuole private: nella scuola
statale, tranne eccezioni, essi sono stati, o sono stati costretti ad essere, un interlocutore assente.
Il diritto primario dei genitori all’educazione dei figli non è sancito solo dalla Chiesa, ma è
patrimonio e cultura universale: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo afferma che «I
genitori hanno diritto preferenziale a scegliere il tipo di educazione che dovranno ricevere i loro
figli» (art.3). Anche la Costituzione Italiana (art. 30, comma 1) riconosce questo diritto originario ai
genitori, ma al di là delle affermazioni di principio l’esercizio di questo diritto può essere favorito
(o limitato) da un lato dal tipo di rapporto che esiste nei diversi Paesi fra scuola e famiglia, e
dall’altro dai modelli di finanziamento del sistema scolastico. La definizione del rapporto tra scuola
e famiglia continua a rappresentare un nodo cruciale per le moderne società democratiche, in cui «la
polarizzazione delle opinioni riflette una divisione dei valori profondi, che coinvolgono le
convinzioni su quale sia la giusta divisione di competenze fra lo Stato e le famiglie, sui pericoli che
deriverebbero alla coesione sociale da dottrine devianti, sulle rispettive capacità dei clienti e dei
professionisti di decidere che cosa è meglio per loro, e infine sull’importanza di mantenere l’ordine
istituzionale esistente» (Coleman, 1978).
Nell’insieme dei Paesi occidentali, l’offerta di formazione si attua in un arco di possibili soluzioni
che va dall’assoluto monopolio statale all’adozione di criteri di libero mercato, anche se le due
posizioni estreme sono più che altro teoriche: nessuna moderna democrazia pensa realmente di
abolire la libertà di scelta, subordinando interamente la famiglia allo Stato, così come nessun
liberista, per quanto radicale, pensa che la scuola debba essere lasciata solo alle famiglie, dal
momento che la libera scelta deve essere compatibile con un quadro di riferimento basato su
presupposti di valore condivisi. Per le vicende storiche del nostro Paese, la scelta di attribuire un
forte ruolo alla scuola, motivato dalla necessità di unificare tra loro popolazioni anche
profondamente diverse, a partire dal linguaggio, ha di fatto marginalizzato la famiglia, e la famiglia
cattolica in particolare, vista come potenziale portatrice di una cultura di separatezza. Nel secondo
dopoguerra, quando qualcosa avrebbe potuto cambiare, si è privilegiata la scelta di ricostruire
l’unità nazionale attraverso una scuola unica ispirata ai valori della Costituzione, con una massiccia
attribuzione dei compiti educativi alla scuola, resa più agevole dal parallelo indebolimento delle
capacità educative della famiglia e della Chiesa. La misura del paradosso si è avuta con i decreti
delegati del 1974, che “consentivano” la partecipazione della famiglia, alla pari con altre “forze
sociali”, con una funzione esclusivamente consultiva.
2. Gli indicatori di cambiamento
Oggi la situazione è profondamente mutata, sia grazie allo sviluppo di modelli innovativi di
partecipazione reale, promossi sul piano formale dall’avvio dell’autonomia e dal concetto di
“responsabilità” della scuola nei confronti degli utenti, sia perché cresce la tendenza ad una
riappropriazione del controllo da parte degli utenti sul servizio educativo, che può essere letta come
una fase del processo di riduzione dell’influenza governativa nello Stato sociale e di recupero delle
funzioni della famiglia (e della comunità). La riorganizzazione del sistema formativo chiama in
causa il modo in cui vengono erogati i servizi pubblici alla persona, che non devono solo rispettare
criteri di economicità e razionalizzazione della spesa, ma anche di qualità del servizio e di
ridistribuzione delle risorse, a tutela delle fasce più deboli: tale urgenza è maggiore nella scuola per
la particolare rilevanza sociale del ruolo da essa svolto nella trasmissione del patrimonio culturale.
Sarebbe quindi limitativo, per non dire scorretto, leggere la domanda di partecipazione o la scelta
del privato come una semplice reazione allo scadimento della qualità, perché esso rappresenta
l’espressione di un desiderio sincero di farsi carico della crescita dei propri figli, desiderio ancora
confuso e che fatica ad esprimersi in un modello organizzativo, ma non per questo meno preciso.
Nonostante una maggiore disponibilità ad ammettere la possibilità di coesistenza di più progetti
educativi all’interno della scuola statale (il cosiddetto “pluralismo nelle istituzioni” contrapposto al
“pluralismo delle istituzioni”), i sostenitori della scuola unica statale sono tuttora convinti che nella
scuola confessionale esista il rischio reale che i genitori “inculchino” le proprie idee nei figli,
rinforzandole per mezzo della scelta di una scuola che ad esse si ispira: ora, la trasmissione di un
sistema articolato e coerente di valori, norme e comportamenti – che costituiscono nel loro insieme
quel che i sociologi definiscono “cultura” - è uno dei compiti primari per cui la famiglia come
soggetto sociale si è costituita, e sarebbe da considerare suicida quella società che non avesse a
cuore la continuità intergenerazionale. Chi asserisce che tale compito spetta allo Stato, in quanto le
famiglie non sono affidabili, corre il rischio molto più negativo di “normalizzare” le personalità
imponendo un’idea di uomo standardizzato. Per questo, i sostenitori della scelta familiare ritengono
che non sia compito dello Stato democratico incoraggiare o scoraggiare le culture delle famiglie, ma
solo accertare che non vadano attivamente contro i principi su cui esso si fonda, e dopo questo
controllo, garantire loro la possibilità di esprimersi liberamente, senza penalizzazioni di tipo
economico (scuola privata non sovvenzionata) o burocratico (mancato riconoscimento dei titoli
conseguiti). L’altra obiezione frequentemente avanzata è che questo tipo di continuità educativa
forse consentirebbe lo sviluppo di personalità mature, ma porterebbe ad una segmentazione
integralista della società in gruppi non comunicanti. Questa affermazione non è stata provata da dati
attendibili di ricerca, e resta quindi uno dei tanti miti indimostrabili legati al concetto di scuola
unica.
3. Sussidiarietà e autonomia per la riorganizzazione del sistema formativo
L’introduzione dell’autonomia, con l’affermazione che il valore di una scuola non deriva dalla sua
appartenenza allo Stato, ma dalla sua capacità di formulare un progetto educativo affidabile e
rispondente alle richieste degli utenti (i ragazzi, le loro famiglie, la comunità, il mercato del lavoro),
ha ridato respiro alla presenza della famiglia come titolare del diritto – dovere di educare i propri
figli, insieme alla scuola. Non si tratta di sostituirsi ai tecnici insegnando loro ad insegnare, ma di
riaffermare con decisione che solo un curricolo costruito intorno ad un preciso progetto educativo,
condiviso dagli studenti, dalle loro famiglie, dal gruppo a cui appartengono, è in grado di far
crescere adulti responsabili, capaci di controllare la complessità del mondo in cui vivono, di seguire
l’intreccio (com – plexus) delle loro esperienze.
Per questo la partecipazione della famiglia, benché abbia come scopo un’educazione di qualità, non
può essere vista come un fatto mercantile, in cui i “consumatori” si organizzano per ottenere un
prodotto migliore, possibilmente a un prezzo accettabile: se si vuole utilizzare una terminologia
economica, sfuma la distinzione fra “produttori” e “consumatori”, e si afferma un ruolo attivo che
vede collaborare le famiglie ai tre livelli dell’individuazione dei bisogni, della determinazione delle
strategie e del controllo. La scuola è, insieme alle altre agenzie educative, ma più di esse soprattutto
per il tempo che il giovane vi trascorre, uno strumento qualificato di aiuto alla famiglia in quanto e
nella misura in cui, sulla base di una ideale continuità, aiuta la maturazione critica della cultura di
base acquisita in famiglia. È sulla base di questa funzione sussidiaria della scuola che si fonda il
diritto della famiglia alla libera scelta della stessa e il diritto a definire, assieme ai gestori e agli
insegnanti, il progetto educativo dell’istituto scolastico.
Le scuole non sono un valore in sé, ma nascono da una precisa opzione storica, e hanno un senso in
quanto forniscono, prima di tutto a coloro che ne fanno uso, cioè bambini, o ai genitori per conto
dei bambini, un servizio che è insieme pubblico e privato-pubblico, sia perché influenza la qualità
della vita della comunità, sia in quanto influisce sulla crescita dei singoli individui che ne fruiscono.
La quasi totalità delle ricerche mostra che se in un ambiente educativo esiste un accordo sui valori
di base tra i genitori e gli insegnanti o anche solo se esiste un progetto educativo basato su un
sistema coerente di valori, la qualità dell’educazione è migliore, in quanto l’efficacia delle scuole
deriva non dall’aver adottato un sistema di compromesso tra le parti, ma dall’essere organizzata
intorno a specifici principi educativi ed etici. E’ particolarmente interessante l’esito di ricerche
svolte recentemente nei Paesi dell’Est, in cui la riapertura delle scuole confessionali nel giro di
pochissimi anni ha portato alle stesse conseguenze.
Il complesso concetto di accountability, affidabilità, che oggi viene considerato il primo requisito di
una scuola, presume l’esistenza di una base etica, di un accordo sul sistema di valori, e in questo
senso non coincide con la pura e semplice responsabilità legale, ma è una «metafora che indica
l’esistenza di richieste della comunità agli amministratori professionali che mandano avanti la
scuola (standard di apprendimento, contenuto dei curricoli, partecipazione dei genitori e della
comunità, responsabilità amministrative)» (Maclure, 1978). Il riferimento ad un sistema forte di
valori struttura l’attività quotidiana e potenzia il senso di appartenenza, la fiducia reciproca crea una
sorta di "capitale sociale" che spiega il miglior funzionamento delle scuole confessionali rispetto a
quelle “neutre”, in cui i programmi educativi rappresentano un compromesso tra cittadini con punti
di vista diversi, sulla base del rispetto di alcuni principi comuni.
La crescita della frammentazione sociale, con la presenza di nuovi gruppi di cittadini con tradizioni
e valori diversi porrà con più vigore il problema di selezionare e fissare i valori che vengono
considerati costitutivi della cittadinanza, e che proprio perché sono pochi ed essenziali non sono
negoziabili. Tuttavia è probabile che ci saranno dei conflitti, come è accaduto ad esempio in Francia
o in Gran Bretagna per questioni legate alla pratica della religione islamica, perché un
compromesso, politicamente inevitabile, può essere considerato indifendibile dalle famiglie dal
punto di vista educativo, se viene applicato ad aree e a fini che non possono essere oggetto di
compromesso senza minare le posizioni di valori ad esse sottostanti. Il conflitto si manifesta nella
scuola pubblica in cui sono presenti ragazzi di gruppi etnici diversi (e organizzati), ma finora solo in
rari casi, per esempio in Olanda, sono state finanziate scuole confessionale islamiche o induiste, sia
pure soggette ad alcuni vincoli. In linea di massima, però, l’orientamento acquisitivo delle famiglie,
volte all’integrazione e al successo per i figli, porta i genitori, e i ragazzi stessi, a rifiutare delle
scuole che vivono come ghetti.
L’autonomia è il modello che rispetta e promuove la presenza delle famiglie come soggetto
educatore nel sistema formativo allargato, in un momento in cui la ricerca educativa sta diffondendo
la consapevolezza che essa gioca un ruolo centrale che non si limita al semplice sostegno affettivo
del bambino, ma (soprattutto nelle diverse fasi dell’infanzia e della pre-adolescenza) a precisi
contenuti socializzanti e formativi, e media fra i diversi e incontrollati messaggi che il contesto
trasmette: nel momento in cui si insiste per un riconoscimento delle scuole non statali, e dei progetti
formulati da famiglie e genitori insieme, non si deve dimenticare che la pervasività dei messaggi
televisivi, pubblicitari e in generale dei mass media rischia di portare ad una socializzazione non
solo descolarizzata, ma anche “defamilizzata”. Di fronte alla richiesta/necessità di affidare alla
famiglia nuove competenze, o vecchie competenze abbandonate, il sistema sociale deve dunque
sviluppare forme diverse di assegnazione di responsabilità, ma anche di risorse: questo nella scuola
incontra opposizioni così pesanti che ci si chiede se il sistema non tema una cresciuta autonomia
della famiglia, che se da un lato rappresenta la condizione perché essa possa essere un luogo di
ricomposizione della complessità e di risposta ai bisogni dei suoi membri, dall’altro viene vista
come un pericolo e una sfida per la stabilità del sistema stesso.
La sussidiarietà come principio regolatore di una politica sociale
di reale promozione della famiglia
Ivo Colozzi
1. La sussidiarietà: un principio a cui guarda l’Europa
Negli anni di crescita dei sistemi europei di welfare il principio di sussidiarietà era condiviso solo
da alcune forze politiche di ispirazione cristiana, soprattutto tedesche e olandesi, che lo hanno
utilizzato in qualche modo per realizzare i loro modelli di Stato sociale, mentre era osteggiato dai
partiti socialdemocratici che avevano teorizzato il modello istituzionale o quasi totale di welfare,
cioè quel sistema in cui le prestazioni e i servizi sono forniti direttamente dalla pubblica
amministrazione su base universalistica. In Italia, come si sa, la costruzione dello Stato sociale ha
seguito questa seconda strada, anche se in una forma peculiare, nonostante le coalizioni di governo
fossero guidate da un partito democristiano. Non è questa la sede per analizzare in dettaglio i motivi
che hanno portato a questo sviluppo per certi versi anomalo; vorrei solo sottolineare che nel nostro
paese il principio di sussidiarietà è rimasto del tutto marginale nell’ambito del dibattito sulla
costruzione dello Stato sociale.
Dalla fine degli anni ‘70, però, quando in molti Paesi europei di più lunga tradizione welfarista il
sistema statale di prestazioni sociali ha cominciato ad evidenziare difficoltà sempre più consistenti,
il principio di sussidiarietà ha iniziato a godere di un consenso più ampio. Il processo che ha
contribuito di più alla sua valorizzazione, però, è stata l’unificazione dell’Europa. Tutti gli stati
membri e gli organismi della Comunità europea hanno inteso superare le difficoltà poste al processo
di integrazione europea appellandosi al principio di sussidiarietà.
Questo successo, documentabile tramite i vari documenti prodotti dalla Comunità europea e le
dichiarazioni solenni di vari governi nazionali, non significa che il principio di sussidiarietà abbia
acquisito una fisionomia operativa precisa o che ad esso sia dato da tutti lo stesso significato. Prima
di analizzare cosa comporti la sua applicazione alle politiche sociali, quindi, è necessario tentare di
chiarire cosa si deve intendere con questo termine e che problemi suscita il suo utilizzo in chiave
operativa.
2. Per una definizione del principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà, che riguarda l’ordine dei rapporti fra Stato e società, fa parte
dell’insegnamento sociale della Chiesa cattolica. Questo non significa che si tratti di un principio
cattolico: è rintracciabile, infatti, in molti autori classici di filosofia sociale.
Il principio di sussidiarietà implica che lo Stato di fronte alla società - singoli cittadini, famiglie,
gruppi intermedi, associazioni e imprese - non debba fare di più, ma neanche di meno, che offrire
un aiuto all’autonomia. Il concetto deriva dal latino subsidium ferre, che significa prestare aiuto,
offrire protezione. La formulazione classica del principio si trova nell’enciclica Quadragesimo anno
di papa Pio XI, pubblicata nel 1931. In quell’enciclica suona così: «Siccome è illecito togliere agli
individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l’industria propria per affidarlo alla
comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e
inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto
ordine della società, perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di
aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle». (n.
80)
Successivamente, il principio di sussidiarietà è stato più volte ripreso e sviluppato. Giovanni XXIII
nella Pacem in terris ne ha esteso la portata riferendolo all’attività delle comunità politiche a livello
internazionale, e più di recente la Congregazione per la dottrina della fede nell’istruzione Libertà
cristiana e liberazione del 1986 ha ricordato che i principi di solidarietà e di sussidiarietà sono i due
pilastri fondamentali della dottrina sociale cristiana e che entrambi sono legati all’obiettivo di
promuovere la dignità dell’uomo. Infine, l’attuale pontefice nell’enciclica Centesimus annus, dopo
aver ricordato che il principio di sussidiarietà va coniugato con quello di solidarietà, lo ha applicato
proprio al welfare state, rilevando che le degenerazioni in cui quest’ultimo è incorso sono dovute
proprio al mancato rispetto del principio di sussidiarietà: «Disfunzioni e difetti nello Stato
assistenziale derivano da un’inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato. Anche in
questo ambito deve essere rispettato il principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non
deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue
competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione
con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune». (n. 48)
Questo principio, quindi, obbliga coloro che ne sono destinatari sia all’azione che
all’autolimitazione. Obbliga, infatti, lo Stato, come anche la Comunità europea o il Comune, ad
aiutare le articolazioni sottostanti così da metterle in condizione di sostenere i singoli cittadini nello
sviluppo di una vita degna dell’uomo (funzione promozionale). Nello stesso tempo proibisce a
questi stessi destinatari di intervenire nell’ambito di vita e di azione delle articolazioni sottostanti se
queste sono nella condizione di regolarsi autonomamente e di gestire in proprio i loro compiti
(funzione protettiva). Se queste articolazioni non riescono ad espletare i loro compiti con le loro
forze, il principio di sussidiarietà impone allo Stato di non assumere subito su di sé questi compiti,
ma di cercare vie di rafforzamento delle energie e delle capacità in modo da aumentarne
l’autonomia, intesa come capacità di scegliere l’ambiente con cui entrare in relazione.
Il principio di sussidiarietà, quindi, possiede una duplice dimensione: una che attiva lo Stato o altro
destinatario, l’altra che limita questo intervento o protegge nei confronti di questo intervento. Molto
spesso negli ultimi anni è stata sottolineata solo questa seconda dimensione, quella protettiva, con il
risultato di far coincidere il principio di sussidiarietà con una politica liberista di privatizzazioni e di
ridimensionamento dell’intervento statale, anche in termini di spesa pubblica. Questa concezione
del principio di sussidiarietà non gli rende giustizia.
Esiste anche una terza dimensione del principio. Essa, che potremmo definire funzione di
responsabilizzazione degli attori, difende lo Stato e gli altri destinatari dei doveri di sussidiarietà da
un sovraccarico di compiti. Nel principio, infatti, è contenuto un obbligo per lo Stato di respingere i
compiti, e i relativi oneri, che singoli cittadini o comunità subordinate pretendono di scaricare su di
esso, pur essendo in grado di assolverli.
3. Conseguenze politiche e problemi applicativi del principio di sussidiarietà
Se proibisce ai suoi destinatari di intervenire nella vita o nella sfera di azione delle unità più piccole,
fino a che queste siano in grado di svolgere autonomamente i propri compiti, e se li obbliga,
qualsiasi cosa facciano, a farla incentivando e stimolando le unità più piccole, ciò significa che i
destinatari del principio di sussidiarietà hanno una funzione di servizio alle unità più piccole. Lo
Stato, in quanto destinatario del principio di sussidiarietà, quindi, deve concepirsi al servizio della
società civile.
Se scopo di uno Stato sussidiario è di sostenere le articolazioni sociali e, con esse, i cittadini nelle
loro disponibilità e capacità di sviluppare e realizzare iniziative proprie, ne segue che lo Stato non
deve solo sostenere l’autonomia della società civile, ma anche limitare in modo significativo le
proprie competenze decisionali. In breve, ciò significa che lo Stato deve assumere una connotazione
federale e democratica o, in negativo, che il principio di sussidiarietà è incompatibile con uno Stato
centralistico e autoritario, e che agli enti territoriali vanno lasciati non solo competenze giuridiche o
diritti di iniziativa, ma anche i mezzi finanziari ed amministrativi necessari all’organizzazione e
all’esercizio concreto di questa facoltà. Il principio di sussidiarietà, quindi, esige dallo Stato una
suddivisione dei poteri legislativi in legislazione esclusiva e legislazione concorrenziale, così come
una suddivisione dei mezzi fiscali e di bilancio.
Il principio di sussidiarietà non è una formula giuridica immediatamente applicabile, ma un
principio costituzionale e regolativo che deve essere interpretato. In altri termini, si può dire che
quello di sussidiarietà è un principio di competenza che non definisce nel contenuto ciò che le
singole entità sociali devono perseguire come valori e obiettivi. Indica, invece, il criterio
fondamentale di azione di ogni istituzione o sottosistema sociale, che è il sostegno: ogni istituzione
è tenuta ad intervenire a sostegno dell’altra, quando quest’ultima non riesce a portare a termine il
proprio compito, in un modo che le consenta di aumentare il proprio grado di autonomia. Ma questo
vale per tutte le istituzioni e le formazioni sociali, in forma mutua e reciproca, e non solo per lo
Stato rispetto alla società civile.
4. L’applicazione del principio di sussidiarietà alla rifondazione dello Stato sociale
Mi pare che si possano tipologizzare tre diverse possibili concezioni dell’applicazione del principio
di sussidiarietà alle politiche sociali. Un primo orientamento, che potremmo definire privatistico,
parte dal presupposto della inefficienza del modello burocratico tipico della Pubblica
Amministrazione. Secondo i sostenitori di questo orientamento, il modello burocratico pubblico è
molto costoso e rigido, quindi poco capace di rispondere flessibilmente al modificarsi dei bisogni.
Si caldeggia, pertanto, l'affidamento sempre più esteso della gestione dei servizi alle organizzazioni
private, sia di profitto che non-profit, mentre il pubblico dovrebbe riservarsi compiti di supporto
finanziario, di controllo della qualità e affidabilità dei servizi e di intervento “in ultima istanza” nei
confronti di quei problemi o di quelle situazioni per le quali le famiglie, le associazioni e le
organizzazioni non riescono a trovare risposte.
L'orientamento istituzionale, invece, insiste sul fatto che la legittimità della politica pubblica
dipende dalla capacità di soddisfare le domande dei cittadini. Di conseguenza il contributo dei
soggetti privati, in particolare quello del Terzo Settore, consiste solo nell'integrare o “sussidiare” le
prestazioni dei servizi pubblici, permettendo di aumentarne l'efficacia e l'efficienza anche grazie al
minor costo.
L'orientamento del pluralismo societario, infine, parte dalla constatazione che il modello "quasitotale" di welfare state non solo non riesce più a gestire in modo adeguato ed efficace i servizi
sociali e sanitari, ma agisce come fattore di compressione delle emergenti organizzazioni
"intermedie" fra Stato e cittadino. Il Terzo Settore, infatti, pur nella sua complessa articolazione,
rappresenta un nuovo progetto sociale e umano che esprime un modo nuovo di vivere in società e di
fare società, nella misura in cui mette al primo posto «il senso della dignità umana, la solidarietà, il
nesso fra libertà e responsabilità, assumendosi l’onere di una piena autonomia che si legittima in
quanto realizza il bene comune» (Donati).
5. La politica sociale a livello locale
Utilizzare la sussidiarietà come principio ordinatore delle nuove politiche sociali a livello locale
richiede che l'obiettivo strategico degli enti locali diventi l'aiutare le persone a diventare o a
rimanere membri attivi della società. Le nuove modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi
non solo dovranno accentuare la partecipazione degli utenti nel definire i loro bisogni, ma dovranno
soprattutto riconoscere il ruolo che essi e le loro famiglie possono avere come partners attivi
piuttosto che come destinatari passivi di benefici e servizi.
Nel nuovo Stato sociale, i servizi sociali personali dovranno incoraggiare l'autonomia, il saper
contare su di sé, l'auto-aiuto, la mutualità, e valorizzare le cooperative e le agenzie di volontariato
che lavorano nell'ambito della comunità locale. Questa opzione diventa desiderabile non solo a
causa delle ristrettezze finanziarie dello Stato ma soprattutto come modo per produrre servizi più
umani ed efficaci, orientati alla prevenzione, alla riabilitazione, alla reintegrazione sociale delle
persone socialmente deboli. Ciò richiede un nuovo coinvolgimento delle famiglie e delle reti sociali
primarie, ma tale coinvolgimento non comporta in alcun modo la deresponsabilizzazione finanziaria
dello Stato. Nel progettare ed attuare le nuove politiche sociali si deve essere consapevoli, anzi, che
allo Stato restano le maggiori responsabilità nel far sì che i bisogni sociali siano coperti, ma anche si
deve prendere atto che la loro gestione deve coinvolgere gli utenti.
Oggi siamo consapevoli che nonostante la grossa crescita dei servizi istituzionali di welfare, la gran
parte delle risposte ai bisogni di vita quotidiana dei soggetti deboli viene ancora dalle famiglie e
dalle reti informali di aiuto formate dai parenti non conviventi, dai vicini e dagli amici. Siamo,
inoltre, consapevoli del fatto che questo è un bene, non solo dal punto di vista economico o
sistemico, ma anche da quello dei "mondi vitali quotidiani", cioè del benessere relazionale delle
persone. Sappiamo però anche che queste reti sono fragili e che oggi rischiano di diventarlo ancor
di più per una serie di cambiamenti importanti in atto. L'ente pubblico, quindi, non può limitarsi a
prendere atto della loro esistenza, ma ha il dovere di sostenerle intervenendo a supporto e
complemento delle stesse. Ciò significa che il modello organizzativo dell’assistenza deve
riconoscere il principio di sussidiarietà come cardine del nuovo sistema di politiche sociali.
L’associazionismo familiare
Giovanna Rossi
1. L’associazionismo familiare come espressione della soggettività sociale della famiglia
L’associazionismo familiare italiano è un fenomeno eterogeneo, il cui carattere “familiare” si
declina con modalità e “intensità” differenti. Il suo nucleo forte è costituito da organismi che si
costituiscono attorno ad uno specifico bisogno familiare, sono promossi da famiglie e attuano un
intervento che non solo è rivolto alla famiglia, ma la coinvolge in modo diretto e la rende
protagonista dell’azione: in questo modo l’associazionismo familiare agisce sulle relazioni
familiari, rigenerandole e rafforzandole (fornendo loro le risorse), perché trovino autonomamente la
risposta risolutiva al proprio bisogno, facendo leva sullo codice della solidarietà, specifico della
famiglia. L’associazione promuove, così, una solidarietà di tipo familiare, legata cioè al quotidiano,
continua, personalizzata, flessibile, mutevole, che assume forme differenziate sulla base dei livelli
diversi di risposta ai bisogni delle famiglie.
Comprendere ed identificare la “familiarità” dell’azione associativa è uno degli aspetti cruciali nella
riflessione sull’associazionismo familiare. Il modello a cui faccio riferimento considera
fondamentali per definire lo spazio di un’associazione autenticamente familiare due caratteri
dell’esperienza associativa:
il primo carattere è il diverso rapporto che i membri possono intrattenere col bisogno a cui
l’associazione risponde, ovvero l’associazione può essere costituita solo da soci che sono anche
portatori del bisogno oppure da soggetti che non lo vivono in prima persona, oppure ancora da
un mix di soci del primo e del secondo tipo;
il secondo carattere coincide con il carattere stesso dell’azione associativa, che può essere
orientata in modo specifico alla famiglia, oppure proporsi finalità più generali, oppure un mix di
obiettivi familiari specifici e di obiettivi sociali generali.
Sulla base delle due dimensioni, poste l’una in verticale e l’altra in orizzontale, come assi di un
piano cartesiano, è possibile costruire una matrice in cui il familiare si connota in forma generale
per diventare via via più specifico, fino ad un associazionismo che è “familiare” in senso stretto, in
quanto risulta molto marcata la caratteristica di condivisione del bisogno familiare e di influenza
sulle mediazioni familiari.
Se questi sono tratti peculiari dell’associazionismo familiare, si comprende per quale motivo
rappresenti un luogo privilegiato per l’espressione della cittadinanza in senso proprio della famiglia.
Nelle relazioni familiari si genera continuamente un complesso intreccio di interdipendenze tra
diritti individuali e diritti intersoggettivi, che possono combinarsi in modo sensato proprio grazie
alla specifica capacità di mediazione della famiglia, sulla quale si incentra l’azione delle
associazioni familiari: questa competenza, valorizzata e promossa dall’associazionismo familiare,
rende la famiglia titolare di una “cittadinanza societaria”.
L’associazionismo familiare consente alla famiglia di diventare un soggetto cruciale del contesto
societario, svolgendo, con un codice d’azione improntato alla solidarietà, un’essenziale funzione di
coordinamento tra risorse esterne ed interne all’unità familiare, che si caratterizza come produzione
di un “bene comune relazionale”, un bene connotato dall’“essere insieme”, non solo come
caratteristica che ne origina la produzione, ma anche la fruizione.
2. I caratteri distintivi dell’associazionismo familiare
L’esperienza associativa promuove e potenzia le relazioni familiari, facendo leva su quattro
caratteri discriminanti.
Il carattere “generativo” della famiglia
La famiglia che interpreta la propria vocazione generativa come incapacità di rimanere segregati
entro i confini “privati” del proprio nucleo familiare e necessità di socializzare, “pubblicizzare”,
le esigenze familiari e sceglie l’esperienza associativa, produce famiglia.
La “soggettività” e il ruolo sociale della famiglia
Il fine sociale, la sfida alla quale la famiglia deve rispondere, è quello di agire come “soggettività
sociale” con i relativi diritti/doveri di cittadinanza, di influire sull’evoluzione e sul progresso
della società, imponendo una dimensione “familiare” alle politiche sociali; ciò è possibile se
l’immagine che rimanda è quella di una relazione che medi tra livello individuale, livello
familiare e livello sociale: così si presenta la famiglia che aderisce ad un progetto associativo.
La “cittadinanza societaria” della famiglia
Nella società globale, caratterizzata da un’accentuazione dei particolarismi che risultano, in
ultima analisi, irriducibili, l’unica strada percorribile per coordinare e regolamentare in modo
uniforme le relazioni tra i vari attori del sistema, è adottare un approccio relazionale, ossia
evidenziare l’intreccio tra responsabilità individuali e intersoggettive, tra livello privato e livello
pubblico/istituzionale. In questa prospettiva, l’associazione costituisce una valida mediazione tra
bisogni privati e necessità di dare ad essi una voce “istituzionale”, una veste legale. Attraverso la
mediazione dell’associazione familiare, la famiglia acquisisce piena cittadinanza.
La famiglia come “sorgente” e “custode” dei valori
Notevole risulta essere l’influenza di queste due esperienze sulla presa di coscienza da parte
delle famiglie dei valori di cui sono portatrici.
Il carattere generativo costituisce una risorsa, un bene che la famiglia può “spendere” in diversi
modi; come pure i valori di cui la famiglia è sorgente rappresentano un’altra risorsa da giocare per
acquisire soggettività sociale e intervenire direttamente nel sociale; la soggettività della famiglia e
la titolarità di una cittadinanza societaria costituiscono una sfida che concerne la capacità di
svolgere nel sociale un ruolo specifico, proprio attraverso l’esperienza associativa.
3. L’associazionismo familiare come sorgente di benessere per la famiglia
Le famiglie si associano a partire dalla necessità di condividere problemi concreti e trovare insieme
soluzioni ai bisogni familiari in risposta ad essi. Sono in questo senso una sorgente di “benessere”
per le famiglie, intendendo il benessere come un effetto che può derivare dall’attivazione di
relazioni o reti di relazioni.
Le relazioni in gioco si sviluppano su due livelli:
ad un primo livello, le relazioni tra le famiglie e le associazioni a cui esse danno vita; qui il
benessere deriva, innanzitutto, dai servizi che le associazioni offrono alle famiglie, ma anche
dagli effetti prodotti dall’impegno nell’esperienza associativa sulla vita familiare stessa;
ad un secondo livello, le relazioni delle associazioni familiari tra loro e con altri soggetti del
terzo settore (in questo senso l’esempio più significativo in Italia è il Forum delle Associazioni
Familiari, che ha costituito comitati regionali in molte regioni italiane e raggruppa sia
associazioni propriamente familiari, sia altri organismi di terzo settore) e le relazioni delle
associazioni familiari con attori politico-istituzionali, attori e istituzioni del mercato, mass
media; il benessere generato in queste relazioni si riverbera in modo indiretto sulla vita familiare
ed il benessere familiare diventa un modello per il benessere della società nel suo complesso.
4. I settori di intervento dell’associazionismo familiare
Le associazioni familiari si costituiscono intorno ad una specifico bisogno familiare ed in ragione di
questo coprono diversi settori di intervento che vanno dall’educazione alla formazione, dal sostegno
all’assistenza, dal recupero di persone devianti ed emarginate alle attività informative e di
consulenza, ecc.
Possiamo ricondurre questa molteplicità di iniziative a due grandi settori di intervento: la tutela dei
diritti delle famiglie e l’auto-organizzazione dei servizi di vita quotidiana.
La tutela dei diritti delle famiglie. In esso le associazioni sostengono la cittadinanza societaria
delle famiglie, esprimendo ed organizzando le esigenze collettive e diffuse delle famiglie,
attraverso la promozione di una solidarietà reciproca. Le associazioni tutelano diritti che spesso
lo Stato non riconosce o riconosce solo in parte a individui e gruppi, inoltre promuovono
iniziative di voice. L’azione associativa vuole sensibilizzare lo Stato verso le tematiche familiari
e rendere maggiormente consapevoli le famiglie del loro ruolo sociale.
L’auto-organizzazione dei servizi di vita quotidiana. Copre una vasta gamma di iniziative ed
attività che vanno dall’istituzione di scuole per i figli, al sostegno e cure per i membri malati agli
aiuti ai portatori di handicap ecc. In questa area sono compresi tutti i compiti di cura svolti dalle
famiglie. Tali servizi si connotano per il loro carattere familiare: coinvolgono nella risoluzione
dei problemi la famiglia nel suo complesso, attraverso un’azione di responsabilizzazione ed
imprimono agli interventi il carattere di flessibilità che distingue le attività di care della famiglia.
Per sintetizzare efficacemente l’esito più significativo dell’azione condotta dalle associazioni
familiari, si suole dire che tali organismi “producono famiglia”, ovvero stimolano una nuova
consapevolezza del proprio essere famiglia. Ciò avviene condividendo con altri o, semplicemente,
partecipando ad altri le necessità familiari: in termini più tecnici, “socializzando il proprio bisogno”,
mettendo in comune le problematiche.
La famiglia e il suo stile di azione, quindi, nell’intervento di un’associazione autenticamente
familiare, sta sia a monte, cioè come ragione dell’associarsi stesso, sia a valle, cioè come
orientamento dell’azione che l’associazione produce.