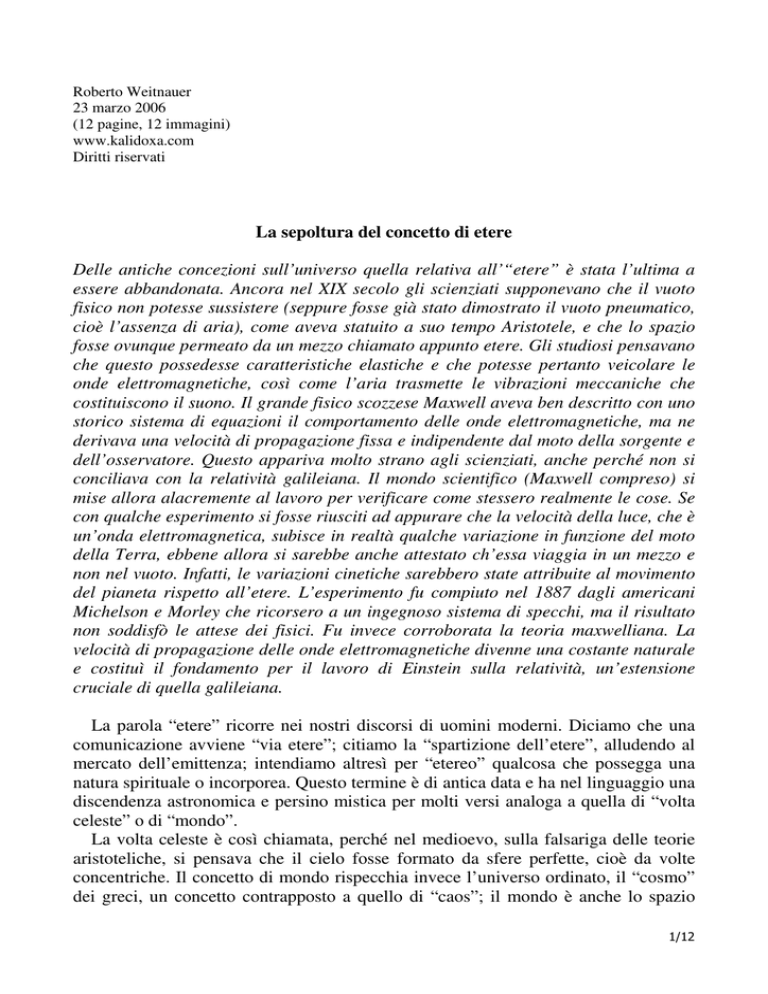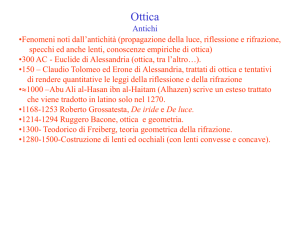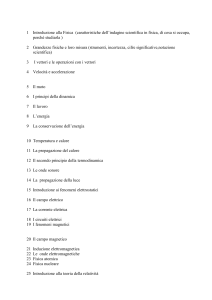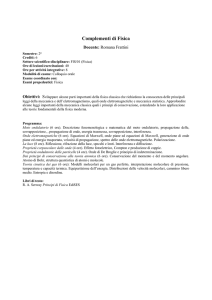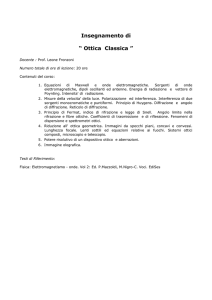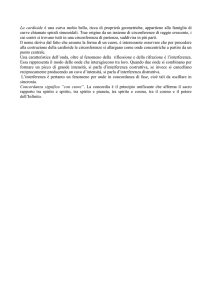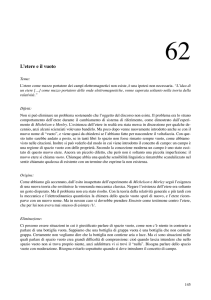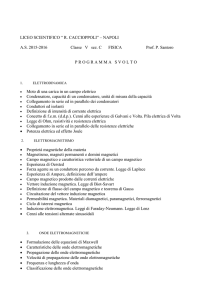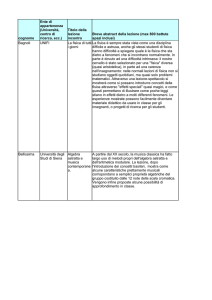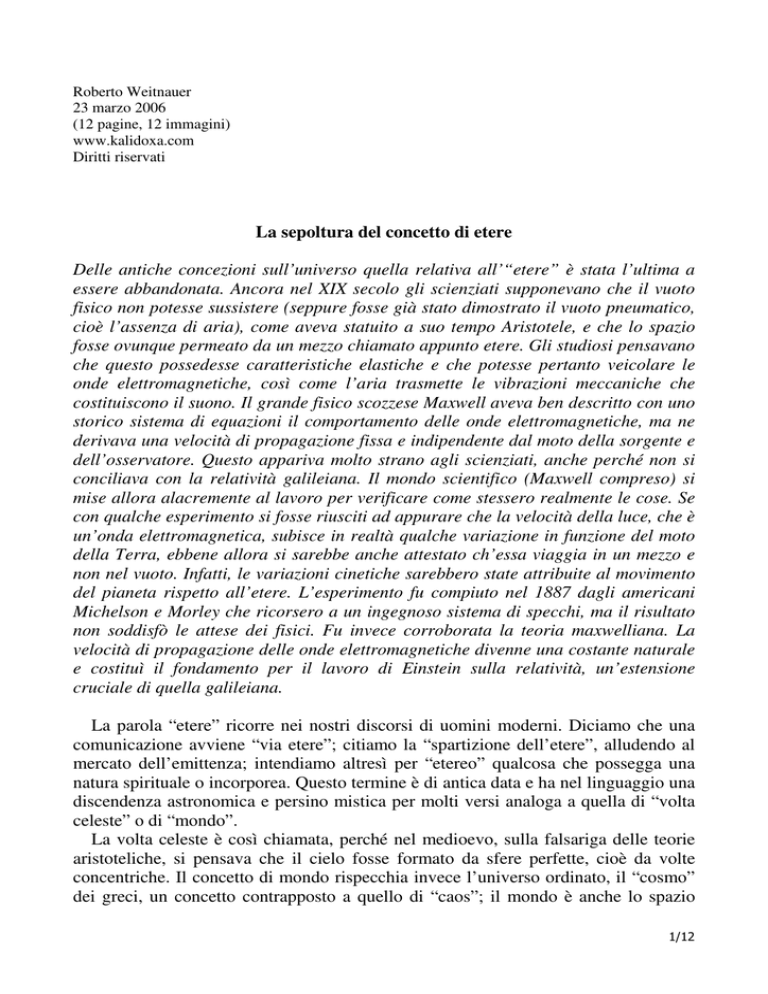
Roberto Weitnauer
23 marzo 2006
(12 pagine, 12 immagini)
www.kalidoxa.com
Diritti riservati
La sepoltura del concetto di etere
Delle antiche concezioni sull’universo quella relativa all’“etere” è stata l’ultima a
essere abbandonata. Ancora nel XIX secolo gli scienziati supponevano che il vuoto
fisico non potesse sussistere (seppure fosse già stato dimostrato il vuoto pneumatico,
cioè l’assenza di aria), come aveva statuito a suo tempo Aristotele, e che lo spazio
fosse ovunque permeato da un mezzo chiamato appunto etere. Gli studiosi pensavano
che questo possedesse caratteristiche elastiche e che potesse pertanto veicolare le
onde elettromagnetiche, così come l’aria trasmette le vibrazioni meccaniche che
costituiscono il suono. Il grande fisico scozzese Maxwell aveva ben descritto con uno
storico sistema di equazioni il comportamento delle onde elettromagnetiche, ma ne
derivava una velocità di propagazione fissa e indipendente dal moto della sorgente e
dell’osservatore. Questo appariva molto strano agli scienziati, anche perché non si
conciliava con la relatività galileiana. Il mondo scientifico (Maxwell compreso) si
mise allora alacremente al lavoro per verificare come stessero realmente le cose. Se
con qualche esperimento si fosse riusciti ad appurare che la velocità della luce, che è
un’onda elettromagnetica, subisce in realtà qualche variazione in funzione del moto
della Terra, ebbene allora si sarebbe anche attestato ch’essa viaggia in un mezzo e
non nel vuoto. Infatti, le variazioni cinetiche sarebbero state attribuite al movimento
del pianeta rispetto all’etere. L’esperimento fu compiuto nel 1887 dagli americani
Michelson e Morley che ricorsero a un ingegnoso sistema di specchi, ma il risultato
non soddisfò le attese dei fisici. Fu invece corroborata la teoria maxwelliana. La
velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche divenne una costante naturale
e costituì il fondamento per il lavoro di Einstein sulla relatività, un’estensione
cruciale di quella galileiana.
La parola “etere” ricorre nei nostri discorsi di uomini moderni. Diciamo che una
comunicazione avviene “via etere”; citiamo la “spartizione dell’etere”, alludendo al
mercato dell’emittenza; intendiamo altresì per “etereo” qualcosa che possegga una
natura spirituale o incorporea. Questo termine è di antica data e ha nel linguaggio una
discendenza astronomica e persino mistica per molti versi analoga a quella di “volta
celeste” o di “mondo”.
La volta celeste è così chiamata, perché nel medioevo, sulla falsariga delle teorie
aristoteliche, si pensava che il cielo fosse formato da sfere perfette, cioè da volte
concentriche. Il concetto di mondo rispecchia invece l’universo ordinato, il “cosmo”
dei greci, un concetto contrapposto a quello di “caos”; il mondo è anche lo spazio
mondato (pulito) dalle imperfezioni della materia corruttibile che ci circonda sulla
Terra, un’altra idea di origine aristotelica e, indirettamente, platonica.
Anche la nozione di etere ha una discendenza greca. L’etere era inteso come la
porzione più limpida dello spazio sopra l’atmosfera. Aristotele lo riteneva la
quintessenza di una realtà in cui non poteva sussistere il vuoto. L’idea risale ad
Anassagora che lo assumeva come fattore primigenio del cosmo, un principio secco e
caldo (dal greco ‘áither’, ‘ardente’).
Volta celeste, mondo, spazio ed etere sono stati nei secoli concetti variamente
intrecciati. In verità, la commistione era determinata da un’inevitabile ignoranza
relativamente alla realtà fisica che abitiamo. Dopo la nascita della scienza moderna
divenne chiaro che l’universo non fosse formato da cieli concentrici e che non
esistessero dimensioni più o meno illusorie o corruttibili. Le leggi naturali dell’ordine
cosmico sono ovunque le medesime, sul nostro pianeta, come nelle più remote
galassie.
Il grande filosofo Aristotele (384-322 a.C.) stabilì che la natura aborrisse il vuoto e che il mondo
sublunare fosse imperfetto e corruttibile rispetto ai cieli che ruotavano in un sistema di sfere
concentriche.
http://www.geophysics.geol.uoa.gr/frame_gr/histo/aristotle.jpg
La questione dell’etere venne invece risolta più tardi, qualche tempo dopo la
scoperta delle onde elettromagnetiche. Il grande scienziato scozzese James Clerk
Maxwell stabilì nel 1873 un potente sistema di equazioni differenziali che descriveva
la propagazione di queste vibrazioni a una velocità c fissa e indipendente da come si
rilevassero. Come le già note onde meccaniche (ad esempio quelle sonore), era
evidente che anche quelle elettromagnetiche costituissero un trasporto di energia e
non di massa. Ma c’erano delle differenze non da poco. Come riuscivano le onde
elettromagnetiche a propagarsi in mancanza di un chiaro supporto fisico? E come
poteva essere che la velocità apparisse costante, indipendentemente dall’osservatore?
Maxwell aveva introdotto una curiosa nozione per definire lo spazio in cui si
producono le interazioni elettriche e magnetiche. Era il concetto di “campo”. In
verità, già l’inglese Michael Faraday aveva in precedenza anticipato qualcosa di
analogo, studiando le forze scambiate tra fili metallici posti in prossimità uno all’altro
e percorsi da una corrente elettrica. Il campo di Maxwell andava però oltre le
intuizioni di Faraday e corrispondeva a una regione di spazio in cui si predisponeva
una sorta di “potenzialità” interattiva che, nel caso fossero stati presenti certi corpi
(ferromagnetici), si sarebbe chiaramente manifestata su di essi. Questa
interpretazione non corrispondeva ad alcunché di materiale ed appariva quindi a molti
fisici troppo astratta.
Il fisico scozzese James Clerk Maxwell (1831-1879) formulò nel 1873 un sistema di quattro
equazioni differenziali che descrivevano l’evoluzione spaziale e temporale del campo elettrico e di
quello magnetico che sono accoppiati in un’onda elettromagnetica. Il concetto di “campo” era
duro da digerire, perché presupponeva una specie di potenzialità interattiva che non aveva nulla di
materiale.
http://www.nrao.edu/whatisra/images/maxwell2.jpg
Ecco allora che gli scienziati del XIX secolo ricorsero alla vecchia idea di etere.
Quest’ultimo doveva costituire l’effettivo mezzo di propagazione per la radiazione
elettromagnetica. Gli studiosi ipotizzarono insomma che le sue deformazioni e le sue
tensioni interne spiegassero le oscillazioni maxwelliane. La convinzione di fondo era
che l’etere reagisse alla stregua di un corpo elastico, trasmettendo le sollecitazioni,
come succede per le onde sonore che si propagano in virtù della compressione e
decompressione periodica dell’aria.
La velocità di un’onda in un mezzo di propagazione dipende dalle caratteristiche
del mezzo stesso. La velocità del suono, ad esempio, dipende dal modulo di
compressibilità del fluido e dalla sua densità. Per Maxwell la velocità delle vibrazioni
elettromagnetiche corrispondeva invece a una grandezza invariante di natura, qual’è
ad esempio la costante gravitazionale o la costante dei gas. Ciò faceva storcere il naso
a molti scienziati, perché era come ritenere che esistesse un limite invalicabile per le
velocità che potessero prodursi nel mondo fisico. Allora si riteneva che le velocità
osservabili potessero crescere a dismisura.
In effetti, la teoria maxwelliana si scontrava con quella di Galileo. Quest’ultimo
aveva a suo tempo ben introdotto i concetti inerenti il moto relativo, sottolineando
l’importanza del punto di vista dell’osservatore. Era ad esempio assodato che le
velocità dovessero sommarsi (vettorialmente). Ad esempio, un uomo che corre in
avanti nel corridoio di un treno, il quale a sua volta si sposta sulle rotaie, si muove
rispetto a una stazione a una velocità data dalla somma della sua velocità nel
corridoio e di quella del convoglio rispetto alla stazione.
Galileo Galilei (1564-1642), uno dei padri della scienza moderna (insieme a Cartesio e Newton).
Secondo la relatività classica galileiana le velocità dipendono dal punto di vista dell’osservatore.
Ad esempio, rispetto all’osservatore posto su un treno una stazione di passaggio sembra scorrere
all’indietro alla stessa velocità che possiede il treno rispetto alla stazione. Analogamente, la
velocità di un uomo che corra in un treno verso la motrice è rispetto a un osservatore posto nella
stazione pari a quella dell’uomo rispetto al treno sommata a quella del treno rispetto alla stazione.
Secondo le equazioni di Maxwell c’era invece un limite superiore per i valori della velocità, dato
che nella sua teoria le onde elettromagnetiche si propagano a velocità fissa e totalmente
indipendente da come le si osservi.
http://www.bo.astro.it/universo/venere/Sole-Pianeti/planets/stoimm/galileo2.jpg
Le equazioni di Maxwell dicevano invece che il punto di vista non contava per le
onde elettromagnetiche, ossia che la loro velocità di propagazione fosse qualcosa di
assoluto, non qualcosa di relativo. Così, un raggio di luce, che è un’onda
elettromagnetica, doveva avanzare alla stessa velocità, sia che fosse visto dall’interno
del treno in movimento, sia che fosse misurato dalla stazione; e questo
indipendentemente dai versi di percorrenza.
Bisognava d’altronde riconoscere che in senso puramente formale nessuno aveva
scoperto errori nella elegante costruzione matematica di Maxwell, tantomeno
sembrava ch’egli fosse esordito da fondamenti fisici inaccettabili. A quel punto per
rimuovere le difficoltà insite nella nozione di campo e di velocità assoluta non restava
che procedere con qualche esperimento che tagliasse la testa al toro. Ci si aspettava in
effetti che su larga scala la grande velocità della radiazione presentasse alcune
differenze in funzione del moto dell’osservatore. Tale verifica avrebbe confermato la
presenza di un mezzo di propagazione ubiquitario. La parola “campo” sarebbe stata
allora ridimensionata o addirittura abolita, giacché il fenomeno elettromagnetico
sarebbe rientrato nella consueta ottica galileiana.
Divenne presto chiaro quale fosse l’opportunità principale da sfruttare: occorreva
innanzitutto concentrarsi sulla misurazione della luce. Come infatti si accennava, essa
è un’onda elettromagnetica che si propaga nello spazio a grandi distanze; uno spazio
che i fisici credevano appunto riempito dall’etere. Inoltre, si comprese che la
misurazione avrebbe dovuto compiersi, tenendo conto dei movimenti della Terra
nello spazio siderale.
Ruotando intorno alla stella madre, il nostro pianeta si sposta a una media di circa
108'
000 km/h. Anche il Sole segue un suo movimento e anche l’intera Via Lattea. Gli
studiosi dell’epoca pensavano quindi che nel suo moto articolato (planetario, solare,
galattico) la Terra incontrasse un “vento dell’etere”, un po’ come capita a un
motociclista che è lambito da un flusso d’aria mentre viaggia sul suo veicolo
scoperto. C’è un termine intuitivo che i velisti usano spesso: “vento apparente”. Esso
sottintende il vento percepito da bordo dell’imbarcazione che solca il mare; vento che
è diverso da quello rilevato da un riferimento fisso come una costa.
Il vento reale (freccia blu) spira da sinistra e fa sbattere la vela di un’imbarcazione ferma. Quando
essa procede l’aria che le viene incontro (freccia viola) si combina col vento reale e forma il vento
apparente (freccia azzurra).
Elaborato da: http://www.abc-of-sailing.com/images/pics/wind.jpg
Si pensava dunque che il nostro pianeta fosse soggetto a un vento apparente di
etere la cui direzione e intensità dipendessero dal particolare movimento che la Terra
segue in ogni dato istante lungo la sua orbita, oltre che dalla rotazione su sé stessa. Il
vento dell’etere poteva quindi variare con l’ora del giorno e con la stagione. Siccome
si era stabilito che la luce si propagasse attraverso l’etere per azione meccanica,
anche la velocità di quest’ultima avrebbe dovuto mutare con l’ora e la stagione.
Misurare la velocità della luce secondo direzioni diverse e in istanti differenti avrebbe
insomma potuto rendere conto di come essa si propagasse nell’etere.
Tutto ciò sarebbe stato un po’ come procedere sull’acqua di un lago con un
idrovolante verso il punto in cui è caduto un sasso e poi tornare indietro, valutando
entrambe le volte dal velivolo la celerità delle onde generate dall’impatto.
Un’eventuale corrente del lago può fare in modo che la misura all’andata sia uguale a
quella ottenuta nel ritorno. Tuttavia, ripetendo la rilevazione con rotte di differente
orientamento o tracciato, si finisce per apprezzare un certo scarto nelle misure.
Esemplificazione: il lancio di una pietra nell’acqua di un lago. Le onde provocate dall’impatto
possono essere viste come una sorgente luminosa. Nel lago c’è una corrente che spinge l’acqua
verso il basso nello schema in pianta e che può essere considerata il vento d’etere. La corrente
trascina le onde generate dal sasso, così che le creste che avanzano verso l’alto sono più lente di
quelle che procedono verso il basso. Seguendo il percorso A dall’idrovolante potrebbe capitare di
misurare lo stesso ritmo di successione tra creste e avvallamenti all’andata e al ritorno. Ma questo
non può capitare lungo il percorso B, seguendo il quale il ritmo sarà senz’altro superiore
all’andata che al ritorno. Questa differenza tra i percorsi è di per sé stessa un’indicazione della
presenza di corrente. In generale, battendo vari tracciati (anche rettilinei) sopra le onde che si
propagano sulla superficie dell’acqua ci si può rendere conto della reale situazione, inquadrando
la velocità della corrente e quella di propagazione.
Grafica dell’autore.
I fisici si misero all’opera, stimolati anche dallo stesso Maxwell, ma per vari anni il
compito risultò semplicemente troppo difficile a livello tecnico. Per quanto elevata, la
velocità della Terra è sempre una piccola frazione di quella della luce. Questo
significava che occorrevano strumentazioni molto precise per rilevare gli scarti
cinetici che quasi tutti si aspettavano. Maxwell aveva sottolineato che la precisione
richiesta fosse di almeno una parte su 200 milioni. Solo nel 1887 fu approntato a
Cleveland negli Stati Uniti un apparato che poteva dare responsi attendibili e
sufficientemente accurati. I fautori erano Albert Abraham Michelson e Edward
Morley (unitosi in un secondo tempo). L’esperimento in oggetto è oggi considerato
uno dei più importanti dell’intera storia della fisica.
Michelson (1852-1931, a sinistra) e Morley (1838-1923, a destra). Dopo alcune prove fallite
nell’ambito della ricerca fisica, i due statunitensi riuscirono per primi a costruire un apparato di
misura che tagliasse la testa al toro relativamente alla questione dell’etere. Il loro esperimento è
oggi riconosciuto come uno dei più importanti della storia della fisica.
Michelson: http://www.sil.si.edu/digitalcollections/hst/scientific-identity/fullsize/SIL14-M004-01a.jpg
Morley: http://www.physics.gla.ac.uk/Physics3/Kelvin_online/Morley.gif
I due americani predisposero una lastra di arenaria galleggiante sopra del mercurio,
onde filtrare i possibili disturbi (traffico stradale) che potevano interferire con
l’esperimento. Sopra la pietra vi era un sistema di specchi multipli che faceva
percorrere alla luce proveniente da una sorgente al sodio (luce gialla) una distanza
complessiva di 22 metri, giudicata necessaria per ottenere la precisione richiesta.
L’intero sistema si fondava sul ricorso al fenomeno dell’interferenza.
Per capire le ragioni del ricorso a un apparato interferometrico dobbiamo
considerare che una precisione di una parte su 200 milioni valutata sul tempo di
percorrenza della luce in varie direzioni era a quei tempi improponibile. Michelson
decise pertanto di focalizzarsi sulle distanze percorse dalla luce, anziché sui tempi.
Ed è proprio in questo contesto che l’interferenza risultava critica.
L’interferenza avviene quando due o più onde si sovrappongono. Succede allora
che i picchi e gli avvallamenti si combinano tra loro, producendo delle tipiche
“frange d’interferenza”. Si tratta di un processo che può essere osservato anche sulle
onde dell’acqua, ad esempio quando gettiamo due sassi a distanza vicina, in modo
che le onde concentriche generate dall’impatto vadano a sovrapporsi. La luce
possiede un carattere ondulatorio e può quindi manifestare frange d’interferenza.
Come si presenta l’interferenza delle onde in acqua.
Elaborata da: http://www.exo.net/~pauld/lectures/patternscostarica/waterwaveinterfere1200.jpeg
I cosiddetti “arcobaleni soprannumerari” sono fenomeni d’interferenza luminosa.
http://epod.usra.edu/library/regnbuer.jpg
In sostanza, la luce emessa dalla sorgente incideva su di un vetro semiargentato
che in parte la rifletteva e in parte la lasciava passare. Il fascio di luce veniva così
diviso in due parti. L’orientamento del vetro era tale da far transitare i due raggi verso
due specchi tra loro perpendicolari che, a loro volta, li riflettevano completamente
indietro, di nuovo verso il vetro semiargentato. In tal modo i due raggi, dopo essere
stati divisi, tornavano a unirsi in un unico fascio che procedeva verso un rilevatore
ottico.
Ora, se i percorsi seguiti dalla luce fossero stati uguali nei due casi e se anche la
velocità della luce fosse stata la stessa, ebbene presso il rilevatore non si sarebbe
dovuta rimarcare alcuna frangia d’interferenza, giacché le onde sarebbero rimaste
perfettamente in fase. Viceversa, se le velocità fossero risultate differenti nelle due
direzioni (a parità di tragitto), allora si sarebbe generato uno sfasamento e quindi
un’interferenza. Siccome l’apparecchio aveva una precisione finita, possiamo dire
che nel primo caso si sarebbe prodotto uno sfasamento e quindi una frangia
d’interferenza minori che nel secondo.
"
#
'
(
&
'
(
"
#
"
$
! #
#
%
!
Schema della strumentazione usata da Michelson e Morley. Per semplicità non sono raffigurati gli
specchi intermedi che servono solo ad allungare il tragitto della luce (sino a 22 m). La sorgente di
luce emette un raggio verso lo specchio semiriflettente centrale che lo divide in due fasci: il fascio 1
viene riflesso, mentre il fascio 2 prosegue dritto. I due fasci rimbalzano poi sugli specchi esterni e
raggiungono nuovamente lo specchio centrale. Si ha una seconda semiriflessione. Così, una
porzione di luce di entrambi i fasci viaggia verso l’oculare di rilevazione. Se le velocità della luce
nelle due direzioni perpendicolari variano una rispetto all’altra nel corso della prova, allora
presso l’oculare si dovrebbe riscontrare uno sfasamento più o meno intenso delle onde e quindi
un’alterazione della figura d’interferenza (frange). I fisici del tempo ritenevano che le ragioni per
cui le velocità dovevano cambiare andassero imputate al vento dell’etere che in vari istanti della
giornata soffiava in direzione differenti (a causa della rotazione del pianeta), influenzando in tal
modo la propagazione luminosa.
Grafica dell’autore.
Come spiegato, si pensava che a influire sulla velocità della luce fosse il vento
dell’etere. L’orientamento dell’apparecchio di Michelson e Morley e il momento
della giornata (rotazione terrestre) stabilivano pertanto fattori discriminanti. La lastra
di pietra, una volta posta in movimento, poteva ruotare per ore e molto lentamente sul
mercurio; ciò consentiva di ottenere vari orientamenti, senza toccare la
strumentazione e leggendo le misure a prefissati intervalli di tempo. La lenta
rotazione dell’apparecchio unita a quella del pianeta determinava differenti
combinazioni tra i fasci di luce e il presunto vento dell’etere.
Le letture vennero effettuate due volte al giorno, a mezzogiorno e alle sei del
pomeriggio. L’esperimento venne protratto per vari giorni. Ci si aspettava uno
sfasamento massimo di una certa entità con conseguente variazione delle frange
d’interferenza nel corso del tempo. Quale fu dunque l’esito? Ebbene, Michelson e
Morley non rilevarono alcuno spostamento. Presso il rilevatore la situazione era
insomma sempre la stessa. Nel corso dei decenni la prova è stata condotta anche con
strumenti molto più precisi, ma i risultati sono ancor oggi i medesimi.
Tutto questo ha un significato fondamentale: l’etere non esiste! Maxwell aveva
dunque ragione e le sue equazioni raccontavano la verità. Le onde elettromagnetiche
non hanno bisogno di alcun mezzo per propagarsi e viaggiano nel vuoto a una
velocità insuperabile che vale c = 299'
792 km/s e che è indipendente dalla sorgente e
dall’osservatore. La condizione può apparire strana, ma così ha decretato Madre
Natura che, evidentemente, non aborrisce affatto il vuoto, come invece pensavano gli
aristotelici. Il concetto di campo non venne dunque rimosso e, anzi, è oggi dominante
nella fisica.
Il responso dell’esperimento di Michelson e Morley fu in fondo un fallimento,
perché molti si aspettavano una scarto nelle velocità della luce. Qualcuno suppose
ancora che il mancato riscontro dipendesse dall’insufficiente precisione dell’apparato
impiegato. Tuttavia, col tempo e col migliorare della tecnica emerse in modo chiaro
anche per gli irriducibili che si trattava di un fatto sostanziale, non di una questione di
accuratezza strumentale. La circostanza aprì gli occhi ai fisici, delineando una realtà
ben diversa da quanto ci si aspettasse. In questo senso la prova fu decisiva per fare
avanzare la scienza.
Tutto questo significava forse che Galileo aveva torto? In un certo senso è proprio
così, ma in un altro senso la sua teoria restava in auge. Oggi sappiamo che quando le
velocità sono basse la loro composizione è perfettamente valida: si pensi all’esempio
precedente del treno e dell’uomo che corre al suo interno. In questi termini la
relatività galileiana è quella che fa testo. Tuttavia, quando le velocità iniziano a essere
frazioni non trascurabili di quella della luce, allora la regola della semplice
composizione (o della somma algebrica se le velocità hanno la stessa direzione e lo
stesso verso) diventa fallace.
Se di notte lanciamo con una torcia un raggio di luce all’interno di un treno che
passa veloce a fianco di una stazione, ebbene da quest’ultima un osservatore non
vedrà che il raggio avanza a una velocità superiore a quella della luce; vedrà invece
ch’esso prosegue proprio alla velocità della luce (come dall’interno del treno), anche
se è su un mezzo in movimento.
)
*+
+
*
Un uomo corre sul tetto di un treno a una velocità *+ rispetto al tetto, mentre il treno prosegue sui
binari a una velocità + rispetto ai binari. Nel caso classico (galileiano) la velocità dell’uomo
rispetto ai binari è data da: VUB = *++ + . Nel caso relativistico, cioè per velocità molto elevate
(frazioni significative della velocità della luce) la sommatoria non è più corretta e occorre invece
applicare una formula più complessa, tale per cui risulta sempre: VUB < *++ + . In altre parole,
la velocità dell’uomo rispetto ai binari è sempre inferiore a quella somma. Per la precisione,
risulta tanto più inferiore a quella somma, quanto più le due velocità ( *+ e + ) sono elevate.
Infatti, la velocità della luce non può essere superata. Ad esempio, nel caso l’uomo corra rispetto al
tetto a una velocità *+pari alla velocità della luce, la stessa velocità sarà rilevata anche dai
binari. Anche se ad avanzare alla velocità della luce è il treno l’uomo si sposterà alla velocità
rispetto ai binari, qualunque sia la sua velocità *+rispetto al tetto del treno.
www.naturamediterraneo.com/Public/data3/stekal/0002%20treno%20.jpg_200631919711_0002%20treno%20.jpg
Grafica dell’autore.
Come si fa allora a combinare le velocità in quest’ultimo caso? In effetti, era
questa una delle domande cruciali che sottostavano alla scoperta di Michelson e
Morley. A indagare sulla questione nel modo più prolifico, mentre lavorava presso un
ufficio brevetti di Berna in Svizzera, fu un giovane tedesco (poi naturalizzato
svizzero) di origine ebrea di nome Albert Einstein, forse il massimo scienziato del
secolo appena passato.
Einstein comprese molto bene che se la velocità della luce era una grandezza
invariante e insuperabile le leggi fisiche non potevano restare quello che erano nella
letteratura dell’epoca e che occorressero degli aggiustamenti. In effetti, la relatività di
Einstein è un’estensione di quella galileiana che è in fondo solo un caso speciale che
vale per velocità basse. La legge generale non è dunque quella di Galileo, bensì
quella di Einstein. Nel 1905 Einstein pubblicò la “relatività ristretta”, coniugando
l’elettromagnetismo con la meccanica per osservatori in moto uno rispetto all’altro.
Ma i fenomeni elettromagnetici e meccanici restavano ben distinti.
Albert Einstein (1879-1955) esordì dall’evidenza sperimentale di Michelson e Morley per
formulare la teoria della “relatività ristretta”, valida per osservatori inerziali, e poi per estendere
il ragionamento alla “relatività generale”, valida anche per osservatori soggetti alla gravità.
http://hep.fi.infn.it/wyp2005/img/einstein.jpg
Quella relatività è detta “ristretta”, perché si riferisce a osservatori inerziali, cioè
che si spostano uno rispetto all’altro, ma senza accelerare, decelerare o cambiare
direzione (moto rettilineo uniforme). La “relatività generale”, sempre per opera di
Einstein, sarebbe stata pubblicata nel 1915, inglobando nella teoria anche gli
osservatori immersi nei campi gravitazionali e quindi accelerati. Le conseguenze
delle leggi einsteiniane sono finora state verificate dagli esperimenti e sono a dir poco
mirabolanti. Ma questa è un’altra storia.
Roberto Weitnauer