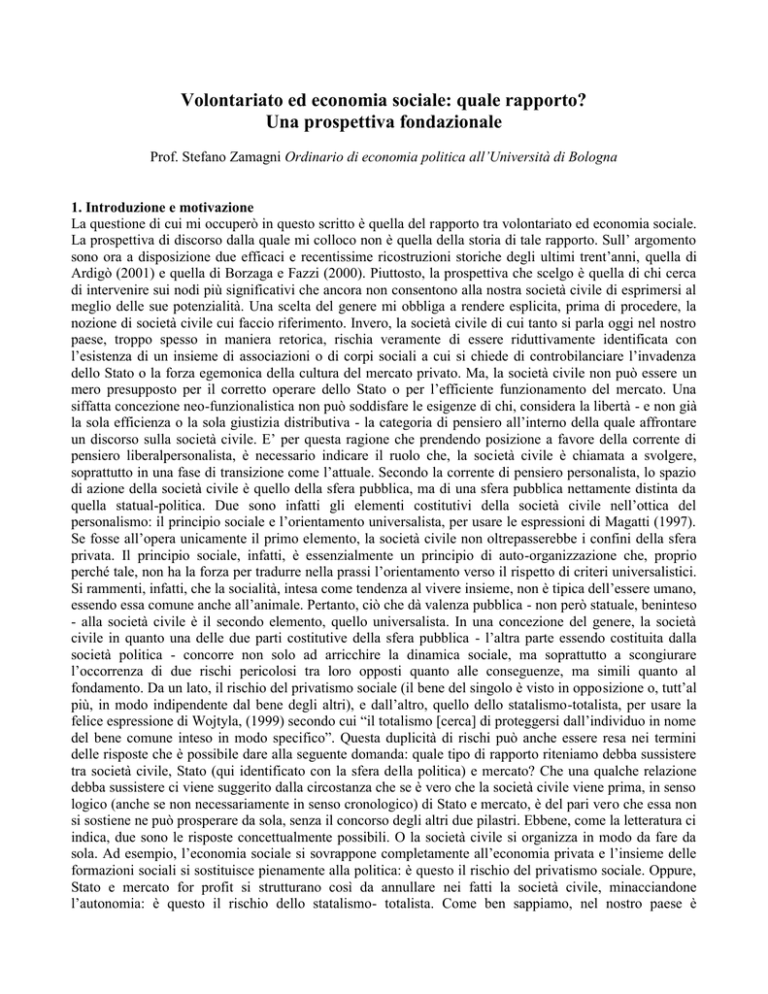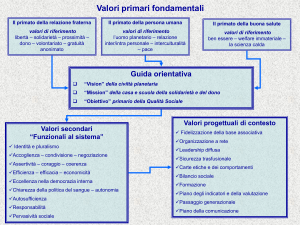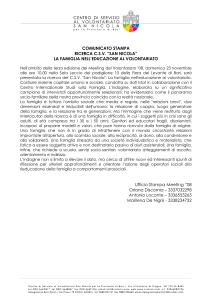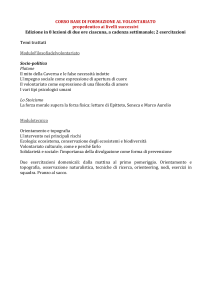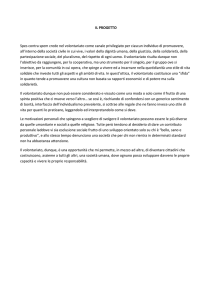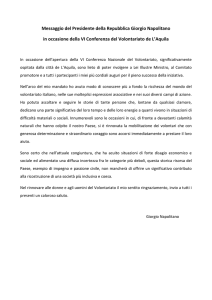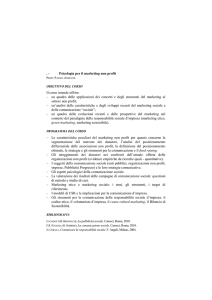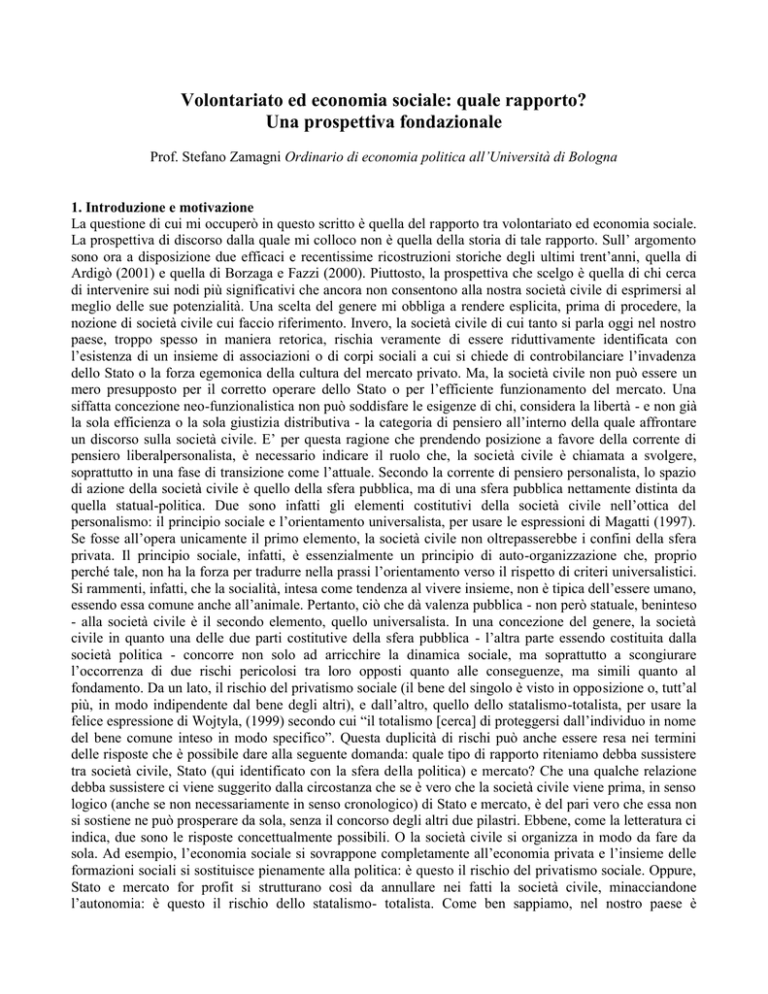
Volontariato ed economia sociale: quale rapporto?
Una prospettiva fondazionale
Prof. Stefano Zamagni Ordinario di economia politica all’Università di Bologna
1. Introduzione e motivazione
La questione di cui mi occuperò in questo scritto è quella del rapporto tra volontariato ed economia sociale.
La prospettiva di discorso dalla quale mi colloco non è quella della storia di tale rapporto. Sull’ argomento
sono ora a disposizione due efficaci e recentissime ricostruzioni storiche degli ultimi trent’anni, quella di
Ardigò (2001) e quella di Borzaga e Fazzi (2000). Piuttosto, la prospettiva che scelgo è quella di chi cerca
di intervenire sui nodi più significativi che ancora non consentono alla nostra società civile di esprimersi al
meglio delle sue potenzialità. Una scelta del genere mi obbliga a rendere esplicita, prima di procedere, la
nozione di società civile cui faccio riferimento. Invero, la società civile di cui tanto si parla oggi nel nostro
paese, troppo spesso in maniera retorica, rischia veramente di essere riduttivamente identificata con
l’esistenza di un insieme di associazioni o di corpi sociali a cui si chiede di controbilanciare l’invadenza
dello Stato o la forza egemonica della cultura del mercato privato. Ma, la società civile non può essere un
mero presupposto per il corretto operare dello Stato o per l’efficiente funzionamento del mercato. Una
siffatta concezione neo-funzionalistica non può soddisfare le esigenze di chi, considera la libertà - e non già
la sola efficienza o la sola giustizia distributiva - la categoria di pensiero all’interno della quale affrontare
un discorso sulla società civile. E’ per questa ragione che prendendo posizione a favore della corrente di
pensiero liberalpersonalista, è necessario indicare il ruolo che, la società civile è chiamata a svolgere,
soprattutto in una fase di transizione come l’attuale. Secondo la corrente di pensiero personalista, lo spazio
di azione della società civile è quello della sfera pubblica, ma di una sfera pubblica nettamente distinta da
quella statual-politica. Due sono infatti gli elementi costitutivi della società civile nell’ottica del
personalismo: il principio sociale e l’orientamento universalista, per usare le espressioni di Magatti (1997).
Se fosse all’opera unicamente il primo elemento, la società civile non oltrepasserebbe i confini della sfera
privata. Il principio sociale, infatti, è essenzialmente un principio di auto-organizzazione che, proprio
perché tale, non ha la forza per tradurre nella prassi l’orientamento verso il rispetto di criteri universalistici.
Si rammenti, infatti, che la socialità, intesa come tendenza al vivere insieme, non è tipica dell’essere umano,
essendo essa comune anche all’animale. Pertanto, ciò che dà valenza pubblica - non però statuale, beninteso
- alla società civile è il secondo elemento, quello universalista. In una concezione del genere, la società
civile in quanto una delle due parti costitutive della sfera pubblica - l’altra parte essendo costituita dalla
società politica - concorre non solo ad arricchire la dinamica sociale, ma soprattutto a scongiurare
l’occorrenza di due rischi pericolosi tra loro opposti quanto alle conseguenze, ma simili quanto al
fondamento. Da un lato, il rischio del privatismo sociale (il bene del singolo è visto in opposizione o, tutt’al
più, in modo indipendente dal bene degli altri), e dall’altro, quello dello statalismo-totalista, per usare la
felice espressione di Wojtyla, (1999) secondo cui “il totalismo [cerca] di proteggersi dall’individuo in nome
del bene comune inteso in modo specifico”. Questa duplicità di rischi può anche essere resa nei termini
delle risposte che è possibile dare alla seguente domanda: quale tipo di rapporto riteniamo debba sussistere
tra società civile, Stato (qui identificato con la sfera della politica) e mercato? Che una qualche relazione
debba sussistere ci viene suggerito dalla circostanza che se è vero che la società civile viene prima, in senso
logico (anche se non necessariamente in senso cronologico) di Stato e mercato, è del pari vero che essa non
si sostiene ne può prosperare da sola, senza il concorso degli altri due pilastri. Ebbene, come la letteratura ci
indica, due sono le risposte concettualmente possibili. O la società civile si organizza in modo da fare da
sola. Ad esempio, l’economia sociale si sovrappone completamente all’economia privata e l’insieme delle
formazioni sociali si sostituisce pienamente alla politica: è questo il rischio del privatismo sociale. Oppure,
Stato e mercato for profit si strutturano così da annullare nei fatti la società civile, minacciandone
l’autonomia: è questo il rischio dello statalismo- totalista. Come ben sappiamo, nel nostro paese è
quest’ultima la risposta che finora è prevalsa, a livello anche istituzionale, ma nulla impedisce di pensare
che in futuro possa essere l’altra alternativa a prevalere. La sfida da raccogliere deve allora essere quella di
disegnare un percorso di ricerca al termine del quale entrambi i rischi possano essere scongiurati. Ciò
chiarito, possiamo riprendere il filo del discorso.
2. I fronti odierni di attacco al volontariato
Perché si pone, oggi, un problema di rapporto tra volontariato e economia sociale? Non è difficile trovare la
risposta. Il fatto è che dopo gli straordinari successi dei decenni passati, durante i quali il volontariato
italiano si è imposto con la forza dei numeri e dei riconoscimenti legislativi, oggi tale realtà si trova sotto
attacco su un duplice fronte. Da un lato, l’irrompere sulla scena politico-economica delle organizzazioni
dell’economia sociale - dalle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle associazioni di promozione
sociale - sta diffondendo il convincimento secondo cui del volontariato una società avanzata possa fare a
meno. L’argomento, in buona sostanza, è che del volontariato si avrebbe bisogno solamente nelle fasi
iniziali del processo di crescita della società civile; dopodiché esso conserverebbe un valore tutt’al più
simbolico. Rivelatore di tale linea di pensiero è il fatto che il recente censimento ISTAT sul mondo non
profit (reso pubblico nell’agosto 2001) abbia scelto quale oggetto di indagine privilegiato l’ente non profit
produttivo, ponendosi l’obiettivo di giungere ad identificare la presenza in Italia di un vero e proprio
fenomeno di imprenditorializzazione all’interno del terzo settore. Chiaramente, il volontariato può essere
tutto fuorché una forma nuova di imprenditorialità. Dall’altro lato, in non pochi ambienti serpeggia la
preoccupazione che l’azione volontaria, se troppo esaltata, possa alla lunga spiazzare l’azione politica,
conducendo la società italiana verso un modello di community without
politics. In altro modo, la preoccupazione è che il volontariato possa ritardare la piena espressione della
cittadinanza democratica attiva, la quale sola assicurerebbe l’attenzione alla persona qua cittadino, mentre il
volontariato - centrato come è sul principio del dono - si rivolgerebbe al prossimo. Solamente alla luce di
una tale preoccupazione si possono spiegare affermazioni apodittiche del tipo di quelle di Luigi Ciotti
(“Sogno che in futuro non ci sia più bisogno del volontariato”, Rivista del Volontariato, giugno, 1998, p.17)
oppure di padre Giuseppe Bettoni (“Suggerisco di dimenticare la figura del volontariato e di pensare solo a
quella del cittadino solidale, detentore di uno stile di vita che lo porta a impegnarsi ovunque, non solo nelle
poche ore di lavoro in associazione”, Vita , 21 dicembre 2001, p.8). Sulla stessa linea si muovono non pochi
illustri studiosi della realtà sociale, secondo i quali la presenza in un paese di un robusto e vitale
volontariato segnalerebbe una carenza di cittadinanza democratica. Ebbene, quando un soggetto sociale
come il volontariato si trova di fronte ad attacchi del genere non v’è altra via che quella di andare ai
fondamenti della questione. E’ perfettamente inutile cercare accomodamenti di compromesso; ancora più
inutile tentare linee di difesa basate sull’evidenza dei fatti o sulla dimostrazione di ciò che il volontariato
riesce a conseguire in determinate circostanze. La tesi che sostengo, in netta controtendenza rispetto
all’opinione oggi dominante, è che il volontariato è, nelle attuali condizioni storiche, ancora più
indispensabile che non durante la lunga stagione della modernità. Infatti, il compito specifico che il
volontariato è chiamato ad assolvere è quello di rifondare la società civile intesa alla maniera di cui si è
detto nel precedente paragrafo, vale a dire il compito di operare affinché l’universalità dei diritti e dei
doveri della persona possa prevalere sul principio, di per sé statico, di cittadinanza. Per dirla con Donati
(1997), missione propria del volontariato è quella di espandere lo spazio del civilizzato, il quale sta “nel
saper riconoscere e gestire il legame sociale, secondo forme e contenuti che rigenerino il legame sociale”
(p.72). Ma a quali condizioni un compito del genere può essere realizzato? Due, in particolare. La prima è
che il volontariato deve trovare il modo di riaffermare la propria identità, la quale non può ridursi alla sola
gratuità del dono. A scanso di equivoci conviene sottolineare, sin da ora, che la gratuità è condizione bensì
necessaria ma non sufficiente a definire, (cioè, letteralmente, a dare una direzione, produrre un senso per) il
volontariato. Si tenga infatti presente il cosiddetto “paradosso del volontariato”: una società in cui tutti (o
anche una larga maggioranza) fossero dei donatori gratuiti non sarebbe sostenibile. Tanto è vero che molte
Banche del Tempo non funzionano - come opportunamente documenta Coluccia (2001, p.104) - perché tutti
vogliono dare e nessuno è disposto o interessato a chiedere! Il punto è che - come vedremo più avanti - il
vero meccanismo donativo postula una particolare forma di reciprocità. La seconda condizione che il
volontariato deve soddisfare è quella di trovare il modo né di confondersi con l’economia sociale, né di
tenersi da essa separato. Per dirla in forma positiva: il volontariato deve mantenere rapporti di “buon
vicinato” con i vari soggetti dell’economia sociale, ma al tempo stesso deve da questi differenziarsi. Quanto
a dire che il volontariato - nonostante le opinioni contrarie in proposito - non appartiene al terzo settore,
perché diversa è la sua logica di azione e soprattutto perché il suo fine specifico è la generazione di nessi e
di reti di relazionalità tra gli uomini. Prova tangibile di quanto grande sia ancora la confusione su questo
punto, perfino tra gli stessi addetti ai lavori, è quella che ci viene dalla recentissima ricerca promossa dalle
United Nations Volunteers, nell’occasione dell’Anno Internazionale dei Volontari, e realizzata
dall’organizzazione statunitense Independent Sector. Se si legge il rapporto di Kofi Hannan alla 56a
assemblea generale delle Nazioni Unite (5 dicembre 2001), si troverà l’affermazione, supportata da dati
statistici, secondo cui “il volontariato contribuisce alla formazione del prodotto nazionale lordo”. Non ci
vuol molto a comprendere come posizioni del genere abbiano un solo esito certo: quello di annientare la
fisionomia propria del volontariato e decretarne la lenta eutanasia. Tanto è vero che Salamon e Anheir nel
loro recente Global Civil Society (1999) parlano del volontariato come “fattore di riserva” a disposizione
dei vari soggetti dell’economia sociale, negando, con ciò stesso, la sua propria specificità.
3. Perché non è corretto l’uso che se ne fa delle espressioni “non profit” e “terzo settore”
Prima di passare a difendere la tesi sopra enunciata e a discutere delle due condizioni di fattibilità, ritengo
opportuno premettere una precisazione importante. In quel che segue parlerò sempre di organizzazioni della
società civile (OSC) e non di organizzazioni non profit, né di terzo settore. La ragione è basicamente che
non esiste (perché non può esistere) una teoria generale delle organizzazioni non profit, una teoria cioè
capace di rappresentare il modo di operare di tali enti quale che sia il contesto storico e culturale in cui sono
inseriti. Infatti, nonostante la più accreditata letteratura anglosassone in argomento lasci credere il contrario
- si pensi ai lavori di Hansmann, Weisbrod, Rose-Ackermann, ecc.1 - il modus agendi di tali organizzazioni
è specifico ad un particolare contesto locale, il quale influisce sia sui sistemi motivazionali che stanno alla
base dei comportamenti degli agenti sia sulle performances delle organizzazioni stesse. Un solo esempio per
chiarire il punto. Si pongano a confronto l’ambiente USA e quello Europeo. Come è ampiamente noto, nella
società americana lo Stato come istituzione sociale non ha mai giocato un ruolo determinante nella
caratterizzazione dell’ordine sociale, il quale è assai più robustamente plasmato dal mercato, identificato
con il mondo del for profit. Ne deriva che un’organizzazione che voglia differenziarsi sul piano dell’agire
dal modo prevalente di produzione non può che chiamarsi non profit. In altri termini, le organizzazioni non
profit si connotano, in un tale contesto, come non mercato. Non è privo di interesse ricordare che negli USA
la gran parte delle organizzazioni non profit sono nate per iniziativa di imprenditori for profit e non già di
associazioni, di un tipo o dell’altro, come in Europa e in Italia in particolare. Nel 1864, Jean Henri Dunant che diverrà poi il primo Nobel per la pace nel 1901 - fonda la Croce Rossa e successivamente la World’s
Young Men’s Christian Association. Nel 1892, John Muir, altro ben noto imprenditore, fonda il Sierra
Club. Si pensi ancora al re dell’acciaio A. Carnegie e alle organizzazioni non profit da lui fondate, tra cui un
ospedale e un’università. In anni più recenti, Michael Brown e Alan Khazei danno vita al “City Year” a
favore dei giovani, mentre Wendy Kopp fonda il “Teach for America” per aiutare gli studenti in posizione
di svantaggio. E così via con moltissimi altri esempi: basti pensare che le università e gli ospedali non profit
- che costituiscono la grande maggioranza di tali enti negli USA - sono denominati con il nome del loro
fondatore o benefattore, quasi sempre uomini di affari. Si consideri ora l’Europa, un contesto nel quale da
tempo lo Stato va esercitando un ruolo importante nella sfera sia economica sia sociale. Il welfare state è
un’invenzione tipicamente europea, come tutti sanno. In un contesto culturale del genere, allora,
l’antagonista con cui confrontarsi dialetticamente è lo Stato e non già il mercato; e dunque
un’organizzazione che voglia differenziare il proprio modo di fornitura dei servizi di welfare da quello
pubblico-statuale non ha senso che si definisca non profit - anche gli enti pubblici sono enti non profit -; si
chiamerà piuttosto organizzazione di terzo settore. E’ precisamente per queste ragioni che in Europa tali
organizzazioni si caratterizzano, in primis, come non- Stato, anche se la definizione corrente è “né Stato, né
mercato”. Ecco perché non si potrà mai giungere ad una teoria generale delle OSC: in tale ambito di studio,
le teorie, al pari dei nomina, sunt consequentia rerum. Non così, invece, per la teoria dell’impresa o delle
organizzazioni capitalistiche, le quali esprimono una medesima logica di azione quale che sia il contesto di
riferimento. Quest’ultimo inciderà, semmai, sui sistemi di vincoli cui l’impresa è sottoposta nel
perseguimento del suo obiettivo. D’altro canto, una OSC non potrà mai articolare la propria strategia di
intervento prescindendo dalla conoscenza puntuale della motivazione intrinseca di coloro che ne fanno
parte, una motivazione difficilmente riconducibile all’individualismo assiologico, e collegata piuttosto ad
una logica, di identificazione con valori e principi ideali che sono propri di una determinata matrice
culturale. Riusciamo così a comprendere perché non è corretto, sotto il profilo metodologico, parlare di non
profit oppure di terzo settore qualora, sotto tali espressioni, si voglia ricomprendere l’intero universo delle
OSC. Quella di “organizzazione della società civile” è invece un’espressione neutrale che è in grado di
includere al proprio interno sia il paradigma per settori tipico della realtà europea, sia il paradigma
americano secondo cui la forma normale di attività economica è quella del for profit. A quest’ultimo
riguardo, giova riferire il pensiero di un autorevole studioso americano, Michael Piore del celebre MIT.
Dopo aver definito “intermediari sociali” le istituzioni e i soggetti che si è soliti raggruppare sotto
l’espressione di organizzazioni non profit, Piore scrive: “Queste non sono istituzioni che normalmente
pensiamo come centrali nell’effettivo funzionamento di un’economia capitalistica” (2001, p.339). E se il
non profit non è centrale, vuol dire che è residuale, e pertanto che di esso si può fare a meno qualora il buon
funzionamento dell’economia capitalistica possa essere assicurato in altro modo. Sulla medesima falsariga
si muove Hansmann quando molto onestamente riconosce che quelle non profit sono “transitional
organizations” (organizzazioni transitorie). Come è ormai noto, l’argomento è che in un mondo di mercati
perfetti, l’esistenza di opportune strutture di incentivi capaci di indurre tutti gli agenti a rispettare le regole
del gioco e ad alimentare nessi di fiducia, il non profit non avrebbe alcun ruolo specifico da assolvere. In
altro modo, la ragion d’esistere del non profit è in una duplice tipologia di fallimenti: quelli del mercato e
quelli dello Stato. Nella misura in cui le situazioni generatrici di tali fallimenti scompaiono o possono essere
corrette con gli strumenti tipici della logica for profit, in quella stessa misura le organizzazioni non profit
diventano irrilevanti e dunque devono cedere il passo alle strutture for profit, pena la conservazione nel
sistema di pericolose posizioni di rendita. Un’ulteriore prova dell’opportunità di andare oltre il binomio
terzo settore/non profit e di parlare, invece, di OSC ci viene dalla seguente considerazione di fatto. Si
prenda un paese come la Cina. Avrebbe senso applicare alla realtà di questo paese le espressioni non profit
oppure terzo settore per cercare di interpretare il risveglio (sia pure ancora timido) di quella società civile?
Certamente no, perche in Cina non esiste (ancora?) un settore profit, in senso occidentale, e quindi le nuove
forme organizzative che finalmente vanno nascendo anche in quel paese dovrebbero, semmai, chiamarsi
“secondo settore”. Del tutto simile il discorso che si potrebbe fare a proposito delle organizzazioni non
governative (ONG), una realtà questa in continua e rapida crescita in questa stagione di globalizzazione. Si
può correttamente affermare che le ONG appartengono al terzo settore? Chiaramente no e ciò per la
semplice ragione che, per natura sua, una ONG è un soggetto transnazionale e dunque non può essere terzo,
dopo lo Stato e il mercato. Eppure, nessuno potrà negare che il volontariato internazionale di advocacy
costituisce oggi un elemento di assoluta novità, oltre che di straordinaria vitalità, della società civile
transnazionale che reclama una sua propria collocazione concettuale.
4. Sull’identità propria del volontariato
Si è scritto, nel paragrafo precedente, che missione specifica del volontariato, nelle attuali condizioni
storiche, è quella di concorrere a rifondare la società civile e che per risultare all’altezza di un tale compito
la prima condizione che esso deve soddisfare è una ricalibratura della propria identità. Possiamo
accontentarci della definizione di volontariato oggi prevalente in sede sia italiana sia internazionale, basata
sui tre principi canonici della gratuità delle prestazioni; della spontaneità dell’azione (cioè della libera
scelta); del beneficio arrecato ad una terza parte? Non lo credo proprio e ciò per le seguenti ragioni, che
espongo in ordine crescente di rilevanza. In primo luogo, occorre indicare con precisione cosa debba
intendersi per gratuità. Vuol forse dire che il volontario non riceve remunerazione alcuna né in denaro né in
natura? Non basta. Infatti, non pochi sono i casi di soggetti che decidono di svolgere gratuitamente una
certa attività per un determinato lasso di tempo presso una organizzazione di volontariato (OV) in cambio
della promessa, ovviamente non formalizzata, di una sistemazione lavorativa successiva. E che dire delle
situazioni, tutt’altro che infrequenti, del professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico, ecc.) che
si avvale dell’attività svolta gratuitamente in qualità di volontario presso una OV come investimento
specifico in reputazione? Come si sa, la reputazione è un vero e proprio asset patrimoniale che può essere
accumulato o decumulato e che conferisce al suo possessore il godimento di una specifica rendita di
posizione. Non ci vuol tanto a comprendere come in casi del genere la gratuità possa diventare facile
paravento per fini non propriamente disinteressati. In buona sostanza, il non pagamento delle prestazioni
non assicura, di per sé, la gratuità, la quale è essenzialmente una virtù, cioè una disposizione d’animo. E’
dunque condivisibile quanto dichiara S. Siniscalchi, segretaria nazionale di Mani Tese: “ Azione gratuita ...
non significa solo fare le cose gratis, ma ritagliare la propria libertà rispetto alla logica del mercato e
dell’utilitarismo ... [Si tratta cioè di affermare il] concetto della condivisione e della partecipazione al
processo di cambiamento in coerenza con lo stile di vita personale”. (Rivista del Volontariato, ottobre 2001,
p.42). Quanto a dire che se opero in una OV senza ricevere corrispettivo alcuno, ma il mio modo di agire è
quello tipico di chi opera in un’impresa for profit - ad esempio, perché l’efficienza è l’unico mio criterio di
azione - il canone della gratuità non è rispettato. In secondo luogo, è necessario dire, in termini positivi, del
modo in cui una OV persegue l’obiettivo di arrecare beneficio a terzi. Se un certo numero di persone ben
intenzionate e ben disposte verso gli altri, cioè altruiste, decidono di dare vita ad un’organizzazione alla
quale forniscono gratuitamente risorse di vario tipo per “far cose” a favore di determinate tipologie di
portatori di bisogni, questa sarà un’organizzazione filantropica, certamente benemerita e socialmente utile,
ma non ancora per ciò stesso una OV. La specificità di quest’ultima - come si è detto - è la costruzione di
nessi di relazionalità fra persone. Laddove l’organizzazione filantropica fa per gli altri, l’OV fa con gli altri.
E’ proprio questa caratteristica che differenzia l’azione autenticamente volontaria, tipica delle OV, dalla
beneficenza privata, tipica della filantropia. Infatti, la forza del dono gratuito non sta nella cosa donata o nel
quantum donato - così è invece nella filantropia, tanto è vero che esistono le graduatorie o le classifiche di
merito filantropico - ma nella speciale qualità umana che il dono rappresenta per il fatto di essere relazione.
In altri termini, mentre la filantropia genera quasi sempre dipendenza nel destinatario dell’azione
filantropica, il volontariato autentico genera invece reciprocità e quindi libera colui che è il destinatario
dell’azione volontaria dalla “vergogna” di cui parla Seneca nella X Lettera a Lucilio: “La pazzia umana è
arrivata al punto che fare grandi favori a qualcuno diventa pericolosissimo: costui, infatti, perché ritiene
vergognoso non ricambiare, vorrebbe togliere di mezzo il suo creditore. Non c’è odio più funesto di quello
che nasce dalla vergogna di aver tradito un beneficio”. Non è propriamente volontaria l’azione di chi, al di
là delle intenzioni soggettive, tende a generare nel beneficiario dipendenza o obbligazioni di sorta. Se chi
riceve gratuitamente, non viene posto nelle condizioni concrete di reciprocare, in qualche misura e in
qualche forma, costui finirà per sentirsi umiliato e alla lunga finirà con l’odiare il suo benefattore, come
appunto ci ricorda Seneca. E’ questa la mia interpretazione della recente dichiarazione di Giancarlo
Bregantini, vescovo di Locri: “Il frutto più maturo della solidarietà, infatti, è la reciprocità. Senza
reciprocità, la solidarietà è sempre un pò, perbenista, perché ti dà quel senso di soddisfazione per le cose
belle che hai fatto per l’altro. Diventa invece autentica quando tu ricevi dall’altro, quando in un dono fatto
c’è un dono accolto”. (Rivista del Volontariato, ottobre 2000, p.14). Quanto precede mi introduce alla terza
delle ragioni di insoddisfazione nei confronti della concettualizzazione corrente di volontariato. Scrive
Romano Guardini in un saggio giustamente famoso: “La persona umana non può comprendersi come chiusa
in se stessa, perché essa esiste nella forma di una relazione. Seppure la persona non nasca dall’incontro, è
certo che si attua solo nell’incontro” (1964, p.90). Come a dire che l’essere umano si scopre nel rapporto
interpersonale e dunque che il suo bisogno fondamentale è quello di reciprocità. A sua volta, la reciprocità
può nascere dalla pratica del dono oppure dallo scambio di equivalenti, cioè dal contratto. Nella reciprocità
che nasce dal dono, l’apertura all’altro - una apertura che può assumere le forme più varie, dall’aiuto
materiale a quello spirituale - determina una modificazione dell’io che, nel suo rientro verso la propria
interiorità, si trova più ricco per 1’incontro avvenuto. Non così invece nella reciprocità che nasce dal
contratto, il cui principio fondativo è piuttosto la perfetta simmetria tra ciò che si dà e ciò che si può
pretendere di ottenere in cambio. Tanto è vero che è a causa di tale proprietà che la forza della legge può
sempre intervenire per dare esecutorietà alle obbligazioni nate per via contrattuale. Ebbene, l’identità
propria e fondamentale del volontariato è nel dono che genera reciprocità. L’uscita dell’io verso un tu di cui
sempre si ha bisogno è ciò che definisce la gratuità dell’ azione volontaria. Perché è massimamente
importante definire la gratuità del volontariato nei termini di cui sopra? Per la ragione che, come la scuola
del MAUSS2 ha chiarito a tutto tondo, c’è una concezione del dono tipica della premodernità, ma che
continua a sussistere ancora in alcuni strati delle nostre società contemporanee, secondo cui il dono va
ricondotto sempre ad una soggiacente struttura di scambio. E’ questa la concezione del dono come munus,
come strumento per impegnare l’altro, fino ad asservirlo3. Secondo tale concezione, si ha che il dono
diventa, paradossalmente, un obbligo per preservare il legame sociale: la vita in società postula di necessità
la pratica del dono, la quale diventa per ciò stesso una norma sociale di comportamento, vincolante al pari
di tutte le norme di tale tipo. Non ci vuol molto a comprendere come una tale concezione del dono non salvi
né la spontaneità né la vera gratuità dell’azione volontaria, dimenticando che il segreto del volontariato sta
nella potenza del voluto che si contrappone alla fragilità del dovuto, anche se il dovuto proviene da
tradizioni consolidatesi nel corso del tempo oppure da norme sociali-tradizioni e norme sociali che spesso
sono più vincolanti delle stesse norme legali. Eppure, per strano che ciò possa apparire, è un fatto che nel
nostro paese è ancora radicata l’idea in base alla quale il volontariato genuino è quello che si appoggia sulla
nozione di dono come munus. Come darsi conto delle difficoltà che molti (pure seriamente impegnati nel
volontariato) hanno di comprendere che l’autentica gratuità è quella del dono come reciprocità? Duplice la
risposta che riesco a darmi. La prima è che la relazione di reciprocità continua ad essere confusa con quella
di scambio di equivalenti. Il fatto è che la nostra cultura è talmente intrisa di economicismo che ogni
qualvolta sentiamo parlare di relazione biunivoca tra due soggetti siamo istintivamente portati a leggervi un
sottostante, sia pure indiretto, rapporto di scambio di equivalenti. E’ questa una delle pesanti eredità
intellettuali della modernità. “Perché vi sia dono - scrive Jacques Derrida - bisogna che il dono non appaia,
che non sia percepito come dono” (1996, p.18). Ma un tale dono non può esistere, è impossibile perché
l’uomo è un essere ontologicamente auto-interessato, cioè egocentrico. La modernità vede il dono come una
sorta di assoluto che, però, essa stessa dichiara impossibile. L’unico atteggiamento possibile è quello della
beneficienza privata, cioè della filantropa, che, come si è detto, è perfettamente compatibile con l’assunto
antropologico del self-interest. La seconda risposta all’interrogativo sopra posto è che non si riesce ancora a
capire come la categoria del dono ricomprenda al suo interno la dimensione dell’interesse. Invero, il termine
interesse - dal latino “inter-esse” - significa propriamente “essere in mezzo” e ciò a significare che per
perseguire un interesse bisogna interagire con l’altro, utilizzandosi reciprocamente perché ne derivino frutti
a entrambi. Eppure, la concezione oggi dominante di interesse si è talmente allontanata dal suo significato
originario che quando questo termine viene usato esso viene quasi sempre inteso con connotazioni negative
sotto il profilo morale. Ma la verità è che il dono non è affatto incompatibile con l’interesse del donante, se
questo viene inteso come interesse a stare nella relazione con l’altro. Il filantropo, invece, non ha questo
interesse, tanto è vero che il filantropo puro (quello che vuole conservare l’anonimato) neppure vuol
conoscere l’identità di coloro ai quali la sua beneficienza si indirizza. E non v’è dubbio che l’atto
filantropico sia un atto gratuito nella accezione volgare di cui si è detto nel paragrafo precedente. E’ proprio
l’esistenza di un forte interesse a dar vita alla reciprocità tra donante e donatario a costituire l’essenza
dell’azione volontaria. Perfino nel cosiddetto dono ad estranei c’è restituzione, cioè controdono: questo
risiede nel valore di legame4. Nonostante la pervasività di una certa vulgata economicistica, non v’è da
pensare che solo due siano le categorie di valore: valore d’uso e valore di scambio, quali vengono illustrate
nei manuali di economia. Esiste anche il valore di legame: la relazione tra persone, tra loro in qualche modo
collegate, è di per se un bene che, in quanto tale, genera valore. In definitiva, la differenza ultima tra la
gratuità del volontario e la gratuità del filantropo (o dell’altruista puro) sta in ciò che il volontario non
pretende la restituzione, accetta l’asimmetria, rinuncia all’equivalenza, ma tutto ciò non implica affatto che
il volontario non coltivi un interesse: l’interesse per l’altro (e non già all’altro) che nasce dal desiderio del
legame. Un’idea questa che - se colgo nel segno - venne magistralmente compresa e illustrata da G. Vico
quando teorizzò che il declino di una società inizia nel momento in cui gli uomini non trovano più dentro di
se la motivazione per legare il proprio destino a quello degli altri; quando cioè viene a scomparire l’interesse. Alla luce di ciò si può dire che, tra tutte le strutture di interazione personale, il volontariato è quella
che con più forza e incisività contrasta la riduzione del legame sociale al cash nexus5.
5. La plurivocità di significati dell’espressione “economia sociale”
Che l’espressione economia sociale indichi e denoti realtà diverse a seconda dei contesti nazionali e degli
usi teorici in cui viene impiegata è cosa nota da tempo. Un esempio per tutti: in Francia, l’economia sociale
include, tra gli altri soggetti, le imprese pubbliche! A cosa è dovuta questa plurivocità di significati? Non
certo al sostantivo, ma all’aggettivo. Tre (almeno) sono i significati di “sociale” che è possibile rinvenire in
letteratura. Primo, sociale rinvia ad un’istanza di parità tra tutti coloro che prendono parte ad un processo
decisionale in ambito economico e dunque sociale è l’economia formata da imprese nelle quali è assicurata
la partecipazione di tutti sia al controllo della conduzione degli affari sia alla ripartizione dell’utile di
esercizio. La forma dell’impresa cooperativa realizza appieno questa accezione del termine in questione.
Secondo, sociale allude all’autonomia propria della società civile organizzata e pertanto alla sua capacità di
esprimersi, in forma consona al proprio statuto, anche in ambito squisitamente economico. L’economia
sociale, allora, è costituita dall’insieme di quelle organizzazioni il cui principio fondativo non essendo la
massimizzazione del profitto, ma il principio di reciprocità, sono in grado di produrre beni e servizi che, né
l’economia for profit né l’economia pubblica, sarebbero in grado o avrebbero interesse a produrre. Infine,
sociale veicola l’idea di un benessere condiviso che tende ad includere, via via, tutti i segmenti della società
e dunque sociale è l’economia - non importa se privata o pubblica - che si pone come obiettivo primario
quello di correggere le distorsioni distributive generate dal mercato for profit. Di fronte a tale pluralità di
accezioni si riesce a comprendere perché non sia possibile offrire una definizione esaustiva di economia
sociale, capace cioè di ricomprendere al proprio interno le sue plurime espressioni. Allora, piuttosto che
attardarsi nella ricerca di impossibili definizioni pienamente soddisfacenti, conviene indicare la prospettiva
dalla quale guardare alla realtà dell’economia sociale. Due sono le prospettive che vanno oggi per la
maggiore: quella del welfare mix e quella della collocazione di nicchia. Vediamo, in breve, di che si tratta.
Secondo la prospettiva del welfare mix, l’economia sociale viene vista come strumento di rivitalizzazione
dell’intervento pubblico, il quale può servirsi del contracting-out per accrescere l’ambito e l’incisività delle
proprie forme di intervento. In un assetto organizzativo del genere, il decisore pubblico si occupa delle
public provision; la public production viene quanto più possibile affidata ai soggetti dell’economia sociale.
Molto è stato scritto sul modello del welfare mix, sui sentieri battuti per arrivare ad esso, oltre che sul ruolo
politico da esso svolto. Ai nostri fini, preme porre in risalto una ragione specifica del perché il welfare mix
non abbia dato i risultati che da esso ci si attendeva. Si tratta del fatto che, a prescindere dall’autenticità
delle scelte di servizio effettuate dalle varie organizzazioni dell’economia sociale e a prescindere anche
dalla capacità di queste ultime di operare in modo efficiente, l’agire dei produttori corre sempre il rischio
dell’autoreferenzialità. Detto altrimenti, quand’anche un’organizzazione produttiva non persegua l’obiettivo
del profitto - come è appunto il caso delle imprese sociali - la unilateralità del modo di rappresentarsi i
problemi di coloro ai quali ci si rivolge con la fornitura di determinati beni o servizi è una possibilità che
non può essere affatto esclusa. E’ questa la causa di ciò che è stato chiamato “il fallimento del non profit”:
una volta posto il vincolo alla distribuzione degli utili, l’organizzazione produttiva si comporta come ogni
altra organizzazione for profit; tende cioè a diventare isomorfica a quest’ultima. In buona sostanza,
l’autoreferenzialità della produzione non è fenomeno esclusivo del modo capitalistico di produzione - come
ancora tanti si ostinano a credere -, ma di qualsiasi produttore che non risulti controllato dai rispettivi
soggetti di domanda. L’impresa sociale non può affermare di andare esente da tale rischio mortale solo
perché il movente di coloro che in essa operano è lo spirito di servizio o qualcosa di simile. Un chiarimento
è qui necessario. In un interessante saggio, Ascoli e Pavolini (1999) sostengono la tesi secondo cui la
crescente professionalizzazione e imprenditorializzazione delle OSC rischia di porre in moto un processo di
allontanamento dalle tradizionali basi sociali entro le quali quelle organizzazioni presero avvio. Non solo,
ma la “laicizzazione” delle OSC sarebbe causa ed effetto ad un tempo della imprenditorializzazione. Causa,
perché - come scrivono Ascoli e Pavolini - tale processo favorisce un approccio più pragmatico nelle scelte
di cambiamento organizzativo, meno vincolato da motivazioni di carattere ideale o etico. Effetto, perché
l’OSC che si trasforma in impresa sociale rischia di corrispondere sempre meno all’immagine di un
soggetto portatore di una specifica cultura. Se ne trae che il passaggio da “associazioni fondate sui valori”
ad imprese sociali finirebbe con il mettere in crisi la legittimazione stessa di tali organizzazioni. C’è
sicuramente del vero in un’analisi del genere, soprattutto se si pensa a certe situazioni e realtà locali. Ma il
punto che desidero sottolineare è che, anche nell’ipotesi di non esistenza di un dilemma fra identità e
servizio reso, si porrebbe comunque il rischio dell’autoreferenzialità della produzione come conseguenza
diretta di una lettura soggettivistica - per non dire paternalistica - dei bisogni di coloro cui si rivolge quella
produzione. Secondo la prospettiva che abbiamo chiamato della collocazione di nicchia, invece, l’economia
sociale viene visualizzata come l’insieme dei soggetti, espressione della società civile organizzata, che sono
in grado di fornire risorse al di fuori dei circuiti disegnati dai decisori politico-amministrativi. Questi ultimi
intervengono con la concessione oppure con la fissazione di schemi di incentivo a favore di iniziative
giudicate meritorie anziché con la erogazione di corrispettivi derivanti da legami di tipo contrattuale, come
accade nella situazione precedentemente illustrata. L’economia sociale verrebbe allora a costituire un modo
per allargare il quadro delle transazioni al di là delle forme assicurate dal mercato capitalistico e
dall’intervento pubblico. Chiaramente la sua sfera di operatività non riguarderebbe i settori pesanti del
welfare, ma tutti quegli interventi con finalità integrative che sicuramente sarebbero migliorativi della
qualità della vita ma che non riguarderebbero le garanzie fondamentali in ordine ai merit goods. In
definitiva, secondo la prima prospettiva, l’economia sociale verrebbe, di fatto, assorbita nella sfera delle
politiche di public provision e ad essa verrebbe chiesto di gestire il welfare pesante in competizione con il
privato for profit, ma ad esso sempre più isomorficamente simile. In base alla seconda prospettiva, d’altro
canto, l’economia sociale si riserverebbe per sé la gestione del welfare leggero, sicuramente utile ma non
indispensabile. L’economia sociale potrebbe dunque continuare ad esistere e ad operare in maniera
indisturbata, ma a condizione di accettare una collocazione di nicchia, come da tempo va dicendo Serge
Latouche e con lui la scuola francese di MAUSS.
6. La prospettiva dell’ economia civile
C’è una terza prospettiva dalla quale affrontare il problema di come concettualizzare l’economia sociale,
quella che fissa l’attenzione sul lato della domanda dei beni di welfare, piuttosto che sul lato dell’ offerta
come fanno invece le altre due prospettive. Per comprendere di che si tratta, si ponga mente alla
considerazione seguente. Come è noto, una delle questioni centrali che troviamo al fondo dei vari progetti
di riforma del sistema di welfare è quella che concerne la definizione appropriata di libertà di scelta da parte
del consumatore delle prestazioni. Ma chi è il soggetto cui riferire la libertà di scelte? Tre sono le posizioni
che è possibile distinguere nel dibattito corrente. Secondo una prima, favorita da chi si riconosce nella tesi
dello stato sociale come “stato dei trasferimenti” il consumatore di servizi sanitari è un mero utente degli
stessi e pertanto un soggetto la cui unica reale opzione di scelta è quella della forma di protesta, ovvero
della “voce” nel senso di A. Hirschman. Una seconda posizione, di matrice liberal-individualista, è quella
del consumatore come cliente: questi è un soggetto che, dotato di potere d’ acquisto, “ha sempre ragione” e
ciò nel senso che, almeno in un certo ambito, esercita una vera e propria sovranità, dalla quale discende la
possibilità di impiego dell’opzione “uscita”. Infine, c’è la posizione, di derivazione dalla teoria dei diritti,
che pensa al consumatore come cittadino, il quale non si limita a consumare i servizi che preferisce, ma
“pretende” di concorrere a definire e talvolta a produrre, con i vari soggetti di offerta, i pacchetti di
prestazioni. Non è difficile cogliere le implicazioni delle tre posizioni. La prima condurrebbe ad una
riproposizione, sia pure in versione aggiornata, del modello statalista di welfare, un modello che
distribuisce, magari generosamente, servizi in risposta ai bisogni astratti dei soggetti, prescindendo però
dalle loro specifiche biografie. Ma ormai sappiamo che quando si dimenticano o si annullano le specificità
proprie dei soggetti beneficiari dei servizi sociali, si ottiene una lievitazione dei costi e un aumento dei
livelli di insoddisfazione. D’altro canto, il consumatore-cliente solo in apparenza è libero di scegliere. Lo è
certamente nel senso debole di scegliere in base alle sue preferenze, ma queste, in un ambito come quello
dei servizi alla persona, sono massimamente manipolabili, e ciò, a causa di irremovibili asimmetrie
informative, tra chi produce e chi consuma. Più in generale, v’è da osservare che la domanda di servizi alla
persona è una domanda derivata, soggetta sia “all’effetto disponibilità” (le variazioni dell’offerta inducono
una corrispondente variazione della domanda) sia “all’effetto insieme di scelte” (le opportunità di accesso
alle cure condizionano le preferenze del paziente, proprio come la parabola “dell’uva acerba” e la teoria
della dissonanza cognitiva insegnano). Ecco perché è veramente poco, e quindi solo consolatorio, declinare
il concetto di libertà di scelta con riferimento alla figura del consumatore-cliente. E’ alla figura del
consumatore-cittadino che reputo necessario applicare il principio della libertà di scelta. Concretamente,
questo significa che l’organizzazione del welfare deve riconoscere ai soggetti - individuali e collettivi quella capacità, vale a dire quell’empowerment che consente loro di diventare partners attivi nel processo di
programmazione degli interventi e nella adozione delle conseguenti scelte strategiche. A sua volta ciò
presuppone che la società civile si organizzi in maniera acconcia se si vuole trovare il modo di convertire i
bisogni concreti in una offerta di prestazioni che sia rispettosa dell’autonomia personale. In buona sostanza,
il passaggio culturale da favorire è quello dalla libertà come potere di autodeterminazione - secondo cui la
libertà di scelta è valutata per ciò che essa ci consente di fare o di ottenere - a quello della libertà come
potere di autorealizzazione, secondo cui la libertà ci interessa perché ci consente di affermare la nostra
dignità. Quanto a dire che mentre la negazione della libertà come autodeterminazione ci sottrae utilità, la
negazione della libertà come autorealizzazione ci toglie dignità il che è certamente più grave. Quanto
precede ci permette di capire perché si ha la necessità di OSC che operano in modo da autonomizzare la
domanda, facendo sì che sia quest’ultima a dirigere l’offerta. Come è noto, caratteristica precipua di una
OSC è quella di appartenere ad una pluralità di stakeholders, cioè di portatori di interessi, quanto a dire che
i proprietari di una OSC non sono solamente coloro che investono in essa per trarne un vantaggio in termini
di rendimento sul capitale investito. La funzione obiettivo di una OSC è piuttosto quello di servire, in
qualche modo specifico, la comunità in cui opera mediante la produzione di esternalità sociali e la
salvaguardia delle ragioni dell’equità. (Tecnicamente, una esternalità viene a crearsi tutte le volte in cui le
azioni di un soggetto hanno un impatto - positivo o negativo - sul benessere di altri soggetti, un impatto che
non risulta mediato o regolato dal sistema dei prezzi. D’altro canto, un’esternalità è sociale, o collettiva,
quando concerne la comunità nel suo insieme). La salute pubblica è un esempio tipico di esternalità sociale,
così come lo è la coesione sociale oppure lo sviluppo locale. In presenza di esternalità sociali, i benefici
complessivi generati dall’attività di un soggetto di offerta non sono solamente quelli attribuibili all’output
ottenuto, ma anche quelli collegati al modo - cioè al tipo di processo - in cui quell’output è stato ottenuto e
soprattutto al sistema motivazionale che anima coloro che promuovono quella certa attività. Ne consegue
che l’esistenza di esternalità positiva, mentre scoraggia l’impresa for profit dall’accrescere il proprio
investimento, rappresenta la missione stessa della OSC, la ragione cioè per la quale i membri di
quest’ultima si uniscono per dare vita ad una attività economica. Si badi che, con ciò, non si vuol affatto
significare che l’impresa for profit non sia interessata a prendere in considerazione le esternalità sociali
oppure che non sia contenta di produrle. Si vuol semplicemente affermare che l’obiettivo della
massimizzazione del profitto (o di un qualche altro indicatore di profittabilità) non consente all’impresa for
profit di “attribuire” un qualche peso a tali esternalità all’interno del proprio processo decisionale, anche se
resta vero che altri soggetti (ad esempio, un ente locale oppure un’associazione di consumatori) potrebbero
indurre o costringere l’impresa for profit a ciò. Ebbene, propongo di chiamare le OSC, la cui funzione
specifica è quella di realizzare le condizioni per un comportamento attivo della domanda che
costruttivamente interviene con l’offerta nella determinazione del risultato finale, imprese dell’economia
civile. Si noti la differenza con le imprese dell’economia sociale. Mentre queste ultime intervengono, per
così dire, sul lato dell’offerta, operando in modo da “umanizzare” i processi di produzione (vale a dire,
dimostrandosi capaci non solo di generare ricchezza in modo efficiente, ma anche di ridistribuirla secondo
un qualche canone di equità), le imprese dell’economia civile intervengono sul lato della domanda,
consentendole di strutturarsi e organizzarsi per interloquire in modo autonomo con i soggetti di offerta. E
ancora. Laddove l’ideale di riferimento dell’economia sociale è la giustizia, per l’economia civile tale ideale
è piuttosto la libertà come autorealizzazione, cioè la libertà in senso positivo di cui parla A. Sen. In vista di
ciò, obiettivo ultimo dell’economia civile è quello di far sì che il mercato possa diventare uno spazio nel
quale il consumatore è cittadino, vale a dire portatore di diritti nei confronti non solo del prodotto
dell’attività economica - bene o servizio che sia - ma anche del processo produttivo che conduce a quel
prodotto. E’ un fatto che i consumatori di oggi prestano attenzione non solamente al prezzo più basso a
parità di qualità. Vogliono piuttosto dire la loro anche sulle diverse tipologie di beni e servizi che è possibile
produrre. In buona sostanza, il consumatore di oggi non si accontenta più di scegliere all’interno di un dato
menu; vuole poter decidere anche il menu tra quelli tecnologicamente possibili, vuole cioè orientare la
produzione per scongiurare i rischi delle varie forme di manipolazione dei consumi. (L’espressione
“economia civile” compare per la prima volta nel Settecento. Quando nel 1753 l’Università di Napoli
istituisce la prima cattedra al mondo di economia, chiamandovi a ricoprirla l’abate Antonio Genovesi, la
denominazione adottata è proprio economia civile. D’altro canto, l’opera fondamentale del Genovesi, del
1765, ha per titolo Lezioni di economia civile). Proporre oggi la prospettiva dell’economia civile,
concretamente, significa mirare a due fini fondamentali. Il primo è quello di provvedere a risolvere una
scarsità tipica delle nostre società avanzate, le quali si trovano tutte, a fare i conti con un problema di
inadeguata fornitura di beni relazionali, di beni cioè nei quali l’identità e le motivazioni dell’altro con cui
interagisco sono elementi essenziali nella creazione del valore del bene (l’amicizia è un bene relazionale,
così come lo sono tutti i servizi alla persona). Poiché questi sono beni veri e propri, la società che non fosse
in grado di assicurarne livelli adeguati di offerta sarebbe una società a più basso livello di benessere (e ciò a
prescindere dal volume e dalla qualità di beni privati che essa fosse capace di assicurare). D’altro canto, la
produzione di beni relazionali non può avvenire né secondo le regole del mercato for profit - e ciò per la
fondamentale ragione che rispetto a tale categoria di beni non è definibile alcuna allocazione di diritti di
proprietà - né secondo le modalità di fornitura dei beni pubblici ad opera dello Stato - la coercizione
distrugge, infatti, la relazionalità. Il secondo fine fondamentale che l’economia civile è chiamata a
realizzare è quello di rendere concretamente possibile il passaggio dal welfare state alla welfare community.
Per realizzare il modello del welfare mix è sufficiente l’economia sociale come si è visto nel paragrafo
precedente. E’ ormai acquisito che il superamento del modello statalista di welfare presuppone che si
disponga di una specifica tipologia di mercati, tuttora inesistenti nel nostro paese: i mercati di qualità
sociale, come ormai vengono denominati nella più recente letteratura. Si tratta di mercati senz’altro sui
generis, ma pur sempre mercati. In essi, le risorse che lo Stato decide di destinare al welfare vengono
utilizzate per interventi di promozione e sostegno della domanda di servizi sociali, trasformando così in
effettiva una domanda che altrimenti resterebbe solo virtuale, cioè non pagante. D’altro canto, si tratta di
intervenire sul lato dell’offerta, con misure sia legislative sia amministrative, per assicurare la pluralità dei
soggetti di offerta delle varie tipologie di servizi e ciò allo scopo di scongiurare i rischi della formazione di
posizioni di rendita e di consentire una reale capacità di scelta da parte dei cittadini. E’ in ciò l’idea di un
welfare sussidiario che si serve dei meccanismi di mercato come strumento per rafforzare il vincolo sociale
e nel quale lo Stato diviene promotore della società civile organizzata incentivando tutte quelle forme di
azione collettiva che hanno effetti pubblici. In altri termini, ciò di cui abbiamo urgente bisogno è uno Stato
promotore della società civile organizzata: è questa l’idea di uno stato sociale sussidiario. Il modello dello
Stato-gestore poteva ben funzionare ieri, quando prevalenti erano le condizioni della società fordista e, in
particolare, i bisogni delle persone erano astratti, cioè indifferenziati. Riproporlo ora, sia pure in versione
razionalizzata nella forma del welfare mix, non potrebbe che sortire effetti perversi e finanziariamente
disastrosi. In un disegno del genere, allo stato spetterebbe un duplice, importante ruolo. Da un lato
riconoscere (e non concedere!) l’auto-organizzazione dei soggetti collettivi in tutti gli ambiti in cui i loro
membri ritengono, in piena autonomia, di avere interessi legittimi da tutelare. Ciò corrisponde a quanto
esige il principio di sussidiarietà in senso proprio: l’organo superiore non deve semplicemente delegare o
distribuire quote di sovranità all’organo inferiore - questa sarebbe una sussidiarietà “ottriata”, cioè il
decentramento politicoamministrativo - ma deve riconoscere e perciò favorire quanto l’organo inferiore è in
grado di realizzare da sé. Dall’altro, lo stato deve garantire le regole di esercizio di questa autoorganizzazione (trasparenza; regole di accesso alle fonti di finanziamento; regimi fiscali), facendo in modo
che sia la competizione leale a stabilire il confine tra economia civile ed economia for profit e non già
interventi dirigistici dall’alto, come appunto si verifica nel modello concessorio. La nozione di autoorganizzazione competitiva è ciò che definisce, in senso proprio, il metodo concertativo di ordine sociale.
Essa cattura l’esigenza di lasciare agli attori, individuali e collettivi, il potere di decidere, in libertà, le
modalità di offerta delle varie categorie di beni - dai beni privati ai beni relazionali - di cui fanno domanda
utilizzando il loro potere d’acquisto. La libertà, cioè, di decidere sia la composizione dell’insieme dei beni
prodotti (più beni privati oppure più beni relazionali), sia le modalità di fornitura degli stessi (l’utilità che
traggo dal consumo di un bene o servizio non dipende solo dalle caratteristiche oggettive di quel bene o
servizio, ma anche dal grado del mio coinvolgimento o della mia partecipazione all’atto di scelta stesso). In
sostanza, sono i consumatori-cittadini che devono poter decidere quanta qualità sociale si deve produrre e
quindi quale ha da essere il mix ottimale di imprese for profit e imprese civili. E’ in ciò il significato
profondo di una autentica democrazia economica, alla quale non basta il pluralismo nelle istituzioni
economiche; essa esige piuttosto il pluralismo delle stesse istituzioni.
7. Una nota conclusiva
Ritorno, infine, al problema evocato dal titolo di questo saggio, quello del rapporto tra volontariato ed
economia sociale. Dopo quanto siamo venuti dicendo è chiaro che non di uno ma di due rapporti si tratta:
quello tra volontariato e economia sociale e quello tra volontariato e economia civile. Il primo è un rapporto
di mutua distinzione al livello del fondamento identitario e di fattiva collaborazione nelle forme varie che le
circostanze storiche di volta in volta suggeriscono. Il secondo invece è un rapporto affatto nuovo che
esprime l’esigenza che i soggetti della società civile si caratterizzino non solamente per la loro capacità di
fornire beni e servizi a condizioni di superiore efficienza e efficacia rispetto a quanto può essere assicurato
dallo Stato e dal mercato for profit - a ciò basta l’economia sociale - ma anche per il contributo che essi
sanno dare al ripensamento radicale del concetto di benessere, cioè di qualità sociale. Questo implica che
l’advocacy e il counselling, per quanto importanti, non sono la sola vocazione del volontariato. Ben più alta
è la sua missione. Se si vogliono ricercare i modi per civilizzare la competizione, per superare cioè quella
visione polemologica del mercato che, a fronte di costi umani e sociali inaccettabili, non riesce a soddisfare
neppure i canoni della stessa razionalità economica, è più conveniente organizzare il processo economico
chiamando la società civile a cooperarvi che non assegnandole mere funzioni residuali o di nicchia. A ben
considerare, le questioni sollevate in questo scritto rinviano tutte ad una questione, per così dire, ultima:
quale ha da essere il principio universale da porre a fondamento dell’ordine sociale. Se si sceglie che questo
sia l’efficienza, allora chiunque prevalga usando come arma competitiva la propria capacità efficiente di
servire il mercato, fa una concorrenza leale che la controparte - sia essa una OSC o un’impresa for profit deve accettare. Se invece il principio universale condiviso è il rispetto reciproco per i valori di cui ciascuno
è portatore e dunque per le priorità che i soggetti della società civile si danno, allora il mercato deve servire,
chiaramente in modo efficiente, queste priorità e non surrogarsi ad esse. Chi scrive si riconosce nella
seconda posizione perché crede alla profezia non raccolta di Emmanuel Mounier (1950), e cioè che “una
struttura economica, per quanto razionale possa essere, se è basata sul disprezzo delle esigenze
fondamentali della persona, porta in se la propria condanna”.
Note
1. Per una rassegna critica di tale letteratura rinvio a Zamagni (1998).
2. MAUSS è l’acronimo di Movimento Anti Utilitarista nelle Scienze Sociali, una corrente di pensiero francese che annovera tra i
suoi più noti artefici Serge Latouche, Alain Caillé, J. Godbout e altri ancora. Si veda Caillé (1998).
3. Si pensi alle analisi, ormai classiche, degli antropologi Marcel Mauss e C. Levi-Strauss, relativi a fenomeni sociali, ai loro tempi
celebri, come il Potlach e il Kula. E’ noto che nelle società arcaiche il dono era un altro modo per farsi la “guerra”, o meglio, una
forma sui generis di competizione, perché chi più donava più guadagnava potere. Per una efficace ricostruzione e rassegna critica
si veda Champetier (1999).
4. Per una approfondita indagine filosofica della nozione di valore di legame e della caratterizzazione dell’homo reciprocus si può
vedere l’interessante saggio di Elena Pulcini (2001).
5. Può essere interessante leggere l’intervista di A. Caillé alla Rivista del Volontariato, novembre 1999. Alla domanda se il
volontariato può essere concepito come dono gratuito, il nostro risponde: “Tutto dipende da cosa intendiamo per gratuità. Se per
gratuità si intende dono completamente disinteressato, senza aspettarsi nulla in cambio, allora la gratuità non esiste. Non diamo per
ricevere qualcosa in cambio, ma diamo nella speranza che un giorno gli altri daranno a loro volta qualcosa. Allora, esistono sì la
gratuità e il dono, ma non sono mai totalmente puri. Non sono mai atti assolutamente disinteressati” (p.18). * testo pubblicato sul
n. 4 del 2002 della rivista “Studi Zancan politiche e servizi alle persone” edito dalla fondazione Zancan di Padova,
www.fondazionezancan.it e-mail [email protected] Per un approfondimento vedi anche l'interessante e appassionato
dibattito suscitato dalle tesi qui esposte dal prof.Zamagni e riprese sulle pagine del settimanale Vita (www.vita.it) che dal n.25 del
21 giugno 2002 al n.31 del 9 agosto continua ad ospitare gli interventi di alcuni fra i più autorevoli esponenti del nonprofit
italiano.
Bibliografia
Ardigò A., Volontariati e globalizzazione, Bologna, EDB, 2001.
Ascoli U., E. Pavolini, “Le organizzazioni di terzo settore nelle politiche socio-assistenziali in Europa”,
Stato e Mercato, 57, 1999.
Borzaga C., Fazzi L., Azione volontaria e processi di trasformazione del settore nonprofit, Milano, Angeli,
2000.
Caillé A., Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono, Torino, Bollati Boringhieri, 1998.
Champetier C., Homo consumans. Morte e rinascita del dono, Bologna, Arianna Ed., 1999.
Coluccia P ., La banca del tempo, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.
Derrida J ., Donare il tempo. La moneta falsa, Milano, Raffaello Cortina, 1996.
Donati P., “Alla ricerca della società civile” in Id. (a cura di), La società civile in Italia, Milano,
Mondadori,1997.
Guardini R., Scritti Filosofici, vol.II, Milano, Vita e Pensiero, 1964.
Magatti M., Per la società civile, Milano, F. Angeli, 1997.
Piore M., “The emergent role of social intermediaries in the new economy”, Annals of Public and
Cooperative Economics, 72, 2001, pp.339-350.
Pulcini E., L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale, Torino,
Bollati Boringhieri, 2001.
Salamon L., H. Anheier, Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector, Baltimora, The Johns
Hopkins Center for Civil Society Studies, 1999.
Wojtila K., Persona e atto, Milano, Rusconi, 1999.
Zamagni S., Non profit come economia civile, Bologna, Il Mulino, 1998.