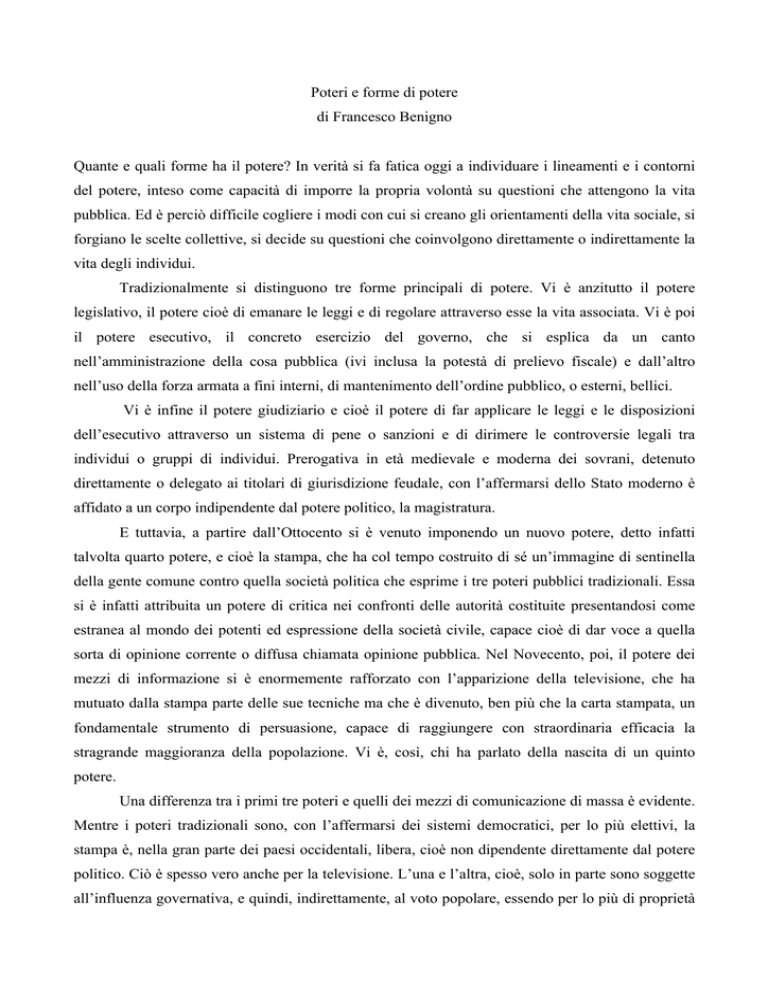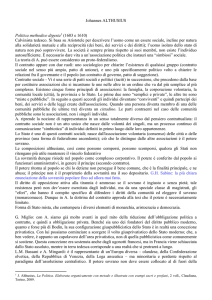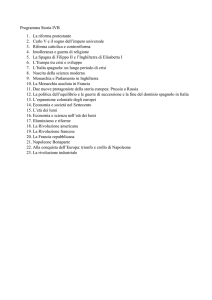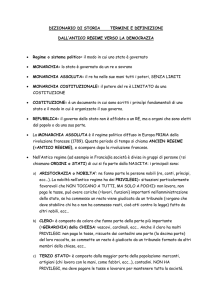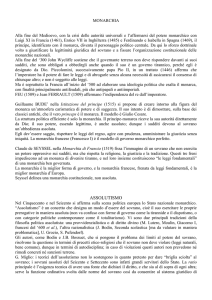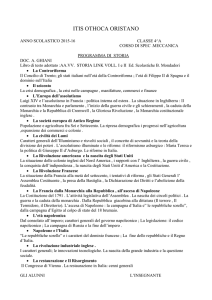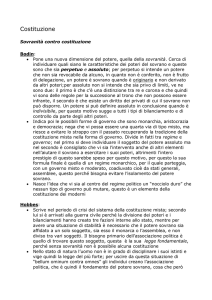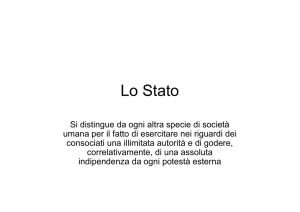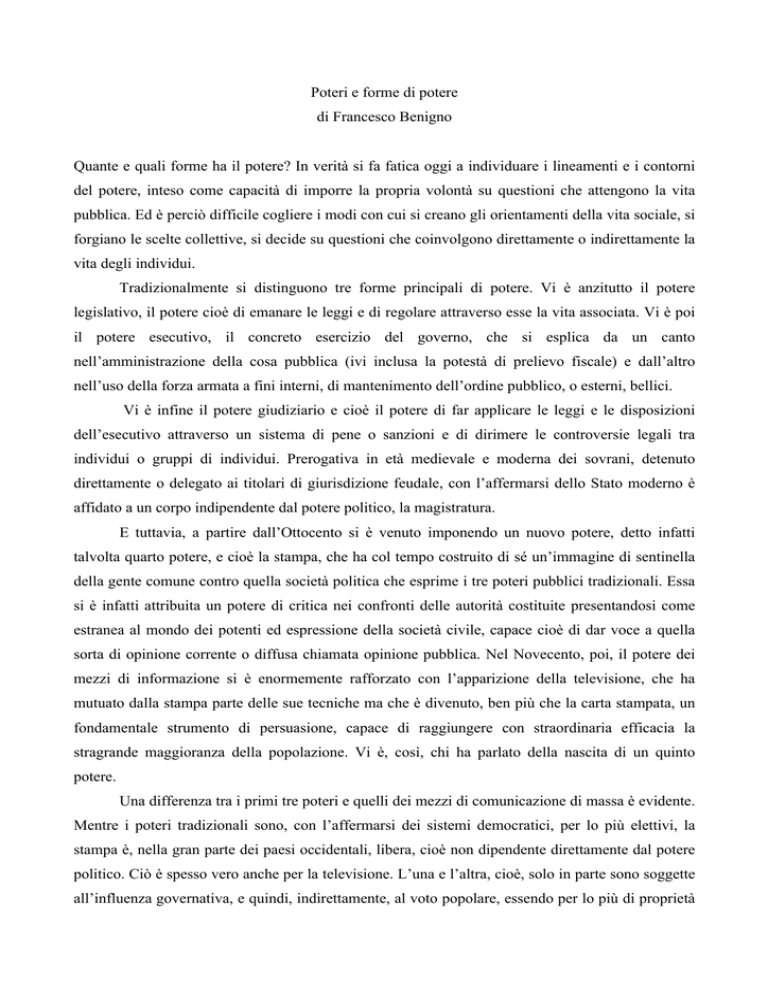
Poteri e forme di potere
di Francesco Benigno
Quante e quali forme ha il potere? In verità si fa fatica oggi a individuare i lineamenti e i contorni
del potere, inteso come capacità di imporre la propria volontà su questioni che attengono la vita
pubblica. Ed è perciò difficile cogliere i modi con cui si creano gli orientamenti della vita sociale, si
forgiano le scelte collettive, si decide su questioni che coinvolgono direttamente o indirettamente la
vita degli individui.
Tradizionalmente si distinguono tre forme principali di potere. Vi è anzitutto il potere
legislativo, il potere cioè di emanare le leggi e di regolare attraverso esse la vita associata. Vi è poi
il potere esecutivo, il concreto esercizio del governo, che si esplica da un canto
nell’amministrazione della cosa pubblica (ivi inclusa la potestà di prelievo fiscale) e dall’altro
nell’uso della forza armata a fini interni, di mantenimento dell’ordine pubblico, o esterni, bellici.
Vi è infine il potere giudiziario e cioè il potere di far applicare le leggi e le disposizioni
dell’esecutivo attraverso un sistema di pene o sanzioni e di dirimere le controversie legali tra
individui o gruppi di individui. Prerogativa in età medievale e moderna dei sovrani, detenuto
direttamente o delegato ai titolari di giurisdizione feudale, con l’affermarsi dello Stato moderno è
affidato a un corpo indipendente dal potere politico, la magistratura.
E tuttavia, a partire dall’Ottocento si è venuto imponendo un nuovo potere, detto infatti
talvolta quarto potere, e cioè la stampa, che ha col tempo costruito di sé un’immagine di sentinella
della gente comune contro quella società politica che esprime i tre poteri pubblici tradizionali. Essa
si è infatti attribuita un potere di critica nei confronti delle autorità costituite presentandosi come
estranea al mondo dei potenti ed espressione della società civile, capace cioè di dar voce a quella
sorta di opinione corrente o diffusa chiamata opinione pubblica. Nel Novecento, poi, il potere dei
mezzi di informazione si è enormemente rafforzato con l’apparizione della televisione, che ha
mutuato dalla stampa parte delle sue tecniche ma che è divenuto, ben più che la carta stampata, un
fondamentale strumento di persuasione, capace di raggiungere con straordinaria efficacia la
stragrande maggioranza della popolazione. Vi è, così, chi ha parlato della nascita di un quinto
potere.
Una differenza tra i primi tre poteri e quelli dei mezzi di comunicazione di massa è evidente.
Mentre i poteri tradizionali sono, con l’affermarsi dei sistemi democratici, per lo più elettivi, la
stampa è, nella gran parte dei paesi occidentali, libera, cioè non dipendente direttamente dal potere
politico. Ciò è spesso vero anche per la televisione. L’una e l’altra, cioè, solo in parte sono soggette
all’influenza governativa, e quindi, indirettamente, al voto popolare, essendo per lo più di proprietà
privata. E comunque la partecipazione dei cittadini alla vita politica o pubblica non comprende
automaticamente il diritto di accesso alla parola pubblica, e cioè alla possibilità di scrivere sui
giornali o di apparire in televisione: diritti che sono regolati autonomamente dai mezzi di
comunicazione. Essa si esprime piuttosto nelle altre e varie forme di organizzazione della cosiddetta
società civile, una sfera idealmente contrapposta a quella politica ma di cui quest’ultima deve tener
conto.
Vi sono, infine, le Chiese. Al di là dell’autorità esercitata sui credenti (e che può spingersi
fino a imporre forme di disubbidienza ai comandi dei poteri civili) il potere religioso esercita
un’influenza su tutte le più importanti questioni del vivere associato. E anche in questo caso siamo
in presenza di un potere che in gran parte esorbita dalle regole democratiche.
La complessità del sistema dei poteri pubblici nelle nostre società è dovuta anche alle
differenti radici di quella legittimità che ne costituisce il fondamento. In via generale un potere è
legittimo intanto in quanto la gente crede che sia giusto e questa convinzione ha origini differenti,
che contribuiscono a rendere complessa la mappa dei poteri pubblici.
In primo luogo un potere è considerato legittimo per rispetto della consuetudine. La
tradizione e l’antichità di certi poteri conferiscono a essi un’aura di incontestabilità in quanto
contribuiscono a presentarli come parte del mondo sociale, quasi come elementi naturali. Una
seconda fonte di accreditamento è costituita dalla legalità. Un potere è legittimo intanto in quanto
previsto e regolato dalla legge. In quanto, cioè, si inscrive in un ordinamento che assegna a esso un
ruolo e dei limiti, e ne regola il funzionamento rispetto agli altri poteri. Una terza fonte è
rappresentata dalla sacralità del potere. Per molto tempo il potere civile è stato, nella società
europea occidentale, strettamente collegato alla sfera religiosa. A lungo, perciò, i detentori del
potere hanno valorizzato e utilizzato questa commistione. Di ciò restano ancora oggi tracce
evidenti: ad esempio, la Corona d’Inghilterra ha mantenuto la titolarità di massima autorità della
Chiesa anglicana. Perfino nei casi di governanti democraticamente eletti, tuttavia, e sia pure in
minor misura, la tendenza a utilizzare la dimensione implicitamente sacrale del potere si è
mantenuta attraverso i rituali solenni, il ricorso a simboli e a una accorta strumentalizzazione della
propaganda. Più generalmente, coloro che aspirano a un ruolo di potere tendono a sfruttare
l’immedesimazione delle persone nella propria figura e l’aspettativa suscitata in esse dai propri
programmi, per creare attorno a sé una dimensione di irraggiungibilità sacrale e di intensa
partecipazione emotiva chiamata carisma. Il carisma è considerato anzi abitualmente la dote
naturale del leader, di colui che si propone per posti di comando.
L’avvento della società di massa ha poi esasperato quest’ultimo elemento. L’avvicinamento
virtuale realizzato dalla televisione permette alla gente comune di guardare in faccia i potenti, di
scrutarne gli sguardi e i sorrisi, di familiarizzare con le loro immagini e di immedesimarsi con loro.
Perciò la televisione si propone per gli aspiranti leader come il passaggio obbligato, lungamente
preparato, alla stregua di una recita teatrale, per la necessaria ricerca del consenso.
Eppure, nella società occidentale, una larga parte del potere non è immediatamente visibile.
Esso ha origine, infatti, dalla potenza economica, che consente ad alcuni individui di finanziare le
campagne elettorali e i partiti, di influenzare le scelte legislative dei parlamentari (un’azione detta di
lobby), di possedere o acquistare mezzi di comunicazione di massa.
VI è dunque una contraddizione tra la regola generale di una società democratica – quella
secondo cui i governanti sono scelti dai governati, le leggi sono uguali per tutti e ogni potere è
soggetto a precise regole che ne determinano ambiti e confini – e l’esistenza di forme di potere che
non vengono scelte democraticamente e che tendono a eludere ogni tipo di controllo. Per
comprendere meglio questa contraddizione è allora necessario ripercorrere all’indietro il lungo e
tortuoso processo di formazione e di sviluppo dei poteri pubblici nella società occidentale.
Re e parlamenti nell’antico regime
La monarchia è l’istituzione che prevede la concentrazione del potere politico nelle mani di
un solo individuo. Nelle monarchie e europee di età medievale i poteri pubblici tendono infatti a
essere riassunti nella persona del re, insieme capo militare, legislatore, giudice, rappresentante di
Cristo in terra. I simboli di questa compresenza di poteri sono lo scettro, il trono e la corona.
Lo scettro è un bastone, di legno o metallo, che originariamente designava il comandante,
colui che in azioni belliche guida le truppe. Tenere il bastone, nella società di antico regime, vuol
dire comandare, perché il bastone è segno di una relazione di dominio, simbolo della potenza di un
superiore rispetto a un inferiore che deve ubbidire e quindi anche ammonimento che ogni
disubbidienza verrà punita.
Il trono è una sedia che denota, anche per la sua posizione sopraelevata (essendo per lo più
poggiata su una pedana o su un palco) la superiorità di chi è legittimato a sedere su di esso, di chi
cioè viene a rivestire il ruolo sovrano nell’ambito di una dinastia (una successione di padre in figlio
di individui della stessa famiglia) designata da Dio al governo della nazione. Sul trono il sovrano
riceve, seduto e a capo scoperto, le richieste, i consigli o le proposte di coloro che sono ammessi al
colloquio e che, a segnare la loro subordinazione, restano in piedi a capo scoperto.
La corona, infine, è il simbolo del fondamento sacrale del potere monarchico. Essa viene
indossata infatti nel momento della cerimonia dell’investitura del sovrano, dell’ascesa al trono, che
in genere è un rito religioso, in cui il nuovo re riceve a capo chino la corona dalle mani di un’alta
autorità religiosa, alla presenza dei massimi rappresentanti della classe dirigente del regno.
Come l’uso di questi simboli dimostra, i sovrani dell’Europa di antico regime hanno teso a
legittimare il proprio potere attraverso l’idea che sia dio a volere che un determinato esponente di
una precisa famiglia regnante governi, così come avevano fatto i suoi predecessori e così come
avrebbero fatto i suoi successori. Ne deriva la tendenza delle monarchie a fare della persona del re
l’incarnazione del potere pubblico, e del comando un attributo sovrano, una prerogativa personale;
al contrario delle repubbliche, nelle quali il potere non inerisce alle persone ma a cariche che
possono essere ricoperte da vari individui.
La tendenza alla sacralizzazione della monarchia e all’innalzamento della dinastia regnante
che si verificano a partire dall’alto Medioevo hanno un preciso scopo: allontanare lo spettro della
monarchia elettiva, e cioè di un sovrano eletto dai nobili del regno, un modello che conta precedenti
nella tradizione delle tribù germaniche ma anche nei sistemi elettivi dell’imperatore e del papa. Gli
imperatori, infatti, per lungo tempo ricevono la consacrazione dei papi; a partire dal 1356, tuttavia,
vengono designati da sette Grandi elettori tedeschi (quattro principi – di Boemia, Brandeburgo,
Palatinato e Sassonia – e da tre arcivescovi – di Colonia, Treviri e Magonza). I pontefici, a loro
volta, vengono a lungo eletti per acclamazione dal clero e dal popolo della città di Roma. Dal 1179
essi sono eletti da un conclave, un’assemblea che riunisce il vertice della gerarchia ecclesiastica, i
cardinali: una severa procedura, che comporta l’isolamento degli elettori, viene seguita per scegliere
colui che ascende al trono di Pietro. La monarchia elettiva fa invece la sua comparsa in Europa solo
sporadicamente, come ad esempio nel Regno di Polonia dal 1572.
La costruzione di una legittimità dinastica, sottratta all’alea dell’elezione e stabilmente
fissata, è così al centro dell’affermazione della monarchia. Il regno di un sovrano viene perciò
inteso come parte di una più ampia missione, quella di una dinastia cui Dio ha affidato le sorti di un
regno per il benessere dei sudditi e la difesa della fede. Contribuisce a ciò una concezione della
sovranità ammantata di tratti soprannaturali, di cui il segno forse più vistoso è la credenza, diffusa
in epoca medievale e nei primi secoli dell’età moderna, che i re di Francia e Inghilterra fossero
addirittura in grado di guarire con il tocco magico della loro mano una diffusa malattia infettiva, la
scrofolosi.
È parte integrante di questo processo di legittimazione sacrale una teoria della monarchia
che prevede una sorta di sdoppiamento della figura del sovrano, che finisce così per avere due
corpi. Da una parte vi è la sua persona fisica, il suo corpo mortale, caduco e circoscritto nel tempo.
Dall’altra vi è la sua figura simbolica che rappresenta un corpo immateriale, politico e spirituale,
che si estende ad abbracciare la nazione e l’eternità del potere monarchico indipendentemente dalle
vicende terrene dei singoli sovrani regnanti. Il re diventa, al di là della sua individualità,
l’incarnazione della legittimità e continuità monarchica e dinastica, e, come tale, perde le sue
caratteristiche di finitezza umana per ascendere a una funzione semidivina di garante dell’ordine
terreno.
Attraverso teorie come questa, e nel corso di un processo secolare, le monarchie tentano di
giustificare il concreto tentativo di accrescere il proprio potere, irrobustendo la forza militare a loro
disposizione, organizzando apparati burocratici di comando da loro strettamente dipendenti,
consolidando la propria potestà legislativa, creando corpi di giudici legati alla Corona. Si tratta in
sostanza di un processo, non sempre lineare, di rafforzamento dei poteri della Corona a scapito di
quelli della nobiltà, delle città, delle autonomie regionali e locali e dei gruppi sociali.
Per comprendere questo processo di crescita dei poteri monarchici, che talvolta assume i
tratti di una relativa centralizzazione e omogeneizzazione amministrativa e le difficoltà che
incontra, occorre tener presente che esso è contrastato dalla natura stessa del potere nella società
europea medievale. Quella società pensa se stessa come parte di un ordine dato, immutabile in
quanto divino. La società politica terrena si dispone così secondo forme prestabilite, che prevedono
che l’individuo partecipi della vita politica non in quanto tale, come persona, ma in quanto parte di
corpi o ceti, ossia di organismi sopraindividuali, dotati di un riferimento preciso all’ordine voluto da
Dio, e dunque possessori di propri diritti e organizzati autonomamente in funzione dei fini collettivi
cui si crede siano naturalmente preposti. La società politica nasce dalla composizione di questi corpi
sociali, immaginati come gerarchicamente disposti ma anche come funzionalmente legati l’uno
all’altro in modo da comporre un organismo unitario.
Il potere sovrano è dunque considerato l’apice e il regolare del sistema, non come un potere
che inglobi tutti gli altri o da cui questi ultimi discendono. Si tratta inoltre di un potere in molti
sensi limitato.
Vi è in primo luogo l’obbligo per il sovrano del rispetto della legge di Dio, posta a
fondamento dell’ordine sociale. Vanno poi osservate ancora le leggi e le consuetudini antiche, da
cui deriva, tra l’altro, l’ordine di discendenza dinastica che dà diritto alla sovranità legittima.
Occorre salvaguardare, infine, i diritti dei corpi sociali, derivanti da usi inveterati, da privilegi
concessi e confermati, da contratti a titolo oneroso, da patti sottoscritti.
Anche la delega di funzioni di governo, politiche, amministrative e giudiziarie con la
concessione di un feudo, a tratti, durante il Medioevo, finisce per costituire un ordinamento quasi
separato e su cui il potere sovrano è limitato. Un feudo, infatti, si trasmette di padre in figlio e la
riconferma regia diviene un atto dovuto, mentre la confisca e il ritorno del feudo al patrimonio della
Corona è un evento possibile solo in caso di reati gravi quali la lesa maestà, cioè l’offesa alla
persona del monarca, e la fellonia, il tradimento a favore del nemico.
Inoltre, in tutte le principali monarchie europee medievali e poi moderne il re è affiancato –
secondo il modello della dinastia franca – da un’assemblea dei rappresentanti del regno. In
Inghilterra, ma anche in Scozia, nel Regno di Napoli e in quello di Sicilia, questa assemblea si
chiama parlamento. Nel caso inglese il parlamento è diviso in due camere: nella camera dei Lords o
pari del regno (detta anche Camera alta, non elettiva) siedono i signori cui il sovrano ha concesso
titoli di nobiltà e delegato la giurisdizione sulla popolazione delle terre ricadenti in loro possesso,
oltre a un certo numero di ecclesiastici. Nella Camera dei Comuni, invece, siedono i rappresentanti
delle città e delle terre abitate non infeudate. In Francia e nei Paesi Bassi questa assemblea, divisa in
tre camere o bracci rispondenti ai tre ordini nei quali tradizionalmente si divide la società, si chiama
Stati generali. In Castiglia, viceversa, le riunioni dei rappresentanti del Regno – in questo caso si
tratta solo dei procuratori delle città – sono chiamate Cortes. In Aragona e in Catalogna le
assemblee sono organizzate per ordini in camere dette Corts. Nei territori dell’Impero, infine, le
riunioni dei rappresentanti dei ceti ai vari livelli del potere territoriale sono denominate diete.
In via generale non si tratta di istituzioni permanenti ma di assemblee che si riuniscono con
cadenza periodica: a seconda dei diversi Stati, una volta all’anno o una volta ogni tre, quattro anni o
solo all’occorrenza. In queste riunioni il sovrano chiede all’assemblea dei rappresentanti del popolo
contributi finanziari per le sempre esauste casse della Corona. Molti monarchi europei hanno il
diritto di imporre particolari tasse indirette sui consumi, ma quasi sempre per imporre tasse dirette
sui beni hanno bisogno del consenso espresso del parlamento.
A fronte di queste concessioni economiche al sovrano, apparentemente prive di contropartite
e perciò dette spesso donativi, i rappresentanti esprimono richieste che si indirizzano a due dei
principali attributi della sovranità. Il primo è la munificenza, ovverossia la capacità del sovrano di
distribuire titoli, pensioni, privilegi, riconoscimenti. Il sovrano è infatti comunemente immaginato,
a somiglianza di Dio, come generoso elargitore di una grazia terrena fatta di riconoscimenti
materiali e simbolici da concedere ai propri fedeli servitori. Il secondo è l’equa amministrazione
della giustizia. Il sovrano è pensato, ancora una volta a immagine di Dio, come il garante ultimo
della giustizia, cui è demandato il compito di ristabilire gli equilibri in un mondo turbato dal
peccato e dalla fallibilità umana. Gli stessi atti emanati dal sovrano o da qualche ministro della
Corona possono urtare precedenti diritti o essere in contrasto con la legge divina o con le leggi
fondamentali del regno. In questo caso, la riunione del parlamento è l’occasione in cui il sovrano,
sollecitato da petizioni e rimostranze, può riparare a torti ed errori, restaurando l’ordine violato.
Spesso queste procedure comportano un defatigante lavorio di mediazione, una
contrattazione che fa si che le sedute parlamentari si prolunghino nel tempo, durando talora
settimane o anche mesi. In alcuni casi, come ad esempio nei territori della Corona d’Aragona, il
diritto di rimostranza, cioè di contestazione, per atti regi compiuti a detrimento dei privilegi
acquisiti (fueros) è particolarmente garantito e ciò rende le sedute difficili da gestire per il governo.
Nel caso del Parlamento inglese, poi, le attribuzioni dei rappresentanti del Regno includono il
diritto a chiedere la modifica di decreti e a proporre specifiche normative, nonché un potere
giudiziario di ispezione e di repressione nei confronti dei funzionari della Corona (impeachment).
Non è dunque un caso se a fronte di queste difficoltà di gestione delle assemblee i sovrani tendano a
convocarle il meno possibile e solo in caso di necessità.
Il gioco dei poteri: le monarchie nella prima età moderna
Nella prima età moderna, tra XIV e XVI secolo, il potere dei sovrani non è illimitato. Alle
limitazioni imposte dall’azione delle assemblee rappresentative si accompagnano quelle derivanti
dalla presenza di altri poteri. In primo luogo, nelle principali monarchie europee le più importanti
cariche di governo sono tradizionalmente appannaggio di grandi famiglie nobili. Lo stesso vale per
rilevanti posti di comando periferico, come le cariche di governatore, luogotenente, viceré e così
via. Anche nel caso delle nomine dei quadri dirigenti dell’amministrazione civile, stretti vincoli alla
libertà di scelta regia sono imposti dalle qualifiche richieste ai candidati, dalle consuetudini stabilite
e, soprattutto, dalle norme che regolano tradizionalmente l’operato dei vari corpi sociali.
Per ciò che riguarda la potestà regia di emettere diritti, regolamenti e ordini essa è
subordinata non solo al rispetto dei principi religiosi, pena la scomunica papale, ma anche alla
conformità alle cosiddette leggi fondamentali del regno e alla non contraddittorietà rispetto ad altre
norme emesse in precedenza. In tutti i regni esistono leggi che a tal fine obbligano i sovrani a
sottoporre a verifica i propri atti. Vengono creati perciò appositi organi di controllo con il compito
di verificare le norme regie, di dare a esse efficacia e renderle concretamente eseguibili o altrimenti
di rimandarle al sovrano affinché le emendi.
Nel Regno di Francia tale funzione è affidata in epoca moderna a una corte suprema,
esistente a Parigi e nelle principali città: il parlement, parlamento, nome abitualmente dato altrove
alle assemblee rappresentative. Il parlamento ha il diritto di sospensione dell’esecuzione di norme
ritenute illegali o contraddittorie: in tal caso il testo torna al re, che può rettificarlo e rimandarlo
all’esame della corte che si interrompe soltanto quando il sovrano decide di riunirsi in seduta
solenne insieme al parlamento. Solo in quell’occasione la volontà del sovrano non può subire veti e
la ragione di ciò è la concezione secondo cui la regalità e la legalità riunite insieme esprimano
appieno il potere supremo.
In Inghilterra, viceversa, tale parziale condivisione del potere si realizza in parlamento e cioè
nella riunione congiunta del sovrano e dei rappresentanti del Regno (king in parliament), che è
considerata l’unico contesto in cui si possono prendere decisioni particolarmente rilevanti quali
l’introduzione di nuove tasse o le dichiarazioni di guerra. Anche in questo caso la volontà regia
viene, per così dire, coadiuvata e rafforzata dal consiglio dei parlamentari, secondo una tradizione
che vuole che il sovrano, primo fra pari, prenda le sue decisioni con l’ausilio dei rappresentanti del
Regno.
Di fronte a tali vincoli, a partire dal XV secolo, il potere regio innesca una serie di processi
che lo portano a liberarsi di molti di questi condizionamenti.
Il primo elemento che contribuisce a tale rafforzamento è la crescita dell’apparato
burocratico e finanziario statale. Si tratta di un processo di lungo periodo, che affonda le sue radici
nell’epoca medievale ma che vede uno sviluppo importante a partire dal XV secolo, quando il
recupero e la rilettura dei testi degli autori classici forniscono gli strumenti per teorizzare e praticare
una politica di «buon governo» che prevede un’efficiente e autonoma macchina amministrativa
statale. Attraverso il progressivo monopolio dell’uso della forza armata e della riscossione delle
tasse alcune monarchie europee assurgono a una potenza militare ed economica incomparabile
rispetto a quella dei più facoltosi fra i propri sudditi. Il re cessa così di essere solo il primo tra i pari
e diviene, anche in virtù delle ricchezze che può distribuire, la fonte semidivina della grazia terrena,
elargitore di premi per i servitori fedeli e di castighi per i disobbedienti e i nemici.
Il secondo elemento è dato dal ridimensionamento del controllo della Chiesa. Approfittando
della Riforma protestante, molti sovrani riescono a impossessarsi dei beni materiali e perfino
dell’autorità spirituale della Chiesa, contribuiscono a riscrivere le regole della vita religiosa e
incrementano l’influenza della Corona su questioni in precedenza demandate agli ecclesiastici.
Anche i sovrani cattolici, pur nel rispetto formale delle prerogative della Chiesa, ottengono un
aumento della propria capacità di controllo sul clero, decidendone le nomine e spesso orientandone
le posizioni politiche.
Il terzo elemento è il diffondersi di concezioni della sovranità che teorizzano la possibilità
per il sovrano di svincolarsi dal rispetto delle leggi consuetudinarie o stabilite in precedenza,
derogando da esse, annullandole o riscrivendole. Tali concezioni, che gli storici definiscono politica
assoluta o assolutismo – dall’espressione latina a legibus solutus, libero da vincoli legali – fanno del
sovrano un onnipotente in terra, consentendogli atti di arbitrio e la violazione dei patti,
l’annullamento dei privilegi concessi, la revisione delle regole sociali.
Idee sulla sovranità: dal diritto divino al Leviatano
Un presupposto per l’affermazione dello Stato assolutista è la trasformazione della
concezione delle funzioni dello Stato avvertibile nel pensiero di autori come il francese Jean Bodin
(1530-1596) e soprattutto l’inglese Thomas Hobbes (1588-1679). È significativo come entrambi
questi autori elaborino le loro teorie sullo Stato in nel pieno della grave temperie politico-religiosa
innescata dallo scontro tra cattolicesimo e protestantesimo. Di fronte al rischio concreto di
disgregazione dello Stato entrambi puntano su un rinnovamento della monarchia come fulcro della
convivenza civile. Le vecchie teorie che giustificavano la monarchia unicamente sulla sua
partecipazione a un ordine divino appaiono deboli proprio mentre si accendono discussioni accanite
sulla natura di quell’ordine. In altre parole, se la religione è argomento controverso e fonte di
divisione, il fondamento sacrale diviene improvvisamente un piedistallo insicuro per la sovranità e
rischia di trascinarla in una rovinosa caduta. Occorre allora uno sforzo per ripensare su basi nuove
la sovranità monarchica.
Jean Bodin sperimenta direttamente l’asprezza delle guerre di religione che lacerano la
Francia tra il 1562 e il 1598, partecipando a quel movimento intellettuale detto dei politiques, che
auspica un accordo tra le parti in lotta in nome del rafforzamento dell’istituzione monarchica e nel
segno della convivenza civile e della tolleranza religiosa. Nell’opera I sei libri della Repubblica
(1576) Bodin formula quella che può essere considerata la prima sistemazione teorica della
sovranità monarchica, sulla base della quale egli giunge ad affermare il diritto del sovrano a
derogare dalle leggi vigenti, non essendo tenuto a seguire le disposizioni dei suoi predecessori.
Ancora più importante è la trasformazione della concezione della sovranità in Thomas
Hobbes. Vi è in lui l’idea che lo Stato sia una creazione artificiale ma necessaria, destinata a
costruire un ordine politico durevole e tale da evitare i drammi della guerra civile, a lui peraltro ben
noti essendo stato costretto, in quanto cattolico, a emigrare a Parigi nel 1641. Nella sua opera più
famosa, Il Leviatano (1651), lo Stato assoluto viene identificato con un mostro biblico di forma
sovrumana e capace perciò di garantire la pace laddove la natura degli uomini, lasciati a se stessi,
produrrebbe inevitabilmente uno stato di lotta intestina permanente, una continua guerra di tutti
contro tutti. Per Hobbes, al fine di ottenere le necessarie pace e sicurezza, gli uomini si sono adattati
a cedere la propria sovranità a un’entità sopraindividuale che l’ha assunta in sé in modo irreversibile
e incontestabile, garantendo però così anche l’esercizio di diritti personali limitati ma tutelati.
Vi sono in Hobbes, dunque, due importanti elementi nuovi, che distruggono la visione del
mondo politico come espressione di un ordine voluto da Dio. Il primo è l’idea che alla base della
sovranità del re vi sia una cessione di sovranità da parte del popolo, suo originario intestatario, che
ha tutti i caratteri di un contratto in cui il potere monarchico deve assicurare una «prestazione» in
termini di ridimensionamento di ogni forma di conflitto interno e di protezione dalle aggressioni
esterne. Il secondo elemento è la contraddizione, da Hobbes evidenziata, tra una sfera di poteri e
diritti pubblici e una sfera di poteri e diritti individuali. Nella visione di Hobbes, il cittadino deve
cedere i propri poteri allo Stato (e al monarca che lo incarna) ma deve riceverne in contraccambio la
tutela dei propri diritti individuali.
La figura del primo ministro nel Seicento
La possibilità, per la volontà regia, di essere sciolta dai vincoli tradizionali, permette di
esaltare l’enorme potenza dell’apparato statale in formazione. Ciò comporta una maggiore
articolazione del potere, un controllo più stringente dell’amministrazione e nuovi strumenti di
costruzione del consenso. In particolare, il governo dell’amministrazione statale – sul terreno
militare, economico-fiscale e giuridico – richiede non solo una maggiore capacità d’intervento
legislativo, ma soprattutto meccanismi esecutivi efficienti, che consentano agli ordini e alle linee
politiche di essere trasmessi dal centro alle periferie per essere eseguiti. A tal fine, tra Cinque e
Seicento, si diffonde l’uso fra i sovrani di delegare il proprio potere a un ministro plenipotenziario
di fiducia, chiamato primo ministro o favorito. Uomini come i cardinali Richelieu (1585-1642) e
Mazzarino (1602-1661) in Francia, il duca di Lerma (1553-1625) e il conte duca di Olivares (15871645) in Spagna e il duca di Buckingham (1592-1628) in Inghilterra divengono così i detentori del
potere regio, tentando di creare, attraverso legami di fedeltà personale, catene di comando che diano
maggiore operatività a una macchina statale costruita ancora da corpi semiautonomi e dotati
ciascuno di regole particolari e di relativa autonomia. Allo stesso tempo si costruiscono campagne
di propaganda destinate a esaltare, attraverso l’immagine del sovrano, la potenza e l’efficienza dei
nuovi regimi.
Il tentativo di aggirare, scalzare o abrogare quel fitto reticolo di norme e privilegi che
costituiscono l’ossatura tradizionale della società di antico regime porta i sovrani e i loro ministri –
specie in tempo di guerra – a inviare dal centro emissari di fiducia, che in Francia si chiamano
intendenti, per controllare la pronta esecuzione delle direttive; ad arrestare – al di fuori delle
procedure giudiziarie stabilite – oppositori e dissidenti; a delegare la riscossione dei tributi a
finanzieri di fiducia in grado di anticipare alla Corona grandi quantità di denaro contante; a creare
giunte di governo su particolari problemi in modo da scavalcare gli ambiti decisionali ordinari; a
violare quei patti, contratti o privilegi ritenuti incompatibili con l’azione di governo.
Questo repertorio di comportamenti tradisce una concezione della politica come svincolata
dal quadro dei precetti religiosi cristiani, secondo gli insegnamenti di colui che per primo svela
come l’esercizio dell’attività politica risponda a logiche sue proprie, autonome da quelle religiose:
Nicolò Machiavelli (1469-1527). Per Machiavelli la politica è l’arte dell’ottenimento e del
mantenimento del potere, un risultato che non dipende da piani provvidenziali o dal rispetto dei
dettami della Chiesa ma dall’abilità e dalla spregiudicatezza dei governanti. Malgrado la condanna
della Chiesa, il pensiero di Machiavelli, unito al recupero di autori dell’antichità greco-romana,
costituisce la base di una riflessione diffusa sulla cosiddetta ragion di Stato e cioè sulla natura dello
Stato moderno, sulle sue esigenze e sui rapporti con l’etica e la religione. I governi ne sono
profondamente influenzati, al punto di elaborare dottrine dell’arte di governo (dette con espressione
latina arcana imperii) nascoste alle moltitudini e volte a dettare le regole essenziali, e
sostanzialmente prive di scrupoli e di condizionamenti morali, che devono consentire la
salvaguardia e l’incremento del potere.
L’avversione per le pratiche di politica assoluta, esasperate e raffinate nel periodo della
lunga guerra dei Trent’anni, dal 1618 al 1648, costituisce il comune denominatore di un’estesa serie
di ribellioni, rivolte e rivoluzioni concentrate nel periodo 1647-53. Da questa fase convulsa,
coincidente con il riassetto politico-diplomatico degli Stati europei tra la pace di Westfalia (1648) e
la pace dei Pirenei (1659), che chiudono un lungo ciclo di conflitti militari e inaugurano un nuovo
scenario europeo dominato dalla potenza francese, emergono un significativo mutamento nella
concezione del potere politico e due modelli alternativi di monarchia: la monarchia assoluta
francese e la monarchia parlamentare inglese.
La monarchia assoluta
Il lungo regno di Luigi XIV (1643-1715) segna l’affermazione piena della concezione della
monarchia assoluta di stampo cattolico. Con lui si torna, dal 1661, a un controllo diretto da parte del
monarca del processo decisionale, senza quindi la mediazione di potenti primi ministri, e a un
tentativo di coinvolgimento dei gruppi dirigenti del regno nel processo di rafforzamento delle
catene di comando (militari, amministrative, fiscali e giudiziarie) distese dal centro verso la
periferia per ottenere una maggiore prontezza di risposta degli apparati alle direttive governative. Il
segno più vistoso di questa nuova politica è dato dal tentativo di trasformare la corte – stabilita nella
grandiosa reggia di Versailles, vicino Parigi – nel luogo di residenza di gran parte della nobiltà del
regno, indebolendone il radicamento territoriale e coinvolgendola nel progetto di incremento del
potere statale incarnato dalla figura del sovrano. Questa idea del potere statale come di ciò che
ingloba e riassume tutti i poteri sociali richiede, per essere posta in atto, una serie di fattori
favorevoli.
In primo luogo si tratta di un modello vincente. Ai primi del Settecento, la Francia conclude
positivamente la lunga competizione con la Spagna per il predominio europeo e riesce perfino, a
insediare su membro della dinastia regnante francese dei Borbone, Filippo V (1700-26) sul trono di
Spagna, dopo l’estinzione per cause naturali del ramo spagnolo della dinastia degli Asburgo. La
monarchia di Luigi XIV è dunque innanzitutto un’efficiente monarchia militare, basata sulla
creazione di un imponente e temibile esercito e di un’agguerrita flotta in grado di imporre
un’egemonia continentale.
In secondo luogo questo modello vincente gode dell’appoggio della Chiesa, da cui ottiene
un fondamentale sostegno alla sacralizzazione della figura del sovrano in cambio del ruolo di attiva
difesa della fede e di braccio armato del cattolicesimo, un ruolo già interpretato nei decenni
precedenti dagli Asburgo di Spagna.
In terzo luogo la politica di Luigi XIV è sostenuta da un’operazione di propaganda dai tratti
innovativi, tesa a costruire l’immagine invincibile di un sovrano dallo splendore senza pari – non a
caso egli si definisce il «re Sole» - e di cui sono manifestazioni tangibili le architetture
monumentali, le splendide feste e le rappresentazioni teatrali, la commissione di numerose opere
d’arte, il patrocinio accordato ad accademie culturali e scientifiche.
Il modello assolutistico proposto all’Europa da Luigi XIV viene imitato da molti sovrani,
con un’accentuazione nel caso dello zar di Russia Pietro I Romanov (1682-1725), detto Pietro il
Grande, dell’importanza dell’esercito, elemento portante di una società militarizzata che il sovrano
ritiene di poter plasmare a piacimento. Ne è segno preciso la promulgazione di una Tavola dei
ranghi (1722) che riordina in senso gerarchico rigido il sistema delle dignità e degli onori pubblici.
Non diversa la strada percorsa da Federico II di Hohenzollern (1740-86), re di Prussia, anch’egli
noto come Federico il Grande. Anche nel suo caso l’intervento dirigista statale ha il suo perno
nell’esercito e nel coinvolgimento del ceto militarizzato dei proprietari terrieri di estrazione
aristocratica, gli Junker, nell’attività di governo.
A partire dalla metà del XVIII secolo la volontà di intervento dei monarchi si precisa. Rotta
la distinzione, invalsa dall’antichità, tra una sfera politica, quella della cosa pubblica (res publica), e
una sfera economica, immaginata come privata, domestica, lo Stato inizia a considerare suo
compito precipuo intervenire per il miglioramento dell’attività economica in generale. Nelle aree
dell’Impero asburgico si afferma anzi, nella prima metà del XVIII secolo, una concezione rinnovata
del governo dell’economia (detta cameralismo), non più volta solo a proteggere le attività
economiche ma anche a promuoverle nell’ambito di un ripensamento dell’intera attività
amministrativa statale.
L’attività riformatrice dei monarchi – in precedenza indirizzata essenzialmente al
miglioramento degli apparati bellici, fiscali ed amministrativi dello Stato – riceve un potente
impulso dalla diffusione delle idee illuministiche, che esaltano la possibilità di correggere le usanze
e le istituzioni tradizionali, bollate come sostenitrici di una religione superstiziosa e portatrici di
valori oscurantisti, e quindi di purgarle delle incrostazioni retrograde alla luce di una razionalità
finalmente dispiegata razionalmente. Sovrani come l’imperatrice Caterina II di Russia (1762-96),
l’imperatrice d’Austria Maria Teresa d’Asburgo (1745-80) e suo figlio Giuseppe II d’Asburgo
Lorena (1756-90) attivano politiche di riforma tese a promuovere le industrie nazionali, a
centralizzare e a omogeneizzare la legislazione e gli apparati amministrativi, a mettere i beni della
Chiesa al servizio di più efficaci politiche pubbliche nei settori della sanità e dell’istruzione, a
sgretolare i poteri dei ceti e i privilegi delle classi dirigenti locali.
Tale evoluzione si accompagna a una maggiore articolazione degli apparati centrali di
governo, con l’istituzione di ministri appositi per particolari rami dell’amministrazione (finanze,
attività produttive), della politica (interni, esteri) e della guerra (esercito, marina). In generale,
tuttavia, tali ministri, di esclusiva nomina regia, sono scarsamente coordinati fra loro e fanno capo
unicamente al sovrano. Nel caso francese, ad esempio, non esiste un preciso controllo delle entrate
dei ministeri, che vengono stabilite dal sovrano con i singoli ministri senza darne conto al ministro
deputato al controllo delle finanze: una prassi che si rivela causa non secondaria del dissesto delle
finanze statali francesi dell’ultimo quarto di secolo.
Le vie alternative all’assolutismo: repubblica federale e monarchia parlamentare
L’itinerario assolutistico non è tuttavia l’unico nell’esperienza europea. A esso va affiancato
(ma anche contrapposto) un secondo percorso in cui – essendo capaci le assemblee rappresentative
di conservarsi come centri di iniziativa politica – si delinea una convivenza forzata tra i due poteri,
destinati l’uno a monopolizzare le funzioni dell’esecutivo e l’altro ad assumere pienamente la
funzione legislativa.
La prima realtà che sperimenta tale modello è quella dell’Olanda o, più propriamente, della
Repubblica delle Province Unite (delle quali l’Olanda, in età moderna, è la più importante), una
nuova formazione statale forgiatasi nel corso di una lunga guerra per l’indipendenza dal dominio
spagnolo (1579-1648), che è anche uno scontro religioso poiché le province secessioniste sono di
fede calvinista.
La forma statale prescelta è in questo caso quella repubblicana di tipo federale, il che
significa che varie realtà statali autonome si danno una struttura sovrastatale comune cui
demandano funzioni di difesa, di coordinamento politico e di rappresentanza diplomatica. In Olanda
si realizza un sistema fondato sulla divisione dei poteri: l’assemblea rappresentativa degli Stati
generali assume un ruolo di guida politica, sviluppando via via la potestà legislativa mentre la
direzione militare e in certa misura esecutiva viene assunta dal luogotenente in capo, detto
stadhouder, una carica che diviene appannaggio della famiglia nobile degli Orange Nassau.
Il secondo importante paese in cui si realizza la divisione dei poteri tra esecutivo e
assemblea rappresentativa è l’Inghilterra, e anche in questo caso nel corso di una lunga vicenda di
opposizione alla pretesa della casa regnante Stuart di modellare lo Stato inglese secondo gli schemi
della politica assoluta. Già Giacomo I Stuart (1603-25) teorizza una monarchia a immagine e
somiglianza di Dio e come tale svincolata dalla costituzione non scritta che regola in Inghilterra i
rapporti tra sovrano e paese e che viene fatta risalire ai privilegi concessi dal re Giovanni Senzaterra
(1167-1216) ai baroni del regno e alla città di Londra (Magna Charta libertatum, 1215).
Il tentativo assolutistico di Giacomo I incontra un’accanita resistenza del Parlamento, che si
accresce ancora di più di fronte al tentativo fallito del figlio ed erede Carlo I Stuart (1625-49) di
governare senza convocare l’assemblea. Costretto alla convocazione da difficoltà finanziarie
straordinarie, nel 1640, il sovrano si trova di fronte a un’opposizione durissima, all’emanazione di
un decreto che gli impedisce di sciogliere l’assemblea d’autorità e infine all’accusa esplicita di
voler introdurre in Inghilterra – che dal 1534 si era staccata dalla Chiesa romana – una politica
filocattolica e assoluta. Ne segue una sollevazione antimonarchica, la Rivoluzione inglese, e una
guerra civile. Carlo I viene sconfitto e – per la prima volta nella storia europea – si arriva a
celebrare un processo al re, che viene giudicato colpevole di aver tentato di trasformare il potere
monarchico in potere tirannico e perciò condannato a morte e giustiziato in nome del popolo
inglese.
Nel successivo periodo di regime repubblicano (1649-58) si apre una dialettica a tratti aspra
tra esecutivo e parlamento. Il potere esecutivo viene, infatti, monopolizzato dal capo militare della
rivoluzione, Oliver Cromwell (1599-1658), fattosi nominare – sul modello olandese dello
stadhouder, lord protettore della repubblica inglese, mentre il parlamento, ridotto a una sola camera
a seguito dell’abolizione della Camera dei lords, appare incerto e diviso. Allo morte di Cromwell
segue la restaurazione in armi della dinastia degli Stuart ma prima Carlo II (1660-85) e poi
Giacomo II (1685-88) continuano a scontrarsi con un parlamento restaurato nella sua forma
bicamerale, senza riuscire ad allontanare da sé il sospetto di voler introdurre in Inghilterra una
politica assoluta e filoassolutista.
La seconda Rivoluzione inglese, detta Gloriosa (1688-89) è una rivoluzione pacifica, in cui
la maggioranza della classe dirigente inglese decide la sostituzione del sovrano e lo costringe alla
fuga, chiamando sul trono il genero di questi, Guglielmo III d’Orange, stadhouder d’Olanda. Si
instaura così, col riconoscimento esplicito da parte di Guglielmo dei diritti del Parlamento e del
popolo inglese (Dichiarazione dei diritti, 1689), una divisione di poteri tra un esecutivo diretto dal
sovrano e un potere legislativo espresso dal parlamento con poteri di controllo sull’operato dei
ministri.
Tale processo si accentua con l’ascesa al trono inglese della dinastia tedesca degli Hannover.
Giorgio I Hannover (1714-27) continua addirittura a vivere all’estero nei suoi possedimenti senza
imparare la lingua inglese. È davvero evidente, adesso, che il re d’Inghilterra è tale non solo per
grazia di Dio ma soprattutto per volontà della nazione.
Emerge in questo contesto la figura del primo ministro, così come è intesa modernamente:
non solo più amico personale e fiduciario del sovrano, ma carica istituzionale obbligata a ricevere la
fiducia, con un voto a maggioranza, anche dal parlamento. La divisione dei poteri – soprattutto nel
periodo di governo del ministro Robert Walpole (1721-42) – assume un profilo del tutto nuovo: la
carica di primo ministro, in teoria sempre attribuita dal sovrano, diviene di fatto attribuzione del
leader della maggioranza parlamentare. Questi assume tutte le principali responsabilità di governo,
guidando un governo di gabinetto, ovvero un gruppo coordinato di ministri specializzati nelle varie
branche dell’amministrazione. Al re rimangono riconosciuti un’influenza sulle più importanti
scelte, specie di politica estera, e il ruolo di garante delle istituzioni e di simbolo dell’identità della
nazione: un re che regna, ma non governa.
Come nel caso dell’Olanda anche l’assetto degli Stati Uniti d’America, all’indomani della
guerra d’indipendenza contro gli inglesi (1774-83), è quello di una repubblica federale. La
federazione di Stati indipendenti – originariamente le tredici colonie inglesi separatesi dalla
madrepatria, cui si aggiungono via via gli Stati creati con la colonizzazione delle terre verso
occidente – viene organizzata su due livelli di potere: da una parte il potere degli Stati, con
competenze molto vaste che includono il prelievo fiscale, un’autonoma legislazione, un sistema
giudiziario e sanitario e una propria polizia, e dall’altra il potere federale, con un potere legislativo
di indirizzo generale, recepito poi dai singoli Stati, e con competenze esclusive relative alla difesa,
al bilancio economico generale della federazione e alla sicurezza (con tribunali e una polizia
federale).
Questa compresenza di poteri di diversi livelli di potere si accompagna nel sistema federale
statunitense a una netta divisione dei poteri: al potere esecutivo, incarnato nella persona del
presidente della repubblica eletto, si affianca il potere legislativo, espresso da un’assemblea
legislativa bicamerale, di cui una camera a suffragio diretto, il Congresso, e una camera costituita
da due rappresentanti per ciascun Stato facente parte della federazione, il Senato. Il potere
giudiziario, indipendente, è anch’esso definito su base elettiva.
Dalle libertà personali alla volontà generale
All’indomani della seconda Rivoluzione inglese, nel volume I due trattati del governo
(1690), il filosofo inglese John Locke (1632-1704) delinea una precisa idea di monarchia
parlamentare dai poteri rigidamente definiti, che si arrestano di fronte alla sfera dei diritti
dell’individuo: la libertà di parola, di culto, il diritto alla proprietà e l’uguaglianza di fronte alla
legge. Non solo lo Stato non può attentare a questi diritti ma il suo principale scopo è la loro
protezione e difesa. Per evitare il rischio di derive assolutistiche è perciò bene che il potere sia
diviso in una serie di funzioni (esecutiva, legislativa, giudiziaria) che, affidate a istituzioni e persone
diverse, si contrappongano e si bilancino perfettamente.
Questi temi vengono poi ripresi in Francia da Charles-Louis Secondat de Montesquieu
(1689-1755) nel fondamentale Lo spirito delle leggi (1748), un testo che offre una lettura attenta del
modello inglese di separazione dei poteri, allo scopo di delineare una costituzione politica adatta a
una Francia attardatasi sul modello assolutistico. Montesquieu, in opposizione ai modelli
repubblicano e assolutistico, propone l’idea di uno «Stato moderato», una monarchia costituzionale
in cui al re spetta il potere esecutivo, a un parlamento bicamerale all’inglese il potere legislativo e a
una magistratura indipendente il potere giudiziario.
La tematica contrattualistica, così come viene impostata da Hobbes e da Locke, viene ripresa
nella seconda metà del Settecento dal pensiero illuminista e in particolare da Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), che in opere fondamentali, e soprattutto con Il contratto sociale (1762), delinea i
lineamenti di una repubblica fondata su un accordo fra individui liberi, un contratto originario sul
quale si basano l’autorità della legge e delle istituzioni di governo. Rousseau è un ammiratore della
cosiddetta «libertà degli antichi», ovvero del modello di cittadinanza della polis della Grecia antica
che si esprime mediante il libero confronto pubblico delle opinioni e la partecipazione di tutti i
cittadini alle decisioni. Vi è qui il recupero dell’idea di una democrazia diretta, esercitata in prima
persona da tutti i cittadini di piccole comunità che si autogovernano, come ad esempio, nel caso
della Confederazione svizzera, un’unione interstatale di comunità locali autonome, i cantoni.
Rousseau ammette, tuttavia, che le dimensioni degli Stati moderni sono tali da rendere difficoltoso
l’esercizio della democrazia diretta e da rendere necessario il ricorso a una democrazia delegata,
fondata cioè sul principio della rappresentanza della collettività da parte di soggetti liberamente
eletti. Per fondare la legittimità della democrazia delegata e il principio di rappresentanza, Rousseau
elabora il concetto di volontà generale. La volontà generale è la concreta manifestazione della
sovranità di un popolo che si esprime sia in forma diretta, esattamente come nella polis greca, sia in
forma indiretta, attraverso il voto di delega, ovvero il voto della maggioranza dei rappresentanti del
popolo che così non esprimono solo un orientamento personale ma si fanno interpreti degli interessi
e delle scelte di tutta la collettività.
La Francia napoleonica e la monarchia amministrativa
Il rivolgimento sociale e politico creato dalla Rivoluzione francese sfocia nella prese del
potere da parte di uno dei più brillanti generali delle armate rivoluzionarie, Napoleone Bonaparte.
Atteggiatosi dapprima a protettore e salvatore della Repubblica contro i tentativi di restaurazione
realista, è l’uomo forte di un triumvirato protagonista di un colpo di Stato noto alla memoria storica
come 18 brumaio (9-10 novembre 1799), secondo la denominazione che il giorno ha nel calendario
rivoluzionario allora vigente. Questo atto ha lo scopo esplicito di realizzare un netto rafforzamento
del potere esecutivo, superando definitivamente il primato del potere legislativo, già minato nel
1795 con lo scioglimento della Convenzione nazionale e l’istituzione della Camera degli Anziani e
della Camera dei Cinquecento.
Dopo una breve parentesi di gestione collegiale del governo (detta Consolato, dal nome
della magistratura che nell’antica Roma occupa il vertice del potere esecutivo), nel 1802 Napoleone
ottiene attraverso un plebiscito la conferma della carica a vita e nel 1804 la trasforma, sempre
attraverso un plebiscito, in monarchia ereditaria, assumendo il titolo di imperatore dei Francesi.
Quest’ultima dizione – imperatore dei Francesi, non di Francia – così come il ricorso al plebiscito
testimoniano della consapevolezza del carattere nuovo e diverso della monarchia napoleonica
rispetto a quelle tradizionali di diritto divino e cioè il riconoscimento che il fondamento del potere
risiede nella volontà popolare.
Con Napoleone si realizza perciò, per la prima volta, un regime al cui centro sta un «uomo
forte», capace di controllare l’esercito ma che al contempo ottiene il consenso grazie all’appoggio,
sancito col voto, della maggioranza della popolazione. Questo modello verrà ripetuto, dopo la sua
proposizione da parte di Napoleone, in varie forme nell’Europa del XIX secolo, a partire dalla sua
imitazione da parte di Luigi Napoleone, nipote di Napoleone I e protagonista nel 1851 di un colpo
di Stato autoritario ricalcato su quello compiuto dallo zio. Gli storici hanno chiamato questo
fenomeno cesarismo, con riferimento al regime di dittatura militare imposto nella Roma antica da
Giulio Cesare (48 a.C.) che mise fine, proprio come quello di Napoleone, all’esperienza
repubblicana.
Per i francesi, stanchi di un lungo periodo di insicurezza, Napoleone rappresenta la fine dei
turbolenti contrasti politici interni, una normalizzazione che tuttavia promette di conservare una
parte delle conquiste realizzate con la Rivoluzione. Ed effettivamente l’ordine politico e sociale
costruito da Napoleone è qualcosa di molto diverso da quello della monarchia dei Borbone. SI
realizza infatti la rottura di quell’universo di diritti e poteri legittimi di antico regime che la politica
assolutistica ha solo scalfito. Riaffermata la propria volontà – espressione riflessa di un’originaria
volontà popolare – come un'unica fonte della legislazione, Napoleone si impegna in un lavoro di
codificazione e di omogeneizzazione delle norme giuridiche, promulgando un Codice civile che
salvaguarda i diritti essenziali di libertà personale, di rispetto della proprietà privata, di uguaglianza
giuridica degli individui.
Al tempo stesso Napoleone, attraverso una politica di pacificazione con i filomonarchici, la
reintroduzione di titoli onorifici della nobiltà e un concordato con la Santa Sede (1801), che prevede
il riconoscimento del regime in cambio della proclamazione del cattolicesimo come religione della
maggioranza dei francesi, tende a consolidare le dubbie fasi di legittimità del proprio potere.
Il perno del mutamento prodotto da Napoleone è però la riforma amministrativa. Le tecniche
di comando elaborate in campo militare vengono infatti trasferite alle procedure esecutive della
macchina statale, impostata in modo gerarchico e piramidale e strettamente dipendente da ordini
provenienti dall’alto. L’intero territorio francese viene sottoposto a un immenso sforzo conoscitivo
necessario alla costruzione di un governo centralistico, realizzato attraverso la scelta governativa
dei sindaci e l’azione al loro fianco, con funzioni di controllo e di direzione generale, di speciali
inviati di governo, chiamati prefetti,
In ogni aspetto della vita collettiva lo Stato pretende di avere un ruolo sempre più incisivo.
Ciò, da un lato, produce il netto miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, dell’istruzione e
dell’efficienza amministrativa; dall’altro, comporta la sottomissione di tutta la società francese a
ordini emessi da un potere imperscrutabile, alla tendenza a porre stretti vincoli all’attività
individuale, all’imposizione di un serrato controllo poliziesco sull’espressione del libero pensiero.
Nasce un nuovo ordine, in cui un potere esecutivo di ispirazione militaresca, pur riconoscendo
l’irreversibilità di alcune conquiste democratiche, tende a far leva su di esse per imporre una
gestione autoritaria, svincolata da contrappesi e controlli.
Essenziale per il processo di razionalizzazione e potenziamento delle strutture statale è
anche la formazione di personale addestrato a lavorare nella nuova macchina amministrativa
pubblica, un gruppo sociale il cui incremento quantitativo si accompagna all’acquisto di una diversa
consapevolezza della rilevanza del proprio ruolo. Si tratta di persone che godono di un salario certo
e di un corrispondente riconoscimento sociale e che sono animate da una nuova etica del servizio
pubblico, ispirata a valori di dedizione alla patria e al bene collettivo. Soprattutto, essi vedono
confermati i principi egualitari della Rivoluzione che impongono che gli alti gradi
dell’amministrazione siano riservati ai meritevoli e non ai privilegiati per nascita.
A questo fine Napoleone dà avvio al sistema delle grandi scuole pubbliche d’eccellenza,
vera e propria fucina di quadri per l’amministrazione pubblica. Grazie al talento chiunque adesso
può aspirare, anche partendo da posizioni sociali svantaggiate, agli alti gradi della burocrazia. È
attraverso questi funzionari e impiegati pubblici che viene promosso e si realizza il sempre più
massiccio intervento dello Stato nella vita dei Francesi. Lo Stato assume così il volto anonimo e
imperscrutabile di una catena di comando che dall’autorità imperiale discende fino alle più modeste
funzioni degli uffici amministrativi periferici. Anche la forma di governo monarchica si piega alle
nuove regole di organizzazione dello Stato e diviene quella che è stata chiamata una monarchia
ammnistrativa, la cui autorità e visibilità si basa sui moderni apparati dell’amministrazione pubblica
più che sulla tradizionale legittimazione sacrale.
Apparentemente, la quantità di direttive emanate dall’amministrazione è tale da ridurre il
peso delle scelte degli impiegati pubblici, di quella che comincia a essere chiamata burocrazia
statale. Sembrerebbe, cioè, a prima vista, che la precisione delle norme sia tale da ridurre il margine
di discrezionalità del funzionario, in ossequio all’ideale rivoluzionario del primato e della certezza
della legge scritta priva di equivoci e lacune dove possono annidarsi abusivamente poteri particolari
e privilegi.
In realtà, la straordinaria crescita della produzione legislativa, l’affermarsi di un un
tecnicismo giuridico, l’ampliamento del raggio di intervento dello Stato all’intera vita associata,
aumentano sensibilmente il potere burocratico di mediazione. Essendo crescente la mole delle
norme e delle procedure da rispettare, il funzionario dispone di un ampio margine di interpretazione
e di discrezionalità e può contare, tra la cieca ubbidienza ai regolamenti e l’indolente trascuratezza
verso di essi, su un’infinità di varianti di comportamento. I burocrati sono, a ben vedere, i
protagonisti della monarchia amministrativa. È grazie a loro che il regime napoleonico si consolida
e sono ancora loro a creare i modelli di gestione della cosa pubblica che le truppe francesi
esportano, a seguito della spinta espansionistica impressa da Napoleone, in tutta Europa.
L’estensione del modello statale a larga parte d’Europa e la sua adozione anche da parte di
regimi legittimisti, guidati cioè dai tradizionali monarchi, suscita un’ondata di reazioni senza
precedenti. I primi due terzi del XIX secolo sono un’epoca di vivissima discussione pubblica sulla
natura e l’equilibrio dei poteri, di lotte furibonde sulla loro distribuzione, di rivolte. La spinta
egualitaria impressa dalla Rivoluzione francese, che il regime napoleonico ha in parte mantenuto, si
manifesta in un nuovo ordine politico e nel conseguente smantellamento delle istituzioni di antico
regime. La sua estensione a larga parte d’Europa incontra aspre resistenze da parte dei ceti
privilegiati ma offre anche un orizzonte di speranza per masse di individui cui la partecipazione alla
vita politica appare adesso la strada maestra per il miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Liberalismo e democrazia
L’esperienza della prima e, soprattutto, della seconda Rivoluzione inglese e la riflessione
teorica che corre da Hobbes a Rousseau affermano con forza nella cultura europea del XVIII secolo
l’idea che esiste una sfera di diritti individuali che è inviolabile – qualunque sia l’ordinamento
politico che si auspica – e che la sovranità, l’insieme dei poteri cui devono sottostare gli abitanti di
un determinato territorio, non rappresenta un diritto acquisito, per volontà divina, dai monarchi, ma
appartiene al popolo, cioè all’insieme dei cittadini, che la cedono al fine di ottenere pace, sicurezza
e un adeguato funzionamento della macchina statale. Questi principi essenziali costituiscono la base
ideologica della Rivoluzione americana e della Rivoluzione francese che, sin dai loro momenti
fondativi, sono caratterizzate dall’esigenza di porre per iscritto i limiti dell’azione del potere statale
e le regole condivise che devono ispirare la vita comune di tutti i cittadini.
Già nella Dichiarazione d’indipendenza americana (1776) sono sanciti per la prima volta
alcuni diritti inalienabili e naturali di tutti gli uomini, gli stessi sostenuti in Inghilterra nella lotta
contro il progetto assolutistico degli Stuart: il diritto di ogni persona alla vita, alla libertà, alla
ricerca della felicità, all’espressione delle opinioni e della fede, alla proprietà e a un giusto
processo. Ciò entro il quadro dell’affermazione della supremazia della legge (rule of law) sui poteri
costituiti e sulla divisione e autonomia di questi ultimi. A questi principi, definiti principi di libertà
o principi liberali – donde il termine di liberalismo per indicarne l’insieme – si affiancano tuttavia
altri principi, elaborati dalla tradizione repubblicana e dalla cultura illuministica, che prevedono
l’eguaglianza di ogni individuo di fronte alla legge e perciò l’eliminazione di ogni partizione per
ordini o ceti, la sovranità popolare e la partecipazione di tutti alla decisione politica. Questi principi
sono stati definiti democratici, dal greco dèmos, popolo, e kràtos, potere: democrazia è il termine
che descrive un regime in cui il potere spetta al popolo.
La definizione e diffusione dei principi democratici riceve un forte impulso con la
Rivoluzione francese, che decreta il fallimento del modello assolutistico, ormai anacronistico in
un’epoca in cui il principio della compartecipazione, almeno delle élites, alle principali scelte
politiche inizia ad affermarsi con forza. Oltre ad abbattere la monarchia, a fondare la Prima
Repubblica francese e a trasformare completamente il linguaggio della politica, la rivoluzione
afferma nel Vecchio Continente l’elemento basilare che è alla radice della formazione degli Stati
Uniti d’America: i governanti devono essere eletti dai governati e rimanere sotto il loro controllo.
Soprattutto, la sovranità appartiene esclusivamente al popolo che la esercita attraverso
un’assemblea di rappresentanti che ne esprime la volontà generale. Per tale ragione la Rivoluzione
francese privilegia il principio elettivo a quello della nomina, che è un tipico attributo della
monarchia e subordina il ruolo del potere esecutivo e del potere giudiziario a quello del potere
legislativo, l’unico in cui possa esprimersi in modo trasparente la volontà popolare. Allo stesso
modo, la scelta di optare per una sola camera – senza creare una «camera alta» come in Inghilterra e
negli Stati Uniti – rappresenta un netto orientamento a favore della forma repubblicana di Stato e di
un accesso al voto molto ampio, tendenzialmente universale.
L’alternativa tra monarchia e repubblica ben rappresenta per tutto il corso dell’Ottocento il
terreno di confronto e di contrasto tra liberalismo e democrazia. In via generale, il pensiero liberale
ottocentesco individua nella monarchia un utile strumento di difesa dagli eccessi della democrazia e
per lungo tempo indica nella monarchia parlamentare di tipo inglese la forma di Stato meglio adatta
a garantire i diritti della proprietà privata, della libertà personale, della divisione dei poteri.
Viceversa il pensiero democratico vede nella monarchia, anche costituzionale, un’istituzione del
passato, un residuo del mondo del privilegio opposto a quello dell’eguaglianza giuridica e politica
di tutti i cittadini.
Un esempio delle differenze fra liberali e democratici nel pensare la distribuzione dei poteri
nella società è dato dalla diversa impostazione del problema della partecipazione al voto. Mentre i
democratici vedono il voto come l’espressione di un diritto naturale, proprio di ogni persona adulta
(inizialmente gli uomini, poi anche le donne) è tipico dell’impostazione liberale, almeno di quella
ottocentesca, tentare di riservare il diritto di voto solo a coloro che possiedono una proprietà o che
comunque pagano un livello minimo di tasse detto censo (da cui deriva l’aggettivo censitario per
indicare i sistemi elettorali a voto ristretto), Seguendo un pensiero tradizionale, già sviluppato nelle
società di antico regime, l’accesso al voto è infatti legato per il pensiero liberale al diritto di
controllare come siano spesi i soldi versati allo Stato dai cittadini sotto forma di imposte: solo chi
partecipa al mantenimento della cosa pubblica ha un interesse reale e positivo a migliorarne
l’efficienza.
Altro requisito richiesto è la capacità dell’elettore di leggere e scrivere: un elemento di
grande peso in molti paesi europei dove consistenti quote della popolazione sono analfabete. Anche
quando viene costretto, via via sempre più a partire dalla seconda metà del XIX secolo, ad accettare
il principio democratico del suffragio universale, il punto di vista liberale ritiene comunque
necessario privilegiare e offrire maggiore spazio politico a coloro che sono considerati come la
parte migliore e più sana della nazione, i benestanti e i colti.
Tale diversa impostazione del problema della partecipazione popolare al voto si riflette
anche nelle diverse opzioni sul tipo di modello di competizione elettorale e sulle forme del potere
legislativo.
I democratici preferiscono tendenzialmente una rappresentanza di tipo proporzionale, in cui
cioè gli eletti sono in numero proporzionale ai voti raccolti da tutta la lista in cui figurano: un
sistema che garantisce l’espressione parlamentare di tutte le tendenze politiche del corpo elettorale.
I liberali, viceversa, basandosi sul modello inglese e statunitense, preferiscono l’elezione per collegi
uninominali, in cui viene cioè eletto il candidato che prende più voti in assoluto in un’area ben
precisa. Ciò perché questo sistema favorisce l’alternanza e la governabilità conferendo un’ampia
maggioranza parlamentare a chi è in grado di conquistare collegio per collegio anche un risicato
margine di vantaggio.
I democratici, inoltre, prediligono il sistema parlamentare monocamerale, secondo il
modello impostosi con la Rivoluzione francese, mentre il sistema bicamerale è sostenuto dai liberali
che ritengono che le scelte di carattere legislativo vadano assoggettate a un meccanismo di
bilanciamento e di doppia votazione in due camere distinte in modo da far prevalere l’equilibrio
degli interessi e la ponderazione. Spesso questa ispirazione risente del modello inglese, in cui la
Camera dei Lords – fino a tutto l’Ottocento – funge da freno conservatore alle scelte della Camera
dei Comuni. Non potendo riproporre per i sistemi che non l’avevano mai contemplata una «camera
dei nobili» con accesso per mera ereditarietà in un’epoca – l’Ottocento – di crescente
democratizzazione, i liberali propongono varie formule per fare delle seconde camere (spesso
chiamate senati) un contrappeso moderato al rischio di eccessi democratici: ipotizzano, perciò, e
realizzano assemblee i cui membri vengono scelti dal re o dai presidenti delle repubblica tra i
facoltosi, i nobili, i benemeriti della cultura e della scienza, gli industriali. Il fatto che per l’attuale
Senato della Repubblica italiana l’elettorato attivo (chi vota) e passivo (chi è votato) prevedano età
di accesso più elevate di quelle richieste per le elezioni della Camera dei Deputati così come la
possibilità per il presidente della Repubblica di nominare cinque senatori a vita tra le persone più
illustri della nazione, sono evidenti retaggi di tale impostazione.
La società civile contro la società politica
L’Ottocento è il secolo in cui più profondamente emerge la contraddizione tra principi di
uguaglianza teoricamente stabiliti e pratiche sociali dell’esclusione e dell’ineguaglianza, tra il
proclamato primato del potere legislativo e una crescente tendenza a rafforzare il potere esecutivo.
Ed è anche il periodo in cui emerge un nuovo protagonista del potere pubblico: la società civile.
Questo termine è venuto a indicare col tempo la crescita e la stabilizzazione di una capacità
autonoma del corpo sociale di difendere o reclamare diritti e prerogative in autonomia e anche in
contrasto rispetto alle scelte legislative e di governo. Il mantenimento, in altre parole, di una
capacità di espressione dei governati che si manifesta, così, al di fuori dei canali della
rappresentanza politica. Si viene costruendo in tal modo quella che è una caratteristica di fondo
delle società moderne e cioè la contrapposizione tra una sfera politica, composta dai detentori a
vario titolo dei poteri pubblici, e una sfera civile immaginata come depositaria dell’opinione
pubblica e capace di esprimere perciò la libera volontà dei cittadini.
Questa contrapposizione non è solo teorica. La società civile è stata a lungo, nel XIX secolo,
una società rivoluzionaria, impegnata a cospirare contro regimi autoritari e a combattere per la
libertà politica o per la liberazione dei popoli dal dominio straniero. Tutte queste lotte vengono
organizzate per lo più al di fuori dei palazzi del potere politico e in contrapposizione a esso, nelle
strade e nei caffè, in ritrovi informali e nei club, nonché in associazioni segrete con finalità ideali e
politiche come la Massoneria, a livello internazionale, o la Carboneria e la Giovine Italia
mazziniana, nell’Italia del Risorgimento, che sostengono la sovranità popolare, la libertà dei popoli,
la tolleranza religiosa e il libero pensiero.
Mentre la sfera politica, attraverso i nuovi modelli amministrativi napoleonici, punta a
controllare tutto l’universo sociale, una sfera pubblica, propria cioè della società civile, si fornisce
di una capacità comunicativa autonoma, non del tutto controllata dal potere politico e anzi capace di
resistere a tale controllo. Strumento fondamentale di questa sfera comunicativa pubblica è,
naturalmente, la stampa. Giornali, riviste, libri si vanno moltiplicando agevolando la circolazione
dell’informazione, accrescendo le opportunità di confronto e discussione, definendo ambiti in cui
l’esercizio della critica politica e sociale si conquista uno spazio autonomo rispetto alle istituzioni
del potere pubblico.
Cambia naturalmente la qualità della partecipazione. A dispetto della Restaurazione
successiva alla caduta dell’impero napoleonico, la forza di rottura dell’esperienza della Rivoluzione
francese e dell’amministrazione napoleonica in molti paesi europei modifica profondamente i
rapporti politici. Gli individui, adesso, entrano a far parte della vita politica in quanto tali e non più
come componenti di corpi o di ceti sociali e questo significa concretamente una, sia pur parziale,
ammissione ai circuiti della politica di masse di uomini tenuti in precedenza i margini della
discussione delle scelte pubbliche. La lotta per la democratizzazione della politica, in particolare, si
viene affermando nel corso del XIX secolo attraverso ripetute battaglie per la riforma dei sistemi
elettorali e la conquista del suffragio universale, per la piena attuazione dell’uguaglianza giuridica,
per la libertà di espressione, per la tolleranza religiosa. I regimi politici monarchici di stampo
assolutistico ne escono travolti. Ma anche i sistemi politici liberali sono costretti a tenere conto di
questa immensa spinta e si democratizzano progressivamente, accettando il principio
dell’eguaglianza dei cittadini e assumendo l’orientamento che oggi definiamo liberaldemocrazia.
Nel corso dell’Ottocento, inoltre, questa tensione incontra, fondendosi con essa, la tendenza
alla rivendicazione nazionale, all’idea, cioè, che laddove ci sia un popolo caratterizzato da lingua e
costumi identificabili debba esserci uno Stato nazionale. Si può dire, in altre parole, che il
linguaggio nazionale e la discussione pubblica sui diritti dei popoli alla libertà sono il tramite
attraverso cui si affermano in parte anche istanze democratiche.
Contemporaneamente si afferma, però, anche un uso autoritario della tematica nazionalista,
volto cioè a mobilitare le masse contro un nemico esterno al fine di rinsaldare il consenso
all’interno attorno a un’autorità suprema, un «capo». Tanto nella Francia della Terza Repubblica
quanto nella Germania dell’Impero, si afferma una concezione che vuole la struttura democratico-
parlamentare, cui è assegnato il potere legislativo, controbilanciata da un esecutivo forte. In Francia,
al presidente della Repubblica sono riservate la competenza della politica estera e il ruolo di capo
dell’esercito: per questa ragione presidenzialisti si dicono tutti i regimi in cui al presidente sono
assegnate competenze importanti. Nel Reich, l’Impero tedesco nato nel 1871, il cancelliere,
responsabile delle attività di governo, riceve l’incarico dall’imperatore e risponde del suo operato a
lui e non al Parlamento, che mantiene una funzione legislativa limitatamente alla politica interna e
un ruolo di controllo sulle finanze.
L’affermazione di queste tendenze autoritarie ha molto a che fare con la diffusione di idee
radicalmente democratiche e con il loro fuoriuscire dalla sfera strettamente politica per abbracciare
l’insieme dei rapporti sociali. La tensione egualitaria e la critica del privilegio, in altre parole,
investono ambiti prima non direttamente toccati dalla discussione politica, quali quelli della
proprietà personale, del controllo dei sistemi produttivi, della sperequazione delle condizioni
sociali. Si può, anzi, meglio dire che nella crescita della sfera pubblica hanno un ruolo decisivo le
rivendicazioni sociali e cioè l’ampliamento della lotta politica a temi come le condizioni del lavoro,
il salario o il diritto alle cure sanitarie, in precedenza lasciati alla contrattazione dei singoli.
In riferimento all’esplodere, nel corso dell’Ottocento, della consapevolezza diffusa che
enormi masse di uomini e donne non accettano più lo sfruttamento, lo squallore di vite distrutte
dalla fatica e dalla miseria e il senso di ingiustizia derivante dall’ineguaglianza delle condizioni tra
chi lavora duramente e chi gode di una condizione di privilegio sostenuta proprio dai frutti di quel
lavoro, si parla di questione sociale. E quei movimenti che si propongono di democratizzare non
solo le condizioni di accesso alla politica ma anche le condizioni di vita, rendendole il più possibile
uguali, sono i movimenti socialisti.
Essi non considerano le proprie lotte come continuazione di quelle per i diritti politici,
sostenendo che il sistema delle garanzie individuali e i sistemi elettorali a suffragio ristretto
configurano una democrazia limitata, utile solo ad alcune fasce sociali privilegiate ma tendente a
escludere i più: una democrazia monca, fatta per soddisfare concretamente solo la difesa di alcuni
diritti, come quello al godimento della proprietà privata, e pronta a escluderne altri: una democrazia,
perciò, rinchiusa in alcune regole formali e incapace di dare corpo all’ideale dell’uguaglianza di
tutti gli individui di fronte alla legge. Anche laddove si realizzi un sistema politico totalmente
democratico, la democrazia formale lascia in altre parole inevasa la questione dell’ineguaglianza
delle condizioni sociali, connaturata alla proprietà privata e in specie al controllo privato dei mezzi
di produzione che presuppone, per conseguire il proprio obiettivo economico, lo sfruttamento del
lavoro salariato.
Per concludere
Nel corso del XX secolo lo scontro tra un movimento democratico sempre più radicale e
governi tentati da soluzioni autoritarie, che si produce nell’Ottocento, raggiunge il suo apice con la
nascita di movimenti e regimi comunisti, volti a imporre l’istituzione di una società integralmente
egualitaria e perciò in teoria perfettamente democratica. Dopo la vittoriosa rivoluzione russa
dell’ottobre 1917 questa possibilità diviene realtà con la nascita dell’Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche. Lo sforzo di questa costruzione di una società più giusta e più libera dallo
sfruttamento è tuttavia condotto dall’alto e attraverso un uso autoritario della macchina statale, con
un privilegiamento del potere esecutivo su quello legislativo e senza garanzie di autonomia del
potere giudiziario. Ciò significa la distruzione progressiva di tutti i principali diritti civili e delle più
elementari garanzie democratiche fino alla creazione, sotto la guida di Stalin, di un regime del
terrore di massa. Questo modello viene esportato dall’Urss in tutto il mondo e prende piede in molti
paesi del Terzo mondo in cui l’ideologia comunista si mescola con il richiamo nazionalistico nel
quadro delle lotte per la liberazione dal dominio coloniale.
Gli ideali comunisti sono perciò per il mondo intero, e per gran parte del XX secolo, gli
ideali del riscatto di enormi masse di persona – si pensi solo alla nascita della Repubblica popolare
cinese nel 1949 – desiderose di vincere l’oppressione straniera e di fuoriuscire da condizioni di
sfruttamento, di umiliazione e di sofferenza. Allo stesso tempo, ciò provoca l’adozione di un
modello di organizzazione dello Stato che, identificato nei fatti con il Partito comunista, abolisce le
elezioni e le garanzie democratiche, impedisce con la forza e talora con la pura e semplice
repressione armata ogni attività di dissenso e in generale ogni manifestazione di autonomia da parte
della società civile. Il tentativo di imporre la collettivizzazione o nazionalizzazione delle terre e
delle industrie e al più o meno ampia confisca statale della proprietà privata conducono oltretutto a
un’abnorme crescita degli apparati statali pubblici, e di conseguenza della loro corruzione e
inefficienza, mentre viene indebolita grandemente la capacità di produrre ricchezza e innovazione.
Questo dominio del potere state si presenta con simile forza anche in regimi di ispirazione
nazionalista e razzista sorti in Europa (il fascismo in Italia e il nazismo in Germania) e da qui
diffusisi in Europa e nel mondo. Liquidata con forza la questione sociale, questi regimi viceversa
mantengono e favoriscono l’ineguaglianza delle condizioni economiche, in un quadro di
privilegiamento di un potere esecutivo dai tratti autoritari di stampo militarista. Al vertice del potere
sta un capo, insieme militare e civile, che fa valere la propria volontà, talora criminale, al di fuori e
al di là di ogni regola. Abolite le garanzie democratiche, si impone un ferreo controllo dello Stato
sulla società civile che viene a essere quasi annullata.
Le somiglianze tra i due tipi di regime – il nazifascismo da una parte e il comunismo
sovietico dall’altra – sono molteplici e hanno portato gli storici, per sottolinearle, ad adottare la
categoria di totalitarismo. Ciò che qui interessa rimarcare è che quel secolare processo di
costruzione di spazi di libertà individuale, di affermazione dei diritti delle persone, di garanzie
democratiche di controllo dei governati sui governanti, iniziato nel Seicento, subisce nel corso del
XX secolo una tragica battuta d’arresto. Nei regimi totalitari, infatti, la società civile non ha alcuno
spazio separato di espressione ed è, per così dire, assorbita da un apparato statale che si può definire
totale perché nulla può accadere ed è ammesso se non all’interno di esso e sotto il suo diretto
controllo.
L’attuale distribuzione dei poteri nella nostra società è il frutto di questa esperienza e cioè
del difficile superamento dei regimi totalitari e della graduale estensione delle libertà a molte
società che ne erano prive. Per quanto si possa a buon diritto sostenere che la vera democrazia oggi
è ben lungi dall’essere realizzata e che buona parte dei poteri pubblici sfugge realmente al controllo
dei cittadini, l’insieme di contrappesi e di garanzie che sono stati elaborati, conquistati e difesi nella
lunga vicenda storica europea, nonché la stessa esistenza di una società civile distinta da quella
politica, costituiscono le sole forme di resistenza storicamente esperite rispetto alla tendenza dello
Stato a dettare interamente le regole del gioco sociale.
Oggi, le resistenze contro questa tendenza si sono fatte ancora più forti. Il potere esorbita
largamente dai confini tradizionali e si presenta come capacità di influenza esercitata da gruppi di
pressione o da potentati economici, soggetti in teoria esterni al sistema politico democratico. A
fianco di quelli codificati dalla tradizione politica, altri e nuovi poteri si rafforzano. I grandi gruppi
economici, in particolare, si attrezzano per orientare direttamente, e non più solo in modo indiretto,
la vita politica. Negli Stati Uniti e in molti stati europei sono state varate normativa sul cosiddetto
conflitto di interessi, al fine di impedire un uso strumentale del potere esecutivo a vantaggio di
interessi economici personali di esponenti di governo, ma resta aperta la questione se un sistema
democratico possa tollerare l’influenza pervasiva sulle decisioni politiche di veri e propri giganti
economici, le cui finalità di profitto non sempre si conciliano con la cura della cosa pubblica.
All’indomani della caduta in Europa di ogni forma di regime totalitario, si può dire che la
monarchia intesa come esercizio del potere da parte di un univo soggetto sovrano – sia pure esso lo
Stato – sia davvero finita e che al suo posto la democrazia abbia dato vita a una molteplicità di
poteri che reclamano autonomia e un proprio spazio di azione. La tradizionale separazione tra la
società politica e la società civile si fa più imprecisa, così come più incerta tende a divenire la
definizione dei poteri pubblici nella misura in cui funzioni pubbliche vengono affidate a mani
private, in base al cosiddetto principio della sussidiarietà.
In generale, dopo il lutti del XX secolo, nessun Leviatano, il mostro biblico divenuto
simbolo del potere assoluto dello Stato, sembra più in grado di raccogliere la fiducia collettiva e
cresce anzi, e si fa acuto, il sospetto nei confronti delle sue pretese.