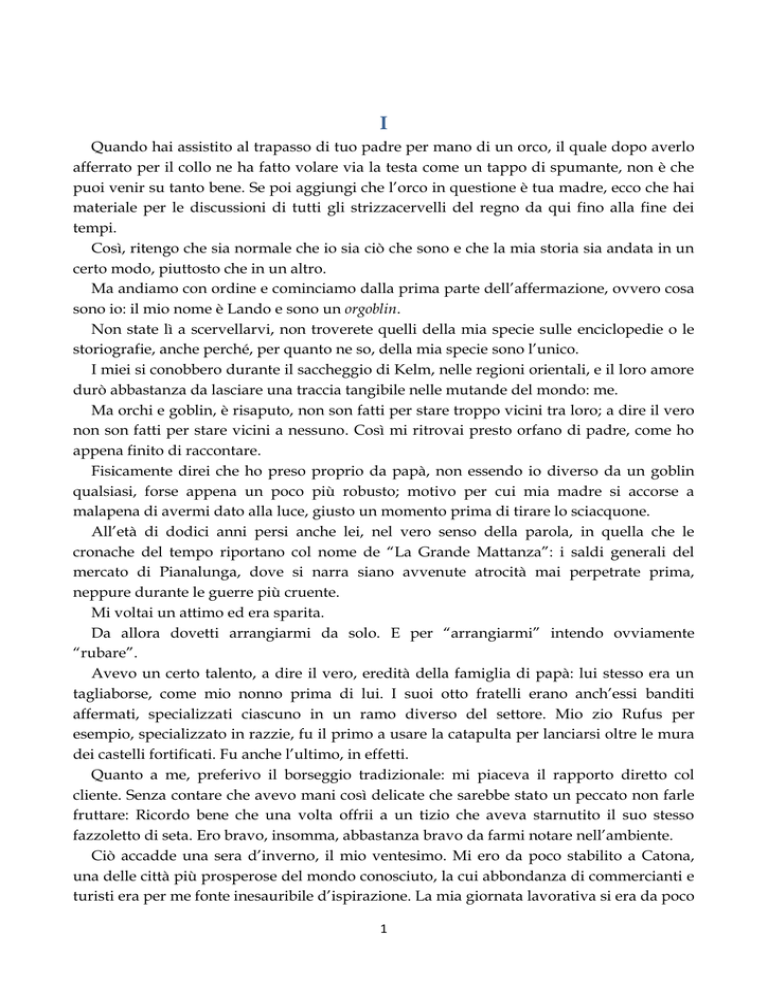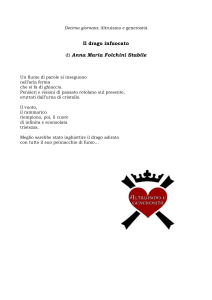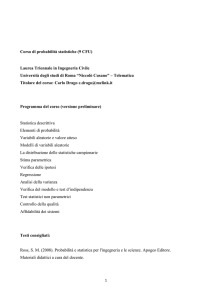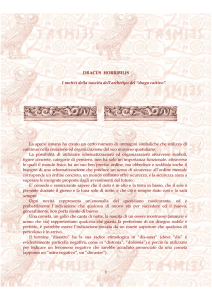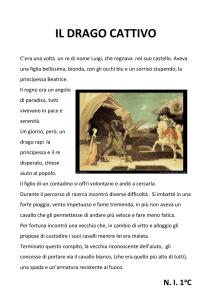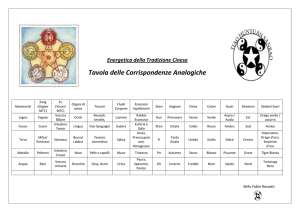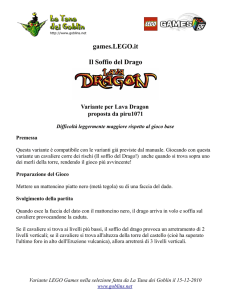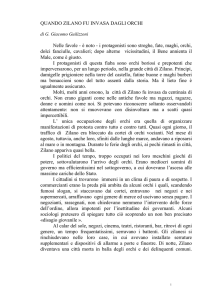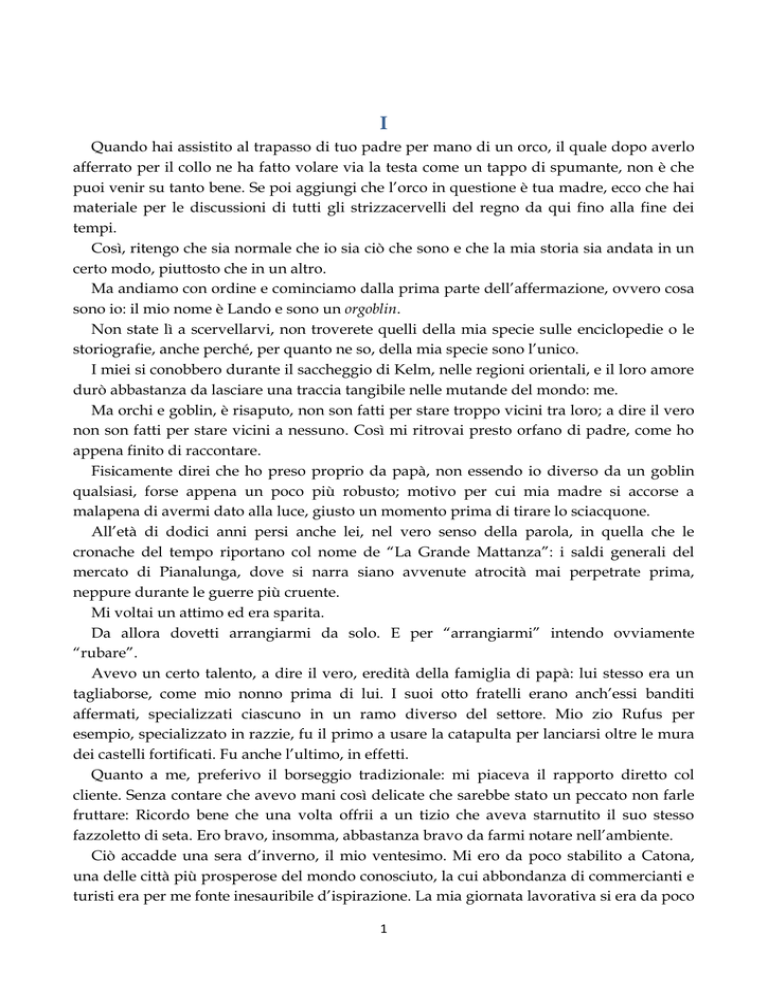
I
Quando hai assistito al trapasso di tuo padre per mano di un orco, il quale dopo averlo
afferrato per il collo ne ha fatto volare via la testa come un tappo di spumante, non è che
puoi venir su tanto bene. Se poi aggiungi che l’orco in questione è tua madre, ecco che hai
materiale per le discussioni di tutti gli strizzacervelli del regno da qui fino alla fine dei
tempi.
Così, ritengo che sia normale che io sia ciò che sono e che la mia storia sia andata in un
certo modo, piuttosto che in un altro.
Ma andiamo con ordine e cominciamo dalla prima parte dell’affermazione, ovvero cosa
sono io: il mio nome è Lando e sono un orgoblin.
Non state lì a scervellarvi, non troverete quelli della mia specie sulle enciclopedie o le
storiografie, anche perché, per quanto ne so, della mia specie sono l’unico.
I miei si conobbero durante il saccheggio di Kelm, nelle regioni orientali, e il loro amore
durò abbastanza da lasciare una traccia tangibile nelle mutande del mondo: me.
Ma orchi e goblin, è risaputo, non son fatti per stare troppo vicini tra loro; a dire il vero
non son fatti per stare vicini a nessuno. Così mi ritrovai presto orfano di padre, come ho
appena finito di raccontare.
Fisicamente direi che ho preso proprio da papà, non essendo io diverso da un goblin
qualsiasi, forse appena un poco più robusto; motivo per cui mia madre si accorse a
malapena di avermi dato alla luce, giusto un momento prima di tirare lo sciacquone.
All’età di dodici anni persi anche lei, nel vero senso della parola, in quella che le
cronache del tempo riportano col nome de “La Grande Mattanza”: i saldi generali del
mercato di Pianalunga, dove si narra siano avvenute atrocità mai perpetrate prima,
neppure durante le guerre più cruente.
Mi voltai un attimo ed era sparita.
Da allora dovetti arrangiarmi da solo. E per “arrangiarmi” intendo ovviamente
“rubare”.
Avevo un certo talento, a dire il vero, eredità della famiglia di papà: lui stesso era un
tagliaborse, come mio nonno prima di lui. I suoi otto fratelli erano anch’essi banditi
affermati, specializzati ciascuno in un ramo diverso del settore. Mio zio Rufus per
esempio, specializzato in razzie, fu il primo a usare la catapulta per lanciarsi oltre le mura
dei castelli fortificati. Fu anche l’ultimo, in effetti.
Quanto a me, preferivo il borseggio tradizionale: mi piaceva il rapporto diretto col
cliente. Senza contare che avevo mani così delicate che sarebbe stato un peccato non farle
fruttare: Ricordo bene che una volta offrii a un tizio che aveva starnutito il suo stesso
fazzoletto di seta. Ero bravo, insomma, abbastanza bravo da farmi notare nell’ambiente.
Ciò accadde una sera d’inverno, il mio ventesimo. Mi ero da poco stabilito a Catona,
una delle città più prosperose del mondo conosciuto, la cui abbondanza di commercianti e
turisti era per me fonte inesauribile d’ispirazione. La mia giornata lavorativa si era da poco
1
conclusa e mi accingevo a consumarne i frutti al Verro Danzante, una locanda pittoresca
situata nei pressi del porto.
A pochi passi dalla meta, fui però raggiunto e fermato da due brutti ceffi.
Il brutto ceffo numero uno era un uomo alto, col labbro leporino, che in un ambiente di
gentiluomini quale quello di cui stiamo discutendo non poteva che essere conosciuto col
nomignolo di Pete il Coniglio.
Il brutto ceffo numero due lo chiamavano Mastro Panza, e con ciò spero di potermi
risparmiare ulteriori spiegazioni.
«Fei tu Lando?» mi chiese Pete il Coniglio.
«Dipende chi vuole saperlo.»
Mastro Panza mi diede un pugno nello stomaco.
«Riproviamo. Fei tu Lando?»
«Fì, fono io.»
Ora fu Pete il Coniglio a darmene uno, e fu così che quel giorno imparai che i brutti ceffi
non hanno il senso dell’umorismo.
«C’è un amico che vuole vederti» proseguì «feguici.»
E io: «Fubito.»
D’accordo, forse non lo imparai proprio quel giorno.
Fui scortato lungo un vicolo buio e umido, fino all’entrata di uno dei magazzini del
porto. Con un cenno del capo Mastro Panza mi fece capire che dovevo entrare.
Era un vecchio deposito di reti e cordami, in cui il lezzo di pesce e salsedine si
mescolava a un vago sentore di liquore di contrabbando. Era più grande di quel che
sembrava da fuori: le innumerevoli casse e i rotoli immensi di corda per gli ormeggi erano
stati addossati alle pareti, lasciando al centro uno spiazzo abbastanza grande, dal fondo di
terra, illuminato da lanterne a olio così fuligginose che più che luce facevano buio. Al
centro di questo spiazzo c’era una sedia, legato alla sedia c’era quel che restava di un
uomo. Di spalle, con una mazza grondante sangue stretta nella mano destra, c’era lui.
Zio Lou, così lo conoscevano tutti, era un uomo calvo e grasso, sui sessant’anni, di cui si
diceva che fosse forte come un orco, ma non altrettanto amichevole. Sul petto ora nudo
cresceva un pelo grigio setoloso.
Vedendomi sorrise, mostrando zanne indegne di un essere umano.
«Ti stavo aspettando» disse, strascicando i piedi mentre veniva nella mia direzione.
Io deglutii così forte che mandai giù anche la lingua.
«Mi hanno parlato molto bene di te. Molto bene. Siediti, vuoi? Siediti.»
E così dicendo indicò la sedia, in verità ancora occupata.
«Sto bene in piedi, grazie.»
Lui fece spallucce, poi proseguì: «Ho sentito dire che sei veloce e che in questi giorni ti
sei dato parecchio da fare nel quartiere. Nel mio quartiere.»
Si voltò, diretto verso una pila di casse ammonticchiate alla rinfusa. Sulla schiena gli
cresceva una specie di criniera, una striscia villosa larga circa due centimetri e lunga dalla
nuca fino al sedere, che ben completava quella sua aria da cinghiale sudato.
2
Depose con delicatezza l’arma e dalla cassa estrasse una bottiglia contenente un liquido
torbido, che tracannò avidamente dopo averne estratto il tappo con i denti.
Poi la passò a me. «Bevi» ordinò.
Aveva l’odore dello zolfo e se mai avessi assaggiato lo zolfo prima d’allora avrei detto
che ne aveva anche il sapore. Mi disintegrò completamente le budella, come trangugiare
una manciata di chiodi roventi.
«Distillato di fegato di drago» spiegò Zio Lou «una rarità. Un’autentica rarità, almeno
da quando i maledetti ambientalisti hanno deciso che i draghi non sono bestie schifose ma
“specie a rischio d’estinzione”. A rischio d’estinzione, capisci?»
Sputò in terra sdegnato e la saliva densa impattò il suolo con l’effetto di un petardo.
«Ma parliamo d’affari, vuoi? Parliamo.»
Quando Zio Lou diceva “parliamo” ovviamente intendeva che lui avrebbe parlato e tu
avresti ascoltato e condiviso tutto quello che aveva da dire. Così accadde che, senza sapere
bene come, mi ritrovai coinvolto nel giro del contrabbando.
Era un lavoro semplice tutto sommato e a ben pensarci anche meno rischioso dello
scippo tradizionale. Dovevo soltanto recuperare le ampolle di concentrato di olio di fegato
di drago alla periferia della città e farle arrivare alla distilleria di Zio Lou. I cacciatori di
draghi da cui mi rifornivo erano tipi taciturni e a me andava bene così: niente domande,
niente problemi.
Finché, ovviamente, un bel giorno qualcosa andò storto.
Erano passati mesi da quando avevo cominciato a lavorare per lo Zio Lou. Il luogo dove
ero solito incontrare i cacciatori era un vicolo sudicio nei pressi del mercato settentrionale,
attraversato perennemente al suo centro da un rivolo maleodorante di liquami dei quali la
calura estiva amplificava i miasmi, che si levavano in continue zaffate. Potete immaginare
dunque quanto ardentemente desiderassi che gli scambi si concludessero in fretta, per
rimanere il meno possibile in quel tunnel degli odori.
E di norma, davvero lo scambio si concludeva in un batter d’occhio, o meglio di spalla:
individuato il mio uomo, vi andavo quasi per caso a sbattere contro, facendo scivolare con
l’abilità di un prestigiatore l’ampolla nella mia sacca e il denaro nella sua.
Quel giorno però non avvenne nulla di tutto ciò. Attesi il mio gancio, tra conati
irresistibili, per oltre un’ora, finché risolsi che era meglio tornare sui miei passi e affrontare
la rabbia cinghialesca di Zio Lou piuttosto che passare ancora un solo minuto in quel tetro
merdaio.
A ritroso dunque passai per il mercato, dove gli strilloni già tacevano e i commercianti
avevano cominciato a riporre le loro cianfrusaglie, così da lasciar libero il gigantesco
piazzale prima che calasse il buio e con esso il coprifuoco; da lì sgattaiolai lungo la via del
Piacere, le cui professioniste imbellettate resistevano stoiche agli schiaffi del caldo; ancora
svoltai nel Vicolo dei Cocci, per poi sboccare e proseguire indisturbato lungo la via Prona,
che docilmente declinava, in un carosello di straccioni, mendicanti e farabutti, verso la
massa scura del mare là in fondo.
3
Che qualcosa non andava lo capii già a due isolati di distanza dalla distilleria
clandestina di Zio Lou.
Le sue urla suine rintronavano sulle vecchie pareti di mattoni degli edifici del distretto
del porto, incuranti dei rischi e della decenza. Entrai piano e scivolai dietro una cassa di
bottiglie vuote, al riparo, così speravo, dalla frustrazione omicida di Zio Lou.
«Come si può essere così idioti? Come si può?» ululò, e afferrata con entrambe le mani
la ruota di un carro, che giaceva lì tra altro ciarpame, e issatala sopra la testa, la mandò a
frantumarsi in fondo al magazzino. Pete il Coniglio e Mastro Panza assistevano impotenti
allo sfogo del capo, senza osare neppure respirare.
Quando si fu calmato, dopo cioè un quarto d’ora di devastazioni e cocci e schegge e
bestemmie da somaro, decisi che era il momento di uscire allo scoperto.
«Uh, sei qua» disse con un luccichio sinistro negli occhi piccoli e neri. «Di’ un po’: ti
piace la caccia? Ti piace.»
Non so dire se la seconda fosse la semplice, caratteristica ripetizione di un concetto, o
piuttosto un’affermazione. Ma se Zio Lou dice che qualcosa ti piace, ti piace.
«Certo» lo assecondai, nonostante non avessi mai cacciato nulla.
«Bene.»
La Terra dei Draghi è quel genere di posto in cui non vorresti mai passare le vacanze, a
meno che tu non sia un drago, ovviamente.
Si tratta di un altopiano desolato, caratterizzato dalla presenza di massi taglienti, aria
satura di esalazioni solforose e vegetazione praticamente assente, se si eccettua il
dragospino, una pianta arborea la cui unica ragione d’esistere pare sia pungere il
prossimo.
Lì i draghi, creature antiche come il mondo, da sempre si ritrovano per deporre le uova
e dare alla luce i loro piccoli (il che, aggiungo io, spiega il perché del loro pessimo
carattere) e sempre lì i cacciatori di draghi si appostano per tendergli ogni genere di
tranello pur di catturarli.
Zio Lou mi ci aveva mandato dopo aver scoperto che i suoi contrabbandieri vi erano
rimasti bloccati, intrappolati a loro volta da un assembramento agguerrito di “schifosi
animalisti”.
Quanto a me, dovevo fare in modo che il distillato di olio di fegato giungesse nelle sue
mani e non gli importava se per farlo avrei dovuto liberare i cacciatori o ucciderlo io
stesso, il maledetto drago.
Così, dopo quasi tre giorni di cammino, superata la pianura paludosa del fiume Far, i
sette laghi di Piagnonia e l’ultimo baluardo degli uomini in quelle regioni, la città-fortezza
di Medrana sull’Orrido, giunsi ai piedi dell’Altopiano del Drak, confine sacro della Terra
dei Draghi. Per onestà intellettuale, bisogna dire che era molto più “alto” che “piano”.
Guardavo da sotto in su quella ripida montagna dalla testa piatta, nel tentativo di trovare
il punto migliore per attaccarla, ma la sua superficie si presentava ovunque più austera e
inviolabile di una monaca.
4
Mi ci vollero quasi due ore per scalare i primi trenta metri, tanto era liscia e compatta la
roccia in quel tratto: fui costretto a issarmi con la sola forza delle dita, facendo tesoro della
più piccola crepa, della più insignificante fessura. Al termine di quel tratto però, la parete
si fece improvvisamente più accidentata, irta di punte e scaglie come la pelle dei suoi più
antichi abitanti, e l’ascesa divenne più agile.
Dopo quasi tredici ore di scalata, superato l’ultimo sperone roccioso, il Drak s’aprì
improvviso davanti ai miei occhi.
Il cielo sulla Terra dei Draghi, di una perenne tonalità tra il porpora e il viola, era
solcato incessantemente dai voli di quelle maestose creature, che in millenni di
occupazione ne avevano reso l’aria pressoché irrespirabile (di fatto, il metano e lo zolfo
prodotti dai draghi sono tra le principali cause dell’effetto serra e del relativo
surriscaldamento globale).
Non so dirvi esattamente per quanto tempo mi aggirai come un fantasma tra i massi e il
dragospino, stremato dalla salita, stordito dai miasmi draconici e dalla mancanza di
ossigeno. So solo che, a un certo punto, come in un sogno m’imbattei proprio in quello che
stavo cercando. La sagoma immensa di un drago, un bell’esemplare adulto, nero cromato,
giaceva incatenata al suolo, le ali tarpate, la bocca chiusa da una specie gabbia di
dimensioni impressionanti, che non gli impediva tuttavia di manifestare il suo disappunto
con vampate di fuoco tali che avrebbero potuto incenerire all’istante una colonna di carri.
Di fianco al drago, le armi in pugno, c’erano i contrabbandieri di Zio Lou; davanti ai
contrabbandieri, un centinaio di fricchettoni vestiti di bianco, i capelli lunghi e lucenti
sciolti o raccolti in ghirlande, che cantavano, ballavano o fumavano da lunghe pipe.
Insomma, i dannati elfi.
Ora, dovete ben sapere che per un orco o un goblin non c’è nulla di più detestabile di
quegli arroganti, frivoli, fiacchi figli di padre ignoto. Un po’ perché sono tutto ciò che noi
avremmo voluto essere e non siamo, un po’ perché non perdono occasione per farcelo
pesare.
Così non riuscii a trattenere il mio sdegno quando, fluttuando eterei e perfetti,
apparentemente immuni al clima apocalittico di quei luoghi, due di essi mi vennero
incontro con un sorriso da un orecchio appuntito all’altro.
«Nam-ur-bal, pace a te, fratello goblin. Io sono Eugelfo, e questo è mio fratello Elfonso.»
La sua voce, perfezionata sicuramente da secoli di corsi di dizione, aveva il suono del
mare sulla spiaggia.
«Che cosa ti porta qui da noi, fratello goblin?» chiese Elfonso, col tono melenso di un
medico che sta per eseguire un tampone rettale.
«Poche chiacchiere,» dissi io, sfoggiando la mia espressione peggiore «sono qui per
ammazzare un drago.»
«Accomodati pure» disse Eugelfo, ancor oggi non saprei dire se con ironia. Tese un
braccio verso il luogo in cui il drago giaceva aggiogato: scuotendo la testa titanica irta di
corna, e roteando tutto intorno quell’occhio viperino e sapiente grosso come il portone del
5
castello di Ur-Ghrab, lasciò partire un ruggito e una fiammata che, sebbene a parecchi
metri di distanza, mi bruciò completamente le sopracciglia.
«Sei libero, fratello goblin, lo siamo tutti. Ma vorrei che ci ripensassi.»
Continuavo a spostare lo sguardo dalla faccia disgustosa e cordiale di Eugelfo al drago
al manipolo di cacciatori di draghi, senza saper prendere una decisione.
«Quando non sai cosa fare» mi aveva detto una volta mio zio Gretzel «temporeggia
finché non ti viene un’idea migliore».
Io l’ho sempre reputato un ottimo consiglio, per lo meno fino a quando ho scoperto che
mio zio Gretzel, anima semplice, credeva che temporeggiare fosse un modo colto di dire
scoreggiare.
Purtuttavia, nel suo significato letterale, anche se non voluto da chi l’aveva pronunciato
per primo, mi sembrava allora un suggerimento adatto alla situazione.
Decisi quindi di andare a fare quattro chiacchiere con i cacciatori di taglie, giusto per
vedere che aria tirava da quelle parti.
Si trattava di dieci energumeni di rara bruttezza, i cui occhi brillavano di ignorante
brutalità. Barbari delle Lande del Nord: gli unici esseri umani abbastanza forti e stupidi da
infastidire deliberatamente bestie mastodontiche come quella incatenata alle loro spalle.
Mi avvicinai con fare deciso a quello che sembrava essere il capo, vale a dire al più
grosso, un individuo alto più di due metri la cui faccia feroce era ricoperta da un unico
ammasso di barba, sopracciglia e capelli stopposi. Solo il naso e gli occhi facevano
capolino: spezzato il primo, e volto dolorosamente a destra; piccoli e sfavillanti come
tizzoni i secondi, che roteavano all’impazzata nel tentativo di sorvegliare in una sola volta
il drago, i maledetti elfi e, adesso, anche me.
«Ciao capo» salutai.
«Come sai che sono il capo?»
«Hai l’aria del capo.»
«Beh, che vuoi?»
«Mi manda Zio Lou, vuole sapere come mai i suoi dragonieri, quelli che per inciso paga
profumatamente e che gli avevano assicurato di essere i migliori sulla piazza, si sono fatti
spaventare da un branco di elfi vegani.»
Lui si rizzò in tutta la sua altezza, i bicipiti si gonfiarono minacciosamente mentre
serrava la presa intorno alla sua grossa ascia. «Io sono Wolfgang, capo del clan dell’Orso:
colui che ha ucciso Pjornak, re dei Troll; colui che ha guardato negli occhi Khruul, la bestia
dell’Abisso; colui che ha sventrato il gigante a due teste del Dorn. Gli uomini delle Lande
del Nord non temono nulla! Tranne…»
«…gli elfi» concluse un altro barbaro, un uomo dalla testa a forma di patata e piena di
cicatrici al punto che la barba non trovava spazio in cui crescere.
«Gli elfi» confermò Wolfgang.
6
«Loro fanno le cose magiche. E tanto per essere chiari» continuò, chinandosi fino ad
oscurarmi completamente con la sua ombra «non ho paura neanche di Zio Lou. Finché ci
sono gli elfi, il drago io non lo tocco. Se vuoi ammazzarlo, puoi farlo da te.»
E concluse dicendo che, se non mi stava bene, potevo anche andare a prendere qualcosa
nel qualcos’altro di mia madre.
Eugelfo e suo fratello Elfonso intanto seguivano la scena con espressione serafica,
annuendo come se stessero dando il proprio assenso al compimento di un qualche destino
già scritto, e che solo loro conoscevano.
Io gli mostrai il medio, poi mi voltai e andai verso il drago.
Visto da vicino era ancora più grosso di quel che sembrava. Alto come un palazzo di tre
piani, lungo come una notte invernale. Un’unica catena, di un metallo speciale, gli correva
tutt’intorno, puntellata qui e là al terreno con grossi occhielli.
Una grossa alabarda, dello stesso metallo della catena, giaceva a pochi passi da me e dal
drago: i dragonieri la usavano per sferrare il colpo di grazia lassù, in un punto preciso tra
la testa e il collo. Me lo aveva raccontato un giovane apprendista cacciatore, il giorno in cui
fu divorato.
Presi un bel respiro, raccolsi l’alabarda e cominciai ad arrampicarmi su per la belva,
trovando gli appigli tra le scaglie d’ossidiana della sua corazza. Il drago dal canto suo,
forse sentendo la fine vicina, prese a dimenarsi e a guaire disperatamente, buttando ora
fiamme, ora lacrime, che cadevano al suolo corrodendolo come il più aggressivo degli
acidi. Mi ci volle quasi un’ora per arrivare in cima, e più volte avevo rischiato di perdere
l’alabarda. Il mostro, ormai rassegnato, emetteva solo più radi sbuffi e sospiri che
ricordavano lo sferragliare di un plotone di cavalieri in armatura. Il punto dove dovevo
colpire era proprio lì, vicino alla decima vertebra, dove la catena compiva due giri per
mantenere la testa più ferma.
Guardai giù i barbari, poi gli elfi. I due fratelli ancora mi fissavano impassibili.
«Siamo tutti fratelli» gridò a un tratto Elfonso «io, tu, i bracconieri, il drago.» La sua
voce eterea era giunta chiara ed elegante fino a me, lassù, nonostante il vento e la distanza.
Maledetti barbari cagasotto, pensai.
Maledetto Zio Lou, maledetti draghi e stramaledetti gli elfi, coi loro dannati sensi di
colpa.
Abbattei l’alabarda con tutte le forze, spezzando la catena in una pioggia di scintille.
Pochi istanti dopo, impigliato per un piede, vedevo il suolo farsi sempre più distante.
Niente ti fa vedere le cose da un’altra prospettiva quanto stare sospesi a testa in giù,
penzolando come un frutto troppo maturo a centinaia di metri d’altezza. Il drago, troppo
impaurito, infuriato o semplicemente stupido, non dava impressione di voler perdere
quota e io osservavo il paesaggio sottostante cambiare colore e conformazione come in un
immenso caleidoscopio. Sorvolammo le Pianure Porporine, così chiamate ormai da secoli
per via dell’ l’insolito colore che aveva preso l’erba dopo una battaglia sanguinosissima,
durata oltre cento anni, di cui più nessuno ricordava la causa; superammo le rigogliose
7
Colline della Seta e seguendo il percorso scintillante e voluttuoso del fiume Lucino
giungemmo fino alle Terre Brulle.
Si dice che l’Orco Primordiale abbia visto la luce, agli albori dell’universo, proprio nelle
Terre Brulle. Si dice così perché da sempre gli orchi popolano queste lande sconfinate,
dove ancora corrono i maestosi trisonti, che se pensate che un bisonte sia grosso, aspettate
di vedere un trisonte.
Mio nonno materno, Ggrch, era il capo della Tribù degli Unghioni, una delle più grandi
e forti di tutte le Terre Brulle. Era un orco all’antica, figlio d’un tempo in cui gli orchi non
parlavano ancora la Grande Lingua, quella che oggi accomuna tutti gli abitanti del Basso
Continente. Ora che ci penso gli orchi sono stati proprio gli ultimi a impararla, perfino
dopo i troll.
Tradotto nella Grande Lingua, Ggrch significa “Colui che comanda coi piedi”, titolo che
s’era guadagnato mettendo in riga a calci nel culo i guerrieri dell’intera tribù.
Potete immaginare dunque come non fosse un tipo incline alle manifestazioni d’affetto.
La cosa più carina che ha fatto per me credo sia stata non mangiarmi quand’ero ancora
piccolo; motivo per cui, una volta rimasto orfano, ritenni saggio non rivolgermi a lui.
La nonna invece non la conobbi mai, perché morì in battaglia prima che nascessi. So
solo che si chiamava Vrujcka, che nella Grande Lingua ha un significato assai poco carino.
Mio zio Krog, il secondogenito, era una specie di artista. Le sue teste impalate andavano
a ruba e lui era costretto a procurarsene costantemente di nuove, motivo per cui un giorno
gli abitanti dei villaggi vicini gli fecero la festa.
Avevo poi un numero sterminato di cugini, praticamente tutta la tribù, e anche
qualcuno nelle tribù vicine. Il più famoso era Wokka, il più grande cacciatore di trisonti
della storia dei cacciatori di trisonti: di lui si narrava che, armato solo di un bastoncino e di
uno scoiattolo morto, avesse ucciso il leggendario Battitore Nero, un trisonte così grosso
che dopo gli acquazzoni, nei solchi lasciati dai suoi zoccoli si formavano dei piccoli stagni.
Con la sola sua pelle costruirono una grossa tenda, la stessa che ancora oggi ospita le
riunioni solenni della Tribù degli Unghioni.
Durante i mezzogiorno roventi delle Terre Brulle, io mi rintanavo nel fresco odoroso di
muschio ed erbe di quella grande tenda in cui, coi cugini della mia età, si giocava a sputi,
alla lotta o a “schiaffeggia Buzuk e scappa”. Buzuk era lo sciamano della tribù, prozio di
mia madre e di un'altra trentina di orchi e orchesse. Gli adulti lo tenevano in grande
considerazione e reputavano una grande mancanza di rispetto disturbarlo quando
piombava in una delle sue sempre più frequenti estasi mistiche.
La verità era che il prozio Buzuk era un vecchio rimbambito e s’appisolava un po’
ovunque, borbottando nel sonno. Io, piccolo e svelto orgoblin, ero più bravo dei giovani
orchi a “schiaffeggia Buzuk e scappa”, mentre a sputi e alla lotta perdevo miseramente,
non potendo in alcun modo competere con loro.
Verso sera, mentre la mia mente, forse anche a causa di tutto il sangue che in quella
posizione fluiva al cervello, si lasciava andare a simili ricordi, il drago ebbe un sussulto.
8
Doveva aver fiutato qualcosa di grosso, perché s’era fermato a mezz’aria, sorretto dalle
ali immense che sbattevano rimbombando come tuoni. Cercai di dare il giro dondolando
con il corpo, in modo da rivolgere lo sguardo dove lo stava rivolgendo anche il drago.
Laggiù, dove il buio era già denso e aveva inghiottito l’orizzonte, un punto risplendeva
di un bagliore ardente.
Il profilo affusolato e austero della fortezza di Roccamara si delineava davanti ai miei
occhi, più nero dell’oscurità in cui era immerso. La superficie liscia e scoscesa dei suoi
bastioni risplendeva come ossidiana di rimando alle fiamme dei bracieri da campo che gli
ardevano tutt’intorno.
Vista da lontano aveva le sembianze di una gigantesca cozza piantata di lungo nella
roccia del monte, al cui interno, al sicuro come il mollusco al riparo delle valve, si trovava
la cittadella.
Così com’era, la fortezza di Roccamara aveva fama d’essere inespugnabile; eppure
aveva visto più volte nel corso della storia cambiare il proprio vessillo. Quando
passeggiando o più spesso fuggendo con mio padre attraverso le Terre Brulle scorgevamo
in lontananza il suo contorno severo, lui soleva agitare il pugno in quella direzione e
maledirne tutti signori in ordine cronologico, dai costruttori fino agli attuali. Non seppi
mai il perché di questa avversione del mio sfortunato genitore nei confronti dei suoi
reggenti, ma lungo andare ne imparai la storia: fatta costruire dai duchi di Ghiaiona
(maledetti) oltre sei secoli prima, la fortezza passò poi sotto il dominio dei Mangiaponte
(stramaledetti), dai quali fu ceduta ai vassalli di Borgo Vecchio (figli di troll) che la persero
a favore dei Signori di Argiò e delle Valli Alte (possano crepare e restare insepolti), i quali
però si videro presto costretti ad abbandonarla nelle mani del visconte Ubertino delle
Fosse (il diavolo se lo porti), che ancora la deteneva all’epoca dei fatti.
La sua importanza, anche se meramente strategica, era fondamentale: si trovava infatti
a guardia del Cariato, uno dei tre passi montani che collegavano le terre dell’Impero a
quelle dell’Impero vicino, ché a quel tempo anche il re più cencioso aveva la smania di
definirsi Imperatore.
Il visconte Ubertino, signore di Roccamara, era un personaggio ambiguo, volubile e
sanguinario. Dopo aver giurato fedeltà all’Imperatore, quello da questa parte del valico,
aveva cambiato idea e aveva deciso di giurare fedeltà piuttosto all’altro, quello dall’altra
parte, motivo per cui l’intero esercito del primo s’era mobilitato per fargli tornare il senno
o toglierglielo una volta per tutte.
E proprio durante l’assedio di Roccamara capitai io scarrozzato dal drago, il quale,
fiutata la possibilità di un pasto così facile e abbondante quale quello offerto solitamente
dalle battaglie, vi si lanciò a velocità spaventosa.
Le sentinelle di entrambi gli schieramenti, vedendo la bestia che si avvicinava e potendo
già scorgere i baleni fiammeggianti che irradiavano dalla sua gola attraverso le fauci
spalancate, si affrettarono a dare fiato ai corni. Appresi in seguito che il codice guerresco,
notoriamente semplice sì da poter essere inteso anche dal miliziano più tonto, in proposito
9
era chiarissimo: “il nemico del mio nemico è mio amico, l’amico del mio nemico è mio nemico e se
arriva un drago si salvi chi può.”
Così, disinteressandosi completamente gli uni degli altri, i soldati di entrambe le fazioni
corsero ai ripari.
Un primo nugolo di frecce, simile a uno stormo di rondini, saettò verso l’alto a un
ordine del comandante degli arcieri assedianti. Il drago però era ancora troppo distante e
le osservai mentre ricadevano in picchiata e si conficcavano al suolo.
Poi fu la volta dei tiratori di Roccamara, che dalla loro posizione sopraelevata potevano
prendere la mira assai meglio dei loro avversari. Stavolta delle frecce udii anche il fischio,
e poco ci mancò che una non arrivasse al bersaglio. Il drago dal canto suo era come
indeciso e volava in tondo senza sapere chi arrostire per primo. Lasciò partire un bolide
ardente dalla narice sinistra, spiovente, che impattò come un colpo di mortaio tra le fila
inermi dell’accampamento assediante, poi si portò a volteggiare sui tetti di Roccamara.
Una seconda palla infuocata lasciò la narice destra, sfondando il tetto di una casa che
esplose letteralmente all’impatto. Le maledizioni di entrambi gli schieramenti si univano
alle mie, che dondolando senza sosta per via dei costanti cambi di direzione soffrivo di
feroci conati di vomito.
Sul tetto della torre più alta allora gli armigeri, dopo essersi accorti dell’inutilità delle
frecce tradizionali, avevano messo mano a una grossa balista. Era una specie di balestra
gigante, che scagliava dardi delle dimensioni di strali e che, se l’avesse colto, avrebbe
causato qualche fastidio perfino al dragone.
«Oh, dèi!» sospirai, vedendo la punta acuminata rivolta verso la belva e quindi, seppur
accidentalmente, verso il sottoscritto. Cominciai allora a cercare di issarmi, facendo leva
sul piede impigliato, ma il continuo movimento rendeva l’impresa faticosa e dolente.
Avevo quasi afferrato, dopo un colpo di reni da applausi, la catena che mi
imprigionava; quand’ecco uno scatto, come il vibrare di una corda enorme, seguito da un
sibilo sinistro. Il drago scartò appena in tempo per evitare il dardo e, poiché i draghi son
bestie permalose, parve non prenderla troppo bene.
Gonfiò il petto al punto che potevo sentirne scricchiolare le scaglie e gettò una fiammata
tale che della balista, dei soldati e dell’intera torre non rimase più nulla.
Quindi vomitai.
10