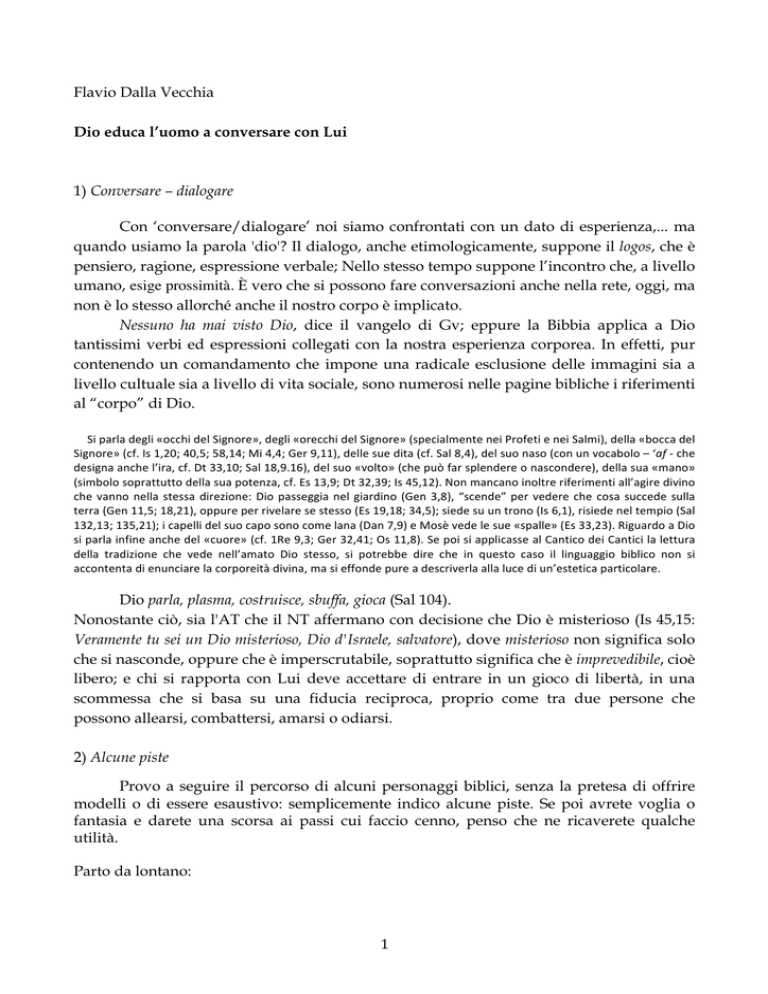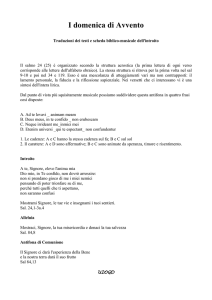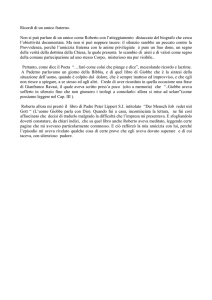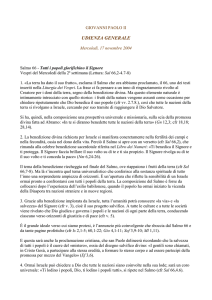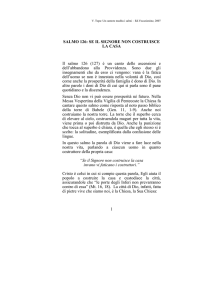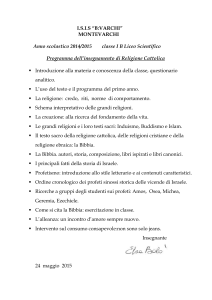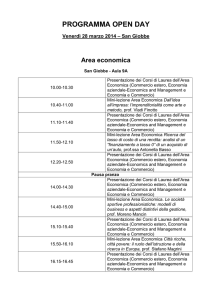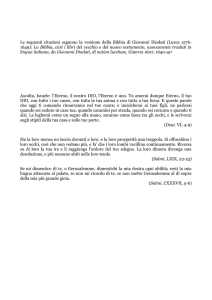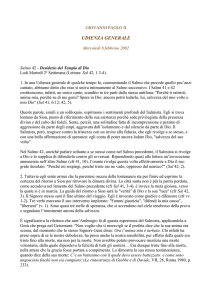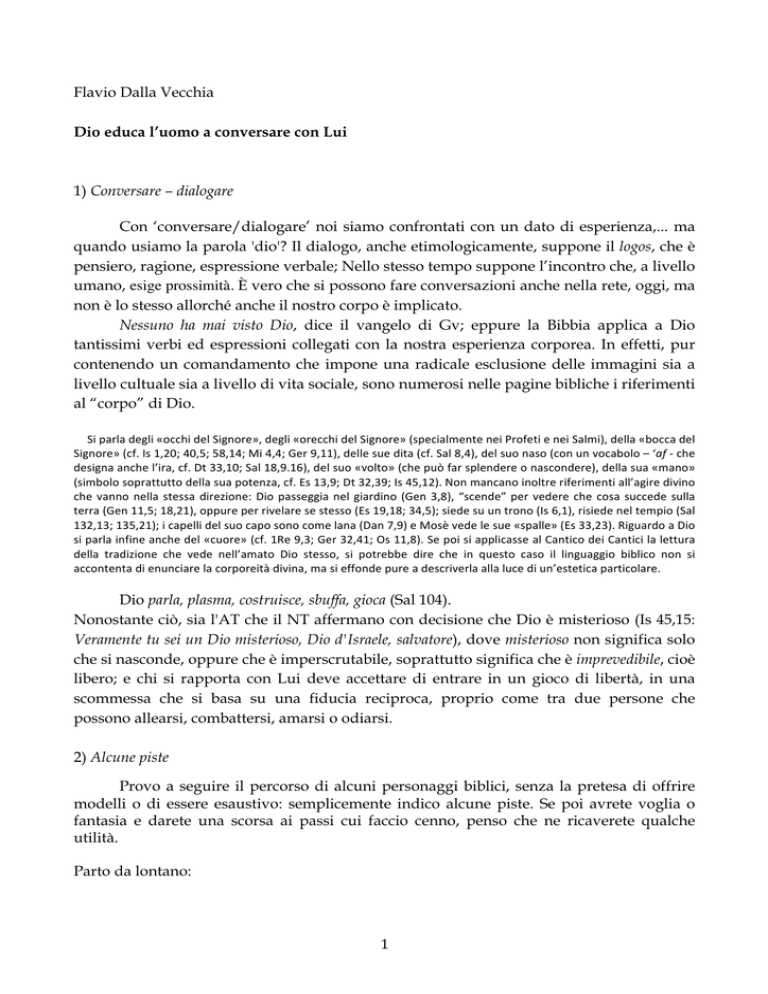
Flavio Dalla Vecchia
Dio educa l’uomo a conversare con Lui
1) Conversare – dialogare
Con ‘conversare/dialogare’ noi siamo confrontati con un dato di esperienza,... ma
quando usiamo la parola 'dio'? Il dialogo, anche etimologicamente, suppone il logos, che è
pensiero, ragione, espressione verbale; Nello stesso tempo suppone l’incontro che, a livello
umano, esige prossimità. È vero che si possono fare conversazioni anche nella rete, oggi, ma
non è lo stesso allorché anche il nostro corpo è implicato.
Nessuno ha mai visto Dio, dice il vangelo di Gv; eppure la Bibbia applica a Dio
tantissimi verbi ed espressioni collegati con la nostra esperienza corporea. In effetti, pur
contenendo un comandamento che impone una radicale esclusione delle immagini sia a
livello cultuale sia a livello di vita sociale, sono numerosi nelle pagine bibliche i riferimenti
al “corpo” di Dio.
Si parla degli «occhi del Signore», degli «orecchi del Signore» (specialmente nei Profeti e nei Salmi), della «bocca del
Signore» (cf. Is 1,20; 40,5; 58,14; Mi 4,4; Ger 9,11), delle sue dita (cf. Sal 8,4), del suo naso (con un vocabolo – ‘af - che
designa anche l’ira, cf. Dt 33,10; Sal 18,9.16), del suo «volto» (che può far splendere o nascondere), della sua «mano»
(simbolo soprattutto della sua potenza, cf. Es 13,9; Dt 32,39; Is 45,12). Non mancano inoltre riferimenti all’agire divino
che vanno nella stessa direzione: Dio passeggia nel giardino (Gen 3,8), “scende” per vedere che cosa succede sulla
terra (Gen 11,5; 18,21), oppure per rivelare se stesso (Es 19,18; 34,5); siede su un trono (Is 6,1), risiede nel tempio (Sal
132,13; 135,21); i capelli del suo capo sono come lana (Dan 7,9) e Mosè vede le sue «spalle» (Es 33,23). Riguardo a Dio
si parla infine anche del «cuore» (cf. 1Re 9,3; Ger 32,41; Os 11,8). Se poi si applicasse al Cantico dei Cantici la lettura
della tradizione che vede nell’amato Dio stesso, si potrebbe dire che in questo caso il linguaggio biblico non si
accontenta di enunciare la corporeità divina, ma si effonde pure a descriverla alla luce di un’estetica particolare.
Dio parla, plasma, costruisce, sbuffa, gioca (Sal 104).
Nonostante ciò, sia l'AT che il NT affermano con decisione che Dio è misterioso (Is 45,15:
Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio d'Israele, salvatore), dove misterioso non significa solo
che si nasconde, oppure che è imperscrutabile, soprattutto significa che è imprevedibile, cioè
libero; e chi si rapporta con Lui deve accettare di entrare in un gioco di libertà, in una
scommessa che si basa su una fiducia reciproca, proprio come tra due persone che
possono allearsi, combattersi, amarsi o odiarsi.
2) Alcune piste
Provo a seguire il percorso di alcuni personaggi biblici, senza la pretesa di offrire
modelli o di essere esaustivo: semplicemente indico alcune piste. Se poi avrete voglia o
fantasia e darete una scorsa ai passi cui faccio cenno, penso che ne ricaverete qualche
utilità.
Parto da lontano:
1
Abramo. Troppo conosciuto, direte; ma chi è Abramo? La sua vicenda si apre con un
ordine: Vattene! (Gen 12,1) ed coronata da un ordine dello stesso tipo: Vattene! (Gen 12,2:
letteralmente si potrebbe tradurre in entrambi i casi: «va’ verso di te»). Come ha incontrato
Dio quest’uomo? Un Dio che ordina e promette, un uomo che obbedisce senza discutere: si
può parlare di dialogo?
Segnalo tre passi: Abramo che sta invecchiando: «che cosa mi hai dato, Signore?»
(Gen 15: la promessa incompiuta). La sorte di Sodoma e Gomorra (Gen 18,16-33: quello
che Dio fa è sempre giusto?). Gen 22: Dio mette alla prova Abramo. Non c’è nulla di
scontato nella vita, nulla già scritto. Che Dio è questo che promette e non mantiene (o
comunque che non ti fa vedere come va a finire)? Come è possibile vivere solo in vista di
un futuro che forse vedranno i tuoi discendenti secoli dopo di te? Che differenza c’è tra
questo Dio e le tante promesse che hanno accompagnato il Ventesimo secolo e che hanno
riempito i cimiteri di milioni di cadaveri?
La domanda fondamentale però è: davvero Abramo vive con la testa nel futuro? per
Abramo, Dio è il futuro, e questo è ciò che conta. Non la terra, non la discendenza: dopo la
rande prova che lo vede disposto a uccidere il proprio figlio (il futuro), l’angelo di Dio gli
dichiara: ora so che temi Dio (Gen 22,12), cioè riconosci che la vita non dipende solo dai tuoi
sforzi, dalla tua genialità, dai mezzi di cui disponi. Temi Dio cioè non: hai paura di Dio,
ma: ti fidi di Lui, sai che puoi contare su di Lui.
Giona. Un dialogo che non produce frutto. Fin dall’inizio il profeta vive con
riluttanza il dialogo con Dio: non parte subito per la missione e quando va è praticamente
costretto; alla fine Dio perdona i malvagi e Giona non accetta questo suo modo di fare. Il
libro si chiude con un dialogo in cui entrambi espongono le loro posizioni, ma senza
giungere a un consenso.
Giona dichiara che teme Dio (1,9): si fida di Dio o ne ha paura? Il Dio di Giona è
convincente? Non sappiamo se ha convinto Giona: può convincere noi? Vi dicevo che Dio
è imprevedibile: e se non corrisponde alle mie attese? In ogni relazione noi mettiamo in
gioco delle attese e quando sono deluse l’altro diventa ai nostri occhi irritante, lontano,
incomprensibile. Dio perdona Ninive; Giona non perdona a Dio di essere così. Che Dio
attendo nella mia vita? E se non corrispondesse alle mie attese?
C’è una cosa importante in Giona: alla fine Dio non se la prende con Giona; è Giona
che se la prende con Dio. E Dio ha pazienza, non lo minaccia: si ferma a parlare con lui,
come fa un amico con un altro o un educatore che si preoccupa della crescita di chi gli è
affidato. Il dialogo finale rimane aperto: il libro non ci dà la risposta di Giona, perché è il
lettore che è invitato a rispondere. Dio aspetta con pazienza che tu comprenda perché egli
agisca così.
Giobbe. Il silenzio di Dio di fronte al male, all’ingiustizia, ai diritti negati, alla
malattia. Perché soffre Giobbe? Risposta pronta – quella dei suoi amici: avrà commesso
qualche peccato! Una risposta che accompagna tanti commenti a situazioni umane, anche
se non si usa il termine peccato. Anche la filosofia si domanda: unde malum? E Giobbe ha
davanti a sé quattro esponenti della saggezza orientale. Che cosa chiede Giobbe a Dio
nella sua sofferenza? Dio non risponde. Anche molti Salmi contengono affermazioni vicine
alle sue, nello stesso tempo non mancano inviti simili a quelli degli amici di Giobbe:
2
«Sta’ in silenzio davanti al SIGNORE, e aspettalo; non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per
l’uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti» (Salmo 37,7).
Così Is 8,17 dice: «È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore».
Giobbe, però, non sta in silenzio. La pazienza di Giobbe è un mito letterario (si
legga Giobbe di Joseph Roth). Giobbe vuole che sia Dio a rispondere, non i ragionamenti
degli amici. Quella falsa solidarietà della ragione che di fatto inchioda l’essere umano al
suo limite oppure una spiegazione scientifica o meccanicistica degli eventi, non riescono a
placare la sua angoscia.
Chi regge l’universo: un despota crudele, un burattinaio insensibile e cinico, un
apatico del tutto estraneo ai drammi umani, soprattutto di chi non ha alcuna garanzia in
questo mondo? E quando Dio tace, o sembra essersi appartato che cosa si può fare? Giobbe
chiede a Dio di difendere se stesso, di non lasciare che il peso della vita lo porti a negare
tutto ciò che ha fino a quel momento sorretto ogni sua scelta. E Dio risponde a suo modo:
non si scusa e non scioglie tutti i dubbi di Giobbe; gli dice soltanto che lui non è
disinteressato alla sua situazione. Dio non è però il salvagente: è compagno di viaggio, sta
accanto a lui e porta il peso di una storia che deve compiersi. È questo mi sembra il senso
che ricava dalla sua esperienza anche Etty Hillesum:
«Dio non è responsabile verso di noi, siamo noi a esserlo verso di lui. So quel che ci può ancora
succedere [...]. Le ultime notizie dicono che tutti gli ebrei saranno deportati dall’Olanda in Polonia,
passando per il Drenthe. E secondo la radio inglese, dall’aprile scorso sono morti 700.000 ebrei, in
Germania e nei territori occupati. Se rimarremo vivi, queste saranno altrettante ferite che dovremo portarci
dentro per sempre. Eppure non riesco a trovare assurda la vita. E Dio non è nemmeno responsabile verso di
noi per le assurdità che noi stessi commettiamo: i responsabili siamo noi! Sono già morta mille volte in mille
campi di concentramento. So tutto quanto e non mi preoccupo più per le notizie future: in un modo o
nell’altro, so già tutto. Eppure trovo questa vita bella e ricca di significato. Ogni minuto [...]» (E. Hillesum,
Diario 1941-1943, Milano 1996, 136-137)
«Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire l’oggi con i pesi
delle mie preoccupazioni per il domani [...]. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di
me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè
che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi.
L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo
di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri
uomini» (Ivi, 169).
Giobbe non si accontenta di parlare di Dio: vuole parlare con Lui. Anche con Dio,
però, come con le persone, capita talvolta che il dialogo sia fatto di incomprensioni. Allora
bisogna lasciar perdere tutto? Etty dice che difendere Dio è difendere la nostra dignità
umana!
A questo punto vorrei farvi notare un dato comune alle esperienze descritte: in tutti
i casi nessuno dei personaggi è giunto a Dio al termine di una ricerca. Dio non è l’esito di una
ricerca (Siddharta) o di una profonda introspezione, così come non è l’esito di una
speculazione. Ci si imbatte in Dio... quasi come capita di imbattersi in una persona
durante un viaggio o perché ci si scontra in un corridoio. Dio disse ad Abram, a Giona... la
parola di YHWH avvenne a Geremia. Giobbe temeva Dio e stava lontano dal male.
3
Nella Bibbia, perciò, l’accento cade sul fatto che l’essere umano incontra Dio perché
Dio gli si fa incontro. Ecco il vangelo: sulla riva del mare, sulla strada; hai bisogno di
guarigione, di perdono: puoi toccarlo, infrangere le regole sociali. La vita è piena di
incognite e tra queste vi è Dio. Un incontro che non si programma, ma che esige
attenzione: ti passa accanto, chiama, ti riconosce (Zaccheo, scendi!); sa che nella tua storia
qualcosa non funziona, ma non è un giudice: ti aiuta a vedere in una luce diversa il futuro
(cf. Gv 4).
C’è infine un aspetto che va tenuto sempre presente. Per il cristiano questo Dio ha
un volto umano: non solo perché noi siamo sua immagine, ognuno di noi, anche quando
non siamo del tutto soddisfatti di noi. Soprattutto Dio ha il volto umano di Gesù. Anche
lui ha dovuto fare i conti con l’imprevedibilità del Padre suo. Non sapeva tutto Gesù: ha
compreso come noi, lungo il cammino, il percorso da compiere nella sua vita. E il punto
culminante è in quella scena nel Getsemani, in cui il lettore è introdotto nell’intimo di
Gesù. Gesù ha paura: l’essere umano solo di fronte alla morte che parla al Padre suo.
Dag Hammarskjöl scriveva nel 1954, commentando espressioni di san Giovanni della
Croce:
«"La fede è l'unione di Dio con l'anima". La fede è: dunque, non può essere
afferrata, né tantomeno identificata con le formule usate per parafrasare ciò che è. In una
notte oscura. La notte della fede, tanto oscura che non si può cercare nemmeno la fede. È
nella notte del Getsemani che l’unione si compie, quando gli ultimi amici dormono, gli
altri tramano la tua rovina e Dio tace. Essere guidati da quel che vive quando "noi" più non
viviamo come parti in causa o "saccenti". Saper ascoltare e vedere ciò che dentro di noi è
nel buio. E nel silenzio»
3) E se Dio si fosse dimenticato di noi?
Il libro dei Salmi è la grande scuola che la Bibbia ci consegna perché impariamo a
conversare con Dio.
Ho scelto un esempio tra i tanti il Salmo 44.
Il secondo libro del salterio inizia con i Sal 42 e 43 e si chiude con il Sal 72. I salmi
da 42 a 49 sono i salmi di Core – così dice la sovrascritta – una raccolta che si completa nei
Sal 84-85 e 87-88. Sono salmi connotati non dalla teologia della storia, ma dalla teologia di
Sion, il monte dal quale Dio offre salvezza e vita. Sono salmi che si collegano tra loro per
la terminologia usata, ma anche per i motivi che sono ripresi: uno di questi - presente nel
Sal 44 con enfasi nella sua conclusione - è l’accento posto sul ḥesed di Dio, sulla bontà di
Dio; un altro è il motivo del Dio salvatore.
Nella disposizione dei salmi dei figli di Core nel Salterio si può inoltre individuare
uno schema ricorrente: nei salmi che iniziano il secondo libro c’è innanzitutto la supplica
nei Sal 42/43 e 44, seguita dalla risposta divina nei Sal 45-48, infine si incontra una nuova
supplica nel Sal 49. Lo stesso schema si rinviene nei Sal 84-88, suggerendo che c’è una
struttura intenzionale: Dio accoglie la supplica del suo popolo, va incontro quindi a una
comunità messa alla prova dalla storia. Leggendo queste suppliche, infatti, noi siamo
introdotti in momenti di crisi che il popolo vive, momenti che nella vicenda storica narrata
4
nella Bibbia, ma anche in quella successiva di Israele, sono ricorrenti; queste preghiere non
sono dunque necessariamente collegate a una situazione specifica, anche se forse in alcuni
casi una collocazione meglio definita contribuirebbe a una più profonda intelligenza. In
realtà questi testi hanno ormai fatto un loro cammino a livello liturgico, a livello di
meditazione da parte del popolo, e come tali vanno accolti.
Il Sal 44 inizia con un tono riflessivo, una sorta di rivisitazione storica, ma poi
sfocia in una grande supplica, anche molto accorata. Possiamo dividerlo chiaramente in 4
momenti: vi è anzitutto il ricordo delle opere di Dio, che occupa tutta la parte (vv. 2-9);
segue una prima supplica (vv. 10-17); chi prega eleva poi una proclamazione (protesta) di
innocenza che è quasi un atto di accusa di Dio (vv. 18-23: noi non abbiamo colpa per
quello che sta succedendo); il tutto si chiude con una supplica accorata (vv. 24-27).
Se leggiamo il salmo secondo questa suddivisione, ci accorgiamo che all’inizio non
si presenta come una supplica, sembrerebbe anzi quasi un’espressione di fiducia: si
proclama quanto Dio ha fatto per il suo popolo lungo la storia. Tutta la seconda parte
invece è tesa a mostrare a Dio i motivi per cui dovrebbe intervenire: qui incontriamo i
tratti della supplica. Faccio notare subito alcune caratteristiche che cercherò poi di mettere
a fuoco.
Il popolo vive un’esperienza terribile: forse un’invasione nemica, forse l’esilio,
comunque una prova assai dura da sopportare; eppure, a differenza di quello che
troviamo in altri salmi, il popolo non confessa nessuna colpa. Nei salmi c’è normalmente
la consapevolezza del peccato espressa in vari modi: abbiamo peccato, è a causa della nostra
condotta che soffriamo, ma tu adesso perdona. Qui non troviamo affermazioni di questo
genere.
C’è un altro aspetto: il libro di Giobbe, ci presenta una persona che si trova nella
sofferenza e che chiede ragione a Dio di questa, in un certo senso eleva una protesta. Nel
Sal 44 non si incontra nessuna protesta, nessuna recriminazione. Si presenta invece
all’inizio una meditazione, una riflessione, e in seguito una supplica: non si mette Dio in
stato di accusa, si riflette, si argomenta e poi si supplica. Questo è il dinamismo che va
colto all’interno del salmo.
Il “noi” prende la parola fin dall’inizio: «Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri
padri ci hanno raccontato l’opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi». Perché si
ritorna al passato, qual è il motivo per cui si richiama e si ricorda il passato? Non è raro
infatti nella Bibbia l’invito a guardare al passato. Nel libro del Deuteronomio il richiamo al
passato, l’invito a ricordare è fondamentale: «Quando tuo figlio ti chiederà... tu dirai eravamo
schiavi del faraone in Egitto» (Dt 6,20). La motivazione che Mosè dà nel Deuteronomio è per
comprendere il valore delle leggi, capire come vivere nella terra: il ricordo è necessario per
vivere. Ciò è tanto più significativo, se si tiene conto che un saggio come Qohelet dice che
non c’è memoria, non c’è ricordo del passato (cf. Qo 1,11); in effetti se si legge il suo libro si
scopre però che Qohelet ha ben pochi motivi per sperare e non supplica mai. In questo
salmo noi siamo invitati anzitutto a guardare al passato con il popolo di Israele, per
comprendere se sia ancora possibile sperare e se abbia senso supplicare; il ricorso al
passato diventa quindi la motivazione che fonda la supplica.
5
«I nostri padri ci hanno raccontato l’opera da te compiuta nei tempi antichi», e qui c’è tutto
il racconto. «Tu per piantarli hai spossessato le genti, per fare loro posto hai distrutto i popoli».
Qui ovviamente il riferimento è alla conquista, quando il popolo entra nella terra e scaccia
le nazioni; si noti però che chi prega non dice «noi abbiamo vinto», ma dice: «Tu hai fatto
questo, hai spossessato le genti, hai scacciato i popoli per fare posto a loro, per dare a loro
uno spazio di libertà». È dunque Dio che è intervenuto, è l’opera di Dio che ha permesso al
popolo di possedere la terra; a tale proposito risalta la notazione: «non con la loro spada
conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del
tuo volto, perché tu li amavi». Questa affermazione - non la loro spada né il loro braccio – ha
condotto qualche commentatore antico, sia ebraico sia cristiano, a sottolineare che
l’ingresso nella terra sarebbe avvenuto senza violenza (non con la loro spada); in realtà,
secondo il racconto di Giosuè gli ebrei hanno anche combattuto, perciò la conquista non è
stata incruenta; eppure alcuni padri della Chiesa hanno visto qui addirittura la beatitudine
dei miti: come si ottiene la terra? Beati i miti perché erediteranno la terra.
Incontriamo poi una confessione di fede: perché Dio ha dato la terra? «perché ti eri
compiaciuto di loro». La Bibbia CEI traduce perché tu li amavi, una resa certamente fondata; il
verbo ebraico esprime però in particolare il compiacimento, il gradimento, come
significato abituale.
Il salmo prosegue: «sei tu il mio re, o Dio, che decidi vittorie per Giacobbe» (v. 5). Anche
questo è un passo abbastanza discutibile dal punto di vista della traduzione: chiaramente
però l’accento cade sull’identità di questo Dio di cui si ricordano le gesta. È Dio che ha
garantito al popolo la sicurezza. Qualcuno pensa che qui sia intervenuta la persona
singola, mentre io credo che a parlare sia ancora il popolo. È un popolo intero che dice: sei
tu il mio Dio. Anche questa parte è fondamentale, perché questo modo di parlare mostra
qual è il rapporto tra Israele e il suo Dio: chi è il vero re di Israele, chi è il vero comandante
dell’esercito di Israele, chi è in grado di sostenere la vita del popolo? Tutti i libri della
Bibbia, soprattutto quelli che narrano la storia, ci mostrano persone che continuamente
invitano il popolo a riconoscere questo, come Gedeone che, in risposta alla richiesta del
popolo di diventare re, dichiara: il Signore è il nostro Dio, è lui che deve regnare su di noi
(cf. Gdc 8,23). Chi è il Signore? Il libro di Isaia si apre con la visione del re, YHWH degli
eserciti.
L’affermazione che Dio è re qualifica anche la condizione del popolo, perché il re ha
offerto il suo compiacimento, li ha accolti, non perché loro hanno fatto qualcosa. Dio ha
fatto per loro tutto questo «perché ti eri compiaciuto di loro». All’origine di questa
relazione c’è questo volgersi di Dio verso il suo popolo. Ora però chi parla sostiene
qualcosa di diverso, perché, secondo una lettura possibile, il testo potrebbe essere tradotto
addirittura al presente: «con te noi adesso respingiamo i nostri avversari, nel tuo Nome
calpestiamo i nostri aggressori». Leggendo il testo al presente, anche noi possiamo sentirci
interpellati. Chi parla nel salmo afferma di avere una certa esperienza di Dio e non smette
di confidare nel potere di Dio, perciò afferma: «con te respingiamo i nostri avversari, nel tuo
Nome calpestiamo i nostri aggressori. Perché io non confido nel mio arco e non è la mia spada a
darmi vittoria, perché tu ci salvi dai nostri avversari, tu svergogni i nostri nemici» (vv. 6-7). Ciò
spiega le affermazioni che chiudono la prima parte: «in Dio ci gloriamo ogni giorno e
rendiamo grazie senza fine al tuo nome» (v. 9).
6
Siamo partiti dal ricordo e siamo ormai giunti alla fine di questo ricordo, che non è
la memoria di un passato glorioso, come si faceva nella letteratura epica antica; neppure si
tratta del ricordo glorioso di chi fa parate militari – anche oggi ci sono queste
manifestazioni - non è il trionfo del condottiero, come avveniva nell’impero romano. Non
è qui preservata una stele commemorativa, come quelle che i vincitori erigevano ai confini
o nei templi, oppure una delle spettacolari iscrizioni antiche che ricordano le gesta dei
sovrani. Nessun accento trionfalistico, ma una confessione di fede. Ricordare è confessare,
quindi nessun trionfalismo nazionalistico.
Il ricordo qui espresso è la voce di chi riconosce un debito, di chi ammette che la sua
situazione felice è originata dal compiacimento di Dio, dal suo gradimento: nessun merito,
nessuna violenza, nessun vanto. Al centro sta quel che Dio ha fatto, quello che Dio ancora
può fare. Ecco perché, quando poi si passa alla fotografia della situazione attuale, ci si
trova di fronte forse a un dilemma – è il salmista che ce lo presenta – «eppure ora ci hai
respinti e coperti di vergogna e più non esci con le nostre schiere, ci hai fatto fuggire di fronte agli
avversari e quelli che ci odiano ci hanno depredato. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai
dispersi in mezzo alle genti, hai venduto il tuo popolo per una miseria e sul loro prezzo non hai
guadagnato» (vv. 10-13).
Queste affermazioni hanno portato ovviamente a chiedersi se si possa individuare
qualche situazione storica che le chiarisca. Gli avvenimenti che meglio corrispondono, alla
luce della sequenza storica narrata nella Bibbia, potrebbero essere quelli collegati al
tracollo dei due regni: quello d’Israele spazzato via dagli Assiri nel 721 a.C. quello di
Giuda conquistato nel 587/6 dai Babilonesi; da quel momento in poi, infatti, per diversi
secoli il popolo rimase in balia di potenze straniere: chi in esilio chi nel paese, ma tutti alle
dipendenze di stranieri. Questa situazione permane lungo i secoli, poiché – tranne forse
per una breve parentesi nel sec. II a.C. – il popolo non ha più potuto avere una struttura
politica indipendente. Anche l’Israele del tempo di Gesù sperimenta il dominio di altri:
non ha più Dio come re, perché ci sono tanti altri che dicono di essere il re, addirittura
sovrani che si spacciano per il dio che si manifesta, che si rivela, cioè che si presentano
come la manifestazione del dio. È per questo motivo che il popolo diventa una sorta di
favola, di disprezzo per gli altri e perciò afferma sconsolato: «le nazioni ci dileggiano, usano
sberleffi nei nostri confronti... il mio disonore mi sta sempre davanti, la vergogna copre il mio volto
all’udire la voce di chi mi insulta e oltraggia, davanti al nemico e a chi brama la vendetta».
Questa seconda strofa è davvero angosciosa, tetra, è la costatazione di un
fallimento, ma il fallimento non dimentichiamo inizia dicendo: «eppure tu ci hai consegnato,
ci hai respinto, ci hai fatti fuggire»; quindi è un fallimento voluto da Dio: tu ci hai fatto fallire,
noi siamo lo zimbello delle genti perché tu chi hai abbandonato. Ecco il problema, perché?
È questo un tema diffuso nelle Bibbia – non solo nella Bibbia, ma nella Bibbia trova accenti
molto particolari in tanti testi. Se la storia va male, se le nostre attese sono frustrate, se c’è
un fallimento, di chi è la colpa? La domanda più radicale però è: chi ha in mano la storia?
E ancora più radicale: il Dio che io venero è davvero in grado di determinare la storia? C’è
una spiegazione, normalmente utilizzata quale spiegazione potremmo dire teologica – che
all’apparenza si presenta molto evidente e razionale - ed è quella cui si accennava
all’inizio: abbiamo peccato, ci hai puniti, ci hai lasciato in balia dei nemici; quello che ci sta
succedendo è dunque colpa nostra. Che cosa si deve fare in tal caso? È l’atteggiamento che
suggeriscono a Giobbe i suoi amici: hai peccato? Chiedi perdono, Dio sicuramente ti
riaccoglierà; però devi riconoscere la tua colpa: hai peccato, chiedi perdono. Quindi il
7
fallimento nella vita, nella storia, è un fallimento che dipende da te, riconosci la tua colpa.
Anche nelle suppliche comunitarie del Salterio ci si imbatte spesso in confessioni di questo
tipo: abbiamo peccato perciò siamo stati sconfitti, ma ora perdonaci, Signore.
Proprio in questo il salmista ci sorprende: «tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo
dimenticato, non avevamo rinnegato la tua alleanza. Non si era volto indietro il nostro cuore, i
nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero, ma tu ci hai stritolati in un luogo di sciacalli e ci
hai avvolti di ombre di morte. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio, teso le mani verso un
Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, lui che conosce i segreti del cuore. Per causa
tua ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello» (vv. 18-23).
L’ultima frase (per causa tua ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da
macello) è ripresa da Paolo nel c. 8 della Lettera ai Romani, proprio per indicare la
condizione di chi confessa il nome del Signore: per causa tua… nella beatitudine Gesù dirà
per causa mia e del Vangelo. Da qui parte l’ultimo grido di supplica e questo mi sembra il
punto fondamentale: perché soffre Israele?
Nei vv. precedenti (18-19) trova espressione il legame appassionato di Israele con il
suo Dio (tutto questo ci è accaduto non ti avevamo dimenticato), Israele è rimasto unito a lui
con il cuore, quindi con il pensiero (non si era volto indietro il nostro cuore) e con l’azione (i
nostri passi non avevano abbandonato il tuo sentiero). Anche adesso chi sta pregando è
sollecitato a dire: io non voglio dimenticarti, non voglio cambiare modo di vita, anche se
adesso mi trovo nell’ombra della morte, in una condizione in cui non capisco più quello
che tu vuoi. Perché qui sta il vero dilemma: che cosa ci sta chiedendo Dio nel momento
della prova, nel momento del fallimento, nel momento in cui tutto sembra remare contro
quello che, confessiamo nella fede, «i nostri padri ci hanno raccontato», quello che noi
sappiamo di questo Dio, quello che abbiamo riconosciuto forse nella nostra esperienza
personale?
Nel momento del buio anche l’immagine di quel Dio che forse è penetrato nel
nostro intimo rischia di svanire; l’orante però la conserva nel cuore, mantiene la fedeltà e
addirittura si spinge a dire che Israele c’è per soffrire: «per causa tua noi siamo messi a morte,
stimati come pecore da macello» (v. 23). Israele deve soffrire perché «Dio lo ha scelto come
suo popolo, nel quale manifesta il suo essere Dio» (E. Zenger); quindi Israele deve
sperimentare nella sua esistenza una condizione particolare. Qui mi sembra importante
richiamarlo, perché questo ci porta ad alcune delle più profonde intuizioni che troviamo
nella seconda parte della Bibbia. Israele sperimenta in questo momento che il Signore non
sta dalla parte dei potenti e dei vincitori. Dove si trova Dio? Dalla parte dei deboli dei
sofferenti. Accettando questa verità, Israele può essere testimone che in questa condizione
è possibile incontrare Dio. La memoria iniziale celebrava il Dio che ha risollevato, protetto,
accompagnato, vinto.
C’è però anche una memoria di Dio dentro la prova, dentro la sofferenza, dentro
l’umiliazione, ecco perché in questo momento chi prega non rimprovera Dio: in effetti la
frase «per te siamo messi a morte» potrebbe suonare come un rimprovero a Dio, denuncia
del suo rigetto; invece qui è subito seguita dalla supplica finale: «svegliati, perché dormi
Signore, destati, non respingerci per sempre». Non c’è nessun timore a provocare Dio; l’uso
della parola svegliati dà quasi l’impressione di avere a che fare con una certa indolenza,
inerzia di Dio. Svegliati, perché dormi? Si richiama l’Esodo, dicendo: «perché nascondi il tuo
8
volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione?». L’Esodo inizia con Dio che si ricorda, che
ode il grido dall’oppressione (salvaci per la tua bontà, Signore, alzati vieni in nostro aiuto); Dio
aveva allora ascoltato il grido dall’oppressione.
Il grido che chiude il salmo è quello di chi non vuole più fare l’esperienza
semplicemente del Dio onnipotente, di chi vuole adesso sperimentare il Dio di ogni bontà
(v. 27). La parola finale è appunto ḥesed, che il testo CEI traduce con “misericordia”, e che
possiamo pure tradurre con “bontà” – Alonso Schökel invece traduceva con “lealtà”. Si
tratta di un vocabolo ricco di sfumature, che esprime in primo luogo uno dei tratti
caratteristici del Dio che si è rivelato al Sinai (cf. Es 34,6-7), celebrato nel Sal 136: «in eterno
è il suo ḥesed», cioè eterno è questo volgersi di Dio verso la sua creatura, che è un volgersi
gratuito, non spinto da chissà quale motivo se non il fatto che la creatura ha bisogno di
Dio.
Ecco perché possiamo tradurre con misericordia, senza dimenticare che al nostro
salmo si collega la composizione successiva (Sal 45) quasi come risposta: nel Sal 45, in cui
si parla del re sposo e della sua sposa, il salmista ci vuole parlare di Gerusalemme. Si
inizia con lo sposalizio e poi si sperimenta, con la sposa che è Gerusalemme, che Dio è il
suo baluardo. La supplica trova la sua risposta nella preghiera successiva: Dio risponde,
non rimane inerte, accetta la provocazione, non la sente come una sorta di mancanza di
rispetto. Dio si lascia potremmo dire - con questo modo di pregare – strattonare.
Vorrei però terminare approfondendo un altro aspetto. L’orante dice: «Non si era
volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevamo lasciato il tuo sentiero, se avessimo
dimenticato il nome del nostro Dio, teso le mani verso un dio straniero, non abbiamo rinnegato la
tua alleanza»... e c’è chi pensa che, dietro questa forma di confessione di innocenza, ci sia
un atteggiamento simile a quello del fariseo della parabola narrata da Gesù. Un giusto
che, in un certo senso, si mette davanti a Dio a chiedere il conto: tu devi fare quello che io
voglio, ho la pretesa che tu agisca. Se non sbaglio, questa è un’idea proposta da un
importante commentatore; bisogna però chiedersi se sia davvero così. Qui il giusto non
presenta alcun conto a Dio, perché fin dall’inizio ci ha detto che tutto è frutto della grazia.
Riprendiamo quella parola: ti sei compiaciuto di noi; è la parola che in seguito è applicata a
Gesù: «in lui mi sono compiaciuto»; tutto quello che Dio ha fatto per il suo popolo è frutto
della sua grazia, non è stato fatto perché il popolo è particolarmente capace di
corrispondere. Il racconto di quello che ci hanno narrato i padri serve appunto a mostrare
questa grazia, questa bontà di Dio. Chi parla sa che tra lui e Dio c’è un vincolo (la berit, cioè
il patto), che non dipende dai suoi meriti. Il libro del Deuteronomio lo dice chiaramente:
non perché voi siete il popolo più sapiente vi ho scelto, ma perché vi amo. Dio ha scelto questo
popolo con elezione gratuita, e lo ha scelto perché ascolta il grido dell’oppresso. Lo ha
scelto e lo ha strappato dalle mani dell’oppressore, quindi il male che il popolo subisce,
l’esperienza che sta vivendo non è conseguenza di infedeltà, come ci ha detto prima il v.
23 («per causa tua siamo messi a morte»); è questo vincolo il motivo della sofferenza.
Ci sono stati molti momenti vita di Israele in cui ha sperimentato questo, in
particolare durante l’epoca della minaccia del re Antioco alla religione ebraica, ma non è
stato l’unico momento; non la presunzione della propria integrità motiva l’invocazione
d’Israele, ma la consapevolezza di questo vincolo che rivela la bontà divina: sorgi,
soccorrici, riscattaci per il tuo ḥesed, la tua misericordia, la tua bontà, la tua lealtà.
9