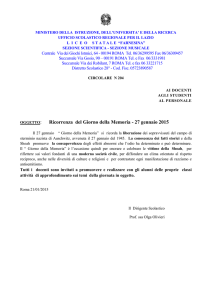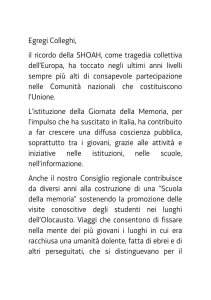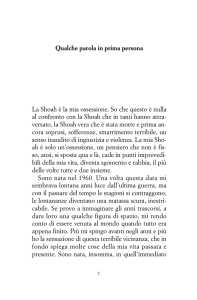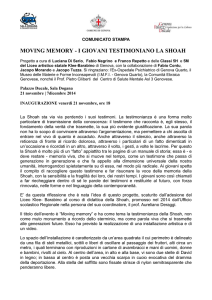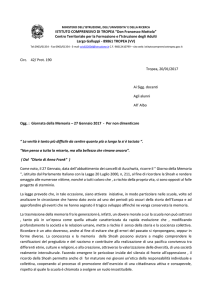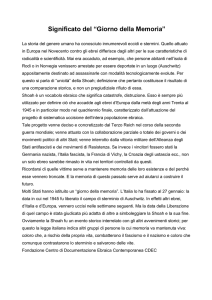DIRITTO DI STAMPA
Diletta Carmi
L’identità ebraica
come paradigma
della contemporaneità
Prefazione di
Massimo Squillacciotti
Introduzione di
Antonella Castelnuovo
Copyright © MMXIII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, /A–B
Roma
()
----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: novembre
Indice
Prefazione di Massimo Squillacciotti ........................................................................ 7
Introduzione di Antonella Castelnuovo .................................................................. 13
Capitolo 1. Presentazione dell’oggetto d’analisi
1.1 Premessa ............................................................................................................ 21
1.2 Cultura e identità .............................................................................................. 23
1.3 Il rapporto minoranza-maggioranza attraverso un caso-tipo ...................... 28
Capitolo 2. Alcuni aspetti dell’ebraismo diasporico
2.1 L’ebraismo, ethos morale-religioso ................................................................. 33
2.2 Ebraismo ed ebraicità ...................................................................................... 34
2.3 L’identità ebraica come paradigma della contemporaneità ......................... 37
Capitolo 3. La comunità italiana
3.1 Gli ebrei e l’Italia, dall’Emancipazione ebraica ai giorni nostri .................. 41
3.2 L’ebraismo italiano oggi e la sua organizzazione istituzionale..................... 47
3.3 Momenti di presentazione pubblica dell’ebraismo italiano .......................... 49
Capitolo 4. La rappresentazione pubblica della comunità ebraica italiana
4.1 Il Giorno della Memoria .................................................................................. 53
4.2 La Giornata Europea della Cultura Ebraica ................................................. 61
4.3 Altre rappresentazioni pubbliche degli ebrei e dell’ebraismo in Italia ....... 63
Conclusioni .............................................................................................................. 65
Bibliografia .............................................................................................................. 77
Sitografia ................................................................................................................. 81
Indice dei nomi ........................................................................................................ 83
Prefazione
Prefazione
Apro il giornale e leggo che…
Massimo Squillacciotti
Università degli Studi di Siena
Oggi, 27 gennaio 2013, apro i giornali alla ricerca di interventi
sulla 27a Giornata della Memoria: ne trovo diversi, tutti pubblicati con
un certo rilievo nelle rispettive pagine centrali1 e leggo articoli di storia, letteratura e cinema sulle persecuzioni, le deportazioni,
l’olocausto, la memoria… Sono interventi di vario tipo e carattere, dal
documento all’intervista, al reportage… le parole forti sono celebrazione, commemorazione, ricordo, testimonianza, memoria… ma, anche se le parole non si equivalgono, le posizioni espresse a riguardo
sono comunque piuttosto omogenee e “celebrative” ed è questo per
me un immediato richiamo al lavoro di indagine di Diletta Carmi su
L’identità ebraica come paradigma della contemporaneità.
Fin qui nulla di nuovo nei quotidiani riguardo alla ripetitività
ossequiosa del canone comunicativo specifico che rischia di sommarsi
alle tante “giornate di…” senza una riflessione sulla sua efficacia pedagogica, sulla sua portata nella trasmissione della memoria, nel superamento dei confini identitari, nella “rielaborazione del lutto”; insomma sembra quasi di partecipare ad un rito senza esito, simulacro e
monumento e non, invece, rimemorazione di un evento tragico, sua
rappresentazione con linguaggi di mediazione simbolica, sua restituzione nel presente e lungo un tempo in cui non ci sono più i testimoni
diretti dell’evento. Ma su questo torneremo…
Al contrario, un intervento di particolare interesse su cui voglio
qui soffermarmi e da cui partire, per proporre alcune ulteriori riflessioni intorno allo studio di Diletta, è l’intervista curata da Alberto
1
I quotidiani cui mi riferisco sono La Stampa del 22 gennaio alle pagine 32 e 33, Il Sole
24 Ore-domenicale del 27 gennaio alle pagine 29 e 30, La Repubblica del 27 gennaio alle pagine 28 e 29.
7
8
Prefazione
Mattioli – corrispondente da Parigi del quotidiano La Stampa – allo
storico della Shoah, Georges Bensoussan dal titolo Non si può insegnare la Shoah ai bambini. Cito alcuni passi significativi
dall’intervista: A.M. «Lei ha polemizzato con Nicolas Sarkozy che
aveva proposto che ogni bimbo francese ricostruisse la storia di un
bimbo ebreo deportato.» – G.B. «Semplicemente, da storico ho fatto
presente che l’idea era benintenzionata ma assurda. Non si può insegnare la Shoah ai bambini, non si può mostrare loro Treblinka. Perché
è una memoria troppo pesante, troppo dura da portare e finisce per
colpevolizzarli. Si può, anzi si deve, insegnare loro cosa c’è intorno
alla Shoah, cosa sono il razzismo o l’intolleranza. Alle elementari
puoi parlare di Anna Frank. Delle camere a gas, no.» – A.M. «Sulla
memoria, c’è qualcosa che si potrebbe fare e non si fa?» – G.B. «Forse avere ben presente che, dal punto di vista storico, la memoria è una
trappola. La memoria non è la storia, è una religione. E non serve a ricordare, ma a dimenticare, perché è fatalmente selettiva. […]» – A.M.
«Insomma, della Shoah si parla troppo?» – G.B. «Se ne parla troppo
perché se ne parla male. Cioè se ne parla in maniera compassionevole
per le vittime, mentre la Shoah è un’enorme questione politica e antropologica. Politica, perché pone il problema di come un popolo civilizzato abbia scientemente deciso di eliminarne un altro. Antropologica, perché rappresenta una cesura, una rottura della civiltà occidentale.
[…]» – A.M. «Ma a livello mediatico, lei dice, è troppo presente.» –
G.B. «C’è una saturazione della memoria. Il discorso sulla Shoah, sui
giornali, nei film, in televisione, è talmente invadente e basato soltanto sul pathos da diventare banalizzante. La nostra è una società compassionevole, dove lo status di vittima è quello più ambito. Dunque
ognuno vuole avere la sua Shoah. […]».
Parole, queste, che chiedono un nostro riposizionarci rispetto
non tanto all’accadimento in sé quanto alla sua e nostra resa in pertinenza nel presente, una diversa strategia rispetto alla nostra memoria
ed alla sua Memoria.
Una prima riflessione in questa prospettiva di trattamento della
memoria ci viene dalle pagine introduttive del saggio di Jean-Yves
Tadié e Marc Tadié Il senso della memoria: «Ciò che caratterizza
Prefazione
9
l’uomo è la memoria. Viene al mondo come un bambino freudiano: in
apparenza affetto da amnesia, reprime nel subconscio tutte le proprie
ferite. Cresce come un giovane bergsoniano: la memoria serve
all’azione, è preminentemente pratica e rivolta al futuro. Come Baudelaire, ritrova il passato in un profumo, in una musica e lo riscopre
attraverso i cinque sensi. Divenuto proustiano, con l’avanzare degli
anni, estasi di memoria involontaria gli fanno rivivere il passato, fino,
forse, a farlo sfuggire al tempo. Presto invecchierà e, come Chateaubriand, i suoi ricordi non gli saranno più di conforto. Sofocle gli aveva
mostrato il cammino di Edipo a Colono, quello della serenità dopo un
passato pesante, insanguinato. Forse si è fermato nella landa in cui Re
Lear gridava ai quattro venti la sua demenza, laddove non vi è più
memoria per nessuno. […] La funzione della memoria è quella di
permettere ad ogni uomo di riconoscersi come essere unico che è esistito e continuerà ad esistere. È la memoria ad unificare la personalità»2.
Una seconda riflessione da cui partire per una fondazione della
“nuova memoria di persona unificata” è sperimentare la condizione
che possiamo oggi assumere per trasmettere il senso dell’accadimento
“com-prendendo” quanto ci rimemora ad esempio in letteratura Winfried Georg Sebald nel suo Austerlitz con il brano su Vĕra e Agáta:
«Fu sei anni dopo esserci lasciate davanti al cancello della fiera di Holešovice, continuò a raccontare Vĕra, che venni a sapere del trasferimento di Agáta a est nel settembre del 1944 insieme con altri millecinquecento internati di Terenzín. Lei stessa, disse Vĕra, dopo aver
avuto quella notizia, per molto tempo non era quasi più riuscita a pensare a nulla, né ad Agáta né a ciò che doveva esserle accaduto né alla
propria vita che stava procedendo ora verso un futuro privo di senso.
Per settimane non era più tornata realmente in sé, aveva avvertito una
specie di strappo fuori dal suo corpo, si era messa alla ricerca dei fili
spezzati, non riuscendo a capacitarsi che le cose fossero andate davvero così»3.
2
3
Jean-Yves Tadié e Marc Tadié, Il senso della memoria, Bari, Dedalo, 2000, pp. 7-8.
Winfried Georg Sebald, Austerlitz, Milano, Adelphi, 2002, p. 220.
10
Prefazione
Una terza riflessione sul nostro riposizionarci, accogliendo le
indicazioni e le suggestioni fin qui raccolte, riguarda la strategia di
forma e contenuto che dobbiamo assumere per una comunicazione
che trasmetta conoscenza e coscienza, che sia di prospettiva ma che
contemporaneamente ci interroghi sui poli ed i termini implicati nella
comunicazione: istituzioni e persone, storia ed identità, differenze e
somiglianze.
Partiamo da un esempio di storia personale (e forse opinabile,
ma così è): io non sono stato in grado fisicamente e psichicamente di
vedere, tra i molti film presenti sull’argomento, Schindler's List di
Steven Spielberg (Usa 1993) mentre, uscito dal cinema dopo la proiezione de La vita è bella di Roberto Benigni (Italia 1997), ho commentato con un mio figlio di 16 anni: «questo film dovrebbe essere obbligatorio per tutte le scuole superiori» (e pensare, poi, che era stato proprio Giulio a convincermi alla visione del film). Proviamo ora ad evidenziare premesse e implicazioni di questo mio ricordo: nato subito
dopo la guerra, per i racconti in famiglia ero a conoscenza della
Shoah, della storia di guerra e dei crimini contro la persona (la massa
di persone), della storia di quanti in Europa si erano opposti e di quanti avevano collaborato… Sapevo, ma sapere non è vedere, anche se
immaginavo cosa significassero quei “fatti” e capivo come fosse importante parlarne, di farlo sapere ai figli dei figli; poi cominciarono a
circolare le prime documentazioni fotografiche sui campi di concentramento e le camere a gas; poi la lettura in famiglia del Diario di Anna Frank, che seguivamo come fosse un radio-dramma… ma trovarmici davanti in un film: no, non avrei retto la crudeltà delle immagini
che pensavo il film di Spielberg contenesse, anche se conoscevo la
crudeltà degli uomini attraverso le parole per dirla.
Cosa era cambiato con il film di Benigni? Non credo siano stati
i 4 anni di distanza tra i due film, come la distanza ulteriore dagli
eventi e dal tempo della Shoah, o la modificazione della mia memoria
delle narrazioni avute o altro ancora che non so… Penso che il film di
Spielberg ti documenta, ti mette con le spalle al muro, ti toglie il respiro, ti dice “attento a te!”, ma io lo sapevo già e la visione del film
mi avrebbe solo compresso l’anima con le sue immagini documentarie. La vita è bella ti fa sentire parte del racconto, come se fossero gli
Prefazione
11
attori a guardati mentre segui la loro fantasia “politica ed umana”: i
simboli rimangono gli stessi tra i due film, ma quest’ultimo conferisce
loro un senso ulteriore, non guarda con gli occhi del passato, non documenta, ma ti fa vedere con i tuoi occhi una meta-storia, attua un trasferimento di significati del passato in una espressione di nuova prospettiva…
A ben vedere le mie riflessioni sono tutte riconducibili ad una
questione sola e di non poco conto: credo che non sia la storia in sé a
dover essere narrata, esposta, riproposta oggi nella sua documentalità,
come non spetta agli storici far incontrare i giovani con la Shoah come
fosse una questione di identità di popolo. Credo che il compito di non
perdere o tradire la nostra memoria e la sua Memoria oggi spetti agli
artisti perché gli unici in grado di riferire e riferirsi all’evento facendone un ponte per una proposta, esperienza, programma di incantamento, coinvolgimento, senso di responsabilità.
La rappresentazione d’arte di un documento storico, se sembra
non avere più nulla a che fare con l’evento, al contrario con la sua
strategia di documento metastorico ci guarda e riguarda con una doppia funzione comunicativa: il nostro coinvolgimento e il suo potere
documentale proprio perché presentifica l’evento passato, restituisce
un senso al significato storico attualizzandolo. Decolonizza il nostro
sguardo proponendo un’etica della forma in cui è a noi che viene affidata la costruzione di senso: la memoria non è più e non solo un ricordo del passato, un “monumento ad un evento”, ma una proiezione di
memoria aperta per una persona unificata.
È questo il paradigma, ad esempio, adottato da Andrea Petrillo
con la sua istallazione visiva Radio della Memoria presentata ad Itri
(Latina) in occasione della Giornata della Memoria del 2010 e che poi
ha trovato anche un canale attivo di riferimento in web. Nel suo diario
di lavoro affiora l’inadeguatezza di concepire e quindi di tradurre in
linguaggio lo sterminio: «Una parola può essere l’olocausto? La risposta è no. Una parola simile può non rappresentare niente». Così
«raccontare la Shoah è mille storie, è siamo tornati, è sopravvissuto, la
Shoah ha mille nomi, è mio, tuo, di lui» e per questo la Shoah non si
può contenere, non si può dire… Come evidenzia il critico Giovanni
12
Prefazione
Burali d’Arezzo nella presentazione di Radio della Memoria: «Per Petrillo fare memoria significa dare vita ad operazioni di manipolazione
di materiali inerti (perciò volontarie, intellettuali, in qualche modo
pianificate), facendo sì che tali materiali recuperino le loro presenzialità e il loro accadere (siano cioè immessi nel flusso della vita, di una
vita particolare, quindi nel magma dinamico di un’autobiografia) di
cui si può solo mostrare il divenire. La manipolazione rappresenta
un’evoluzione processuale che preannuncia un compimento oltre la
forma». Ed è con questa strategia comunicativa e di prospettiva che
l’identità di una persona, l’identità di un popolo può trasmutare nel
tempo e ridefinirsi nell’oggi con il superamento dei “confini” identitari con cui ci vestiamo come illusione, dietro cui ci nascondiamo come
illusione. Francesco Remotti, antropologo, così definisce questi confini di una falsa identità, definibile come identitarismo:
«L’identitarismo è un’auto-illusione, un mito pernicioso del nostro
tempo, creato da società che con l’identità pensano di difendere le
proprie ricchezze e i propri privilegi, arroccandosi in una sorta di fortilizio eretto di fronte alle minacce dell’alterità. Ma l’identitarismo
non sa che sotto gli schemi oppositivi dell’identità e dell’alterità permane, anche se ridotto, il groviglio dinamico delle somiglianze e delle
differenze, da cui soggetti più liberi e meno accecati possono trarre
ispirazione per intendere in un altro modo i rapporti tra i gruppi umani. […] A ben vedere, è il concetto di somiglianza ciò che ci consente
di uscire dalle secche e dalle illusioni dell’identità, perché la somiglianza contiene in sé due componenti che si intrecciano e mai si annullano: una relativa permanenza e una relativa diversità»4.
4
Francesco Remotti, Identità e identitarismo, in “tamtàm democratico”, n. 3, novembre
2011, pp. 42 e 40.