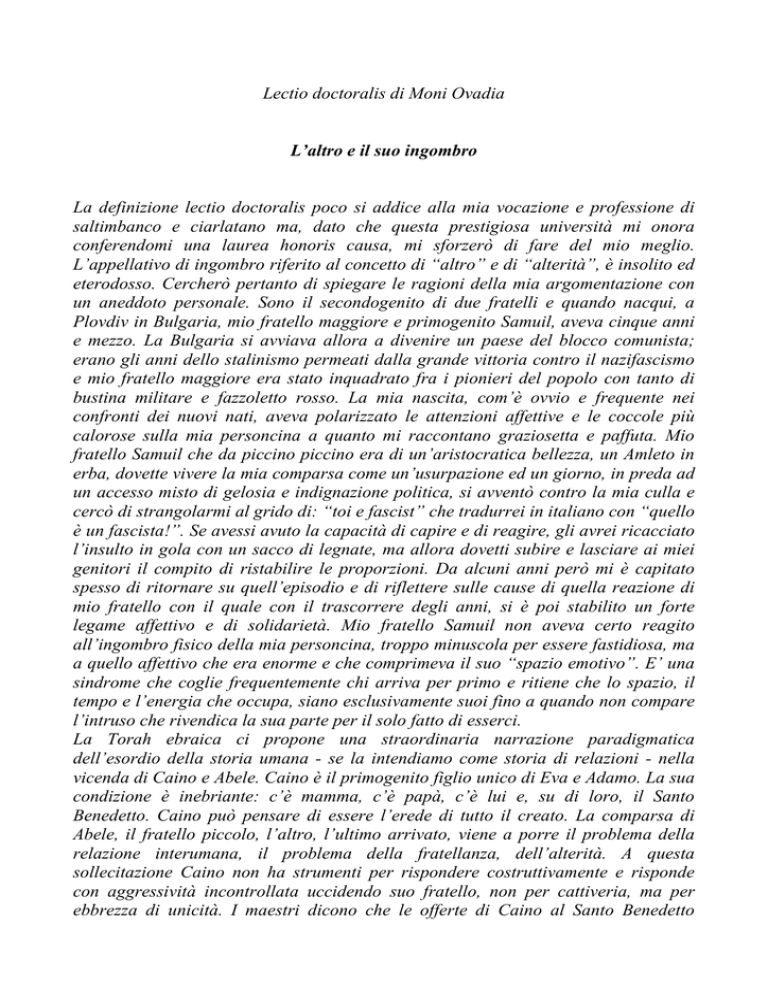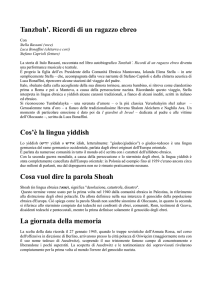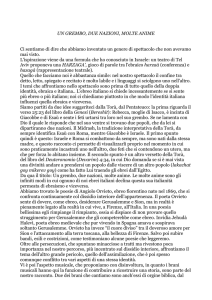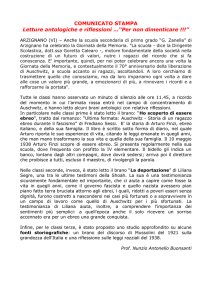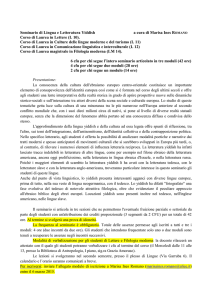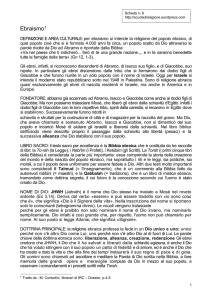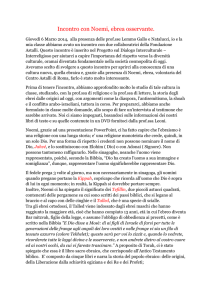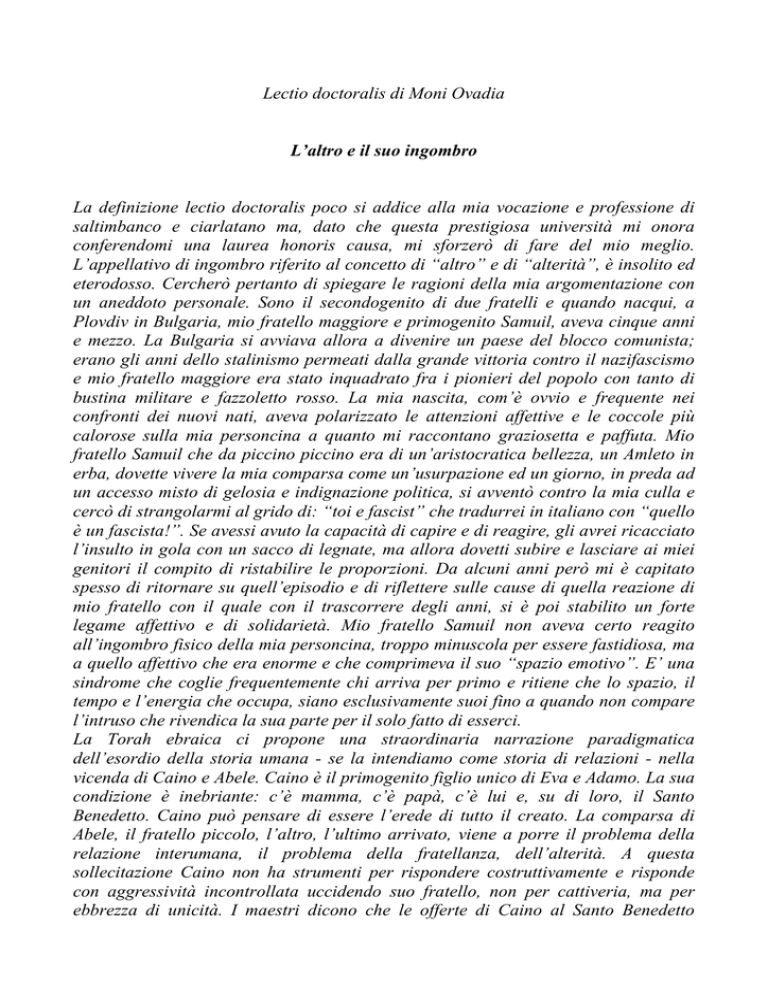
Lectio doctoralis di Moni Ovadia
L’altro e il suo ingombro
La definizione lectio doctoralis poco si addice alla mia vocazione e professione di
saltimbanco e ciarlatano ma, dato che questa prestigiosa università mi onora
conferendomi una laurea honoris causa, mi sforzerò di fare del mio meglio.
L’appellativo di ingombro riferito al concetto di “altro” e di “alterità”, è insolito ed
eterodosso. Cercherò pertanto di spiegare le ragioni della mia argomentazione con
un aneddoto personale. Sono il secondogenito di due fratelli e quando nacqui, a
Plovdiv in Bulgaria, mio fratello maggiore e primogenito Samuil, aveva cinque anni
e mezzo. La Bulgaria si avviava allora a divenire un paese del blocco comunista;
erano gli anni dello stalinismo permeati dalla grande vittoria contro il nazifascismo
e mio fratello maggiore era stato inquadrato fra i pionieri del popolo con tanto di
bustina militare e fazzoletto rosso. La mia nascita, com’è ovvio e frequente nei
confronti dei nuovi nati, aveva polarizzato le attenzioni affettive e le coccole più
calorose sulla mia personcina a quanto mi raccontano graziosetta e paffuta. Mio
fratello Samuil che da piccino piccino era di un’aristocratica bellezza, un Amleto in
erba, dovette vivere la mia comparsa come un’usurpazione ed un giorno, in preda ad
un accesso misto di gelosia e indignazione politica, si avventò contro la mia culla e
cercò di strangolarmi al grido di: “toi e fascist” che tradurrei in italiano con “quello
è un fascista!”. Se avessi avuto la capacità di capire e di reagire, gli avrei ricacciato
l’insulto in gola con un sacco di legnate, ma allora dovetti subire e lasciare ai miei
genitori il compito di ristabilire le proporzioni. Da alcuni anni però mi è capitato
spesso di ritornare su quell’episodio e di riflettere sulle cause di quella reazione di
mio fratello con il quale con il trascorrere degli anni, si è poi stabilito un forte
legame affettivo e di solidarietà. Mio fratello Samuil non aveva certo reagito
all’ingombro fisico della mia personcina, troppo minuscola per essere fastidiosa, ma
a quello affettivo che era enorme e che comprimeva il suo “spazio emotivo”. E’ una
sindrome che coglie frequentemente chi arriva per primo e ritiene che lo spazio, il
tempo e l’energia che occupa, siano esclusivamente suoi fino a quando non compare
l’intruso che rivendica la sua parte per il solo fatto di esserci.
La Torah ebraica ci propone una straordinaria narrazione paradigmatica
dell’esordio della storia umana - se la intendiamo come storia di relazioni - nella
vicenda di Caino e Abele. Caino è il primogenito figlio unico di Eva e Adamo. La sua
condizione è inebriante: c’è mamma, c’è papà, c’è lui e, su di loro, il Santo
Benedetto. Caino può pensare di essere l’erede di tutto il creato. La comparsa di
Abele, il fratello piccolo, l’altro, l’ultimo arrivato, viene a porre il problema della
relazione interumana, il problema della fratellanza, dell’alterità. A questa
sollecitazione Caino non ha strumenti per rispondere costruttivamente e risponde
con aggressività incontrollata uccidendo suo fratello, non per cattiveria, ma per
ebbrezza di unicità. I maestri dicono che le offerte di Caino al Santo Benedetto
furono rifiutate perché contenevano piante a stelo unico, un segno simbolico del
rifiuto dell’altro. L’ebbrezza di unicità segna anche gli edificatori monolinguistici
della Torre di Babele con la loro sfida al cielo. La Torah ci descrive il loro contesto
comunicativo: “Va yehì kol haarets safà akhat udevarim akhadim”, (E su tutta la
terra ci furono una sola lingua e parole uniche. Genesi 11,1). Il mio Maestro, il
professor Bakharier, ricorda in una sua lezione memorabile che nel leshon hakodesh
- la lingua santa priva di grafemi vocalici -, l’espressione devarim akhadim, parole
uniche, può anche essere letta devarim akhudim, parole chiuse. Le parole babeliche
non accoglievano le altre lingue, non accettavano l’ingombro del
controargomentare, non lasciavano spazio alla dignità della critica e pertanto erano
asfittiche e generatrici di asfissia. Così come lo erano i linguaggi delle tirannie,
come la lingua dell’universo concentrazionario nazista. Per evitare questo rischio,
essere cioè concepito come unico, l’essere umano fu poi creato “duplice”, “Lo creò,
maschio e femmina lo creò”, maschile e femminile, perché ci fosse alterità e la
donna, contrariamente a quanto evocano le pessime traduzioni del leshon hakodesh,
la lingua santa della Torah, non viene creata in subordine al maschio ma “contro”,
“di fronte” al maschio, perché si stabilisca fra le due alterità dell’essere umano una
relazione di mutua responsabilità e non il dominio di una parte sull’altra. Il maschio
nel corso dei secoli ha compresso ”l’ingombro” della donna per ridurne il ruolo. Si
è spinto fino a negarle l’anima pur di non lasciarle spazio, tempo, influenza,
intelligenza e creatività e ancora ci prova grazie ad artifici come la riduzione del
femminile a sex simbol.
Il monoteismo prima e l’ebraismo in seguito, scelgono in un certo senso una
prospettiva femminile. Contrappongono all’incombenza della materia e alla
sottomissione ad essa (idolatria), l’assenza, l’ineffabilità (il Dio vivente che non si
vede, non si può nominare), alla forza e alla potenza, lo studio e la Legge severa ma
giusta, alla richiesta di sacrifici umani, la misericordia – in ebraico rakhmanut dalla
radice rekhem (utero) ovvero gli uteri divini che accolgono anche chi ha
abbandonato la via e chiede di tornare -, alla rigidità delle patrie e delle frontiere, il
grembo vivificante di una patria mobile, la Toràh.
L’ebreo è sin dall’antichità il fratello minore, il piccolo, non il fratello maggiore. La
sua consistenza numerica è esigua, al di là delle promesse incoraggianti “Sarete
numerosi come i granelli di sabbia sulle rive dei mari e come le stelle in cielo” anche
se quell’esiguità di popolazione, corrisponderà ad un ingombro immenso nella
spiritualità, a partire dall’assenza materica del divino. L’ebraismo inoltre
inaugurerà l’universalismo dell’essere umano, occuperà il futuro, dimensione
totalmente ostile per il concetto idolatrico della ruota dell’eterno ritorno, dilatazione
di un presente ipertrofico, affermerà l’universalismo come accesso all’uguaglianza.
Il divino del monoteismo ebraico, il tetragramma ineffabile si dichiarerà “Dio”
dell’intero genere umano con particolare predilezione per lo schiavo e lo straniero e
ad essi affiderà il compito di redimere il genere umano.
Affidato ad una forza centrifuga senza controllo, liberato nel mondo dell’antica
idolatria, un tale messaggio sarebbe stato deflagrante, insopportabile per la struttura
socio-antropologica di quell’umanità. Gli ebrei comprimono il proprio ingombro
universalista dentro un particolarismo desunto da un’elezione della responsabilità.
Questa elezione è espressa in un patto sacerdotale esclusivo direttamente con il
divino, berith milà, patto della circoncisione, e permette di affidare la relazione degli
ebrei con il resto dell’umanità al patto noachita - patto universale con tutti gli
uomini - riducendo a minor ingombro l’alterità ebraica.
Il prezzo che episodicamente gli ebrei pagheranno al particolarismo sarà
l’incremento del suo tasso di ingombro che finirà per comprimere l’orizzonte
universalista. Ma a fasi alterne la dialettica fra i due ingombri produrrà una
sconvolgente ricchezza di pensiero nel Talmud in particolare e nel pensiero di Israel
in generale.
Facendo riferimento al fatto che Ruth la moabita, ovvero una straniera, è fondatrice
della stirpe davidica, Julia Kristeva scrive in “Etrangers à nous mêmes” la sua
opera memorabile: “L’estraneità e l’incesto stanno dunque al fondamento della
regalità davidica (…) Non è assolutamente un incoraggiamento alla devianza né al
proselitismo, ma un invito a considerare la fertilità dell’altro. Tale è infatti il ruolo di
Ruth la moabita, l’esterna, la straniera, l’esclusa. Tuttavia se “l’estraneo
all’alleanza” accetta le regole morali dell’alleanza essa vi trova il suo motore, il suo
slancio vitale, la sua regalità. Sciupata forse, in ogni caso inquieta, questa regalità si
apre – attraverso l’estraneità che la fonda – alla dinamica di un’interrogazione
eterna, curiosa e ospitale, avida dell’altro e di se stesso come altro.
Gli osservanti divorano lo straniero, l’assimilano e lo integrano sotto la protezione
del codice morale della loro legge, al quale l’integrante e l’integrato aderiscono
entrambi. Coperti da questi ideali giuridici i fantasmi divoratori non si esprimono e
la colpa che potrebbero suscitare è deviata. Più ancora, sotto la protezione degli
ideali morali propri di quella legge, lo straniero incorporato lavora l’osservante
stesso dall’interno, ma a titolo di “doppio” – chiamando ad un’identificazione verso
il basso, verso l’eccesso e il “fuori dalla legge” che è offerta in permanenza al
credente e che stimola la dinamica della sua perfezione. Se Davide è anche Ruth, se
il sovrano è anche una moabita, allora la quiete non sarà mai il suo lotto, ma una
ricerca permanente per l’accoglienza e il superamento dell’altro in sé”.
L’arrivo dell’ebreo più celebre di tutti i tempi, Gesù di Nazareth o, per essere più
precisi, il significato progressivamente attribuito in Occidente e nell’Oriente
ortodosso, pur con prospettive diverse, alla parusìa del Cristo, trasforma la delicata
e inquieta dialettica ebraica di sé e ingombro dell’altro, in ingombro pernicioso per
la nuova dirompente religione universalista. Paolo l’ebreo ellenizzante, cosmopolita
e poliglotta, trasforma la piccola ecclesia ex circumcisione in ecclesia ex gentibus,
spezza l’inquietudine e la dialettica ebraica spingendo spregiudicatamente sul pedale
dell’universalismo: “Quando sono con gli ebrei vivo come essi pur di guadagnarli al
Cristo (…) Allo stesso modo quando mi trovo fra i “senza-legge”, mi faccio “senzalegge” per conquistarli, io che non sono sotto una legge di Dio, essendo sotto la
legge del Cristo (…) mi sono fatto tutto per tutti per salvarne alcuni ad ogni costo”.
(dall’epistola ai Corinzi IX, 20)
Il grande filosofo ebreo Rosenzweig, in uno scambio epistolare con Rosenstock, un
ebreo convertito al cristianesimo - che per spingerlo alla conversione afferma come
solo attraverso il Cristo ci si possa avvicinare al Padre -, gli fa osservare con ironico
candore: “Perché dovrei passare dal Cristo per avvicinarmi al Padre, visto che in
quanto ebreo sono vicino al padre da quattromila anni?”. Ma il problema si capisce
meglio collocandolo nella prospettiva aperta dal filosofo ed ebraista Lévinas:
“L’etica parla in ebraico, la filosofia in greco”. L’etica come filosofia prima, è la
grande intuizione dell’ebraismo ed è espressa nel celeberrimo versetto del Levitico
19,18 “Ve ahavtà lereekhà kamokha. Anì hashem” (Amerai il prossimo tuo come te
stesso. Io sono il Signore) compendiato dall’altro sublime versetto nello stesso
capitolo del Levitico: “Keezrakh mikem yhyiè lakhem hager, ha gher itkhem
veahavtà lò kamokha ki gherim hyitem beerets mitsrayim. Anì hashem elohekem” (Lo
straniero che abita tra voi lo considererete come chi è nato tra voi. Lo amerai come
te stesso poiché siete stati stranieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore. - Levitico
19,34). Questi due versetti cruciali trovano la loro naturale e definitiva confluenza
nel versetto 23 del capitolo 25 Parashà di Behar: “Ve haarets lo timakher litsmitut,
ki lì haarets, ki gerim ve toshavim atem imadì” (La terra non verrà venduta in
perpetuità perché la terra è mia e voi presso di me siete come stranieri e abitanti
temporanei). Un brillante traduttore protestante sceglie questa strategia di
traduzione: perché voi tutti presso di me siete come stranieri e meticci avventizzi. Il
comandamento dell’amore universale nell’alterità è enunciato dalla Torah con
inaudita ed ineguagliata potenza espressiva nel contesto dell’irrisolvibile
contraddizione di particolarismo ed universalismo che si rincorrono, si accolgono e
si superano reciprocamente in un’interrogazione senza fine. Il “prossimo” non è mai
connotato, dunque contiene in sé anche il nemico e persino lo sterminatore come
insegna Lévinas nella sua memorabile riflessione sul processo al boia nazista Klaus
Barbi che lo porta ad elaborare la teoria della “responsabilità per il volto altrui”.
San Paolo si propone di far parlare l’etica in greco attraverso il Cristo come verità
unica e assoluta. Ontologia ed etica si identificano. La radicalità universalistica di
Paolo, pur di conquistare al Cristo più anime possibili, porterà ad accettare il
compromesso con l’universalismo di potere di Roma e da lì, verosimilmente, nascerà
il temporalismo della Chiesa, il Dio Verità incarnato potrà essere scolpito nella
pietra o nel legno e divenire comprensibile per la mentalità romana. Gli ebrei erano
inomologabili a qualsiasi paganesimo neppure a quello del disponibile ecumenismo
imperialista della Roma dell’Era Volgare. Di tutte le province del vastissimo impero
romano, la Giudea era la più riottosa ed irriducibile. L’aveva capito Tito, che perse
un nipote, il generale Onkelos il quale, inviato a reprimere le rivolte in Giudea, vi
incontrò l’ebraismo e vi si convertì divenendo uno dei suoi più celebrati maestri.
Dopo questo “sgarro”, quando Tito entro nel kodesh ha kodashim, il sancta
sanctorum e vide che era totalmente vuoto, capì che con gli ebrei non c’era rimedio,
distrusse il tempio e li deportò in massa come schiavi sradicandoli dalla loro Terra e
dando l’avvio alla bimillenaria diaspora. Iniziava per il popolo ebraico la carriera
di ingombrante spina nel fianco del cristianesimo, testimonianza di un’alterità
prossima eppure lontanissima, emblema vivente del deficit salvifico cristiano proprio
nei riguardi di chi al cristianesimo aveva dato vita.
Gran parte del mondo cattolico e cristiano di fronte all’imbarazzo e alle difficoltà
dottrinarie derivanti da quella carenza, rispose all’ingombro spirituale ebraico con
persecuzioni e stermini, contribuendo ad avviare l’Occidente verso la bancarotta
fraudolenta della Shoà. Duemila anni dopo che un giovane ebreo era salito sulla
croce, saliva sulla croce di Auschwitz l’intero popolo ebraico con un milione e mezzo
di bambini. Un bimbo in particolare - condannato dai nazisti all’impiccagione per
una ridicola trasgressione - che a causa del suo esile peso agonizzò più di mezz’ora
prima di rimettere l’anima al Creatore, divenne per una certa teologia cristiana,
l’incarnazione del Cristo del Duemila. Ma sulla croce del Golgota nazista non sono
saliti i cristiani in quanto tali, ma gli ebrei in quanto tali, di educazione cristiana
invece erano tutti i carnefici. Il sacrificio più immane di quel diluvio, colpì il popolo
della yiddishkeit, l’ebraismo ostjudish, popolo in tutto e per tutto per cultura, lingua,
identità, profonde strutture dell’emozione intraducibili in parole, sentimento di
appartenenza, fede, spirito di redenzione, musica, canto, letteratura, tradizioni. E
colpita a morte fu la sua impareggiabile lingua, lo yiddish voce di esilio, condizione
dello spirito prima ancora che lingua.
Franz Kafka la descrive con queste parole memorabili: “Avanti la recita dei primi
versi di poeti ebrei orientali vorrei ancora dirvi, egregi signori e signore, che voi
capite molto più yiddish di quel che pensiate […] Il che non può accadere finché
alcuni di voi hanno, di questo gergo, una tal paura, che quasi gliela leggo in
viso.[…] Lo yiddish è la più giovane lingua europea, non ha che quattrocento anni e
in realtà è ancora più recente. Non ha ancora formato strutture linguistiche così
nette come ci sono necessarie. Le sue espressioni sono brevi e nervose. Non ha
grammatica. Certi amatori tentano di scrivere delle grammatiche, ma lo yiddish
viene parlato senza sosta, e non trova pace. Il popolo non lo cede ai grammatici.
Esso si compone solo di parole straniere. Queste, però, non riposano nel suo seno,
ma conservano la fretta e la vivacità con cui sono state accolte. Lo yiddish è
percorso da un capo all'altro da migrazioni di popoli. Tutto questo tedesco, ebraico,
francese, inglese, slavo, olandese, rumeno e persino latino che vive in esso è preso da
curiosità e da leggerezza, ci vuole una certa energia a tenere unite le varie lingue in
questa forma. Perciò nessuna persona ragionevole penserà mai a fare dello yiddish
una lingua internazionale, benché l'idea si offra quasi da sé. Solo il linguaggio della
malavita vi attinge volentieri, perché gli occorrono non tanto nessi linguistici quanto
singoli vocaboli. E poi, perché lo yiddish è stato a lungo una lingua disprezzata. […]
E ora, in queste strutture linguistiche impastate di arbitrio e di norme fisse, si
riversano ancora i dialetti. Perché tutto lo yiddish non si compone che di dialetto,
compresa la lingua scritta, anche se in massima parte ci si è accordati sulla grafia.
Con tutto ciò, signore e signori, penso di aver convinto, per ora, la maggior parte di
voi che non capirete una sola parola di yiddish. Non vi aspettate un aiuto dalla
spiegazione delle singole poesie. Se davvero non siete in grado di capire lo yiddish
nessuna illustrazione di dettaglio vi potrà mai aiutare. Nel migliore dei casi capirete
la spiegazione […]. Ma se ve ne state tranquilli, vi troverete di colpo nel bel mezzo
dello yiddish. Ma una volta che esso vi abbia afferrati - e tutto è yiddish: la parola,
la melodia cassidica e l'indole stessa [dell’ebreo orientale ndr]- allora non
conoscerete mai più la vostra pace di un tempo. Allora sentirete la vera unità dello
yiddish, e così forte, che avrete paura, ma non più dello yiddish: di voi stessi. Non
sareste capaci di sopportare da soli questa paura, se dallo yiddish medesimo non vi
venisse anche una fiducia in voi stessi che fronteggia validamente tale paura e che è
più forte di essa. Godetene meglio che potete! Ma se poi la perderete, domani o dopo
- e come potrebbe reggersi al ricordo di un solo recital! - allora vi auguro di aver
perso intanto anche la paura”. (Franz Kafka: dal “Discorso sulla lingua yiddish” in
“Diari e confessioni”)
Il popolo dello yiddish è stato un capolavoro di umanità: senza confini, senza
frontiere, senza eserciti, senza burocrazie, senza deliri nazionalisti. Un popolo con la
sua patria portatile, la Torah, che sapeva vivere a cavallo dei confini, fra cielo e
terra, tenendo per mano l’ineffabile Dio del monoteismo come un compagno di
giochi, rispettandone la maestà ma denunciandone contemporaneamente la correità
nei mali del mondo. Un popolo di uomini semplici e sapienti che glorificavano
l’uomo fragile e facevano della fragilità la potenza di chi accetta la sfida di
redimersi redimendo il Santo Benedetto, capaci di vertigini di pensiero in cui il più
umile si misurava con le asperità del sapere ebraico, capaci di stupore estatico di
fronte ad ogni più insignificante manifestazione del creato e di pietas per il soffrire di
ogni essere vivente, goffamente belli con i loro cernecchi svolazzanti ai lati delle
tempie (ho sempre pensato che Gesù sia stato ritratto coi capelli lunghi perché aveva
delle peyòt lunghe come un super khassid e così lo rappresenterò in un mio prossimo
spettacolo) erano persino malinconicamente sublimi nei loro difetti e nelle
superstizioni, separati dal mondo che li circondava ma non chiusi ad esso, ai suoi
umori, ai suoi suoni, alle sue musiche e alla sua gente buona, sognatori ed umoristi
per vocazione, inventori dell’umorismo ferocemente autodelatorio come rimedio
contro l’idolatria e la violenza.
Questo “popolo della domanda che rimane aperta anche dopo che la bocca si è
chiusa” era un ingombro insopportabile per un mondo brutale posseduto dal demone
dell’odio, del nazionalismo, animato da pulsioni di morte, dalla brama di risposte
perentorie, di supremazia. E’ stato così facile annientarlo perchè era solo e indifeso,
era troppo per un mondo così infame e violento:
“E chi è mai un grande ebreo del passato di fronte ad un piccolo ebreo di oggi, un
semplice ebreo di Polonia, di Lituania, di Volinia. In ogni ebreo urla un Geremia,
ruggisce un Giobbe disperato, in ogni piccolo ebreo un re scettico canta il suo canto
d’Ecclesiaste”. (Itzkhak Katzenelson: “Canto del popolo ebraico massacrato” Canto
IX, Ai cieli.) Al loro ingombro inespresso carico di energia spirituale e poetica, ho
dedicato gran parte della mia vita, convinto che essi ci abbiano lasciato in eredità la
loro incessante interrogazione per costruire un futuro fondato sulla fragilità. Oggi
l’ebreo ha perso questi statuti li cede in cambio di certezze, di confini, di forza, di
status sociale autorevole, anche se talora il suo ingombro pregresso riaffiora: come
nel caso dei deliri di un dittatore squalificato in cerca di facili consensi ed è il caso
del presidente iraniano Ahmadinedjad. Un tempo l’ebreo era come lo zingaro, oggi
lo zingaro è l’ebreo, porta l’ingombro che l’ebreo ha accantonato. L’antico
ingombro dell’ebreo si specchia sempre più spesso negli occhi di un vecchio
palestinese che infrange il suo sguardo contro un brutto muro di cemento elettrificato
o negli occhi di una palestinese che guarda la sua casa abbattuta e i suoi ulivi
sradicati in nome della sicurezza.
L’ingombro dell’altro è sempre lì per parlarci, sta a noi ascoltarlo.
Moni Ovadia