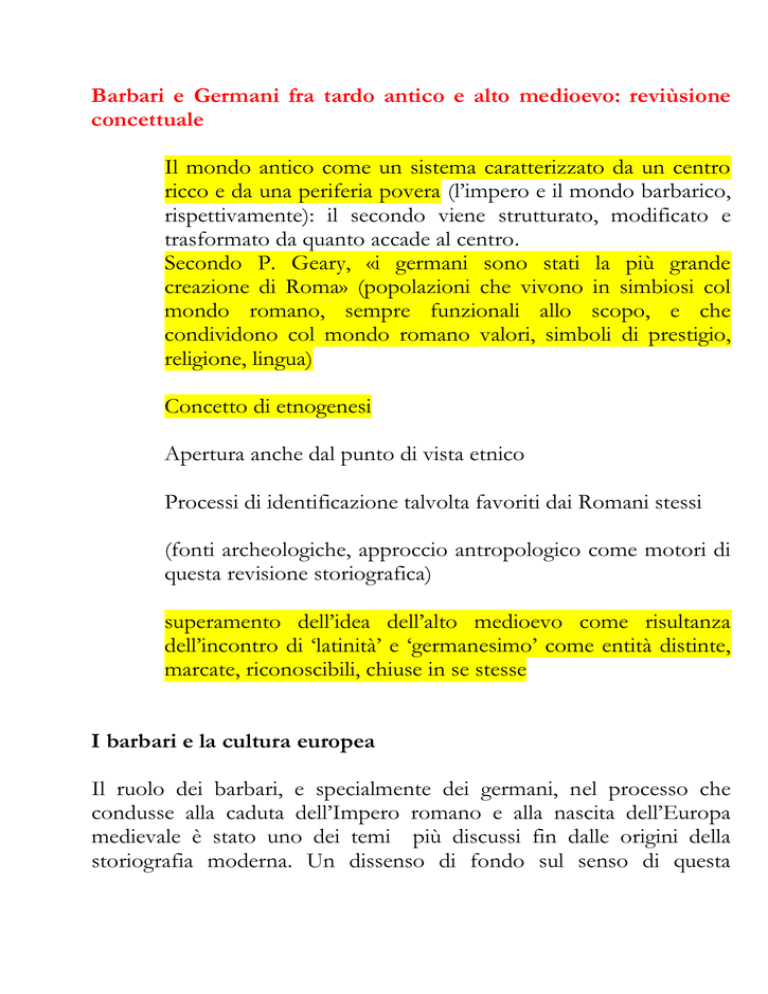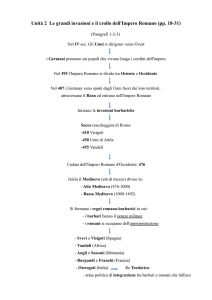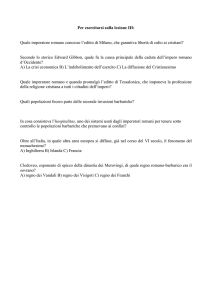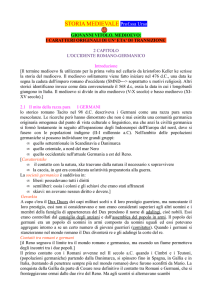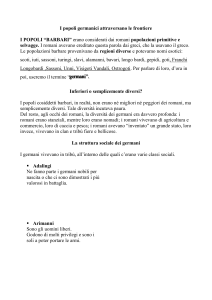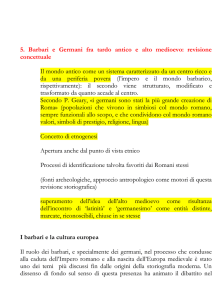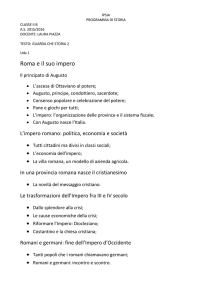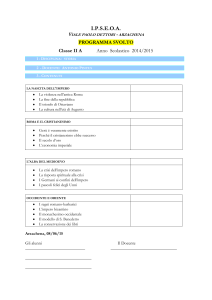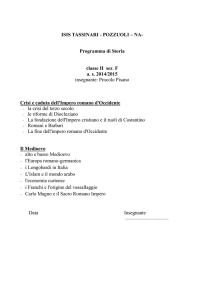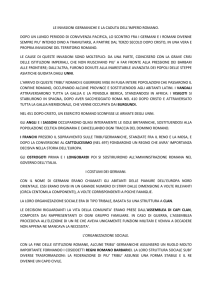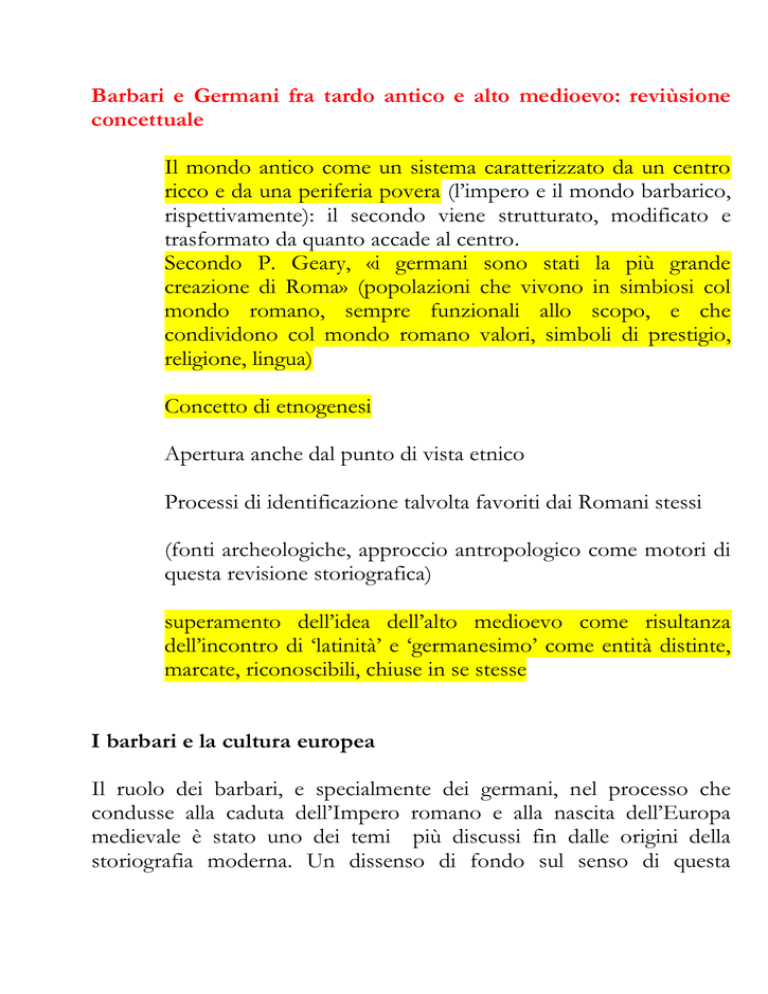
Barbari e Germani fra tardo antico e alto medioevo: reviùsione
concettuale
Il mondo antico come un sistema caratterizzato da un centro
ricco e da una periferia povera (l’impero e il mondo barbarico,
rispettivamente): il secondo viene strutturato, modificato e
trasformato da quanto accade al centro.
Secondo P. Geary, «i germani sono stati la più grande
creazione di Roma» (popolazioni che vivono in simbiosi col
mondo romano, sempre funzionali allo scopo, e che
condividono col mondo romano valori, simboli di prestigio,
religione, lingua)
Concetto di etnogenesi
Apertura anche dal punto di vista etnico
Processi di identificazione talvolta favoriti dai Romani stessi
(fonti archeologiche, approccio antropologico come motori di
questa revisione storiografica)
superamento dell’idea dell’alto medioevo come risultanza
dell’incontro di ‘latinità’ e ‘germanesimo’ come entità distinte,
marcate, riconoscibili, chiuse in se stesse
I barbari e la cultura europea
Il ruolo dei barbari, e specialmente dei germani, nel processo che
condusse alla caduta dell’Impero romano e alla nascita dell’Europa
medievale è stato uno dei temi più discussi fin dalle origini della
storiografia moderna. Un dissenso di fondo sul senso di questa
presenza ha animato il dibattito nel corso di vari secoli, dissenso che si
rispecchia in una terminologia che è rimasta sempre la stessa: il
fenomeno delle «invasioni barbariche», come furono definite dagli
storici italiani e francesi, assumeva infatti nel linguaggio storiografico
tedesco l’etichetta di «migrazione dei popoli» (Völkerwanderung).
Anzi, generazioni di tedeschi, dall’Umanesimo quattrocentesco al 1945,
hanno elaborato la propria identità e la propria peculiarità culturale
come radicate nei tempi dei primi germani. I «nobili selvaggi» descritti,
intorno al 100 d.C., da Tacito nella Germania, furono assunti a
modello di una vita semplice, pura, non corrotta da influssi della civiltà
urbana e mediterranea. Questa costruzione ideologica ha assunto nel
corso del tempo e a seconda dei contesti storici valori ben diversi nella
storia moderna dell’Europa, attirando l’attenzione anche di intellettuali
di altri paesi. Nella prospettiva di un illuminista come Montesquieu, nel
Settecento, la Germania antica serviva come esempio di una vita libera
e democratica; nella letteratura romantica del primo Ottocento tedesco,
simbolizzava i valori comuni e profondi di una nazione culturale che
non poteva diventare Stato nazionale; nel nazionalismo tedesco
intorno al 1900, stava al centro di un’ideologia antimoderna e
militaristica; e, infine, durante il nazismo, entrò in relazione con le
teorie pseudo-scientifiche della superiorità della razza germanica che
avrebbero istigato alla guerra e all’Olocausto.
Solo nel dopoguerra furono gradualmente smantellate le costruzioni
ideologiche delle quali i barbari del passato costituivano un punto di
riferimento. Oggi quei barbari non vengono più concepiti come facenti
parte di una realtà nettamente definita, dotata di un’unica, autentica
matrice identitaria, più pura della civiltà classica, o magari della nostra.
Non è più possibile guardare alle società barbariche come modello di
una vita incorrotta e più vicina alla natura, anche se nella cultura
comune ancora oggi può succedere di registrare immagini di questo
tipo, magari attribuite più frequentemente, in ambienti che coltivano
culture mistico-esoteriche, ai celti. Per gli storici di oggi, anche il
mondo barbarico è un fenomeno storico, dinamico, pieno di rotture e
contraddizioni, da analizzare innanzitutto come spazio periferico della
civiltà antica e non più come espressione di una perduta età dell’oro.
Eppure, negli studi storici si sente ancora il peso, molto più forte di
quanto si creda, delle antiche ideologie. Chiunque si occupi dei
germani, infatti, deve anche tornare a leggere le molte interpretazioni
che sono state date nel corso del tempo e che si sono sovrapposte su
questo tema, determinando, come accade con ogni grande questione
storica, un intreccio difficilmente districabile. Una lettura innocente,
non ideologica, ad esempio della Germania di Tacito, è diventata
impossibile. La realtà del passato da una parte e le sue percezioni
antiche e moderne dall’altra sono piani inseparabili.
Ci chiederemo dunque che ruolo giocano nella formazione dell’Europa
altomedievale le tradizioni culturali, religiose e politiche delle
popolazioni germaniche e nomadi che si confrontano con il mondo
romano e cristiano; quali di queste culture resistono meglio e quali
vengono cancellate; come conosciamo le civiltà che non ci hanno
lasciato (in linea di massima) fonti scritte. Ma c’è un interrogativo del
tutto preliminare. Qual era, presso i contemporanei, la percezioni
dell’alterità etnica nel mondo tardoantico?
Le fonti scritte sul barbari e i germani
Per noi, i barbari tardoantichi restano più o meno muti. A parte
qualche iscrizione runica, spesso molto breve ed enigmatica, le culture
barbariche non hanno lasciato fonti scritte dirette. L’unico testo
germanico esteso è la traduzione gotica della Bibbia, elaborata da
vescovo Ulfila nel secolo IV e fatta copiare in un lussuoso codice
purpureo dal re ostrogoto Teodorico nell’Italia del secolo VI (il
cosiddetto Codex argenteus, oggi a Uppsala). Gli storici di origine
barbarica, come il goto Jordanes (sec. VI), il burgundo-franco
Fredegario (sec. VII), l’anglosassone Beda e il longobardo Paolo
Diacono (sec. VIII), scriveranno la storia dei Regni romano-barbarici
adottando il latino e un punto di vista che, più o meno, riprendeva
quello degli autori classici.
Solo più tardi cominceranno ad apparire i primi testi non frammentari
in lingua germanica, dapprima, dal secolo VII, in Inghilterra (tra l’altro,
leggi e poemi epici come Beowulf), e poi, dal secolo VIII, anche nel
mondo franco. Trascorsero altri secoli prima che nascessero due
distinte tradizioni letterarie, spesso considerate come autenticamente
germaniche: da una parte le saghe nordiche, dall’altra i poemi epici di
ambientazione feudale. La tradizione delle saghe – leggende costruite
attorno alle vicende di personaggi eroici si sviluppa fra l’Islanda e la
Scandinavia. Il frutto principale è l’Edda, raccolta di storie epiche
scandinave che contiene molte notizie sui dei ed eroi pagani. I racconti
dell’Edda furono scritti tuttavia nei secoli XII-XIII in un ambiente già
cristianizzato e l’autore più famoso, Snorri Sturlusson, che aveva
studiato a Parigi, apparteneva all’élite intellettuale dell’Europa cristiana.
Anche per questo i testi nordici difficilmente possono essere
considerati una chiave per accedere al mondo germanico continentale
del primo millennio.
Più o meno nello stesso periodo, l’Europa feudale elaborava una
letteratura epica, che narrava storie remote con soggetti mitici come i
nibelunghi, o di origine storica come Teodorico/Dietrich o
Attila/Etzel. Anche queste leggende hanno più a che fare con la
cultura del Duecento e del Trecento che non con quella barbarica di
molti secoli prima. Il quadro è simile per la cultura celtica, che trovava
espressione scritta principalmente nella cultura cristiana irlandese.
In realtà, ciò che sappiamo sul mondo barbarico prima dei carolingi
proviene in gran parte dagli scrittori greci e latini. Il termine stesso,
«barbaro», è una parola greca che significava in origine «straniero» e
che alludendo al gergo incomprensibile dei non elleni assunse nel corso
del tempo, nella cultura greco-romana, risonanze negative e di
disprezzo. Nella storiografia contemporanea esso viene ancora
adoperato, ma in modo neutrale, puramente descrittivo. L’immagine
del barbaro era costruita su generalizzazioni e stereotipi e qualche volta
si colorava di dettagli suggestivi: i barbari erano selvaggi, più simili ad
animali che a uomini, erano nomadi privi di case, spesso giravano nudi
o coperti di pelli, erano sporchi e puzzavano. Spesso venivano
rappresentati con corporature gigantesche, con barbe folte e lunghi
capelli incolti. L’immaginario poteva arricchirsi di toni inverosimili:
ecco allora i guerrieri che mangiano carne cruda e talvolta bevono
sangue, anche umano. Gli autori antichi sottolineavano il loro
coraggio, che poteva trasformarsi in folle temerarietà, e il loro terribile
furore bellico: ma contro un esercito romano ben disciplinato
emergeva la loro fragilità e la loro scarsa resistenza psicologica. Lo
stereotipo guerriero non lascia da parte le donne: esse accompagnano
gli uomini al campo di battaglia per incitarli o magari per lottare anche
loro; e se i loro uomini fuggissero, esse reagirebbero duramente fino a
ucciderli, per poi sacrificare se stesse per non cadere nelle mani dei
nemici. Tali comportamenti sono determinati – dicono queste
rappresentazioni – dal clima freddo, che a sua volta riscalda il sangue
degli uomini rendendoli irascibili. Nella prospettiva della cultura
mediterranea il Settentrione d’Europa era abitato allora da popolazioni
numerose, costantemente minacciose, sempre in cerca di luoghi più
miti e fecondi in cui trasferirsi e pronte per questo ad abbandonare il
suolo patrio per invadere le regioni occupate da altri popoli.
L’immagine dei barbari può comunque assumere anche un carattere
più positivo. Essi possono essere evocati come nobili selvaggi, ad
esempio da Tacito che descrive i germani, o da Pompeo Trogo e
Giustino che riflettono sugli sciti. Questi ritratti dell’Altro dipingono in
modo moralizzante un mondo opposto alla civiltà mediterranea, ma
rievocandolo ritrovano in esso alcune delle virtù della Roma arcaica.
Elogiano così il pudore dei popoli non civilizzati: non viene praticato il
sesso prematuro e gli sposi si mantengono fedeli. Sottolineano altresì
che i barbari non hanno bisogno del circo, del teatro e degli spettacoli,
del lusso e dei gusti raffinati. Sono questi i tratti della Germania di
Tacito nei quali generazioni di tedeschi hanno trovato la prova della
propria superiorità morale, e attraverso i quali hanno formulato il
richiamo alle virtù primordiali dell’anima del popolo (Volksseele),
un’anima pura da restituire, in uno sforzo morale guidato dagli antichi
modelli, ai corrotti tempi moderni.
In realtà ora sappiamo che queste immagini spesso ci dicono di più
della cultura mediterranea che le elaborava che non del mondo
barbarico che vorrebbero descrivere. Certo, negli stereotipi c’è spesso
un’elemento di verità, e i greci e i romani erano capaci di percezioni
molto acute. Ma comparando i diversi testi che parlano dei barbari, si
nota anche quante incertezze e contraddizioni essi contenessero.
Nemmeno gli elementi fondamentali di questi immagini erano senza
ambiguità: erano biondi i germani, come vuole anche il mito moderno,
oppure rossicci, come sostenevano altri autori? Erano avidi d’oro o
piuttosto così primitivi che con l’oro non sapevano nemmeno che
fare? Erano tenaci e lungimiranti oppure i loro tremendi furori ne
fiaccavano facilmente l’azione? Questi, e molti esempi simili,
dimostrano che l’immagine del barbaro era un’astrazione non adatta a
descrivere correttamente le molteplici forme di vita alle periferia del
mondo romano.
I processi di acculturazione
L’archeologia conferma questa prospettiva aiutando a mettere in luce la
diversità e la ricchezza culturale di tutte le presenze collocate fuori
dell’Impero e con le quali i romani entravano in contatto.
Ad esempio, le ricchissime tombe trovate in aree diverse dimostrano
che i guerrieri barbari, si servivano di vasellame d’argento, di oggetti in
vetro, di cinture militari di fattura romana, non diversi in questo
dall’élite imperiale dello stesso periodo. In realtà, attraverso complessi
processi di acculturazione e di romanizzazione il mondo barbarico si
trasformò ben prima dell’avvio della stagione delle invasioni. D’altra
parte, entro i confini dell’Impero, per esempio in molte regioni di
montagna, sono attestate forme di vita che si differenziavano dallo
splendore classico delle metropoli, e che alterano l’apparente
uniformità di cultura e stili di vita della società romana. Ciò significa
che la frontiera imperiale, nonostante tutta la sua impressionante
architettura difensiva, non era affatto un confine che separava con
nettezza due spazi omogenei, civiltà e barbaritas, come sosteneva
l’ideologia imperiale. Studi recenti hanno sottolineato questa differenza
fra la «frontiera immaginaria» e le molte funzioni delle strutture reali
del limes. Quest’ultimo era in realtà un simbolo imperiale; era una linea
di controllo militare e civile, ma anche una zona di scambio e di
comunicazioni; ed era pertanto, lo spazio di confine, un canale di forte
penetrazione dei modelli di vita romani, modelli che forse non bisogna
assimilare alle immagini classicistiche dell’antico trasmesse a noi a
partire dal Rinascimento, ma che comunque esercitavano un’attrazione
molto intensa. La recente archeologia ha messo in luce molti aspetti
dell’influenza del mondo romano sulle culture materiali barbariche,
come ad esempio nel modo di vestire, nonché sull’arte e l’iconografia
dei popoli confinanti: si pensi ai bratteati nordici, i medaglioni d’oro
con uomini e animali stilizzati che seguono modelli di monete romane
anche quando raffigurano scene della mitologia germanica.
Lo spazio barbarico non era dunque quel mondo tanto diverso e
incomprensibile, dipinto dagli scrittori romani, ma parte integrante
dell’universo tardoantico. Era la periferia di un sistema del quale Roma
e l’Italia, e più tardi Costantinopoli, erano i centri. Questa osservazione
fondamentale non implica, come abbiamo già accennato, che non ci
fossero differenze culturali entro questo immenso spazio periferico.
Variavano molto la qualità delle relazioni fra i diversi gruppi barbarici e
il mondo romano, e il grado di integrazione all’interno di quest’ultimo
delle popolazioni che avevano accettato la convivenza. La disponibilità
al contatto, allo scambio e anche all’integrazione non era una
meccanica funzione della distanza geografica, come ipotizzavano gli
autori romani, per cui le popolazioni più lontane dai confini
dell’Impero, ambientate in climi più freddi, erano anche quelle più
barbariche. Non ci sono, per esempio, altri luoghi al mondo dove sono
state ritrovate tante armi romane come in certe paludi scandinave (ad
esempio, a Illerup in Danimarca), dove, forse per ragioni di culto,
finivano sommerse centinaia di spade e lance romane. Simili
rinvenimenti fanno pensare alla diffusione di manufatti e di modelli
culturali provenienti dal mondo romano presso nuclei di guerrieri che
vivevano anche a grande distanza dal limes: per costoro imitare le
forme militari romane era evidentemente un modo per accrescere il
proprio prestigio.
Questo sistema di relazioni era dunque molto dinamico, e finiva per
trasformare entrambi i mondi in contatto, ossia il centro e la periferia
dell’universo tardoantico. Alla base di tale sistema vi erano interessi
reciproci alla cooperazione, e la possibilità che fra i capi delle etnie
barbariche e l’Impero avvenissero precisi scambi politici. Nel corso
delle loro conquiste, ad esempio, i Romani tendevano a mantenere
l’equilibrio politico preesistente, preservando il dominio delle élites
barbariche sulle città e sulle comunità sottomesse. Fu in questo modo
che la Gallia divenne parte integrante dell’Impero, attraverso cioè la
cooperazione attiva dei capi delle popolazioni locali. In questo senso,
l’Impero assomigliava più a un’alleanza di migliaia di comunità locali
che a una monarchia assoluta, premesso che non era in discussione né
il pieno controllo militare da parte dell’Impero delle regioni
conquistate né l’inglobamento di queste ultime nel sistema fiscale dello
Stato. Una soluzione di questo tipo era sufficientemente elastica:
inevitabilmente facilitava una concentrazione formidabile di potere e di
ricchezza; ma offriva al contempo ai soggetti più ambiziosi delle élites
regionali significative prospettive di carriera nell’apparato centrale,
specie nell’ambito dell’esercito.
Quando, nel 16 d.C., l’imperatore Tiberio interruppe le offensive
militari al di là del Reno, fino a quel momento incessanti, la diplomazia
romana costruì una rete di rapporti privilegiati con molti capi di popoli
e tribù germanici. A questo fine esistevano strumenti molto efficaci: a
parte la stipulazione di alleanze formali, veniva praticata l’offerta di
doni ai capi con i quali l’Impero desiderava avviare relazioni; e talora si
provava a scegliere, fra gli ostaggi o i profughi barbari che vivevano in
Italia, qualcuno da elevare alle condizioni regia (?) con il sostegno
imperiale e da rispedire in questa veste al suo popolo. Le buone
relazioni con i barbari servivano all’Impero soprattutto per soddisfare
la continua necessità di armati da inserire nelle proprie unità militari,
tanto nelle vere e proprie legioni dell’esercito quanto nelle formazioni
ausiliarie che partecipavano solo ad alcune bataaglie. Questa richiesta
costante di guerrieri barbari s’intensificava a seguito delle numerose
guerre, interne ed esterne, che furono combattute negli ultimi secoli
dell’Impero, a partire dal III d.C. Dal punto di vista dei barbari,
l’ingresso nelle potenti armate romane rappresentava un motivo di
prestigio e di potere che non aveva eguali. Molti, dopo una carriera
nell’esercito imperiale, tornavano a casa, nelle foreste della Germania,
portando con sé armi e altre insegne che rappresentavano le prove
visibili di un successo a cui coloro che erano rimasti a casa non
avrebbero potuto potuto ambire. Reperti militari di provenienza
romana si trovano ancora, per esempio, nelle ricche tombe del iii e iv
secolo nell’ambito del cosiddetto «gruppo Hassleben-Leuna» della
Germania centrale.
Da questi fenomeni di assimilazione, l’Impero romano sicuramente
trasse grandi vantaggi: per molte generazioni, infatti, migliaia di barbari
diedero la vita nelle guerre romane. Ma a lungo termine, quegli stessi
fenomeni stimolarono una dinamica ben diversa. Fin dall’inizio, gruppi
di barbari avevano tentato di conquistare con la forza ciò che le
autorità romane non sempre erano pronte o disponibili a offrire loro.
E questa pressione aumentò gradualmente nella misura in cui pezzi di
società barbariche entravano a far parte del sistema imperiale.
Ma determinavano le relazioni di tipo militare fra romani e barbari ben
più profonde conseguenza nelle società di questi ultimi. Le opportunità
di promozione offerte dal mondo romano mettevano in moto al loro
interno processi che incrementavano infatti le diseguaglianze sociali.
Abbandonare le occupazioni e i lavori tradizionali e seguire il modello
prestigioso del guerriero specializzato diventava una prospettiva
sempre più attraente. Le società barbariche militarizzate che
affrontarono l’Impero nei secoli tra il IV e il VI erano dunque in larga
misura realtà diverse da quelle dei secoli precedenti, frutto in parte di
esigenze espresse dall’Impero. Nel mondo barbarico, amici e avversari
dei romani appartenevano tutti agli stessi gruppi di guerrieri, sempre
alla ricerca di opportunità per inserirsi nel sistema militare e
istituzionale romano, in cui circolavano onori e ricchezze che nessuna
delle società barbariche poteva offrire. Il contatto prolungato con il
mondo romano aveva profondamente mutato le realtà barbariche e il
processo di trasformazione del primo aveva determinato anche una
trasformazione parallela nelle seconde.
Per una revisione dei concetti di etnicità
Chi erano questi barbari? A questa domanda tanto la storiografia antica
quanto quella moderna hanno risposto fornendo, innanzitutto,
definizioni di carattere etnico. Secondo questa logica, i barbari erano
celti o germani, goti o franchi, avari o slavi. Fino a non molti anni fa,
nessuno dubitava che queste classificazioni etniche riflettessero un
ordine quasi naturale di tribù e di popoli. Nelle ideologie
nazionalistiche dell’Ottocento e del primo Novecento, le radici
nazionali nelle etnie del primo millennio venivano gelosamente difese.
I tedeschi vantavano così la propria origine germanica, gli ungheresi
erano fieri di richiamarsi al re unno Attila come loro progenitore, croati
e serbi tentavano (e tentano ancora) di collocare l’inizio della propria
storia in un periodo ancora più remoto. Oggi un modello di questi
tipo, che assicuri l’esistenza di identità etniche coerenti e omogenee, è
al centro di accesi dibattiti. Vediamo alcuni dei problemi principali che
questa discussione solleva.
Innanzitutto si pone una questione metodologica. Nei primi decenni
del Novecento sembrava chiaro (e veniva esplicitamente sottolineato
dalla scuola di Gustav Kossinna) che le tracce nelle fonti scritte,
nell’analisi filologica e nelle scoperte archeologiche dovessero essere
espressione della stessa realtà etnica: un popolo cioè doveva per forza
parlare la stessa lingua, avere la stessa cultura, e vivere in un’unica, ben
determinata comunità politica; situazioni diverse rappresentavano
anomalie, giudicate spesso transitorie e di cui era necessario rintracciare
il superamento; veniva applicata in tal modo una logica non dissimile
da quella adoperata per la descrizione delle nazioni moderne. Oggi,
invece, è diventato chiaro che un caso di questo tipo – un popolo
come unità linguistica, culturale e politica chiaramente delineata – non
rappresenta la norma ma piuttosto l’eccezione. L’archeologia
altomedievale ci dice che ben difficilmente a un’area insediativa
circoscrivibile corrispondeva un’unità etnica definita. E le fonti scritte
di regola non consentono di delimitare una regione abitata dalle etnie
delle quali parlano. Ambedue le discipline insomma, l’archeologia e la
filologia, non possono attribuire i propri materiali a raggruppamenti
umani «naturali», a comunità preesistenti.
La distribuzione geografica di gran parte dei reperti archeologici non
corrisponde alla geografia delle supposte etnie. Spesso, le attribuzioni
etniche che ancora oggi molti studiosi propongono si riferiscono a
pochi tipi di oggetti, a certe forme di fibbie o di ceramica. Ma anche
queste interpretazioni poggiano su idee preesistenti, spesso avanzate
non da archeologi ma da studiosi, storici o filologi, che utilizzano fonti
letterarie tradizionali. Simili interpretazioni, che danno l’illusione di una
ricognizione interdisciplinaria di un problema complesso, lasciano
sempre aperta la possibilità di letture alternative. Questo non vuol dire
che sia impossibile l’attribuzione etnica di reperti archeologici. Qualche
volta, come nel caso degli avari, il profilo culturale di una comunità
etno-politica è abbastanza riconoscibile. In altri casi (come quello degli
unni) gli oggetti trovati nelle tombe testimoniano non l’esistenza di una
cultura etnica, ma di una civiltà internazionale, diffusa dal Mar Nero
alla Gallia. Paradossalmente, se la tomba del re franco Childerico
(morto nel 482) a Tournai, nell’odierno Belgio, fosse stata scoperta in
Ucraina, avrebbe potuto tranquillamente essere scambiata per il
corredo di un re unno. La definizione etnica può dunque essere, a
volte, il risultato di studi molto dettagliati, ma non può costituire il
presupposto «normale» delle indagini sulla realtà barbarica.
Passiamo al secondo problema. È difficile individuare in cosa consista
l’etnicità altomedievale, il carattere etnico di una comunità. Che cos’è
un popolo? Dall’etnografia antica fino alla sociologia moderna sono
stati offerti nutriti elenchi di tratti distintivi dell’etnia come la lingua, il
costume, i modi di vestire e di combattere. Ma tutti questi criteri
oggettivi sono validi solo in qualche caso, e non validi in altri; non
sono veramente applicabili neppure alle nazioni moderne, anche dopo
lunghi processi di unificazione politica e istituzionale. Negli studi
altomedievali, è stato Reinhard Wenskus negli anni sessanta a
rinunciare per primo all’impiego di questi cataloghi oggettivi, fondando
l’identità etnica esclusivamente su fattori soggettivi: qualcuno
appartiene a un’etnia se sente di farne parte. Questa appartenenza
può esprimersi attraverso segni esteriori, che tuttavia non sono sempre
della stessa natura. Dal punto di vista semiotico possiamo dire che il
segno «etnico» può solo essere interpretato come parte di un discorso
etnico, un sistema culturale complesso e variabile, che non sempre è
facile ricostruire.
Terzo problema. Non possiamo assumere automaticamente l’identità
etnica come un dato culturale condiviso da un’intera popolazione. In
larga misura infatti i barbari si distribuivano in gruppi molto localizzati
e molto ristretti, simili a quelli che gli antropologi chiamano faceto-face-groups, all’interno dei quali, secondo modalità specifiche, gli
condividevano un’identità culturale e sentivano di appartenere a una
comunità unitaria. Sembra che nel mondo barbarico del tardoantico e
dell’alto medioevo solo nuclei socialmente ristretti di capi e di guerrieri,
e forse di sacerdoti o di sapienti, si muovessero all’interno di ambiti più
ampi. I franchi, ancora nel secolo VIII, non erano, nel senso stretto
della parola, tutta la popolazione riconducibile a questa sigla, ma solo i
potenti che s’incontravano ogni anno per decidere le guerre e le
vicende politiche del Regno: era questo un esempio di face-to-face-
group, come fuoco di un’identità etnico-politica più ampia ed
eterogenea. Reinhard Wenskus ha chiamato questi gruppi «nuclei di
tradizione», dai quali dipendeva la coesione di «popoli» come i goti o i
franchi.
Etnie, dunque, come realtà soggettive. Ma si pone un quarto problema.
Le testimonianze di cui disponiamo non offrono, di solito,
autodefinizioni, ma percezioni esterne. È lecito ritenere, come si faceva
una volta, che queste percezioni romane o greche (o, più tardi, franche)
descrivessero fedelmente le realtà barbariche? In realtà sembra
piuttosto che quelle letture contenessero lo sforzo di inquadrare una
situazione confusa e dinamica all’interno di schemi riconoscibili e
ordinati. Per questo dobbiamo essere prudenti a proposito delle
specifiche denominazioni con le quali la politica romana individuava i
gruppi concreti con i quali aveva contatti: possiamo fidarci fino d un
certo punto della terminologia latina. Erano due, principalmente, le
strategie cognitive di cui disponevano gli scrittori latini per mettere
ordine nella confusa percezione della complessa realtà barbarica. La
prima era fondata sull’idea, che in varie forme sopravvive quasi fino ad
oggi, sicuramente fino al primo Novecento, secondo cui i popoli in
fondo non cambiavano, ma cambiavano solo i nomi (al fine di
ingannare i romani). Dunque era lecito recuperare denominazioni in
uso centinaia di anni prima. Per questo gli unni furono chiamati sciti
(come il popolo delle steppe di un millennio fa), poi gli avari, gli unni, e
ancora più tardi gli ungheresi furono tutti assimilati all’interno della
stessa tradizione etnica, posta di volta in volta sotto le denominazioni
tradizionali: sciti, unni e avari. In modo analogo, i franchi furono
chiamati anche sugambri (un popolo disperso dalle guerre di Augusto),
e i goti geti (un popolo di nome simile, che viveva vicino ai Carpazi
orientali intorno agli inizi della nostra era). La seconda strategia
consisteva nell’adoperare denominazioni generali che designassero la
popolazione di un territorio ampio, con forme di vita più o meno
simili. Questi erano nomi generici, che però venivano usati come nomi
etnici, perché individuavano un popolo concreto. È il caso,
soprattutto, dei germani. Qui siamo di fronte a un fenomeno
sconcertante. La storiografia moderna ha letto i testi antichi come
prove che si riferissero a di popoli concreti. Ma gli autori antichi, come
Tacito o Strabone, sapevano che il nome dei germani era stato dato
dagli stessi romani per designare una realtà di cui poco si sapeva e si
comprendeva, fatta di popoli e tribù insediati in un certo territorio.
Il caso ‘particolare’ dei Germani
Un popolo che si chiamava «germani» forse non c’è mai stato. In ogni
caso, se c’era, non corrispondeva a quello che gli studiosi moderni
chiamano così. L’origine dei germani è ancora poco nota, e rimane al
centro di dibattiti accesi. Due cose invece sono chiare. L’antico termine
«germani», come designazione della popolazione insediata nell’ampio
territorio che si estendeva al di là del Reno, termine usato nell’antichità
e nell’alto medioevo, fu introdotto da Giulio Cesare. Prima di lui, dal
punto di vista romano c’erano solo due grandi complessi di popoli
barbarici: i celti (o galli a Ovest, galati a Est), che abitavano nelle
foreste della Gallia, della Britannia e dell’Europa centrale; e gli sciti,
acclimatati nelle steppe dell’Europa orientale. I romani, fino al i secolo
a.C., non avevano rapporti con i celti, che dominavano tutte le regioni
a nord dell’Italia, da quelle dell’area danubiana fino a quelle
prospicienti l’Oceano Atlantico. Anche nell’invasione tremenda dei
cimbri e teutoni, alla fine del secondo secolo a.C., era percepita, dai
contemporanei, una matrice gallica. Solo quando conquistò la Gallia
Giulio Cesare si accorse del fatto che proprio dal punto di vista dei
celti gallici c’erano dei popoli al di là del Reno che erano diversi, più
primitivi. Corrispondeva ai disegni politici di Cesare accentuare questa
diversità, così da giustificare da una parte la necessità di sottomettere la
Gallia (per proteggerla dagli attacchi dei germani), e dall’altra
l’opportunità di non sottoporre a inutili rischi gli eserciti romani
avanzando oltre il Reno, dove abitava una popolazione più barbarica
dei già barbari galli. Cesare introdusse dunque una netta distinzione fra
Gallia e la Germania: nacque allora la Germania come spazio
geografico delimitato a ovest dal Reno, a sud dal Danubio, a est dalla
Vistola, e a nord dal Mar Baltico. La definizione non era priva di
contraddizioni, perché c’erano germani anche a ovest del basso Reno:
questa presenza derivava probabilmente dal fatto che nuclei germanici
avevano in precedenza attraversato il Reno per cercare in Gallia regioni
più prospere. Può darsi che appunto questi germani collocati fuori del
sistema territoriale immaginato da Cesare fossero i primi a essere
chiamati così: ma non sappiamo se il nome sia di origine gallica o sia
un’autodefinizione.
In ogni caso, attraverso Cesare, l’immagine e il nome dei germani
diventarono corrente nella letteratura antica. Abbiamo però scarse
prove che per i popoli ai quali si riferiva il termine «germani» fosse
un’autodesignazione significativa. A quanto pare esso circolava fra le
fila dell’esercito romano, in particolare fra le unità ausiliarie d’origine
«germanica». Ma nelle popolazioni al di là del Reno e del Danubio
erano adoperati maggiormente altri nomi, riferiti a specifiche realtà
tribali. Nella tarda antichità, con l’apparizione di altri due nomi assai
generici, franchi e alemanni, la designazione «germani» perse significato
anche per i romani. È importante sottolineare un altro fatto poco
considerato: avendo una connotazione
territoriale, il termine
«germani», non includeva i popoli «gotici» che, dal III secolo d.C.,
erano stanziati presso il Mar Nero e il basso Danubio. Gli osservatori
romani assimilavano piuttosto questi ultimi agli sciti, i popoli delle
steppe, oppure li identificavano con i geti.
La seconda definizione dei germani, quella moderna, è fondata
principalmente sulla lingua. Esempio classico è quello relativo alla
Bibbia gotica di Ulfila, dalla cui analisi si può facilmente dedurre che il
gotico era una lingua germanica: dunque i goti erano germani. È questa
modalità di individuazione che ha dominato tutte le ideologie
germanofile dell’Ottocento e del Novecento. Oggi i goti vengono
annoverati nell’ambito dei «germani in Italia», una definizione bene
accetta in ambito scientifico, ma si deve tenere presente che anche
questa è un’astrazione, e non corrisponde affatto all’identità dei popoli
dell’alto medioevo. Non è affatto chiaro infatti se fra tutti coloro che
parlavano una lingua germanica esistesse la consapevolezza di servirsi
di una lingua comune. Isidoro di Siviglia, nel secolo VII, quando
enumera diversi popoli della Germania, nota che hanno costumi e
lingue diverse. Solo nell’epoca dei carolingi (per esempio nell’opera del
longobardo Paolo Diacono), si sviluppa la coscienza che le lingue
germaniche fossero apparentate. Questa lingua vernacolare viene
chiamata teotisca, che significa «popolare»: è la parola dalla quale
deriva il nome «tedesco», e che originariamente designava anche la
lingua longobarda e quella anglosassone. È dunque molto importante
rendersi conto che non c’è uno sviluppo diretto dai germani antichi ai
tedeschi moderni. Le rotture e le contraddizioni nella terminologia
riflettono i movimenti dei popoli e li fluttuazioni della loro identità. Lo
dimostrano anche i diversi nomi adoperati nelle lingue moderne per
individuare i tedeschi. Gli inglesi li chiamano Germans, nonostante
siano essi stessi di prevalente origine germanica; i francesi (e, in modo
simile, gli spagnoli) allemands, termine derivato da uno dei principali
popoli tedeschi, gli alemanni; i popoli slavi adottano nemeci, che certi
filologi spiegano come «i muti», in contrasto con gli slavi stessi, «quelli
chi parlano».
Etnogenesi
Soltanto oggi siamo in grado di capire, almeno fino a un certo punto,
come sono complicati i processi etnici, le «etnogenesi». Gli
scrittori medievali offrivano un modello più semplice:
1. l’albero genealogico. Secondo il modello dell’albero tutti i popoli
avevano un progenitore, da cui spesso derivava anche l’origine del
nome. Lo schema più famoso di diramazione dei popoli da un
unico ceppo è quello contenuto nella Bibbia, uno schema che ebbe,
peraltro, un’influenza straordinaria nel medioevo. Secondo il libro
della Genesi, tutti i popoli del mondo discendevano dai tre figli di
Noè: Sem (da cui provengono i semiti), Cham e Japhet. Isidoro di
Siviglia attualizzò questo modello, inserendovi molti popoli del suo
tempo.
2. Questo modello si alternava, senza contraddizione, con un secondo
tipo di genealogia, di derivazione classica, che seguiva l’esempio
delle leggende sull’origine dei romani. Così, ad esempio, i franchi
credevano che anche i loro progenitori fossero arrivati da Troia,
come Enea.
3. Per noi, comunque, il terzo tipo di genealogie è quello più
interessante. L’esempio più famoso si riferisce ai longobardi: si
tratta del tema dell’origo gentis, l’origine del popolo, elaborato nel
Regno longobardo del secolo VII e sviluppato poi da Paolo
Diacono in quello successivo, ma che forse trae origine da una
tradizione orale più antica. In questo mito d’origine, i longobardi
partono dalla Scandinavia, sotto la guida della saggia Gambara, e il
dio germanico Wodan dà loro il nome. Un’origine chiaramente non
cristiana e non classica, dunque. Una storia simile, anche se più
frammentaria,si ritrova nella storia dei goti di Jordanes (secolo VI), i
quali, secondo questo autore, giungono anch’essi dalla Scandinavia,
a bordo di tre navi. L’immagine delle tre navi ritorna anche nella
storia degli anglosassoni, che attraversarono la Manica sotto la guida
di Hengist e Horsa.
La discussione sull’attendibilità di quei miti non si è ancora conclusa. È
accertato tuttavia che queste leggende non possono essere interpretate
come fonti storiche, come repertori di eventi reali. Esse non possono
provare, per esempio, che longobardi e goti siano veramente venuti
dalla Scandinavia, sei o sette secoli prima che queste informazioni
fossero messe per iscritto. Il dibattito recente si è sviluppato piuttosto
a proposito dell’autenticità o meno delle leggende sulle origini
«germaniche» come miti arcaici. Le opinioni divergono. C’è chi pensa,
come Herwig Wolfram e Stefano Gasparri, che quei racconti
contengano informazioni sulla religione e sulla «cultura tradizionale»,
precristiana, dei popoli di cui raccontano le gesta. All’opposto, il punto
di vista di Walter Goffart è che tali miti esprimano essenzialmente le
idee e le preoccupazioni di coloro che li hanno descritti (Jordanes o
Paolo Diacono) e non riflettano veramente le credenze dei tempi
pagani a cui si riferiscono.
Quest’ultima posizione, fondata spesso su argomentazioni persuasive,
è legata alle idee del cosiddetto linguistic turn (svolta linguistica), un
movimento teorico sviluppatosi nelle scienze sociali innanzitutto in
America durante gli anni ottanta, che tende a giudicare i testi della
storiografia (medievale o moderna) come prodotti letterari più che
come fonti per la storia dei fatti. Quando i ragionamenti ispirati al
linguistic turn si radicalizzano, producono però interpretazioni
discutibili perché tendono a cancellare completamente la dimensione
storica delle scritture, leggendo tutti i testi come espressione del solo
presente, e non del passato. Per il medioevo questa posizione è quanto
meno riduttiva, perché quasi tutti i testi storici riflettono un passato
ricco e complesso. Certo essi vengono riscritti e riconcepiti a ogni
generazione, la loro funzione culturale e politica varia come pure le
«verità» che essi esprimono. Ma, d’altra parte, essi mantengono sempre
una fondamentale dimensione diacronica: si può capire che funzione
assolvono nel presente nel quale si collocano solo decifrando il passato
che riscrivono. Per comprendere queste dinamiche, più utili del
concetto dell’autore-creatore autonomo offerto da Goffart, sono le
idee sulla memoria sociale, ad esempio di Chris Wickham, e quelle sui
meccanismi di memory and oblivion (memoria e oblio) di Patrick
Geary. Queste prospettive consentono non solo di percepire il
continuo variare della memoria che una società ha di se stessa, ma
anche di interpretare queste variazioni come attività culturale, come
produzione del proprio passato e quindi della propria identità.
Possiamo tornare così ai testi frammentari che parlano delle origini di
un popolo, e analizzarne in particolare due aspetti. Il primo si riferisce
alla loro «profondità» cronologica, alla stratificazione di livelli testuali
diversi in essi contenuta e dunque ai diversi caratteri di questi vari
livelli. Tale analisi non ci conduce mai a un testo autentico e puro, ma
aiuta a scoprire delle tracce anteriori o posteriori (anteriori, per
esempio, alla cristianizzazione, o alla monarchia). Il secondo richiama il
contesto «materiale» della forma manoscritta di un testo, più o meno
databile: facendo luce, attraverso le forme della scrittura, non solo sulle
preoccupazioni dell’autore, ma anche sulla funzione politica della
scrittura, sul suo significato per il pubblico e per l’identità di un
gruppo. Ad esempio, quando Paolo Diacono, monaco longobardo di
Montecassino, racconta dell’origine pagana dei longobardi, egli osserva
che si tratta di una «ridicola favola». Una simile espressione lascia
trasparire l’esistenza di un problema affrontato dall’autore: che ci fosse
cioè un pubblico che forse già conosceva queste favole, e che si
aspettava probabilmente di ritrovarle nella storia scritta, e che dunque
anche il pio monaco si sentisse obbligato a dare notizia di miti pagani
che altrimenti difficilmente avrebbe avuto ragione di riportare o di
inventare. È possibile dunque leggere questi testi antichi come testi
storici, e non solo come letteratura. Tuttavia, l’accesso al passato
barbarico che descrivono è comunque molto indiretto, sempre
ipotetico. Siamo lontani della disinvoltura con cui gli studiosi
dell’Ottocento guardavano a testi di questo tipo come all’espressione
diretta di un’autentica cultura «germanica».
Potere e regalità nella società germanica altomedievale
Mettiamo a confronto, per un attimo, i miti d’origine di popoli
barbarici, nella forma in cui sono stati tramandati dagli scrittori latini
dei secoli VI-VIII, e la storiografia moderna su questi popoli,
soprattutto quella dell’Ottocento e del primo Novecento. Anche
quest’ultima ha la sua profondità diacronica: parla infatti di un passato
di millecinquecento anni attraverso la riflessione su una serie di testi
intermedi. Ed è legata, in modo forse difficilmente percepibile ma
spesso verificabile, al proprio contesto, vale a dire alle esigenze del
presente (ottocentesco e primo novecento), al quale essa vuole fornire
le proprie verità. C’è però una fondamentale differenza metodologica:
nella loro opera gli studiosi moderni indicano, almeno fino a un certo
grado, le fonti adoperate e il metodo prescelto, e ciò consente di
controllare le loro strategie cognitive.
Per quanto riguarda le realtà barbariche altomedievali, disponiamo tutti
delle stesse fonti scritte. Dal primo Ottocento a oggi sono state infatti
rarissime le scoperte di nuovi testi. E tutte queste fonti parlano poco
della società e della vita dei barbari. Da ciò deriva che la possibilità di
dire qualcosa di nuovo e di approfondire la conoscenza di quel passato
(indipendentemente dal contributo delle fonti non scritte, come quelle
archeologiche) dipende in larga misura dalle interpretazioni, e dal
modello generale in cui esse si collocano. Occorre esserne consapevoli
quando incontriamo, nella storiografia ottocentesca ma talvolta ancora
in quella dei decenni scorsi, ricostruzioni dettagliate delle società
germaniche, o barbariche. I modelli di riferimento cui si ispirano
queste ricostruzioni hanno infatti un’origine, un proprio contesto
storico e culturale, una funzione, spesso ideologica. Non c’è da
meravigliarsi, ad esempio, che fossero soprattutto gli studiosi tedeschi
a esplorare in profondità il sistema giuridico e istituzionale dei germani
(che, in tedesco, rientra nella categoria di Verfassung, ossia
costituzione). Anche in questo campo, dunque, s’incrociano la storia
dell’alto medioevo e quella dei nostri tempi. Vediamo alcuni esempi.
L’istituzione più tipica degli stati barbarici era il regno. I re dei goti,
come Alarico o Teoderico, dei franchi come Clodoveo, degli unni
come Attila sono personaggi ben noti, anche fuori dalla cultura
specializzata degli storici. In passato c’erano opinioni differenti
riguardo alle origini dei regni, di quei regni barbarici che caratterizzano
il tempo delle invasioni, se fossero cioè istituzioni arcaiche oppure
relativamente recenti. Ora, tanto nel pensiero degli illuministi del
Settecento quanto nella storiografia romantica del primo Ottocento
era consueto vedere quella germanica come una società
democratica: un punto di vista che venne poi fatto proprio, per il
tramite di Friedrich Engels, dal pensiero marxista. Secondo le teorie
del materialismo storico, la società germanica conobbe il passaggio
dall’epoca dell’Urkommunismus (comunismo primitivo) a quella
della «democrazia militare», rimanendo caratterizzata da forme
associative di tipo comunitario: il possesso comune della terra, una
società in larga misura egualitaria, assemblee popolari e decisioni
collettive. Così i germani potevano costituire un fattore progressivo, di
spinta alla rivoluzione antischiavistica e di accelerazione del processo
che diede origine al feudalesimo. Anche gran parte degli studiosi non
marxisti dell’Ottocento contrapponeva la «libertà germanica» alla
schiavitù romana. Una parola chiave per la descrizione di queste forme
comunitarie e collettive era Genossenschaft, con cui si intendeva
un’istituzione sociale collettiva chiaramente individuata e la cui
coesione risultava assicurata da una forte solidarietà interna: una
solidarietà tanto intensa da assumere una matrice di sacralità e da
presuppone la natura delittuosa di ogni sua lesione.
Nella storiografia tedesca del primo Novecento questo paradigma
assunse caratteri nuovi, nel contesto della diffusione di ideologie
autoritarie. Importante, a questo proposito, è il pensiero di Otto
Höfler, che esercitò una notevole influenza fino al secondo
dopoguerra. Secondo Höfler le società barbariche conoscevano due
tipi di re: uno, arcaico, era il re sacrale (Sakralkönig), che era allo
stesso tempo la massima autorità politica e il sacerdote supremo.
L’altro tipo era quello del re militare, il potere del quale era fondato
sulla capacità di guidare al successo in guerra: era quest’ultimo già il
caso di Ariovisto, nemico di Giulio Cesare, o di Arminio, colui che nel
9 d.C. nella foresta di Teutoburgo sconfisse l’esercito imperiale, ma
soprattutto di Teoderico o Clodoveo. Attraverso la conversione al
cristianesimo questi re militari avrebbero poi assunto una nuova
legittimazione sacrale. Questa tipologia corrispondeva al modello
elaborato dallo storico delle religioni francese Georges Dumézil:
secondo tale modello tutte le società indoeuropee erano organizzate
attorno a tre elementari funzioni sociali: quella sacrale-religiosa
rappresentata dai sacerdoti, quella politico-militare rappresentata dai
guerrieri, quella economico-produttiva rappresentata dai contadini. Che
appartenessero al tipo del guerriero o del sacerdote, i re posti a capo
dei regni dei goti o dei franchi si caratterizzano, all’interno di queste
ricostruzioni, come figure che fanno pienamente parte della tradizione
germanica.
Ed è questo uno degli elementi di giudizio in seguito più
frequentemente contestati. Oggi infatti i fattori di origine romana
nella costituzione dei regni romano-barbarici sono considerati
molto più significativi. Le influenze romane sulla struttura politica
delle società barbariche sono visibili, in realtà, molto prima
dell’insediamento di questi popoli nelle province dell’Impero. Ariovisto
era stato riconosciuto come re dal Senato romano, mentre Arminio e
quasi tutti i re del tempo delle invasioni erano alti ufficiali
dell’esercito romano o godevano di altre posizioni d’onore. Ulteriore
elemento di debolezza del modello di Höfler è costituito dal fatto che
le prove dell’esistenza di responsabilità religioso-sacrali dei re arcaici
sono molto scarse.
Questioni simili, anche se più complicate, dominavano la discussione
sulle strutture della società barbarica nel suo complesso. Le ideologie
autoritarie sottolineavano in particolare il ruolo delle clientele,
specie nel campo militare. L’ipotesi tradizionale era fondata sulla
Germania di Tacito che contiene una descrizione abbastanza chiara
della clientela, un legame personale attraverso cui i giovani guerrieri
sceglievano un signore, che dava loro protezione, i mezzi per vivere,
spesso le armi, e parte del bottino, e che essi dovevano seguire in
guerra, fino a sacrificare la propria vita; secondo Tacito, sopravvivere
al signore caduto in battaglia era considerato un disonore per i membri
del suo seguito. Sono appunto questi alcuni degli elementi peculiari
dell’immagine degli antichi germani privilegiata dall’ideologia nazista e
usati dalla propaganda di regime con effetti disastrosi.
Oggi sappiamo di più sul clima culturale in cui si inseriva il discorso di
Tacito. E vediamo più chiaramente quanti elementi dell’organizzazione
della clientela germanica in effetti non trovi
no riscontro nel testo di Tacito: per quanto riguarda ad esempio il tema
della fedeltà, è facilmente dimostrabile che, contrariamente all’idea
secondo cui chi giurava fedeltà a un capo poi doveva seguirlo per tutta
la vita, i guerrieri spesso cambiavano signore, secondo le opportunità
che venivano loro offerte e le prospettive di successo.
In realtà appare chiaro oggi che il carattere istituzionale delle
strutture sociali è stato sopravvalutato da generazioni di studiosi.
La dignità che le nostre fonti denominano «re» (rex) non è infatti
un’istituzione fissa, che ricorre secondo alcune tipologie regolari, ma la
designazione comune data dai romani a vari fenomeni: capi di gruppi
locali o di piccole tribù, comandanti di eserciti piccoli o grandi, sovrani
di grandi imperi di steppa come Attila, o reggenti di regni potenti sul
suolo romano come Teoderico o Clodoveo. La situazione è simile con
le clientele, che potevano essere di carattere esclusivamente militare o
anche civile, di breve o lunga durata; potevano essere dominate da una
gerarchia forte o essere il risultato di una libera associazione; potevano
apparire strutturate e resistenti oppure agglomerati temporanei di
guerrieri.
Una conclusione analoga si può trarre per quanto riguarda le strutture
di parentela, le famiglie e i clan. Anche qui l’interpretazione dipende
molto da una questione metodologica ancora irrisolta, relativa al
carattere più o meno arcaico di queste strutture. Le leggi altomedievali,
quelle dei goti, franchi, longobardi, alemanni o bavaresi, contengono
molte clausole relative a questioni legate alla parentela, e soprattutto ai
diritti di successione. È ovvio che per molti aspetti si tratta di regole
divergenti dal diritto romano, ed è dunque plausibile che riflettano le
consuetudini più arcaiche delle società barbariche. Le leggi
altomedievali concordano inoltre nell’evocare la centralità della
solidarietà familiare quando consentono il giuramento di un certo
numero di parenti per difendere l’innocenza di un consanguineo
accusato di un crimine. Nonostante tutto questo, per un verso rimane
largamente ipotetico il carattere arcaico di una legge scritta in latino e
probabilmente influenzata, in più punti, da modelli giuridici romani;
per un altro, scorrendo i casi previsti dalle leggi non emerge un chiaro
modello delle strutture di parentela. Erano agnatizi o cognatizi i clan?
Le relazioni agnatizie caratterizzano le strutture di parentela definite
dalla prevalenza della successione maschile, mentre il termine
«cognatizio» (o bilaterale) implica una dimensione della parentela che
include le linee femminili. La supposizione tradizionale era che i clan
dei germani fossero agnatizi, e dunque che le genealogie fossero
chiaramente definite su questa base. Alexander Murray ha sviluppato di
recente, fondandosi su un riesame complessivo delle leggi barbariche,
una posizione contraria: la struttura della parentela non escluderebbe la
cognazione, e il clan non sarebbe un organismo omogeneo, ma
piuttosto una struttura fluida. L’articolazione concreta della parentela e
l’intensità del sentimento di solidarietà sarebbe dipesa dalla percezione
di individui e di gruppi, che era variabile e che lasciava trasparire
l’esistenza di spazi di parentela più stretti o più ampi. Osservazioni
ulteriori derivano dall’analisi non solo delle fonti narrative, ma anche
delle carte giuridiche private: le quali rivelano che le famiglie e i clan
non erano, come pretendevano gli studiosi dell’Ottocento, un rifugio
di pace e di mutua solidarietà. Erano invece frequenti i conflitti
all’interno degli ambiti parentali, basti pensare ai molti membri della
dinastia franca dei merovingi ammazzati da fratelli, figli o mogli.
Un’occasione in cui la parentela giocava un ruolo decisivo era
comunque rappresentata dalla faida: nel caso di crimini di sangue, ma
anche di altri tipi di offesa, la vendetta toccava infatti alla famiglia della
vittima. In alcuni casi queste vendette potevano protrarsi per anni, con
un numero considerevole di vittime da ambedue le parti. Lo
storiografo e vescovo Gregorio di Tours racconta esempi clamorosi;
ma i materiali più ricchi per studiare questo fenomeno si trovano nelle
saghe dell’Islanda. Eppure le faide, con le loro lunghe code sanguinose,
non sono affatto un monopolio delle società barbariche o arcaiche, ma
ricorrono in tutte le società – anche moderne e contemporanee – in cui
lo stato non è in grado d’imporre la propria autorità (di assumere il
monopolio della violenza, come disse Max Weber). La faida è
dunque diffusa, come ha mostrato Otto Brunner, durante tutto il
medioevo.
In ogni caso già i regni romano-barbarici tentarono di stabilire
un’alternativa giuridica alla faida, attraverso il pagamento di
compensazioni, il cosiddetto wergeld (guidrigildo). Il wergeld era una
somma di denaro che stabiliva il valore teorico di un uomo o di una
donna, all’interno di un sistema assai elaborato che fissava le differenze
fra diverse categorie di soggetti: un uomo libero valeva più di uno
schiavo, una donna più di un uomo, chi era al servizio del re più di un
uomo normale, e così via. Nella legge longobarda venne persino
stabilito che il porcarius, lo schiavo che si occupava dei porci (li doveva
cioè condurre nei boschi, e aveva per questo una maggiore
responsabilità), valesse più di schiavi normali. Chiunque uccideva
doveva pagare il prezzo intero dell’ucciso; le lesioni o le offese erano
definite in frazioni del wergeld, descritte spesso in elenchi molto
dettagliati, che arrivano ad enumerare, in alcuni testi, il prezzo delle
singole dita. Non sappiamo però se questa ricca casistica avesse di
precedenti nelle consuetudini più arcaiche.
Se la famiglia offesa accettava il prezzo, rinunciava alla faida, altrimenti
doveva vendicarsi. Alla base della faida era la nozione di onore, da
ripristinare dopo un’offesa che metteva a repentaglio il prestigio d’una
famiglia. Altra domanda fondamentale è quella relativa a chi, in
concreto, toccasse la vendetta, quali fossero cioè i confini del gruppo
familiare responsabile della faida. Come al solito, il conflitto metteva
alla prova le strutture e le relazioni sociali. Dalle nostre fonti narrative
sembra che l’impatto della faida dipendesse molto più dai rapporti
concreti che non dalla applicazione di regole rigide e predefinite.
Dalle etnie ai regni
Regni romano – barbarici
Ostrogoti in Italia 489-559
Visigoti in Spagna
Siagrio, poi Franchi nella Gallia
Burgundi
Longobardi 569-774
Vandali