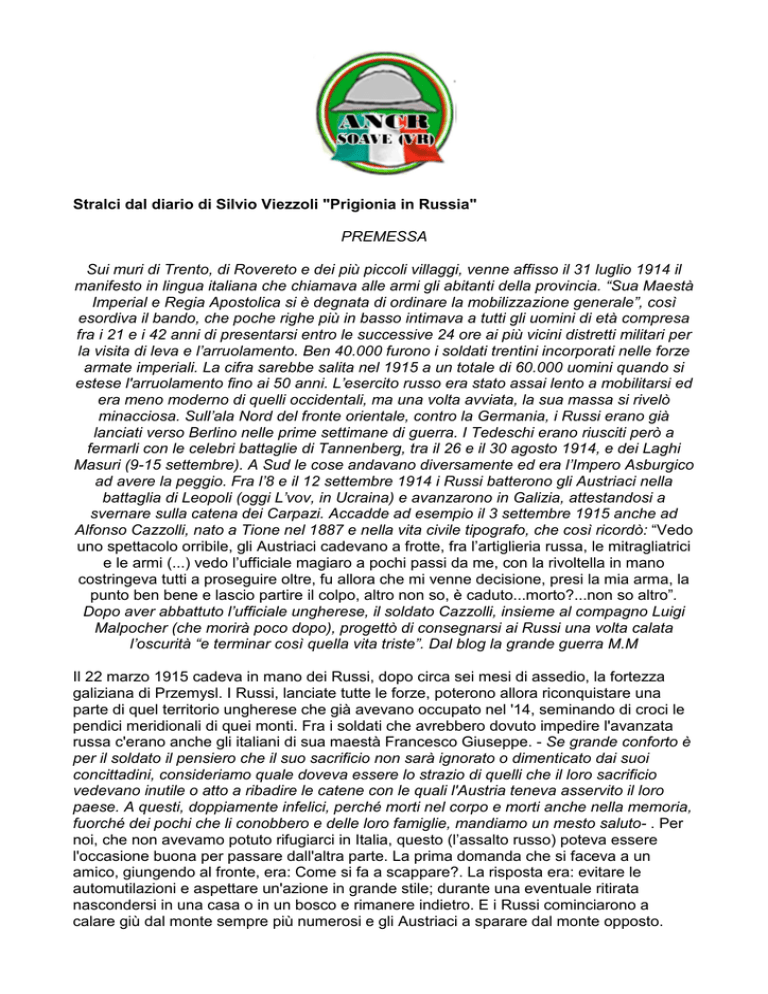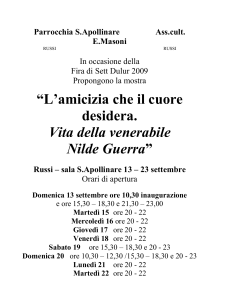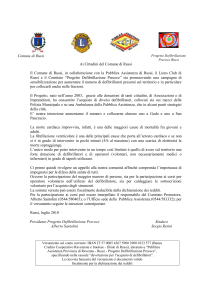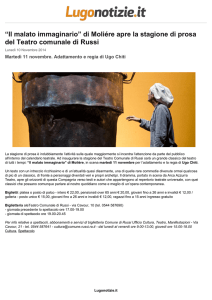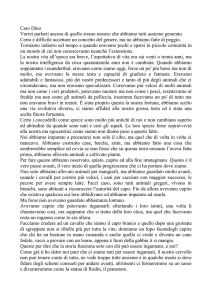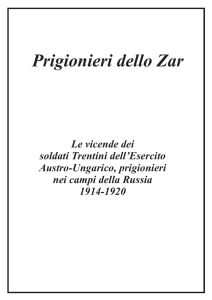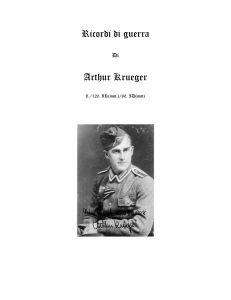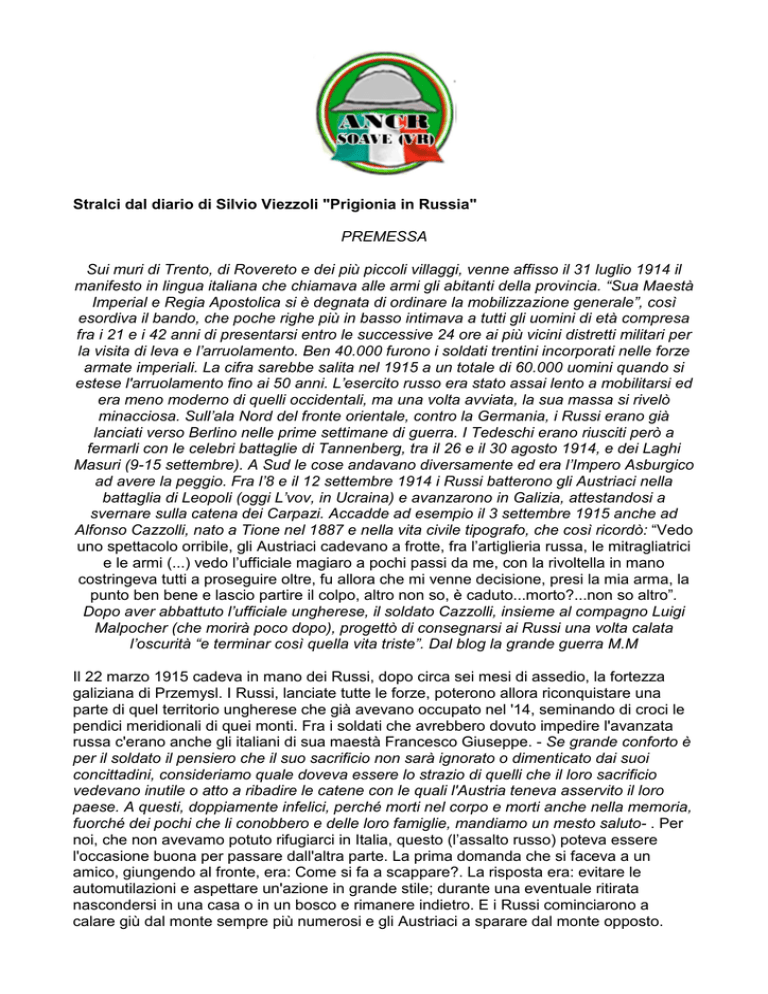
Stralci dal diario di Silvio Viezzoli "Prigionia in Russia"
PREMESSA
Sui muri di Trento, di Rovereto e dei più piccoli villaggi, venne affisso il 31 luglio 1914 il
manifesto in lingua italiana che chiamava alle armi gli abitanti della provincia. “Sua Maestà
Imperial e Regia Apostolica si è degnata di ordinare la mobilizzazione generale”, così
esordiva il bando, che poche righe più in basso intimava a tutti gli uomini di età compresa
fra i 21 e i 42 anni di presentarsi entro le successive 24 ore ai più vicini distretti militari per
la visita di leva e l’arruolamento. Ben 40.000 furono i soldati trentini incorporati nelle forze
armate imperiali. La cifra sarebbe salita nel 1915 a un totale di 60.000 uomini quando si
estese l'arruolamento fino ai 50 anni. L’esercito russo era stato assai lento a mobilitarsi ed
era meno moderno di quelli occidentali, ma una volta avviata, la sua massa si rivelò
minacciosa. Sull’ala Nord del fronte orientale, contro la Germania, i Russi erano già
lanciati verso Berlino nelle prime settimane di guerra. I Tedeschi erano riusciti però a
fermarli con le celebri battaglie di Tannenberg, tra il 26 e il 30 agosto 1914, e dei Laghi
Masuri (9-15 settembre). A Sud le cose andavano diversamente ed era l’Impero Asburgico
ad avere la peggio. Fra l’8 e il 12 settembre 1914 i Russi batterono gli Austriaci nella
battaglia di Leopoli (oggi L’vov, in Ucraina) e avanzarono in Galizia, attestandosi a
svernare sulla catena dei Carpazi. Accadde ad esempio il 3 settembre 1915 anche ad
Alfonso Cazzolli, nato a Tione nel 1887 e nella vita civile tipografo, che così ricordò: “Vedo
uno spettacolo orribile, gli Austriaci cadevano a frotte, fra l’artiglieria russa, le mitragliatrici
e le armi (...) vedo l’ufficiale magiaro a pochi passi da me, con la rivoltella in mano
costringeva tutti a proseguire oltre, fu allora che mi venne decisione, presi la mia arma, la
punto ben bene e lascio partire il colpo, altro non so, è caduto...morto?...non so altro”.
Dopo aver abbattuto l’ufficiale ungherese, il soldato Cazzolli, insieme al compagno Luigi
Malpocher (che morirà poco dopo), progettò di consegnarsi ai Russi una volta calata
l’oscurità “e terminar così quella vita triste”. Dal blog la grande guerra M.M
Il 22 marzo 1915 cadeva in mano dei Russi, dopo circa sei mesi di assedio, la fortezza
galiziana di Przemysl. I Russi, lanciate tutte le forze, poterono allora riconquistare una
parte di quel territorio ungherese che già avevano occupato nel '14, seminando di croci le
pendici meridionali di quei monti. Fra i soldati che avrebbero dovuto impedire l'avanzata
russa c'erano anche gli italiani di sua maestà Francesco Giuseppe. - Se grande conforto è
per il soldato il pensiero che il suo sacrificio non sarà ignorato o dimenticato dai suoi
concittadini, consideriamo quale doveva essere lo strazio di quelli che il loro sacrificio
vedevano inutile o atto a ribadire le catene con le quali l'Austria teneva asservito il loro
paese. A questi, doppiamente infelici, perché morti nel corpo e morti anche nella memoria,
fuorché dei pochi che li conobbero e delle loro famiglie, mandiamo un mesto saluto- . Per
noi, che non avevamo potuto rifugiarci in Italia, questo (l’assalto russo) poteva essere
l'occasione buona per passare dall'altra parte. La prima domanda che si faceva a un
amico, giungendo al fronte, era: Come si fa a scappare?. La risposta era: evitare le
automutilazioni e aspettare un'azione in grande stile; durante una eventuale ritirata
nascondersi in una casa o in un bosco e rimanere indietro. E i Russi cominciarono a
calare giù dal monte sempre più numerosi e gli Austriaci a sparare dal monte opposto.
Durante la notte i Russi occuparono due villaggi nella valle sotto di noi (eravamo sui
Carpazi Beschidi a sinistra del Dukla). Nell'oscurità delle notti precedenti avevamo sentito i
pianti e i lamenti dei poveri contadini evacuati. Questi villaggi diventarono allora il
bersaglio delle artiglierie austriache, e tutte le case furono in poco tempo completamente
incendiate, (tanto) che vi si potevano contare le travi. La mattina del 25 marzo, prima del
levar del sole, quando meno ce l'aspettavamo, ecco che i Russi hanno passato i reticolati
a sinistra delle nostre posizioni, hanno rotto la linea e conquistato le trincee. Allora
avvenne una fuga generale. Tutti saltarono fuori dalle trincee gettando via il sacco,
qualcuno anche il fucile, tutto quello che avevano per essere più leggeri. In quella
confusione mi misi a correre anch'io assieme agli altri. Mentre correvo, pur con la paura in
corpo delle pallottole che ci fischiavano intorno, pensai che avrei potuto dire di aver visto "i
Tedeschi a fuggir".
Poi mi accorsi di essere rimasto indietro e di essere solo, e allora pensai che quello era il
momento buono per arrischiare di fermarmi, perché altrimenti chissà quando se ne
sarebbe presentata un'altra occasione. Mi buttai a terra perché ero stanco non soltanto
per la corsa ma anche perché non avevo dormito tutta la notte; e poi potevano
sopraggiungere altri austriaci; nel qual caso avrei dovuto fare di necessità virtù e
continuare la fuga. Mi passarono invece a poca distanza alcuni soldati russi, che non mi
guardarono nemmeno; inseguivano i fuggenti col fucile spianato e gridavano «alt». Poi da
un anfratto del terreno ne sbucarono altri due, e a questi feci subito manifesti segni di
resa; si teneva sempre pronta una pezzuola bianca. Così ebbero inizio le mie prigioni. Ho
detto «così», ma non ho detto come; il principio fu alquanto drammatico, poiché uno dei
due soldati non voleva saperne di resa e mi venne sopra per infilzarmi con la sua
baionetta. Mi vidi a un palmo dal petto una di quelle baionette russe lunghe lunghe e nere
della forma di quelle dei nostri carabinieri, ed era anche sporca di fango. In quel terribile
istante lo pregai di essere buono, ricorrendo alle mie poche cognizioni di lingua slava.
Allora l'altro, che doveva essere suo superiore, caporale o sergente, lo trattenne con un
gesto del braccio dicendogli: «stoj». I due, dopo aver gettato lontano il mio fucile, mi
lasciarono per inseguire i nemici. Io mi alzai da terra e andai incontro a un altro soldato
che era sopraggiunto; ci stringemmo cavallerescamente la mano e diventammo subito
amici. Il soldato russo si fermava spesso ad aprire i sacchi per portar via specialmente
roba da mangiare, scatole di carne in conserva, caffé, biscotto; io invece avevo una gran
voglia di allontanarmi di là più che fosse possibile. Appena dietro le linee ci avrebbero
messo in un bel vagone, se non proprio di prima classe almeno di terza, e spedito in
qualche bella città, forse a Mosca! Ma le cose non stavano proprio in questi termini. Prima
che arrivassimo alle abbandonate trincee austriache, ecco arrivare gruppi di prigionieri,
venti di qua, cinquanta di là, cento da più lontano, piovevano da tutte le parti. . …..
Ritornando malinconicamente verso il mio buco, lungo una fila di ricoveri in legno che quei
soldati s'erano costruiti, mi fermai a chiacchierare un poco con un italiano senza dirci i
nostri nomi. Era quello che ora mi parlava. Ci presentammo; lui era Ariberto Smareglia,
figlio del musicista. Diventammo amici e passammo insieme tutto il tempo della prigionia a
Troisk a Taskent a Orloff a Kirsanoff. Fu per sua spinta, perché a me dispiaceva di farlo,
che vendei l'orologio d'argento, regalo della cresima, a un soldato russo che si aggirava
fra di noi e comperava ogni sorta di oggetti. Ci vennero distribuite delle cartoline e così
potemmo subito scrivere alle nostre famiglie.
Cominciò la marcia attraverso le digradanti colline della Galizia. Mezza Austria che andava
in Russia. «Oesterreich rueckt nach Russland vor» dicevano i Tedeschi che non parevano
malcontenti di essere prigionieri. Pure io ricordo di aver provato un senso di umiliazione
davanti a quei Polacchi che ci guardavano passare; erano poveri contadini che ci offrivano
dieci uova per venti centesimi. La neve cominciava a sciogliersi; dappertutto fango e
pantano; dopo un lungo periodo di trincea si camminava a stento; mi trovavo spesso in
coda alla colonna. I cosacchi che venivano dietro ci spingevano talora in malo modo coi
calci dei fucili, e ai nostri lamenti rispondevano che se avevamo avuto la forza di sparare
(«a streliat vam mozno» ) dovevamo avere anche quella di marciare. A questo bel
ragionamento c'era poco da replicare. Giungemmo, dopo sei o sette giorni, alla cittadina di
Przeworsk. Qui c'era chi diceva che si sarebbe dovuto andare a piedi fino a Leopoli; dieci
o dodici giorni di marcia; c'era da spaventasi! Ma per fortuna non fu così. Qui salimmo sul
treno che ci doveva portare lontano. Ed ecco ora l'Austria, che pareva tanto solida e
omogenea al di là delle trincee, cominciare a scomporsi in diverse nazionalità; Polacchi
con Polacchi, Cechi con Cechi, Croati con Croati, Italiani con Italiani, ecc., e tutti
naturalmente a parlare la loro lingua. Intanto il treno correva attraverso la Polonia russa;
eccoci a Lublino; e dopo ecco la città di Brest-Litowsk (diventata poi famosa per la pace
separata dei bolscevichi con la Germania nel 1918). Si attraversava la sterminata pianura
per boschi e paludi. Per di là Napoleone aveva trascinato la grande armata; mai come
allora l'impresa m'era sembrata temeraria e incredibile; le città a distanze grandissime, ore
e ore si correva senza incontrare villaggi o case. Al di là di Minsk siamo alla Beresina.
Arrivammo e ci fermammo anche a Smolensk, poi Borodino e la Moscova. Siamo ormai a
Mosca, nel cuore della santa Russia. «Vsiò Rossii» dicevano i soldati della scorta
indicandoci in giro il lontano orizzonte. Girammo con la nostra tradotta intorno a tutta la
città, e così avemmo occasione di ammirarne la bellezza dei dintorni, tutti sparsi di
magnifiche ville in mezzo a deliziosi boschetti. Era una bella giornata d'aprile, e donne e
ragazzi uscivano a soleggiare sui prati dove la neve cominciava a sciogliersi. ……Dopo
qualche giorno eravamo a Orenburg. Da queste parti incominciammo a vedere i primi
cammelli, colà adoperati dai contadini per i lavori dei campi; avevamo attraversato parte
delle famose «terre nere» (il «cernosiom») ricche di frumento. Ma dopo Orenburg
cominciò a delinearsi la steppa. Non potei ammirare il panorama dei monti Mugogiar,
continuazione meridionale degli Urali Selvosi, perché vi arrivammo che annottava. Ricordo
d'aver provato un misto di piacere e di meraviglia nel ritrovare finalmente dei monti dopo
tanto immenso territorio piano oltrepassato, coll'orizzonte da ogni parte a perdita d'occhio,
e sul quale vedevamo ogni mattina sorgere il sole da una parte per descrivere un
magnifico arco nel cielo fino al tramonto in mezzo a vapori rossastri dall'altra parte. La
mattina dopo ci svegliammo in piena steppa nel paese dei Kirghisi. Ecco delle vele, ecco
delle enormi barche in lontananza. Dove siamo? E' il lago Aral. Eccoci giunti a una piccola
ma linda stazione proprio sulla riva del lago; si chiama appunto stazione di Aralskoje morje
(mare di Aral). Scesi dal treno e corsi a immergere le mani nell'acqua.
Alla fine, diciotto giorni dopo la partenza da Przeworsk, eccoci giunti alla meta: il
pomeriggio del 18 aprile (1915) eravamo a Taskent, capitale del Turkestan. Ci meravigliò
un poco il vedere nei pressi della stazione molta gente che passeggiava vestita
elegantemente, sul figurino di Parigi; ma erano russi, in maggioranza signorine, abitanti
della città europea. «Jesciò'» (ancora!) udii esclamare nel veder giungere quella gran
massa di prigionieri, dopo molti altri arrivati precedentemente, e dopo gli altri trasporti di
quei giorni, taluni dei quali non si fermarono a Taskent, ma proseguirono per Samarcanda,
Merv, Ashabad. Coll'arrivo a Taskent non era però finito il nostro viaggio. Alla maggior
parte venne l'ordine, verso sera, di partire per un accampamento presso un villaggio,
chiamato Troisk (o Troiskoje Selò), una trentina di chilometri a sud-est di Taskent, vicino a
un fiume affluente del Sir-Daria. La marcia la facemmo la notte stessa e il giorno
seguente, ed è, per me, uno dei più bei ricordi della prigionia. Devo dire che la steppa
cessa prima di Taskent; questa città è situata nel mezzo di una grande oasi ricca di una
lussureggiante vegetazione. Era una notte tranquilla e serena, quasi calda, come potrebbe
essere da noi una notte di piena estate; alti alberi si elevavano ai lati di un'ampia
magnifica strada, in cielo brillavano le stelle, l'aria pareva impregnata di profumi. Ogni
tanto ai lati qualche casa degli indigeni Sarti, coi caratteristici sporti e ballatoi: mi pareva di
trovarmi nel paese delle «Mille e una notte». Voi penserete che laggiù ci fosse qualche
ufficiale russo ad attenderci, qualcuno insomma che ci mettesse a posto. Neanche per
idea. I soldati di scorta se ne andarono per i fatti loro; e noi rimanemmo là soli sdraiati
sull'erba ad aspettare. Ma quando era già sera, e nessuno s'era fatto vivo, allora
pensammo ai casi nostri, e cominciò la corsa all'assalto della migliore baracca; queste
erano molto distanti fra loro; e quando, dopo averne occupata una, si aveva notizia che in
un'altra posizione più bella ce n'era una migliore ancora disponibile, corri di nuovo verso di
questa, per paura che altri la occupassero prima di noi. Ci fu detto che in queste baracche
avevano alloggiato fino a qualche anno prima prigionieri giapponesi della guerra del 190405. Finalmente in una baracca, o dirò meglio tettoia, giacché erano semplici tettoie
completamente aperte ai due lati, ci trovammo a essere da una parte tutti italiani e
dall'altra tutti polacchi. E mangiare? Niente per quel giorno, e neppure per altri due giorni
dopo, se qualcuno non aveva con sé un pezzo di pane. Le cucine per noi dovevano
appena essere fabbricate, e s'intende che dovevamo fabbricarcele noi. Finché queste non
fossero pronte, e finché il comando non avesse avuto di tutti i nuovi arrivati le liste dei
nomi distribuiti per ciascuna tettoia e divisi in decine, non ci avrebbero dato da mangiare.
Bisognò mettersi all'opera subito il giorno dopo; alcuni costruirono le cucine; altri si
offersero come cuochi, altri incominciarono a contare i prigionieri, a ordinarli, a scriverne i
nomi per portarli al Comando. Finalmente anche questo cominciò a funzionare. In
generale non c'era necessità di andare fuori dall'accampamento. Dentro di esso era stata
aperta una specie di osteria, dove si andava specialmente la sera a bere il «Kvas» o
qualche altra bibita; chi disponeva di qualche soldo in più poteva anche mangiare qualche
cosa. Lì avevamo combinato un teatro all'aria aperta senza bisogno di palcoscenico:
spettacoli d'ogni sorta; c'era un contorsionista e un finto atleta dall'enorme muscolatura; e
poi si cantava e si suonava; c'era un triestino con una bella voce baritonale; altri si erano
procurati mandolini e chitarre; venivano naturalmente anche prigionieri di altre nazionalità;
fra questi un tedesco, artista di caffè-concerto, che ci dilettava con le sue buffonate. Noi
graduati, che formavamo lo stato maggiore della tettoia, c'eravamo anche costruito un
rozzo tavolo davanti alla stessa per prendere i pasti.
Un giorno venne a rompere la monotonia della vita nell'accampamento la visita di due
eccelsi signori, i due grandi khani o emiri dei due khanati, vassalli della Russia, di Bokara
e di Kiva; ci elargirono anche una somma di denaro, non ricordo bene quanto, cento o
duecento rubli; ma poiché, dividendola fra tutti avremmo ricevuto pochi kopeki a testa,
decidemmo di lasciarla ai medici per comprare medicine, di cui c'era penuria, e per il
sostentamento degli ammalati. Dopo circa un mese e mezzo di questa vita, un giorno,
mentre sdraiati all'ombra lasciavamo passare le ore del caldo opprimente, udiamo a un
tratto gridare: «Italija Italija, vojnà»: era un ragazzetto che veniva a vendere i giornali, e
lanciava la grande notizia dell'entrata in guerra dell'Italia a fianco dell'Intesa (maggio
1915). A tanta distanza e in queste circostanze apprendemmo che l'Italia aveva rotto
gl'indugi e dichiarato la guerra. (Di ciò che avveniva in Italia nel periodo della neutralità
sapevamo ben poco. Sui Carpazi, pochi giorni prima che fossimo fatti prigionieri, circolava
la voce che l'Austria aveva ceduto all'Italia il Trentino, e che in cambio l'Italia avrebbe
mandato sul fronte russo 15.000 bersaglieri).Si può immaginare come accogliemmo quella
notizia; comprendemmo subito che avevamo finito di essere austriaci, e per prima cosa
strappammo dalla divisa mostrine stemmi e monogrammi, finché non potemmo buttar via
anche quella cambiandola con altri vestiti fornitici dai Russi o che noi in qualche modo
potemmo procurarci. (ndr. quando pochi giorni dopo venne chiesto agli italiani di
dichiararsi pro Intesa, coi benefici di alleati, alcuni vecchi non vollero aderire “Dicevano:
Andate voi che siete giovani; noi nessun aiuto possiamo recare all'Italia; abbiamo ancora
in Austria la moglie e i figli, esposti a chi sa quali feroci rappresaglie” E rappresaglie ci
furono: famiglie che fino allora erano state risparmiate vennero internate; a tutte furono
tolti i sussidi, e furono sottoposte a ogni sorta di vessazioni. Sebbene fossimo tanto
lontano e usassimo prudenza, l'Austria in breve venne a sapere i nomi di tutti). Intanto la
vita di quelli che dovevano partire per l'Italia andava facendosi difficile nell'accampamento
di Troisk. Sorgevano frequenti dispute con gli austriaci e coi tedeschi, che erano pure
numerosi e minacciavano di dare l'assalto alla baracca degli italiani. Dovemmo rivolgerci al
comandante del campo per avere dei soldati a protezione. Finalmente verso la metà di
luglio si partì; i Tedeschi vennero a vederci partire e a lanciarci le ultime ingiurie. Noi si
credeva di andare diretti in Italia. Invece, ritornati a Taskent, fummo condotti in una grande
caserma, nella quale restammo fino all'ottobre. Qui intanto avveniva il concentramento di
tutti gli italiani del Turkestan. Un giorno ne arrivava una colonna di un centinaio da
Samarcanda, un altro giorno duecento da Askabad, dopo qualche settimana cinquanta da
Merv; e poi ne giunsero da Hogent, da Kokand, da Aulie-Alta e da altri luoghi. L'arrivo di
ogni gruppo, con alla testa un bel tricolore, era un grande avvenimento, anzi una festa:
canti, grida di «Viva l'Italia». Uno trovava fra i nuovi venuti il fratello che aveva lasciato a
casa quando era partito per la guerra, e del quale non aveva nessuna notizia, e voleva
sapere come stava la famiglia; un altro trovava il parente o l'amico. Abbracci, saluti, grida,
canti. «Ma si va proprio?» si sentiva chiedere l'uno all'altro. «Mi par impossibile di essere
ancora vivo; quell'assalto alla baionetta!» E poi tutti a ricordare i pericoli corsi, il freddo, la
fame e il resto. Ognuno raccontava ciò che aveva visto nei vari luoghi. I nomi delle città del
Turkestan ci erano divenuti familiari. Finché durò il concentramento sopportammo con
pazienza l'indugio. Poi cominciarono le impazienze e i malumori. Spedimmo telegrammi al
marchese Carlotti, allora nostro ambasciatore a Pietrogrado; ci rispondeva, con fin troppa
longanimità e bontà, che avessimo pazienza e confidassimo nella sua opera, che non
eravamo dimenticati, che c'erano degli impedimenti, eliminati i quali, la partenza si
sarebbe effettuata senz'altro, e tante altre belle e buone parole. Intanto passavano i giorni
le settimane i mesi. (ndr l’entrata in guerra dei Bulgari a fianco dei tedeschi aveva
definitivamente chiuso il passaggio per la neutrale Grecia, non restava altro che il circolo
polare artico, ma era tardi).
Un giorno, in cinque o sei, ottenemmo il permesso di andare; accompagnati da un soldato
a visitare la città tartara. Questa si trova a circa 25 minuti dalla città russa. Per la strada
udimmo delle voci da un'altana; era un maestro tartaro che faceva scuola, e gli alunni
ripetevano ad alta voce la lezione. La città tartara è quanto di più sudicio e sconnesso si
possa immaginare. Strade quasi affossate e coperte da tende e vetrate, in una semioscurità; ai lati botteghe piccole e strette, alquanto alte dal suolo, tutte tappezzate; dentro,
seduto per terra il padrone con un gran libro davanti, il Corano. Più in là fucine primitive di
fabbro, basse, come buche sotto il livello della strada, nere e affumicate: un'industria dei
tempi di Tubalkaim. Le abitazioni basse non hanno finestre sulla strada, ma solo una
piccola porta. Donne se ne vedevano poche, e queste completamente velate. Una sola
volta e di sfuggita vedemmo il viso di una giovane indigena mentre frettolosa rientrava in
casa da un orto. Entrammo anche in una moschea. Intanto venimmo a sapere che in una
città della Russia europea, e precisamente a Kirsanoff nel governatorato di Tamboff, si
stava facendo il concentramento di tutti gli irredenti che avevano chiesto di essere
trasportati in Italia, che già vi erano quasi tutti quelli venuti dalla Siberia e dalle altre parti
della Russia, che anche noi si sarebbe dovuto presto partire a quella volta.
E infatti partimmo il 4 di ottobre. Quando arrivammo al ponte sull'Ural, confine tra Asia ed
Europa, tutti si misero a urlare come indemoniati, a fare un baccano assordante: era una
manifestazione di giubilo! Passato il ponte, i primi europei che incontrammo furono un
branco di porci; e allora molti, presi dall'entusiasmo, si diedero a gridare: viva i maiali! Era
un sincero omaggio a quelle buone e utili bestie che si chiamano porci non per colpa loro.
A Kirsanoff molti prigionieri italiani e alcuni ufficiali russi erano alla stazione ad attenderci.
Ma con nostro grande disappunto ci fu annunziato che là non c'era più posto per noi,
essendo già occupati tutti i locali disponibili. Dovevamo andare più a nord in una cittadina
chiamata Orloff, vicino a Viatka (oggi Kiroff), situata sul fiume dello stesso nome, affluente
della Kama. Proseguimmo quindi per Tamboff, dove la stazione era ingombra di vagoni
carichi di profughi delle terre invase dai Tedeschi. Faceva gran pena quella povera gente
che aveva dovuto abbandonare la casa e il paese natio e viveva lì dentro carri ferroviari tra
grandi stenti e miseria. Di là piegammo verso nord. Passammo per la seconda volta da
Mosca, e quindi a Jaroslavl, dove mangiammo in una specie di gran salone-teatro;
giungemmo poi a Vologda, la più graziosa e simpatica città russa ch'io abbia veduto. Da
Vologda, che si trova circa all'altezza di Pietrogrado (oggi Leningrado), piegammo verso
est. Eravamo giunti nella regione dei boschi. Da qui fino alla piccola stazione di Sozino
non incontrammo più nessuna città né grande né piccola. Si correva ore e ore in mezzo al
bosco, che formava come due pareti lungo la linea, e pareva di correre in una specie di
galleria. A grandi distanze una radura e una piccola stazione, e cataste enormi di legna,
che talvolta noi stessi caricavamo sul tender, giacché da quelle parti i treni vanno avanti
anche a legna. Questo viaggio, al quale ho accennato con poche parole, durò la bellezza
di diciannove, dico 19 giorni. Giungemmo alla piccola cittadina di Orici, prima di Viatka, il
23 ottobre. Ed eccoci finalmente alla riva della Viatka. Qui bisognò sostare, perché
eravamo sulla riva sinistra del fiume, la città di Orloff (Kiroff o Kirov) è invece sulla destra.
A gruppi passammo al di là su enormi zatteroni spinti dai Russi con lunghe grosse
pertiche. Un po' fuori dalle ultime case sorgeva l'edificio che ci doveva ospitare nei mesi
invernali, la più triste e orrida dimora che avemmo in Russia, e dove passammo anche i
più tristi mesi. Era una caserma con un grande stanzone a terreno e uno eguale al piano
superiore; inoltre due o tre altre stanze più piccole. Nel mezzo e all'intorno c'erano dei
tavolati sui quali dormivamo uno a ridosso dell'altro, stipati come le sardelle, vestiti, perché
non c'era altro per coprirsi. Io e il mio amico fiumano Marassi giacevamo vicini, e avevamo
anche la disgrazia di trovarci presso a un ampio portone sempre spalancato dal quale
entrava l'aria rigida e la neve.
Racconto tratto da ritagli di giornale di cui non si capisce il titolo.