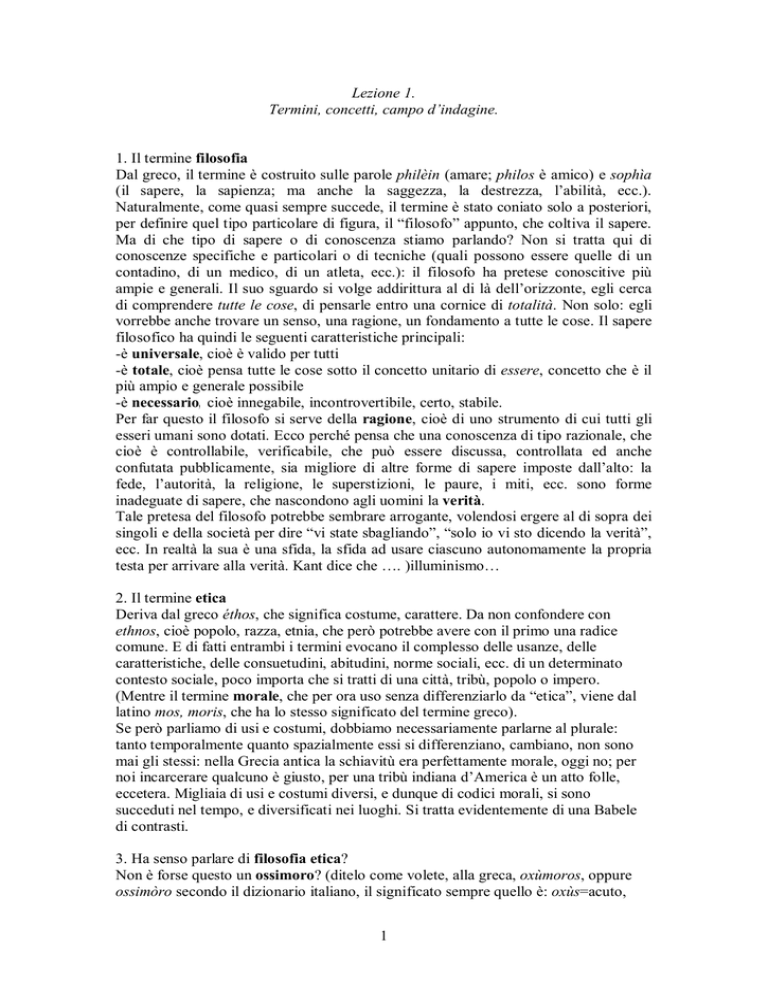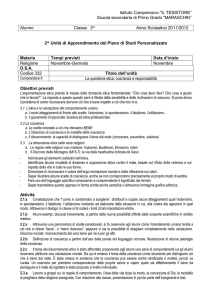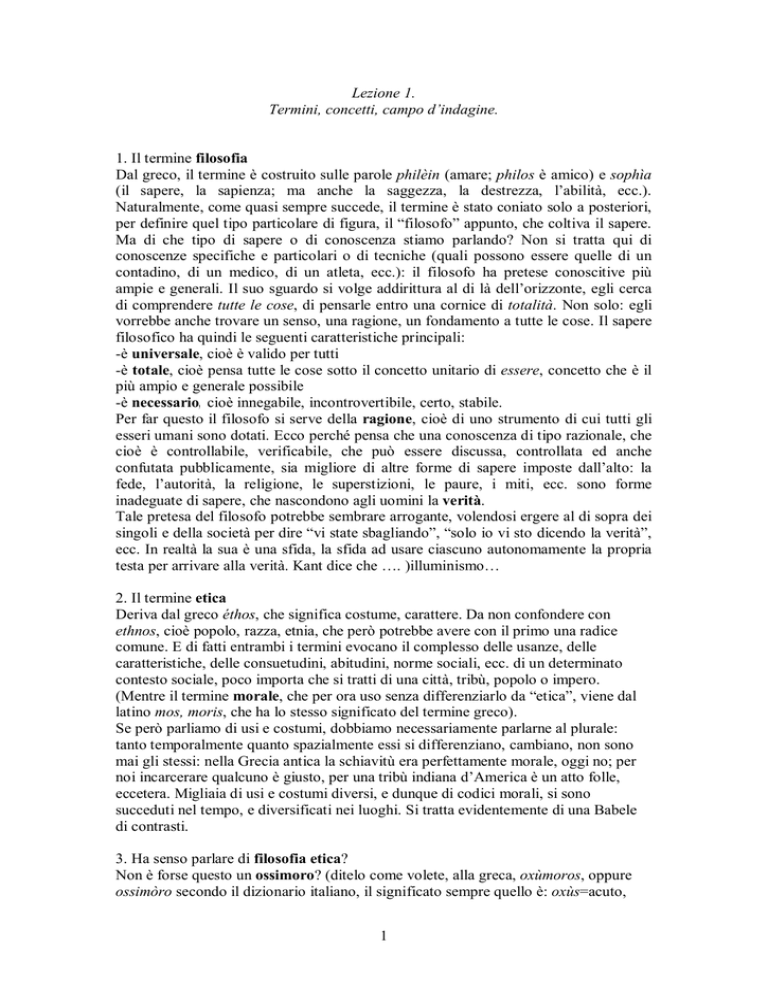
Lezione 1.
Termini, concetti, campo d’indagine.
1. Il termine filosofia
Dal greco, il termine è costruito sulle parole philèin (amare; philos è amico) e sophìa
(il sapere, la sapienza; ma anche la saggezza, la destrezza, l’abilità, ecc.).
Naturalmente, come quasi sempre succede, il termine è stato coniato solo a posteriori,
per definire quel tipo particolare di figura, il “filosofo” appunto, che coltiva il sapere.
Ma di che tipo di sapere o di conoscenza stiamo parlando? Non si tratta qui di
conoscenze specifiche e particolari o di tecniche (quali possono essere quelle di un
contadino, di un medico, di un atleta, ecc.): il filosofo ha pretese conoscitive più
ampie e generali. Il suo sguardo si volge addirittura al di là dell’orizzonte, egli cerca
di comprendere tutte le cose, di pensarle entro una cornice di totalità. Non solo: egli
vorrebbe anche trovare un senso, una ragione, un fondamento a tutte le cose. Il sapere
filosofico ha quindi le seguenti caratteristiche principali:
-è universale, cioè è valido per tutti
-è totale, cioè pensa tutte le cose sotto il concetto unitario di essere, concetto che è il
più ampio e generale possibile
-è necessario, cioè innegabile, incontrovertibile, certo, stabile.
Per far questo il filosofo si serve della ragione, cioè di uno strumento di cui tutti gli
esseri umani sono dotati. Ecco perché pensa che una conoscenza di tipo razionale, che
cioè è controllabile, verificabile, che può essere discussa, controllata ed anche
confutata pubblicamente, sia migliore di altre forme di sapere imposte dall’alto: la
fede, l’autorità, la religione, le superstizioni, le paure, i miti, ecc. sono forme
inadeguate di sapere, che nascondono agli uomini la verità.
Tale pretesa del filosofo potrebbe sembrare arrogante, volendosi ergere al di sopra dei
singoli e della società per dire “vi state sbagliando”, “solo io vi sto dicendo la verità”,
ecc. In realtà la sua è una sfida, la sfida ad usare ciascuno autonomamente la propria
testa per arrivare alla verità. Kant dice che …. )illuminismo…
2. Il termine etica
Deriva dal greco éthos, che significa costume, carattere. Da non confondere con
ethnos, cioè popolo, razza, etnia, che però potrebbe avere con il primo una radice
comune. E di fatti entrambi i termini evocano il complesso delle usanze, delle
caratteristiche, delle consuetudini, abitudini, norme sociali, ecc. di un determinato
contesto sociale, poco importa che si tratti di una città, tribù, popolo o impero.
(Mentre il termine morale, che per ora uso senza differenziarlo da “etica”, viene dal
latino mos, moris, che ha lo stesso significato del termine greco).
Se però parliamo di usi e costumi, dobbiamo necessariamente parlarne al plurale:
tanto temporalmente quanto spazialmente essi si differenziano, cambiano, non sono
mai gli stessi: nella Grecia antica la schiavitù era perfettamente morale, oggi no; per
noi incarcerare qualcuno è giusto, per una tribù indiana d’America è un atto folle,
eccetera. Migliaia di usi e costumi diversi, e dunque di codici morali, si sono
succeduti nel tempo, e diversificati nei luoghi. Si tratta evidentemente di una Babele
di contrasti.
3. Ha senso parlare di filosofia etica?
Non è forse questo un ossimoro? (ditelo come volete, alla greca, oxùmoros, oppure
ossimòro secondo il dizionario italiano, il significato sempre quello è: oxùs=acuto,
1
moròs=stupido, come dire capra con cavoli, cioè accostare due termini che non
c’entrano l’uno con l’altro, cosa che oggi va molto di moda, basti come esempio
quello della “guerra umanitaria”).
Mi spiego: se il termine filosofia implica unità, ordine, totalità, universalità, stabilità,
ecc., in modo esattamente opposto etica, visto che non c’è forse nulla di più
molteplice, variabile e caotico.
Come dire che quando si tratta di scoprire leggi che riguardano il cosmo, la natura, la
logica, la matematica, la fisica, ecc. forse ce la caviamo meglio (almeno un tempo si
pensava che fosse così, oggi non è più nemmeno sicuro questo), ma certo se
dobbiamo mettere ordine nel mondo umano (storico, sociale, politico, etico, ecc.) le
cose sembrano subito complicarsi. Come faccio a dire che la schiavitù è sbagliata (o
viceversa) e che il carcere è giusto (o viceversa)? Come faccio a sapere se ciò che è
giusto, bene, piacevole, virtuoso per me lo è anche per un altro?
Ecco che nascono subito alcuni problemi…
4. Giusto/sbagliato in termini assoluti: universale/relativo
Se la filosofia, come sembra, ha la pretesa di trovare un’etica universale, e dunque
valida per tutti, certo ha bisogno di fondarla su qualcosa di altrettanto stabile e
universale. Ha allora due strade:
-o cerca in direzione extramondana, e allora è un dio che detta una legge esterna a
regolare il meccanismo del giusto/sbagliato (ma già qui sorgono due complicazioni: la
filosofia ha poche competenze in questioni di fede, e, soprattutto, se gli dèi, e quindi
le religioni, e quindi i codici morali sono tanti come si fa?)
-oppure, ed è stata la strada più seguita, si sforza di trovare una natura umana
immodificabile su cui fondare le sue costruzioni etiche. Se cioè tutti gli uomini (e le
donne) hanno in se stessi qualcosa di comune (tipo l’anima, la ragione, un sentimento,
ecc. ecc.), allora il gioco è fatto. Semplice a dirsi, dato che anche su quale sia
l’essenza della natura umana, cioè le caratteristiche universali che accomunano gli
esseri umani, è piuttosto difficile mettersi d’accordo.
Da questa molteplicità di punti di vista, tanto sulla natura umana quanto sull’etica che
quella dovrebbe fondare, emerge chiaramente come non solo sia problematico fissare
una volta per tutte che cosa è etico, ma anzi l’universale cercato si rovescia
facilmente in qualcosa di relativo: come dicevamo prima, quel che per una società è
giusto, moralmente accettabile o buono, non lo è più per un’altra.
5. La filosofia, per cercare di aggirare questi ostacoli, prova allora a mettere un po’ di
ordine, a fare dei distinguo, a classificare, suddividere, ecc.
Innanzitutto distingue tra due piani fondamentali:
-tra i valori, che si pongono su un livello riflessivo, formale, e che per comodità
definiamo propriamente il campo dell’etica;
-e i fatti, cioè quel complesso di codici morali così come si danno storicamente e
praticamente, che potremmo chiamare campo della morale.
Come dire: il filosofo non si limita ad osservare e descrivere la morale che si trova
davanti (e che si produce sempre senza il suo intervento, visto che fa parte della storia
e della tradizione di un popolo, di una cultura, ecc.); ma va a scavare dentro e sotto
quel complesso di norme e di costumi morali, li “decostruisce” (cioè li smonta pezzo
per pezzo), per vedere se hanno un senso, una loro coerenza, se rispettano delle regole
generali (indipendentemente dai contenuti), se si rifanno a valori più universali, ecc.
2
6. Lungo la storia della filosofia, a partire da questo lavoro di scavo e di riflessione,
sono emersi almeno tre importanti modelli (possono essercene altri, ma questi sono i
più importanti):
a) etiche della virtù
Si tratta di quel complesso di teorie etiche diffuso specialmente nel mondo antico,
prima greco poi romano, che cercano di rispondore alle domande: come devo vivere
per raggiungere la felicità? a quali modelli mi devo ispirare? quali sono le virtù da
coltivare?
b) etiche deontologiche
(Dal greco déon, che al genitivo fa déontos, che vuol dire “dovere”). Si occupano
principalmente dei motivi e delle intenzioni che ci dovrebbero guidare nell’azione
morale. Tanto l’etica cristiana quanto quella kantiana rientrano in questa categoria. La
domanda su cui si concentrano è: che cosa devo fare?
c) etiche consequenzialiste
Diversamente dalle etiche del dovere, le etiche consequenzialiste, come ci suggerisce
la parola, non si concentrano sui motivi quanto piuttosto sulle conseguenze
dell’azione morale: quali effetti? La più famosa è senz’altro l’utilitarismo.
7. Scandagliare queste posizioni, ci permetterà di vedere se possono essere utilizzate
nel presente, al fini di discernere ed impostare correttamente le questioni etiche.
Il percorso che ci proponiamo di seguire è pertanto il seguente:
a) L’etica antica (3 lezioni):
-dalla morale eroica di Omero alla polis virtuosa di Socrate
-rigenerazione etica e politica in Platone; l’etica di Aristotele
-il mito del saggio: cinici, stoici, epicurei
b) L’etica moderna (2 lezioni):
-la Critica della ragion pratica di Kant
-le “etiche sociali”: utilitarismo e marxismo
c) Problemi di etica contemporanea applicata (2 lezioni):
-la bioetica
-la guerra, la violenza, la pace, i diritti
3
Lezione 2
Dalla morale eroica alla polis di Socrate
1. Caratteristiche generali dell’etica antica
Le due parole chiave dell’etica antica sono areté e eudaimonìa.
Areté è traducibile innanzitutto con virtù, ma copre un’area di significati molto più
vasta: eccellenza, qualità, valore, stato felice, prosperità, onore, stima, splendore,
nobiltà, fama, merito. Il termine eudaimonìa (formato da eu, bene e dàimon, spirito) è
invece la felicità, il benessere (dell’anima più che del corpo, e tutti i filosofi marcano
questa differenza). Potremmo anche tradurlo con “buona sorte”. L’etica antica va per
l’appunto alla ricerca della virtù al fine di ottenere la felicità: ma potremmo anche dire
che già la vita virtuosa implica uno stato felice, la felicità non è cioè qualcosa che si
raggiunge a posteriori, ma è contenuta nella pratica delle virtù.
2. Il soggetto morale
L’etica greca, fin dall’epoca di Omero, viene costruendo un “soggetto morale”, cioè
l’individuo che è alla ricerca della vita bella, buona e felice, attraverso meccanismi
gerarchici di esclusione – sociale, etnica e di genere: esso è in origine l’àristos, il
nobile dell’epoca eroica, figura che dunque vede esclusi gli altri ceti sociali, i nongreci (barbari) e le donne. Anche più tardi, nell’epoca aurea della democrazia greca,
nell’Atene di Pericle, i cittadini liberi e responsabili nel loro agire (poi vedremo entro
quali limiti va inquadrata questa “libertà”), dunque i “soggetti morali”, sono solo una
parte degli abitanti della pòlis (=città): sono fondamentalmente i capifamiglia dei ceti
che possono permettersi di non lavorare e quindi di occuparsi degli affari pubblici.
3. La morale degli eroi
Seguirò, in questa prima parte del corso dedicata all’etica greca, l’illuminante analisi
che Mario Vegetti conduce nel suo libro L’etica degli antichi.
Cominciamo dall’ira di Achille. L’episodio con cui si apre il libro dei libri dei Greci,
l’Iliade, che racconta appunto dell’ira funesta di Achille e del suo scontro con
Agamennone, capo dello schieramento acheo che combatte contro Troia, ci dà
un’immagine molto nitida dell’antica “morale eroica”. Non dobbiamo pensare ad
un’arrabbiatura passeggera: no, qui si tratta di collera e furore incontenibile, perché
Achille ha subito un torto da parte dell’alleato Agamennone (che gli ha portato via la
schiava Briseide, parte del bottino di guerra), e che quindi ha leso la sua timè (onore).
Achille rompe così l’alleanza, si ritira dalla guerra e torna a combattere solo quando
Ettore gli ucciderà l’amico Patroclo, quindi per una questione privata, quando
sopraffatto di nuovo dall’ira dovrà vendicare la sua morte. Tutto questo ci dà un
quadro piuttosto preciso della morale eroica delle origini, dove ciò che prevale è bìa,
la violenza, o anche kràtos (forza, dominio, potenza) – e dunque la legge del
pòlemos, della guerra. Ciò che guida l’azione degli eroi è dunque la dinamica
dell’onore (timé), che può sempre però essere sopraffatto dalla hybris (tracotanza,
violenza, prepotenza), dal sovrappiù di forza dell’altro eroe. E’ chiaro quindi che la
figura del guerriero incarnata da Achille non può che essere anarchica, sfugg ndo
così alla possibilità di essere sottoposta ad alleanze stabili o a codici comuni. A voler
ben guardare, la morale eroica è piuttosto uno stato premorale e prepolitico. Il mondo
omerico, che canta la virtù degli eroi, è anche un mondo in crisi, perché se a prevalere
è la logica della forza, nessuna convivenza tra gli esseri umani sarà possibile: esso
rischia anzi l’autodistruzione.
4
4. Una parentesi
Con un salto mortale di qualche millennio, vediamo riproporsi una situazione analoga
in uno dei più importanti pensatori degli inizii dell’epoca moderna, e cioè Hobbes
(filosofo inglese, 1588-1679). Egli sostiene che gli uomini nello stato di natura, cioè
prima che sorgessero la società e soprattutto lo stato, erano in guerra permanente tra di
loro: homo homini lupus, dice Hobbes, cioè l’uomo è lupo per l’altro uomo. Dunque,
non diversamente dalla morale bellica dell’Iliade, per evitare che prevalgano la
violenza e la guerra, bisognerà trovare delle forme sociali, delle norme, dei codici
etici condivisi per fondare una possibile convivenza. Tanto dal punto di vista eroicoleggendario, che da quello più prosaico e antropologico di Hobbes, la soluzione del
problema della guerra si lega quindi strettamente alla fondazione del mondo
etico-politico.
5. Ma torniamo al mondo greco classico…
C’è prima di tutto una importante premessa da fare: per i greci, almeno fino ad
Aristotele, è praticamente impossibile distinguere tra politica ed etica: il nòmos, la
legge, il complesso cioè di regole comuni che vige all’interno della pòlis (=città), ha
una valenza tanto giuridica quanto etica, non è possibile distinguere tra i due piani.
Nella nostra epoca, in genere non è più così: per fare un esempio, un conto è la legge
che regola la pratica dell’aborto, valida per tutti i cittadini, un altro è il punto di vista
cattolico sulla questione che, in uno stato laico, ha validità solo sul piano etico e non
su quello giuridico.
6. Dopo la “crisi” del mondo omerico, due sono le strade che si presentano per sanare
quell’endemica conflittualità che rende impossibile stabilire relazioni virtuose fra gli
individui: la “via della pòlis” o la “via dell’anima”. Cioè o una morale politicizzata,
oppure una morale dell’interiorità: quest’ultima strada rimarrà per molto tempo,
almeno fino a Socrate, decisamente marginale.
7. La “via della pòlis” si lega innanzitutto alla fase in cui si cominciano ad imporre
leggi comuni alla città, creando nello stesso tempo uno spazio di mediazione – cioè
l’ambito etico-politico – per la composizione dei conflitti. Ad Atene, la legge viene
per la prima volta scritta e codificata da Solone nel VI secolo a.C.: questo vuol dire
che tutti i cittadini, sia ricchi che poveri, a prescindere dal loro status di potenza e
dalla loro influenza sociale, sono soggetti ad un nomos (=legge) comune.
Nasce così l’epoca classica della pòlis greca, quella incarnata dalla democrazia
ateniese, e con essa l’illusione che la violenza, controllata al suo interno, possa essere
scaricata all’esterno, attraverso una politica imperialista di conquista e di
assoggettamento di altri popoli e città. Ma si tratta appunto di un’illusione: la hybris
rinasce sempre anche all’interno della città, che infatti vivrà una lunga epoca di
guerre, non solo esterne (quella del Peloponneso contro Sparta), ma anche di
sanguinosi conflitti sociali e politici all’interno.
8. S’affaccia parallelamente quella che sopra abbiamo definito “via dell’anima”.
I movimenti mistici e religiosi dionisiaco e orfico-pitagorico, pur nella loro radicale
diversità (il primo più legato agli istinti primordiali, l’altro ad una pratica ascetica),
rappresentano per alcune fasce sociali una possibile alternativa alla pòlis, tanto più
che schiavi, donne, stranieri, non-cittadini, ecc. non trovano nella città alcuna
5
rappresentanza. Cominciano a sorgere quelle istanze extramondane (tra promesse di
salvezza e vie della purificazione, cicli di reincarnazione, ecc.) che secoli dopo
confluiranno, tra l’altro, nel cristianesimo. Anche un pensatore come Platone accoglie
alcune di queste istanze (basti pensare alla sua, più volte rimaneggiata, teoria
dell’anima). I pitagorici, poi, governeranno addirittura la città di Crotone, e la loro
influenza etico-politica, oltre alla loro dottrina, si diffonderà in vaste aree della Magna
Grecia.
9. Prima di vedere come queste due vie finiscono per confluire nel primo vero
pensatore morale dell’antichità, cioè Socrate, dobbiamo però dare uno sguardo a
quella che forse è la più importante istituzione culturale della Grecia del V-IV secolo
a.C., e cioè la tragedia. Ovviamente qui non è tempo né luogo di affrontare in modo
ampio la cosa, ma è importante far emergere alcune concezioni tipiche della tragedia,
che influenzeranno non poco le teorie etiche dei filosofi.
Innanzitutto è il caso di ricordare che la tragedia era per i greci quel che per noi è oggi
il cinema: i drammi, le passioni, i dilemmi, il destino, la morte, la vita, tutto veniva
rappresentato sulla scena tragica. Era come una sorta di specchio in cui ci si vedeva
riflessi, e insieme l’occasione per riflettere pubblicamente dei vizi e delle virtù, del
bene e del male, della felicità o dell’infelicità degli esseri umani. Uno straordinario
caleidoscopio etico, insomma.
Ciò che però qui risulta importante per il nostro discorso, è il problema della libertà e
della responsabilità morale. Se questa viene almeno in parte teorizzata da Aristotele
nella sua Etica nicomachea (ma siamo già nel IV secolo a.C.), nell’epoca aurea della
tragedia (e cioè di Eschilo, Sofocle, Euripide), i personaggi tragici non sono mai liberi
di scegliere. Essi sono piuttosto “agiti”, come posseduti da forze esterne (gli dèi, il
fato, il destino) o interne (il thymòs, cioè l’animo o sede delle passioni, spesso
violente e incontrollabili: odio, amore, collera, ecc.). Figure come quelle di Edipo,
Agamennone, Medea o Fedra non sono libere di scegliere: la loro sorte (tragica) è già
stata decisa, che loro lo vogliano o no.
Per un filosofo come Gorgia, il principio morale addirittura non esiste: egli salva
anche Elena dalla colpa della sua condotta che, secondo alcuni, avrebbe portato morte
e lutti ai Greci (i dieci anni di guerra contro Troia), sostenendo che non di colpa si
tratta ma di sventura (si veda il suo Encomio di Elena).
10.
Socrate (469-399 a.C.) opera il tentativo di mediare tra le due strade di cui abbiamo
parlato, cioè tra quella dell’anima e quella della pòlis, e di risolvere il problema della
vita felice attraverso la conoscenza.
Insieme al movimento dei Sofisti (filosofi esperti specialmente in ambito politico,
retorico e pedagogico, che per primi si fecero pagare per le loro competenze
filosofiche), egli si dedicò quasi esclusivamente al mondo umano, mettendo in
secondo piano le questioni che più avevano interessato i filosofi precedenti (e cioè il
mondo naturale e le origini del cosmo). Cosa sono la virtù, il bene, la giustizia, la
scienza? Queste le domande che interessano Socrate. Una prima risposta immediata è
che la virtù coincide con il sapere e con la scienza (epistéme), ed ha come suo oggetto
il bene. Ma che cos’è il bene? Socrate risponde che il bene dell’uomo non è legato
all’apparenza (i beni materiali, la cura del corpo, il potere, la gloria, ecc.), quanto
piuttosto all’essenza, all’anima.
Conosci te stesso, ecco la direzione in cui guardare per scoprire cos’è il bene.
6
Da questo deriva che se il bene è conoscenza, una volta conosciuto non può essere
evitato, e dunque chi commette il male non lo fa volontariamente, ma solo perché
ignora cosa sia il bene.
Rimane centrale nella figura di Socrate il suo metodo di ricerca del bene e della
felicità, attraverso il dialogo, il continuo interrogare e mettere in dubbio le opinioni
acquisite: queste, essendo dei pre-giudizi, devono essere sottoposte alla discussione,
analizzate, vagliate e accettate solo se rispondono ai requisiti della razionalità e della
scienza: sapere di non sapere diventa così il punto di partenza dell’infinita ricerca
filosofica dell’universale e della verità.
11.
Abbiamo percorso una parabola che partiva da una situazione pre-morale e prepolitica (la morale eroica essendo una morale anarchica, individualista, non
condivisibile socialmente), in cui a prevalere erano la forza, la violenza, la guerra – un
mondo, quello omerico, che non poteva reggere a lungo, e la cui crisi produce una
soluzione originale del problema del conflitto interumano, quello appunto della pòlis;
per arrivare infine alla proposta socratica del dialogo e della ricerca razionale e
comune del bene e della felicità: il totale rovesciamento, cioè, di pòlemos. Ma la città
che si vantava di avere così brillantemente risolto il problema della convivenza, e che
aveva inventato la democrazia, l’Atene gloriosa di Pericle, nel 399 a.C. mandava a
morte proprio lui, Socrate, il migliore e il più morale dei suoi cittadini. Il conflitto tra
società e individuo, tra norme comuni e istanze libertarie, tra conservazione e m
7
Lezione 3
Il concetto di giustizia in Platone, l’etica di Aristotele
1.
Nei due più importanti pensatori della filosofia antica, si profilano due modelli etici
radicalmente diversi, pur nella continuità con la concezione socratica della virtù e con
il quadro “eudemonistico” più generale dell’etica antica. Tale diversità è in qualche
modo riconducibile alle loro teorie filosofiche e metafisiche, che non possiamo qui
affrontare se non di sfuggita, che finiscono per generare rispettivamente un’etica
assoluta o dell’infinito (Platone) e un’etica di carattere descrittivo o del finito
(Aristotele). Vediamo in che senso.
2.
Platone (Atene, 427-347 a.C.), allievo di Socrate, riprende dal suo maestro la
concezione che fa coincidere virtù e sapere, ma respinge la tesi che il male non possa
essere fatto volontariamente. Secondo Platone l’anima è scissa, e in essa vi è pòlemos:
la guerra non è solo un fatto politico, sociale, ma anche psicologico e antropologico.
Dunque occorre riportare pace in entrambi i campi se si vogliono costruire la giustizia
e la virtù. In quest’opera di analisi e di rifondazione etico-politica risulterà centrale,
come vedremo, il parallelismo tra città e anima. Partire dalla città risulterà più
semplice, dato che si ha di fronte come una sorta di macroanima, di cui è quindi più
facile scorgere i meccanismi.
L’opera forse più importante ed ambiziosa di Platone, dove vengono affrontati questi
temi, è la Repubblica, che non a caso si apre con la domanda etica per eccellenza:
che cos’è la giustizia? Il metodo con cui viene condotta questa indagine è quello di
Socrate, che infatti è il personaggio principale del dialogo, e che a partire da quella
domanda formulerà una delle teorie etico-politiche e psicologiche più ardite
dell’antichità.
3.
Il primo nodo da sciogliere è quello opposto da Trasimaco, un filosofo contemporaneo
di Platone, che seccamente risponde alla domanda con la tesi estrema che giusto è
l’utile del più forte, riportando così il dibattito morale alle sue origini, cioè alla logica
omerica della forza e della potenza: le leggi, i codici, lo spazio politico della pòlis
sarebbero così tutte finzioni e maschere di cui i più potenti si servono per governare,
facendo credere alla maggioranza che quel che loro decidono è bene e giusto per tutti,
mentre invece lo è per se stessi e per i loro propri interessi.
(Non diversamente Marx parlerà di ideologia, con questo termine intendendo
quell’apparato morale, religioso, culturale, ideologico appunto, di cui la borghesia, o
le classi dominanti in genere, si servono per coprire il nucleo vero del loro potere, e
cioè l’interesse economico).
4.
Platone aggira l’ostacolo partendo da lontano ed andando a vedere qual è il processo
di formazione della città, il suo sviluppo e la sua dinamica, così da identificare quei
processi che la portano alla decadenza e all’ingiustizia, in modo da tenerli presenti
nell’opera successiva di rifondazione. Questo excursus gli consente di portare alla
luce una sorta di “mito della città delle origini” che avrà lunga vita nella cultura
occidentale: molti filosofi e moralisti di epoca moderna (si pensi a Montaigne o a
8
Rousseau, ma anche ai romantici tedeschi) avranno caro lo schema che vede nelle
origini una purezza ed una perfezione che viene poi col passare del tempo
corrompendosi – se ci si pensa bene altro non è che un’altra versione del mito del
paradiso terrestre, noto anche come mito dell’età dell’oro. Platone conduce però una
vera e propria analisi sociologica di quel che succede alla città nella sua fase di
espansione sia demografica che economica: è gioco forza che l’arricchimento di una
parte, le guerre di conquista, il lusso, ecc. portino conflitti, scissioni e ingiustizia nella
pòlis. Si tratta dunque di mettere ordine in questo caos. E l’unico modo per farlo è
dare il potere ai filosofi…
5.
Tre “caste” dovranno costituire la città giusta: quella dei filosofi-reggitori, quella dei
custodi-soldati, e infine la massa dei lavoratori. La virtù dei primi sarà la sapienza, dei
secondi il coraggio, degli ultimi la temperanza, e solo così la giustizia attraverserà
tutti e reggerà l’organismo sociale. Non utilizzo casualmente il termine “organismo”:
come in un corpo ciascun organo ha una funzione, così nella pòlis: perché tutto vada
bene, perché regni l’armonia, la pace e la felicità di tutti, ciascuno deve svolgere il
proprio ruolo a seconda delle proprie capacità. Un filosofo non può battere il ferro,
così come un contadino non può promulgare le leggi, pena la malattia dell’organismo
e il caos sociale.
Centrale in tutto questo è l’educazione (paidèia, da cui pedagogia), in particolare
della classe reggente, dei filosofi e dei custodi. Questi non dovranno avere né
proprietà né famiglia: requisito necessario affinché essi possano governare
nell’interesse della comunità, è infatti che non abbiano interessi privati da difendere
(altrimenti l’avrebbe vinta Trasimaco). Si attua così una sorta di comunismo al vertice
della piramide sociale, mentre invece le classi lavoratrici saranno libere di riprodurre
gli antichi costumi (famiglia e proprietà), purché questo non comporti eccessivi
squilibri sociali.
6.
Si pone qui una prima domanda: è questa repubblica di Platone un’utopia
irrealizzabile, o una forma anticipata di totalitarismo, oppure una forte istanza
critica di moralizzazione? Il dibattito è apertissimo. Certo nessuno oggi vorrebbe
vivere in una società così gerarchizzata e chiusa, in cui ciascun individuo venga
inchiodato al proprio ruolo sociale per tutta la vita… C’è però un aspetto di tutta la
costruzione sociale di Platone che va preso molto sul serio: il rapporto tra individuo e
società, tra interessi e bene pubblico, tra accumulazione privata e sviluppo sociale –
l’eterna disputa insomma tra libertà e giustizia, deve in qualche modo trovare una
composizione, anche se provvisoria. Nessuna società può reggere a lungo se prevale
la logica di potenza e se Trasimaco vede trionfare le proprie ragioni. La domanda di
giustizia sociale è un nodo ineludibile oggi, come ai tempi di Platone.
7.
Dal macro al micro: vediamo ora come Platone conduce l’indagine sull’anima, e
come egli intenda riformare anch’essa (si noti qui di passaggio come le immagini
tecniche del plasmare e riplasmare, della tessitura, del dar forma, del forgiare, ecc.,
vengano spesso utilizzate da Platone in campo etico-politico).
Innanzitutto l’anima è suddivisa in tre parti:
9
a) l’elemento razionale
b) il thymòs, l’animo, sede delle passioni, del cuore, del coraggio, della collera, ecc.
c) l’elemento irrazionale: la brama, i desideri, l’eros, ecc.
In verità anche il thymòs è irrazionale, ma l’essenziale è per Platone che esso si allei
con la parte razionale per mettere sotto controllo la parte più istintiva e
incontrollabile, quella cioè dei desideri (che sono poi fondamentalmente quello
dell’accumulazione e quello erotico). Platone colloca anche fisicamente questi tre
segmenti dell’anima: nella testa il primo, nel petto il secondo, nel ventre il terzo.
Utilizza poi una metafora “zoologica” per chiarire ulteriormente la suddivisione: è
come se l’anima contenesse tre animali, un uomo, un leone e un mostro policefalo.
Un discorso a parte andrebbe fatto sull’impulso erotico, che in alcuni dialoghi (si
vedano il Simposio e il Fedro), Platone considera, se opportunamente sublimato e
convogliato nella giusta direzione, come la strada che può condurre dalla
contemplazione fisica dei bei corpi alla contemplazione ideale della bellezza e del
mondo delle idee, dunque dal livello fisico-sensibile e istintuale a quello (virtuoso)
della scienza e della conoscenza.
Naturalmente, come per la città, anche per l’anima deve valere il principio che a
governare dev’essere la ragione: la parte razionale, anche qui alleata della forza, deve
controllare gli istinti ed impedire che essi portino caos e disordine nell’armonia
psichica dell’individuo.
L’anima “armonizzata” e la pòlis “pacificata” sono specchio l’una dell’altra, e sono
condizioni reciproche affinché la giustizia regni nel mondo umano.
8.
Ma non basta. Si diceva prima come l’etica di Platone sia un’etica di carattere
“assoluto”. Il Bene che, attraverso la rifondazione tanto della società quanto degli
individui, è possibile raggiungere non è un bene di questo mondo, ma bensì l’idea
stessa di bene che è qualcosa che rinvia quindi ad un mondo ideale, posto al di là di
quello sensibile. A proposito della teoria delle idee, mi limiterò ad un solo accenno,
giusto per comprendere questo punto piuttosto complesso: Platone pensava che la
realtà vera non fosse quella delle cose sensibili (cioè quella che vediamo, tocchiamo,
percepiamo, ecc.), ma quella del mondo delle idee, cioè di quegli enti universali
pensabili solo attraverso la mente, che costituiscono i modelli eterni delle singole
cose. Un atto giusto o un corpo bello, ad esempio, sono cose passeggere e caduche,
che nascono e muoiono, mentre invece l’idea di giustizia o di bellezza sono stabili ed
eterne, modelli di cui le singole cose sono copie. Questa teoria ha valore ontologico
(da òntos, ciò che è esistente), cioè è una vera e propria teoria dell’essere: l’idea del
Bene, secondo questa prospettiva, è una sorta di Idea delle Idee, una sintesi della
molteplicità ideale che rappresenta il vertice della realtà. Platone usa anche qui
un’immagine per rendere più comprensibile il concetto di bene: egli dice che il bene è
come il sole. Così come il sole permette la vista, insieme alla visibilità delle cose, ma
anche la loro esistenza, allo stesso modo l’idea del bene dà all’uomo la facoltà
razionale di vedere il mondo ideale, e nello stesso tempo rende intelligibili (cioè
visibili attraverso gli occhi della mente) le idee, e permette infine che le idee stesse
esistano. Si può pensare ad una sorta di dio, ma del tutto razionale, non personale
come è quello delle religioni monoteistiche. Ora, il filosofo che guida la città e l’uomo
che fa prevalere in sé la parte razionale, hanno la possibilità di accedere all’idea del
Bene: il Bene ha così, insieme, valore ontologico (cioè di realtà essenziale e
fondamentale) ed etico (di valore che eccede e non esaurisce mai ciò che esiste).
Come dire che la realtà vera non è quella che vediamo e tocchiamo e percepiamo tutti
10
i giorni, ma quella che sta al di là del mondo sensibile, e che è raggiungibile soltanto
guardando al mondo delle idee, al vertice del quale sta appunto l’idea del Bene: è
questo un valore assoluto, qualcosa di stabile ed eterno, cui l’anima umana dovrebbe
sempre tendere, ma che forse non può mai essere raggiunto. Da un grado zero di realtà
(di verità e di eticità), si arriva così ad un grado pieno e assoluto, da ciò che è più
caduco e finito si arriva a comprendere ciò che è più stabile ed infinito, dalla copia al
modello, dai beni terreni al bene assoluto, dal buio della caverna al sole che illumina
tutte le cose. Nel famoso mito della caverna, infatti, Platone immagina che gli
uomini siano condannati a vivere in una caverna, incatenati a guardare le ombre e le
immagini proiettate sul suo lato buio interno, come se si trattasse di un cinema,
mentre invece le cose reali stanno alle loro spalle. Ma anche queste cose reali sono
poca cosa rispetto alla realtà che sta fuori dalla caverna, e che solo chi riuscisse a
spezzare le catene riuscirebbe a vedere. E’ un mito, questo, di grande complessità, che
però riassume molti punti importanti delle teorie di Platone.
9.
Aristotele (384-322 a.C.), allievo di Platone e precettore di Alessandro Magno, del
suo maestro contesta radicalmente tanto la teoria delle idee quanto la teoria etica.
Soprattutto spezza l’unità che Platone stabilisce tra ontologia ed etica: un conto è la
realtà metafisica, ciò che regge l’universo, il motore immobile, ecc. ecc. (tutte cose di
cui qui non possiamo occuparci), un altro è il mondo etico e politico.
Aristotele infatti stabilisce un’importante distinzione tra i diversi piani del discorso
scientifico e della conoscenza (lui è il primo filosofo enciclopedico e sistematico, che
si occupa di tutti i campi della realtà, dalla logica alla fisica, dalla metafisica alla
biologia, dalla retorica all’arte, ecc. – classificando e ordinando tutti i saperi): la
distinzione fondamentale è tra scienze teoretiche, quelle che si occupano della natura,
e che quindi non dipendono da noi, e scienze pratiche, quelle che invece dipendono
dalla volontà umana. (Ci sarebbero poi le scienze poietiche, quelle che si interessano
delle tecniche di produzione – da pòiesis=produzione, da cui deriva anche il termine
“poesia”, che rientrano nel campo pratico, pur non essendo delle vere e proprie
scienze, ma conoscenze di rdine tecnologico).
L’etica, che è la scienza del bene individuale, e la politica, scienza del bene
collettivo, rientrano ovviamente nella sfera delle scienze pratiche, dato che si
occupano dei fini dell’agire umano.
L’etica aristotelica, a differenza di quella di Platone, come già abbiamo detto è
un’etica del finito, senza pretese assolute, che guarda ai comportamenti umani
effettivi: è un’etica descrittiva piuttosto che prescrittiva, empirica e non normativa.
E’ un’etica del fine, non del dovere, descrive l’uomo qual è, non come dovrebbe
essere.
10.
Le idee di Aristotele in campo etico sono raccolte nell’Etica nicomachea (da
Nicomaco, il nome di un suo allievo). L’uomo, secondo Aristotele, è zòon politikòn,
cioè animale politico: egli non è fatto per vivere da solo, ma in società. L’etica e la
politica si occupano della condotta individuale e di quella collettiva, ma l’una non è
pensabile senza l’altra, dato che l’uomo non è pensabile al di fuori dei legami sociali,
altrimenti, dice Aristotele, sarebbe o bestiale o divino. Fine di entrambe è
l’eudaimonìa, la felicità. Da questo si capisce come egli sia particolarmente
interessato a determinare com’è fatta la natura umana.
11
Poiché nell’essere umano vi è una parte razionale (intelletto) ed una irrazionale
(sensibilità), esistono rispettivamente virtù dianoetiche (da diànoia = facoltà del
pensiero) e virtù etiche vere e proprie.
Le virtù etiche si occupano del perfezionamento e dell’eccellenza (areté) del carattere,
e fanno riferimento al principio della mesòtes, cioè della giusta misura, della via di
mezzo. I comportamenti estremi vanno esclusi, a preferenza di quelli intermedi ed
equilibrati: così tra la viltà e la temerarietà è preferibile il coraggio, tra l’avarizia e la
prodigalità la generosità, e così via. Non si tratta qui di operare un calcolo
matematico, né di scegliere sempre la via della moderazione (per non dire della
mediocrità): se proprio si volesse mantenere la metafora geometrica, si provi ad
immaginare il vertice di un triangolo, anziché il punto intermedio di un segmento, e
allora la prospettiva potrebbe cambiare radicalmente. E’ anche probabile che in questa
concezione vi sia un influsso della tradizione medica, in particolare della teoria
dell’equilibrio organico di Ippocrate.
11.
Le virtù dianoetiche sono fondamentalmente due: la saggezza (phrònesis), che è la
base conoscitiva per operare le virtù etiche, la propensione cioè a calcolare
correttamente il rapporto tra mezzi e fine dell’agire; e la sapienza (sophìa), che è la
virtù propria della ragione teoretica, dunque l’anello di congiunzione tra scienze
pratiche e scienze teoretiche. Secondo questa prospettiva gerarchica, la felicità umana
si realizza pienamente nella figura del filosofo, che, dice Aristotele, è theoeidès,
addirittura “simile a un dio”!
Questo perché l’attività teorica, a differenza di quella pratica, ha il fine in se stessa, e
dunque è suprema, la più continua, la più piacevole, autosufficiente, amata di per se
stessa, e dunque libera. Solo chi raggiunge questo livello di consapevolezza e di
autosufficienza, solo chi prova il piacere puro della conoscenza e della
contemplazione, chi pertanto non è soggetto all’incostanza e all’incertezza dell’agire
pratico, può essere veramente e compiutamente felice.
Aristotele non vuole certo qui sminuire il lato pratico, etico e politico dell’attività
umana, ma certo nella figura di sapiente da lui additata come vertice dell’umana
ricerca della vita felice e beata, possiamo vedere una prefigurazione del mito del
saggio stoico ed epicureo. Ma di questo parleremo nel prossimo incontro.
12
Lezione 4
Il mito del saggio: cinici, stoici, epicurei
1.
Possiamo far derivare la costruzione della figura antica del saggio direttamente dalla
vita e dal pensiero di Socrate, il quale, a differenza dei filosofi precedenti, aveva dato
maggiore importanza alle questioni etiche e di filosofia pratica, piuttosto che allo
studio della natura e del cosmo. Si potrebbe dunque dire che con Socrate, nonostante
o proprio grazie alla sua condanna a morte, si ha la vittoria definitiva di quella che
avevamo definito “via dell’anima”. Tanto più che pochi decenni dopo la sua
scomparsa, il mondo della pòlis che per qualche secolo era stato il modello
organizzativo e morale più importante per i greci, comincia a dissolversi per cedere il
passo a nuovi modelli politici: Alessandro Magno aprirà infatti l’epoca degli imperi.
Anche la figura del filosofo e la sua funzione sociale si vengono lentamente
modificando, specie dopo Platone ed Aristotele, i due filosofi c e più di altri avevano
creato teorie filosofiche potenti e sistematiche, ed insieme due scuole altrettanto
influenti, l’Accademia e il Liceo.
Ma già subito dopo Socrate qualcosa comincia a cambiare…
2.
Diogene di Sinope (413-323 a.C.) era seguace di Antistene, a sua volta allievo di
Socrate. E’ passato alla storia come il filosofo che viveva nella botte, figura bizzarra e
un po’ pazzoide – e di fatti Platone lo aveva soprannominato il Socrate matto.
Diogene è il più celebre rappresentate della scuola filosofica detta dei cinici, termine
derivato quasi certamente da kuon, kunòs che vuol dire “cane”: si può desumere che il
riferimento ai cani fosse dovuto al loro stile di vita. Erano senz’altro dei veri e propri
hippies e rivoluzionari dell’antichità.
Falsificare i valori costituiti, questo il programma di Diogene, in aperta polemica
con i valori correnti dei cittadini di Atene dell’epoca, e in particolare con quelli che
facevano dell’esteriorità, della ricchezza (“valori” è nòmisma, che però vuol anche
dire moneta), o del decoro i beni più importanti. I cinici, al contrario, ritenevano che
l’etica della pòlis fosse falsa, artificiale e contronatura. Essi predicavano infatti un
vero e proprio ritorno alla natura, dando così inizio a quella lunga tradizione che
vede contrapposte natura (nel senso di originario, genuino, vero, puro, ecc.) a cultura
(nel senso di falso, artefatto, corrotto, ecc.).
Il rovesciamento dei valori prevede la costruzione di una nuova etica: contestazione
dell’autorità, autarchia (da autàrkeia = bastare a se stessi, autosufficienza,
indipendenza), imperturbabilità e tranquillità d’animo – tutti tasselli originari di una
nuova figura di filosofo che si viene costruendo, quella appunto del saggio che prende
le distanze dai costumi correnti.
Diogene pratica una vera e propria filosofia del gesto e della provocazione: egli non
ha pudore, vive all’aria aperta come i cani, dice sempre quello che pensa e non accetta
le gerarchie costituite. Nel contempo promuove uno stile di vita sobrio ed essenziale:
un mantello, una bisaccia e un bastone, questi tutti i suoi averi – ed anzi quando vedrà
un ragazzino bere a coppa dalle mani, getterà via anche la ciotola.
La sua – vista con gli occhi del presente – è una formidabile e feroce denuncia della
società dei consumi!
13
3.
Quello degli stoici (da stoà = portico, il luogo dove si riunivano in origine) è uno dei
movimenti filosofici più complessi e di più lunga durata dell’antichità. Basti pensare
che, dopo i primi tre capiscuola (Zenone, Cleante e Crisippo III-II secolo a.C.), il
movimento si svilupperà (e modificherà le sue teorie) per secoli, fin dentro la classe
dirigente dell’Impero Romano (Seneca, e, dopo di lui, si avrà addirittura un filosofoimperatore, Marco Aurelio, e siamo già nel II secolo d.C.).
Proprio gli stoici elaboreranno la più alta e raffinata figura di saggio della filosofia
antica. Centrale nel loro pensiero sono di fatti l’etica e la pratica della virtù.
Occorrerà però, prima di entrare nel merito dell’etica stoica, delineare brevemente la
loro teoria filosofica più generale (potremmo dire la loro ontologia, o teoria
dell’essere). Per gli stoici il mondo è un cosmo ordinato, retto da una ferrea ragione
interna, quel che viene definito talvolta lògos (=discorso, ragione), altre volte pneuma
(spirito). L’armonia regna in tutte le cose, nulla è casuale, tutto ha una causa
necessaria: l’antico concetto greco di eimarméne (fato) viene qui trasformato in
necessità logica. Come per Platone ed Aristotele , che però avevano teorie molto
diverse in proposito, non si deve pensare ad un’entità divina personale ed esterna: si
tratta piuttosto di un dio razionale interno, qualcosa che potremmo avvicinare
tranquillamente ad una forma di panteismo.
4.
Naturalmente, una visione del genere crea subito un problema: da dove derivano il
male e la malvagità umana? (che sarà poi il problema della teologia cristiana – se Dio
crea il mondo, allora anche il male deriva da lui – e che verrà designato come
problema della teodicea, o “giustificazione di Dio” nei confronti del male).
Gli stoici danno due risposte (che a me personalmente convincono poco): ciò che a
noi, esseri umani parziali e limitati, appare come “male”, in realtà potrebbe essere
classificato come “bene” se si assumesse il punto di vista assoluto del lògos (o di
Dio); non solo: se anche fosse giusto definirlo “male”, non è detto che da esso non
potrebbe venire un maggior bene futuro.
Come dire che dalla Shoah possa essere venuto qualcosa di buono: semplicemente
ridicolo! Certo, dovremmo anche distinguere tra male naturale (le catastrofi, ad
esempio) e malvagità umana (genocidi, guerre e simili), ma ci torneremo.
5.
Secondo questa visione “cosmologica”, anche nell’individuo ciò che deve prevalere è
la ragione: ma come si concilia ciò con l’elemento irrazionale, che pure esiste? Se
tutto è ragione ed armonia, com’è che gli esseri umani sono costantemente divorati da
quel complesso variegatissimo che è il mondo delle passioni, delle pulsioni, degli
istinti? Com’è che vengono posseduti per lo più dal mostro policefalo di cui parlava
Platone?
Gli stoici propongono una sorta di “medicalizzazione” del problema e di sua cura
radicale: le passioni, concepite come “malattia”, devono essere estirpate. Il saggio
deve praticare l’apàtheia, l’assenza di passioni, l’impassibilità, e deve così diventare
“insensibile”. Nella lingua italiana, infatti, il termine “stoico” non a caso indica la
capacità di affrontare con fermezza e sangue freddo anche le prove più dure: stoico,
ad esempio, è colui che sopporta il dolore senza lamentarsi, e che non si lascia
avvincere né abbattere dalle avversità. C’è un’immagine cui tanto gli stoici quanto gli
epicurei fecero riferimento, per spiegare tale atteggiamento: quella del toro di
Falaride. Questi era un tiranno di Agrigento che aveva fatto costruire un terribile
14
strumento di tortura e di morte, cui diede il nome: il malcapitato veniva rinchiuso in
un toro di bronzo cavo che a sua volta veniva posto sul fuoco e che, tramite un
apparecchio acustico, faceva credere che le grida di dolore della vittima fossero i
muggiti del toro. A parte la sadica perversione di Falaride, lo stoico doveva resistere
eroicamente e persino tacere, anche se infilato dentro al suo toro.
Si capisce però come tale figura del saggio, apatica, imperturbabile, tutta ragione
niente passione, fosse un po’ estrema ed irraggiungibile. Alcuni filosofi stoici
attenuarono tale radicalismo, introducendo il concetto di “beni indifferenti, ma
preferibili”: per lo stoico i beni mondani dovrebbero essere del tutto indifferenti,
accettando egli quel che la sorte gli riserva, ma certo se questa gli dovesse concedere
una vita più comoda e agiata va da sé che egli la debba “preferire” ad una vita
dolorosa e di stenti. Non tutti però furono d’accordo con questo “cedimento” del
rigore morale degli inizi.
Fondamentale rimane invece l’accettazione del fato. Il saggio deve accettare senza
battere ciglio quel che il destino gli riserva, visto che nell’ordinata armonia del cosmo
non c’è posto per il caso. Ma come conciliare questo “fatalismo” e “determinismo”
con la libertà? (Tale problema riguarderà anche la futura discussione all’interno del
cristianesimo del concetto di libero arbitrio). Anche qui c’è un’immagine interessante
che viene coniata per illustrare la soluzione: l’individuo, e segnatamente il saggio,
deve comportarsi come il cane incatenato al carro. Il cane può scegliere di seguire
volontariamente il carro, ma se decidesse di resistere il risultato non cambierebbe,
sarebbe comunque costretto (magari torcendosi il collo) a seguire la via segnata dal
carro. La differenza sta nel fatto che nel primo caso si sceglie liberamente quel che il
fato impone. La libertà consiste dunque nell’accettare e nel piegarsi alla necessità del
proprio destino. Come gli eroi tragici – con la differenza (non di poco conto) che qui
si è consapevoli di tale necessità.
6.
Un tema di grande importanza anche oggi, questo della libertà dell’individuo di fronte
alle strutture che (apparentemente) lo sovrastano. Sembra che egli possa poco di
fronte alle potenze della natura (tsunami e quant’altro) o alle tragedie della storia
(guerre preventive e quant’altro). Eppure… una visione “illuministica” e filosofica (se
correttamente intesa) ci può insegnare che le cose stanno ben altrimenti, che non tutto
quello che accade è “fatale” e che l’individuo, se (e solo se) si pensa in un contesto
sociale più ampio, può determinare non poco del suo destino. La natura può essere
gestita e controllata (certo, a condizione che non la si intenda come un giacimento di
risorse da sfruttare indefinitamente); la storia può essere modificata e persino
rovesciata, anche perché sono gli esseri umani e le società a farla.
Ma su questo, torneremo…
7.
Per quanto concerne Epicuro (341-271 a.C.), ci limiteremo qui a commentare
brevemente la sua famosissima Lettera a Meneceo, nota anche come “Lettera sulla
felicità”.
Nell’esordio si dice come la filosofia sia affare di tutti, a prescindere dall’età, visto
che si occupa della salute dell’anima e della felicità.
Il primo tema che Epicuro affronta è quello della paura, cosa su cui un suo grande
interprete latino, Lucrezio, insisterà particolarmente. Per vivere bene, dirà infatti
Lucrezio nel De rerum natura (“Sulla natura delle cose”), si deve vivere liberi dalla
paura, e per far ciò ci si deve dedicare alla filosofia e alla conoscenza della natura.
15
Solo liberandosi dall’ignoranza e dalla superstizione gli uomini potranno vivere liberi
e felici – concezione quanto mai “illuministica”, con quasi duemila anni di anticipo!
Ma torniamo ad Epicuro. Se gli dèi non ci devono assillare, visto che non si occupano
delle nostre vicende, ancor più dobbiamo liberarci dalla paura della morte. Essa non
può nemmeno sfiorarci, visto che è un fatto naturale, che quando noi esistiamo non
c’è, così come quando essa c’è siamo noi a non essere più. Dunque di che
preoccuparsi? Si noti come qui vi è una chiara allusione a ciò che veramente ci fa
paura della morte, e cioè la sua idea, la sua attesa: ma se essa viene ridotta alla sua
dimensione di fatto sensibile e naturale, non può più toccarci. Epicuro individua così
una delle strutture psicologiche più tipiche dell’essere umano, la paura come ansia e
paralisi di fronte al futuro, proiezione ideale e fantasmatica che allontana e fuorvia gli
uomini dai fatti e dalla verità: leva questa indispensabile per ogni potere. Basti
pensare alla categoria di “terrorismo” oggi!
Si passa poi alla teoria dei desideri. Epicuro li classifica secondo tre tipi:
-desideri naturali necessari
-desideri naturali non necessari
-desideri né naturali né necessari, dunque vani
Solo i primi vanno perseguiti, dato che sono legati all’autoconservazione. Dare peso
agli altri darà luogo ad una dinamica perversa di moltiplicazione infinita ed
incontrollata: ogni nuovo desiderio diventerà così un bisogno di cui non potremo più
fare a meno (basti pensare all’odierno mondo delle merci, la dinamica che lo muove è
la medesima denunciata da Epicuro).
Se si vuole veramente essere felici – e qui è il punto essenziale – bisogna condurre
una vita sobria, essenziale, in cui si sia liberi dai bisogni.
Il piacere (edoné, da cui “edonismo”), dice Epicuro, “è principio e fine della felicità”.
Ma che cos’è e come va inteso? Esso è essenzialmente assenza di dolore, e nel suo
rapporto con la dinamica dei desideri va concepito come libertà dalla dipendenza del
bisogno, che, in quanto mancanza, provoca sempre dolore nell’animo umano. Con ciò
Epicuro non vuole dire che si debba condurre una vita monastica, ma che il rapporto
con gli oggetti che soddisfano i nostri bisogni e desideri deve essere ponderato e
calcolato, e per far questo bisogna coltivare la ragione e la phrònesis (saggezza). La
rinuncia ad un piacere oggi (e quindi un dolore oggi) potrebbe condurre ad un
maggior piacere (e dunque ad una assenza di dolore) domani; non solo, se ci si abitua
a vivere con poco il godimento dei piaceri sarà di gran lunga maggiore, e la loro fine
non sarà così dolorosa e traumatica. In ogni caso, quando gli epicurei dicono che il
piacere è il fine, non intendono “i piaceri dei dissoluti e dei gaudenti […] ma il non
soffrire quanto al corpo e non esser turbati quanto all’anima”.
Infine qualche considerazione sull’agire umano. Epicuro sostiene che “il futuro non è
né nostro né interamente non nostro”. Tre sono le cause principali che reggono le
azioni:
-la necessità, di fronte a cui siamo irresponsabili
-il caso o la fortuna, per loro definizione instabili
-infine il nostro arbitrio, che ci dà autonomia e libertà di scelta.
Diversamente da quel che pensano gli stoici, non tutto quel che accade è dunque
sottoposto alla necessità del fato: almeno una parte dell’agire è in nostro potere, e per
questa parte gli uomini sono responsabili.
Tuttavia, la cosa migliore è starsene lontani dalle tempeste politiche e mondane,
vivendo con tranquillità d’animo (ataraxìa, cioè imperturbabilità), liberi da ogni
paura, senza rincorrere la ricchezza o le passioni più forsennate, coltivando sopra tutto
16
l’amicizia e la filosofia: “vivrai allora – conclude Epicuro – come un dio fra gli
uomini. Non sembra più nemmeno mortale l’uomo che vive fra beni immortali”.
8.
Non solo nel pensiero occidentale, ma anche nella stessa lingua e nei modi di dire, è
rimasta una traccia profonda di queste correnti filosofiche.
Cinico, stoico, epicureo sono termini che noi utilizziamo correntemente, non sempre
in verità con un riferimento corretto alla loro origine: “cinico” ha un’accezione solo
negativa che certo non rende giustizia al valore dirompente della critica di Diogene,
ma anche “epicureo” viene usato in modo del tutto fuorviante, indicando chi si dedica
ai piaceri più sfrenati e al vizio.
In realtà questi movimenti costruiscono un vero e proprio mito del saggio, figura
imperturbabile, apatica, autarchica, che non si riconosce più nella pòlis e nella sua
morale corrente. Si va ormai verso l’epoca degli imperi, un nuovo assetto politico si
sta preparando, la pax imperiale romana è alle porte: il filosofo-intellettuale fa fatica a
trovar posto in questo mondo nuovo, egli tende ormai ad essere un cosmopolita e un
senza patria.
Lo stoicismo in particolare avrà questo carattere universalistico: tra le sue fila ci sono
degli schiavi (Epitteto) o degli uomini di potere (Seneca), quando non addirittura
l’imperatore in persona: è il caso di Marco Aurelio. Con questo gli stoici non si
sognano minimamente di contestare l’assetto sociale e le sue ingiustizie: vivere da
saggi vuol dire essere consapevoli che le ricchezze che contano non sono quelle
terrene, ma quelle dell’anima e dell’interiorità, e che l’unica passione da coltivare è
quella per la filosofia – ma il mondo non può essere cambiato, poiché una legge ferrea
lo costringe nelle catene della necessità.
Alcuni di questi elementi (la centralità dell’individuo, il cosmopolitismo e
l’universalismo, l’ascesi, la svalutazione della sfera mondana) confluiranno senz’altro
nel cristianesimo delle origini.
Plotino, un filosofo neoplatonico del III secolo d.C, arriverà a progettare una sorta di
monastero per filosofi, che nulla avrà a che fare con la Repubblica sognata da Platone:
un luogo puro e isolato, al riparo dalle tragedie della storia, dalle guerre, dalle
carestie. Il rifugio ideale per un saggio in fuga dalla storia.
17
Lezione 5
L’etica kantiana
1.
Tutte le teorie fin qui esaminate sono etiche della virtù. Se vi ricordate, avevamo
parlato nella prima lezione di tre principali gruppi in cui raccogliere le varie teorie
emerse via via nel corso della storia della filosofia: etiche della virtù
(fondamentalmente quelle antiche del mondo greco-romano), etiche deontologiche,
etiche consequenzialiste.
Questa sera ci occuperemo di quella che forse è la più famosa teoria etica
deontologica, che cioè ha la caratteristica di mettere al centro il concetto di dovere (in
greco déon, déontos): l’etica di Immanuel Kant.
Ma prima di affrontare Kant, occorrerà qualche breve premessa.
2.
Dalla fine della filosofia antica in poi, due sono state le strade principali della
riflessione etica: la prima, che ha dominato l’Occidente per circa un millennio, lungo
tutto il Medioevo, ricerca l’origine dell’etica in una sfera extraumana, facendola
derivare direttamente da Dio. In primo piano sono la fede e l’appartenenza alla
Chiesa, il sapere assoluto è di pertinenza della sola teologia che fa della filosofia una
sorta di “serva”. In questo quadro, sull’etica prevale senz’altro la fede: Agostino, uno
dei più importanti teologi e padri della Chiesa, diceva “ama e fa ciò che vuoi”.
Tuttavia, molti sono gli elementi filosofici dell’antichità che confluiscono nel corpus
dottrinale del cristianesimo: la svalutazione del mondano e la centralità dell’individuo
sono senz’altro derivazioni dello stoicismo. La “via dell’anima”, dell’interiorità, della
salvezza giunge nel cristianesimo al suo compimento. Il carattere esterno e assoluto
dell’etica cristiana si traduce nell’obbligatorietà dell’azione morale individuale: ciò
che conta nell’agire è il motivo, la retta intenzione. L’etica cristiana, ed è questa una
novità rispetto a quella antica, è un’etica deontologica.
3.
Con il Rinascimento e l’inizio dell’epoca moderna, torna in campo una seconda
possibilità, più terrestre e filosofica: il fondamento dell’etica non va più cercato in
Dio, ma nella stessa natura umana. La pensano così tutti quei filosofi che si rifanno
al movimento giuridico, politico e filosofico del giusnaturalismo (termine composto
da ius = diritto e natura). Come è evidente dal nome stesso, questi pensatori cercano
una fonte naturale dell’etica, del diritto, della politica – tutti quei campi cioè che
organizzano la convivenza umana e ne permettono il funzionamento. Nasce così il
concetto di stato di natura, quello stadio cioè, più ideale che reale, precedente alla
nascita della società e dello stato, in cui andare a cercare quali sono i diritti originari e
naturali degli esseri umani, così da poterli confrontare con la loro applicazione pratica
e storica successiva.
Sarebbe lungo qui ripercorrere tutto il dibattito da Hobbes a Rousseau su queste
problematiche. I due pensatori che ho citato, erano poi divisi sul non piccolo problema
della bontà naturale dell’uomo (se vi ricordate assolutamente respinta da Hobbes),
oltre che sulla centralissima questione della proprietà privata, che secondo la maggior
parte dei giusnaturalisti è naturale, mentre per esempio secondo Rousseau non lo è –
ciò che conta, però, è rilevare il rovesciamento operato rispetto alla prospettiva
religiosa precedente: la fonte dell’etica non è più esterna, ma interna, i suoi principi
non vanno più ricercati nei cieli della divinità, ma nel mondo umano e naturale, qui
18
sulla terra, essi sono cioè a portata di mano, e soprattutto sono discutibili, criticabili e
modificabili…
4.
Ma veniamo a Kant.
Immanuel Kant (Königsberg, 1724-1804) è uno dei più importanti filosofi dell’epoca
moderna. Il suo nome è legato in particolare alle tre famose “critiche”, la Critica della
ragion pura, la Critica della ragion pratica e la Critica del giudizio. Egli in queste
opere intende affrontare tutte le questioni relative alla ragione umana, al modo in cui
essa funziona, alle varie facoltà che essa esprime e ai suoi eventuali limiti.
Rispettivamente si occupa dei problemi della conoscenza teorico-scientifica,
dell’azione morale e del giudizio estetico, col che Kant vorrebbe rispondere alle tre
domande fondamentali:
-che cosa posso pensare?
-che cosa devo fare?
-che cosa mi è lecito sperare?
tutte riassumibili nella fondamentale “che cosa è l’uomo?”.
Come potete vedere, un compito veramente gravoso!
5.
Kant parte dal problema della conoscenza. In che modo noi conosciamo il mondo, gli
oggetti, ciò che ci circonda? Egli pensa che esistano delle facoltà a priori, dei
meccanismi di base attraverso cui il nostro intelletto apprende e costruisce il mondo
esterno: cioè, non è il mondo che ci offre la sua verità, ma siamo noi, con il nostro
cervello, a catturarlo nella rete conoscitiva. Così come Copernico scopre che non è il
sole a girare intorno alla terra, ma viceversa, allo stesso modo Kant opera una
rivoluzione copernicana nel rapporto tra il soggetto (l’essere umano) e l’oggetto (il
mondo dei fenomeni).
Quel che noi conosciamo (i fenomeni, appunto, l’apparire delle cose ai nostri occhi) lo
conosciamo grazie a condizioni a priori quali lo spazio e il tempo e a categorie del
nostro intelletto quali la causalità: queste non sono nel mondo ma nella nostra testa, e
ci permettono di percepire gli oggetti e di dar loro un senso e un ordine senza il quale
non potremmo orientarci nel mondo.
Succede però che di queste categorie, che noi dovremmo limitarci ad usare per la
conoscenza degli oggetti sensibili, viene fatto un uso improprio, “trascendente”, cioè
che va al di là dei limiti delle nostre possibilità conoscitive. L’uomo varca i limiti
propri della ragione, e si fa domande sulla causa prima delle cose, sulla totalità degli
oggetti oppure sull’immortalità dell’anima: nascono così le idee di infinito, totalità,
Dio, anima, ecc., che, a parere di Kant, non sono conoscibili, dato che non sono
oggetti di cui possiamo fare esperienza. Esse sono piuttosto noumeni, oggetti
intellettuali, “cose in sé” soltanto pensabili, ma privi di un contenuto scientifico.
6.
Nella Critica della ragion pratica, che è l’opera che qui ci interessa particolarmente,
Kant discute del problema del fondamento dell’azione morale. Kant porta alle estreme
conseguenze le tesi dei giusnaturalisti, pensando che non solo l’etica vada ricercata
nella natura umana, ma più precisamente che essa abbia origine nella stessa ragione
umana. L’etica ha una sua natura profondamente razionale.
La domanda centrale in campo morale è allora (come già per la conoscenza scientifica
“cosa rende oggettiva e certa la conoscenza”), “che cosa rende un’azione morale”?
19
Kant risponde che ciò che fa dell’azione un’azione buona, e quindi della volontà una
volontà buona, è il motivo, l’intenzione da cui essa è retta. E la motivazione non può
mai essere sensibile, legata cioè alla felicità o al piacere che accompagna l’azione, ma
solo ed esclusivamente al dovere, alla rettitudine. Se cioè noi agissimo solo spinti da
motivi “materiali” ed esterni, quali appunto quelli legati all’utilità, alla felicità, al
benessere individuale o collettivo, noi saremmo in balìa di circostanze estremamente
variabili, e non riconducibili alla certezza della legge morale. Anche se fossimo
preoccupati solo delle conseguenze delle nostre azioni, rimarremmo fuori dalla sfera
della moralità.
Facciamo un esempio: prendiamo il caso del fare beneficenza. Ipotizziamo che ciò
che spinge a fare beneficenza un individuo rientri in uno di questi tre casi (potrebbero
essercene altri):
-perché è mosso da compassione
-perché aumenti la stima delle altre persone nei suoi confronti
-per interesse (ad esempio egli potrebbe aspettarsi che la persona “beneficata” in
futuro lo ricompensi).
A parere di Kant nessuna di queste tre motivazioni è morale. Nell’ultimo caso è
abbastanza evidente, dato che il movente è di carattere egoistico, dunque
contraddittorio rispetto al significato disinteressato che il fare del bene dovrebbe
comportare; ma persino nel primo caso, quello che potrebbe sembrare più moralmente
congruo, il motivo dell’azione non ha a parere di Kant carattere morale, dato che la
compassione è un sentimento e che, in ultima analisi, è riconducibile al piacere, al
fatto che fare una buona azione ci edifica e ci fa star bene (“mette a posto la nostra
coscienza”, come si suol dire).
Affinché il fare beneficenza sia un atto morale, l’intenzione deve essere quella
categorica e razionale della legge morale: deve cioè avere la caratteristica di essere un
obbligo, un imperativo categorico, come dice Kant. (Attenzione: un obbligo, non
una costrizione, altrimenti non si sarebbe più liberi di agire, e la libertà è la base
senza la quale non ci può essere azione morale e quindi responsabilità).
Ma allora come faccio a sapere quando un’azione è morale?
Si deve sempre andare a verificare qual è la massima o il principio che la regge: Kant,
a tal proposito distingue tra “principi ipotetici” e “imperativo categorico”. Nel primo
caso, se l’azione fosse retta da un principio ipotetico, allora noi saremmo solo
interessati ai suoi effetti: ad esempio un principio ipotetico ha una forma del tipo “se
vuoi evitare la prigione, non devi uccidere”. L’imperativo categorico, al contrario, si
limita a dire “non devi uccidere”, senza nessun’altra giustificazione o calcolo delle
conseguenze. L’azione morale ha sempre questa forma pura, assoluta, indiscutibile,
obbligatoria e universale: essa è riconoscibile perché è scritta a chiare lettere nella
nostra ragione, e non nei cieli della divinità o negli anfratti della natura.
7.
Dunque, riassumendo, i principi che reggono un’azione morale devono poter essere
universalizzabili: devi cioè agire come se la tua massima fosse universale, valida
sempre, in tutte le circostanze, e per tutti gli esseri dotati di ragione.
Kant si rende conto che un principio di tal genere è quanto mai astratto e formale, che
cioè non produce un elenco di azioni da fare o non fare, che la legge morale non ha
nessun contenuto, ma è proprio questo che a parer suo la rende assoluta e universale.
Tuttavia la massima dell’universalizzabilità può essere resa attraverso due formule
che ci vengono in aiuto, dandoci qualche indicazione pratica minima:
a) fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te; ma soprattutto
20
b) agisci sempre pensando alle persone come fini e mai come mezzi.
Se si prendesse seriamente quest’ultimo principio, traendone tutte le possibili
conseguenze, credo che potremmo tranquillamente parlare di una vera e propria
rivoluzione antropologica…
8.
Non possiamo tuttavia esimerci dal formulare alcune delle critiche più ricorrenti alla
morale kantiana:
-del formalismo e vuotezza di contenuto abbiamo già detto;
-c’è poi il problema del conflitto di doveri: tra l’imperativo del proteggere un amico e
quello del non mentire di fronte ad un folle con un’ascia in mano che chiede di lui, a
rigore, secondo l’etica kantiana, rimarremmo paralizzati – anche se il buon senso ci
porterebbe a scegliere la cosa più ovvia. Ma se fossimo costretti ad uccidere qualcuno
per difendere noi stessi o qualcun altro, o un’idea, o la patria o… allora cosa
faremmo?
-l’esclusione della sfera emozionale (pietà, compassione, simpatia, colpa, rimorso,
ecc.) pare sia una grossa limitazione;
-l’esclusione infine del calcolo delle conseguenze potrebbe portare a situazioni
incresciose quando non paradossali: come valutare azioni indesiderate prodotte da
rette intenzioni, dalla buona volontà o da quella che potremmo definire una “bontà
pericolosa”? Facciamo un esempio estremo: se per salvare un bambino che sta
affogando in un fiume mi butto d’istinto e poi, visto che non so nuotare, faccio
affogare lui e magari anche la persona che per salvarci si butta dopo di me, come
valutare la mia azione, pur retta dalle migliori intenzioni?
9.
Dobbiamo affrontare brevemente un ultimo aspetto della morale kantiana, a
conclusione del nostro discorso.
In uno scritto che gli è costato una pesante diffida da parte del potere politico, La
religione nei limiti della semplice ragione, Kant sostiene come non sia la religione a
fondare la morale ma, viceversa, la morale a fondare la religione. Del resto, se
teniamo presente tutto il discorso fatto prima sul fondamento razionale della moralità,
non potevamo che arrivare a queste conclusioni.
Ma c’è un altro aspetto interessante da far emergere: quelle idee che naturalmente la
ragione insegue, e che però insegue invano visto che non hanno riscontro
nell’esperienza oggettiva, e che quindi non hanno un peso conoscitivo e scientifico,
assumono ora in campo morale un peso enorme. Dio, immortalità dell’anima, libertà,
totalità, secondo questa prospettiva sono “postulati della ragion pratica”, cioè idee
regolative per il nostro comportamento. Noi siamo spinti ad agire mossi da quelle
idee, come se esse avessero realtà – e in qualche maniera esse hanno realtà, non
scientifica, non oggettiva, ma morale.
Dunque Kant ritiene che al di sopra del mondo meccanico, materiale, necessario
tipico della natura (e che la scienza newtoniana studia con altrettanto meccanicistico
rigore), vi sia un mondo dello spirito, della libertà e dei fini – un mondo umano, non
divino, si badi bene – che ha in sé dei compiti da realizzare. E questi compiti, affinché
possano essere portati a termine, hanno bisogno di idee meno prosaiche, potremmo
dire “poetiche”, che facciano uscire il mondo dalla ripetitività meccanica e dalle
catene della necessità: il compito infinito di realizzare la libertà umana attraverso le
forme spirituali dell’etica e dell’arte, della religione (entro la sua cornice morale e
razionale, senza fronzoli mistici o superstiziosi), della politica, della storia, in ultima
21
analisi del “progresso” in generale. Il raggiungimento di tale perfezione (il Bene, che
è rappresentabile con l’idea divina) è un compito che non ha mai fine (ecco il perché
dell’immortalità dell’anima), e però richiede come suo fondamento la volontà libera
tanto dalle catene della necessità (natura), quanto da quelle della superstizione.
In una pagina memorabile, una delle ultime della Critica della ragion pura, Kant
scrive: “Due cose colmano l’animo di ammirazione e riverenza sempre nuova e
crescente, quanto più spesso e assiduamente sono oggetto di riflessione: il cielo
stellato sopra di me e la legge morale in me […] Il primo spettacolo, di una quantità
innumerevole di mondi, annulla, per così dire, l’importanza di me in quanto creatura
animale che deve restituire la materia da cui si originò al pianeta (un mero punto
nell’universo), dopo essere stata provvista di forza vitale per breve tempo (non si sa
come). Invece la seconda veduta eleva infinitamente il valore di me quale intelligenza
in virtù della mia personalità, in cui la legge morale mi rivela una vita indipendente
dall’animalità e persino dall’intero mondo sensibile, almeno per quanto si può
desumere dal fatto che la mia esistenza sia determinata in senso finale da questa legge,
e che tale destinazione finale non sia limitata a condizioni e confini di questa vita, ma
vada invece all’infinito”.
22
Lezione 6
L’utilitarismo. La crisi dell’etica
1.
Prima di passare al terzo tipo di etica che prenderemo in considerazione, una breve
annotazione sulle critiche di Hegel (il più “sistematico” di tutti i filosofi) alla filosofia
morale kantiana.
Hegel critica Kant in particolare su un punto, quello cioè della posizione
dell’individuo nel contesto storico e sociale: Hegel ritiene che Kant dia troppo peso al
singolo e alle sue “speranze”, e che la contrapposizione tra “essere” (l’effettiva realtà
del mondo) e “dover essere” (come cioè il mondo dovrebbe essere), vada criticata e
respinta. Nella Fenomenologia dello spirito (1807), una delle sue opere più famose,
egli parla ad un certo punto di “virtù” e di “corso del mondo”, come di due realtà
separate: l’anima bella, l’individuo alla ricerca della moralità e della perfezione, tenta
inutilmente di plasmare il “corso del mondo”, che ritiene ingiusto, a sua immagine e
somiglianza, ma non c’è niente da fare, la storia procede comunque per conto suo, con
le sue leggi, prima fra tutte la dialettica.
A parere di Hegel l’etica (che è differente dalla morale, proprio perché questa
riguarda il singolo individuo) si incarna nel corso storico: è la storia stessa, anche
attraverso le guerre e le tragedie che la insanguinano, a realizzare l’eticità – eticità
che, a parere di Hegel, è tutt’uno con le leggi, il diritto, lo Stato, la politica, insomma
le grandi realizzazioni dello spirito umano.
L’individuo non può opporsi alla necessità del divenire storico. E la filosofia, come la
nottola di Minerva che spicca il volo solo di sera, arriva sempre dopo a comprendere
quel che è accaduto.
Prendete tutto ciò come un brevissimo cenno, molto semplificato, della
contrapposizione tra il punto di vista di Kant e quello di Hegel in campo etico.
2. Le etiche consequenzialiste
E’ questo il terzo gruppo di etiche che analizzeremo. Come si può facilmente
comprendere dal nome utilizzato, si tratta di etiche che più che ai motivi guardano agli
effetti, alle conseguenze dell’azione – in netta polemica con la concezione kantiana (e
più in generale deontologica), che come si ricorderà ritiene morale un’azione solo se
questa è motivata in tal senso, se cioè è retta da un obbligo morale che la fonda.
Le etiche consequenzialiste, molto più pragmatiche di quelle deontologiche, sono
interessanti perché permettono di estendere il campo di applicabilità delle norme
etiche al di là del mondo umano (ad esempio nei confronti degli animali o di altri
esseri viventi, ma ci torneremo nell’ultima lezione). Il principio responsabilità
elaborato da Jonas nei confronti delle generazioni future ed anche il cosiddetto
principio di precauzione specie in ambito biotecnologico hanno senza dubbio a che
fare con il punto di vista consequenzialistico.
3. Il concetto di utilità
La più famosa etica consequenzialista è l’utilitarismo.
Il concetto di utile, che molti pensano sia frutto della modernità, è in realtà già
reperibile in un filosofo greco contemporaneo di Socrate, un sofista di nome
Protagora. Egli sostenne per la prima volta che “l’uomo è misura di tutte le cose”,
operando una vera e propria rivoluzione, sia in campo gnoseologico (da gnosis =
conoscenza), sia in campo etico e politico. Dire che l’uomo è métron, misura di tutte
le cose equivale a dire che tanto la verità quanto la giustizia sono a lui relative, cioè
23
che non sono necessariamente oggettive, né tanto meno che vengono garantite da
qualcosa di eterno (gli dei, la necessità, un’idea assoluta, ecc.): a ragione Protagora
viene ritenuto il fondatore teorico del relativismo, cioè di quella corrente di pensiero
che non ritiene la verità o la morale come valide per tutti in ogni luogo e in ogni
tempo, ma variabili a seconda dei diversi luoghi (popoli, culture) e modificabili nel
tempo. Se in campo scientifico può essere indifferente pensare che ciò che è vero per
me non lo sia per un altro, in campo etico invece stabilire che cosa sia utile per me e
per le altre persone di una determinata comunità è una faccenda piuttosto importante,
dato che ne va della possibilità di convivenza, della giustizia e della felicità
individuale e sociale: è proprio su quel concetto di “utile” che si vuol fondare il
concetto di “giusto”. Si badi però che qui ci allontaniamo dall’idea di Trasimaco che
“giusto” sia “utile” per il più forte, dato che Protagora insiste sulla valenza sociale
dell’utilità.
4.
L’utilitarismo viene fondato teoricamente da Jeremy Bentham, filosofo inglese
(1748-1832), anche se il termine verrà coniato da un suo seguace, il più noto J.S.
Mill, uno dei più importanti teorici del liberalismo e della liberaldemocrazia.
Il principio da cui Bentham parte è quello dell’egoismo individuale, principio a suo
giudizio autoevidente, che non ha alcun bisogno di essere dimostrato.
Tuttavia, affinché l’utile individuale diventi qualcosa di morale deve necessariamente
trovare applicazione in campo interindividuale, farsi cioè principio sociale: ecco che a
questo punto l’utilità diventa la massima felicità per il maggior numero. Il
ragionamento appare semplice: se ciò che è utile per me mi procura piacere e felicità,
è evidente che l’estensione di tale principio a livello collettivo deve produrre la
maggiore felicità per il maggior numero di persone. La moralità di un’azione viene
quindi giudicata per i suoi effetti sociali in termini di utilità, felicità e piacere che essa
riesce a produrre. Più persone rende felici, più avversità e dolori toglie di mezzo, e più
essa viene giudicata giusta.
Bentham arrivo addirittura a “matematizzare” la morale e a ideare una sorta di tabella
con sette principi per effettuare il calcolo: la maggior felicità (e il minor dolore) sono
misurabili in relazione all’intensità, alla durata, alla fecondità, alla certezza, ecc.
Naturalmente il signor Bentham prendeva tutto ciò molto seriamente (oltre tutto, non
va dimenticato che tanto lui quanto i suoi amici avevano idee piuttosto radicali e
avanzate per l’epoca in tema di libertà, giustizia sociale, diritti delle donne, ecc.).
Ciononostante, non possiamo non considerare grossolani e discutibili alcuni aspetti
della sua teoria: del resto, chi oggi riterrebbe ancora che la felicità sia una questione di
numeri, di calcoli e di più o di meno? Chi infatti dovesse entrare nel negozio
utilitarista a comprare, che so, un paio di chili di felicità, rischierebbe, una volta a
casa, di aprire la busta e di rimanere molto deluso…
5.
Risulta chiaro come vi sia qui un errore metodologico grave: applicare categorie delle
scienze naturali (quale la matematica) in campo sociale (etico, politico, economico,
ecc.) – cosa che diventerà sempre più frequente dall’800 in poi con il Positivismo –
comporta conseguenze contraddittorie.
Giova però sottolineare un altro fatto importante che emerge con l’utilitarismo: ciò
che tradizionalmente veniva escluso dalla sfera morale, e cioè il lato economico,
l’interesse, la ricchezza, il lusso (cose anzi normalmente giudicate immorali), diventa
addirittura la base stessa dell’eticità. Tale profondo rivolgimento, insieme
24
all’emergere della teoria del liberismo di Adam Smith, preparerà fra l’altro il terreno
alla critica di Marx all’economia politica e più in generale alla società capitalistica: il
velo ideologico potrà così cadere, e dietro le idee e le costruzioni morali si potrà
finalmente intravvedere il crudo profilo dell’interesse.
6.
Del resto c’era stato un precedente illustre: la Favola delle api di Mandeville, un
medico olandese che nel 1729 scrive un apologo dove immagina un alveare ricco e
fiorente, le cui api si lamentano però per la mancanza di onestà; ecco che interviene
allora Giove, e nell’alveare come per magia i vizi spariscono e si diffonde la virtù –
accompagnata però da un inesorabile impoverimento generale. Questa è, per
Mandeville, la morale:
“La semplice virtù non può fare vivere le nazioni
nello splendore; chi vuole fare tornare
l’età dell’oro, deve tenersi pronto
per le ghiande come per l’onestà”.
Non diversamente mezzo secolo dopo, l’economista scozzese Adam Smith, fondatore
del liberismo, scriverà nella Ricchezza delle nazioni che l’egoismo e l’individualismo
generano armonia e ricchezza sociale, senza che i singoli se le pongano come scopo –
ecco comparire per la prima volta l’invisibile mano del mercato…
7.
Abbiamo così concluso la nostra rassegna sui tre principali tipi di etiche filosofiche.
Prima di passare a qualche esempio di etica applicata, ritengo opportuno spendere
due parole sulla crisi che investe il pensiero filosofico nel suo complesso a partire
dalla metà dell’800, crisi che non risparmia l’ambito etico e i cui effetti durano ancora
oggi.
Naturalmente procederò per brevi accenni, “voli pindarici” veri e propri su questioni e
autori che, da soli, richiederebbero decine di corsi e di lezioni di approfondimento.
Ad interessarci qui sono quelli che un filosofo francese ha definito come “maestri del
sospetto”: Marx, Nietzsche, Freud, cui si può aggiungere anche Schopenhauer.
Pensatori cioè che dietro il velo dell’armonia, della razionalità, del senso, vedono un
mondo scisso, caotico e talvolta insensato. Ciò che la filosofia, la religione e la morale
hanno tentato per millenni – la fondazione cioè di un ordine assoluto, di una gerarchia
stabile di valori, di idee immutabili ed eterne cui fare riferimento – va definitivamente
in crisi.
Prendiamo ad esempio Marx e Nietzsche.
Il primo, attraverso il concetto di ideologia, analizza cosa si nasconde dietro la
morale, la religione, il diritto, ecc.: nient’altro che l’interesse di classe (della classe al
potere in un dato momento storico), filtrato e distillato in un sistema di valori con
pretese universali, che vorrebbero cioè valere per tutti. Torna qui ad affacciarsi la tesi
di Trasimaco, e cioè che “giusto è l’utile del più forte”.
Se Marx si occupa della genesi sociale, storica, materiale delle idee morali, Nietzsche
fa un’operazione simile, pur con prospettive e scopi radicalmente diversi, in campo
psicologico e antropologico. La genealogia della morale scava come un martello
pneumatico nella coscienza, portandone alla luce la vera natura di “potere
introiettato”. I valori vitali originari (l’elemento dionisiaco, passionale, eroico),
vengono repressi a parere di Nietzsche in favore di una morale da schiavi, quella
25
cristiana, i cui valori di riferimento sono l’abnegazione, la rinuncia, il senso di colpa,
il risentimento.
In sostanza, i pensatori della crisi fanno emergere il rimosso della natura umana
(come farà Freud con le categorie di inconscio, libido, aggressività, ecc.), che secoli di
“fandonie idealistiche” hanno coperto e sepolto.
Tutto ciò si accompagna alla cosiddetta morte della metafisica che è anche la morte di
dio: l’uomo è solo sulla terra, e deve poter contare solo su se stesso. Egli è colui che,
individualmente e socialmente, produce la storia, i significati, i valori. Egli, così come
li produce, può anche trasformarli, rovesciarli, produrne di nuovi.
Se Marx vede nella trasformazione sociale e nella rivoluzione comunista i processi
storici che porteranno gli esseri umani a riappropriarsi del proprio destino e ad
instaurare la giustizia sociale e l’uguaglianza, senza né dèi né pseudovalori universali
a conculcarne la libera creatività, Nietzsche propone una trasvalutazione dei valori,
che attraversi e superi il nichilismo, che è il vero carattere dell’età contemporanea, e
che conduca all’avvento dell’epoca del superuomo (che sarebbe meglio tradurre con
l’oltreuomo), colui cioè che accetta la volontà di potenza come proprio destino. In
entrambi i casi la rottura con l’ordine etico, politico, antropologico tradizionale non
può essere più netta e radicale.
Vedremo nel prossimo incontro che cosa questa crisi ideale, che si traduce anche in
una crisi storica della civiltà occidentale, produrrà sul piano etico, specie dopo la
seconda guerra mondiale.
26
Lezione 7
L’etica e la guerra
1.
Riprendiamo il concetto di “crisi” cui abbiamo accennato la volta scorsa.
Possiamo vedere operare tale crisi su due fronti:
a) sul piano oggettivo: crisi dei sistemi di valori, di idee, di concezioni del mondo;
b) sul piano soggettivo: crisi dell’individuo, che non si riconosce più in quei sistemi.
Se cioè da una parte il mondo perde la sua tradizionale armonia (che gli proviene da
un piano divino, oppure da un senso metafisico complessivo, un ordine naturale, ecc.),
anche il soggetto perde la sua fisionomia unitaria: l’individuo non è più riducibile alla
sua razionalità (il cogito cartesiano), cioè non è più un io unitario, tutto d’un pezzo,
ma un flusso scomposto di pulsioni (si veda Freud). Per di più, oltre che sentirsi scisso
all’interno, egli sempre più avverte come il mondo esterno, con le sue strutture spesso
caotiche, lo sovrasti e lo schiacci.
L’esperienza tragica delle due guerre mondiali è in tal senso significativa.
2.
Non è un caso che proprio a partire dagli anni ’50, dopo Auschwitz e Hiroshima, sulle
macerie materiali delle distruzioni e ideali dei valori tradizionali, si sia ricominciato a
parlare di etica e in particolare di etica applicata.
Nella nostra epoca, a fronte della potenza che la scienza e la tecnica sono in grado di
esercitare, in campo ambientale, biologico, sulla vita e sulla morte; a fronte dei
conflitti e delle guerre globali, delle migrazioni, delle nuove ingiustizie – non può non
sorgere il problema e la domanda sul significato di una nuova etica globale.
Questa nuova etica, però, non potrà più avere i caratteri assoluti e universali della
vecchia etica. Essa si dovrà distinguere per caratteristiche più “umane” e provvisorie,
meno dettate da sistemi, idee, dèi calati dall’alto. Essa dovrà pertanto essere:
-non infinita, ma finita, modificabile e fallibile: da calare e applicare, appunto, nei casi
concreti che via via si presentano;
-sarà un’etica complessa, che rifiuti di ridurre l’essere umano a una sua parte
(razionale, pulsionale, sentimentale che sia), ma che tenga conto di tutti gli elementi
che compongono la sfera esistenziale;
-sarà infine un’etica dialogica e delle differenze, o meglio delle diversità: questo non
significa che debba essere necessariamente relativistica (e cioè che qualsiasi cosa o
valore vadano accettati), ma nemmeno che si ponga in un’ottica antirelativistica (per
cui solo un punto di vista è quello valido).
Proveremo a dare qualche esempio applicativo di questa nuova etica nei campi quanto
mai cruciali della guerra e della bioetica.
3.
La guerra è un fenomeno complesso e certo non riducibile alla sua evidenza del
combattere e soprattutto dell’uccidere per qual si voglia motivo o causa. Se così fosse
sarebbe possibile ridurre la questione alla luce del precetto etico “non uccidere” e
vedere in quali casi questo sia valido e applicabile e in quali casi non lo sia. Potremmo
così facilmente parlare di legittima difesa, ma altrettanto facilmente si arriverebbe ad
un terreno quanto mai scivoloso, come nel caso del concetto di guerra giusta (dalle
Crociate alla Resistenza), o della legittimità o meno di combattere in nome di patrie,
bandiere, idee comprese quelle più nobili. In realtà mai come di fronte alla guerra è
27
necessario procedere ad una analisi complessiva che vada al di là della sua immediata
evidenza.
Procederemo qui per suggestioni, tentando comunque di indicare alcuni approcci
possibili alla comprensione del fenomeno guerra. Escluderò tuttavia dall’analisi il
piano materiale della guerra, che è quello scontato (o che tale dovrebbe essere) delle
sue cause economiche, politiche, legate prevalentemente agli interessi, e che pur
essendone i motori principali non ne esauriscono tuttavia la complessità.
Proveremo pertanto a gettare uno sguardo che si porti al di là dei dati materiali e
storici, per indagare brevemente in tre possibili direzioni, significative per la nostra
indagine etica:
a) la naturalità della guerra
b) l’ossessione identitaria
c) l’individuo di fronte alla guerra.
4. Naturalità e immemorialità della guerra
Fin da Omero, e poi con i presocratici, si è pensato alla guerra come a qualcosa di
naturale. Eraclito, pensatore greco che visse a cavallo tra il VI e il V secolo a.C.,
scrisse nei suoi frammenti che pòlemos (la guerra, da cui il termine “polemica”) è
padre di tutte le cose. Un'altra considerazione importante su cui riflettere è la sua
immemorialità, cioè il fatto incontestabile che se ne sia sempre sentito parlare, e che
dunque pare non esistere un’epoca di pace. La guerra (e la sua categoria estensiva,
cioè la violenza) appare così come un dato primo e originario, che esiste da sempre (e
che presumibilmente ci sarà sempre), un modo di essere che sembra scritto nel codice
della natura (e dunque nel nostro DNA), che è parte della struttura del cosmo. E di
vere e proprie cosmologie della guerra si può parlare, anche in epoca
contemporanea, se è vero che questa concezione permane in pensatori come Nietzsche
o Freud, ed anche nelle teorie biologiche di Darwin e dei suoi epigoni. Freud pensa ad
esempio che nella psiche umana vi sia una sorta di “lato oscuro”, una pulsione
aggressiva e distruttiva, un principio di morte (in greco Thànatos), che sta alla base
dei fenomeni sociali della violenza e della guerra. Anche la teoria darwiniana della
lotta per l’esistenza e della selezione naturale è stata ampiamente utilizzata in ambito
sociale.
Oriana Fallaci fa di queste concezioni (“la vita è guerra”, “la guerra è inevitabile”),
uno dei punti chiave della sua battaglia in favore del presunto scontro di civiltà
attualmente in corso tra Islam e Occidente.
La pericolosità di queste teorie salta subito all’occhio, per almeno due motivi:
-se è vero che la guerra è un fenomeno naturale, allora è un dato immodificabile;
-inoltre, i motivi economici e materiali passano così decisamente in secondo piano.
5. L’ossessione identitaria
La specie umana, nel suo dispiegamento spaziale e temporale, ha dato origine a
differenti raggruppamenti che, di volta in volta, sono stati denominati in modi
differenti (razze, etnie, culture, civiltà, popoli, nazioni, patrie), ma che hanno un dato
comune, quello di rifarsi cioè ad una separazione dall’altro e ad una concentrazione
su di sé. Sembra quasi che la costruzione di sé avvenga proprio grazie al differenziarsi
dall’altro, come se non ci fosse possibilità di costruire identità in altro modo. Non si
vuole qui criticare il concetto di identità, di cui certo non si può fare a meno (ognuno
di noi funziona in termini identitari, cioè tende a concepirsi come un’entità a sé stante,
un io diverso dagli altri), il problema è in che modo l’identità viene costruita, a scapito
di che cosa e come si pone nella relazione con l’altro: il problema sorge cioè quando
28
l’identità diventa una vera e propria ossessione, e quando dà origine alla coppia
amico/nemico.
Esistono diverse teorie e spiegazioni possibili di questo fenomeno, ne elenco alcune:
a) secondo alcuni etologi, la differenziazione culturale è una sorta di derivazione
naturale del fenomeno della speciazione, cioè di quel meccanismo biologico
grazie al quale gli esseri viventi si differenziano ed organizzano in specie e
varietà;
b) secondo gli antropologi, il fatto che l’unità umana si spezzi in categorie a cerchi
concentrici (individuo-famiglia-villaggio-tribù-città-nazione-patria-impero-razzaciviltà-genere) è abbastanza normale, e tale fenomeno viene definito
etnocentrismo. Esso, oltretutto, è universale, riguarda cioè tutti i gruppi umani fin
qui noti. Se ipotizzassimo di trovarci di fronte ad una specie aliena, sicuramente
avremmo un’ulteriore espansione dell’etnocentrismo per cui oltre che sentirci, ad
esempio, italiani (contro i francesi), bianchi (contro i neri) ci sentiremmo anche
umani contro gli alieni.
c) Secondo il filosofo del diritto Carl Schmitt, è proprio l’opposizione
amico/nemico, e dunque in ultima analisi la guerra come risoluzione estrema e
decisiva del conflitto che ci oppone all’altro, a definire la sfera propria del
politico;
d) Rousseau ha una spiegazione piuttosto interessante di questo fenomeno: egli pensa
che nell’essere umano ci sia originariamente un impulso naturale
all’autoconservazione (e dunque di tipo identitario) che chiama amor di sé.
Questo impulso si accompagna a quello della pietà, che accomuna gli esseri
viventi sensibili, facendoli sentire parte della stessa comunità vitale e biologica. Se
le cose funzionassero entro questi limiti, probabilmente tutto andrebbe bene,
senonché l’amor di sé si trasforma (e degenera) in amor proprio, generando
insieme l’impulso all’accumulo e alla proprietà. Ciò che succede a partire da
questa degenerazione originaria, viene denunciato con forza nella famosissima
apertura della seconda parte del Dialogo sull’origine della disuguaglianza tra gli
uomini: “Il primo che, avendo cinto un terreno, pensò di affermare: questo è mio, e
trovò persone abbastanza semplici per crederlo, fu il vero fondatore della società
civile. Quanti delitti, guerre, omicidi, quante miserie ed errori non avrebbe
risparmiato al genere umano colui che, strappando i piuoli e colmando il fossato,
avesse gridato ai suoi simili: Guardatevi dall’ascoltare questo impostore; siete
perduti se dimenticate che i frutti sono di tutti, e che la terra non è di nessuno!”
6.
Come si diceva poco fa, ciò che costituisce il vero problema è la progressiva
degenerazione dell’identità in ossessione, quando cioè si ritiene che l’identità propria
sia unica, intangibile, perfetta e che le altre siano imperfette, inferiori, sbagliate.
L’altro viene, potremmo dire, “inferiorizzato”. Storicamente ci sono state molte
manifestazioni di questo processo. Qui ne ricordo solo alcune:
-infantilizzazione: valga come esempio quello delle culture sottomesse durante i
processi di colonizzazione, dove si ritiene che le popolazioni indigene siano barbare,
selvagge, primitive, meno evolute e così via. Secondo questa logica c’è bisogno di un
adulto che indichi loro la via d’uscita dallo stadio infantile: ancora oggi si parla ad
esempio di paesi in via di sviluppo, come se si trattasse di uno stadio umano meno
evoluto. Il concetto stesso di sviluppo, di progresso e di evoluzione è parte integrante
di questa logica;
29
-animalizzazione: il caso del genocidio del 1994 in Rwanda è emblematico: i tutsi
massacrati dagli hutu venivano definiti come “scarafaggi”. Qui sarebbe poi
interessante analizzare il processo di costruzione delle identità etniche hutu e tutsi da
parte dei colonialisti belgi;
-deumanizzazione: il caso della Shoah valga naturalmente per tutti. Alcuni
sopravvissuti, poi, hanno parlato nelle loro testimonianze della cosiddetta figura del
musulmano (termine probabilmente dovuto alle sue movenze), colui che nel campo
era al di là della vita e della morte, al di là di ogni identità possibile;
-streghizzazione: streghe e stregoni erano, in epoca moderna (e non durante il buio
medioevo) donne, eretici, zingari, omosessuali, vagabondi, folli, diversi di ogni tipo,
fino a intere categorie e popolazioni, compresi gli indios delle Americhe…
E si potrebbe continuare con le recenti macellerie etniche dei Balcani, purtroppo il
catalogo degli orrori dovuti all’ossessione identitaria è infinito…
7. L’individuo e le strutture
C’è infine da considerare l’atteggiamento del singolo individuo di fronte alla guerra e
più in generale a tutte quelle strutture storiche che lo sovradeterminano (le varie
identità di cui abbiamo parlato poco fa, oltre alla dimensione economica e materiale, il
linguaggio, la morale, ecc.).
Succede spesso che di fronte alla storia e alle sue tragedie l’individuo si senta come
schiacciato e paralizzato: si ripresenta qui in altra forma il concetto classico di fato.
L’arte e la letteratura, molto più della filosofia, sono state le migliori forme
rappresentative di questo senso di angoscia di fronte all’inesorabilità dell’accadere.
In particolare, per quanto concerne la guerra, ci sono alcune opere straordinarie del
pittore spagnolo Francisco Goya. In Mostruosa bestia feroce e nel celebre Colosso,
le forze storiche vengono rappresentate come creature mostruose che sovrastano gli
esseri umani, i quali sono costretti a subirle senza poter reagire. Ma l’opera più
eloquente in tal senso è Tristi presentimenti di ciò che deve accadere, una delle
acqueforti del ciclo intitolato ai Disastri della guerra: qui si può infatti vedere un
uomo lacero e con il viso angosciato, che allarga le braccia in segno di rassegnazione,
mentre intorno a lui incombono le ombre e le tenebre.
Lo scrittore sudafricano J.M. Coetzee, recentemente insignito del premio Nobel per
la letteratura, ha poi raccontato nel bellissimo romanzo La vita e il tempo di Michael
K., il tentativo di fuga dell’individuo dalle gabbie d’acciaio della guerra e dai suoi
campi di concentramento. Cosa che mi dà lo spunto per accennare alla necessità della
fondazione di un diritto universale alla fuga dalla guerra (e al reciproco dovere di
dare asilo) – diritto che qualche etologo ritiene di dover rinviare alle sue basi naturali,
lamentando il fatto che, essendo oggi l’intero pianeta ricoperto di stati e di confini,
non rimangano più zone neutre in cui poter rifugiarsi, laddove nello stato di natura
l’animale ha sempre la possibilità di sottrarsi allo scontro attraverso la fuga in un altro
territorio.
Tutto questo si può infine ricollegare all’atteggiamento del saggio antico, di cui già
abbiamo parlato, in fuga dalla storia. Basti l’esempio di Lucrezio che, all’inizio del
secondo libro della Natura delle cose, ci canta la dolcezza di guardare da lontano, da
una zona sicura, il travaglio degli altri e le grandi contese di guerra: “nulla è più dolce
che abitare là in alto i templi sereni del cielo saldamente fondati sulla dottrina dei
sapienti”.
30
8.
Quelle che sopra abbiamo esposto sono solo suggestioni, schizzi disordinati,
propedeutici ad un discorso etico da costruire, che sia alternativo alla logica di
potenza e di guerra che, oggi non diversamente da ieri, incombe su scala planetaria. E
che insieme si sottragga al pericolo della fuga dell’individuo dalle sue responsabilità
etiche e storiche. Tale possibile rifondazione etica e politica, ha però bisogno della
riaffermazione di una premessa e di una verità che personalmente ritengo
autoevidente: gli individui non subiscono fatalisticamente la storia e le strutture, ma
piuttosto, tanto singolarmente quanto collettivamente, sono essi a produrre il loro
mondo e dunque hanno la facoltà di modificarlo. E’ questo ciò che qualifica l’essere
umano come libero e responsabile, e che pertanto ne fonda l’eticità.
Qui di seguito indicherò due o tre idee chiave che potrebbero essere
“programmatiche” per questo lavoro di rifondazione etica, e dunque anche politica. Si
tratta di idee generali ed astratte, più “filosofico- teoriche” che “pratiche” – ma senza
le bussole del pensiero non credo si sia in grado di andare da nessuna parte:
a) per un superamento della logica del negativo. Rinvio qui alle pagine del saggio di
Luigi Tarca, all’interno del testo La filosofia come stile di vita, dove viene
discusso e criticato il fondamento negativo del pensiero filosofico occidentale,
secondo cui, come per l’ossessione identitaria, ogni cosa viene determinata a
partire dalla negazione delle altre;
b) di fondamentale importanza è poi la distinzione tra guerra e conflitto, e dunque la
necessità di fondare una teoria della conflittualità non violenta (si veda a tal
proposito di Andrea Cozzo, Conflittualità nonviolenta: filosofia e pratiche di lotta
comunicativa). Sottrarsi alla logica della guerra e della violenza non vuol dire
sottrarsi al compito storico (e profondamente etico) di trasformare il mondo e con
ciò di superare le ingiustizie che lo attraversano;
c) infine, si rende sempre più necessaria la fondazione di un’etica del dialogo, che
non sia insieme né universalistica né relativistica. Il primo passo da fare in tale
direzione è quello di fare piuttosto un passo indietro: chi vuole ancora
scommettere che il proprio punto di visto etico, e con esso i propri valori, il
proprio modo e stile di vita, sia superiore a quello degli altri, il migliore in
assoluto, il più giusto e perfetto? Chi è pronto ad imporlo di nuovo con la guerra e
con la violenza? In nome di quale nuova ossessione identitaria?
9.
La sfida etica della grecità si era aperta proprio con l’epocale problema del controllo
della guerra e della violenza – della bìa e dell’hybris eroiche. La pòlis, e con essa il
mondo etico-politico, era nata in Grecia per arginare il lato oscuro, sempre insorgente,
del pòlemos, e consentire una possibile convivenza pacifica tra gli esseri umani.
Questo stesso nodo ci si ripresenta oggi su scala planetaria: come si uscirà dall’attuale
era omerica (e hobbesiana) della guerra globale?
31
Lezione 8
La bioetica
1.
Con la bioetica potremmo praticamente dire che tutti i nodi vengono al pettine…
E’ poi proprio di questi giorni l’eclatante caso di Terri Schiavo, la povera donna
statunitense che vive (o sopravvive o “sottovive”, a seconda dei punti di vista) grazie
alle macchine da quindici anni, e sul cui corpo si sta combattendo una battaglia legale,
ideologica, culturale, etica senza esclusione di colpi. Al di là della spettacolarità tutta
americana della vicenda, possiamo vedere come in un caso-limite come questo,
affinché possa essere espresso un giudizio etico razionale, occorra dotarsi di strumenti
critici e conoscitivi che non possono limitarsi alla sfera morale tradizionale. Non solo:
in un caso come questo vengono chiamati in causa la scienza, la tecnica, il concetto di
vita e di natura umana, gli stessi fondamenti dell’etica. Ma cerchiamo di fare un po’ di
ordine.
2.
Prima di tutto occorre fare almeno due premesse:
a) oggi il termine “etica” va molto di moda e si tende ad applicarlo a tutti i campi
dell’azione umana: si parla ad esempio di etica degli affari, di etica politica, di
banca etica, di etica ambientale, di bioetica… Secondo me è meglio a tal proposito
operare qualche distinzione terminologica e insieme concettuale, senza con questo
voler irrigidire troppo il discorso o stabilire gerarchie. Ritengo sia preferibile
parlare di deontologia a livello professionale (doveri e responsabilità dei medici,
degli ingegneri, ecc.); di morale nel momento in cui ci si riferisce a valori, regole
e comportamenti legati ad una tradizione, ad esempio religiosa, ma non solo; e
infine tenderei a limitare l’uso di etica al campo filosofico della riflessione e della
discussione razionale dei problemi. Questo non significa che l’etica è affare dei
filosofi, anzi, semmai il contrario: trovo però che una decisione etica o una scelta
responsabile in un certo ambito, abbiano bisogno di essere prima vagliate e
discusse basandosi su argomenti razionali;
b) questo conduce direttamente alla seconda premessa: per far ciò occorre avere
accesso alla conoscenza. Senza conoscenza non c’è agire etico. Anche qui è bene
fare una distinzione: non è sufficiente essere informati, occorre conoscere.
L’informazione, specie nei tempi del villaggio globale-virtuale e di internet, ha
sempre un carattere frammentario, selettivo, veloce, ad uso e consumo
dell’attualità, e, soprattutto, pone il problema dell’attendibilità della fonte. Penso
viceversa che la conoscenza sia un processo di apprendimento e di maturazione
individuale, certo più lento e faticoso, ma che ha il vantaggio di produrre un
sapere qualitativamente più alto, sistematico, critico, e meglio radicato nelle teste
degli individui. Arriverei anzi a sostenere che la conoscenza ha già una sua
valenza etica, già il solo conoscere è cioè un atto rilevante dal punto di vista etico.
Non si deve tuttavia dimenticare che la conoscenza non è riducibile alla sola
conoscenza razionale o scientifica. Questo ci conduce ad un’altra importante
premessa generale prima di affrontare l’argomento della bioetica.
3. Amoralità della scienza?
Naturalmente etica e scienza (così come arte e scienza) sono ambiti da tenere distinti:
una legge fisica o un teorema matematico non hanno alcun valore etico, così come
contemplare la natura e riprodurla su una tela o con dei versi non ha alcun valore
32
scientifico. Ciò non toglie che si tratti in tutti questi casi di forme, seppur diverse, di
conoscenza. Ciò che il poeta o il filosofo mi dicono della natura, se anche non è
espresso in formule e teoremi ma con linguaggi diversi, rimane comunque una forma
di conoscenza. Lo scienziato guarda alla natura in modo diverso, egli non ha nessuna
preoccupazione morale o estetica.
Detto questo, bisogna anche ricordare che la scienza occidentale nasce e si sviluppa in
un contesto economico e sociale preciso e che la sua presunta neutralità etica deve
tuttavia fare i conti con una certa connotazione storica. Bacone, un filosofo che nel
‘600 aveva visto bene quale potenza si nascondeva nel sapere scientifico, aveva
espresso altrettanto bene quale doveva essere l’atteggiamento dell’uomo (borghese,
occidentale) di fronte alla natura: essa deve essere torturata, le si devono estorcere i
segreti con la forza, fino allo stupro! Tale linguaggio, come ha denunciato la
scienziata e filosofa indiana Vandana Shiva, non ha nulla di neutro. La scienza
occidentale ha così prodotto una serie di categorie interpretative, che sono funzionali
ad un certo modo di intendere e di intervenire sui processi naturali, e che ha effetti
rilevanti in campo economico e sociale: meccanicismo, determinismo, riduzionismo
sono qui le parole chiave. La natura è una macchina, o è riducibile a meccanismo, e
dunque può essere sfruttata e controllata dall’uomo che ne è l’unico dio e padrone.
Dietro la pretesa neutralità della scienza si nasconde in realtà il mito e il sogno del
dominio e dell’onnipotenza.
4.
E veniamo alla biologia, che ha ereditato buona parte di quelle categorie. Concepire la
vita e i corpi viventi in termini di macchine determinate geneticamente (e dunque
modificabili se se ne conoscono i meccanismi e le leggi) deriva direttamente da quel
sogno. In questo caso, il sogno del dominio si innesta su un sogno ancora più antico,
quello dell’immortalità.
La bioetica si misura dunque con il campo immenso delle conseguenze che
sull’esistenza umana derivano dalle scienze biologiche, dalle neuroscienze e dalle loro
applicazioni biotecnologiche: si tratta cioè di esprimere dei giudizi sul potere che la
scienza e la tecnica hanno sulla vita e sulla morte, nientemeno!
Il termine “bioetica”, costruito sulle parole greche bìos (vita) ed ethos, è stato coniato
nel 1970 dal cancerologo americano Von Potter, proprio per porre l’attenzione sugli
scenari inediti che venivano via via aperti dalla rivoluzione scientifica in corso.
Esistono diverse sfere, più ristrette o più ampie, cui applicare il termine “bioetica”.
Possiamo individuarne almeno tre:
a) l’essere umano (campo più ristretto di applicazione)
b) gli esseri senzienti (estensione agli animali)
c) l’ambiente (massima estensione possibile)
5.
Vediamo ora, prima di occuparci del campo più attinente alla vita umana, di
presentare brevemente alcune delle teorie generali più interessanti:
a) principio-responsabilità di Jonas
Hans Jonas (1903-1993) è il filosofo tedesco che per primo, fin dagli anni ’50, si è
posto il problema della necessità di fondare un’etica adeguata ai tempi della società
scientifica e tecnologica, occupandosi di temi quali la malattia, la medicina,
l’eutanasia, la clonazione, ecc. Negli ultimi anni della sua vita si è poi occupato della
questione ambientale, applicandovi il principio-responsabilità, coniato per
33
opposizione al principio-speranza di un altro filosofo tedesco, Ernst Bloch, che aveva
fatto dell’utopia della trasformazione uno dei cardini del suo pensiero. Jonas ritiene al
contrario che non di trasformare il mondo ci si deve preoccupare, quanto piuttosto di
risparmiarlo. In particolare è di fronte alle generazioni future che la specie umana
deve assumersi delle responsabilità per il suo modo di agire nel mondo. Come si può
notare, si tratta per certi aspetti di un’etica di tipo utilitaristico, che si pone il problema
delle conseguenze dell’agire, cui però Jonas conferisce anche caratteri categorici e
deontologici tipici dell’etica kantiana.
Jonas fissa poi dei limiti etici alla ricerca biologica a suo giudizio invalicabili, nel
campo della clonazione e in quello dell’allungamento indefinito della vita umana.
b) etiche “animaliste”
E’ un caso classico di estensionismo etico, cioè di applicazione di norme etiche al di
fuori del campo umano tradizionale. Avevamo visto come fin dagli inizi della
riflessione etica, era fondamentale definire il suo campo di applicabilità: è vero che
l’etica riguarda l’uomo, ma lo stesso concetto di “uomo” viene definito per selezioni
ed esclusioni, sociali, di genere, di razza e così via. Con Kant si era arrivato a definire
il campo di applicabilità agli esseri umani in quanto razionali. Ma che dire di quegli
esseri viventi che non lo sono (o che noi presumiamo che non lo siano)? Così di
recente si è pensato di estendere ulteriormente il campo alla sfera animale, per lo
meno agli animali senzienti, cioè che provano dolore. Un atteggiamento etico in
questo caso si pone il problema di evitare o risparmiare sofferenze a tutti quei viventi
che le potrebbero avvertire.
c) etiche ambientali
Vi sono qui molte teorie e molti pensatori e pensatrici che varrebbe la pena citare, ma
su cui non ci possiamo soffermare. Diciamo in linea generale che esistono due
tendenze di fondo nel dibattito filosofico-ambientale, una che potremmo definire
antropocentrica e l’altra biocentrica. Nel primo caso, la preoccupazione
fondamentale dei pensatori ecologisti è quella di conservare e preservare il pianeta in
funzione dell’utilizzazione che ne fa la specie umana: l’uomo rimane al centro della
biosfera e della natura, si tratta solo di correggere e di modificare i suoi
comportamenti affinché non venga compromesso l’equilibrio naturale che gli
permette la sussistenza. L’altro punto di vista, quello biocentrico, mette viceversa in
discussione proprio il primato umano e la gerarchia che ne deriva: umani, animali,
piante, montagne, fiumi, ambienti, lo stesso intero pianeta, sono enti e soggetti
eticamente rilevanti, alla pari, senza alcuna priorità o superiorità. L’ecologia
profonda è una di queste teorie. Non posso non rilevare una contraddizione presente
in queste tesi, nonostante la loro originalità: colui che mette in discussione la propria
centralità è pur sempre il soggetto umano, che quindi, in ogni caso, rimane al centro
del discorso.
Vi sono poi altre teorie molto interessanti quali l’ecofemminismo, l’etica della terra,
l’ecologia sociale, l’ecoregionalismo che qui non abbiamo tempo di affrontare: per
un primo approccio rinvio al testo Pensare ambientalista a cura di Brian Schroeder e
Silvia Benso.
6.
Ci occuperemo infine dell’ambito bioetico più “ristretto”, quello cioè che riguarda più
da vicino la vita (e la morte) umana.
34
Il dibattito bioetico è in corso da anni e si sta misurando giorno per giorno con
questioni sempre nuove, anche in relazione ai continui rivolgimenti in campo medico
e biotecnologico. Anzi, si può dire che c’è un certo affanno e una certa rincorsa dietro
ai progressi scientifici, oltre a poca informazione e, soprattutto, pochissima
conoscenza appropriata delle varie questioni.
A grandi linee esistono due posizioni opposte che si fronteggiano (emerse anche in
America nel caso di Terri Schiavo):
a) la posizione cristiana e specialmente cattolica che fa della sacralità e
indisponibilità della vita il suo punto fermo
b) la posizione “laica” (con tutta l’ambiguità che questo termine ha ormai assunto)
della qualità della vita.
7.
Sulla prima posizione non c’è poi molto da dire. Essa si rifà alla morale e alla teologia
cristiana, secondo cui esisterebbe una natura umana fissa ed intangibile che va
conservata così come è stata creata da Dio.
Tesi a mio parere smentita dall’osservazione della stessa natura umana, che tutto è
tranne qualcosa di fisso ed immobile, anzi potremmo dire che se proprio una natura ed
un’essenza umana esistono (cosa di cui dubito), essa è proprio la sua continua
negazione: l’essere umano è cioè fondamentalmente quell’essere che rompe con la
circolarità e la ripetitività naturale-animale, e che crea conseguentemente un mondo
(umano e culturale) in perenne trasformazione. Così, ritenere che la famiglia, le
pratiche sessuali, i ruoli di genere, la stessa identità sessuale, ecc. siano dati una volta
per tutte, sarebbe come voler inchiodare l’uomo alla sua animalità, dimenticando che
tutte quelle sue caratteristiche sono i frutti della cultura e della storia. Non c’è una
sola cosa nella sfera biologica e fisiologica umana che non sia stata trasfigurata in
cultura, spirito, forma in divenire perenne, dal cibo all’atto sessuale, dalla nascita alla
morte. La separazione tra natura e cultura e i concetti stessi di natura e di natura
umana sono perciò, io credo, alquanto fuorvianti quando non pericolosi.
Questo non significa che la posizione religiosa sia anti-filosofica o irrazionale, visto
che utilizza argomenti derivanti dalla tradizione teologica e che fa comunque uso di
metodi razionali.
8.
Le etiche laiche si fondano invece sul concetto prettamente filosofico della qualità
della vita. Lo si può derivare ad esempio da Seneca, che lo utilizza come base
concettuale per condurre una vera e propria apologia del suicidio. Nella lettera 70
delle Lettere a Lucilio, intitolata proprio “Considerazioni sul suicidio”, egli scrive
infatti al suo discepolo: “La vita, come sai, non sempre merita di essere conservata.
Non è un bene il vivere, ma il vivere bene. Perciò il sapiente vivrà tutto il tempo che
ha il dovere di vivere, non tutto il tempo che può vivere. Vedrà lui dove dovrà vivere,
in quale società, in quali condizioni e in quali attività. Egli pensa sempre quale sarà la
vita, non quanto debba durare. Se gli si presentano molte disgrazie che turbano la sua
serenità, dà l’addio alla vita”.
Non si fraintenda: l’argomento estremo del suicidio (che comunque nel pensiero
stoico ha una sua logica e giustificazione filosofica e sociale), ci mostra chiaramente
come la concezione della vita che vi sta dietro, rifiuti di considerarla come un valore
in sé, e soprattutto come qualcosa di indisponibile, cioè donato all’uomo e derivato da
altri (la natura o Dio, poco importa), forze che avrebbero sull’individuo pretese più o
meno “padronali”. L’uomo diversamente non sarebbe più padrone della propria vita,
35
così come la donna della vita che le nasce in grembo – e le decisioni in proposito
avverrebbero al di fuori e persino contro i soggetti interessati.
Questo significa almeno due cose:
a) che è più importante l’elemento qualitativo di quello quantitativo, non è cioè
importante quanto (in più) si vive, ma come si vive;
b) che tutte le decisioni relative al bios umano e alla gestione del corpo, a proposito
di allungamento della vita, di riproduzione, di clonazione, di eutanasia – insomma
di vita e di morte, compresa l’eventualità estrema del suicidio, devono essere
riportate al principio della qualità e della dignità tutta terrestre e mondana del
vivere, senza intromissione alcuna di principi esterni. Ed è qui che il problema
della diversità etica si ripropone, dato che in questo modo non viene stabilito una
volta per tutte che cosa siano l’essenza umana, la vita buona, la dignità, ecc. – tutti
concetti e principi storicamente determinati e variabili in relazione alla diversità
dei tempi e dei luoghi dello sviluppo umano.
Non rimane a questo punto che rifarsi ad una opzione pluralistica, dialogica e fallibile
dell’etica – principii cui abbiamo accennato all’inizio della scorsa lezione.
9.
A tal proposito, il filosofo etico texano Engelhardt (conservatore e cattolico), ha
coniato per le società multietniche dei nostri tempi l’interessante termine di straniero
morale. Gli individui cioè che vivono nella stessa società, spesso hanno principi etici
diversi quando non addirittura incompatibili, a seconda delle tradizioni morali e
religiose cui si rifanno (musulmani, cattolici, laici, femministe, omosessuali, ecc.).
Affinché questo stato di “immoralità reciproca” non degeneri nell’incomunicabilità e
nella guerra aperta, è necessario trovare un terreno comune di dialogo, di intesa e di
riconoscimento reciproco. Poiché né Dio, né la ragione illuministica universale
riescono a produrre un accordo che non sia in realtà un’annessione derivata dalla forza
ed imposta con la violenza, l’unica autorità ammissibile è ormai quella che deriva dal
basso, dalla decisione degli individui di collaborare e di coesistere pacificamente da e
tra diversi.
10.
Come si vede sono tutti problemi aperti e complessi, che però vanno affrontati e,
almeno in parte, risolti. La riflessione etica – che assume un punto di vista
metamorale, che cioè analizza e discute dall’esterno i principi etici servendosi del
metodo razionale, per suo principio aperto, pubblico e democratico – ci può venire in
aiuto. Riassumendo, trovo fondamentale che si parta da alcuni principi di base senza i
quali non ci può essere alcuna risoluzione dei conflitti:
a) importanza della conoscenza
b) pluralità e dialogo reciproco
c) fallibilità e finitezza
d) giustizia e responsabilità
In particolare, su quest’ultimo punto, vorrei ricordare come ogni nostra scelta pratica
sia eticamente rilevante, e dunque richieda una assunzione individuale di
responsabilità, su almeno quattro fronti: nei confronti degli altri individui, degli altri
popoli, delle generazioni future, del pianeta tutto.
Qui la necessità di rifondare l’etica finisce per confluire nel discorso attualissimo
della ricostruzione di un agire politico nell’epoca globale, nella prospettiva di un
mondo più giusto e più libero per tutte e tutti.
Ma questa è materia per un altro corso…
(md, aprile 2005)
36
Bibliografia
La vastità dei temi affrontati ha naturalmente prodotto una bibliografia sterminata.
Qui darò solo alcune indicazioni a proposito di testi introduttivi e non troppo
specialistici. Chi poi volesse approfondire alcuni argomenti, troverà nei testi indicati
bibliografie che rinviano ad altri testi, e così via, all’infinito. Il sapere e la lettura
hanno questa straordinaria caratteristica del continuo rinvio ad altro oltre che della
circolarità.
Etica antica (lezioni 1-4)
Citerò qui alcuni testi introduttivi alla filosofia in generale e alla filosofia etica in
particolare.
Di Emanuele Severino, uno dei più importanti filosofi italiani contemporanei, sono
usciti tre volumi intitolati La filosofia antica, La filosofia moderna e La filosofia
contemporanea (Rizzoli, ultima ed. 2004), che sono delle buone introduzioni alla
storia della filosofia e che hanno il pregio di essere chiare e profonde al contempo.
Un’ottima introduzione alla filosofia con un taglio tematico anziché storico è quello di
Nigel Warburton, Il primo libro di filosofia, Einaudi. Sono sette le aree tematiche
scelte, tra cui c’è anche l’etica (II cap., “Giusto e sbagliato”).
Per quanto concerne l’etica antica, il miglior testo in circolazione è senz’altro quello
di Mario Vegetti, L’etica degli antichi, Laterza. Non è però un testo propedeutico e la
lettura non è facilissima. E’ stato tuttavia il testo che, per quanto concerne l’etica
antica, mi ha dato più spunti.
La miglior traduzione dell’Iliade è quella di Rosa Calzecchi Onesti, edizione Einaudi.
Recentemente Alessandro Baricco ha riscritto la vicenda della guerra di Troia nel
libro Omero, Iliade, Feltrinelli, che può essere una buona introduzione al mondo
omerico.
Per le tragedie greche esistono varie edizioni. Per il nostro discorso si raccomanda in
particolare la lettura di Edipo re e di Antigone (entrambe di Sofocle), di Medea e di
Ippolito (di Euripide).
La migliore fonte per conoscere Socrate, che com’è noto non ha scritto nulla, è
senz’altro Platone, che però spesso sovrappone al pensiero del maestro il proprio.
Esiste, edita da Laterza, una raccolta delle fonti e delle testimonianze intitolata
Socrate: tutte le testimonianze.
La lettura della Repubblica di Platone non è affatto impossibile anche per i neofiti.
Tanto più che la forma di scrittura scelta è quella dialogica, che per sua natura è
aperta, esplicativa, pubblica, discorsiva. Vi sono diverse edizioni, Laterza e Rizzoli le
migliori. Tuttavia il dialogo forse più bello di Platone è il Simposio dove viene narrata
la sua concezione dell’eros e della scala della conoscenza.
Anche l’Etica Nicomachea di Aristotele non è un testo impossibile da affrontare. Ne
esiste una buona versione in edizione Laterza.
Per quanto riguarda i Cinici, splendida la raccolta di frammenti curata da Luciano
Parinetto con il titolo Il vangelo dei cani in edizione Stampa Alternativa¸ purtroppo
difficile da trovare.
Sul pensiero stoico consiglio senz’altro le Lettere a Lucilio di Seneca, in edizione
Rizzoli, che, nonostante la lunghezza (2 volumi per 124 lettere), si lasciano leggere
visto che sono divise per argomenti, e possono essere selezionate a seconda degli
interessi.
37
Di Epicuro la famosissima Lettera a Meneceo (nota anche come Lettera sulla felicità,
un vero e proprio best seller nell’edizione Millelire di Stampalternativa di alcuni anni
fa), è reperibile anche nelle raccolte degli scritti epicurei, dove fra l’altro val la pena
leggere anche le Massime.
Etica moderna (lezioni 5-6)
Ahimé, leggere Kant per i non addetti ai lavori è un’impresa!
Sono molti i suoi scritti di argomento etico: Critica della ragione pratica, La
metafisica dei costumi, La fondazione della metafisica dei costumi, La religione entro
i limiti della sola ragione, opere edite tutte da Laterza. Ci si può provare, magari con
l’ausilio di qualche buona introduzione al pensiero kantiano: c’è ad esempio di S.
Landucci La critica della ragion pratica di Kant: introduzione alla lettura, Nuova
Italia; oppure una Guida alla lettura di F. Gomelli, Laterza; una Introduzione a Kant
di A. Guerra, sempre Laterza; o, più divulgativo, di Piattelli Palmarini il Ritrattino di
Kant ad uso di mio figlio, edito da Mondadori.
Gli autori inglesi sono in genere di più facile lettura (perché più chiari e meno
aggrovigliati) di quelli continentali.
Sulla fondazione dell’utilitarismo si può leggere l’Introduzione ai principi della
morale e della legislazione di Bentham (Utet, 1998), ma è preferibile leggere di J.S.
Mill il brillante On liberty (tradotto in italiano come Saggio sulla libertà, il Saggiatore
1981), breve opera di filosofia politica che vuole introdurre e giustificare dal punto di
vista dell’etica utilitaristica le libertà civili e individuali. Molto bello perché, con
grande preveggenza, Mill critica il rischio della massificazione ed esalta la libertà di
ricerca.
Interessante anche la Favola delle api di Mandeville (Laterza, 1987), dove si sostiene
che sono il vizio e l’egoismo individuale a generare la ricchezza ed il benessere
sociale.
Marx scrive insieme ad Engels L’ideologia tedesca (ed. Editori Riuniti 1972), opera
fondamentale per comprendere la loro concezione materialistica della storia, nonché i
concetti di ideologia, comunismo, divisione del lavoro, struttura, sovrastruttura, ecc. –
in sostanza i fondamenti stessi del pensiero marxista. Risulta un’opera un po’
complicata da leggere perché è un dialogo fitto e critico con i filosofi tedeschi
dell’epoca (Feuerbach, Stirner, Bauer), di cui occorrerebbe conoscere le teorie.
Per La genealogia della morale di Nietzsche (come tutte le opere tradotte in italiano,
edizione Adelphi), vale la raccomandazione generale per chi affronta questo
pensatore: trattandosi di uno scrittore straordinario che fa spesso uso di metafore,
immagini, allegorie, ecc., può essere facilmente frainteso. Basti pensare al concetto di
superuomo e alla sua (fuorviante) lettura “nazista”. In questo testo tardo scritto nel
1887, egli affonta i temi della morale cristiana, della cattiva coscienza e
dell’ascetismo, criticandone radicalmente i fondamenti.
L’etica e la guerra (lezione 7)
Sulla guerra in generale:
-G. Bouthoul, Le guerre. Elementi di polemologia, Longanesi 1982
E’ forse il testo di più ampio respiro sulla guerra che sia stato scritto, dato che l’autore
è colui che ha fondato nel secondo dopoguerra in Francia la “polemologia” da
38
intendersi come scienza umana rigorosa. Forse un po’ datato per l’impostazione
troppo positivistica, ma comunque interessante per la vastità dei punti di vista sul
fenomeno guerra (teorico, tecnico, economico, psicologico, demografico, ecc.).
-C. Von Clausewitz, Della guerra, Einaudi 2000
Classico della guerra moderna, scritto da un generale prussiano (che quindi se ne
intendeva). Il tentativo è quello di spiegare razionalmente la guerra, specie in
relazione ai suoi scopi politici (da cui il famoso motto “la guerra è la continuazione
della politica con altri mezzi”).
Per apprezzare la potenza rappresentativa (ed antimilitarista) delle acqueforti del ciclo
I disastri della guerra del pittore spagnolo Francisco Goya, bisognerebbe poterle
visionare dal vivo, nei musei o ad una mostra. Tuttavia, nelle varie monografie
sull’artista c’è sempre una sezione che riproduce qualcuna di queste straordinarie
incisioni. Molto interessante, sia per il numero di riproduzioni che per la trattazione,
di A. De Paz, La ragione e i mostri, Liguori Editore.
Sui filosofi e la guerra:
-S. Cotta, Dalla guerra alla pace, Rusconi 1989
Interessante, anche se un po’ sbrigativo nell’analisi. La tesi di fondo è che nella gran
parte i filosofi, da Eraclito a Nietzsche, hanno pensato alla guerra come
“fondamento” e alla pace come un “residuo”, ciò che resta quando non c’è guerra.
L’autore si propone di rovesciare questa tesi, dimostrando la priorità antropologica del
momento dialogico su quello conflittuale.
-U. Curi, Polemos. Filosofia come guerra, Bollati Boringhieri
Qui polemos è da intendersi come vis polemica, anima interna del confronto, che è
anzi uno scontro, tra idee filosofiche diverse. La linea della belligeranza attraversa
infatti dall’interno lo stesso pensiero occidentale. Un testo difficile e molto “tecnico”,
per chi ha già una solida formazione filosofica.
-E. Severino, La guerra, Rizzoli
Il noto filosofo italiano pensa che la “guerra” sia un aspetto essenziale del modo
occidentale di intendere le cose, il divenire, il nostro rapporto con la natura, ecc.: se si
pensa cioè che le cose divengono, nascono e muoiono, escono e tornano nel nulla, la
guerra non può essere che una conseguenza logica di questa struttura profonda del
pensiero occidentale.
M. Walzer, Guerre giuste e ingiuste, Liguori Editore 1990
Un discorso morale, con esemplificazioni storiche, sulla guerra: dalla guerra
preventiva (oggi di grande attualità) alla responsabilità nei confronti dei civili, dai
crimini di guerra alle varie convenzioni che regolano i combattimenti. Piuttosto
interessante, specie per i molti riferimenti a fatti cruciali del passato più o meno
lontano. Nel 2004 Laterza ha pubblicato Sulla guerra, dove Walzer, alla luce di
quanto accaduto nell’ultimo decennio, aggiorna la sua analisi, chiedendosi se vi sia la
possibilità di fondare una teoria morale della guerra giusta.
E’ impossibile citare i passi o i testi dove i filosofi parlano di guerra o (molto meno)
di pace. Mi limito qui ad una breve rassegna dei riferimenti che mi sono sembrati più
significativi:
Eraclito, Fuoco non fuoco, Mimesis 1992 o in altre raccolte sui Presocratici (Laterza)
raccolte in cui si può anche dare uno sguardo ad altri filosofi-cosmologi del conflitto,
quali Anassimandro o Empedocle.
39
Ovviament se si vuole approfondire l’argomento della concezione greca della guerra
si devono affrontare i testi classici dell’Iliade, delle Guerre persiane di Erodoto e
della Guerra del Peloponneso di Tucidide.
La prima immagine del “saggio” antimilitarista si trova sicuramente nei filosofi cinici
(si veda il già citato Vangelo dei cani).
Molto difficile dare indicazioni bibliografiche su Nietzsche e la guerra. Forse un’idea
la si potrebbe avere ne La volontà di potenza, che però è una raccolta in parte costruita
ad arte a cura della sorella di una serie di frammenti postumi. Il nucleo del pensiero di
Nietzsche e la sua visione conflittuale (e “darwiniana”) del mondo ci vengono
comunque resi in modo molto chiaro.
Per gli aspetti politici o politico-filosofici:
N. Machiavelli, Dell’arte della guerra, in Tutte le opere, Sansoni
Hobbes, Leviatano, Laterza, specie i capitoli XIII-XVII, sulla natura umana, la guerra
di tutti contro tutti e la costituzione dello stato.
Negli Scritti politici di Rousseau (varie edizioni) si trovano i cosiddetti “Scritti
sull’abate di Saint-Pierre”, con l’Estratto del progetto di pace perpetua dell’abate, i
commenti e le critiche di Rousseau e la sua concezione della guerra.
Il celebre Per la pace perpetua, progetto di Immanuel Kant si trova in edizione
Rizzoli oppure nella raccolta, edita da Laterza, Scritti di storia, politica e diritto.
Breve ma efficace la voce “Guerra” del Dizionario filosofico di Voltaire.
Per una rassegna generale del pensiero politico intorno alla guerra e alla pace degli
ultimi due secoli si veda di L. Bonanate, Guerra e pace, Franco Angeli 1994.
Per una prospettiva che contempli il conflitto come pratica nonviolenta di
superamento delle ingiustizie e delle disuguaglianze si veda A. Cozzo, Conflittualità
nonviolenta. Filosofia e pratiche di lotta comunicativa, Mimesis 2004. Il testo, che ha
l’ambizione di fondare la nonviolenza su basi logiche rigorose, ha anche il pregio di
rifarsi al pensiero orientale.
Su biologia, psicologia e guerra:
una buona raccolta antologica a cura di Nicole Janigro è La guerra moderna come
malattia della civiltà, Bruno Mondadori 2002, con testi di Freud, Jung, Fromm, ecc.
Sulle analisi “etologiche” della guerra e sui suoi eventuali fondamenti biologici o
naturali si vedano:
K. Lorenz, L’aggressività, Saggiatore 2000
I. Eibl-Eibesfeldt, Etologia della guerra, Bollati Boringhieri 1999, dove si trovano le
tesi, molto interessanti, sulla differenziazione culturale come riflesso della speciazione
e sul diritto naturale e animale alla fuga dai territori di guerra.
Sugli aspetti più specificamente psicologici o psicanalitici:
F. Fornari, Psicoanalisi della guerra, Feltrinelli
E. Fromm, Anatomia della distruttività umana, Mondadori
Un punto di vista più specificamente sociologico, e “realista”, ai limiti del
pessimismo, è quello di W. Sofsky, Saggio sulla violenza, Einaudi.
Infine, sulla guerra globale:
sulle guerre recenti (giuste, umanitarie, infinite, preventive, e via delirando), molto è
stato scritto. Spesso si tratta di “instant book”, di pamphlet dal valore limitato a una o
due stagioni. Nella confusione, si è voluto scegliere solo alcuni testi che, a prescindere
dalla loro condivisibilità, hanno il pregio dello spessore teorico, dello sforzo di
“pensare” la guerra senza limitarsi a condannarla in modo frettoloso e moralistico.
40
Un testo, breve ma intenso, di grande respiro teoretico è senz’altro
C. Galli, La guerra globale, Laterza 2002, che analizza la trasformazione della guerra
da conflitto interstatale a conflitto globale in relazione ai cambiamenti politici,
economici, spazio-temporali, antropologici dovuti alla globalizzazione neoliberista.
Un’analisi di ampio respiro sulle forme del “politico” e della sovranità nel mondo
globale, e dunque anche della guerra, si trova in
M. Hardt, A. Negri, Impero, Rizzoli 2002
seguito recentemente da
A. Negri, Guide. Cinque lezioni su impero e dintorni, Cortina 2003
Da segnalare inoltre:
A. Asor Rosa, La guerra, Einaudi, una raccolta di riflessioni intorno alle tre forme di
guerra dell’ultimo decennio (“giusta”, in Irak 1991; “umanitaria”, in Kossovo 1999;
“preventiva”, dalle Torri in poi).
Segnalo infine uno dei più straordinari romanzi sulla guerra che siano mai stati scritti,
e cioè La vita e il tempo di Michael K., dello scrittore sudafricano J.M. Coetzee,
pubblicato da Einaudi, storia di un moderno “buon selvaggio”, anima pura e imbelle
“idiota” in fuga da guerre, campi e filo spinato entro i quali il potere lo vorrebbe
recludere. Michael K. è il vero “eroe” antimilitarista dei nostri tempi.
La bioetica (lezione 8)
Innanzitutto, le Edizioni Unicopli hanno recentemente pubblicato un libretto curato da
Giuseppe Deiana con una bibliografia ragionata proprio sulla bioetica. La bibliografia
è divisa in aree tematiche, dalle introduzioni generali ai problemi etici e bioetici, ai
manuali specialistici, a testi che affrontano problemi particolari (eutanasia,
fecondazione artificiale, biotecnologie, medicina e salute).
Do qui alcune indicazioni sparse di testi interessanti su scienza e tecnica, biologia e
biotecnologie, etica e ambiente, bioetica in senso stretto:
-F. Bacone, La Nuova Atlantide, Tea 1991. E’ una visionaria utopia tecnologica quella
che qui ci viene descritta, un vero e proprio “paradiso tecnico” reso possibile dai
progressi della scienza. Vengono persino immaginate, con quattrocento anni di
anticipo, le attuali biotecnologie!
-S. Rose, Linee di vita, Garzanti 2001. Una critica netta, fatta da un biologo, al
determinismo e al riduzionismo imperanti nella scienza moderna. La vita è complessa
e non è mai riducibile alle sue particelle elementari, DNA o geni che siano (cosa
invece sostenuta da un altro biologo, Richard Dawkins, noto per Il gene egoista,
Mondadori).
-E. Fox Keller, Il secolo del gene, Garzanti 2001. Viene ripercorsa l’entusiasmante
quanto discutibile vicenda delle genetica lungo tutto il ‘900, decostruendo
criticamente il concetto di gene (che, a parere dell’autrice, è appunto un concetto, non
un dato reale).
-H. Jonas, Sull’orlo dell’abisso, Einaudi 2000. Una raccolta di interventi, in forma di
dialogo-intervista, di uno dei massimi filosofi del secolo scorso, sul tema del rapporto
uomo-natura. Si va dalla questione della crisi ecologica allo spinoso problema
dell’eutanasia, dalla clonazione alla responsabilità della ricerca scientifica.
-B. Schroeder, S. Benso, Pensare ambientalista, Paravia 2000. Una panoramica del
pensiero ecofilosofico, dall’etica della terra all’ecologia sociale, passando per
41
l’ecofemminismo e l’ecologia profonda; segue un’antologia di testi delle posizioni e
degli autori più significativi.
-E. Tiezzi, Fermare il tempo, Cortina 1996. Come recita il sottotitolo, si tratta di
“un’interpretazione estetico-scientifica della natura”, contravvenendo così alla rigida
separazione dei campi conoscitivi. Vengono passati in rassegna, in modo brillante e
comprensibile, alcuni grandi nodi scientifico-filosofici (l’entropia, il tempo,
l’evoluzione biologica) legandoli strettamente alle tesi etiche dello sviluppo
sostenibile.
-V. Shiva, Monocolture della mente, Bollati Boringhieri 2000. Una difesa
appassionata della biodiversità e delle esperienze indigene e delle donne contro la
cosiddetta biopirateria e lo strapotere delle multinazionali. Una riflessione
imprescindibile sui problemi etici e ambientali derivanti dall’imposizione globale del
modello di sviluppo (o di malsviluppo) occidentale.
-Philippe Lettellier è il curatore della raccolta L’eutanasia. Aspetti etici e umani, testo
edito da Sapere 2000 nel 2004, con il patrocinio dell’Unione europea: si tratta di una
serie di interventi con pareri diversi sull’argomento, da parte di medici, filosofi,
giuristi, teologi. Nel 2005 è uscito il secondo volume, L’eutanasia. Diritto e prassi in
Italia, Europa e Stati Uniti, che si occupa degli aspetti pratici e giuridici.
-E. Mazzarella, Sacralità e vita. Quale etica per la bioetica?, Guida 1998. Agile
volumetto che affronta senza pregiudizi la contrapposizione tra paradigma cattolico
della “sacralità della vita” e paradigma laico della “qualità della vita”.
Alcuni testi interessanti sulle biotecnologie:
J. Rifkin, Il secolo biotech, Baldini & Castoldi 2000
Bazzi, Vezzoni, Biotecnologie della vita quotidiana, Laterza 2000
M. Buiatti, Le biotecnologie. L’ingegneria genetica fra biologia, etica e mercato, il
Mulino 2001
Infine, alcuni testi introduttivi alla filosofia etica in generale:
P. Donatelli, La filosofia morale, Laterza 2001
S. Cremaschi, L’etica del novecento, Carocci 2004
D. Neri, Filosofia morale. Manuale introduttivo, Guerini 1999
J. Russ, L’etica contemporanea, il Mulino 1997
m.d.
42