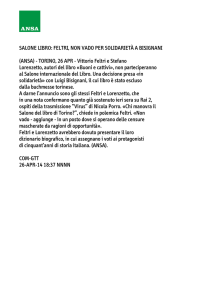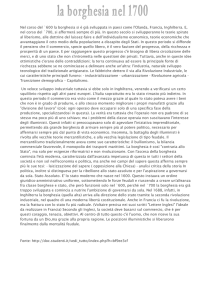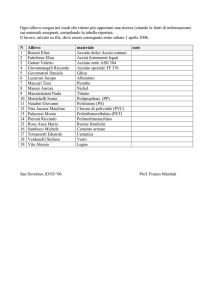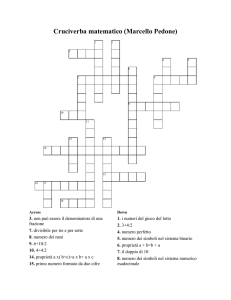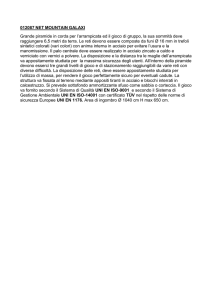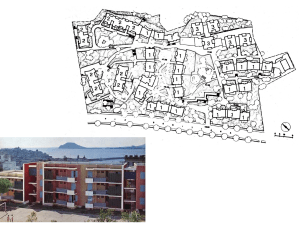unità
8
Politica e società
tra Ottocento e Novecento
Riferimenti storiografici
1
Nel riquadro una veduta di Berlino nel 1905. Il numero degli abitanti
della capitale tedesca crebbe notevolmente tra la fine del XIX e l’inizio del
XX secolo.
Sommario
1
2
3
4
5
L’espansione dell’industria tedesca
I ceti medi in Germania all’inizio del
Novecento
La nascita dei grandi magazzini
Il pensiero di Michail Bakunin
Le incoerenze della borghesia
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
6
7
8
9
Da Sedan alla Comune
Destra e Sinistra nel sistema liberale
italiano
Stato e classi lavoratrici negli anni
Sessanta
La fuga dall’Italia meridionale
1
L’espansione dell’industria tedesca
UNITÀ 8
Nei decenni immediatamente seguenti l’unificazione nazionale, l’impero tedesco divenne una potenza economica di eccezionale livello, capace di produrre più acciaio dell’Inghilterra e di esportare i propri manufatti in tutto il mondo. In alcuni
settori, inoltre, si crearono dei complessi giganteschi, che non
avevano rivali neppure negli Stati Uniti.
POLITICA E SOCIETÀ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
2
Stimolata da una domanda crescente e accelerata da
una ricerca di vaste proporzioni, cominciò una seconda
rivoluzione industriale. Se la prima ondata dell’industrializzazione aveva fatto per un secolo dell’Inghilterra l’officina del mondo, dal periodo a cavallo dei due secoli furono la Germania e gli Stati Uniti ad assumere la guida
in settori chiave dell’industria del futuro. Massima importanza assunsero l’acciaio, la chimica dei colori e delle
materie sintetiche e l’industria elettrica. Quest’ultima, in
rapido sviluppo, fu quella che, con l’illuminazione elettrica
ed il telefono, il ferro da stiro e le ferrovie, trasformò nel
modo più deciso la vita quotidiana degli uomini. Dal
1860 al 1913 il prezzo dell’acciaio calò dell’80-90%. Il ribasso fu accelerato soprattutto a partire dall’applicazione
del procedimento Gilchrist-Thomas per la produzione di
acciaio basico ad un procedimento Bessemer migliorato,
applicazione introdotta su vasta scala a partire dal 1880.
Dalle 125 000 tonnellate prodotte dagli europei continentali nel 1861, la produzione raggiunse le circa 32 milioni di tonnellate del 1913. L’acciaio, ancora nella prima
metà del diciannovesimo secolo una materia prima scarsamente diffusa ed estremamente costosa, sostituì il
ferro fucinato. Il vecchio vantaggio dei britannici, basato
sul fatto di avere sotto i loro piedi dei buoni minerali ferrosi a basso contenuto fosforico, trattabili sulla base del
procedimento Siemens-Martin, venne annullato. Il perfezionamento del procedimento Bessemer permise alle
acciaierie tedesche di trattare i minerali ferrosi della Lorena, la cui produzione era stata fino a quel momento
quasi non redditizia, e i pressoché inesauribili giacimenti
della Svezia. I tedeschi sfruttarono così il vantaggio di chi
arriva tardi: cominciarono in modo sistematicamente
scientifico, evitarono di percorrere strade più lunghe,
concentrarono i loro impianti e puntarono, per poter resistere all’iniziale posizione di superiorità dei britannici,
sulla razionalizzazione e la concentrazione.
Già negli anni a cavallo dei due secoli le acciaierie tedesche erano diventate decisamente più grandi e più
moderne di quelle britanniche. […] Grazie ad un migliore
impiego del capitale e alla razionalizzazione sistematica,
alla vigilia della guerra mondiale la capacità di produzione annuale di un metalmeccanico [un impianto, n.d.r.]
della Ruhr o della Slesia aveva raggiunto le 77 tonnellate,
mentre in Inghilterra era rimasta al di sotto delle 50. I tedeschi ne ottennero crescenti vantaggi in termini di
prezzi di mercato. Alla vigilia della guerra, i produttori di
acciaio di Essen erano in grado di vendere a prezzi del
20-25% inferiori a quelli dei loro concorrenti di Clyde. Già
nel 1893 i tedeschi producevano più acciaio degli inglesi. Nel 1903 i tedeschi si attestarono al primo posto
anche nella produzione di ghisa. Per un lungo periodo
la costruzione delle industrie metallurgiche aveva assorbito gran parte della produzione tedesca ed americana. Ma a partire dagli anni a cavallo dei due secoli entrambe le nazioni si spinsero sul mercato mondiale. Già
nel 1910 i tedeschi esportavano più ferro ed acciaio degli inglesi. E i produttori d’acciaio dell’isola dovettero accorgersi a loro spese che ormai l’acciaio d’esportazione tedesco della migliore qualità era in grado di
contrastarli con successo anche sul mercato di casa.
L’industria chimica, facente parte di uno dei settori più
vecchi dell’industrializzazione, negli anni a cavallo dei
due secoli conobbe innovazioni in molti ambiti e fu convertita per la produzione in massa. Dal 1866 era possibile
produrre a buon mercato e su vasta scala l’alluminio – per
molto tempo un metallo scarseggiante – ricavandolo
dalla bauxite. Gli acciai legati [tipi particolari di acciaio, in
cui la lega ferro e carbonio è arricchita da una o più ulteriori sostanze, n.d.r.] si conquistarono dei mercati specifici. Il mercato si espandeva ovunque – nel campo della
produzione di cemento, in quello delle vernici, in quello
della gomma e nell’industria ceramica – anche se quelli
che sarebbero stati i più notevoli settori di applicazione del
cemento e della gomma erano ancora di là da venire. I risultati più importanti furono ottenuti dal procedimento
Solvay per la produzione della soda ammoniacale e dai
progressi della chimica organica nella produzione di nuovi
materiali. […] Un esempio di come la produzione e la domanda potessero trasformarsi è offerto dall’acido solforico, che veniva utilizzato in molti processi. Ancora negli
anni a cavallo dei due secoli gli inglesi erano alla guida di
questo settore. Ma solo dieci anni più tardi la produzione
tedesca era ormai circa due volte superiore a quella inglese. Nel campo dei colori all’anilina le aziende tedesche
– soprattutto BASF, Hoechst e Agfa – avevano raggiunto
una posizione di dominio sul mercato mondiale già intorno al 1870; intorno al 1900 circa il 90% di tutti i coloranti sintetici erano di produzione tedesca. L’industria
chimica controllava anche la maggior parte delle ditte affiliate all’estero. In Francia, alla vigilia della guerra, solo una
fabbrica di coloranti era in mano ai francesi, mentre sei
erano in mano ai tedeschi e due agli svizzeri. […]
L’Inghilterra aveva cominciato come l’officina del
mondo; un secolo più tardi, i tedeschi erano in procinto
di diventarne la fabbrica. Un puro raffronto numerico a livello di produzione ed esportazione fra Inghilterra e Germania non rispecchia la situazione reale: era infatti soprattutto nelle industrie più antiche che l’Inghilterra
manteneva la sua forza. Nella grande chimica e nell’elettrotecnica, le industrie scientifico-tecniche del futuro, che
avevano cominciato a caratterizzare il volto della civilizzazione industriale moderna, i britannici erano decisamente distaccati, e per un lungo periodo gli stessi americani furono soltanto il numero due o il numero tre.
M. STÜRMER, L’impero inquieto. La Germania dal 1866 al 1918,
il Mulino, Bologna 1993, pp. 417-421, trad. it. A. ROVERI
Individua i principali dati e indicatori che dimostrano la crescente supremazia tedesca sull’Inghilterra, nella produzione di
acciaio.
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
Lo sviluppo dell’industria e dell’economia tedesche, verso
la fine dell’Ottocento, provocò anche malcontento e preoccupazione. Mentre gli artigiani non reggevano la concorrenza della produzione in serie, i piccoli artigiani osteggiarono la nascita delle prime catene di grandi magazzini.
Nel 1890 la Germania era ormai la massima potenza industriale d’Europa. Ma i successi dell’industrializzazione tendevano a occultare [nascondere, mascherare, n.d.r.] il fatto che esistevano in realtà due
Germanie: a far da sfondo all’impetuoso fiorire delle
fabbriche della Ruhr o della Sassonia c’era un mondo di
piccoli agricoltori e di piccole città che ancora nel 1914
rappresentava il 40 per cento della popolazione tedesca
(la corrispondente cifra inglese era l’8 per cento). Le
grandi città tedesche presentavano uno schieramento
politico abbastanza simile a quello delle altre città europee: liberali di destra, liberali di sinistra, cattolici, socialisti. Ma l’intero schema era complicato da una dimensione agraria, la quale aveva a sua volta una componente di artigiani indipendenti. Intorno al 1900 il dibattito politico tedesco era dominato dalla questione del
Mittelstand [classe media, ceti medi, n.d.r.]. […]
Mittelstand non significava «borghesia». Il termine
designava piuttosto quel mondo di agricoltori e artigiani
indipendenti che stava tra il vecchio proprietario terriero
e i suoi contadini. Sotto più di un profilo, il Mittelstand era
la gloria della Germania settentrionale, come lo era della
maggioranza delle civiltà protestanti. […] Finché le cose
andarono bene, il liberalismo tedesco ricevé i voti del Mittelstand protestante. Ma già negli anni Novanta questa
fedeltà cominciò a incrinarsi. La Germania del Mittelstand
aveva molto di cui dolersi, e nei primi anni Trenta del nostro secolo [il Novecento, n.d.r.] avrebbe fornito a Hitler
quella ch’era di gran lunga la sua principale base d’appoggio. Gli inizi di questo processo, e la conseguente
dissoluzione del liberalismo tedesco, possono esser fatti
risalire al penultimo decennio dell’Ottocento.
Gli aspetti agrari del fenomeno erano abbastanza
chiari. Il declino dei prezzi alimentari raggiunse la Germania malgrado le tariffe [la legislazione protezionistica finalizzata a limitare l’importazione di prodotti agricoli stranieri, n.d.r.]. Ebbe luogo un’imponente fuga dalla terra, col
risultato di far lievitare i salari. I primi anni Novanta videro
il momento peggiore della «Grande Depressione», e gli
agricoltori – protestanti e cattolici – gridarono con violenza
le loro rimostranze. Ciascuno tentò di far fronte alla caduta
dei prezzi accrescendo la produzione, col risultato che i
prezzi scesero ulteriormente. Contemporaneamente, dal
lavoro di chimici ingegnosi stavano uscendo surrogati [sostituti, di peggiore qualità, ma meno costosi, n.d.r.] di alcuni beni agricoli. Spuntarono la «saccarina» e la «margarina». Furono inventate macchine per «vendere»
bottiglie di birra nelle stazioni ferroviarie, e i birrai e gli osti
locali videro minacciati i loro affari. […]
Spiega l’espressione secondo cui esistevano «due Germanie».
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
Questi ceti denunciarono il «manchesterismo», ossia la
dottrina liberale [liberista, n.d.r.] secondo la quale i prezzi
sia delle merci che del lavoro dovevano scendere o salire
sino a raggiungere i loro naturali livelli di mercato, senza riguardo per i danni che tale processo poteva provocare. Gli
agricoltori volevano protezione, e moltissimi di loro si spingevano oltre: volevano che lo Stato garantisse credito a
basso tasso d’interesse, e addirittura un mercato. C’era
anche un vivace risentimento antiebraico. Si pensava che
gli ebrei approfittassero dei mali dell’agricoltura. […] Agli
occhi di molti era il liberalismo tedesco nella sua totalità ad
apparire come «ebraico». Negli anni Ottanta parecchi dei
suoi uomini più in vista – tra cui Lasker, Bamberger e Richter – erano ebrei o mezzi ebrei, o avevano mogli ebree.
I radicali Freisinn [gruppo parlamentare di orientamento
progressista, n.d.r.] di Berlino avevano la loro più forte base
d’appoggio nella comunità ebraica. Più di ogni altro
gruppo, gli ebrei sembravano trarre vantaggio dalle novità
moderne che si affermavano in Germania. In Prussia, su
100 000 maschi protestanti 58 completavano un ciclo d’istruzione superiore. Per i cattolici la cifra scendeva a 33,
ma per gli ebrei saliva a 519.
Né erano soltanto gli agricoltori a protestare. Anche il
vecchio mondo artigiano – carradori [riparatori di carri,
n.d.r.], calzolai, sarti, piccoli fonditori, lavoranti tessili a domicilio e simili – si trovava a fare i conti con la concorrenza
delle merci prodotte in fabbrica, sia estere che nazionali.
La nascita nelle città dei grandi magazzini – per esempio
la catena Tietz, che cominciò con un bottegaio ebreo di
Rostock, e si allargò in una rete di empori che copriva l’intero paese – provocò la protesta dei piccoli esercenti:
spiazzati sul lato dei prezzi, si trovavano costretti a giornate lavorative lunghissime. Anche qui faceva capolino
l’antisemitismo, questo «socialismo degli imbecilli», secondo la definizione datane da un austriaco. […]
Nel 1893 nacque una «lega degli agricoltori» (Bund der
Landwirte), che si diede rapidamente un’organizzazione di
massa, con una propria stampa. Essa chiese, per esempio, che si desse alla margarina un bruttissimo color genziana (il colore del battiscopa del Reichstag), allo scopo di
respingere il consumatore. Non solo, ma alla margarina doveva anche esser imposto l’orribile nome di Oeltalg («olio
di sego»). Fu proposta la messa al bando delle macchine
per la vendita automatica nelle stazioni ferroviarie, e nel
Wuertemberg fu attuata. Tutto ciò andava insieme con una
seriosa solennità ch’era tipicamente tedesca. Il manifesto
elettorale redatto dal Bund nel 1893 recitava: «Una lenta
ma regolare ascesa del prezzo del grano è stata il contrassegno di tutte le grandi civiltà». I grandi magazzini venivano liquidati come un Unwesen (una «mostruosità»).
L’attacco si appuntava poi sull’emancipazione femminile,
sugli ebrei e su altri analoghi bersagli.
N. STONE, La grande Europa 1878-1919, Laterza, Roma-Bari
1976, pp. 177-181, trad. it. G. FERRARA
UNITÀ 8
I ceti medi in Germania all’inizio
del Novecento
3
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
2
3
La nascita dei grandi magazzini
UNITÀ 8
I conservatori di tutti i Paesi guardarono con orrore e disprezzo ai nuovi grandi magazzini che stavano nascendo nelle metropoli dell’Europa di fine dell’Ottocento e negli Stati Uniti. Di solito, l’accento cadeva sul fascino che avrebbero esercitato le merci esposte: come il frutto proibito dell’Eden, sarebbero
state per le donne una tentazione irresistibile. Le famiglie sarebbero andate in rovina, e con esse la società intera.
POLITICA E SOCIETÀ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
4
«Carrie passò attraverso i reparti affollati, impressionata dalle mostre di chincaglieria, abiti, cartolerie e
gioielli. Ogni banco costituiva una prepotente attrazione
di per sé. Non poteva fare a meno di sentire il richiamo
d’ogni gingillo che le cadeva sotto gli occhi, eppure
non rallentò, né si fermò. Non c’era nulla che non
avrebbe potuto usare, nulla che non avrebbe desiderato
da tempo di possedere. Eleganti pantofole, calze, gonne
increspate e bluse e giacchette, merletti, nastri, pettini,
borsette; ogni cosa le risvegliava dei desideri, anche se
poi doveva riconoscere che nessuno avrebbe potuto essere compatibile con quello che aveva nella borsa».
Quante volte abbiamo provato le stesse sensazioni
dell’eroina del romanzo di Theodor Dreiser, Carrie Meeber,
che arriva nella Chicago del 1890 dalla provincia e gira alla
ricerca di un lavoro nella megalopoli percorsa da una frenetica attività. […] «Centinaia di negozi riuniti in uno solo»:
è questo il pensiero che domina la mente di Carrie di fronte
alla visione del grande magazzino. In effetti la caratteristica
del grande magazzino consisteva e consiste nella sua organizzazione in reparti specializzati, nella varietà dell’offerta
merceologica e nella possibilità di poter operare con margini di guadagno inferiori sfruttando invece le opportunità
di utili offerte dalla maggior dimensione delle vendite. L’evoluzione verso il grande magazzino fu relativamente rapida. Pionieri in questo cammino furono la Francia e gli
Stati Uniti, che ancor oggi si contendono il merito dell’invenzione. I francesi naturalmente sostengono che il trofeo
spetta a Ristide Boucicaut che nel 1852 entrò in società
con Jean Videau nella gestione del Bon Marché [il primo
dei grandi magazzini francesi, sorto a Parigi nel 1838,
n.d.r.] […]. Boucicaut modificò il sistema di vendita in maniera radicale. Applicò il principio del basso ricarico alle
merci, rese visibili i prezzi delle merci, rese libero l’ingresso
senza obbligo di acquisto e accettò la restituzione delle
merci da parte dei clienti insoddisfatti. Non si può dire che
fosse l’inventore di ciascuno di questi aspetti, ma seppe
metterli in relazione trasformando l’impresa commerciale.
La fama di Boucicaut era elevata anche presso i contemporanei. Lo dimostra il fatto che David Lewis in visita
a Parigi rimase così impressionato dal magazzino e dalla
reputazione del francese da chiamare con lo stesso nome
un esercizio commerciale aperto a Liverpool.
Non fu certo un caso se lo sviluppo del grande magazzino ebbe inizio nel campo dei tessuti e dell’abbigliamento. In questo settore la possibilità di aumentare
l’offerta abbassando i prezzi erano maggiori. Solo in seguito altre branche industriali poterono raggiungere gli
stessi standard produttivi. Di conseguenza mutò anche
la natura del grande magazzino che si arricchì di nuovi
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
reparti moltiplicando e variando l’offerta di merci. Se nel
1852 i reparti in cui era diviso il Bon Marché erano
quattro, nel 1882 erano diventati trentasei. Tra il 1870 e
il 1880 la varietà merceologica degli oggetti esposti aumentò vertiginosamente, accanto ai reparti di tessuti e
abbigliamento si aggiunsero sezioni per la vendita di mobili, profumi, argenteria, calzature e perfino oggetti da
camping. Negli Stati Uniti nel 1877 Macy poteva offrire
ai suoi clienti una vasta gamma di prodotti che andava
dall’arredamento ai giocattoli, dai dolci alle scarpe. […]
La diffusione della grande distribuzione restò per
lungo tempo un fenomeno marginale nel panorama italiano in cui ancora nel 1938 il piccolo negozio occupava
il 91% del mercato contro il 57% degli USA e il 66% della
Gran Bretagna. In Germania la prima impresa che si avvicinava al grande magazzino fu fondata a Stralsund da
Georg Wertheim nel 1876 e fu presto imitata da altri imprenditori come Leonhard Tietz nel 1879 e Karstadt a Wismer nel 1881. Inizialmente si trattò di imprese che, ad
eccezione del magazzino Messow & Waldschmidt di
Dresda, nascevano in centri medi o piccoli, solo in seguito
questo genere di impresa si diffuse nelle grandi aree urbane. Wertheim aprì il suo famoso magazzino a Berlino
nel 1885 e Tietz ne aprì uno a Monaco nel 1889. […]
Non si pensi però che l’evoluzione verso il grande
magazzino non incontrasse resistenze. Quando Abraham
e Strauss aprirono un reparto di drogheria nel loro magazzino di Brooklyn i negozianti della zona inscenarono
una manifestazione di protesta. I grandi magazzini, definiti come mostri onnivori, furono accusati di distruggere il
piccolo commerciante e di produrre una dipendenza da
centri di potere economico che nel tempo si sarebbe trasformata in una sorta di tirannia. Di fronte alla crisi economica degli anni Novanta vari stati introdussero tasse
sulla «piovra che ha disteso i suoi tentacoli in ogni direzione». Tuttavia i tentativi dei piccoli commercianti di fissare
limiti legislativi all’espansione della grande distribuzione,
non raggiunsero l’obiettivo. Leggi restrittive furono bocciate da alcuni stati e la corte suprema del Missouri giudicò incostituzionale una legge a tutela del piccolo commercio che era stata approvata. Nel 1901 la Industrial
Commission federale assolse infine i grandi magazzini
dalle accuse di monopolio difendendo la loro presenza
come un vantaggio per il consumo della gente. […]
S. CAVAZZA, Dimensione massa. Individui, folle, consumi
1830-1945, il Mulino, Bologna 2004, pp. 161-166, 174-179
Quali novità (assolute per l’epoca, ovvie e familiari ai
nostri giorni) introdusse Ristide Boucicaut nella tecnica
commerciale?
Quale settore produttivo adottò per primo la tecnica di
vendita che aprì la strada al grande magazzino? Per quali
ragioni?
Per quali ragioni i grandi magazzini furono chiamati
«mostri onnivori»? Quale orientamento politico li odiò in
modo speciale?
Appassionato sostenitore della libertà umana, Bakunin si opponeva alla religione, allo stato e alla proprietà privata. Nello stesso tempo, accusava anche il marxismo di essere un pericolo per
la libertà: ai suoi occhi, una dittatura del proletariato non era in
fondo molto diversa dalla tirannia dei nobili e dei borghesi.
Il cardine intorno al quale ruotano tutte le idee del
Bakunin è il concetto di libertà; basta seguirne, nei suoi
scritti, lo svolgimento, per portare alla luce il nucleo sostanziale del suo pensiero. La libertà deve regolare i rapporti tra le nazioni, come i rapporti tra la nazione e le sue
singole parti; dev’essere base di esistenza per ogni individuo; egli [= Bakunin – n.d.r.] è «un amante fanatico
della libertà» perché la considera «come l’unico ambiente in cui possono svilupparsi e progredire l’intelligenza, la dignità e la felicità degli uomini». [...]
Scopo fondamentale di ogni uomo ha da essere [=
deve essere – n.d.r.] dunque la conquista della propria
libertà, di tutta la propria libertà. Alla quale meta non si
giunge se non si abbia realizzata dapprima una completa autonomia spirituale attraverso la rivolta contro la
società e contro Dio.
Per rivolta contro la società Bakunin intende lo sforzo
di liberazione da quei germi di abitudini mentali che la
società stessa o meglio l’ambiente depongono in ogni
individuo, incatenandolo fin dalla nascita in un complesso d’idee tradizionali sui problemi fondamentali della
vita. Queste idee innate (sulla giustizia, sull’anima, sulla
divinità, sulla materia, ecc.) impregnano di sé, per sempre, lo spirito dell’individuo, il quale, se pure evolverà spiritualmente, assai di rado oserà varcare i confini di questo ambiente tradizionale e porre in discussione le basi
stesse del suo pensiero. È necessario uno sforzo immenso per procedere a una coraggiosa e obiettiva valutazione dei valori imposti come indiscutibili dalla suggestione sociale [= dall’influenza della società – n.d.r.];
ma è, per l’uomo pensante, tappa indispensabile nel
cammino per la conquista della vera libertà.
Fra queste idee innate o tradizionali, la più funesta è
quella di Dio; poiché la nostra libertà cessa di esistere se
ci sottoponiamo a un’autorità superiore, invisibile, insindacabile, irresistibile. Ammettere Dio significa abdicare alla ragione e alla giustizia umane; se Dio esiste,
l’uomo è schiavo; se l’uomo è libero, intelligente, giusto,
Dio non esiste. Dio rende schiavo l’uomo non solo nel
pensiero, ma anche nella attività pratica: perché adorare
Dio nei cieli significa obbedire ai suoi rappresentanti in
terra; e tutti i despoti, tutti i peggiori nemici della libertà
hanno sempre legittimato la loro autorità col suggello del
consenso divino [= affermando di essere stati istituiti da
Dio – n.d.r.]. [...]
Condizione prima ed essenziale di libertà e nello
stesso tempo libertà prima ed essenziale è che ogni
uomo sia messo in grado di raggiungere il pieno svi-
luppo di tutte le sue facoltà, ricevendo un’adeguata
istruzione ed educazione. Ma può l’uomo, nell’attuale organizzazione sociale, istruirsi ed educarsi se non possiede congrui mezzi di fortuna? Evidentemente no; non
v’è che una piccola minoranza che abbia tale possibilità, ossia l’incommensurabile privilegio di essere e di
sentirsi libera in una massa di schiavi. Ecco dunque la
necessità di rivoltarsi contro lo Stato, che garantisce il
mantenimento dell’odierno assetto sociale. Bisogna
abolire il diritto di proprietà, che crea una così profonda
disuguaglianza tra gli uomini e il diritto di eredità, che
concede di trasmettere il privilegio; bisogna assicurare
a tutti gli uomini uguali condizioni di partenza.
Vana fatica è quella di spingere le classi privilegiate a
mitigare le sofferenze dei nullatenenti; esse non risolveranno mai il problema perché non potranno mai rinunciare al loro privilegio. Necessità fondamentale [...] è invece quella di abolire tali classi, non sopprimendo gli
individui, ma sopprimendo il privilegio. Molti pensano
che ciò significhi uccidere nell’uomo il più forte stimolo al
lavoro; ma questo è vero solo nell’attuale società che
considera sommo bene la possibilità di vivere senza bisogno di lavorare e una dannazione il lavoro: nella società
futura il lavoro sarà considerato un bene necessario, un
bisogno naturale, irresistibile nell’uomo, legge suprema
della vita, poiché sarà un lavoro misurato, giustamente
retribuito, conforme alle attitudini individuali. [...]
La libertà sarà il principio informatore della nuova società, che si ordinerà dal basso in alto: nuclei di individui spontaneamente riunitisi concorreranno a formare
delle associazioni di produzione; queste a formare i comuni, i comuni a formare le province, le province a formare la nazione. Le nazioni si uniranno fra loro in una
lega dapprima limitata all’Europa, che più tardi si estenderà a tutto il mondo. [...]
Per preparare l’umanità a questa grande trasformazione, in attesa dell’ora in cui si renda possibile la rivoluzione, bisogna predicare contro la società borghese,
contro Dio, contro l’organizzazione statale, dimostrare il
vuoto e la menzogna che si celano nei vecchi valori tradizionali, coltivare lo spirito di rivolta in seno al popolo.
Bisogna poi chiarire e diffondere alcune idee-basi, quali
federalismo, ateismo, collettivismo, pacifismo; bisogna
promuovere e favorire l’organizzazione dei lavoratori,
cercando di creare un grande, unico nucleo operaio che
sia un modello, in piccolo, di quel che dovrebbe essere
la futura società. Soprattutto [bisogna – n.d.r.] risvegliare
l’istinto rivoluzionario, innato nelle grandi masse incolte.
N. ROSSELLI, Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento
operaio in Italia (1860-1872),
Einaudi, Torino 1967, pp. 143-147
Quale tipo di libertà proponeva Bakunin per l’uomo?
Perché la libertà da lui concepita è conseguibile attraverso una rivolta contro Dio, contro lo stato, contro la società?
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
UNITÀ 8
Il pensiero di Michail Bakunin
5
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
4
5
Le incoerenze della borghesia
UNITÀ 8
Uscita vincitrice dalla Rivoluzione francese, la borghesia si
segnalò ben presto per le proprie incoerenze; dopo aver lanciato,
contro i privilegi nobiliari, la parola d’ordine dell’eguaglianza di
tutti gli uomini, i borghesi si posero subito a difesa delle proprie ricchezze, negando ogni legittimità a qualsiasi tentativo di
estendere l’eguaglianza stessa alla sfera dell’economia.
POLITICA E SOCIETÀ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
6
La borghesia è l’altro nome della società moderna.
Indica una classe di persone che attraverso la libera attività hanno progressivamente distrutto l’antica società
aristocratica, fondata sulle gerarchie di nascita. [...] È
una classe senza statuto, senza tradizioni, senza contorni definiti e non dispone che d’un fragile titolo al dominio, la ricchezza. Fragile, perché può appartenere a
chiunque: chi è ricco avrebbe potuto non esserlo, chi
non lo è, avrebbe potuto esserlo. Pur essendo una categoria sociale definita dall’economico, la borghesia
sbandiera valori universali. Il lavoro definisce non più gli
schiavi, come nell’antichità, o i non nobili, come nelle aristocrazie, ma l’intera umanità: costituisce ciò che di più
elementare possiede l’uomo come individuo nella sua
primitiva nudità di fronte alla natura. Presuppone la libertà fondamentale del singolo, libertà eguale per tutti
di darsi un’esistenza migliore aumentando i propri beni
e le ricchezze. Il borghese dunque si pensa libero dalla
tradizione politica o religiosa e indeterminato, come può
esserlo un uomo libero e eguale in diritto a tutti gli altri.
Regola la propria condotta rispetto al futuro, poiché
deve inventarsi da sé, assieme alla comunità alla quale
appartiene.
Ma l’esistenza sociale di questo personaggio nuovo
nella storia è alquanto problematica. Egli porta alla ribalta
del mondo la libertà, l’uguaglianza, i diritti dell’uomo, insomma l’autonomia dell’individuo contro le società fondate sulla dipendenza, che erano apparse prima di lui.
Ma quale nuova associazione propone? Una società
che metta in comune solo poche cose della sua vita, visto che ha come dovere principale di garantire ai propri
membri il libero esercizio delle loro attività private e il godimento assicurato di ciò che hanno acquisito. Quanto
al resto, è affar loro: i membri della società borghese
possono scegliersi una religione, l’idea del bene e del
male, sono liberi di perseguire i propri gusti e i fini particolari che assegnano all’esistenza, purché rispettino i
termini del contratto minimo che li lega agli altri concittadini. La società borghese dunque s’allontana per definizione dall’idea di bene comune. Il borghese è un individuo separato dai suoi simili, chiuso nei propri
interessi e nei propri beni. [...]
La società moderna è percorsa da un’agitazione
corpuscolare che spinge gli individui a superarsi continuamente e in questo modo approfondisce le contraddizioni insite nell’esistenza stessa della società. Non
basta che sia formata da membri poco inclini a prendersi
cura dell’interesse pubblico. È necessario pure che l’idea dell’eguaglianza e dell’universalità degli uomini,
sbandierata come suo fondamento e novità, venga costantemente negata dall’ineguaglianza delle proprietà e
delle ricchezze, prodotta dalla competizione tra gli individui. Il movimento, il dinamismo della società ne contraddicono il principio, la legittimità. Mentre proclama l’eguaglianza come diritto imprescrittibile dell’uomo, la
società moderna produce di continuo ineguaglianza,
soprattutto materiale, più di qualsiasi altra società conosciuta.
Nelle società del passato, l’ineguaglianza aveva uno
statuto legittimo, dettato dalla natura, dalla tradizione e
dalla provvidenza. Nella società borghese, l’ineguaglianza è un’idea che circola di contrabbando, un’idea
contraddittoria rispetto al modo in cui gli individui immaginano se stessi. Eppure la si trova dovunque, nelle
situazioni che essi vivono e nelle passioni che nutrono.
La borghesia non inventa la divisione della società in
classi, ma ne fa un dramma ammantandola di un’ideologia che la rende illegittima.
F. FURET, Il passato di un’illusione. L’idea comunista nel XX secolo,
trad. M. VALENSISE, Mondadori, Milano 1997, pp. 12-14
Per quale motivo i contorni della borghesia non sono precisi e ben definiti?
Quali sono le incoerenze esistenti tra i valori universali che la borghesia professava in teoria, e il modello di società
che attuò in pratica nei principali paesi europei?
Per quale motivo la divisione della società in classi e l’ingiustizia sociale diventano un dramma, nel contesto di una società
borghese?
In che senso l’ideologia tipica della borghesia rende illegittima la divisione in classi della società?
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
In genere, l’esperienza della Comune di Parigi viene presentata come il primo tentativo di rivoluzione proletaria. Anche
se fu percepita come tale da molti contemporanei (sia borghesi
che proletari), in realtà si trattò prima di tutto di un disperato
tentativo di proseguire una guerra palesemente perduta. Parigi si trovò del tutto sola, poiché non più in sintonia con le province, disposte ad accettare la fine delle ostilità.
Nel 1870 Sedan liquida il bonapartismo, ma il colpo
più grosso lo riceve l’orgoglio nazionale: da Valmy fino
alla guerra con la Prussia, l’esercito francese si era ritenuto invincibile. L’ubriacatura napoleonica era durata
ben oltre Waterloo, ma la débacle [disfatta, n.d.r.] di Sedan sembra togliere ai francesi qualsiasi illusione, e la
catastrofe militare porta di nuovo alla ribalta la Repubblica. Ma che tipo di repubblica può nascere da una tale
sconfitta? La rovinosa caduta di Napoléon le petit [Napoleone il piccolo, espressione denigratoria usata per
designare Napoleone III, n.d.r.] mette pesantemente
sotto accusa anche la classe dirigente formata dalla
ricca borghesia clericale, che, avendo condiviso il potere, è altrettanto responsabile della guerra perduta.
Così, ancora una volta è lo spettro di un nuovo ’48 che
induce Adolphe Thiers a dichiarare che la Terza Repubblica dovrà fornire le più complete garanzie contro
lo sconvolgimento dei «principi di proprietà» e che pertanto potrà sopravvivere «soltanto se conservatrice». In
realtà la Repubblica si troverà a dover fronteggiare la destra reazionaria, che anela a una restaurazione della
monarchia. Nell’assemblea nazionale di Bordeaux i monarchici delle varie tendenze ottengono quattrocento
voti, contro i trecentocinquanta dei repubblicani, rifiutando in linea di principio l’ordonnance répubblicain
[l’atto di proclamazione della Repubblica, n.d.r.]. Questo
fatto, unito all’esasperante lunghezza dell’assedio di
Parigi, che fiacca gli animi e impone sacrifici gravissimi,
fa sì che la popolazione si schieri contro il governo, fomentata da agitatori rivoluzionari che non mancano di infiammare gli animi ricordando con fervore la Grand Révolution e le gloriose giornate del settembre 1792,
quando il popolo era corso in massa alle armi per difendere le frontiere della patria contro quegli stessi prussiani che ora stanno assediando la capitale. Se a tutto
questo si aggiunge il contegno reazionario dell’assemblea nazionale, trasferitasi il 21 marzo a Versailles, non
c’è da stupirsi che a Parigi la restaurazione monarchica
venga a un certo momento ritenuta nella logica degli
eventi.
Al momento dell’entrata delle truppe nemiche, il
parco di artiglieria della capitale era stato dislocato nel
quartiere operaio di Montmartre. Il comitato centrale rivoluzionario decide di impadronirsene e fa fucilare i due
generali inviati dal governo. È la scintilla, e la Comune
tenta l’assalto al cielo dell’universo borghese, innalzando la bandiera rossa, simbolo delle sue aspirazioni
socialiste, disposta all’eroismo: «Era necessario il bagno
di sangue, e di sangue francese, l’olocausto orrendo, il
sacrificio delle vite in mezzo al fuoco purificatore… Che
Parigi sprofondasse, che bruciasse come un immenso
braciere di olocausto, piuttosto che tornare ai suoi vizi
e alle sue sofferenze, a quella vecchia società corrosa da
un’abominevole ingiustizia» (É. Zola, La disfatta). Militarmente i ribelli non hanno alcuna possibilità di successo: è una rivolta utopistica e disperata, e sarà l’ultima
del secolo: «Nella Comune mancava la solida organizzazione del proletariato come classe e la chiarezza di
principio sulla sua funzione storica… Con la caduta
della Comune sono cadute per sempre anche le ultime
tradizioni della vecchia leggenda rivoluzionaria: nessun
favore delle circostanze, nessun eroismo nessuna vocazione al martirio può sostituire la chiara visione del
proletariato… delle imprescindibili condizioni della sua
emancipazione» (F. Mehring). Il resto della Francia rimase
assente all’estrema ventata rivoluzionaria, eccetto pochissime città industriali, come Marsiglia, Saint-Ètienne,
Limoges. Nel momento in cui [il generale] Mac Mahon
riesce a costituire un esercito con i prigionieri liberati
dalla Germania, il destino della Comune è segnato, e
dopo poco più di due mesi la città è nelle mani del governo legittimo. […]
La caduta della Comune ha un peso che va assai più
in là del suo reale significato politico, non tanto per gli
eccessi, le devastazioni e gli incendi, le fucilazioni degli
ostaggi e dei prigionieri (che certamente non mancarono
di incidere sull’opinione pubblica), quanto «per quello
che aveva voluto essere come attentato alle strutture
dello Stato borghese e per lo sviluppo che dalla Comune
avrebbe potuto propagarsi in altre nazioni europee» (F.
Sanpoli); infine, nei movimenti operai rivela in modo
netto la scissione fra la sinistra moderata e l’estrema sinistra nonché un’accentuata tendenza al frazionamento
sul piano teorico. […] La sua sconfitta in una prova di
forza fu un colpo che scosse la coesione internazionale,
già tanto precaria, dell’estrema sinistra, la quale doveva rimanere depauperata nei suoi componenti nazionali fino alla fondazione della Seconda Internazionale nel
1899 a Parigi.
R. REIM, La Parigi di Zola, Editori Riuniti,
Roma 2001, pp. 98-103
Che cosa significa l’affermazione secondo cui la Comune tenta l’assalto al cielo?
La rivolta della Comune aveva qualche possibilità di successo?
Il moto parigino ottenne sostegno dalle altre regioni della Francia?
Che cosa comportò per il movimento operaio degli anni seguenti la disfatta della Comune?
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
UNITÀ 8
Da Sedan alla Comune
7
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
6
7
Destra e Sinistra nel sistema liberale
italiano
UNITÀ 8
Il liberalismo italiano presentò a lungo due schieramenti, chiamati Destra e Sinistra. Ma, al di là delle differenze, tra i due gruppi spesso fu possibile trovare accordi di maggioranza, che rendevano molto sfumate le denominazioni e le posizioni ufficialmente dichiarate.
POLITICA E SOCIETÀ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
8
Quando si parla di Destra e Sinistra non bisogna
pensare a due partiti ben distinti e contrapposti. In realtà
le maggioranze su cui si appoggiarono i governi, soprattutto dal 1882, furono composte da elementi eterogenei provenienti sia da destra che da sinistra. I governi
si qualificavano di destra o di sinistra secondo che vi fossero più numerosi e importanti i ministri provenienti da
destra o quelli provenienti da sinistra. Sia la Destra che
la Sinistra erano espressione di un corpo elettorale ristretto. Tuttavia mentre la Destra tendeva a mantenere
immutato il corpo elettorale ed anzi a renderlo nella pratica ancor più ristretto di quanto non fosse per legge, la
Sinistra tendeva ad allargarlo, come dimostra soprattutto
la riforma elettorale fatta nel 1882 che aumentò gli elettori da circa 600 000 a oltre due milioni.
Da un punto di vista sociale i deputati di Destra appartenevano prevalentemente alle regioni del Settentrione
e del Centro ed erano quei membri della aristocrazia, dell’alta borghesia, del ceto colto che avevano abbracciato
la causa del Piemonte ed il liberalismo durante il Risorgimento. Invece molti deputati di sinistra erano stati legati
al garibaldinismo e al Partito d’azione mazziniano, e avevano tutti un carattere non aristocratico e più marcatamente borghese. Scarsamente legati ad una tradizione di
cultura e di elevato senso dello Stato, erano in genere
sensibili alle richieste, limitate più che altrove ai piccoli interessi locali, degli elettori meridionali. Mentre la Destra
aveva i caratteri di una élite ristretta e qualificata, la base
sociale della Sinistra, anche prima della riforma elettorale
del 1882, era più ampia. I deputati di Destra erano in prevalenza cattolici (ma non clericali), quelli di Sinistra erano
massoni e anticlericali.
Da un punto di vista economico sia la Destra che la
Sinistra erano legate soprattutto ai settori ed agli interessi
più importanti o più forti: che erano, in un paese non ancora industriale come l’Italia di allora, soprattutto terrieri
e bancari. Ma mentre nella Destra prevalevano i legami
con la grande proprietà, la Sinistra raccoglieva anche le
simpatie della piccola borghesia urbana e della nascente
industria. Per concludere, la Sinistra rappresentava, con
i suoi pregi e difetti, la tendenza verso una più diffusa democrazia immanente al sistema liberale. […]
Nel 1861-76 la Destra al governo aveva affrontato e
in parte brillantemente risolto quattro grandi problemi: il
compimento dell’unità nazionale, con l’annessione di
Venezia nel 1866 e di Roma nel 1870; la sistemazione
dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sulla base –
liberale e cavouriana – della reciproca separazione; il
rafforzamento delle finanze dello Stato; la formazione
delle cosiddette infrastrutture economiche (ferrovie e
altre opere pubbliche). Per ottenere questi ultimi scopi
la Destra aveva sottoposto i contribuenti ad una dura
pressione tributaria. L’andata al potere della Sinistra nel
1876 era maturata nel corso dei sei anni precedenti, soprattutto in relazione a due fatti: il compimento dell’unità
nazionale e un iniziale periodo di prosperità economica
che, intorno al 1869-1870, successe ad alcuni anni di
crisi gravissima. […] La migliorata situazione delle finanze dello Stato e quella economica generale aumentarono il malcontento per la politica tributaria e finanziaria della Destra e fecero desiderare un’azione di governo
meno intransigente nella tutela degli interessi dello Stato
e più sollecita di quelli privati. La Sinistra andò al potere
col programma di promuovere una maggior libertà e una
maggior ricchezza privata.
G. CAROCCI, Giolitti e l’età giolittiana, Einaudi,
Torino 1971, pp. 8-10
Costruisci una tabella, mettendo in evidenza le principali differenze esistenti tra gli uomini della Destra e quelli della
Sinistra. Come criteri di lavoro, puoi assumere i seguenti indicatori:
a) prevalente provenienza geografica (Nord/Sud);
b) rapporto con il passato risorgimentale (moderati/garibaldini);
c) estrazione sociale (aristocrazia fondiaria/ceto borghese);
d) disponibilità ad allargare il corpo elettorale.
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
Il nuovo Stato unitario italiano sostenne senza esitazione gli
interessi dei ceti più abbienti, primi fra tutti i grandi proprietari terrieri. Le principali scelte politiche adottate, inoltre, danneggiarono in modo pesante il Sud, a cominciare dal libero scambio, che portò vantaggi all’agricoltura capace di produrre per l’esportazione, ma rovinò gli artigiani e le industrie del Sud, nella misura in cui lasciava entrare sul mercato italiano le merci
inglesi.
Un effetto abbastanza paradossale dell’introduzione
del liberalismo nel 1860 era stato di rendere la grande
maggioranza della popolazione economicamente più
vulnerabile di quanto fosse stata sotto l’assolutismo. I
governanti di ancien régime s’erano sforzati di difendere
i poveri contro le incertezze del mercato e la rapacità dei
proprietari terrieri locali mediante il controllo dei prezzi,
il protezionismo, un basso livello delle imposte, leggi miranti a promuovere la distribuzione della terra e le attività benefiche della Chiesa, la cui gigantesca rete di conventi, ospedali, scuole, orfanotrofi ed enti e donazioni
caritativi costituiva una fonte di assistenza (per tacere dei
posti di lavoro) di cruciale importanza. L’Italia unita aveva
portato con sé il vento freddo del libero scambio, con effetti particolarmente devastanti sul fragile settore manifatturiero meridionale. Aveva inoltre attribuito alle classi
possidenti un potere la cui portata era senza precedenti,
perché i consiglieri municipali e i deputati erano eletti dai
gruppi sociali più ricchi, e a questi rendevano conto e
non più, come in passato, a un monarca paternalista. In
assenza di un forte ethos nazionale a contrastare gli imperativi morali del tornaconto personale, le élites dominanti erano in grado di utilizzare la loro posizione privilegiata per riempire le proprie tasche, spesso con
impudente sfacciataggine.
Che il tentativo del governo di legiferare in favore
delle classi lavoratrici urtasse contro grosse difficoltà
emerse con chiarezza nei primi decenni postunitari.
Malgrado numerose e importanti inchieste portassero
alla luce – negli anni Sessanta, e ancor più nei Settanta
e negli Ottanta – le dimensioni spaventose della povertà
urbana e rurale in Italia, i tentativi d’introdurre un sistema
fiscale più equo, o di accrescere il numero dei poderi
contadini, o di costringere i datori di lavoro a comportarsi in maniera responsabile verso i loro fittavoli e operai, venivano bloccati in parlamento da coalizioni ad
hoc [nate proprio a quello scopo, n.d.r.] di deputati attivamente impegnati a difendere i propri interessi. Se un
provvedimento teoricamente suscettibile di aiutare i poveri riusciva a diventare legge dello Stato, spesso le
realtà della vita locale ne impedivano l’applicazione. Un
esempio fu l’imponente vendita da parte dello Stato di
terre ecclesiastiche ed ex feudali (più di due milioni di ettari) a cavallo tra gli anni Sessanta e i Settanta. Malgrado
una clausola prevedesse il loro spezzettamento in piccoli fondi, in modo da permettere ai contadini di comF.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
prare, l’assenza di strutture creditizie, specialmente nel
Mezzogiorno, e il disperato bisogno del governo di far
denaro in fretta, significarono che, tirate le somme, soltanto chi era già benestante fu in grado di approfittare
dell’occasione. Non solo, ma le aste venivano spesso
truccate dai galantuomini, i quali impiegavano l’arma
dell’intimidazione per assicurarsi che nessuno osasse
competere con loro.
Se dopo il 1860 l’onere della tassazione gravò in misura sproporzionata sulle spalle dei poveri, una ragione
fu la necessità in cui lo Stato si trovava di far affluire fondi
nelle sue casse per far fronte all’enorme debito pubblico.
Alla fine degli anni Quaranta e nel corso del decennio
successivo il Piemonte aveva accumulato un debito gigantesco (molto superiore al miliardo di lire) per combattere gli austriaci e costruire ferrovie; e quando si aggiunsero i debiti che il nuovo regno ereditò dagli Stati
italiani al momento dell’unificazione, i costi della lotta al
brigantaggio nel Mezzogiorno e della guerra del 1866,
nonché le spese rese necessarie dall’equipaggiamento
di tre diverse capitali nel giro di un decennio, non può
sorprendere che l’Italia unita imponesse ai suoi nuovi
sudditi livelli di tassazione anormalmente elevati. Nel
1870 il debito nazionale aveva ormai raggiunto la sbalorditiva cifra di oltre otto miliardi di lire. I proventi delle
imposte dirette crebbero del 63 per cento tra il 1865 e
il 1871, ma le difficoltà in cui s’imbatteva l’accertamento
dei redditi personali costrinsero il governo a ripiegare in
misura sempre maggiore sulle tasse sui consumi, di facile riscossione, ossia le tasse sul sale, sui tabacchi e –
il caso tra tutti più tristemente famoso – sulla macinazione del frumento e degli altri cereali, che colpivano con
particolare durezza le classi lavoratrici. Tra il 1865 e il
1871 i proventi dell’imposizione indiretta crebbero del
107 per cento. Anche le amministrazioni comunali furono autorizzate a imporre tasse, per esempio sui generi
alimentari e sul bestiame; e furono, di nuovo, soprattutto
i poveri a subirne gli effetti. Quando nel 1876 il giovane
liberale toscano Sidney Sonnino visitò la Sicilia, trovò
che i muli e gli asini, tipici beni contadini, erano tassati
più pesantemente dei bovini, che appartenevano ai
grandi proprietari terrieri.
Comprensibilmente, questi enormi oneri fiscali generavano un diffuso risentimento popolare verso lo
Stato; e cresceva il timore che la distanza tra governanti
e governati – o, come si diceva comunemente – tra l’Italia legale e quella reale – potesse dimostrarsi fatale per
il nuovo regno. […] Francesco Crispi, che nell’ottobre
1873 si recò a Tricarico, il collegio nell’entroterra montagnoso della Basilicata che rappresentava alla Camera
fin dal 1870, ma non aveva ancora mai visitato […] fu
profondamente scosso da ciò che vide. Per arrivare a
Tricarico bisognò raggiungere Eboli, la stazione ferroviaria più vicina, e da qui ci vollero due giorni di viaggio
UNITÀ 8
Stato e classi lavoratrici negli anni
Sessanta
9
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
8
in un carretto su strade ripide e malconce. Dei tredici
centri (tra cittadine e paesi) che costituivano il suo collegio elettorale, soltanto due avevano una strada che li
collegasse al mondo esterno; a tutti gli altri si accedeva
mediante viottoli sassosi che le piogge invernali trasformavano in pantani. La povertà era spaventosa, quasi indescrivibile. I contadini vivevano di fagioli od orzo macinato fino a diventare una farina di grana grossa. Ma
venivano dissanguati dalla tassa sul macinato, riscossa
con spietata durezza dagli esattori governativi; ed in
molti luoghi Crispi fu assalito da folle di donne furibonde
che gridavano la loro protesta.
C. DUGGAN, La forza del destino. Storia d’Italia dal 1796 a oggi,
Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 298-301,
trad. it. G. FERRARA DEGLI UBERTI
UNITÀ 8
Spiega l’espressione «il vento freddo del libero scambio».
Quale gruppo sociale trasse vantaggi dalle vendite delle terre ecclesiastiche?
Per quale motivo si preferì la strada delle imposte indirette, rispetto a quelle dirette? Per quali gruppi sociali esse erano
particolarmente gravose?
POLITICA E SOCIETÀ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
10
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
All’inizio del Novecento, il Sud Italia versava in condizioni
drammatiche. Dopo che il protezionismo aveva rovinato l’agricoltura, l’emigrazione verso l’America fu, per milioni di poveri
contadini, l’unica alternativa alla miseria e alla fame.
La relativa [confrontata con la situazione del Nord,
n.d.r.] povertà del Mezzogiorno era facilmente dimostrabile: il reddito pro capite era, nel 1900, meno della
metà di quello dell’Italia settentrionale; nel Mezzogiorno
viveva il 40 per cento della popolazione totale, ma nel
1911 il consumo di energia elettrica per usi industriali
nel Sud raggiungeva appena quello del solo Piemonte.
Il Mezzogiorno era arretrato anche in molti settori dell’agricoltura: la resa di 3-5 quintali di grano per ettaro
costituiva la norma, e anche negli anni più favorevoli la
resa media nazionale di 10,5 quintali venne raramente
raggiunta. Un quadro analogo offrono i dati sul tasso di
mortalità e sulle condizioni di abitazione: nel 1910-14 il
tasso nazionale di mortalità era del 19,2 per mille abitanti, ma nel Mezzogiorno il tasso più basso era del
19,7 per mille in Calabria, e quello più elevato del 22,6
in Basilicata. Mentre nel 1911 meno dell’un per cento
della popolazione di Genova, Firenze e Livorno viveva
in una sola stanza, a Bari la percentuale era del 42 per
cento (con una media di 4,7 persone per stanza) e a
Foggia del 70,5 (6 persone per stanza).
Il tasso di analfabetismo aumentava costantemente
a mano a mano che si scendeva verso sud: nel 1911 era
dell’11 per cento nel Piemonte, del 37 in Toscana, del
54 in Campania, del 65 in Basilicata e del 70 in Calabria;
in Sicilia la situazione era leggermente migliore con il 58.
(La media nazionale era del 37,6 per cento). I comuni più
isolati del Sud potevano toccare punte di analfabetismo
che arrivavano fino al 90 per cento. La deficienza di
scuole era scandalosa: nel 1907-1908 il Piemonte, con
3,4 milioni di abitanti, aveva 9000 scuole, mentre la Sicilia, con 3,6 milioni, ne aveva 5000. […] I meridionalisti
sostenevano che la politica seguita dallo stato dopo l’unità aveva contribuito ad approfondire il divario. Dopo il
1887 il sistema tariffario [il protezionismo sui manufatti
industriali, n.d.r.] aveva costretto il Sud a comprare a
prezzi elevati i prodotti industriali e a vendere a basso
prezzo i suoi prodotti agricoli. […]
Se, nonostante tutto, tra il 1900 e il 1914 le condizioni del Mezzogiorno rurale migliorarono, ciò fu dovuto
non tanto all’azione governativa, quanto all’emigrazione,
un fenomeno di cui il governo non poteva certo menar
vanto. Il numero degli emigranti crebbe ogni anno (se si
eccettuano i periodi di stasi temporanea della crisi economica del 1907-1908 e della guerra libica del 1911), e
raggiunse nel 1913 la punta massima di 873 000 unità:
nessun altro paese, tranne l’Irlanda, poteva vantare un
esodo così imponente. Il contributo del Mezzogiorno alla
corrente migratoria andò sempre aumentando e passò
da un quarto del totale negli anni ’80 fino a quasi la metà
tra il 1905 e il 1913. Questo spostamento dell’equilibrio
mutò anche la natura del fenomeno: l’emigrazione dall’Italia settentrionale e centrale era generalmente di carattere temporaneo, spesso solo stagionale, ed era
orientata soprattutto verso i paesi dell’Europa settentrionale, mentre l’emigrazione dal Mezzogiorno aveva un
carattere più duraturo, spesso permanente, ed era
orientata verso le due Americhe. Dopo il 1898 gli Stati
Uniti presero il posto del Brasile e dell’Argentina come
destinazione preferita degli emigranti, e più di tre degli
otto milioni di italiani che lasciarono il paese tra il 1901
e il 1913 si recarono negli Stati Uniti. Anche nel caso degli emigranti oltreoceano, tuttavia, la percentuale di quelli
che non tornavano più andò diminuendo: su ogni 100
emigranti, ne tornarono 40 nel periodo 1897-1901 e 68
nel periodo 1911-1913. È stato calcolato che tra il 1862
e il 1913 abbandonarono definitivamente l’Italia quattro
milioni e mezzo di persone.
L’esodo dal Sud era cominciato in Basilicata, Calabria e Campania negli anni ’80, e il movimento si era
esteso subito dopo all’Abruzzo: alla svolta del secolo, il
ruscello divenne una fiumana. La Sicilia contribuì al movimento migratorio solo in un secondo tempo, ma dopo
il 1904 diede ad esso il maggiore contributo. La Puglia
fu la sola regione del Sud in cui il tasso di emigrazione
fosse inferiore a quello medio nazionale. L’emigrazione
meridionale fu un fenomeno esclusivamente proletario,
uno spontaneo gesto di protesta contro condizioni di
vita insopportabili: cominciò nelle pianure e nelle zone
costiere, dove i contatti con il mondo esterno erano più
facili, e quindi si diffuse all’interno, raggiungendo le
punte più alte nelle zone montane più isolate, dove la
povertà era maggiore. Le città più grandi non diedero un
grande contributo all’emigrazione: alcuni emigranti erano
artigiani, ma la stragrande maggioranza erano contadini
e braccianti.
Coloro che possedevano terra, o godevano di condizioni di maggiore stabilità sul fondo [sul podere che
coltivavano, n.d.r.], erano i più riluttanti a partire. Quattro quinti degli emigranti erano maschi, soprattutto tra i
20 e i 50 anni, sicché nelle zone più isolate era possibile
trovare villaggi abitati quasi esclusivamente da vecchi e
da bambini: fu proprio questo drenaggio di giovani energie verso terre straniere che colmò di indignazione i nazionalisti ed ispirò loro l’immagine di un’Italia proletaria.
C. SETON-WATSON, L’Italia dal liberalismo al fascismo
1870-1925, Laterza, Roma-Bari 1973, pp. 357-358, 365-366,
trad. it. L. TREVISANI
Individua nel testo i principali indicatori relativi al sottosviluppo delle regioni meridionali, verso la fine dell’Ottocento.
Individua i caratteri fondamentali del fenomeno migratorio negli anni compresi tra il 1890 e il 1914.
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
UNITÀ 8
La fuga dall’Italia meridionale
11
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
9