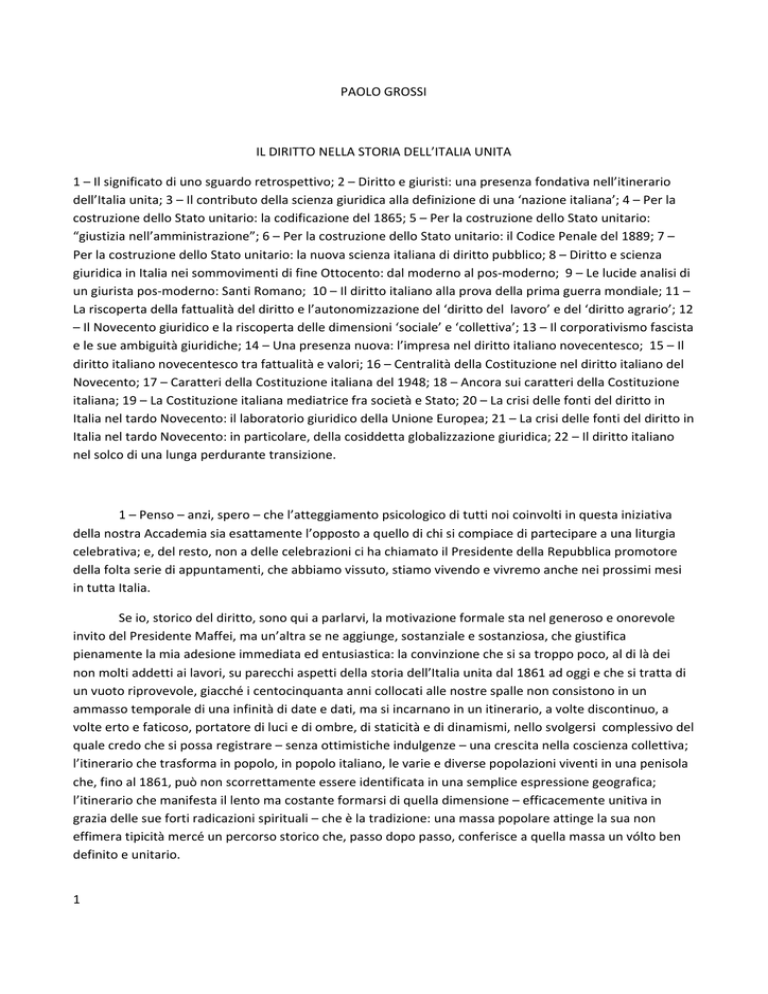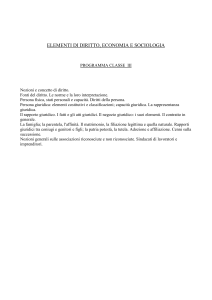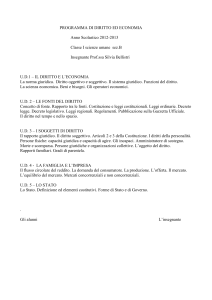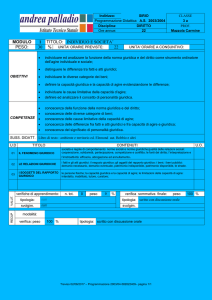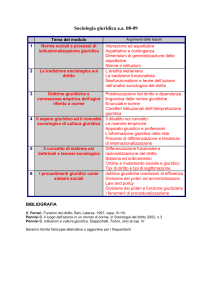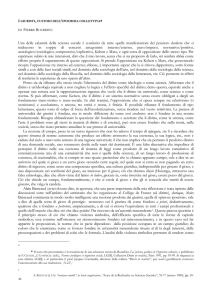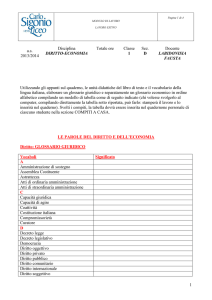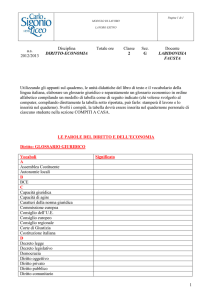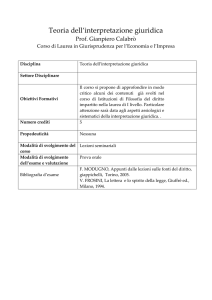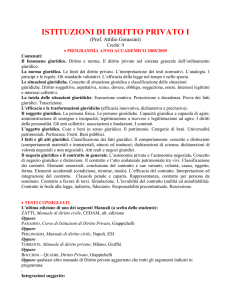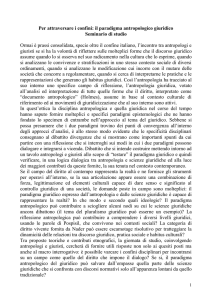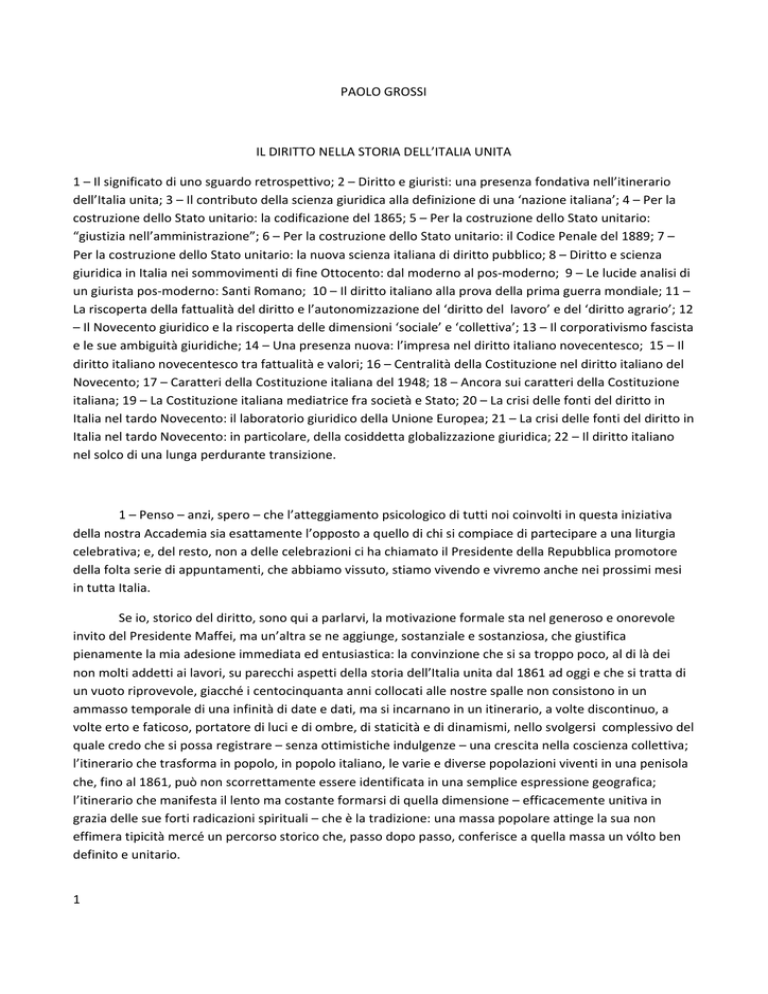
PAOLO GROSSI IL DIRITTO NELLA STORIA DELL’ITALIA UNITA 1 – Il significato di uno sguardo retrospettivo; 2 – Diritto e giuristi: una presenza fondativa nell’itinerario dell’Italia unita; 3 – Il contributo della scienza giuridica alla definizione di una ‘nazione italiana’; 4 – Per la costruzione dello Stato unitario: la codificazione del 1865; 5 – Per la costruzione dello Stato unitario: “giustizia nell’amministrazione”; 6 – Per la costruzione dello Stato unitario: il Codice Penale del 1889; 7 – Per la costruzione dello Stato unitario: la nuova scienza italiana di diritto pubblico; 8 – Diritto e scienza giuridica in Italia nei sommovimenti di fine Ottocento: dal moderno al pos‐moderno; 9 – Le lucide analisi di un giurista pos‐moderno: Santi Romano; 10 – Il diritto italiano alla prova della prima guerra mondiale; 11 – La riscoperta della fattualità del diritto e l’autonomizzazione del ‘diritto del lavoro’ e del ‘diritto agrario’; 12 – Il Novecento giuridico e la riscoperta delle dimensioni ‘sociale’ e ‘collettiva’; 13 – Il corporativismo fascista e le sue ambiguità giuridiche; 14 – Una presenza nuova: l’impresa nel diritto italiano novecentesco; 15 – Il diritto italiano novecentesco tra fattualità e valori; 16 – Centralità della Costituzione nel diritto italiano del Novecento; 17 – Caratteri della Costituzione italiana del 1948; 18 – Ancora sui caratteri della Costituzione italiana; 19 – La Costituzione italiana mediatrice fra società e Stato; 20 – La crisi delle fonti del diritto in Italia nel tardo Novecento: il laboratorio giuridico della Unione Europea; 21 – La crisi delle fonti del diritto in Italia nel tardo Novecento: in particolare, della cosiddetta globalizzazione giuridica; 22 – Il diritto italiano nel solco di una lunga perdurante transizione. 1 – Penso – anzi, spero – che l’atteggiamento psicologico di tutti noi coinvolti in questa iniziativa della nostra Accademia sia esattamente l’opposto a quello di chi si compiace di partecipare a una liturgia celebrativa; e, del resto, non a delle celebrazioni ci ha chiamato il Presidente della Repubblica promotore della folta serie di appuntamenti, che abbiamo vissuto, stiamo vivendo e vivremo anche nei prossimi mesi in tutta Italia. Se io, storico del diritto, sono qui a parlarvi, la motivazione formale sta nel generoso e onorevole invito del Presidente Maffei, ma un’altra se ne aggiunge, sostanziale e sostanziosa, che giustifica pienamente la mia adesione immediata ed entusiastica: la convinzione che si sa troppo poco, al di là dei non molti addetti ai lavori, su parecchi aspetti della storia dell’Italia unita dal 1861 ad oggi e che si tratta di un vuoto riprovevole, giacché i centocinquanta anni collocati alle nostre spalle non consistono in un ammasso temporale di una infinità di date e dati, ma si incarnano in un itinerario, a volte discontinuo, a volte erto e faticoso, portatore di luci e di ombre, di staticità e di dinamismi, nello svolgersi complessivo del quale credo che si possa registrare – senza ottimistiche indulgenze – una crescita nella coscienza collettiva; l’itinerario che trasforma in popolo, in popolo italiano, le varie e diverse popolazioni viventi in una penisola che, fino al 1861, può non scorrettamente essere identificata in una semplice espressione geografica; l’itinerario che manifesta il lento ma costante formarsi di quella dimensione – efficacemente unitiva in grazia delle sue forti radicazioni spirituali – che è la tradizione: una massa popolare attinge la sua non effimera tipicità mercé un percorso storico che, passo dopo passo, conferisce a quella massa un vólto ben definito e unitario. 1 Guardare dietro le nostre spalle fino alle origini del percorso ha il solo intenso significato di seguire le tappe di una radicazione, che incide e modifica a livello sociale economico culturale politico e che merita di essere ricordata. Gli occhi del cittadino italiano del 2011 – e, soprattutto, del giovane e giovanissimo cittadino – non possono che irrobustirsi da un siffatto sguardo retrospettivo e guadagnarne particolarmente nella loro valenza critica. Dopo queste parole, credo che si capisca meglio il perché – ieri – della mia adesione e – oggi – della mia schietta soddisfazione nel vedermi concretamente inserito tra gli accademici proludenti. Rispettando i limiti della mia competenza, io Vi parlerò del ruolo del diritto nella storia dell’Italia unita, partecipàndoVi subito una preoccupazione: il mio è indubbiamente un uditorio culturalmente eletto ma estremamente variegato, dove, accanto alla presenza di alcuni Maestri della nostra scienza giuridica, sta la assoluta prevalenza di non‐giuristi, ossia di personaggi ai cui orecchi suonano ostici e incomprensibili quell’esoterico vocabolario e quel tecnicissimo ideario che accompagnano da quasi tremila anni i discorsi degli esperti di diritto. La preoccupazione sta nella possibile – forse, probabile – incapacità di comunicazione da parte mia. Su questo punto desidero tranquillizzarVi: senza operare alcun cedimento alla più rigorosa dimensione scientifica, non indulgerò in tecnicismi, tentando di instaurare quel colloquio tra oratore e uditori, che è il fine primario della felice iniziativa della nostra Presidenza. 2 – E una prima domanda può legittimamente affiorare nella Vostra mente: cosa ha a che fare il diritto con i centocinquanta anni di storia italiana unitaria, che appaiono – invece – così intensamente contrassegnati sul piano sociale, politico, economico, o – genericamente – culturale? Non è, forse, il diritto ingessato in Codici impassibili al divenire storico come le tavole di pietra del Sinai, o in Pandette vecchie di millequattrocento anni ma ancora oggi invocate? E non sono, forse, i suoi sacerdoti – i giuristi – una sorta di stregoni appartati nel chiuso dei loro laboratorii e immersi in tecniche troppo spesso meta‐temporali? Mi sia consentito di sottolineare con fermezza che simili affermazioni appartengono a una oleografia volgare, frutto di crassa ignoranza e, pertanto, respingibile almeno in un luogo di alta cultura come pretende di essere ‐ ed è – la nostra insigne Accademia. E’ sicuramente avvenuto che diritto e giuristi si siano trasformati in strumenti di potere tirannico e abbiano contribuito a soffocare lo spontaneo svilupparsi di quel corpo vivente che è la società, ed è sicuramente avvenuto che le prescrizioni dei Codici e le pagine dei giuristi si siano, talora, separate dal flusso storico inaridèndosi, isterilèndosi e trasformàndosi in forme costrittive della realtà storica, ma tutto ciò è appartenuto unicamente a deviazioni patologiche che accompagnano , ohimè!, ogni manifestazione dell’umano itinerario nel tempo. Che non si tratti di affermazioni apologetiche di chi è giurista (come colui che Vi parla), e che può essere osservatore unilaterale e partigiano, lo metterà in evidenza – io spero – lo svolgersi di questa conferenza/lezione. 3 – E cominciamo con una premessa, per ora indimostrata, ma che assumo quale mio fine primario da dimostrare: il diritto ha sostenuto con la sua forza ordinante i centocinquanta anni della nostra storia unitaria, è riuscito – in momenti di svolta – a puntellarla nel profondo e ne è stato, perciò, il suo principale salvataggio. E i giuristi, in questo lungo percorso, smentiscono ben spesso l’immagine negativa cui più sopra 2 si accennava, mostràndosi pienamente coinvolti nel cantiere affaccendato dei fatti storici e proponèndosi come autentici facitori di storia. Cerchiamo di calare più nel concreto: sono fattivamente inseriti nella costruzione dello Stato unitario. Di più! Dànno preziosi strumenti alla nascente classe politica per la avviata costruzione del nuovo Stato. E affiora immediatamente al mio pensiero un nome e un personaggio: quello di un non dimenticabile giurista irpino, Pasquale Stanislao Mancini1, che sarà protagonista nella grande opera costruttiva fino alla sua morte avvenuta nel 1888. Mancini appartiene a quella schiera, fortunatamente folta, di giuristi meridionali costretti all’esilio fuori dal Reame, che trovano nel clima acceso del regno sardo un contesto favorevole per dare compiuta formulazione al proprio progetto scientifico. Per lui, esule a Torino, viene istituita nel 1850 la cattedra di ‘Diritto pubblico esterno e internazionale privato’, ed è precisamente nella ‘prolusione’ al suo corso universitario che egli, il 22 gennaio del 1851, comincia a disegnare con tratti nettissimi un progetto teorico funzionale a fornire fondazioni a quanto bolle nella pentola del crogiuolo politico. Il titolo della ‘prolusione’ è eloquente:”Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti”2, e, al suo centro, sta la contrapposizione dirompente fra Stato e nazione. Da un lato, la nazione che “è la società naturale di uomini da unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale”3, dall’altro, lo Stato, soggetto politico artificiale e arbitrario, frutto ben spesso di esercizii potestativi, di compromissioni e di abusi dei poteri supremi. E’ scoperta la sottostante proposta da calare nella effettività storica: i tanti staterelli, in cui è divisa la penisola italiana, frammentano a causa della loro artificiosità un territorio che è, invece, unitario, perché proiezione geografica di una nazione unitaria. Il rilievo della ‘prolusione’ manciniana è di rendere squisitamente giuridico un principio già affermato a livello etno/culturale nell’età romantica, offrendo l’inoppugnabile impostazione teorica perché, di lì a poco, nel congresso di Parigi del 1856, Cavour potesse parlare fondatamente di unità nazionale italiana. 4 – Con il 1861 si può, finalmente, parlare di unità politica, che si estende alla maggior parte del territorio peninsulare; ed è significativo che il nuovo Stato tenda prontamente a tradurre quella proiezione unitaria sul piano giuridico. In un momento di imperante positivismo giuridico, quando cioè non si è ancora incrinata l’immagine tutta moderna di un diritto che si identifica in un complesso di leggi (ossia di 1
Pasquale Stanislao Mancini (1817‐1888), dapprima brillantissimo avvocato, poi uomo politico e uomo di scienza; come politico, fu più volte Ministro del regno unitario, come uomo di scienza dette contributi fondamentali soprattutto nel diritto penale e nel diritto internazionale privato. 2
P. S. MANCINI, Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, a cura di E. Jayme, Torino Giappichelli, 1994. 3
MANCINI, Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, cit., pp. 44/45. 3 manifestazioni d’una volontà sovrana), il programma è quello di porre mano senza indugii alla unificazione legislativa. E già nel 1865 si ha la realizzazione di una parte sostanziosa di questo grosso sforzo unificativo. E’ l’anno della prima codificazione unitaria, che investe la sfera dei rapporti privati dei cittadini nella loro vita quotidiana, del commercio, del processo civile, del processo penale; e sono, infatti, promulgati il ‘Codice Civile’, il ‘Codice di commercio’, il ‘Codice di procedura civile’, il ‘Codice di procedura penale’; per la sfera del diritto penale sostanziale, terreno delicatissimo con riflessi rilevanti sia sul piano dell’ordine pubblico sia su quello della libertà e dignità del cittadino, resta ancora in vigore (esteso a tutto il nuovo regno con l’eccezione della Toscana) il Codice sardo del 18594. E’ una codificazione che ha un modello dominante, quello napoleonico dei primi anni del secolo, quel modello che si era imposto sugli stessi staterelli italiani pre‐unitarii malgrado che la quasi totalità di essi gravitasse politicamente nella piena influenza austriaca; ed è una codificazione che reca evidentissima nelle sue trame una imitazione spesso servile. Le ragioni di un simile atteggiamento sono presto dette, e giustificano il generale successo dell’esperimento francese fuori del regno di Francia, soprattutto del ‘Code Civil’: soddisfaceva quella che era stata la incalzante aspirazione della progrediente borghesia per tanti secoli frustrata dagli incatenamenti cetuali dell’antico regime, e cioè il consolidamento nelle sue mani della proprietà e particolarmente della proprietà immobiliare, della proprietà della terra che è ancora – a fine Settecento ‐ il bene per eccellenza e la fonte di un reddito sicuro. La grande rivoluzione aveva – negli anni immediatamente successivi al 1789 – cancellato proibizioni e condizionamenti di ceto, consentendo a Napoleone di poter realizzare con il ‘Code Civil’ l’antico sogno borghese della proiezione di ogni homo oeconomicus moderno nella rassicurante proprietà del fondo rustico, del podere, come si è affermato nella mia Toscana fino a ieri con un termine che esprime bene la fusione di potere e ricchezza. L’imitazione, da parte del legislatore italiano, si poneva pertanto come naturale, anche se fa della nostra codificazione una manifestazione decisamente ancillare. Precisando, però, anche che la scienza giuridica nostra riuscì a imprimere soluzioni di schietta autonomia in zone di grande rilievo sociale e tecnico. Ne citiamo due soltanto ( anche se l’esemplificazione potrebbe essere più estesa): a) si inseriscono nella ufficialità del diritto legale le persone giuridiche (i corpi morali, come recita l’articolo 2 del Codice Civile), le antiche protagoniste dell’ordine giuridico medievale e pos‐medievale, cancellate totalmente e artificialmente dalla iconoclastia dei rivoluzionarii ma restate presenza costante negli strati latenti della società quali ineliminabili strumenti organizzativi dell’esperienza quotidiana; b) frutto di una visione lungimirante e coraggiosa della scienza giuridica italiana (come non ricordare, anche su questo punto, l’opera brillante e generosa di Pasquale Stanislao Mancini?), nell’articolo 3 del Codice Civile lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino. 5 – Se, a un esame spassionato della codificazione unitaria del 1865, l’atteggiamento imitatorio di un modello transalpino appare prevalente, v’è un campo ‐ ed è campo storicamente vitale – dove una scienza giuridica autenticamente italiana mostra un vólto originale e antesignano: il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, il problema dello stra‐potere (e, quindi, degli abusi) del mostro vorace 4
Cfr. G. VASSALLI, Codice Penale, in Enciclopedia del diritto, VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 261 ss.. 4 identificabile nella pubblica amministrazione, l’esigenza di offrire al cittadino inerme da parte del costruendo diritto italiano una corazza difensiva e un presidio efficiente. E’ questo il motivo ricorrente nei primi trenta anni di storia unitaria , ed è questo il maggior titolo di merito di una scienza giuridica consapevole d’essere gravata d’un impegno che è etico/politico prima ancora che culturale e tecnico/giuridico. Un testo, che riassume puntualmente l’immagine di una riflessione scientificamente impegnata nella costruzione di un progetto teorico traducibile in realtà politico/giuridica, è il discorso – giustamente celebrato – che il ‘giurista’ Silvio Spaventa, fratello del filosofo idealista Bertrando5, pronuncia nel 1880. Il titolo scolpisce con efficacia il tema e il sottostante problema che stanno a cuore all’oratore:”Giustizia nell’amministrazione”6; è quasi l’emblema riassuntivo di un lungo martellìo scientifico. Afferma Spaventa, senza tergiversazioni, che “il problema della giustizia e della legalità dell’amministrazione è il maggiore [corsivo mio] che s’incontra nella vita dei governi parlamentari, massime oggi che l’amministrazione pubblica degli stati moderni ha preso tali dimensioni e sviluppi da non potersi numerare i rapporti, in cui i cittadini si trovano con essa ad ogni loro passo”. Facendo seguire una proposta che tolga immediatamente dal vago l’affermazione:”occorre una revisione di tutte le norme giuridiche della nostra amministrazione per riconoscere se esse contengano garentie sufficienti della libertà e proprietà dei cittadini”7. Il Parlamento, che è ormai italiano, dietro lo stimolo di giuristi consapevoli, non manca di affrontare il difficile problema e tenta di risolverlo ponendo al centro delle sue attenzioni la maggiore salvaguardia del cittadino. Tra quei giuristi spicca vigile la presenza di Mancini, il quale – nel giugno del 1864 – in un discorso in seno alla discussione parlamentare – rilevando il gran fermento scientifico/politico in atto, constata con soddisfazione che si va profilando “un primo tentativo di emancipazione delle nostre istituzioni dalle francesi, un primo tentativo di abituare l’Italia a pensare da sé…di mostrare che può ordinarsi e vivere con istituzioni italiane”8. Istituzioni italiane: non più, dunque, l’imitazione di modelli realizzati altrove anche se appartenenti alla coinè borghese europea9, ma un cammino autonomo che comincia e l’avvìo del formarsi di un diritto italiano in grazia della sua specifica sostanza culturale e tecnica. E, dapprima nel 1865 (contemporaneamente alla codificazione unitaria), indi nel 1889, si hanno in Italia due complessi legislativi 5
Silvio Spaventa (1822‐1893), uomo politico, più volte Ministro, indi consigliere di Stato. 6
S. SPAVENTA, Giustizia nell’amministrazione, ora in S. S., Giustizia nell’amministrazione e altri scritti, Napoli, Istituto Italiano di Studi Filosofici, 2006. 7
SPAVENTA, Giustizia nell’amministrazione, cit., rispettivamente pp. 20 e 30. 8
MANCINI, discorso tenuto alla Camera dei Deputati nel giugno 1864 (cfr. A. SALANDRA, La giustizia amministrativa nei governi liberi, Torino, UTE, 1904, p. 312 ss.. 9
E’ doveroso segnalare che uno stimolo ispiratore lo si trasse dalla carta costituzionale belga. 5 ammirevoli per la tensione che li sorregge a disciplinare in maniera non autoritaria il nodo problematico dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione10. Nel’65 si provvide alla abolizione dei ‘Tribunali del contenzioso amministrativo’, che, modellati su stampo francese, avevano assolto la funzione di sottomettere a un giudice questioni di diritto pubblico insindacabili nei precedenti regimi assoluti, ma che erano viziati nella loro funzionalità dal fatto che i giudici, provenienti dalla Amministrazione Pubblica e in essa inquadrati, erano sostanzialmente compromessi nella loro imparzialità. Contemporaneamente, si attribuì al giudice ordinario la conoscenza dei diritti (civili e politici) dei cittadini lesi dalla Pubblica Amministrazione. Ispiràndosi a una effettiva separazione fra i poteri dello Stato, si affermò, in tal modo, il principio che i rapporti, in cui la Pubblica Amministrazione era parte, dovessero essere giudicati da chi offriva la massima garanzia di assoluta indipendenza. Il progetto ha un suo compimento nell’89, quando si dà un giudice alle situazioni che la legge del’65 aveva lasciato senza tutela giurisdizionale. 6 – Ma v’è un’altra tappa del cammino, che merita di essere sottolineata. Nel 1889 il vuoto rappresentato nella codificazione del’65 dal diritto penale sostanziale viene colmato. Chi sono i protagonisti? Innanzi tutto, il Guardasigilli Zanardelli11, il cui nome sarà –dipoi – sempre legato a questo Codice, e l’omnipresente Mancini, ma, insieme, tutta una scienza giuridica nostra di notevolissime qualità. Finalmente, si realizzava in Italia quella che, come notava giustamente lo stesso Zanardelli, era “la più urgente delle leggi”12. E’ oltremodo significativo che si tratti di un Codice pensato, progettato, redatto con caratteri di indiscutibile originalità, e Codice – per tanti versi – anticipatorio rispetto alle molte coeve sperimentazioni europee. Ėccone i tratti essenziali: abolizione della pena di morte; distinzione fra delitti e contravvenzioni, fra reclusione e detenzione in stretto rapporto alla gravità dei fatti criminosi; funzione decisamente educativa della pena. 7 – Già con quel che si è detto fino ad ora, mi sembra che sia stata completamente smentita l’immagine di una corporazione italiana di giuristi avulsa dal contesto storico e impassibile di fronte alle domande dello Stato nascente. Il diritto appare – al contrario – il nerbo e la dimensione caratteristici del nuovo Stato, con i giuristi né impassibili né estranei, ma anzi coinvolti nella comune edificazione e impegnatissimi in una adeguata cementazione della costruenda struttura. 10
Si tratta della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E e della Legge 31 marzo 1889, n. 5992. 11
Giuseppe Zanardelli (1826‐1904), uomo politico, fu più volte Ministro (tra l’altro, Ministro di Grazia e Giustizia dal 1881 al 1883, dall’87 al’91, da’97 al’98. Su di lui cfr., da ultimo, G. FRIGO, Giuseppe Zanardelli e la costruzione giuridica dello Stato: un’eredità che vive, in Studi e ricerche su Giuseppe Zanardelli e il suo tempo, Brescia, UBI‐Banca di Valle Camonica, 2010. 12
Cfr. G. VASSALLI, Codice Penale, cit., p. 267. 6 E’ questa la coscienza etico/politica e l’azione intellettuale almeno dei più consapevoli. Soprattutto sul piano della scienza del diritto pubblico comincia a circolare l’esigenza di offrire alla prassi politica unitaria strumenti più adeguati, e si fa strada la percezione dell’urgenza di strumenti tecnici sostanzialmente nuovi; è a questa invenzione che il giuspubblicista viene chiamato. Non giovava guardarsi dietro le proprie spalle, dove il paesaggio era ben diverso da quello della scienza del diritto privato guidata dalle lontane maestose architetture del diritto romano e dello ius commune, dalle raffinate analisi della riflessione pandettistica tedesca ancora in corso, dalle limpide riduzioni sistematiche di tanti Codici ottocenteschi. Qui, sul piano del diritto pubblico, c’erano due guasti da sanare: un vuoto scientifico, che aveva appena cominciato a colmare – dalla metà del secolo – il tentativo scientifico dei primi analisti tedeschi13; una indebita mistione – clamorosamente evidente nei grossolani dissodatori italiani – fra giuridico e meta/giuridico, fra diritto pubblico, scienza politica, scienza dell’amministrazione, sociologia, filosofia politica, dando vita a una produzione troppo spesso pseudo‐
scientifica perché dominata dalle nebbie di una metodologia malcerta e approdante a un paesaggio decisamente confuso. Occorreva rompere con questa diffusa inconsapevolezza, che toglieva ogni capacità di visione autonoma al giurista e anche ogni possibilità di adeguate messe a fuoco; occorreva rompere e, se necessario, distruggere, ma anche segnalare un sentiero rassicurante per il futuro itinerario. A questo provvide per primo un giovane giureconsulto siciliano, Vittorio Emanuele Orlando, futuro protagonista della vita politica novecentesca14, il quale si rendeva conto dell’esigenza per lo Stato unitario d’una intelaiatura giuspubblicistica che non si concretasse in disegni fumosi, bensì in un apparato tecnico‐
giuridico che potesse fungere da robusta fondazione; e Orlando èleva forte la sua voce salendo a Palermo, l’8 gennaio del 1889, la cattedra di ‘diritto amministrativo’ e pronunciando la prolusione che si annunciava altamente progettuale fin dalla intitolazione:” I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico”15. Ai fini di questa lezione non interessa seguire Orlando nei contenuti della sua proposta; ci interessa, invece (questo sì!), rilevare il ruolo di cui il giovane cultore del diritto pubblico si sentiva investito. Ecco una frase estremamente espressiva di quell’incisiva ‘prolusione’:”a noi, cui la meravigliosa storia del Risorgimento conferì l’esistenza di uno Stato nazionale e libero, se non fu dato in sorte di potere a quella storia cooperare [Orlando era, infatti, nato nel 1860, ed era, quindi, appena ventinovenne], è però assegnato un altro compito delicatissimo e solenne, che richiede il fervore della nostra attività e l’ispirazione di motivi ancora più ideali che non quelli meramente scientifici. Il sangue dei martiri e il 13
I primi nomi che vengono alla mente sono quelli di Carl Friedrich von Gerber, Paul Laband, Georg Jellinek. 14
Vittorio Emanuele Orlando (1860‐1952), avvocato, uomo di scienza, indi politico; fu diverse volte Ministro e dal 1917 al 1919 Presidente del Consiglio. 15
Ora in V. E. ORLANDO, Diritto pubblico generale. Scritti varii coordinati in sistema (1881‐1940), Milano, Giuffrè, 1940. 7 consiglio degli statisti ci diede lo Stato italiano, la scuola giuridica deve essa ora dare la scienza del diritto pubblico italiano”16. Se può facilmente conquistare un émpito retorico di notevole rango, lo storico del diritto fissa piuttosto la sua attenzione sulla pretesa del giovane scienziato di non realizzare solo un ‘ideale meramente scientifico’, ma di inserire quell’ideale – pur grande e sacrosanto – in una edificazione di altissimo rilievo etico politico sociale. E comincia con Orlando una riflessione giuspubblicistica che consolida la struttura statuale stimolando una sempre maggiore armonizzazione – anche se lenta e faticosa – fra diritti del cittadino e poteri dell’apparato organizzativo pubblico. 8 – Sì! Quegli aggettivi non sono stati scelti a caso, perché si tratta di un itinerario lento e faticoso; aggiungendo che sarebbe stato ancora più lento e faticoso, se lo Stato italiano non avesse cominciato a incrinarsi nella sua rigidità oligarchica in seguito ai disordini sociali dell’ultimo decennio del secolo XIX. Ignorati dalla vecchia storiografia filo‐risorgimentale e filo‐sabauda troppo tesa a disegnarci un paesaggio decisamente oleografico, valorizzati da una storiografia finalmente attenta alla dimensione socio‐
economica, quei disordini costituiscono il segnale, tragico ma sonoro, di uno Stato oligarchico che non riesce più a controllare il magma sociale e di una società che tenta di scrollarsi di dosso le catene di una struttura politica pseudo‐democratica. Che di oligarchia censitaria si trattasse lo dimostrano due elementari puntualizzazioni: nel 1861, primo anno della nuova storia, ha accesso al voto meno del 2 % dell’elettorato maschile, mentre per la realizzazione di un suffragio universale (riservato ai soli maschi, e non proprio a tutti) occorrerà attendere il 191317. Lo Stato unitario italiano reca nel profondo dei suoi basamenti l’impronta della rivoluzione francese, e sotto due profili. Si vanifica ogni articolazione cetuale, liberàndone completamente il cittadino, che ormai si erge solitario nella sua individualità. Si afferma, di conseguenza, l’uguaglianza di ogni soggetto di fronte allo Stato, contentàndosi però di una uguaglianza giuridica che conserva intatte tutte le differenziazioni fattuali tra ricchi e poveri. Il ricco, anzi, vede pienamente tutelate le due espressioni della propria libertà di azione economica, e cioè la proprietà individuale e il contratto (la proprietà, affermazione del suo potere sulle cose, e il contratto, affermazione della loro libera circolazione). Il liberalismo economico è al cuore dello Stato così come è architettato dalla Rivoluzione e realizzato da Napoleone e dalle democrazie parlamentari ottocentesche; e il diritto civile, quale complesso di regole disciplinanti i rapporti privati tra privati, è al cuore del nuovo ordine giuridico, mentre il Codice Civile, dove trovano salvaguardia proprietà e contratto, è la vera costituzione, ossia la vera norma fondamentale di quell’ordine. A questo profilo sostanziale se ne deve aggiungere un altro non meno considerevole. L’ampio liberalismo economico non può non tradursi sul piano giuridico in un autentico assolutismo, ossia in un regime che non dà spazio a modificazioni della strutturazione borghese di Stato e società. Il che viene 16
ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, cit., p. 21. 17
Mi sia consentito di rinviare a una mia recentissima sintesi: P. GROSSI, Novecento giuridico ‐ Un secolo pos‐moderno, Napoli, Università Suor Orsola Benincasa, 2011. 8 attuato togliendo di mezzo ogni pluralismo giuridico, consegnando la produzione del diritto nelle sole mani affidanti dell’apparato statuale e realizzando un rigido monismo assolutistico: il diritto viene a identificarsi (io direi: a rattrappirsi, a ridursi) in un’unica fonte, la legge, ossia nella manifestazione del potere politico, immobilizzàndolo per sempre (questo è, almeno, l’intendimento) e garantendo all’abbiente la piena sicurezza per il suo patrimonio. Al cittadino qualunque, quello privo di beni, resta la minestra di lenticchie della uguaglianza giuridica, che si riduce beffardamente a queste due pseudo‐conquiste: non ci sono ostacoli giuridici a che lui diventi proprietario (con la conseguenza – inespressa ma implicita – che, ove ciò non avvenga, è solo da imputare alla sua pigrizia o stoltezza); egli gode una parità giuridica all’interno del contratto (anche se è beffarda la parità formale tra l’elefante e il topolino clamorosamente smentita dalla concretezza dei fatti). Insomma, la modernità giuridica compie un primo grosso passo affrancatorio dalle iniquità strutturali proprie dell’antico regime, ma, avendo a sua indefettibile caratterizzazione un deciso individualismo proprietario, si rifiuta di compiere quel secondo passo che avrebbe tolto dal limbo della virtualità i sublimi principii perentoriamente affermati e avrebbe fatto sentire a ogni francese – anche al pezzente della strada – il ritornello monotono della égalité come una difesa anche sua, come una prerogativa che egli poteva calare nella effettività della sua esistenza quotidiana. Il perfetto castello murato di principii e di regole esauriva, invece, quella sua perfezione su di un piano formale, e il diritto privato consolidato nei Codici di Napoleone si presentava con due tipizzazioni – la purezza e la astrattezza – che ne sacrificavano irrimediabilmente la storicità, ossia la sua capacità di ordinare effettivamente la società. A fine Ottocento la separazione fra diritto legale e società aveva assunto proporzioni allarmanti, mentre l’uguaglianza galleggiava distante da quel crogiuolo socio‐economico dove il nulla‐tenente appariva sempre più povero e sempre più sfruttato. I disordini sociali, talora cruentissimi, sono in Italia i segni di muraglie che si incrinano, che addirittura cedono all’incalzare di forze sempre meno dominabili scaturenti dal basso. E in basso riprendono lentamente forma, sollecitate da un ampio consenso, quelle formazioni sociali che la Rivoluzione aveva cancellato come pericolosi fattori di coagulazione sociale e di organizzazione d’una massa destinata (nei progetti del potere) a restare passivamente inerte. Se la maggioranza dei giuristi sembra paga dei suoi esercizii su una piattaforma legale occultante il ribollìo del sottosuolo, non sono poche le voci che esprimono disagio e pretendono riforme coraggiose: Emanuele Gianturco, uno dei più ammirati Maestri dell’Ateneo napoletano, non ha esitazione nel qualificare come una irrisione per il contraente economicamente debole la tanto declamata parità delle parti entro il contratto18; Cesare Vivante, il fondatore della moderna scienza del diritto commerciale in Italia, tuona contro una branca del diritto che è troppo modellata sugli interessi degli esercenti il commercio e che pertanto si presenta come un insieme di istituti pensati e risolti a favore di chi gioca un ruolo economicamente portante nell’ingranaggio dello Stato borghese19. 18
Nella ‘prolusione’ al ‘corso’ di Diritto Civile tenuta nell’Ateneo napoletano nel 1891, che Gianturco dèdica a un tema spinosissimo: L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale, ora in E. G., Opere giuridiche, vol. II, Roma, Libreria dello Stato, 1947, p. 25. 19
C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. I, Torino Bocca, 1893, Introduzione, pp. 15/16. Nella stessa direzione è la ‘prolusione’ di un giovane commercialista, allievo spirituale di Vivante, Angelo Sraffa, tenuta presso 9 Tenendo dietro alle istanze metodologiche del positivismo filosofico generalmente accolto nell’àmbito delle scienze naturalistiche, parecchi dei giuristi più giovani abbassano volentieri i loro occhi alle esperienze della vita quotidiana e osservano con sguardo ordinatore il livello incomposto ma concreto dei fatti, tentando di costruire su di essi il sistema di un nuovo diritto privato. E il rinnovatore Vivante, pubblicando nel 1893 il primo volume di un ampio “Trattato di diritto commerciale” non èsita a inserire tra le fonti formali del diritto anche la ‘Natura dei fatti’20. La codificazione resta – soprattutto per i civilisti – come un ineludibile condizionamento per la propria libertà di azione intellettuale; paradossalmente, il giurista che si separa con maggiori difficoltà dalla sua copertura all’ombra del Codice è proprio chi maneggia la realtà concretissima dei fatti di vita quotidiana. 9 – Diversa è la posizione dei gius‐pubblicisti: forti del supporto offerto da rilevanti testi legislativi nati dalla incandescenza della vita politica21, maneggiatori di un diritto – quello pubblico – che nessuno aveva mai pensato a codificare per la sua insopprimibile storicità, non avvertivano la tentazione di una scienza pura. I più sensibili di loro – e l’abbiamo, in parte, già visto – avevan fatto capo nelle loro riflessioni e proposte non al vago e meta‐storico soggetto di uno stato di natura mai esistito, ma a un cittadino ben inserito nel contesto del nuovo Stato unitario, spesso vittima degli abusi del potere e perciò da difendere nella quotidianità della sua esistenza. Qualcuno, dotato di occhi ben aguzzi e attento alla dinamica del movimento/mutamento assai intenso sul crinale tra i due secoli, non manca di rilevare una crisi emergente e serpeggiante, crisi dello Stato, crisi di un rigido modello statuale incapace ormai a resistere all’assedio minaccioso di quelle forze sociali ignorate o rimosse dal paesaggio giuridico ufficiale. E’ merito di uno dei più grandi giuristi italiani del Novecento, Santi Romano22, di avere in ripetuti saggi rilevato questa crisi e di averla individuata come la reazione del corpo sociale a un apparato giuridico ufficiale, artificiosamente costruito in alto e che, ormai, il basso della società sopportava come una soffocante costrizione23. l’Università di Macerata nel 1894 e intitolata: La lotta commerciale (in La scienza del diritto privato, II (1894), p. 220 ss.). 20
VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, cit., vol. I, lib. I, cap. I – Le fonti, §. 9 – Natura dei fatti. 21
Per esempio, quelli sopra menzionati del 1865 e del 1889 sulle garanzie per il cittadino di fronte alla pubblica amministrazione. 22
Santi Romano (1875‐1947) spaziò come scienziato nei campi del diritto costituzionale e amministrativo, nonché della teoria generale del diritto; fu docente in parecchie Università italiane insegnando sempre discipline giuspubblicistiche. Per lunghi anni, durante il ventennio fascista, ricoprì la carica di Presidente del Consiglio di Stato. 23
A questi saggi costituzionalistici di Santi Romano ho dedicato una distesa attenzione in: P. GROSSI, Scienza giuridica italiana ‐ Un profilo storico 1860/1950, Milano, Giuffrè, 2000, p. 111 ss., e in Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti (2006), ora in P. GROSSI, Nobiltà del diritto – Profili di giuristi, Milano, Giuffrè, 2008, p. 669 ss.. 10 Il suo discorso inaugurale all’Università di Pisa a fine del 1909 ( “Lo Stato moderno e la sua crisi”)24 raccoglie e sintetizza un generale disagio: un palcoscenico giuridico, dove soli protagonisti sono lo Stato, lo Stato/persona, e gli individui (in realtà, gli individui abbienti), senza che si dia spazio alle formazioni del ‘collettivo’ e del ‘sociale’, non è riproduttivo di uno scenario autenticamente storico. Occorre che lo Stato riscopra la complessità della società e se ne nutra; il rischio è, altrimenti, l’inaridimento e il distacco dalla vita, ossia dalla storia. La denuncia del riduzionismo posto in atto e ferreamente realizzato dalla modernità giuridica porta a non rinchiudersi in un bozzolo sterile e ad imboccare nuove strade che recùperino il diritto alla storicità del divenire sociale. Il progetto giuridico moderno – sembra dire Romano ‐ è stato pensato nei palazzi alti del potere ed è stato proiettato dall’alto sulla comunità dei cittadini; per questo sa di artificio. E’ da una siffatta diagnosi realistica che egli può arrivare a quel disegno completamente rinnovato del diritto che è la trama della sua penetrante meditazione teorica del 1918:”L’ordinamento giuridico”25. Romano lascia l’osservatorio troppo elevato costituito dalla volontà degli investiti del potere politico, lascia il terreno consueto delle manifestazioni di quella volontà, le leggi, per scendere più in basso e guardare al diritto da sotto in su. Da questo osservatorio capovolto – quello romaniano del 1918 – il diritto appare caratterizzarsi diversamente: più che comando è ordinamento; è, cioè, nella sua essenza e prima di tutto, un processo spontaneo della società che si auto‐ordina registrando valori e interessi diffusi e trasformàndoli in regole. Regole la cui genesi è dal basso e che vengono osservate perché condivise. Come dire: il diritto non è una patologia della società, né si concretizza in strumenti repressivi per dominarla; è, invece, una dimensione fisiologica, che si immedesima con la sua storia, la ordina e – ordinàndola – la salva dal caos di una rissa perenne e distruttiva. Romano non opera un innocuo cambio di nomenclatura, opera una autentica rivoluzione copernicana, riscoprendo quel vólto del diritto, che la modernità aveva totalmente alterato con le sue strategie assolutistiche. In questo egli dimostra di appartenere al secolo nuovo; e il suo messaggio culturale e tecnico rivela la filiazione da un tempo pos‐moderno che rifiuta le ipoteche del passato e si proietta nel futuro. 10 – Il diritto come ordinamento aveva un enorme significato per il cammino della scienza giuridica: il recupero di una dimensione oggettiva del diritto quale pròvvida conseguenza del rifiuto della passata concezione potestativa e imperativa; e, con quel recupero, il rifiuto di poter legittimamente (legittimamente, sul piano della correttezza metodologica) inseguire il disegno di una scienza pura, formale, non immiserita dall’inquinamento con i fatti (strutturali, economici, sociali). La rivoluzione copernicana avviata da Romano sta tutta qui: la riscoperta dei fatti quale naturale piattaforma del diritto, una riscoperta che percorrerà tutto il Novecento, accrescèndosi e addirittura ingigantèndosi via via che si arrivava all’immediato ieri e all’oggi. Il vizio del diritto moderno – lucidamente 24
Su cui, da ultimo: P. GROSSI, ‘Lo Stato moderno e la sua crisi’ (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano), in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, LXI (2011), p. 1 ss.. 25
Da leggersi nella seconda edizione riveduta dallo stesso Autore: Firenze, Sansoni, 1946. 11 voluto, perché facente parte di una precisa strategia, di una precisa politica del diritto – consiste, agli occhi dello storico, nell’aver ripudiato la carnalità del diritto, nell’averlo ridotto a una ossatura secca senza – addosso – né carne né sangue. Il nuovo diritto, quello di cui è araldo Romano, è, al contrario, sempre più contrassegnato dalla sua fattualità. E sarà il contrassegno per un intiero secolo, sarà il contrassegno del Novecento giuridico. Accanto a questa profonda revisione di ordine scientifico, darà mano e vigore a un siffatto indirizzo l’evento tragico ma incisivo chiamato da una ripugnante retorica nazionalistico/statalista “grande guerra”. E qui, negli anni sanguinosi dal’14 al’19, saranno gli stessi Stati dell’Europa continentale, quasi tutti coinvolti nell’avventura bellica da una parte o dall’altra, ad assecondare una pervasiva fattualizzazione del diritto. Ciò avviene grazie ad una massiccia legislazione eccezionale di guerra, necessaria per tener dietro ai bisogni urgenti della colossale e complessa macchina organizzativa della guerra, la quale era chiamata a fare i conti con la brutalità dei fatti soprattutto economici ma anche sociali. E’ un momento in cui la purezza formale del diritto appare quale lusso insopportabile. E sarà, quindi, proprio sul piano ufficiale – quello legislativo ‐ che si verranno a ledere principii fondamentali dell’ordine giuridico borghese26. Due esempii varranno a chiarire meglio: il dogma della assolutezza dei poteri del proprietario – il vero protagonista della civiltà moderna e a cui giovava non poco il mito della astrattezza – cede alle necessità economiche che impongono vincolazioni all’esercizio di quei poteri, soprattutto in ordine alla produzione di beni dalla rilevanza strategica; il dogma, apparentemente così suadente ma sostanzialmente così irridente, della parità giuridica delle parti nel contratto cede di fronte all’esigenza di tutelare certi contraenti economicamente deboli (com’è nella legislazione vincolistica delle locazioni). Si può eccepire che la prima guerra mondiale, anche se vicenda immane, è ristretta a qualche anno e si chiude – alla conclusione – in modo definitivo con il trattato di pace. E’ vero, invece, il contrario: la guerra allenta il controllo dei poteri politici sul diritto e permette, sia pure per il tramite di una legislazione considerata eccezionale e temporanea, che principii ritenuti intangibili siano infranti e che emergano soluzioni nuove non seppellite dalla fine dell’evento bellico. E’ rilevantissimo, anche per rigettare ancora una volta il luogo comune della impassibilità dei giuristi, che questi si accorgono della incidenza della guerra sull’evolversi del diritto europeo continentale, capiscono che non si tratta di episodii effimeri ma di segni di un tempo storico che cambia, dànno cospicua attenzione alla legislazione eccezionale raccogliendo da essa i semi per futuri raccolti27. 11 – La riscoperta della fattualità del diritto viene a incidere a fondo anche in seno allo stesso diritto civile. Era stato costruito da giuristi e legislatori come rigorosamente unitario per la più che fondata (e 26
Si veda nel mio volume di sintesi, L’Europa del diritto (Roma/Bari, Laterza, 2011) il capitolo intitolato:La prima guerra mondiale e la sua incidenza nell’ordine giuridico europeo (p. 229 ss.). Un’ampia informazione sui varii atti legislativi e sulla letteratura giuridica scritta in Italia a loro proposito è offerta da M. ROTONDI, Una legislazione di guerra (1915‐1924), ora in Scritti giuridici, vol. IV Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e di dottrina, Padova, Cedam, 1964. 27
Spiccano, fra i molti, gli interventi lucidissimi di Francesco Ferrara e di Filippo Vassalli. 12 fondamentale) ragione di assumere a suo protagonista non un soggetto socialmente ed economicamente specifico, ma il generico cittadino, concepito ancora come l’ultimo erede del remoto abitatore d’un originario meta‐storico stato di natura. Ma premono, dal di dentro delle sue muraglie chiuse, dei soggetti carnali che esigono spazii speciali corrispondenti alla loro specialità sociale, o assetti speciali della esperienza economica, che è vitale rispettare nella loro specialità al fine di ottenere risultati economicamente più cospicui. E l’unitarietà non può che rompersi, perché è soltanto una ferraglia ingombrante e impeditiva dello sviluppo economico‐
sociale; e prendono forma, proprio nei primi decennii del Novecento, con il conio sapiente dei giuristi e la condiscendenza dello stesso legislatore, il diritto del lavoro e il diritto agrario, due discipline che l’ordine giuridico borghese, nella sua strategia controllatrice, aveva ritenuto di inglobare (e far scomparire) nel grande ventre (questa volta, ventre non materno) del generico diritto civile. Non esistevano, infatti, come figure autonome, né un contratto di lavoro né il lavoratore subordinato, ma semplicemente un contratto unitario di locazione, una specie del quale – la locazione di opere – concerneva il lavoro subordinato; e il lavoratore altro non era che colui il quale locava all’imprenditore l’unico bene di cui disponeva, il lavoro, equiparato assolutamente a una cosa e pertanto brutalmente mercificato. Sul piano della costruzione tecnico‐giuridica, nel diritto ufficiale consegnato nei Codici (per esempio, nel Codice Civile italiano del 1865), locazione di cose e locazione di opere hanno, infatti, una identica struttura. L’indole di questa lezione non ci consente di seguire le tappe della eticamente e socialmente significativa emersione che viene ad autonomizzare il diritto del lavoro; ci basti segnalare che ciò avviene con un movimento estra‐legislativo, cioè dal basso, da una collaborazione fra scienza e prassi, perché i fatti lo esigono, e i fatti hanno ora – nel nuovo clima giuridico novecentesco – la forza di affermarsi e di emergere a livello del diritto28. Prende forma, nei primi anni Venti del secolo ventesimo, un’altra disciplina, la cui autonomia è fondata sulla specificità di taluni aspetti della realtà economica: il diritto agrario. Nel diritto civile unitario il rapporto uomo/cose si risolve in un istituto centrale e assorbente, la proprietà individuale, che è vissuta e realizzata tecnicamente come la proiezione potestativa del soggetto proprietario sulle cose; le quali sono soltanto l’ombra di lui nella realtà esteriore, pertanto oggetti di poteri e, in quanto mere ombre, del tutto prive di autonomia. Questa visione integralmente soggettiva del rapporto uomo/cose, tutta squilibrata a favore del titolare della proprietà, dovette fare i conti con l’esigenza di valorizzare le cose nella loro capacità produttiva, una esigenza che proprio la prima guerra mondiale e il disastro economico ad essa conseguente non poterono che esaltare. La cosa perdeva il suo anonimato e la sua genericità inerte; come res frugifera debitamente coltivata diventava fonte e garanzia di sopravvivenza e reclamava strumenti giuridici peculiari idonei ad intensificare questa sua vitale dimensione economica. Precisamente in questa ottica le cose venivano a diversificarsi, essendo un campo, un pascolo, un bosco ,uno stagno, oppure un terreno montano, o collinare, o pianeggiante, strutture diverse che solo appropriati e differenziati strumenti giuridici potevano valorizzare. La cosa – naturalmente, soprattutto la cosa produttiva – è il fatto agronomico ed economico degno di attenzione da parte dell’ordinamento giuridico e per il quale, all’interno del diritto civile generale, viene ad autonomizzarsi un settore ad essa dedicato: appunto il diritto 28
Cfr. GROSSI, L’Europa del diritto cit., p. IIa, cap. Alle origini del diritto del lavoro, p. 201 ss.. 13 agrario, che avrà in Italia, nel 1922, un primo foglio autonomo di analisi scientifica, la “Rivista di diritto agrario”29. 12 – Dai primordii del Novecento in poi si riscopre la fattualità del diritto, perché tende ad attenuarsi sempre più il distacco fra diritto e società, che era – sul continente – nei programmi della modernità borghese. Con la reimmersione del diritto nella società il palcoscenico storico‐giuridico si fa più movimentato, più complesso, e si attenua quella che era stata la puntigliosa riduzione di ogni rapporto giuridico a rapporto individuale. Tutto ciò che sapeva di comune, di sociale, di collettivo doveva essere rimosso per il suo alto grado di perturbazione dell’ordine costituito. Dietro gli ascoltatissimi mèntori della classicità romana si continuava a ripetere che ‘communio est mater malorum’, fosse anche un innocuo condominio o la società la più semplice, che non potevano mai arrivare a forzare il libero consenso di condomini e socii e la loro volontà di sciogliersi dagli impacci del regime comune. Il Novecento, che pùllula ormai di formazioni sociali dove il cittadino più inerme può trovare rifugio e tutela, comincia a riscoprire proprio quelle dimensioni del ‘giuridico’ che la modernità aveva drasticamente eliminato. La civiltà mono‐classe è agli sgóccioli, e il montante pluralismo giuridico è il segnacolo del nuovo assetto pluri‐classe che tende a investire della produzione del diritto settori sempre più ampii della società; e la società risponde con manifestazioni che si caratterizzano nella loro novità per essere ‘sociali’ e ‘collettive’. Si parla fittamente perfino di contratto collettivo, alterando e snaturando quel nucleo portante dei Codici Civili che è il contratto, pensato e risolto sempre come espressione della libera volontà individuale. Anche se proveniente da una pluralità, il contratto è, infatti, sempre imputabile a una somma di individui. Invece, dall’inizio del secolo, è sulla bocca di molti il sintagma ereticale contratto collettivo, respinto da altrettanti molti come una minaccia alla stabilità dell’ordine pubblico; e lo stesso legislatore italiano, cedendo all’onda montante, redige progetti per ufficializzare il nuovo strumento30. 13 – Di una dimensione ‘collettiva’ del diritto si parla sempre di più nei primi tre decennii del Novecento, almeno in quelle zone dell’Europa continentale vivificate economicamente dalla rivoluzione industriale e socialmente da una presenza non inerte di ampie masse popolari. Quel che più importa allo storico di notare è che se ne parla in un modo che è risolutamente nuovo. La civiltà borghese aveva seppellito il ‘collettivo’ e il ‘sociale’ nello Stato, ossia li aveva annullati all’interno di una entità politica concepita come persona e, in quanto persona, una e unitaria, compattissima nella sua acquisita e gelosamente conservata soggettività. Ma ora, nei primordii del 29
Cfr. ,più distesamente, GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., cap.VI, §. 5 Una disciplina di nuovo conio: il diritto agrario, p. 239 ss.. 30
GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., cap. IV, §. 3 intitolato La ‘Rivista di diritto commerciale’: alla ricerca del contratto collettivo e individuale di lavoro, p. 97 ss.. 14 Novecento, si parla di un ‘collettivo’ che è al di là dello Stato o, addirittura, che è, geneticamente, prima dello Stato. E vi si unisce una idea – rovinosa per il serrato e impenetrabile modello giacobino adottato dal potere borghese ‐ di Stato/comunità, di uno Stato che è comunità di tante e funzionalmente diverse comunità. Accanto alla palingenesi della nozione di ‘collettivo’, è anche quella di ‘pubblico’ a subire una interna sostanziosa trasformazione: anche qui la si sottrae dalla fagocitazione entro lo Stato, recuperando tutta una serie di situazioni ‘pubbliche’ della società al di fuori dell’apparato potestativo statuale. Lo sguardo dei giuristi non è più monopolizzato dalla assorbente sirena statuale, ma si rivolge attento alle articolazioni complesse della società, compiendo il recupero della pluralità della struttura sociale. E’ un atteggiamento che potremmo – lato sensu – qualificare corporativistico, assumendo questo termine – che suona equivoco dopo tutte le scelte autoritarie in tal senso nel corso della prima metà del Novecento – nel suo primo significato, estremamente carico di storicità, di segno della crisi della modernità borghese e di tentativo di una sua soluzione mediante un nuovo assetto socio‐economico‐politico. Una versione autenticamente pluralistica e, quindi, autenticamente democratica è quella realizzata nell’immediato primo dopoguerra dal corporativismo weimariano, dove una kollektive Demokratie è edificata grazie al contributo decisivo di una scienza giuridica tedesca che aveva affinato i suoi strumenti teoretici già nel clima economicamente vivace dello scorcio dell’Impero guglielmino31. Il giurista Hugo Sinzheimer, uno dei fondatori della moderna scienza del diritto del lavoro, è nel nòvero di questi costruttori; forse, il più fornito di un ampio respiro culturale. Nel suo progetto, perfettamente realizzato con l’esperimento inaugurato in Germania nel 1919, la corporazione sindacale è al centro dello Stato/comunità weimariano nella sua duplice veste di cellula essenziale dell’ingranaggio statuale e di soggetto di un rapporto contrattuale con lo stesso Stato32. Questa apparente digressione sulla storia giuridica tedesca serve egregiamente, sia per mostrare i diversi vólti (taluni autenticamente democratici) che il corporativismo può assumere, sia per introdurci alla scelta corporativistica effettuata dal regime fascista in Italia con la Legge 3 aprile 1926 sulla disciplina dei rapporti di lavoro. Una scelta che non può essere passata sotto silenzio nel nostro sommario disegno dell’itinerario del diritto nella storia dell’Italia unita relegàndola tra le effimere e dimenticabili soluzioni di un regime autoritario; e questo proprio per la equivocità e il multiformismo di cui è carico ogni corporativismo, e anche quello italiano. Il quale è indubbiamente la versione autoritaria di una esperienza corporativistica, ma che non ha mancato di nutrire in sé alcuni aspetti positivi, e di proiettarsi positivamente anche nel nuovo diritto che si costruirà in Italia dopo il 1945. E cominciamo con una premessa orientatrice: la scelta fascista consolidata nel 1926 fu più subìta che voluta. Antiliberale e anticomunista, il fascismo si trovò pressoché obbligato a una soluzione mediana, ma ne ebbe sempre una sostanziale diffidenza cercando di snaturare le tipicità corporativistiche e rinviando la concretizzazione di una struttura effettivamente corporativistica: della quale si avviò la realizzazione solo alla fine, nel 1941. 31
GROSSI, L’Europa del diritto, cit., p. III, cap. 4 Il comunitarismo weimariano. 32
Ibidem, in particolare p. 236. 15 Anche in questa architettura ingabbiata e soffocata da ingessature autoritarie, anche in questo pseudo‐corporativismo che ci appare come il contrapposto dell’edificio weimariano, osservatori acuti ed abili poterono tentar di individuare le latenti ma insopprimibili venature pluralistiche di ogni assetto corporativistico e valorizzarle almeno a livello teorico. E nella scienza giuridica italiana dei tardi anni Venti e degli anni Trenta, vi fu chi ne approfittò per avanzare riflessioni gremite di futuro e che nel futuro pos/fascista sarebbero state raccolte e utilizzate. I temi/problemi di maggior spessore costruttivo furono i seguenti: il rapporto diritto/economia, diritto/fattualità economica, puntando su quella auto‐gestione delle forze economiche di cui si parlava ufficialmente sia pure di malavoglia; statalismo/pluralismo; visione rinnovata della dialettica pubblico/privato; valorizzazione della dimensione collettiva anche estra‐statuale33; revisione della dottrina delle fonti del diritto; collaborazione fra capitale e lavoro, anche se ridotta dalle trombe ufficiali a semplice conclamazione retorica. Pretesti preziosi per una riflessione scientifica che interpretò a suo modo affermazioni e soluzioni prospettate dal Regime, cogliendo in esse quel nucleo secreto che c’era al fondo e consistente nella loro sicura collocazione in un tempo pos‐moderno quali superamenti delle posizioni dell’individualismo borghese. Il primo nome che si deve fare è quello di Costantino Mortati, giuspubblicista che definisce il suo progetto scientifico negli anni Quaranta e che sarà, dopo il 1945, uno dei redattori della carta costituzionale repubblicana e dei costruttori del nuovo Stato democratico. Infatti, è proprio Mortati che, nel 1940, redige il suo manifesto programmatico pubblicando “La costituzione in senso materiale”, dove l’idea direttrice essenziale è quella di concepire la Costituzione formale – ossia il testo cartaceo fissato in articoli che, a loro volta, stabilizzano principii e regole – quale espressione di un indirizzo fondamentale scaturente dalla stessa comunità; ragion per cui il cómpito del costituzionalista è quello di “ricercare un contenuto della costituzione, che sia indipendente dalle particolarità delle singole figure storiche di Stato”34, cosicché “la sua funzione, sempre uguale, qualunque sia il tipo di ordinamento, si esplica nel conferire stabilità alla forma di Stato sorta per suo mezzo”35. Qualcuno ha qualificato come fascista una siffatta concezione, pensando alla legittimazione che essa veniva a dare, nel 1940, al partito, al partito unico, ma ha ragione, invece, chi, riflettèndoci sopra in un momento successivo e spogliàndosi di umori mal consiglianti, ha puntualizzato due rilievi: “la costituzione in senso materiale non è una concezione fascista dello Stato, ma una concezione dello Stato applicabile (e applicata) a quello fascista”;” l’influenza maggiore che essa ha esercitato non è stata nel tempo in cui e per cui fu elaborata, ma durante l’opera di fondazione dello Stato repubblicano e nei suoi primi decenni di vita”36. 34
C. MORTATI, La Costituzione in senso materiale (1940) (ristampa, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky), Milano, Giuffrè, 1998, p. 8. 35
Ibidem, p. 11. 36
Così ZAGREBELSKY nella Premessa alla ristampa del 1998 presso Giuffrè (i due passi sono, rispettivamente, a p. XIII e XII). 16 Un secondo nome è quello del civilista Enrico Finzi, che non è sicuramente un adepto del fascismo e che utilizza il corporativismo quale strumento per superare lo statalismo asfittico dell’età dei Codici e per cogliere, autonomizzare e convenientemente disciplinare una realtà sempre più diffusa nel maturo Novecento, “il fenomeno delle pluralità collegate”, cioè delle “pluralità di soggetti o di cose, le quali devono concepirsi organicamente unite nella loro funzione economica”37 14 – Lo straordinario progresso tecnico e la ristrutturazione della organizzazione economica in conseguenza dello sviluppo nell’assetto capitalistico portano, nel primo Novecento, dapprima in Germania e in Austria‐Ungheria, successivamente anche in Italia a una presenza nuova e di grosso rilievo: l’impresa. Nel sistema economico‐giuridico della modernità, che è rigorosamente proprietario, tutto si risolveva in diritti e rapporti facenti capo a un soggetto protagonista, appunto il proprietario; ma il nuovo assetto del capitalismo ‐ dove la macro‐struttura delle cellule economiche si congiunge con un indispensabile corredo tecnico ‐ chiede a gran voce che si deponga l’esasperato soggettivismo ormai nocivo al raggiungimento del maggior prodotto e del maggior profitto, per dare vita a una proiezione più oggettiva, marcatamente de‐personalizzata. Il che si realizza con l’impresa: che non è un soggetto nuovo, bensì una concezione nuova della relazione tra proprietà e gestione efficiente della dinamica economica, che dà vita a una collettività di persone cose servizii completamente interagenti. L’impresa, infatti, è un meccanismo organizzativo finalizzato alla massima efficienza e, conseguentemente, al massimo profitto ricavabile. E’ il momento dell’organizzazione che tipicizza l’impresa38. Come organizzazione, è un ingranaggio che ha regole oggettive, rispetto alle quali la volontà del proprietario non ha che ridotte possibilità di incidenza. Come organizzazione, è creatura nuova in un paesaggio giuridico che conosceva solo diritti e rapporti, perché rappresenta il primato della dimensione economica, l’abbandono totale della dimensione etico/politica e la subordinazione di interessi individuali alla funzionalità del complesso organizzativo. Come organizzazione, è più contrassegnata dalle responsabilità delle persone in essa coinvolte che dai loro diritti soggettivi, diritti – ohimè! – destinati ad affievolirsi di fronte ai bisogni oggettivi dell’intiero ingranaggio. L’inserimento del lavoro e dei fatti economici entro lo schema dell’impresa è, innanzi tutto, il risultato di un progetto scientifico che orecchia quanto una lucida e preveggente dottrina austro‐tedesca aveva cominciato a disegnare fin dai primi anni del Novecento in territorii dove già fioriva un capitalismo maturo. In Italia c’è di più. Durante l’elaborazione del Codice Civile del 1942, Codice che, come si sa, realizza la compiuta unità legislativa delle due – tradizionalmente divise – discipline del diritto civile e del diritto commerciale, l’impresa, grazie alle conoscenze comparatistiche e alla sensibilità per la dinamica storica dei 37
E. FINZI, Verso un nuovo diritto del commercio, in Annuario del R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Firenze, a. a. 1932/33, p. 21). 38
Cfr. P. GROSSI, Itinerarii dell’impresa, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 28 (1999); F. MAZZARELLA, La scoperta di un paradigma complesso. L’ “Unternehmen” nel diritto commerciale e nella dottrina austro‐tedesca del primo Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 39 (2010). 17 grandi giuristi italiani membri della Commissione redattrice, diventa la categoria fondamentale unificante dell’intiero libro quinto dedicato al lavoro; dove, prima di trattare delle imprese agraria e commerciale, si discorre ‘Dell’impresa in generale’ (articolo 2082 ss.). 15 – E’ ora opportuno, per la miglior chiarezza del discorso, riassumere i segni rilevantissimi di novità, che ho sparsamente indicato e che si accumulano (e anche si ingigantiscono) nel corso del Novecento; il quale ci appare – dal nostro osservatorio, che è quello giuridico – come un secolo di riscoperte. Il diritto non galleggia più, alto, al di sopra della società, ma vi si mescola perennemente, tendendo a registrare le istanze che in basso si orìginano, cìrcolano e reclamano accoglimento a livello ufficiale. Necessariamente, perde la limpidità e la purezza delle geometrie disegnate con tanta convinzione nell’età dei lumi e dei Codici in una visione elitaria che pretendeva di porsi come sopraordinata ai fatti e di costringere i fatti in una rete dalle maglie il più possibile strette. Il diritto novecentesco recupera in fattualità, e si segnala nuovamente per la sua carnalità; mescolàndosi con la società, che è fatta non di individui isolati e isolabili ma di nessi, di relazioni, di vincolazioni, recupera in socialità recando in sé una linea di tendenza valorizzante dimensioni prima rimosse, il ‘sociale’ e soprattutto il ‘collettivo’. Il guaio è che i fatti non sono cristalli geometrici, ma un arruffato – anche se vivacissimo – nascere divenire trasformarsi; e per ogni diritto fattuale il rischio è una caotica, indominabile alluvione. E’ indispensabile che il diritto metta ordine, raggiunga lo scopo essenziale dell’ordine; è indispensabile, cioè, che il diritto sia ordinamento. Non gioverebbe un complesso di ammirevoli imperativi, stilati in un impeccabile linguaggio tecnico, da legislatori e maestri di scienza giuridica chiusi in una stanza appartata del Ministero della Giustizia; giova, al contrario, un complesso di principii e regole nati dall’osservazione del magma sociale, del suo divenire, e cioè del suo comporsi disfarsi riassestarsi , facendo i conti con esso, registrando forze e bisogni e traducèndoli in imperativi, che saranno insuscettibili a essere scolpiti sulla pietra e disponibili, invece, al movimento/mutamento socio‐economico‐culturale. Va aggiunta una puntualizzazione rilevantissima. Una oggettiva osservazione, fatta con occhi ben ficcati nel profondo del sociale, registra però anche condivisioni diffuse che si sottraggono all’usura della relatività e che tendono a permanere, connesse come sono con le radicazioni di una comunità. Con questa succinta conclusione si offre all’uditore il messaggio più tipico del Novecento: la fattualità del diritto esige la riscoperta del diritto come ordinamento (ed è da qui che si può agevolmente misurare la lungimiranza – di più: la preveggenza – delle intuizioni di Santi Romano); la fattualità esige la necessaria duttilità del diritto, che con un vocabolo culturalmente più pregnante potremmo chiamare storicità; la fattualità rende pertanto rischiosa la riduzione totale e minuziosa di intiere branche giuridiche nelle trame strette e immobilizzanti di un Codice (almeno di un Codice pensato e realizzato alla maniera delle moderne codificazioni quale minuziosissima raccolta e sistemazione di definizioni, regole, dati). Una siffatta immersione del diritto nel relativo della storia non ha il significato di cedere alle sabbie mobili di un totale relativismo: come or ora si diceva, i valori, su cui si è spontaneamente costruita una determinata comunità, possono e debbono essere registrati e fissati. Non si possono scolpire sulla pietra, 18 giacché non si tratta di rivelazioni celesti; sono pur essi dei prodotti storici, ma, nella loro compenetrazione con la morale e il costume, con la loro posizione alle radici d’una civiltà, acquistano una durevolezza che conferisce stabilità a quella civiltà. E’ quanto avviene per tutto il corso del Novecento, da quando la prima guerra mondiale ha sconvolto l’edificio giuridico della modernità erodèndolo alle fondamenta e permettendo che si potesse dare mano a una costruzione essenzialmente nuova. Tratto saliente del nuovo edificio è la Costituzione, la nuova Costituzione, frutto del nuovo costituzionalismo novecentesco, al quale appartiene anche la nostra Carta del 1948. 16 – Perché si parla di nuovo costituzionalismo? Perché si tratta di soluzioni nuove al problema di fondo del costituzionalismo vecchio e nuovo, che è quello di fornire al cittadino una tutela verso la arroganza del potere politico; soluzioni provocate (anzi: pretese) dalle profonde novità del contesto novecentesco. Qui, come ben sappiamo, è l’irrompere della società, con la sua carica di fattualità, a caratterizzare il tempo storico, ed è, conseguentemente, l’irrompere ad ogni livello del suo tratto forte e tipizzante, la complessità. La struttura sociale mono‐classe va trasformàndosi in pluri‐classe e il pluralismo sociale preme sulla dimensione giuridica affinché questa essenziale trasformazione trovi anche in essa una puntuale registrazione. Uno dei risultati – il più vistoso e anche il più sostanzioso – lo si constata sul piano squisitamente costituzionale. Il costituzionalismo sei‐sette‐ottocentesco si era ben espresso nelle cosiddette ‘carte dei diritti’. Queste erano il frutto del grande movimento giusnaturalistico europeo e certamente furono – se non un traguardo – certamente una prima conquista nella salvaguardia delle libertà del cittadino. Originate, però, in circoli esclusivi di intellettuali, si concretarono in proposizioni filosofico‐politiche e soffrirono il vizio di misurarsi sempre e soltanto non sul cittadino operante quotidianamente nelle strade e nei mercati di Parigi, ma su quel soggetto metastorico che era l’individuo dello stato di natura. Vizio sì, giacché, non essendo mai esistito lo stato di natura ed essendo un puro artificio far capo ai suoi pretesi virtuali abitatori, tutto si risolveva nel disegno di un paesaggio astratto, artificioso come il fondale dipinto di un palcoscenico. Ed è proprio su questa astrattezza che aveva esercitato una critica impietosa l’aguzzo sguardo storicistico del giurista Santi Romano, personaggio ben immerso nel Novecento, quando – nei saggi costituzionalistici più sopra ricordati – aveva sprezzantemente qualificato la ‘prime carte dei diritti’ come ‘catechismi’, ‘decaloghi’, addirittura ‘panegirici’39. E’ ovvio che, quando, dopo lo scrollone della prima guerra mondiale, nel 1919, si comincia a costruire un nuovo edifico sulle rovine ancora fumanti e si comincia dalle fondamenta, si abbia un mutamento radicale su come si debba correttamente confezionare un testo costituzionale e sul ruolo che quel testo debba avere nel rapporto diventato problematico tra società e Stato. Ed è ovvio il ripudio totale della astrattezza e degli artificii di uno stato di natura e di un uomo primigenio quali fonti di legittimazione. 39
Diffusamente, in varii saggi, ma soprattutto nel discorso inaugurale tenuto alla Università di Modena nel 1907 e dedicato precisamente a Le prime carte costituzionali (ora in S. R., Lo Stato moderno e la sua crisi – Saggi di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1969. 19 17 – La nuova Costituzione è figlia del Novecento e, lungi dal disconoscere questa filiazione, intende proporsi come frutto del proprio tempo, di quella maturità di tempi che il Novecento esprime. E’, e vuole essere, pertanto, lettura fedele della società, quasi una trascrizione della sua realtà plurale, complessa. Io, altra volta, l’ho definita atto di ragione40, intendendo sottolineare non già che essa consistesse in un puro atto razionale, ma piuttosto che si concretasse in un atto di conoscenza più che in una volontà potestativa. La Costituzione novecentesca – in Germania, nel 1919, in Italia, nel 1948 – è, infatti, la lettura che una Assemblea Costituente compie della società che le si muove intorno, con il riuscito tentativo di sceverare – al di sotto del coacervo alluvionale dei fatti episodici – scelte radicali, cioè connesse alle radici di una determinata realtà storica, scelte divenute valori e, dunque, pietre forti per costruirci sopra non principii e regole immortali ma sicuramente duraturi perché indocili all’usura del divenire. Prendiamo ad esempio il grosso lavorìo che i nostri Padri Costituenti compirono nel biennio 1946‐
48: ciò varrà a calare di nuovo nell’oggetto specifico di questa lezione e a portare l’attenzione degli uditori su una espressione esemplare dell’atteggiamento che or ora segnalavo. Si tratta di lavori preparatorii, testimoniati in tutta la loro capillarità da una vastissima pubblicazione a disposizione di tutti, che ogni cittadino italiano dovrebbe aver presente; e dove vediamo ripetuto continuamente il verbo ‘riconoscere’. I Costituenti non creano nulla; si lìmitano a individuare nelle trame della società italiana regole scritte non da penna d’uomo, ma dal costume e dalla storia, che il ventennio di regime autoritario e la tragedia d’una seconda guerra mondiale non sono riusciti a intaccare. E’ una lettura che va oltre le contingenze dell’apparato statuale e cala in quegli strati riposti della società dove prospera una costituzione formalmente non testualizzata ma vigorosa e caratterizzante per il popolo che la vive. L’itinerario è ben diverso da quello dei giusnaturalismi sei‐settecenteschi: i Costituenti si guardano bene dal chiedere legittimazioni fasulle a un mondo assolutamente virtuale come l’originario stato di natura; qui è, invece, la storia nelle sue costanti, nei suoi valori, a fondare legittimazioni; è, insomma, lo stesso popolo italiano come storia vivente. I valori portanti della sua vita comunitaria divengono il contenuto della norma giuridica basilare della nuova repubblica, divengono i ‘principii fondamentali’ e la ‘prima parte’ della Carta del 1948; lì è il nucleo della cifra giuridica della società italiana letta e trascritta, per così dire, da una Assemblea di straordinarii lettori. Fra questi, autentici protagonisti furono docenti universitarii di diritto che avevano (e avrebbero anche in seguito) lasciato un’orma profonda nelle discipline scientifiche da ciascuno coltivate. E’ doveroso ricordare – in un ordine meramente alfabetico – almeno coloro, cui molto si deve nella strutturazione della Carta: il penalista Giuseppe Bettiol, il processual‐civilista Piero Calamandrei, il canonista Giuseppe Dossetti, il romanista Giorgio La Pira, il processual‐penalista Giovanni Leone, il penalista Aldo 40
P. GROSSI, La legalità costituzionale nella storia del diritto moderno, in Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, anno CDVI (2009) – Rendiconti delle adunanze solenni‐ vol. X‐ fasc. 9, p. 618; ma anche in La legalità costituzionale nella storia delle legalità moderna e pos‐moderna, in Lo Stato costituzionale ‐ La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale – Scritti in onore di Enzo Cheli, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 45. 20 Moro, il costituzionalista Costantino Mortati, l’internazionalista Tommaso Perassi, il costituzionalista Egidio Tosato. Il frutto di quei due anni – 1946/1948 – di dibattiti accesi ma fertili non fu né un catechismo né un panegirico; insomma, non fu una ‘carta dei diritti’, catalogo di situazioni soggettive protette elencate quali limiti invalicabili per l’arbitrio dei poteri dello Stato; fu, piuttosto, il breviario giuridico del cittadino italiano, il quale non è un soggetto astratto, un modello di uomo, bensì un uomo in carne ed ossa sorpreso nella sua esperienza di vita quotidiana, immerso nel crogiuolo di fatti strutturali economici sociali. Da questa salutare immersione consegue non un individuo isolato, fortificato e anche segregato dagli altri grazie a una corazza costituita da una serie di diritti soggettivi, reso egoistico dal solo dovere di sopravvivenza, il solo che il giusnaturalista Ugo Grozio si compiaceva di constatare, tre secoli prima, nell’uomo allo stato originario. Il soggetto, per cui la Costituzione del’48 è stata scritta, è un personaggio essenzialmente ‘sociale’, pensato accanto agli altri, inserito in un non eliminabile tessuto di relazioni in cui si mescolano diritti e doveri. Sì, anche doveri, giacché è unicamente grazie al dovere che il singolo recupera la sua dimensione sociale e, lasciando l’insularità dell’individuo, assume lo spessore della persona. Che la Costituzione non si componga affatto di schemi virtuali difficilmente traducibili in ordinamenti effettivi lo dimostra il disegno in essa contenuto del principio di uguaglianza; che è principio fondamentale della Carta nostra come lo fu di tutte le ‘carte dei diritti’ giusnaturalistiche.Tuttavia, se identico è il vocabolo (la égalité del 1789 vale la uguaglianza del nostro articolo 3), profondamente diverso è il modo con cui viene disegnato, e diversissimo è il piedistallo ideologico da cui si muove. La égalité delle ‘carte dei diritti’ – già lo sappiamo – è uguaglianza giuridica, è soprattutto una affrancazione da ogni vincolo cetuale sì da rendere ogni individuo uguale di fronte alla legge. La uguaglianza, di cui parla l’articolo 3, è senza dubbio anche questo, come si legge ancora oggi – con frase, per vero, un po’stantia – nelle aule dei nostri Tribunali, non arrestàndosi però a un piano puramente formale e calando a quella carnalità di situazioni dove l’uguaglianza è scritta sulla pelle degli uomini. In questo preciso orientamento, il secondo comma dell’articolo 3 rècita eloquentemente:” E’ cómpito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Quella locuzione avverbiale “di fatto” la dice lunga. Libertà ed uguaglianza non sono oggetti su cui è lecito fare sperimentazioni nel chiuso di un banco di laboratorio; la loro verifica è nei fatti, ed è lì soltanto che si misura la loro valenza in ordine a una efficiente tutela dei soggetti; è nella vita quotidiana, perché è solo lì che l’individuo, nel costante contatto con l’altro, si trasforma in persona e realizza il suo “pieno sviluppo”, come àuspica lo stesso articolo 3. 18 – Come lettura oggettiva della società, la Costituzione ne registra fedelmente la complessità. Il paesaggio giuridico, che l’individualismo moderno aveva ridotto (e anche impoverito), per i motivi che sappiamo, alle due sole individualità dello Stato/persona e del soggetto singolo, nel tempo pos‐
moderno del pieno Novecento ha la possibilità di riespandersi in tutte le sue naturali espressioni; e la Costituzione italiana, affermando così la sua filiazione pos‐moderna, si appropria della avvenuta riespansione e la valorizza. Accanto allo Stato e ai soggetti singoli (considerati ormai come persone) c’è, 21 nell’articolo 2, la affermazione del ruolo significativo che la società democratica italiana assegna alle formazioni sociali quali integrazioni preziose della singola personalità. E lo Stato, più che come apparato di potere, appare quale comunità, quale comunità di comunità. Allo stesso tempo, lo statalismo giuridico lascia il posto a un marcato pluralismo giuridico, e il diritto, relegata all’immediato passato una esclusiva funzione potestativa controllatrice del sottostante corpo sociale, torna a fare capo alla intiera società civile, è individuato come la società stessa che si autoòrdina e si propone, dunque, quale suo autentico salvataggio. Salvataggio, in quanto ordinamento, raggiungimento e conservazione di ordine, un ordine ormai inteso quale armonizzazione di tante diversità, che si attua rispettando la ricca pluralità di ordinamenti giuridici che la società esprime nella spontaneità della sua vita storica. Di questa ricchezza giuridica è indubbiamente manifestazione primaria lo Stato, depositario dei poteri necessarii a reprimere la rissa quotidiana e a garantire la pace sociale; si accompagna, però, anche l’intuizione – tutta pos‐moderna – che lo Stato non può e non deve esaurire quella ricchezza e che si deve un salvante rispetto a quella pluralità ordinamentale germinante nel territorio della Repubblica variegatissimo sul piano della storia, del costume, della caratterizzazione etnica culturale linguistica. Un’ultima notazione. La Costituzione è permeata da una nozione nuova: quella di solidarietà, che il vecchio individualismo moderno non era in grado di percepire e che, invece, campeggia già nell’articolo 2. Derivazione coerente di come è concepito il soggetto, creatura non insulare, ben immersa all’interno di varie e diverse comunità, cui fa capo una molteplicità di situazioni di diritto e di dovere. 19 – Il messaggio della Costituzione – in quel 1948 quando si cominciava a distanziarsi da un passato rovinoso, a disegnare il futuro, a irrobustirsi di speranze non illusorie – fu per il mondo del diritto, allo stesso tempo, una provocazione, una sfida, ma anche una orientazione verso sentieri tutti da percorrere. Ne appariva esaltata quella che un grande costituzionalista e un fattivo operaio nella redazione della Carta, Costantino Mortati, qualificava come la strumentalità dello Stato in funzione del potenziamento della persona. Ma lo stesso soggetto ne usciva rinnovato: da un lato, reso più responsabile dalla duplice appartenenza alla comunità statuale e alle diverse formazioni sociali (prime fra tutte – dopo la famiglia – il partito politico e il sindacato); dall’altro, enormemente più protetto dai cosiddetti diritti sociali che la Costituzione puntigliosamente elencava: il diritto al lavoro (art. 4), il diritto alla salute (art. 32), alla istruzione (artt. 33 e 34), alla assistenza e previdenza (art. 38). Lo sforzo, che faceva spicco e si rivelava nitidamente nella laboriosa edificazione dei Padri Costituenti, consisteva nel tentativo di colmare la distanza fra Stato e società, che si era inasprita a fine Ottocento nel vecchio Stato liberale in crisi e che tendeva a perdurare nell’immediato secondo dopoguerra malgrado la rinnovazione profonda. In questa orientazione la Costituzione servì da base per la costruzione di uno Stato sociale, che si sperimenterà in Italia fino agli anni Settanta. Provocazione, sfida e stimolo fu la Costituzione soprattutto per i giuristi, avvezzi da una tradizione inveterata a fare i conti con uno statalismo e un legalismo indiscussi. O meglio: per i più, dominati da quella pigrizia culturale che è il vizio perverso dei giuristi, la Costituzione, collocata a un livello meramente 22 filosofico‐politico, fu per troppo tempo tranquillamente ignorata; fu, al contrario, stimolo e provocazione per chi, culturalmente più vigile, si trovò a fare i conti non più con un solo livello di legalità, quello tradizionalmente occupato dalla legge ordinaria, prima fra tutte la legge madre, il Codice; con la inevitabile frizione che si veniva a creare fra una norma superiore incarnante i valori della democrazia parlamentare repubblicana e Codici e leggi speciali, la cui definizione risaliva generalmente al prolifico ventennio del regime autoritario, i Codici ‘penale’ e di ‘procedura penale’ all’anno 1930, il Codice ‘civile’ e di ‘procedura civile’, rispettivamente, agli anni 1942 2 1940. Codici indubbiamente egregii, perché frutto di una scienza giuridica italiana di livello altissimo, le cui architetture fondanti potevano ben reggere al radicale trapasso della forma italiana di Stato dalla monarchia quale mascheratura di un regime autoritario con un partito unico alla repubblica parlamentare pluri‐partitica. Se ci fu in Italia un gran dibattito sul dilemma conservazione/cancellazione, prevalse di gran lunga la voce di chi – sensatamente – propose una immediata ‘disinfestazione’ dalle incrostazioni fasciste41, che non avevano tuttavia alterato le linee teoriche e tecniche del sistema giuridico. Smentendo ancora una volta la pretesa impassibilità dei giuristi, vi fu chi, con occhi ben aperti sulla realtà circostante, non mancò, fin dai primi anni Sessanta, di riconoscere nella Costituzione la norma giuridica fondamentale, tentando una rilettura dei Codici alla luce dei valori costituzionali. Ma ci fu una istituzione che garantì efficacemente l’adeguamento del vecchio ordinamento positivo trascinàtosi per inerzia con tutto il suo fardello di decrepitezze e di soluzioni antinomiche con il dettato della nuova Costituzione. Questa fu la Corte Costituzionale, prevista proprio nella parte finale della nostra Carta dedicata alle ‘Garanzie costituzionali’: un giudice delle leggi chiamato al cómpito arduo ma salvante di verificare la congruità di leggi passate e future con i valori fissati nella Costituzione; una sorta di valvola respiratoria dell’ordinamento giuridico, che, grazie a una ininterrotta opera giudiziale, avrebbe potuto mantenere al diritto italiano la sua essenza di specchio vivente della società. Fu, da parte dei Padri Costituenti, una scelta coraggiosa, e lo dimostra la circostanza che fu controversa e combattuta durante i lavori preparatorii della Carta e che, dopo l’entrata in vigore di questa, si è dovuto attendere più di otto anni per salutarne l’avvìo effettivo. Certamente, la nuova istituzione veniva a incrinare il mito più geloso della modernità, che molti politici e giuristi serbavano ancora intatto nel loro cuore, e cioè il culto assoluto della legge in quanto legge, un culto, professato in tutta l’Europa continentale e che, nella Francia degli anni Cinquanta e Sessanta ancora pervasa dalle conclusioni di un assolutismo giuridico pos‐giacobino, fa parlare – da parte di un illustre uomo politico della Sinistra ‐ a proposito della istituzione in terra francese di un tribunale costituzionale come di un ‘colpo di Stato permanente’42. 41
Uso volutamente il termine ‘disinfestazione’ riprendendo l’immagine adottata da Piero Calamandrei nel suo contributo sul problema di cui si parla nel testo; egli, a proposito degli inserimenti imposti dal Regime, parlò – immaginosamente, com’era nel suo stile, ma efficacemente – di “disposizioni isolate, o facilmente isolabili”, e, pertanto, facilmente rimovibili “come bestioline parassite che si estirpano colle pinzette e si buttano nella spazzatura” (P. CALAMANDREI, Sulla riforma dei Codici (1945), ora in Scritti politici – I – Storia di dodici anni, Firenze, La Nuova Italia, 1966, p. 87). 42
Il riferimento è al celebre pamphlet di François MITTERRAND, Le coup d’état permanent, Paris, Plon, 1964. 23 Certamente, il legislatore non poteva più contare sulla incontestabilità e inattaccabilità del proprio volere arbitrario, e lo stesso dogma della divisione dei poteri veniva a subire una incrinatura. Ma si trattava di un risultato che esprimeva bene il vento nuovo del Novecento giuridico, e il tutto nuovo risalto che avevano assunto i valori socialmente condivisi e divenuti ormai il complesso normativo fondamentale. Di fronte a questo vento nuovo, il perdurante giacobinismo sapeva di vecchio e anche di stantìo. 20 – Grazie alla Costituzione del 1948, che i giuristi qualificano ‘lunga’ e ‘rigida’, ossia ampiamente articolata fino a diventare il breviario giuridico del cittadino e sovraordinata alle leggi ordinarie senza poter essere lesionata da quelle; grazie alle continue ossigenazioni fornite dalla Corte Costituzionale, l’ordinamento giuridico italiano ha potuto navigare senza naufragii nelle acque tempestose degli ultimi sessanta anni segnati da un movimento rapidissimo e da un mutamento sostanzioso sotto il profilo socio/politico, economico, tecnico. Spesso, si è, però, verificato un divario tra la disciplina di Codici e leggi ordinarie e le esigenze sempre nuove della società, spesso si sono creati dei vuoti che il legislatore ordinario non è stato in grado di colmare, esigenze e vuoti rispetto ai quali erano necessariamente impotenti sia la Costituzione, sia la Corte Costituzionale. Da molti – e non a torto – si è parlato di ‘crisi’; da taluni di ‘crisi del diritto’, un tema equivoco e spinoso su cui sarò chiamato a parlare io stesso presso la sede ospitale della Suprema Corte di Cassazione domani pomeriggio43. E domani puntualizzerò il carattere poli‐semico della nozione di crisi, alla quale si attribuisce generalmente una valenza negativa, ma che – al contrario ‐ serba in sé, accanto al carattere unitario di scossone per un vecchio corpo, il duplice effetto di demolizione di decrepite strutture e di avvìo e crescita verso il nuovo. A noi, in questa lezione, interessa individuare le ragioni e le conseguenze delle crisi serpeggianti a fine millennio e agenti in modo rilevante sul diritto positivo della repubblica italiana. Senza dubbio e in primo luogo, come si è già precisato, il mutamento dirompente che investe la società italiana soprattutto negli ultimi decennii; ma ci sono dei fattori specifici che vale la pena di menzionare. Per il giurista un fattore particolarmente incisivo è l’Europa, o, per meglio dire, l’inserimento sempre più intenso dello Stato italiano in una realtà sovra‐nazionale, la quale, nata come mercato comune, si è lentamente e progressivamente trasformata in unità politica e giuridica. E si è verificata frizione – e, quindi, crisi – non soltanto perché le istanze dello Stato sociale edificato in Italia nel secondo dopoguerra e quelle, spesso impietose e socialmente sorde, del mercato europeo vengono a una inevitabile collisione,ma anche perché l’Europa è diventata uno straordinario laboratorio sul piano storico‐giuridico. Lì, infatti, si sono venuti a mescolare e a confrontare, grazie all’inserimento del Regno Unito, due diversi modelli di vivere e concepire il diritto: quello continentale (il cosiddetto civil law) dominato dal dogma della statualità, fissato in testi autoritarii, il più delle volte ingessato in leggi e Codici, in essi immobile ma anche chiaro, certo, ridotto in sistemi unitarii e coerenti; quello di Oltremanica (il cosiddetto common law), scritto soprattutto nella storia del popolo inglese, nelle sue consuetudini immemorabili, e 43
Lezione da me volutamente intitolata in una forma interrogativa: “Crisi del diritto, oggi?”. 24 tradotto in regole di vita da un ceto coeso e agguerrito di giudici con le proprie decisioni originate da casi specifici della vita associata. Insomma, un modello legislativo di diritto, così come si era consolidato sul continente grazie alla serrata compiuta dal giacobinismo rivoluzionario, adversus un modello giurisprudenziale che era continuato di là dalla Manica per tutto lo svolgersi della modernità, e che si basava sull’affidamento (di marchio medievale) ai giuristi della formazione ed evoluzione del diritto, giuristi che l’empirismo inglese identificava soprattutto nei giudici, ben calati nel concreto dell’esperienza. L’Europa è realtà ben espressiva di questo confronto tra mentalità strutturalmente diverse: si attenua nel suo seno lo spasmodico assillo per la divisione dei poteri, che sul continente aveva permesso di consegnare nelle mani dello Stato, del cosiddetto legislatore, tutta la produzione del diritto, e un tribunale supremo, la Corte di Giustizia del Lussemburgo, è protagonista – al pari del Parlamento – nella formazione del progrediente diritto europeo. 21 – Ma il diritto italiano deve fronteggiare, negli ultimi decennii del Novecento, un’altra inevitabile dimensione, quella globale, e, proprio qui, in quest’aula, quasi dieci anni fa, gli amici Angelo Falzea e Giorgio Oppo, sempre vigili al divenire dell’esperienza giuridica, mi chiamarono a parlare, in una sessione accademica a classi riunite, della cosiddetta ‘globalizzazione giuridica’; che consiste in un fatto di notevolissimo rilievo. Il potere economico – soprattutto le grandi imprese multinazionali – ha due impellenti necessità: nuovi strumenti tecnico‐giuridici per i nuovi bisogni dell’attuale assetto capitalistico, strumenti che i legislatori statuali – talvolta sordi, talvolta impotenti – non sono in grado di approntare; la proiezione in un orizzonte globale, giacché la nuova economia, cavalcando speditamente il pegaso alato delle tecniche informatiche, è insofferente alle spesso economicamente irragionevoli frontiere dei differenti Stati. Il che provoca il complicarsi del paesaggio giuridico: accanto ai normali produttori di diritto, gli Stati e le organizzazioni internazionali e sovra‐statuali (l’Unione Europea, per esempio), altri produttori si profilano, i protagonisti del potere economico, e, accanto ai normali canali giuridici ufficiali, altri se ne formano, canali non ufficiali, canali privati ma provveduti di quel grosso privilegio che è l’effettività e della quale i primi sono spesso ormai carenti44. 22 La verità è che stiamo vivendo un momento di lenta transizione, che ha cominciato a profilarsi già nell’ultimo scorcio del secolo XIX, ha percorso tutto il Novecento crescendo costantemente e non ha visto ancora il suo termine. Ed è veramente crisi nel suo significato più pregnante: passaggio, passaggio dalla modernità a un tempo profondamente diverso, che possiamo contentarci di chiamare pos‐moderno, paghi di aver segnalato con questo generico aggettivo il suo distacco dai caratteri del tempo precedente. Prima, il diritto era costretto all’ombra dello Stato e tendeva ad identificarsi in un complesso di leggi; ora, va riscoprendo la sua fisiologica dimensione di ordinamento dell’intiera società e chiede di 44
Mi sia consentito di rinviare, per un primo approccio, il lettore a quanto dissi (e, poi, scrissi) nella Conferenza Lincea cui si accenna nel testo: Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, CCCIC (2002), ora anche in P. GROSSI, Società, diritto, Stato‐Un recupero per il diritto, Milano, Giuffrè, 2006. 25 manifestarsi a delle fonti plurali, che, accanto alla legge, sono le consuetudini, le sentenze dei giudici, le opinioni autorevoli della scienza giuridica. Se il diritto moderno – settecentesco e ottocentesco – era all’insegna della semplicità (una semplicità indubbiamente non spontanea, ma forzosa, e quindi artificiosa), quello novecentesco ed odierno, misurandosi ormai liberamente sulla società, si presenta in tutta la sua complessità. Prima, un rigido monismo giuridico; nell’immediato ieri e nell’oggi, un aperto pluralismo giuridico. Prima, solo il grande burattinaio dello Stato nazionale; nell’immediato ieri e nell’oggi, anche l’Europa e il fattualissimo ma effettivo diritto globale tutto modellato sulla fattualità economica emergente. All’interno dello Stato nazionale, non solo leggi, ma una pluralità di fonti che valga a colmare l’incapacità del legislatore a disciplinare il magma che stiamo vivendo. Nuovi protagonisti fanno, ormai, opera di supplenza, e soprattutto i giudici, personaggi di trincea, dai quali il cittadino comune reclama giustizia per il caso concreto delle sua vicenda quotidiana. E si profila anche – e sempre più decisamente – un nuovo assetto delle fonti ormai plurali: prima, esse erano inchiodate in una rigida gerarchia, e contava solo quella pósta nel supremo gradino, ossia la legge; oggi, si parla, con diverso linguaggio ben espressivo della diversità di visione, di rete tra le fonti, sottolineando l’abbandono della scala gerarchica e sostituendovi unicamente una necessaria interrelazione. Qualche giurista parla con franchezza di disordine delle fonti e qualche giovane cultore del diritto civile fa calare le incertezze derivanti dalla transizione in una interiore crisi di identità. Per lo storico del diritto crisi è, più semplicemente, un presente che si sta facendo futuro, un futuro che non ha ancora assunto un vólto definito. E’ naturale che questo possa sgomentare; il movimento è in atto e l’acqua è ancora torbida, ma è il costo da pagare affinché il futuro sia veramente futuro. Noi giuristi siamo, oggi, chiamati a un grave impegno: corrispondere alla complessità e ordinarla, seguire attenti la transizione tentando di ordinarne il corso senza soffocarla, consapevoli che l’ordine è, innanzi tutto, armonizzazione delle diversità nel loro pieno rispetto. E’un cómpito non facile ma di straordinaria fertilità. Deve darci forza l’esempio di quei tanti giuristi costruttori che, sentendosi pienamente inseriti all’interno di un grande processo storico, hanno corrisposto alla chiamata e contribuito fattivamente, da protagonisti, alla storia dell’Italia unita in questi primi centocinquanta anni. Lo sguardo retrospettivo, che abbiamo or ora compiuto, può essere salutare. Ci fa scrollare di dosso il vizio della pigrizia e ci incita all’azione. 26