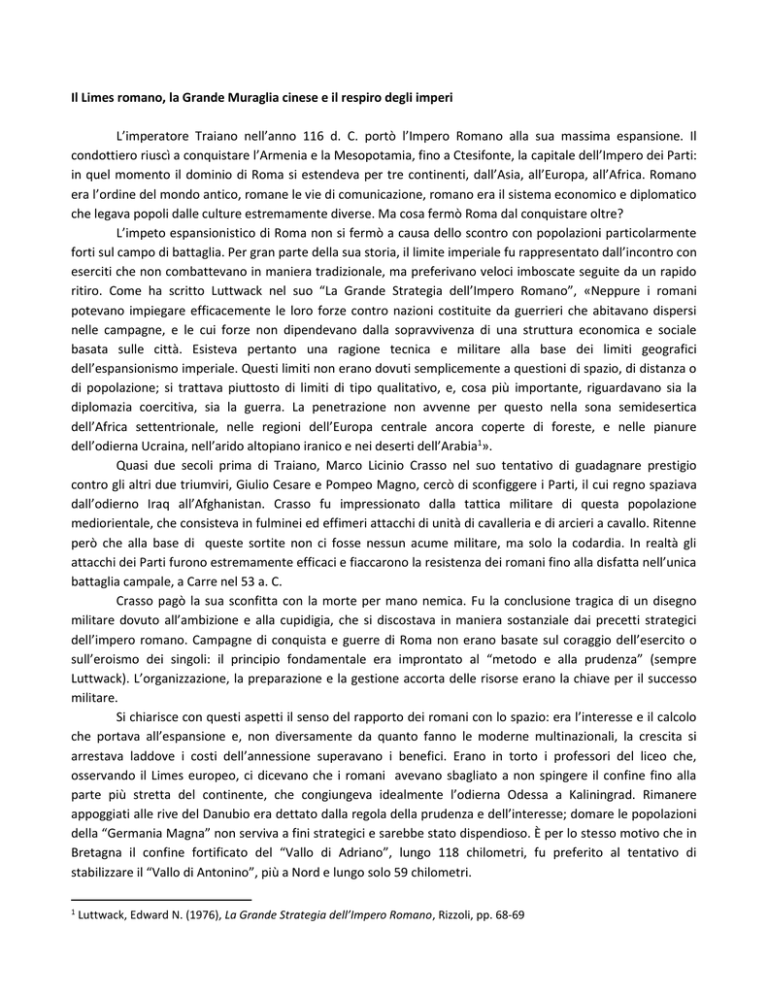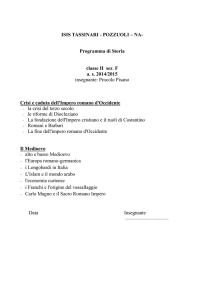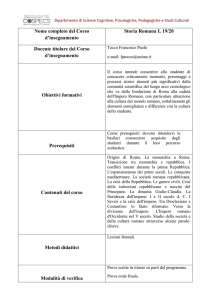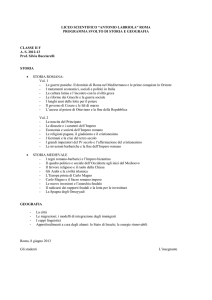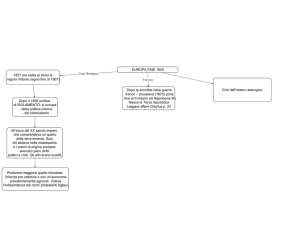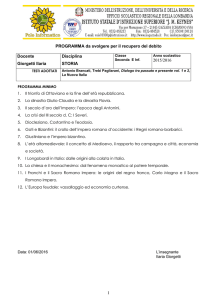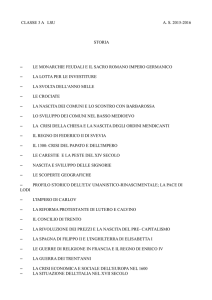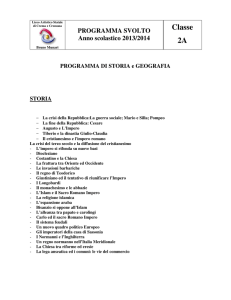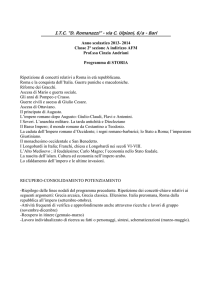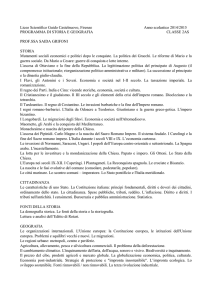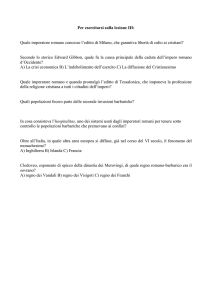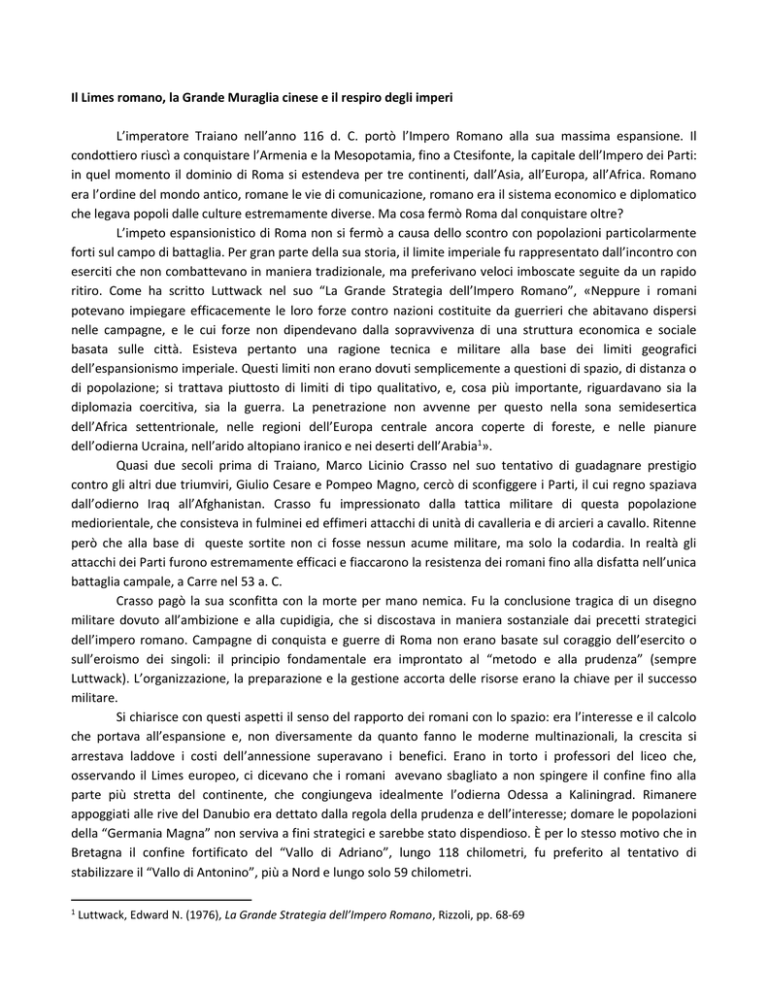
Il Limes romano, la Grande Muraglia cinese e il respiro degli imperi
L’imperatore Traiano nell’anno 116 d. C. portò l’Impero Romano alla sua massima espansione. Il
condottiero riuscì a conquistare l’Armenia e la Mesopotamia, fino a Ctesifonte, la capitale dell’Impero dei Parti:
in quel momento il dominio di Roma si estendeva per tre continenti, dall’Asia, all’Europa, all’Africa. Romano
era l’ordine del mondo antico, romane le vie di comunicazione, romano era il sistema economico e diplomatico
che legava popoli dalle culture estremamente diverse. Ma cosa fermò Roma dal conquistare oltre?
L’impeto espansionistico di Roma non si fermò a causa dello scontro con popolazioni particolarmente
forti sul campo di battaglia. Per gran parte della sua storia, il limite imperiale fu rappresentato dall’incontro con
eserciti che non combattevano in maniera tradizionale, ma preferivano veloci imboscate seguite da un rapido
ritiro. Come ha scritto Luttwack nel suo “La Grande Strategia dell’Impero Romano”, «Neppure i romani
potevano impiegare efficacemente le loro forze contro nazioni costituite da guerrieri che abitavano dispersi
nelle campagne, e le cui forze non dipendevano dalla sopravvivenza di una struttura economica e sociale
basata sulle città. Esisteva pertanto una ragione tecnica e militare alla base dei limiti geografici
dell’espansionismo imperiale. Questi limiti non erano dovuti semplicemente a questioni di spazio, di distanza o
di popolazione; si trattava piuttosto di limiti di tipo qualitativo, e, cosa più importante, riguardavano sia la
diplomazia coercitiva, sia la guerra. La penetrazione non avvenne per questo nella sona semidesertica
dell’Africa settentrionale, nelle regioni dell’Europa centrale ancora coperte di foreste, e nelle pianure
dell’odierna Ucraina, nell’arido altopiano iranico e nei deserti dell’Arabia1».
Quasi due secoli prima di Traiano, Marco Licinio Crasso nel suo tentativo di guadagnare prestigio
contro gli altri due triumviri, Giulio Cesare e Pompeo Magno, cercò di sconfiggere i Parti, il cui regno spaziava
dall’odierno Iraq all’Afghanistan. Crasso fu impressionato dalla tattica militare di questa popolazione
mediorientale, che consisteva in fulminei ed effimeri attacchi di unità di cavalleria e di arcieri a cavallo. Ritenne
però che alla base di queste sortite non ci fosse nessun acume militare, ma solo la codardia. In realtà gli
attacchi dei Parti furono estremamente efficaci e fiaccarono la resistenza dei romani fino alla disfatta nell’unica
battaglia campale, a Carre nel 53 a. C.
Crasso pagò la sua sconfitta con la morte per mano nemica. Fu la conclusione tragica di un disegno
militare dovuto all’ambizione e alla cupidigia, che si discostava in maniera sostanziale dai precetti strategici
dell’impero romano. Campagne di conquista e guerre di Roma non erano basate sul coraggio dell’esercito o
sull’eroismo dei singoli: il principio fondamentale era improntato al “metodo e alla prudenza” (sempre
Luttwack). L’organizzazione, la preparazione e la gestione accorta delle risorse erano la chiave per il successo
militare.
Si chiarisce con questi aspetti il senso del rapporto dei romani con lo spazio: era l’interesse e il calcolo
che portava all’espansione e, non diversamente da quanto fanno le moderne multinazionali, la crescita si
arrestava laddove i costi dell’annessione superavano i benefici. Erano in torto i professori del liceo che,
osservando il Limes europeo, ci dicevano che i romani avevano sbagliato a non spingere il confine fino alla
parte più stretta del continente, che congiungeva idealmente l’odierna Odessa a Kaliningrad. Rimanere
appoggiati alle rive del Danubio era dettato dalla regola della prudenza e dell’interesse; domare le popolazioni
della “Germania Magna” non serviva a fini strategici e sarebbe stato dispendioso. È per lo stesso motivo che in
Bretagna il confine fortificato del “Vallo di Adriano”, lungo 118 chilometri, fu preferito al tentativo di
stabilizzare il “Vallo di Antonino”, più a Nord e lungo solo 59 chilometri.
1
Luttwack, Edward N. (1976), La Grande Strategia dell’Impero Romano, Rizzoli, pp. 68-69
L’essenza del rapporto romano con lo spazio si esprime anche nella struttura dei confini, che si è
evoluta progressivamente nei secoli. Sotto il sistema “Giulio-Claudio”, grossomodo da Augusto a Nerone, si
raggiunse un livello militare di sole venticinque legioni. Non esisteva un confine armato come possiamo
intenderlo oggi, e la sicurezza era garantita da una tela di “stati clienti” che venivano ricompensati per la
fedeltà a Roma. In caso di sommosse o invasioni di una certa entità, le legioni mobili intercettavano il nemico
anche all’interno del territorio imperiale.
Fu solo con la successiva dinastia dei Flavi che iniziò il grande lavoro di fortificazione dei confini. Con
l’erezione di mura e torri di guarda non si arrestò però lo sviluppo delle strategie romane: in un primi periodo,
la forza d’urto militare consisteva nella capacità delle milizie di uscire dalla frontiera armata e intercettare i
nemici all’esterno. Progressivamente, e infine con la “grande crisi del III secolo”, la tattica virò verso un tipo di
difesa “in profondità”, con un sistema di protezione “interno” per la sorveglianza delle principali vie di
comunicazione e dei centri abitati.
In questo lungo percorso cambiò non solo la concezione militare che Roma aveva di se stessa, ma
anche il rapporto con gli stati clienti. Il successo della maggiore città-stato dell’antichità fu dovuto anche alla
sua capacità di creare una “struttura economica” inter-culturale, diventando un “impero egemone”. Proprio la
crescita dei vecchi stati clienti iniziò a rappresentare la principale minaccia per la sicurezza delle popolazioni
romane di confine; e anche per questo l’approccio difensivo approdò alla strategia di fortificazione.
Oggi potremmo dire che la Roma repubblicana e parte di quella imperiale basavano il proprio potere
non solo sulla forza, ma anche sul “soft-power”. Se i confini furono poi “armati e presidiati”, ciò dipese da
influenze interne ed esterne. Le lotte di potere per il controllo del seggio imperiale costringevano
frequentemente a richiamare le truppe dalle periferie per combattere internamente; al di là del Limes, si
temeva che nuovi “stati clienti” potessero diventare troppo forti e contendere il potere e l’integrità di Roma.
È a questo punto che nasce il primo concetto storico di “impero territoriale”, che ha poi contraddistinto
il rapporto di molte altre potenze nazionaliste con l’esterno.
Spesso si paragona la Cina all’Impero romano proprio per questa caratteristica della territorialità. La
Grande Muraglia, oltre a essere un’ambiziosa opera architettonica, è la realizzazione fisica di un attitudine
politica. Dalle prime palizzate erette nel quinto secolo avanti Cristo, fino alle immani fortificazioni della dinasta
Ming (1368-1644), l’idea cinese era quella di separare il territorio controllabile da quello abitato da tribù
indomite, di origine mongola o manciù. Riprendendo ancora Luttwack, possiamo impiegare per questo aspetto
storico cinese una descrizione relativa al sistema di confine romano sotto i Flavi: «i metodi di pianificazione
usati dai romani nelle zone di confine richiedevano che gli abitanti e il territorio fossero adatti all’insediamento
e allo sviluppo, in modo da permettere una sorta di “auto-romanizzazione” volontaria da parte di una
popolazione fiorente, come risposta all’introduzione delle idee e dei manufatti romani. D’altra parte, dal punto
di vista diplomatico, era necessario che i popoli che vivevano oltre il confine fossero sensibili alle minacce e alle
suggestioni esercitate dal sistema romano di controllo indiretto2».
Se vogliamo confrontare il progresso strategico dell’impero romano con la Cina, non possiamo però
affidarci a una teoria “deterministica” dello sviluppo. Non è detto che a una fase egemonica (o, secondo la
nostra definizione, di “soft-power”) ne segua una “territoriale” (che quindi dovremmo definire di “hardpower”). Si tratta piuttosto di fasi che si alternano nei cicli di lungo periodo degli imperi.
2
Luttwack, Edward N., op. cit., p. 122
L’egemonia consente periodi di conquista, perché non si basa su confini tracciati nella pietra. La
territorialità rappresenta l’apice dell’espansione, ovvero il momento in cui la complessità del sistema esterno
supera la complessità del sistema interno. Il muro stabilisce un confine e consente di concentrarsi sulla propria
situazione domestica, fino a quando l’espansione non può essere ripresa.
È chiaro che nell’ambito di un impero i due aspetti dell’egemonia e della territorialità coesistono,
poiché uno non esclude l’altro; si deve però immaginare che il “Respiro degli Imperi” sia contraddistinto da fasi
in cui una di queste caratteristiche prevalga, per poi diminuire e lasciare spazio all’altra. La territorialità
racchiude dentro i propri confini ciò che secondo l’impero può essere definito come “idea politica nazionale”,
quale insieme di tutte le culture che condividano un’idea culturale, e per questo economica e sociale,
compatibile.
La Cina di oggi è passata da una fase di “territorialità” prevalente fino all’avvento di Deng Xiaoping, a
quella di una maggiore espansione della propria pretesa egemone tramite lo strumento della “guerra
economica3”. Non è una strategia “nuova”: ha contraddistinto lo sviluppo dei grandi “cicli di accumulazione del
capitale” dell’epoca moderna e contemporanea, dettando le possibilità di emersione della Venezia dei
mercanti, dell’Olanda, dell’Impero Britannico e degli Stati Uniti4.
Deng ha rappresentato la fine della “colonializzazione interna” della Cina: nel 1978 si era in gran parte
completato il processo di nazionalizzazione Han, e il territorio cinese era diventato area di competenza semiesclusiva dell’etnia centrale. Con la fine di Mao era venuta meno anche la tensione civile che vedeva
contrapposta l’ormai sparuta opposizione del Kuomintang al Partito Comunista. Il sistema nazionale domestico
è tornato a un livello di complessità gestibile; oltre la Grande Muraglia le opportunità offerte dalla crisi
sovietica prima, e in seguito dalla fine della Guerra Fredda, hanno spinto a intraprendere l’espansione.
La Cina come impero socialista è stato più fortunato rispetto a quello sovietico. Mosca ha vissuto la sua
fase di complessità interna fino al 1937, l’anno del “terrore e del sogno”, in cui il lucido pazzo Stalin fece di
Mosca e di tutto il paese un sistema perfetto per la persecuzione dei dissidenti e per lo sviluppo di un ideale
“utopico di una nuova società5”. La fase espansionistica si protrasse poi per i pochi, violentissimi anni del
secondo conflitto mondiale, riaffacciandosi poi solo per brevi periodi, fino alla catastrofe dell’intervento in
Afghanistan negli anni Ottanta. L’URSS si dovette scontrare con la strategia imperiale americana sui suoi
confini, in una globalizzazione del conflitto che ridusse le pretese di Mosca fin dal 1945.
La Pechino di oggi non ha incontrato sul suo cammino recente questo tipo di limite, e la sua crescita
continua in tutti i continenti.
Ci si potrebbe chiedere a questo punto se lo sviluppo di un “impero commerciale” possa avere senso. Il
principio, come per la territorialità, è che lo sviluppo in nuovi mercati abbia senso fino a quando i vantaggi non
superino i costi. Pechino, da questo punto di vista, è una realizzazione ulteriore dei grandi cicli di
accumulazione del passato, ma lo è in maniera più evoluta6. Il grande Impero Britannico è stato criticato dagli
3
Per evitare di rimandare al solito Luttwack (Luttwack, Edward N. (1990), From Geopolitics to Geoeconomics. Logic of
Conflict, Grammar of Commerce, The Nationali Interest) ci è di aiuto la scuola francese dei primi anni Novanta: Esambert,
Bernard (1990), La guerre économique mondiale, Olivier Orban; e Harbulot, Christian (1992), La machine de guerre
économique, Economica
4
Braudel, Fernand (1986), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Armand Colin; e anche
Arrighi, Giovanni (1996), Il lungo XX secolo: denaro, potere e le origini del nostro tempo, Il Saggiatore
5
Schlögel, Karl (2010), Terror und Traum, Fischer Taschenbuch Verlag
6
Sia Braudel che Arrighi sottolineano come i grandi cicli di accumulazione non siano da interpretare in maniera
“sequenziale”; ma non possiamo negare che ogni realizzazione imperiale-capitalistica abbia colto aspetti dei cicli
storici marxisti perché caratterizzato da concetti di dominio e sopraffazione; ma è stato biasimato anche dai
liberali, in quanto «proprio perché l’imperialismo ha distorto il mercato – servendosi di tutto, dalla forza alle
tariffe preferenziali, per modellarlo a vantaggio della madrepatria – a lungo andare non ha fatto l’interesse
neppure dell’economia britannica7».
Alla tentazione di colonizzare il territorio, o almeno di farlo alla maniera inglese, hanno resistito gli Stati
Uniti. Washington ha stimolato la crescita di economie democratiche, liberali e integrate, per proteggere i
confini demarcati in Europa e in Asia (si veda il sostegno al Giappone); laddove la frontiera era più incerta,
come in Medio Oriente o in Africa, ha finanziato la crescita di “stati clienti” ricompensando il capo-tribù di
turno, che si chiamasse Reza Pahlavi (in Iran) o Hosni Mubarak (in Egitto).
La Cina di oggi non impone modelli politici ai suoi principali partner commerciali, e si limita a creare un
sistema di “protezione economica” con le realtà estere. La coesione del sistema politico interno, incarnata
dall’iper-conservatore Partito Centrale, consente di gestire l’espansione esterna in base a un concetto
“prudente e amministrativo”, piuttosto che “eroico ed effimero”. È sulla stabilità domestica che si basa il
potere estero; ed è sugli obbiettivi nazionali che si fondano quelli internazionali. La pulsione alla crescita
imperiale è data da ideali che vanno oltre l’economia: è l’idea di eccezionalismo, che sia inglese, americano o
cinese, a creare l’ansia di conversione del mondo; l’economia ne è solo strumento.
Non è credibile che la logica del “disinteresse” cinese per le altrui questioni politiche possa
rappresentare il cardine a lungo termine delle relazioni di Pechino con il mondo. Ciò è possibile solo in una fase
“espansiva” dell’impero. Con il passare degli anni, sussistono altri rischi: alle merci scambiate sono attaccati
significati politici, che lo si voglia o no. È politica il fatto che, ai margini della crisi del 2008, Pechino abbia messo
a disposizione miliardi di dollari per rivitalizzare l’industria energetica di Mosca, cuore dell’economia russa. È
politica il fatto che Pechino sia così timida nel criticare l’Iran e la Korea del Nord nelle proprie ambizioni
nucleari. È politica il fatto che la Cina abbia sostenuto al governo il partito del discusso presidente dello
Zimbabwe, Robert Mugabe.
Se consideriamo questo, possiamo ritenere che la Cina non sia in realtà ancora un impero, ma solo una
forza nazionale nella fase di conquista. Impero lo diventerà solo se riuscirà a imporre un sistema di valori e
significati sociali, economici, politici. Se accetterà la responsabilità di essere impero.
Sono in atto già dinamiche che potrebbero portare al ritorno a una fase territoriale per Pechino. La
conflittualità interna è in aumento, e insieme a questo ci sono zone in cui l’idea nazionale si sta annacquando. Il
confine sino-russo, oggetto di scontri violentissimi negli ultimi secoli, potrebbe essere il primo a vacillare nel
caso di un ritorno alla territorialità. Nell’ultimo periodo di vita dell’Impero Romano le truppe stanziali presenti
sul Limes germanico avevano ormai acquisito fisionomia e aspetto culturali delle tribù barbariche, con legionari
biondi e alti un palmo in più rispetto ai colleghi romani. In Cina, a causa di decenni di politiche del “figlio unico”,
ci sono relativamente più maschi; e al confine con la Russia questo ha incentivato le unioni trans-nazionali.
A Ovest della Cina, la popolazione uigura dello Xinjiang è sempre meno attratta dal modello centrale, e
il “vantaggio atteso della ribellione” sta superando quello della fedeltà. La Cina per ora è “impero” solo
all’interno dei propri confini statali, e questi segnali suggeriscono che qui Pechino sia già tornata al
territorialismo (posto che ne sia mai uscita).
precedenti, per affinarli ed esprimerli nuovamente. Questo è stato vero soprattutto per il passaggio dal ciclo britannico a
quello americano, e sta succedendo nuovamente da parte cinese rispetto al ciclo americano.
7
Ferguson, Nial (2003), Impero, Come la Gran Bretagna ha fatto il mondo moderno, Oscar Mondadori, p. 8
Altri paesi considerati “stati cliente” stanno imparando dai cinesi l’organizzazione del lavoro e la
produttività. Anche gli Stati Uniti si stanno riorganizzando, cercando di interessarsi sempre meno alle questioni
politiche altrui, sognando piani per la rinascita delle esportazioni.
La circolarità tra egemonia e territorialità si può interrompere, se sopravvengono elementi distruttivi di
questo tipo. È per questo che l’Impero cinese, per dimostrare di essere tale, li dovrà affrontare.
Il mondo esterno alla Cina sta tornando a essere più complesso rispetto agli anni Novanta, ed è per
questo che gli apparati interni di Pechino devono saper rispondere tramite le riforme. Il modello dirigistico del
Partito Centrale ha avuto successo in un sistema frammentato, come quello post-1989; ma adesso la Cina sarà
sottoposta a nuovi impulsi. Come nell’antica Roma, questi impulsi potrebbero tradursi in tentazioni di lotta per
fazioni e gruppi di potere, portando alla disgregazione. Oppure, potrebbero ispirare la nascita di una nuova
Cina, colorando di rosso gran parte del mondo. Forse il sistema a guida statale riuscirà a leggere correttamente
la situazione e conservare il vantaggio nazionale: questo sarebbe un cambiamento epocale. Ma noi vecchi
Europei, in fondo, crediamo che non sia possibile.
Stefano Casertano (Roma, 1978) è docente di politica internazionale all'Università di
Potsdam, in Germania; MBA della Columbia University e Ph.D. dell'Università di Potsdam.
Dal 2011 è Senior Fellow del think tank tedesco BIGS. Il suo campo d'interesse è la storia dei
rapporti tra le grandi potenze a partire dal dopoguerra, in particolare nel settore dell'energia.
E' autore di una trilogia sulla geopolitica energetica in completamento nel 2011. Il primo libro
della serie è "Sfida all'Ultimo Barile" (Brioschi Editore, 2009), una storia della Guerra Fredda
per il petrolio dal 1945 a oggi. Nel 2010 questo lavoro è stato portato avanti con l'uscita di
"Oro Blu" (Fuoco Edizioni), dedicato ai rapporti energetici tra Cina, Russia ed Europa.
Quest'anno uscirà "La Guerra del Clima" (Francesco Brioschi, 2011), sulla geopolitica delle
energie rinnovabili.
Stefano Casertano è stato advisor per gli affari internazionali presso il Ministero dello
Sviluppo Economico in Italia nel 2010, e contribuisce come pubblicista per le riviste
dell'Aspen Institute, dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, e per l'Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale di Milano.