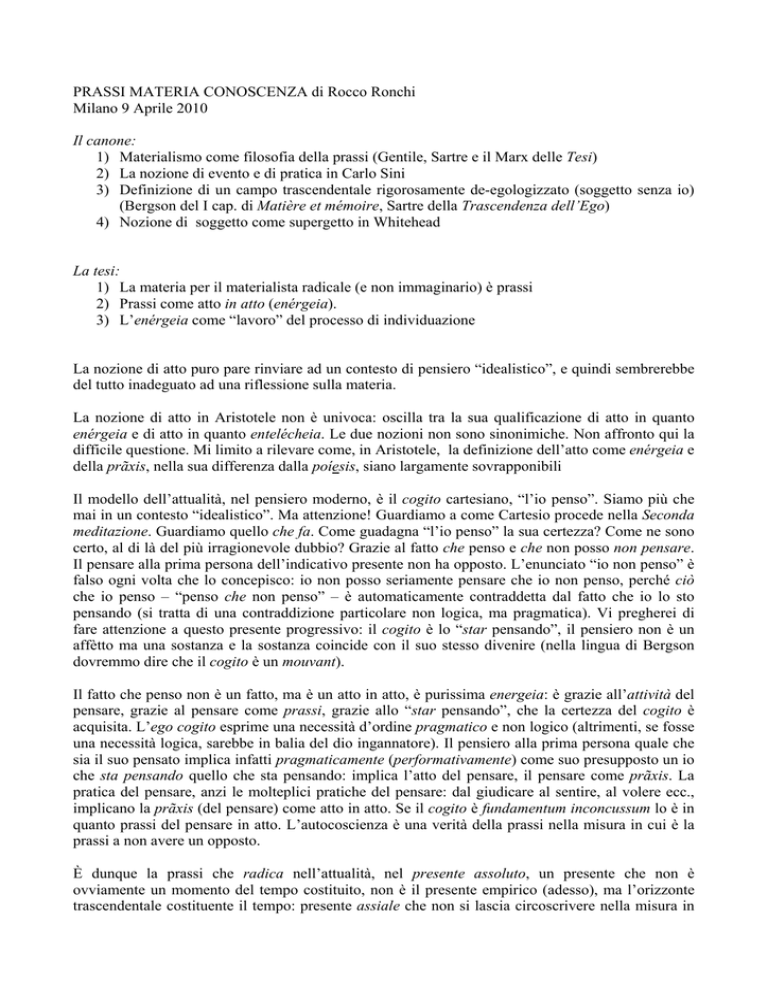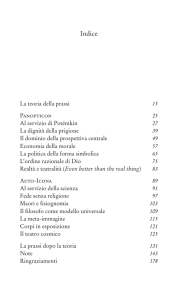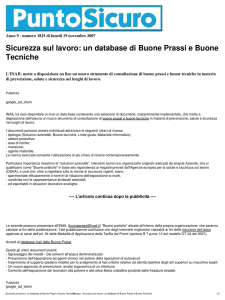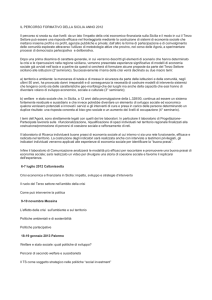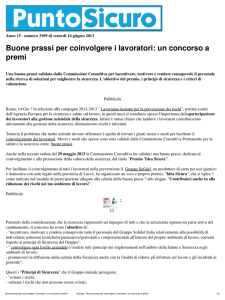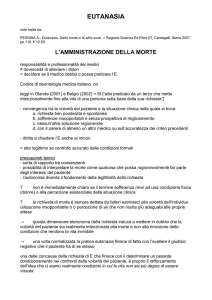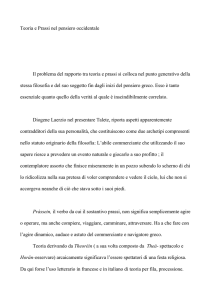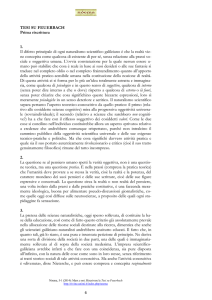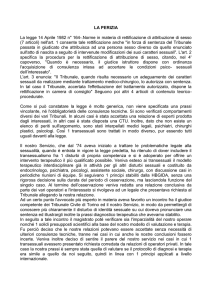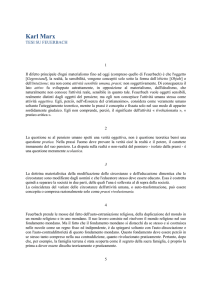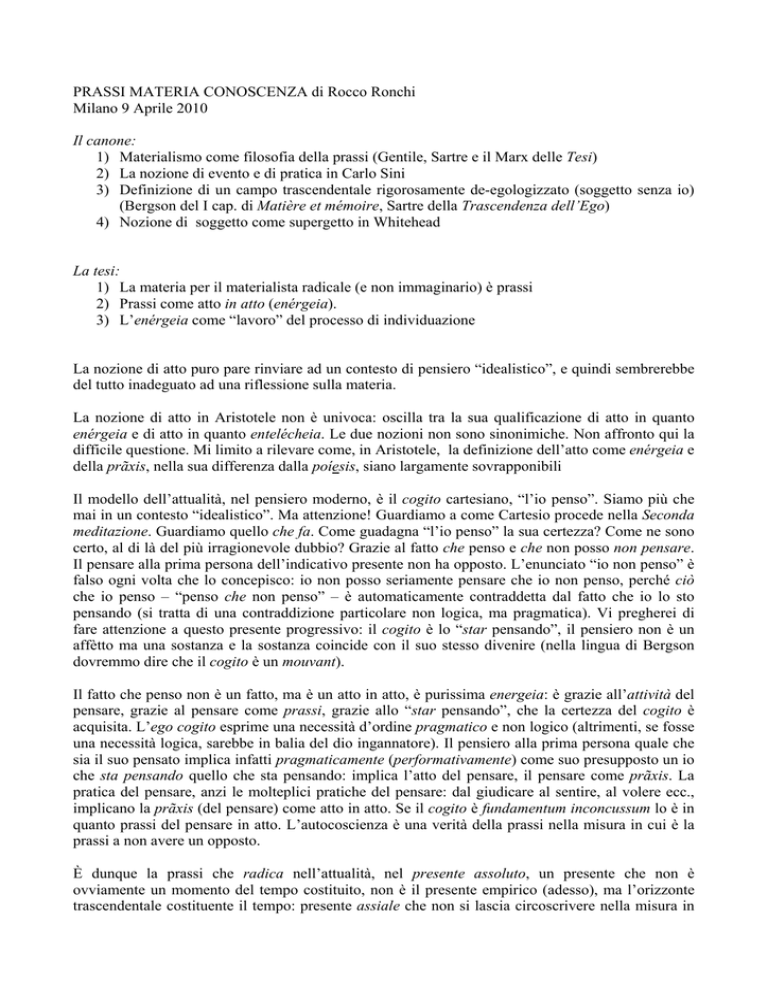
PRASSI MATERIA CONOSCENZA di Rocco Ronchi
Milano 9 Aprile 2010
Il canone:
1) Materialismo come filosofia della prassi (Gentile, Sartre e il Marx delle Tesi)
2) La nozione di evento e di pratica in Carlo Sini
3) Definizione di un campo trascendentale rigorosamente de-egologizzato (soggetto senza io)
(Bergson del I cap. di Matière et mémoire, Sartre della Trascendenza dell’Ego)
4) Nozione di soggetto come supergetto in Whitehead
La tesi:
1) La materia per il materialista radicale (e non immaginario) è prassi
2) Prassi come atto in atto (enérgeia).
3) L’enérgeia come “lavoro” del processo di individuazione
La nozione di atto puro pare rinviare ad un contesto di pensiero “idealistico”, e quindi sembrerebbe
del tutto inadeguato ad una riflessione sulla materia.
La nozione di atto in Aristotele non è univoca: oscilla tra la sua qualificazione di atto in quanto
enérgeia e di atto in quanto entelécheia. Le due nozioni non sono sinonimiche. Non affronto qui la
difficile questione. Mi limito a rilevare come, in Aristotele, la definizione dell’atto come enérgeia e
della prãxis, nella sua differenza dalla poíesis, siano largamente sovrapponibili
Il modello dell’attualità, nel pensiero moderno, è il cogito cartesiano, “l’io penso”. Siamo più che
mai in un contesto “idealistico”. Ma attenzione! Guardiamo a come Cartesio procede nella Seconda
meditazione. Guardiamo quello che fa. Come guadagna “l’io penso” la sua certezza? Come ne sono
certo, al di là del più irragionevole dubbio? Grazie al fatto che penso e che non posso non pensare.
Il pensare alla prima persona dell’indicativo presente non ha opposto. L’enunciato “io non penso” è
falso ogni volta che lo concepisco: io non posso seriamente pensare che io non penso, perché ciò
che io penso – “penso che non penso” – è automaticamente contraddetta dal fatto che io lo sto
pensando (si tratta di una contraddizione particolare non logica, ma pragmatica). Vi pregherei di
fare attenzione a questo presente progressivo: il cogito è lo “star pensando”, il pensiero non è un
affètto ma una sostanza e la sostanza coincide con il suo stesso divenire (nella lingua di Bergson
dovremmo dire che il cogito è un mouvant).
Il fatto che penso non è un fatto, ma è un atto in atto, è purissima energeia: è grazie all’attività del
pensare, grazie al pensare come prassi, grazie allo “star pensando”, che la certezza del cogito è
acquisita. L’ego cogito esprime una necessità d’ordine pragmatico e non logico (altrimenti, se fosse
una necessità logica, sarebbe in balia del dio ingannatore). Il pensiero alla prima persona quale che
sia il suo pensato implica infatti pragmaticamente (performativamente) come suo presupposto un io
che sta pensando quello che sta pensando: implica l’atto del pensare, il pensare come prãxis. La
pratica del pensare, anzi le molteplici pratiche del pensare: dal giudicare al sentire, al volere ecc.,
implicano la prãxis (del pensare) come atto in atto. Se il cogito è fundamentum inconcussum lo è in
quanto prassi del pensare in atto. L’autocoscienza è una verità della prassi nella misura in cui è la
prassi a non avere un opposto.
È dunque la prassi che radica nell’attualità, nel presente assoluto, un presente che non è
ovviamente un momento del tempo costituito, non è il presente empirico (adesso), ma l’orizzonte
trascendentale costituente il tempo: presente assiale che non si lascia circoscrivere nella misura in
cui è l’evento, il luogo di ogni aver luogo (aver luogo del passato, del presente-adesso e del futuro:
essi hanno luogo nel presente assiale)
Il presente assoluto o assiale nella quale la prassi ci radica è il presente dell’enunciazione,
dell’istanza di discorso, dell’atto di parola (Cartesio acquisisce la certezza dell’ego sum/ego cogito
attraverso la via della enunciazione: ogni volta, scrive, che “pronuncio” ego sum il mio detto mostra
che sono e che non posso non essere; ogni volta che penso che penso il mio pensato mostra che sto
pensando e che non posso non pensare. “Mostrare” ha qui il senso della implicazione pragmatica
nella sua differenza dalla implicazione logica: è il “mostrare” di cui parla Wittgenstein nel
Tractatus e che sarà tematizzato dalla filosofia del linguaggio anglosassone (Austin)
Per questo la pratica del dire può essere assunta come pratica di tutte le pratiche e come via che
porta alla verità della prassi. Il dire può essere assunto come pratica di tutte le pratiche, nella misura
in cui le “cose” – tutte le cose, compreso l’ego (che è una cosa trascendente come tutte le altre) –
sono convocate nella presenza dalla istanza di discorso: non sono finché non sono chiamate ad
essere. Non sono finché non sono chiamate ad essere qui e ora nel presente assoluto dell’istanza di
discorso.
La pratica del dire (pre)suppone un fondamento incircoscrivibile e inoggettivabile (nella misura in
cui il dire che lo volesse eventualmente dire ancora lo presupporrebbe: regressione infinita del
presupposto che è la versione semiotica dell’argomento del terzo uomo) La pratica del dire,
indipendentemente dal detto (da ciò che è detto) e indipendentemente dall’altro a cui è detto ciò che
è detto (una indipendenza che è da pensarsi come necessaria implicazione), la pratica del dire
presuppone un io che parla, un io che sta parlando qui e ora, non un io sostanza che ha l’attributo
della parola, non una res, non un fatto costituito, ma un atto di parola, un aver luogo qui e ora di
una parola determinata.
L’atto di parola è il soggetto (il vero “io”), non l’”ego” che parla. Tale dire diventa la mia parola, la
parola che dico “io” (ego), la parola che mi esprime, sul fondamento della relazione con il tu e con
il noi (e il loro) che ogni atto di parola, avendo luogo, implica e porta con sé. Dove c’è parola c’è
infatti sempre qualcuno che sta parlando a qualcun altro di qualcosa di cui altri hanno già parlato
(tale è la struttura dell’enunciato secondo la pragmatica). C’è conversazione, c’è un luogo comune,
c’è “mondo”, c’è situazione e storicità immanente (ogni atto di parola è concatenazione collettiva di
enunciazione, risposta ad enunciati anteriori e domanda rivolta ad un surdestinatario finale). In
questa concreta pratica di parola è inscritto tutto un tessuto di relazioni sociali determinate (ogni
enunciato è un entimema sociale oggettivo).
Ma si deve distinguere con cura l’io che sta parlando in atto, il soggetto della prassi (ma meglio
sarebbe dire la prassi come soggetto), dall’io soggetto dell’enunciato, dal soggetto istituito dalla
prassi del dire. La prassi come soggetto (il dire in atto) è e non è il soggetto dell’enunciato, è e non
è l’ego titolare della parola come di una sua espressione. La prassi del dire implica un soggetto del
dire (un ego che parla, come un tu a cui si rivolge) ma lo implica come ciò che “concresce” o
“emerge” in essa. Il soggetto-ego (inteso come sostanza) è un effetto che, come scrive Whitehead,
diviene padrone del proprio processo nel momento in cui ne deriva: soggetto-supergetto.
La pratica determinata della parola (l’enunciato) suppone il suo evento, evento che non dice, ma
mostra. L’evento è il mostrato dei deittici tutti: dai pronomi personali a quelli dimostrativi, dal
tempo del verbo alle preposizioni come qui, là ecc.; l’evento non è reperibile come tale
nell’enunciato, non appartiene al piano del detto. L’evento sfugge come la soglia illocalizzabile di
Peirce o la diffèrance di Derrida. L’evento non ha come tale, è sovraessenziale, è vuoto (è nulla di
ciò che è), pur non avendo altra consistenza e altra realtà che nelle figure in cui “transita”, ed in cui
non è.
Marx diceva contro Feuerbach: non c’è l’uomo come essenza astratta o universale, “l’uomo non è
che, non è nient’altro che l’insieme delle relazioni sociali” (Tesi 6). Per comprendere il senso del
materialismo di Marx bisogna avere orecchio per questo “non è che”. A questa vigilanza
ermeneutica ci invitano Gentile, nel suo saggio sulla filosofia della prassi, e Sartre nella sua critica
del materialismo storico “ortodosso”. L’uomo è l’insieme delle relazioni sociali e nient’altro che
questo. È l’accadere delle relazioni sociali che lo costituiscono e nient’altro che questo accadere
(tesi del materialismo storico).
Ma, qui direbbe Wittgenstein, c’è la parola accadere. Cusano direbbe c’è l’espressione non aliud: il
non aliud nomina l’evento delle relazioni sociali, la loro determinatezza storica, il oro qui e ora, il
loro presente assoluto o assiale. Ci sono delle pratiche e l’uomo non è altro che il portato di queste
pratiche determinate (il mulino a vento, la staffa, costituiscono l’uomo del feudalesimo), ma,
appunto, queste pratiche ci sono, hanno luogo, accadono. L’uomo del feudalesimo è l’insieme di
queste pratiche (ne è la risultante storica, ne è il soggetto-supergetto) ed è il loro aver luogo, il loro
accadimento, il loro presente assiale (l’istanza del discorso, la prassi come soggetto). Come evento
(Sartre direbbe in quanto esistente, in quanto existentia, in quanto quodditas) non è riducibile ad
esse pur non avendo altra sostanzialità che in esse. Rispetto ad esse ne è la negazione determinata.
Allo stesso modo un enunciato non è nient’altro che un enunciato. In questo non aliud è indicato il
fondamento inoggettivabile della pratica del dire: l’evento, quanto Benveniste chiama l’ “istanza del
discorso”, l’io che parla, dove fondamentale è quel quod che rinvia appunto all’atto in atto o
all’evento. Il pronome personale io è “suireferenziale”: non rinvia a nulla al di fuori dal discorso
perché è il deittico riflessivo che ostende nel discorso l’aver luogo del discorso, il suo evento
incircoscrivibile, il suo “che c’è”.
Cosa non comprende il materialismo dei materialisti, secondo Marx? Non comprende che se le
condizioni fanno l’uomo, l’uomo fa le condizioni. Non comprende, scrive Marx, che l’educatore (le
condizioni) deve essere educato (tesi 3). Non comprende “la prassi rovesciata” (tesi 3) o la
“duplicazione del fondamento” (tesi 4). Ma questo che cosa significa se non che la molteplicità
delle pratiche determinate, che fanno l’uomo qual è, o meglio quale è stato (l’essentia è “ciò che
era essere”), rinviano, come a loro fondamento, alla prassi in atto, al presente assiale della prassi?
Rinviano alla “realtà come prassi”, come scrive Gentile, rinviano alla realtà “come energia”, come
energeia, come atto in atto. “Primo teorema” della filosofia di Marx, continua Gentile, è che “la
realtà è prassi”. Rinviano cioè alla prassi-materia-evento, a quello sfondo di immanenza che ci
“avviluppa”, secondo la felice traduzione che Cambria ci dà dell’espressione sartriana contenuta nel
secondo tomo della Critica della ragion dialettica.
La prassi in atto (l’evento) nomina la differenza impercettibile tra ciò che le circostanze fanno di
noi (in quanto oggetti del mondo o soggetti al mondo, in quanto fatti) e ciò che facciamo delle
circostanze che ci hanno fatto quali siamo (in quanto soggetti del mondo, in quanto atto di quel
fatto): nomina la storicità della storia, quanto permette alla storia, ad esempio al feudalesimo, di
accadere, e, quindi, anche di passare, di transitare in altro. Se il fondamento (il sostrato, dice Marx)
non si sdoppiasse (incessantemente) 1) nel significato (le condizioni, l’ambiente, i fatti ecc) e 2)
nell’evento di quel significato (che non è un significato, ma per così dire il suo orlo o la sua soglia:
il suo atto), come sarebbe possibile la storia? Cioè la negazione determinata, il divenire dialettico?
Ricapitoliamo. 1) Ogni prassi in atto è una pratica di qualcosa: produzione di oggetti da parte di un
soggetto determinato, rapporti di produzione determinati, modi della produzione e universi
ideologici di riferimento. Nel linguaggio dell’idealismo, diremmo che la coscienza è sempre
coscienza di qualcosa, il pensiero è sempre pensiero di questo o di quello, anche di me come
soggetto-oggetto di quel pensiero, come supergetto. 2) Il rapporto tra la prassi e le pratiche è però
un rapporto di differenza e implicazione. La prassi è sempre in atto, en ergon, nelle concrete
pratiche di qualcosa, ma non è una pratica, ne è piuttosto l’evento, ne è il presente assiale. Nel
linguaggio dell’idealismo, stiamo dicendo che la coscienza suppone l’autocoscienza la quale però
non può essere ancora coscienza posizionale di sé come è coscienza della cosa, pena la regressione
infinita del presupposto: essa deve essere supposta integralmente in atto come autocoscienza in
ciascuna delle coscienze determinate senza ridursi a nessuna di esse.
La prassi come soggetto si dispone sul piano trascendentale.
La prassi come soggetto è campo trascendentale de-egologizzato (impersonale o prepersonale senza
io). L’io che sta parlando, dicevamo, l’istanza di discorso presupposta ad ogni pratica del dire, non
sono “io”: “io” sono un effetto della mia parola e della parola dell’altro in risposta alla mia parola.
“Io” sono convocato nell’essere, nella presenza, dalla prassi del dire. “Io” mi incontro nel campo
aperto dall’evento della parola (nella Lichtung della parola). “Io” sono un oggetto del mondo
caratterizzato dalla stessa trascendenza degli oggetti del mondo. Ho la stessa trascendenza del tu a
cui mi rivolgo e di quello di cui parlo (della “cosa”). “Io” (ego) sono “non-io”. Io, tu e la cosa sono
dati a me 1 , ma questo me (questa coscienza) non ha bisogno di declinarsi come io. È un puro campo
di apparizione di qualcosa in quanto qualcosa. Bergson ne ha tracciato lo schizzo nel primo
straordinario capitolo di Matière et mémoire e lo ha chiamato materia. Con la difficile nozione di
immagine (che non è immagini di e immagine per, ma è immagine “in sé”) ha infatti cercato di
pensare una pura materia-coscienza. Una materia che avesse la stessa sostanza (diafana o
translucida, per usare un’espressione cara al primo Sartre) della coscienza come campo
trascendentale de-egologizzato.
Rispetto a questo campo il soggetto (io) si costituisce come supergetto, emergente dalla prassi,
“concrescente” 2 , ne è un effetto che si produce grazie alla opacizzazione in un punto della prassi in
atto. Come per Sartre l’io è una zona di opacità nella diafanicità della coscienza fungente al fondo
del mondo dato, così per Bergson l’io cosciente è una specie di “schermo nero” che trasforma la
materia-immagine in rappresentazione (percezione cosciente).
Questo campo trascendentale impersonale (materia-coscienza) appare con i tratti della cosalità
inerte – si dà “sotto forma di oggetto o di intuizione, e non già come attività sensitiva umana, come
prassi e soggettivamente” (Marx, tesi 1) – al soggetto-supergetto costituito. Sini direbbe che è un
effetto di rimbalzo. Non c’è errore in questa intuizione della materia come cosa, piuttosto “fallacia
della concretezza malposta” (Whitehead). L’astratto è scambiato per il concreto e viceversa.
Un piccolissimo esempio: i “neuroni a specchio”, si dice, darebbero un fondamento oggettivo alle
tesi fenomenologiche (e specificatamente sartriane-merlopontiane) sulla natura originariamente
irriflessa della coscienza. Sarebbero i “fatti” materiali che corroborano una felice quanto spericolata
intuizione filosofica, quella appunto della coscienza come campo trascendentale senza ego. In realtà
i “neuroni a specchio” sono il frutto dell’analisi condotta sul corpo vivente della prassi (del
pensare), sono traduzioni della prassi vivente (in atto) nel prisma analitico dello spazio: la loro
presunta elementarità (si dice che sono i mattoni della coscienza “empatica”) è il risultato di una
pratica particolare, estremamente raffinata, quella dell’astrazione teorica e della scienza
sperimentale. I neuroni a specchio sono “fatticci” (faitiches) nel senso che Isabelle Stengers dà a
questo neologismo coniato da Bruno Latour. “Fatticcio” (faitiche) è crasi di fatto (fait) e feticcio
1
2
E non vale la proposizione inversa: “io non sono davanti a io, a tu e alla cosa”
Espressione che si trova sia nel saggio gentiliano su Marx sia in Whitehead
(fétiche). Essi esistono in sé come attori del reale solo per noi che li abbiamo prodotti teoricamente
attraverso una serie di dispositivi: “i dispositivi che l’hanno fatto esistere – la Stengers parla qui del
neutrino, ma il suo discorso vale anche per quegli altri fatticci postulati “per motivi teorico-estetici
di simmetria” che sono i neuroni a specchio – presuppongono e implicano infatti un enorme
quantità di strumenti, di interpretazioni, di riferimenti ad altre particelle già venute alla luce
nell’ambito del sapere umano, e inoltre, non può prescindere da tutto un groviglio di storie umane,
sociali, tecniche, matematiche, istituzionali, culturali” (Cosmopolitiche, p. 32). I neuroni a specchio
sono il modo o uno dei modi in cui il campo trascendentale si dà “sotto forma di oggetto o di
intuizione” al soggetto-supergetto costituito. La prassi-soggetto alla coscienza riflessiva non può
ritornare (di rimbalzo) che sotto forma di fatto materiale, di oggetto per un soggetto che lo intuisce.
Cosa significa allora essere veramente materialisti? Non scambiare l’atto con il fatto, il divenire con
il divenuto, l’evento con il significato (potremmo dire anche: l’essere con l’ente). Non scambiare gli
oggetti prodotti da una pratica determinata (ad esempio: i neuroni a specchio) con la prassi (con il
presente assiale della prassi) che la pratica presuppone a suo fondamento (il che significa
concretamente “critica dell’ideologia”: smascherare la pretesa inseità di ciò che è per noi, mostrare
marxianamente la complementarità di pratica e di verità 3 ). La materia per il materialista radicale (e
non immaginario) è prassi, atto in atto, energeia.
Il tratto da cui allora si riconosce, in filosofia, l’avversario del materialismo (se volete l’idealismo)
non è il primato della coscienza, del soggetto ecc, ma la concezione della materia come hyle, come
indeterminazione, come dunamis, potenza, comunque questa potenza la si declini. Se la materia è
potenza il processo di individuazione avrà comunque il carattere semi-teologico (“mistico” nel
senso marxiano) della fecondazione miracolosa di una forma, che si dovrà supporre già data da
qualche parte a qualcuno (dio, intelletto agente, sapere assoluto). Non vi è emergenza, novità,
creazione, storicità, se non per il punto di vista dell’intelletto finito. Il tempo non fa nulla e la natura
è un processo solo nella misura in cui deve raggiungere un telos che comunque è già dato (ad
esempio, nel “programma” genetico).
Se la materia è prassi, atto in atto, il processo di individuazione è invece differenziazione creatrice,
emergenza imprevedibile, memoria revisionista che ricalcola continuamente il dato in vista di
inedite esigenze (l’evoluzione creatrice è una “pratica di pratiche”: non suppone nessun
indifferenziato di partenza, ma un “virtuale” che non ha niente a che fare con il potenziale,
“virtuale” che è la differenza). Il “lavoro”, inteso sotto il profilo dello sforzo intellettuale e
dell’invenzione, è la cifra di questa natura naturans. E la sua appropriazione, la sua riduzione
integrale a merce, è un attentato non contro la dignità dell’uomo ma contro la natura. Come tale,
non a caso, è inteso oggi il processo dell’accumulazione capitalistica da parte dei suoi critici più
avveduti e intransigenti (soprattutto nel Sud del mondo).
3
“La questione se al pensiero umano pervenga la verità oggettiva, non è una questione teorica ma una questione pratica.
Nella prassi può l’uomo provare la verità, cioè la realtà e potenza, la positività del proprio pensiero. La discussione sulla
realtà o irrealtà d’un pensiero, che si isoli dalla prassi, è una questione puramente scolastica” (tesi 2). ”“Tutti i misteri,
che sospingono le teorie al misticismo, trovano la loro spiegazione razionale nella prassi umana e nell’intelligenza di
questa prassi” (tesi 8)