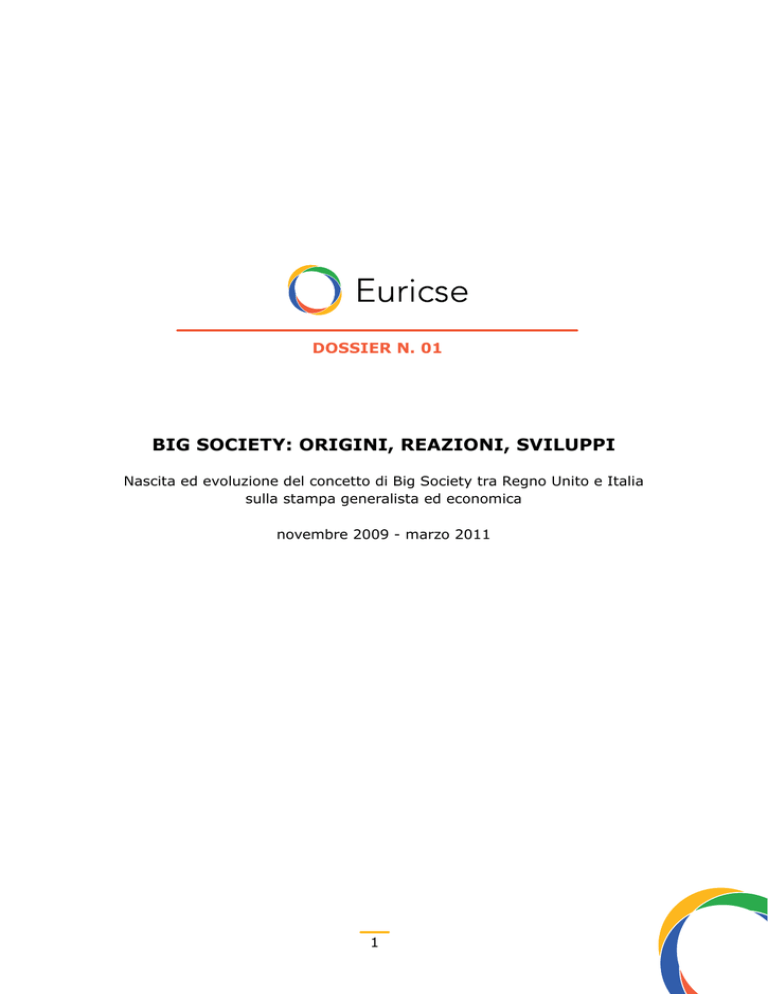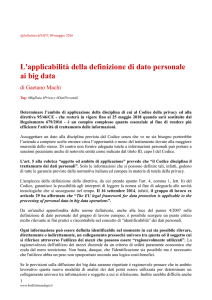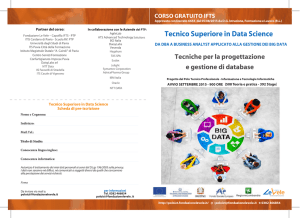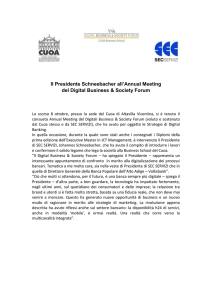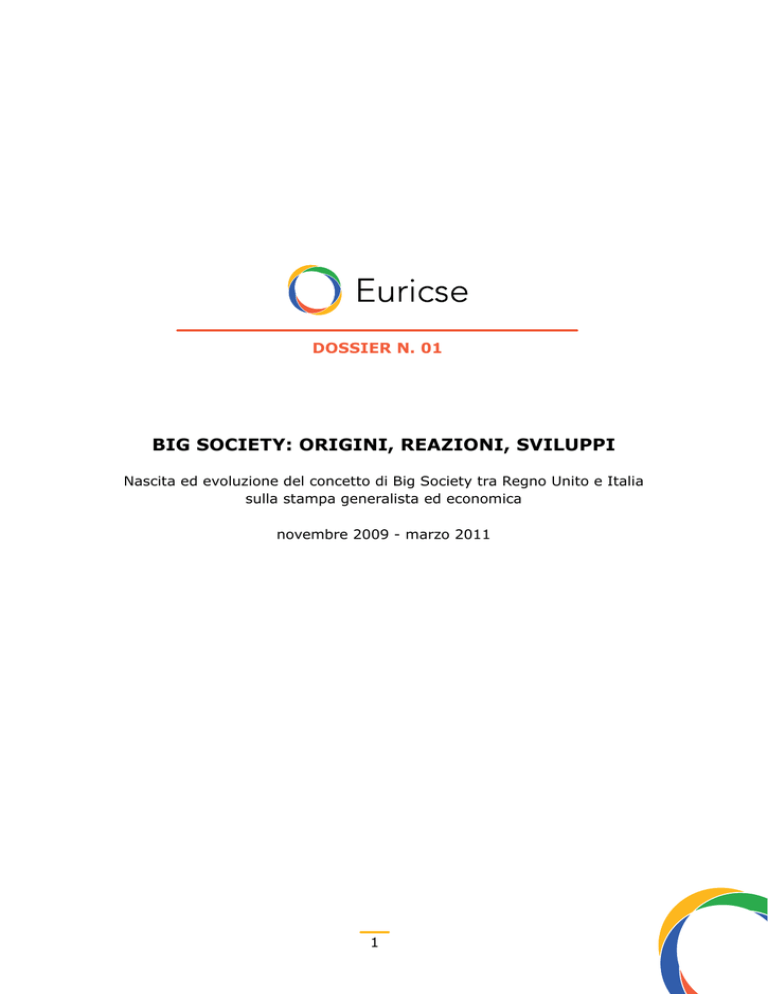
DOSSIER N. 01
BIG SOCIETY: ORIGINI, REAZIONI, SVILUPPI
Nascita ed evoluzione del concetto di Big Society tra Regno Unito e Italia
sulla stampa generalista ed economica
novembre 2009 - marzo 2011
1
1. Uno strumento per la campagna elettorale
1. Uno strumento per la campagna elettorale
Tradizionalmente, il mondo cooperativo nel Regno Unito è un feudo dei
Laburisti. A cavallo tra il 2009 e il 2010, però, qualcosa è cambiato. Nel corso
del 2009 David Cameron – leader del partito dei Tories, storicamente opposto al “socialismo” del Labour – ha preparato il suo cavallo di battaglia per
la campagna elettorale del 2010, anche se è da molti da anni che lavora alla
proposta teorica. In una serie di discorsi, dentro e fuori il partito, ha insistito
sulla necessità di ridurre il Big Government e le sue enormi e crescenti spese
e favorire, di contro, lo sviluppo dell’iniziativa dei liberi cittadini ad associarsi.
In un motto, Cameron si professa favorevole alla “redistribuzione del potere”:
alla limitazione del potere statale, unita a un rinascere della spinta dal basso,
A 20
sia in termini economici che sociali. Il discorso di Cameron del 10 novembre
2009 “The Big Society” rende bene l’intenzione del futuro premier britannico
di andare in questa direzione.
Nel corso dei mesi successivi, in particolare nel periodo che va dal feb-
braio al maggio 2010, periodo di elezioni, Cameron insiste molto sul ruolo che
le cooperative, le imprese sociali e il volontariato svolgerebbero in quella che
lui chiama “Big Society”. Già il Labour a modo suo aveva provato a spostare
la fornitura di alcuni servizi dallo stato alle cooperative, in particolare il tentativo è stato fatto con il Servizio Sanitario Nazionale (NHS). I Laburisti però
non sono riusciti a creare le condizioni sufficienti perché il processo potesse
svilupparsi e le cooperative fossero più libere di rivendere i propri servizi allo
stato. I Tories invece promettono di mettere in pratica le necessarie riforme
legislative, anche perché il progetto ha un respiro più ampio dell’originale
idea del Labour. La formazione delle imprese sociali e lo spostamento di alcune responsabilità dallo Stato ai cittadini sono sostenuti a tutto campo, per
attuare un radicale cambiamento nella società e nel governo. Le reazioni
alle proposte dei Tories sono da una parte entusiaste, dall’altra scettiche e
preoccupate. Riusciranno i Tories a sostenere dall’alto un processo che deve
nascere dal basso? Sembra contraddittorio, infatti, che un progetto fortemente voluto dal premier stesso si possa poi concretizzare dalla base (The Daily
A 31
Telegraph, “Dave's Big Society is not a top-down project – that's why it was
launched by the Prime Minister”, 19 luglio 2010, G. Warner). E ancora: l’operazione è in realtà finalizzata alla privatizzazione dei servizi? (N. Timmins,
A 33
Financial Times, 16 febbraio 2010, “New ways to prop up old concept hard to
find”.)
2
2. Decentralizzare i servizi
2. Decentralizzare i servizi, ridurre la burocrazia
La riduzione del peso dello Stato nel Regno Unito ha principalmente due
obiettivi: da una parte risparmiare, dall’altra incentivare l’iniziativa dei cittadini
e il senso comunitario (questo secondo fine, in realtà, è anche un mezzo per il
primo). Le due strategie proposte dai Tories per conseguire il risparmio sono la
decentralizzazione dei servizi e la riduzione della burocrazia. (N. Timmins, Financial Times, 13 aprile 2010, “Tories claim good government will cost less”.)
A 34
Il piano previsto dalla Big Society è apparentemente semplice: sposta-
re i servizi dallo Stato centrale alle comunità locali, e in queste stesse comunità far sì che siano i cittadini stessi a intraprendere direttamente le azioni
necessarie al loro benessere, rivendendo i loro servizi allo Stato. Il servizio
fornito direttamente all’interno della comunità che lo richiede viene così a costare meno, perché si evita il passaggio dalla comunità al centro governativo
e ritorno. Le azioni nel locale, inoltre, possono essere direttamente mirate
sulle reali necessità della popolazione, evitando così sprechi. Questi sono
alcuni punti dell’agenda della Big Society. Il programma però, come è chiaro
a Cameron stesso, non può prescindere dallo spirito di iniziativa dei cittadini, i quali dovrebbero assumersi alcune delle responsabilità tradizionalmente
attribuite allo Stato (per fare un esempio, l’istruzione). Non a caso Cameron
richiama nei suoi discorsi la sfida che John F. Kennedy rivolse agli americani e
dice ai cittadini inglesi: “Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi,
chiedetevi cosa potete fare voi per il vostro paese”.
In Italia – dove il dibattito sulla Big society è arrivato come riflesso del-
le elezioni britanniche e si è sviluppato nei mesi successivi sull’eventuale importabilità del modello inglese – si è sottolineato proprio questo aspetto della
Big Society: “esito di una spinta vitale che sale dal basso, di esperienze consapevoli, di passione condivisa rispetto alla realtà e ai problemi che presenta”
(Il Sussidiario, 8 settembre 2010, “Un Cameron per l’Italia”, G. Frangi). Fa da
A36
contraltare all’idea la riconosciuta necessità che questo tipo di cambiamenti
siano diretti dall’amministrazione, che deve gestire e organizzarne le forme.
Infatti “Il ‘dimagrimento’ dello stato indotto dalle necessarie misure di risanamento della finanza pubblica in favore della ‘big society’ è destinato ad
accrescere il ruolo dei privati nella produzioni di beni e servizi collettivi. Questa trasformazione, tuttavia, non potrà avvenire semplicemente mettendo da
parte l'amministrazione. Questa, invece, dovrà svolgere un inedito e difficile
ruolo di ‘facilitatore’ dell'iniziativa privata”. (Il Sole24Ore, 28 settembre 2010,
“Se il funzionario cambia cultura”, G. Napolitano)
3
A 37
3. Rivendere i servizi
3. Rivendere i servizi: incentivare i cittadini a formare imprese
Come debba esattamente avvenire il passaggio di consegne tra Stato
e privati e in quale misura debba rimanere un controllo statale sui servizi è
stato oggetto di molteplici proposte e precisazioni da parte del Governo. Gli
interventi dello staff di Cameron (tra cui il ministro del Cabinet Office, Francis Maude) sembrano infatti avere l’esigenza di rispondere ai dubbi esposti dall’opinione pubblica e dalle principali testate nazionali. David Cameron
sostiene che lo Stato non può avere il monopolio della fornitura dei servizi
pubblici: una percentuale di questi devono essere devoluti al settore privato
e a quello del volontariato. Un articolo del Financial Times (N. Timmins e J.
A 39
Pickard, “Cameron scraps idea of quotas in service provision”, 21 febbraio
2011), riportando le parole del primo ministro, spiega che la riforma del settore “create(s) a new presumption (…) that public services should be open to
a range of providers competing to offer a better service”. Ma il punto secondo
il quale “the state does not have to be the default provider” (ibid.) non è condiviso da tutti, tanto che il Financial Times sostiene che “there are tensions
over the extent to which that means traditional privatisation” (ibid.).
Alla base delle tensioni c’è anche l’apparente contraddizione di lanciare
un progetto dal basso, fondandolo sull’iniziativa individuale dei lavoratori, atA 41
traverso l’intervento e la direzione dall’alto dello Stato centrale (N.Timmins,
Financial Times, “Maude backs private role for public services”, 10 febbraio
2011). Il piano di Cameron invita infatti i cittadini a “partecipare al governo
della Gran Bretagna”, andando così a operare a un livello che non è localistico
in senso tradizionale, non riguarda cioè quelle che The Economist definisce
A 42
“Britain’s impotent local authorities” (“Second invitation. David Cameron puts
muscle into his favourite theme”, 22 luglio 2010); è invece chiaro che chiamando “alle armi” i cittadini, “Mr Cameron wants to push power further down,
to the ‘nano’ level. This vision sees parents helping to set up new schools,
public-sector workers running their own services as co-operatives, and small
groups of people volunteering on local projects”.
Un livello, quello della cittadinanza attiva, che non sembra così facil-
mente coinvolgibile, anche perché i lavoratori sono reticenti ad abbandonare
un sistema che li ha sempre sostentati. Forse per colmare queste lacune il
governo britannico ha cercato di tradurre la Big Society in azioni e proposte
concrete, a partire dal programma di governo presentato dai Tories nelle
A 44
elezioni del 2010, definito come “a sort of Five Year Plan without Stalin” (C.
Cavendish, The Times, “This is a five-year plan that might really work”, 21
4
4. Filosofia e sostanza della Big Society
maggio 2010) per la sua concretezza operativa. Altre proposte sono state
avanzate, quali i “laboratori per il decentramento”, o le “enterprise zones”,
dieci aree di sviluppo agevolato che sono state commentate anche in Italia
(G. Gentili, Il Sole24Ore, “Il nuovo sviluppo è zona franca”, 15 marzo 2011)
A 46
in merito al divario tra Nord e Sud del nostro Paese.
La Big Society e la sua realizzazione risultano essere un tema molto
dibattuto, ma per il momento i verbi che più frequentemente appaiono sui
giornali sono “proporre”, “lanciare l’idea”, “annunciare a breve”, “sognare”.
Segno che l’attuazione del programma non è così facile e che il cittadino medio non è sempre preparato a una riforma così radicale, che modifica la sua
vita di ogni giorno.
4. Filosofia e sostanza della Big Society
Il 31 marzo 2010 il Daily Telegraph (“Eureka! At last, I can see what
A 48
David Cameron is on about”) si dimostra ottimista nei confronti del progetto
dei conservatori inglesi: ritiene che, benché molto ambiziosi, gli intenti siano
chiari. Ciò che va cambiato è il rapporto tra lo Stato e gli individui e il modo in
cui questi si relazionano; il punto è spostare il centro sulle piccole comunità.
Su questa linea si tiene anche professore-guru Richard Florida, recentemente
assunto dal premier inglese come consigliere. Come riporta Il Sole24Ore il
12 dicembre 2010 nell’articolo “La mia utopia: un Tamigi da Silicon Valley”,
A 50
Florida vede nel progetto di Cameron una forte spinta innovatrice, proiettata
verso il futuro, disposta a mettersi in gioco e a rinegoziare l’intero apparato
dei rapporti tra Stato e individuo e tra centro e periferia. Felice di un progetto
dall’ampia portata anche Joaquìn Navarro-Vals che dice: “‘si devono creare
comunità che abbiano verve; quartieri che si facciano carico del proprio destino, che sentano che mettendosi insieme possono plasmare il mondo attorno
a loro’. In una parola, si tratta di proporre un grande disegno etico-politico,
capace di comprendere e gestire laicamente le dinamiche culturali del momento, e non solo di presentare una serie minimale di punti programmatici.”
(Repubblica dell’11 ottobre 2010, “Il Ritorno dei valori in politica”.)
A 52
La Big Society viene spesso enunciata come una riappropriazione delle
libertà individuali contro uno Stato opprimente (19 luglio 2010, The Guardian, "Cameron promises power for the 'man and woman on the street'").
Secondo altre descrizioni dell’idea di Big Society, tra cui a volte quelle del
premier inglese stesso, questa visione del progetto è riduttiva. Per Cameron
5
A 54
4. Filosofia e sostanza della Big Society
la Big Society non è semplicemente una riaffermazione del diritto di impresa
o del singolo, essa è allo stesso tempo il rinascere di un sentimento comuA 56
nitario. John Kay sul Financial Times del 22 febbraio 2011 (“Time for the Big
Society to get down to the nitty-gritty”) ha enfatizzato proprio questo punto
dandone una spiegazione filosofica: secondo il modello filosofico politico del
contratto sociale attualmente prevalente, dato da John Rawls e filosofi affini nel ventesimo secolo, le società sono costituite da atomi individuali, uniti
da una spinta razionale a costituire un ordine efficiente. In uno scenario di
questo tipo viene dato poco spazio ai sentimenti di solidarietà e un gran peso
invece alle libertà individuali. Nell’impostazione dell’Inghilterra della Thatcher
e di Gordon Brown, invece, sostiene Kay, vi è, di base, una netta distinzione
tra la sfera pubblica e quella privata, entrambi con una loro autonomia, dove
il singolo e lo stato sono essenzialmente separati (anche se la linea di demarcazione può essere tirata in punti diversi). Ancora diversa l’impostazione di
Blair e di questa Big Society, la cosiddetta Terza Via. Qui i confini sono ben
più sfumati: le istituzioni locali sono un ibrido di cittadino e Stato; nella Big
Society la comunità non è costituita da atomi indipendenti, essa è in un certo
senso preesistente agli individui che la abitano.
In Italia si continua a discutere sulla Big Society, sui suoi principi fon-
danti e su quale ne sia l’effettiva sostanza. In un articolo del 22 febbraio 2011
A 58
il Corriere della Sera intervista Lord Wei, l’ideologo dietro il progetto di Big
Society (“I tagli da soli non bastano La vera ripresa è la Big Society”). Come
per molti inglesi anche qui si fa ancora difficoltà a capire che cosa sia effettivamente la Big Society. Per spiegarlo Lord Wei usa una metafora: “La Big
Society è un progetto politico che stimola la comunità ad essere protagonista
della modernizzazione. Libera l’iniziativa, promuove la solidarietà. Sposta il
baricentro del potere dallo Stato alla società. Riassumo con una immagine:
la Big Society è la ‘coral reef’, la barriera corallina, l’ecosistema nel quale
i cittadini vivono, partecipano, si associano”. A proposito dell’analogia con
Terza Via di Blair, Wei risponde: “In un certo senso è la sua evoluzione. La
terza via laburista valorizzava il ruolo e il contributo dei privati ma non parlava di volontariato. Ci sono quattro dimensioni di cui dobbiamo tenere conto:
l’individuo, la famiglia, le associazioni di cui è parte l’individuo, le istituzioni.
Noi poniamo l’accento non soltanto sull' individuo e sulle istituzioni ma anche sulla famiglia e sul volontariato. La sfida è trovare l’equilibrio fra queste
dimensioni.” Per Wei, infatti, esempi di Big Society sono dati dall’iniziativa
personale e volontaria a migliorare un servizio pubblico: “se in una zona di
Londra, di Manchester, di una qualsiasi città, vi sono un giardino, una scuo-
6
5. Big Society e sussidiarietà all’italiana
la, una struttura pubblica che non funzionano bene o che hanno problemi
di manutenzione anche perché il titolare del contratto non è all' altezza o è
negligente, allora perché non offrire ai cittadini l' opportunità di intervenire
direttamente? Si possono coinvolgere i pensionati per il controllo dei parchi,
si possono creare gruppi di volontariato sia per supervisionare e correggere
le spese destinate ai servizi pubblici sia per vigilare sulla crescita urbanistica.
I cittadini, attraverso le organizzazioni del volontariato, decidono con chi stipulare i contratti e controllano il flusso di cassa.” Da una recente inchiesta del
Financial Times, però, risulta che la percezione delle piccole e medie imprese
non è così chiaramente orientata a considerare la Big Society come diversa
dalla Terza Via di Blair (“SMEs divided on big society idea”, 28 febbraio).
A 60
Non mancano i tentativi di comprendere il fenomeno inglese para-
gonandolo a casi italiani e usandone l’ideologia. Il Corriere della Sera del
10 settembre 2010 (“I cittadini ridisegnano la città”) riporta che l’assessore
A 61
all’urbanistica di Milano, per esempio, ha aperto alle osservazioni in materia
di chiunque sia interessato a dare il proprio contributo: “Come dice Cameron,
dobbiamo cambiare l’approccio verso il governare, perché la gestione dall’alto
al basso, con controllo rigido e totale, ha finito con l’indebolire la responsabilità, l’iniziativa locale e l’azione civica”.
5. Big Society e sussidiarietà all’italiana
Un filone importante del dibattito italiano sulla Big Society è costituito
dal paragone con la nostra struttura sociale e dall’evidenziazione di punti in
comune e di differenza. Secondo alcuni, infatti, la Big Society da noi c’è già,
ed è costituita dall’associazionismo e dalla solidarietà: questa l’opinione di
Emanuele, presidente della Fondazione Roma (“Tappa di Lord Wei a Roma, la
A 63
via italiana della Big Society”, Corriere della Sera, 25 febbraio). Si spinge oltre
Carlo Borzaga, presidente di Euricse, che in un intervento su Vita del 14 gennaio 2011 (“Il modello italiano che fa invidia a Cameron”) fa notare agli entusiasti della Big Society quanto la situazione italiana sia altrettanto – se non
più – interessante: “due le ragioni positive per approcciare almeno con sano
realismo le proposte d’Oltremanica: la prima perché l’Italia ha già sviluppato,
assai prima degli inglesi, proprie forme di imprenditorialità sociale ampiamente studiate da economisti e sociologi di quei Paesi, e la seconda perché ha
fatto di queste nuove forme imprenditoriali un soggetto non semplicemente
sostitutivo dell’intervento pubblico, come nella proposta di Cameron, ma nella
7
A 64
5. Big Society e sussidiarietà all’italiana
maggior parte dei casi aggiuntivo”. Su Italianieuropei Borzaga stesso precisa
che nella formula italiana la cooperazione sociale è riuscita ad andare anche
oltre: “Poichè una buona parte dei servizi sociali del paese - probabilmente
più del 40% - è oggi offerta da cooperative sociali, si può certamente affermare che la cooperazione sociale ha dato un contributo decisivo al passaggio
da un sistema di welfare tutto incentrato su erogazioni monetarie a uno più
A 66
attento alla domanda di servizi” (“La cooperazione sociale”, marzo 2011).
Lo stesso Phillip Blond, consigliere del primo ministro britannico, ritiene
che in Italia le associazioni religiose costituiscano già il collante sociale che
A 71
il Regno Unito sta cercando di ricreare (“Il modello è già in casa: la big society all'italiana”, Il Sole24Ore, 9 settembre 2010). In particolare il modello
di sussidiarietà citato da Phillip Blond, è quello della Lombardia, grazie alla
sua fitta rete di assistenza cattolica. Blond ha anche incontrato il governatore
della regione, proprio per questa ragione (“Big Society, Lombardia modello. Il
governo inglese guarda a noi”. Video dal Forum Terzo Settore).
Ma anche alcuni italiani, come Luca Antonini, insistono nel sostenere
che la sussidiarietà sia una delle basi fondanti del nostro Paese e che sia sostanzialmente questo che si intende con “Big Society” (Il Sole24Ore dell’11
A 72
febbraio 2011 “Rinascere da un nuovo 41”). Recentemente Panorama è tornato sull’argomento, presentando i numeri del terzo settore in Italia ed equi-
A 74
parandolo alla Big Society inglese (“Ma quanto è grande la ‘Big Society’ in
Italia?”, 15 febbraio 2011).
Il Sussidiario dedica all’argomento una serie di articoli dove si sostiene
che in sostanza la Big Society in Italia ci sarebbe già, ma non è valorizzata,
A 75
A 76
né potenziata come dovrebbe. Si ripete del modello virtuoso della Lombardia
(“La Big Society? Grazie Cameron, ma in Lombardia c’è e funziona”, 19 settembre 2010). E’ interessante notare come in alcuni passaggi (“Ecco la filiera
che manca nell’Inghilterra di Cameron”, 23 ottobre 2010) la stessa testata
parli di ciò che è la Big Society non associandola solo al mondo no-profit: “A
valle, la Big Society, in italiano, si traduce operativamente come “filiera sussidiaria aziendale” composta da imprese sociali “di sistema” (associazioni,
cooperative mutualistiche e sociali, fondazioni, comitati, ong ) ed “ex lege”
(L.118/05, D.Lgs.155/06
e decreti attuativi) e imprese private profit che
producono beni e servizi di utilità sociale per l’interesse generale e per il bene
comune. La sfida è passare dal principio di sussidiarietà in termini di mission
politica e di principio giuridico all’operatività incidente nel sistema tramite i
risultati di bene comune perseguiti dalle imprese sociali profit e non profit.”
Su questa “linea ampia” di definizione della Big Society, che include terzo
8
5. Big Society e sussidiarietà all’italiana
settore, società civile e imprese sociali, si muove lo stesso Cameron nella non
facile impresa di dare una chiara idea di quale sia il suo progetto (Financial
Times, “Even Cameron struggles to define concept”, 10 febbraio 2010).
A 78
Anche il governo italiano rielabora una sua versione della Big Society e
la esalta come ossatura del piano di sviluppo economico e sociale dell’attuale
legislatura: in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il ministro Sacconi sostiene che “Il governo pratica fin dall'inizio una rigorosa disciplina di
bilancio, ma lo fa nell' ambito di una visione che si compone di due elementi
tra loro incrociati: il federalismo fiscale e il nuovo modello sociale sussidiario
(…) vale a dire, l' incrocio della sussidiarietà verticale con quella orizzontale.
Meno Stato, più società”. E precisa: “È una rivoluzione nella tradizione. Una
rivoluzione che affonda le radici nella tradizione della fraternità francescana,
delle opere pie, delle società di mutuo soccorso, delle cooperative laiche e
socialiste” (A. Cazzullo, “Sacconi: diamo più spazio alla società. Con la crisi
è finito lo Stato pesante”, 30 agosto 2010). Ma un problema grosso, segnala
Carlo Borzaga (Il Sole24Ore, “Il terzo settore vince con più reti”, 4 ottobre
A 79
A 82
2010) è proprio “il mancato riconoscimento da parte della politica. Non ci
sono forme di sostegno né benefici fiscali, né strategie di sviluppo dell’impresa sociale: mentre nel Regno Unito il governo Cameron lancia il progetto
di una Big Society qui da noi, dove la società civile è anche più radicata, si
naviga a vista”.
Alcune testate, per quanto riconoscano la presenza in Italia di qualcosa
di molto vicino alla Big Society, evidenziano come anche in Italia andrebbe
ripensato il rapporto tra lo Stato e i produttori di servizi sociali. La Stampa vi
dedica un articolo il 30 novembre 2010 (“Ora serve una svolta straordinaria
A 84
nel sociale”) e su Il Sole24Ore, il primo marzo 2011, Guido Gentili sottolinea
che è l’Italia la “culla storico-culturale di un progetto del genere” e qui dovrebbe tornare sebbene il concetto abbia preso piede in Inghilterra (“La Big
A 86
Society? Farebbe bene anche all’Italia”).
Il tema è stato anche al centro delle “giornate sul mondo cooperativo“
tenutesi a Milano inizio febbraio 2011. Legacoop riporta: “‘Per molti anni si
sono contrapposti due modelli, quello dello Stato e quello del mercato libero.
Il risultato è stata la monopolizzazione dei capitali nelle mani di pochi, Stato
o oligarchie di quelli già ricchi”, ha sottolineato Phillipp Blond. “La crisi ha
spazzato via entrambi gli approcci”. Ma come si costruisce allora un modello
più giusto? Secondo Blond la strada è ridistribuire: ‘L’attività cooperativa, la
sussidiarietà, il mutualismo, a lungo considerati marginali nel futuro dell’economia e della società, rappresentano una terza via’”.
9
A 88
6. Big Society Bank
6. Big Society Bank
La Banca per la Big Society, il tassello fondamentale per l’attuazione
del progetto, dovrebbe prendere finalmente il via quest’anno. Il Financial
Times spiega che la storia della banca inizia, in realtà, con il Labour, come
A 90
Social Investment Bank, la Banca per l’Investimento Sociale (“Big Society
Bank – a decade in the making”, 14 febbraio 2011). La Banca ha vissuto una
continua storia di ridimensionamenti: con i Laburisti doveva avere a disposizione due miliardi di sterline di fondi, che poi si è scoperto non essere disponibili. Nell’ultimo periodo del governo laburista la cifra era stata ridotta a 75
milioni di sterline. La notizia era stata accolta positivamente dal mondo del
A 91
volontariato, benché la cifra potesse essere più alta dato che si sarebbe potuto attingere ai conti corrente dormienti (“Social investment wholesale bank
will be established”, Third Sector, 24 marzo 2010).
Ora si vuol dare finalmente vita alla Big Society Bank, con una somma
iniziale che oscilla tra i 60 e i 100 milioni di sterline nel primo anno, attinti
principalmente dai ricavi della lotteria nazionale. Ci si aspetta però di portare
entro i prossimi anni la cifra prima a 200 e poi 400 milioni di sterline, sbloccando il denaro presente sui conti correnti bancari dormienti e attingendo a
fondi messi a disposizione dalle banche commerciali. Qui nasce un problema:
un’operazione di questo tipo richiede l’autorizzazione dell’Unione Europea,
che potrebbe bloccare tutto. Per difendere il progetto di una banca per Big
Society, David Cameron torna a difendere l’idea stessa che è alla base, rispondendo così ai critici: “Some people say it’s too vague. Well, if they mean
by that there isn’t one single policy that’s being rolled out across the country,
A 92
A 94
well yes, I accept that because actually what we are talking about here is a
whole stream of things that need to be done.” (“EU obstacle to Big Society
plan”, 14 febbraio 2011, Financial Times).
Secondo il Financial Times (“Big Society plan ‘will not plug cuts gap’”,
10 febbraio 2011), però, ci sono molte buone idee e proposte nel progetto ma
fondi di questa entità non bastano a coprire l’ampia scala dei tagli. La banca,
infatti, dovrebbe avere un capitale iniziale di alcune centinaia di milioni di
sterline, cui si vanno ad aggiungere i fondi provenienti da azioni di filantropia e simili; nulla a che vedere, però, con gli annunciati tagli di 81 miliardi di
sterline, dei quali tra i 3 e i 5 miliardi colpiranno le organizzazioni di beneficienza.
E’ interessante comunque notare come il governo britannico si stia
sforzando di coinvolgere le banche nella Big Society. La notizie viene data an-
10
7. Uscire dalla crisi economica: uscire dalla crisi sociale
che in Italia da Il Sole24Ore (“Accordo tra governo e banche inglesi sui bonus
dei ceo e i prestiti alle imprese”, 9 febbraio 2011). Nick Clegg, il vice primo
A 96
ministro britannico, infatti, sta riuscendo in una certa misura a convincere gli
istituti finanziari a spendersi in iniziative socialmente utili, anche perché, cosa
da non sottovalutare, sembra che questo sia un tema che diventa sempre più
caro ai singoli investitori. Questo tipo di investimenti dovrebbe colmare lacune che un governo centrale non può riuscire a colmare e allo stesso tempo
permetterebbe di tagliare sui costi statali. Il primo fondo di impatto sociale, di
5 milioni di sterline, proveniente da filantropi e organizzazioni di beneficienza,
è stato usato per la prigione di Peterborough, finalizzato al reinserimento nella società degli ex-galeotti. In questo caso, il profitto proverrà dall’auspicata
diminuzione dei recidivi. Altri progetti di questo tipo sono in corso di progettazione e istituti come JPMorgan e Deutsche Bank si stanno interessando alla
cosa (“Clegg tackles banks on social investing”, Financial Times, 18 gennaio
A 97
2011).
Su la Repubblica (“La Big Society: una storia italiana”, 3 febbraio 2011),
A 99
Leonardo Becchetti ha evidenziato come in Italia esista da tempo un tradizione di banche cooperative, etiche e impegnate in investimenti socialmente
utili: “Con tutto il rispetto (…) per le avveniristiche innovazioni promesse per
il sistema bancario britannico la ricchezza e vitalità della nostra società civile
ha partorito da tempo un sistema di banche cooperative e popolari e, ultimamente di banche etiche, che svolgono da tempo questa funzione e che hanno
saputo capitalizzarsi raccogliendo risorse finanziarie e consensi dalla società
‘non dormiente’ dei nostri territori.”
7. Uscire dalla crisi economica: uscire dalla crisi sociale
Negli ultimi tempi il Financial Times è tornato più di una volta sull’ar-
gomento: gli investitori sono sempre più attenti a dove vanno a finire i loro
soldi. In particolare, aumenta la sensibilità nei confronti di investimenti tesi
non solo a un profitto ma anche ad un vantaggio per la società (“Investors
seek returns in social gain”, 10 febbraio 2011) e, chiaramente, se il loro interesse per questi temi cresce, proporzionalmente fa lo stesso quello degli
istituti finanziari.
In una certa misura è a pulsioni come questa che si appella David Ca-
meron quando chiede ai cittadini britannici di tornare ad avere un sentimento
comunitario. Ancora di più. Il premier ritiene che uscire dalla crisi economica
11
A 101
8. I critici (1): la Big Society è una scusa per tagliare fondi?
A 103
non sia sufficiente, se allo stesso tempo non si supera anche quella, più grave, che è la crisi sociale (“Cameron targets ‘social recovery’”, Financial Times,
14 febbraio). Con questi argomenti Cameron risponde anche a chi lo accusa
di aver messo su l’intero progetto esclusivamente per giustificare gli enormi
tagli apportati alla spesa statale: “We need a social recovery to mend the broken society – to me, that’s what the Big Society is all about” (ibid.). Cameron
insiste che la Big Society non è solo un progetto passeggero: è la sua mission,
l’idea di radicale cambiamento per un Paese in difficoltà.
8. I critici (1): la Big Society è solo una scusa per tagliare fondi e privatizzare?
E’ un dato di fatto che il governo inglese stia mettendo mano ai conti
pubblici, tagliando centinaia di milioni di sterline di fondi. Mancano i fondi.
Questa è la ragione principale per cui almeno 400.000 posti di lavoro statali
A 105
verranno tagliati nei prossimi 5 anni (B. Groom, Financial Times, “Former
public sector workers are a hard sell”, 23 febbraio 2011). Alcuni di questi
lavoratori, si auspica, prenderanno l’iniziativa di formare un’impresa sociale,
o qualcosa del genere, ma – sempre stando al FT – “More than half of private sector companies say they have no interest in taking on ex-public sector
workers and think they lack the right skills, according to a poll by Barclays
Corporate and the Financial Times”.
Alcuni critici ritengono quindi che quella dei tagli necessari sia solo
una scusa: il vero scopo è privatizzare tutto. E i primi a sottolineare i problemi sono proprio i dirigenti delle organizzazioni del terzo settore, quelle che
dovrebbero essere direttamente coinvolte nel progetto. La priorità in un momento di così grande difficoltà per l’economia mondiale – dicono – dovrebbe
A 107
essere risolvere i problemi occupazionali: per la grande società c’è tempo (D.
Kruger, “Death by a thousand cuts for Big Society”, 6 febbraio 2011, Financial Times). Di avviso simile Matthew Scott, rappresentante di organizzazioni
sociali e di volontariato, che dalle pagine di Third Sector Online spinge i conservatori a chiarire la loro idea di “big society”, prima che venga associata da
molti all’idea di “grossi tagli”. Scott loda l’interesse alle attività della società
civile, ma sostiene che per riuscire nei suoi propositi il governo deve ascoltare
i piccoli gruppi già attivi e dimostrarsi disponibile a fare investimenti nel terzo
A 109
settore, altrimenti le attività locali potrebbero diminuire invece che permeare la società (J. Plummer, “Explain 'big society' or cynicism will kill it, go-
12
8. I critici (1): la Big Society è una scusa per tagliare fondi?
vernment is warned”, 12 maggio 2010). Più drastica la denuncia dell’ACEVO
(Association of Chief Executives of Voluntary Organisation), secondo la quale,
contrariamente a quando annunciato dal presidente Cameron, i progetti del
settore volontario vengono tagliati piuttosto che incrementati, e questo prima
ancora che siano annunciati i previsti tagli ai vari distretti (N. Timmins, Financial Times, “Voluntary sector projects ‘already being cut’”, 9 settembre 2010).
A 110
E su questo punto insiste anche James Boxell del Financial Times, sostenendo
che i “charity bosses have told him [Cameron, n.d.r.] he risks killing the Big
Society at birth because of deep cuts to councils’ voluntary sector grants”, tagli che rischiano di rendere inutile la comprovata continuità delle donazioni al
no-profit anche in periodo di crisi. Affinché il terzo settore fornisca più servizi
sarebbero necessari più fondi, non più tagli.
Secondo quanto riporta The Economist il 10 febbraio 2011 (“Platoons
A 111
under siege”) la mancanza di esiti concreti a quasi un anno dalle elezioni ha
portato malumori sia nell’opinione pubblica “David Cameron needs examples
(…) to show that his big idea is more than wishful thinking, or worse. His
government’s inclusive motto—“We’re all in this together”—is being drowned
out by accusations that its grand project is a cynical cover for public-sector
cuts” sia nel suo stesso partito, dove “some Tories believe that last year’s general election might have been won outright had Mr Cameron not harped on
about his pet philosophy, and are not reconciled to it”.
Anche in Italia le critiche su questo versante non sono mancate, so-
prattutto nel mondo della stampa economica. Il Sole24Ore pubblica il 26 febbraio 2011 un articolo dal titolo “Se la big society non dà la felicità proviamo
col Pil”, dove Riccardo Sorrentino sostiene che “la big society non è il tentativo
di rivitalizzare e risvegliare la società civile, la partecipazione, l'innovazione
e l'"imprenditorialità" - in senso lato, anche non-profit - nella gestione beni
pubblici o comuni. È il semplice tentativo di tagliare le spese statali senza
dover fare e annunciare scelte impopolari, un po' scaricando la responsabilità
e gli oneri su altri soggetti.” Il 2 gennaio 2011 lo stesso Il Sole24Ore aveva
commentato aspramente la proposta inglese di tassare gli istituti di credito i
soldi per alleviare la stretta sullo stato sociale: “le mani nel portafogli dei banchieri che le associazioni britanniche del volontariato suggeriscono d'infilare,
una volta di più e con rinnovata lena, sono l'immagine di un contrappasso
dantesco. Ad alta dose di populismo. Sarebbe però riduttivo liquidare solo
come propagandistica l'operazione all'esame del cancelliere dello Scacchiere,
George Osborne, chiamato a valutare se un balzello sui bonus dei bankers
debba attutire le conseguenze della stretta al welfare imposta dal deficit di
13
A 113
9. I critici (2): piccole imprese sociali per una grande società?
A 114
bilancio”, operazione che il giornale italiano considera “segno di una verticale
caduta di credibilità” (“Se la Big Society inizia in banca”).
9. I critici (2): come possono piccole imprese sociali partecipare a un
gioco così grande?
La Grande Società nelle mani delle piccole imprese. L’ossimoro non
sembra solo linguistico, almeno a giudicare dalla seconda ricorrente critica
rivolta alla Big Society: le imprese sociali locali e il volontariato delle comunità
possono davvero sopperire al bisogno nazionale di assistenza e servizi sociali?
Innanzitutto le organizzazioni che si vogliano mettere a disposizione
devono affrontare problemi enormi: uno dei criteri per ottenere l’accesso ai
finanziamenti pubblici (il Transition Fund stanziato è di £100m) stabilisce che
l’organizzazione deve avere “prove o sostanziali ragioni per credere che tra
aprile 2011 e marzo 2012 subirà un taglio di almeno il 30% dei fondi provenienti dall’offerta di servizi front-line” (Sophie Hudson, Third Sector OnliA 115
A 116
ne, “Transition Fund criticised over eligibility criteria”, 13 gennaio 2011). Il
problema è ben chiaro anche ai commentatori italiani: su Bene Comune del
9 marzo 2011 Leonardo Becchetti (“La ‘big society’. Ecco come realizzarla”)
scrive che “usare come unico criterio il prezzo finisce per aumentare il rischio che imprese di dubbia reputazione possano vincere, interrompendo a
metà contratto l’erogazione del servizio per chiedere altri soldi. Inoltre usare
esclusivamente questo criterio vuol dire trasferire precarietà sulle cooperative sociali che vincono la gara, le quali sono costrette a sottopagare il lavoro.
Qualità e copertura dei servizi sono gravemente compromesse”. Il 19 novembre 2010 Il Fatto Quotidiano, parlando dell’Inghilterra cameroniana, riporta:
“sono molti i settori in cui le coop potranno operare. A patto che presentino
un piano di gestione che dimostri la convenienza economica rispetto al servizio statale. Le opposizioni: ‘Dopo i tagli, è la ricetta sicura per il fallimento’”
A 118
(D. Ameri, “‘Big Society’, in Gran Bretagna le cooperative di lavoratori si sostituiscono allo Stato”). Alla base di tutto ci sarebbe dunque una riduzione dei
costi, tattica che il governo inglese suggerisce anche all’Italia “Phillip Blond,
della think tank ResPublica, che fa da consulente a Cameron, sostiene che il
modello di Big Society possa essere esportato anche in Italia. Anzi, il nostro
Paese sarebbe avvantaggiato, perchè le numerose organizzazioni religiose incarnano già, pur senza profitto, questo modello di “imprenditoria del sociale”,
14
9. I critici (2): piccole imprese sociali per una grande società?
diffuso soprattutto in Lombardia. In Italia inoltre ci sono più di 15.000 cooperative sociali, fondazioni e associazioni. Ci lavorano circa 350.000 persone
che forniscono servizi a 5 milioni di utenti” (ibid.).
Ma i numeri del terzo settore sono davvero sufficienti a colmare il vuo-
to statale? Secondo The Economist (“No such thing. What’s wrong with David
A 120
Cameron’s ‘Big Society’”, 10 febbraio 2011) uno dei punti deboli della Big
Society è proprio nel volontariato: non sarebbe sufficiente per la parte importante che lo Stato gli riserva nello svolgimento di servizi pubblici. “Britons
already do a respectable amount of volunteering by European standards, but
there are reasons to doubt that they are willing to do the type or amount that
he hopes” (ibid.).
La “devolution” inglese delle responsabilità statali alle imprese sociali e
ai privati cittadini sembra avere anche delle ricadute sul respiro generale della
politica cameroniana: ripiegata sul localismo e incapace di guardare al resto
del mondo, l’Inghilterra potrebbe affondare. Il rischio di una visione troppo
ristretta per l’Inghilterra viene presto segnalata dagli addetti ai lavori italiani,
a partire da Filippo Addarii, Direttore esecutivo di Euclid, che scrive su Vita
un commento dal significativo titolo “BIG SOCIETY. Una grande società per
A 122
un piccolo paese” (13 ottobre 2010). Incalza il Volontariato del Lazio con un
intervento dal titolo “La taglia small della Big Society”, dove si ribadisce che
A 124
“in teoria si passa da un primo ad un secondo Welfare, più efficace e vicino ai
cittadini, in pratica si scivola da una sussidiarietà circolare ad una della delega. In cui difficilmente gli ultimi saranno i primi”.
Le problematiche dunque non mancano. Irene Tinagli riassume bene
sulle pagine de La Stampa (“Grande società. L'illusione di Cameron”, 21 luglio 2010) gli snodi fondamentali della critica: “il problema che Cameron non
considera o non vuol vedere è duplice. Il primo è che, se davvero lo Stato
vuole stimolare e supportare degnamente le associazioni civili in tutti i settori
di assistenza in cui attualmente opera, con la stessa capillarità territoriale,
il costo dell'operazione non sarà inferiore al costo dello Stato attuale. La seconda (…) questione riguarda l'effettiva adeguatezza della società civile, pur
grande e dinamica che sia, di raggiungere e mantenere su tutto il territorio
nazionale quel livello qualitativo e quel minimo di omogeneità territoriale che
serve per far crescere il Paese e attutire le diseguaglianze tra regione e regione. (…) tutti i grandi passi avanti delle società moderne (…) sono stati compiuti grazie alla capacità di investimento massivo, costante e d'avanguardia
che gli Stati hanno fatto in istruzione, in ricerca, in infrastrutture, in servizi
sociali che consentissero al Paese di muoversi tutto intero verso un obiettivo
15
A 127
9. I critici (2): piccole imprese sociali per una grande società?
condiviso, di qualità, di competitività internazionale. Purtroppo le numerose
comunità sociali che si creano a livello locale, pur avendo centinaia di pregi lodevolissimi e meritevoli di supporto, tuttavia hanno anche dei limiti intrinseci
legati alla qualità dei servizi che sono in grado di fornire, alla loro capacità di
visione strategica di lungo periodo e di comprensione delle dinamiche economiche e sociali globali”. E conclude sostenendo che “da questo punto di vista
il problema principale della Big Society (…) è proprio quello di frammentare il
Paese in un mosaico di iniziative locali che non saranno in grado di garantire
omogeneità e qualità (…), accentuando le disuguaglianze che si propone di
affrontare”.
Secondo alcuni giornali italiani questi timori si sono già rivelati fon-
dati proprio in Italia, nel caso della recente riforma della Social Card. Un
emendamento inserito nel cosiddetto decreto “Milleproroghe” ha rilanciato
la social card anche in versione privatista con l'entrata in campo degli enti
A 129
“caritativi” impegnati nel volontariato. Secondo Roberto Mania (La Repubblica
Affari&Finanza, “Torna la social card, una beffa con pochi fondi, gestita dai
privati”, 18 febbraio 2011) “si vuole affidare anche agli enti ‘caritativi’ un pezzo della gestione della social card. Saranno loro, una volta selezionati (entro
trenta giorni dall'approvazione arriverà un decreto del ministero del Lavoro),
a individuare i soggetti davvero bisognosi. Un esame empirico, sul territorio.
Senza i soggetti pubblici. Ma chi controllerà? Quale sarà, se ci sarà, il ruolo
dei Comuni?”. E ancora Tito Boeri dalla prima pagina de La Repubblica scrive,
facendo appello a un altro aspetto dell’assistenza privata: “lo Stato assegnerà
la carta acquisti a imprecisati "enti caritativi" e saranno questi ultimi a dover
decidere a chi dare la social card e a chi no, sottraendo questo compito ai
servizi assistenza dei Comuni. (…) chi deciderà quali enti caritativi sono degni
di ricevere e distribuire le carte acquisti e quali no? Nel vuoto delle nostre politiche di assistenza, mortificate ulteriormente dai tagli ai bilanci dei Comuni
(…), spesso sono gli enti religiosi o associazioni culturalmente se non politicamente caratterizzate ad assistere i più poveri. Finché gestiscono risorse
proprie che, in principio, dovrebbero integrare le prestazioni pubbliche, non
c'è nulla di male. Ma perché obbligare un immigrato di religione musulmana a
doversi rivolgere a un ente caritatevole cattolico per ricevere l' assistenza cui
A 132
ha diritto secondo una legge dello Stato?” (“Welfare, l' inganno della carità”,
23 febbraio 2011).
16
10. L’Unione Europea e la Big Society
10. L’Unione Europea e la Big Society. Ci sono state reazioni da parte
delle istituzioni?
L’Unione Europea, intesa come le sue istituzioni centrali, ha dovuto
confrontarsi con la Big Society non solo a fronte delle richieste inglesi girate
alla legislazione europea (eliminare la regola Ue secondo cui ogni contratto
del valore superiore di 156.000 sterline deve essere pubblicizzato e soggetto
a una gara d’appalto, oppure avere il via libera per impossessarsi dei fondi
racchiusi nei cosiddetti conti bancari dormienti), ma anche rispetto a un generale impulso al rinnovamento del welfare che ha attraversato l’Europa in
questa fase di crisi. Non era forse possibile per l’UE evitare l’argomento, in
quanto la Big Society appare come una delle poche proposte concrete avanzate dai governi membri a riguardo. Agli occhi de Il Sole24Ore infatti “David
Cameron rischia di trovarsi nella posizione di unico faro ideologico pienamente funzionante su scala europea” dopo che “la sinistra europea ha la febbre
ancora alta” e “l'impressione è che le punte del centro-destra europeo siano
impegnate nella gestione dell'emergenza piuttosto che nella manutenzione
di un orizzonte ideale che possa essere fonte di ispirazione per le altre forze
conservatrici” (A. Romano, “Cameron e l'equivoco della ‘big society’”, 8 otto-
A 134
bre 2010).
In uno speciale de Il Sole24Ore dedicato alla Big Society, Paolo Venturi
evidenzia uno dei percorsi intrapresi dalle istituzioni europee per rispondere
all’esigenza di ripensare lo Stato sociale. Si tratta delle proposte per un Single
Market Act, esposte dalla Commissione Europea nell’ottobre 2010, in cui l’imprenditorialità sociale diviene il centro vivo di un mercato unico europeo che
si rafforza dando supporto al business che “fa bene” alle relazioni sociali. Scrive Venturi: “‘Più società, meno stato’: questo era lo slogan che ha alimentato
la richiesta di politiche capaci di esaltare il protagonismo in Italia dell’impresa
sociale. A più di tre decenni dalle esperienze pioniere, in una fase in cui siamo
chiamati a costruire un nuovo modello di welfare occorre recuperare il senso
di queste parole, traducendole in una nuova stagione di politiche ‘per’ e ‘con’
l’impresa sociale. Soltanto nel momento in cui la costruzione della dimensione
sociale verrà percepita non come un costo, bensì quale investimento si potrà
affermare di aver messo le fondamenta per un competitivo e duraturo mercato unico. La Big society europea passa da questa sfida che non possiamo più
rinviare” (“Il Single Market Act libera talenti e risorse finanziarie”, 28 novembre 2010).
Leggiamo infatti tra le proposte della Commissione Europea (“Verso
un atto per il mercato unico. Per un’economia sociale di mercato altamente
competitiva”, 27 ottobre 2010) la seguente idea: “n. 36: nel 2011 la Commis17
A 136
10. L’Unione Europea e la Big Society
sione proporrà un'iniziativa per l'imprenditoria sociale intesa a sostenere e ad
accompagnare lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi sul piano sociale nell'ambito del mercato unico, utilizzando in particolare il rating sociale,
l'etichettatura etica e ambientale, gli appalti pubblici, l'attuazione di un nuovo
regime per i fondi di investimento e la raccolta del risparmio ‘dormiente’”. La
Commissione europea sembrerebbe quindi venire incontro alla volontà inglese di rafforzare e finanziare il settore, ma allo stesso tempo avverte: “l'applicazione delle regole europee in materia di servizi pubblici solleva numerose questioni di ordine pratico per le autorità pubbliche competenti e alcuni
operatori del settore, in particolare nell'ambito dei servizi sociali. L'Unione e
i suoi Stati membri devono pertanto continuare a farsi garanti dell'esistenza
di un quadro regolamentare che consenta ai servizi pubblici di compiere la
loro missione e di soddisfare effettivamente le esigenze di tutti i cittadini”. Il
potenziamento dell’economia sociale viene dunque inquadrato dall’UE in termini transnazionali, di mercato unico, contrariamente a quella che è la visione
localistica spesso propugnata dal governo inglese.
Alla recente la notizia della conclusione della procedura di consultazio-
ne da parte della Commissione europea sul documento, potrebbe seguire una
validazione anche da parte di Parlamento, Consiglio, Comitato Economico e
Comitato delle Regioni delle proposte che auspicano un “rafforzamento della
A 138
solidarietà mediante (…) l’accesso ai nuovi mezzi per l’economia sociale di
mercato” (Guido Antolini, Milano Finanza, “Mercato unico ed economia sociale”, 25 marzo 2011).
18