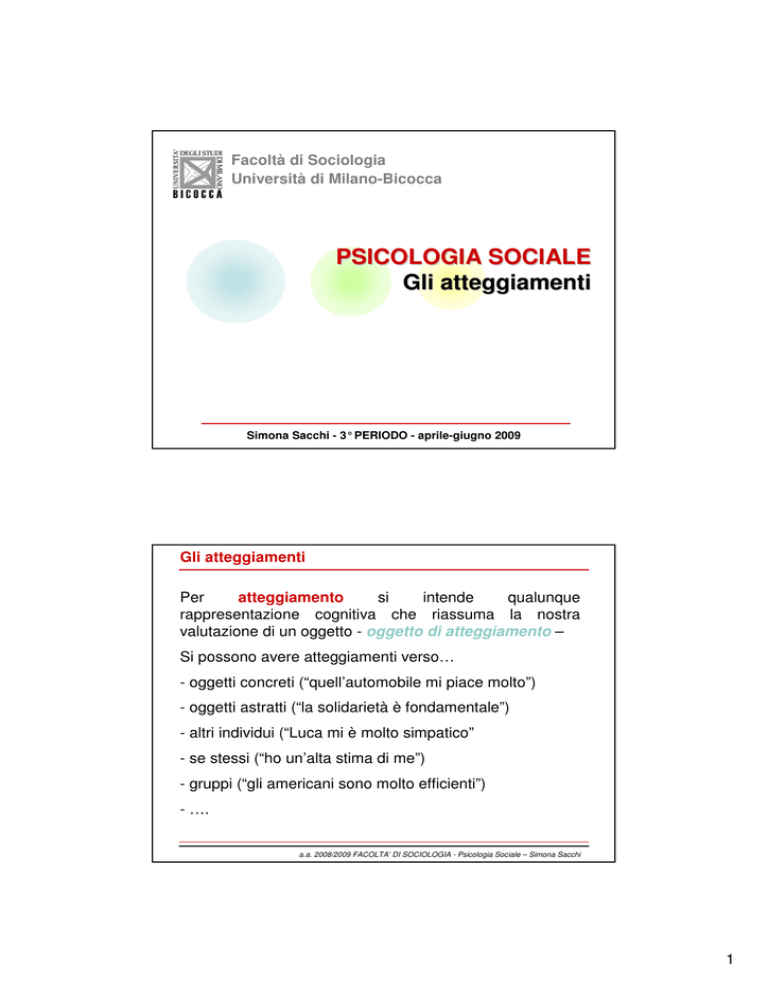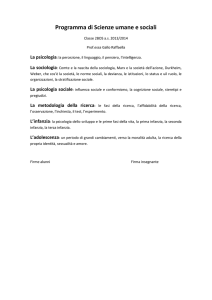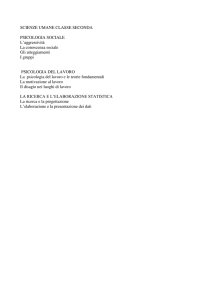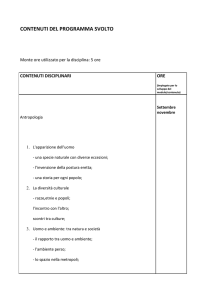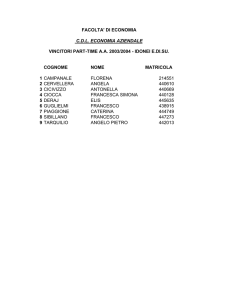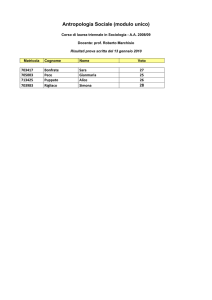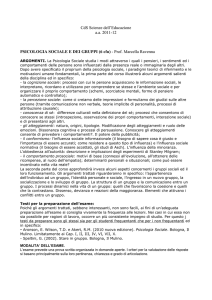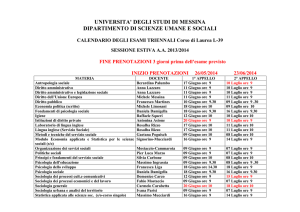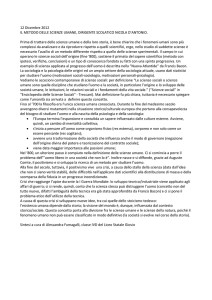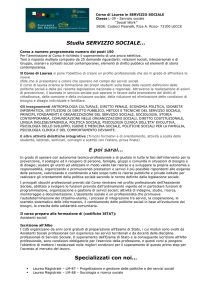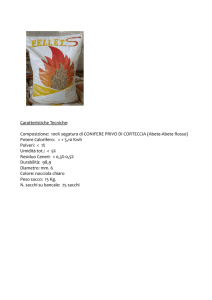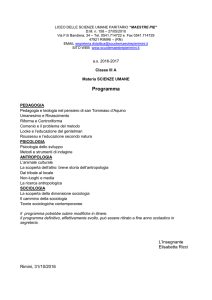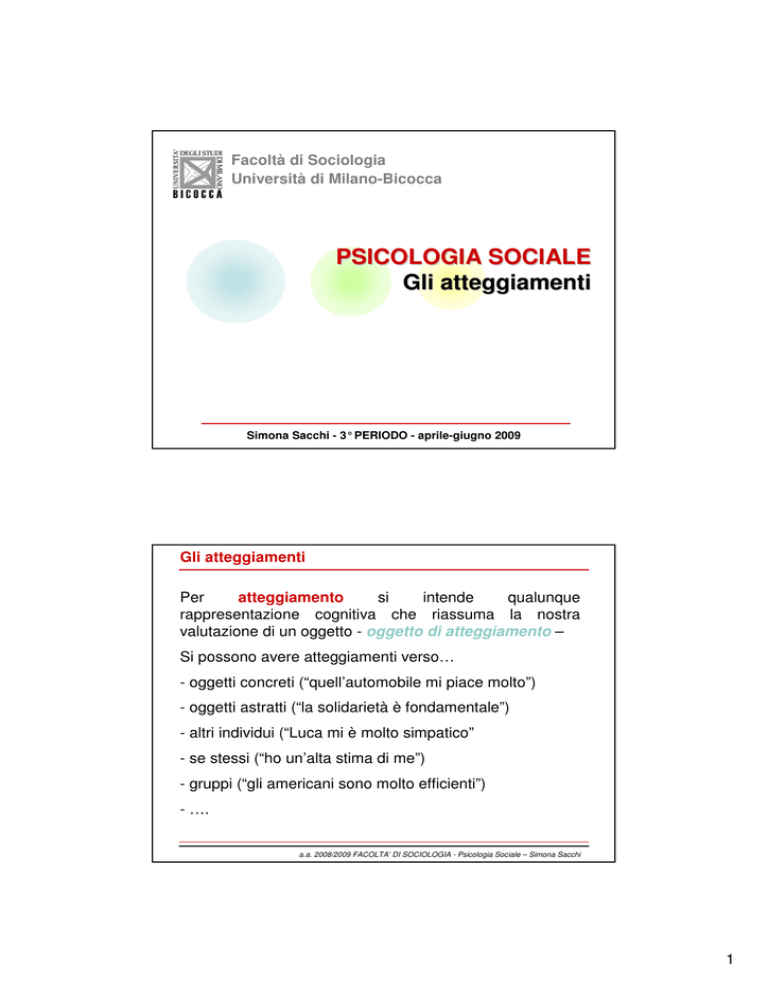
Facoltà di Sociologia
Università di Milano-Bicocca
PSICOLOGIA SOCIALE
Gli atteggiamenti
Simona Sacchi - 3°PERIODO - aprile-giugno 2009
Gli atteggiamenti
Per
atteggiamento
si
intende
qualunque
rappresentazione cognitiva che riassuma la nostra
valutazione di un oggetto - oggetto di atteggiamento –
Si possono avere atteggiamenti verso…
- oggetti concreti (“quell’automobile mi piace molto”)
- oggetti astratti (“la solidarietà è fondamentale”)
- altri individui (“Luca mi è molto simpatico”
- se stessi (“ho un’alta stima di me”)
- gruppi (“gli americani sono molto efficienti”)
- ….
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
1
Gli atteggiamenti
Gli atteggiamenti sono caratterizzati da
UNA DIREZIONE
L’atteggiamento verso l’oggetto può essere positivo,
neutro o negativo
UN’INTENSITÀ
L’atteggiamento può essere moderato o estremo
Direzione e intensità possono essere
• misurate tramite scale di misurazione di atteggiamenti
• inferite tramite osservazione del comportamento
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La funzione degli atteggiamenti
Gli atteggiamenti ci sono molto utili e svolgono per noi
diverse funzioni.
A- funzione conoscitiva – l’atteggiamento organizza e
semplifica la nostra esperienza; ci mette in condizione di
padroneggiare l’ambiente e trattare i suoi oggetti in modo
efficiente;
B- funzione strumentale – l’atteggiamento ci indirizza
verso gli oggetti che ci aiuteranno a massimizzare le
nostre ricompense e a minimizzare le perdite;
C- funzione di espressione – gli atteggiamenti ci
permettono di esprimere la nostra identità, i nostri valori,
la nostra visione del mondo; definiscono ‘chi siamo’
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
2
La funzione degli atteggiamenti
IL MODELLO TRIPARTITO (Rosenberg e Hovland, 1960)
ATTEGGIAMENTO
COGNITIVA
ciò che si sa
AFFETTIVA
ciò che si prova
COMPORTAMENTALE
ciò che si fa
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La funzione degli atteggiamenti
COMPONENTE COGNITIVA: ciò che si sa di un oggetto di
atteggiamento, l’insieme di convinzioni
Es. sono contraria al fumo perché conosco l’alto tasso di tumori ai polmoni
tra fumatori
COMPONENTE AFFETTIVA: ciò che si prova per l’oggetto,
i sentimenti, le emozioni suscitate
Es. viaggio in treno perché ho paura dell’aereo
COMPONENTE COMPORTAMENTALE: conoscenze circa
le interazioni passate, presenti e future con l’oggetto
Es. sono a favore delle donazioni perché, ogni anno, faccio un versamento
a un’associazione
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
3
La formazione degli atteggiamenti
Atteggiamenti a base cognitiva
• Sono finalizzati a valutare un oggetto
• Forniscono una valutazione razionale per orientare
le scelte
• Sono sensibili all’argomentazione e alle informazioni
esterne
Atteggiamenti a base emotiva
• Sono finalizzati a valutare la piacevolezza immediata
dell’oggetto
• Intervento di valori e ideologie
• Poco sensibili all’argomentazione razionale
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La formazione degli atteggiamenti
Atteggiamenti a base comportamentale
• Nascono o si modificano per auto-percezione (Bem,
1972)
• Sono utili quando l’atteggiamento è inizialmente
assente o debole
• Servono a ridurre la dissonanza cognitiva provocata
dal comportamento
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
4
La formazione degli atteggiamenti
Esperienza diretta
• ricordo di precedenti esperienze con l’oggetto
• la ripetizione dell’esperienza
l’attivazione dell’atteggiamento
rende
automatica
• è la fonte degli atteggiamenti più forti
Osservazione dell’esperienza altrui
• forma mediata di esperienza diretta
• legame meno forte
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La formazione degli atteggiamenti
Comunicazione
• raccolta di informazioni (racconti, letture, massmedia…)
• legame debole
Formazione on-line (sul momento)
• quando non disponiamo di esperienze precedenti, o
queste non sono accessibili
• molto instabili
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
5
La formazione degli atteggiamenti
Unione e armonizzazione delle informazioni utili alla
formazione dell’atteggiamento
soppesiamo tutte le informazioni sulla base della loro
rilevanza e le combiniamo algebricamente
(Anderson, 1981)
configuriamo le informazioni in un’unità dotata di
significato e lasciamo che ogni singola informazione
influenzi le altre
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La formazione degli atteggiamenti
Non tutte le informazioni contribuiscono in ugual modo
alla formazione di un atteggiamento
• Visione unilaterale – le informazioni sono
squilibrate; l’ambiente generalmente favorisce
l’accesso a informazioni che vanno in un’unica
direzione
• Accessibilità – sono le informazioni accessibili a
plasmare i nostri atteggiamenti; ruolo dell’attenzione,
della disponibilità in memoria, della salienza
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
6
Atteggiamenti e oggetto
Quanto più pensiamo al nostro atteggiamento verso
l’oggetto, tanto più saldo diventa il legame tra oggetto e
atteggiamento.
- Il legame tra oggetto e atteggiamento diventa
automatico
Es. ragno animale disgustoso
- L’atteggiamento sostituirà con maggiore probabilità
le nostre conoscenze
- L’atteggiamento
diventa
all’influenza
esterna
e
persuasiva
meno
vulnerabile
alla
comunicazione
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
la persuasione e
il cambiamento di atteggiamento
7
La persuasione
CONVINCERE:
PERSUADERE:
adesione razionale
adesione emotiva
valutazione cognitiva
integrazione aspetti
cognitivi ed emotivi
oggettività
informazione e dati di
ancoraggio plausibili
scarso effetto a livello di
comportamento
soggettività
contenuti di ‘contorno’
effetto a livello di
comportamento
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione
informazione
cognitiva
convinzione
comunicazione
cognitiva
+
emotiva
persuasione
comportamentale
comportamento
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
8
La persuasione
MODELLO DI PROBABILITA’ DELL’ ELABORAZIONE
(Petty e Cacioppo, 1981,1986)
Il cambiamento di atteggiamento dipende dall’attivazione di
alte o basse risorse cognitive nell’elaborazione di informazioni
Sì
Comunicazione
persuasiva
Via centrale
Cambiamento
vero e duraturo
degli atteggiamenti
Motivazione?
Abilità?
No
Via periferica
Cambiamento
superficiale e
temporaneo
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione: via periferica
Via periferica
• il destinatario non elabora il contenuto del messaggio
• cambiamento basato su elementi che costituiscono il
contorno (es. l’attrattività e la credibilità della fonte, la
lunghezza e la piacevolezza del messaggio …)
• l’impatto del segnale periferico dovuto all’attivazione ed
all’applicazione di semplici regole od euristiche (es.,
“bisogna sempre fidarsi degli esperti”)
• minor sforzo cognitivo
• nessuna influenza qualità dell’argomentazione
Cambiamento superficiale, di breve durata, suscettibile a
successivi tentativi di persuasione e con minori ricadute a
livello comportamentale
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
9
La persuasione: via periferica
INFORMAZIONI AFFETTIVE
Effetto atmosfera
Se l’ambiente in cui viene trasmesso il messaggio è
gradevole per il destinatario (musica, profumi, emozioni…),
questa impressione piacevole può essere trasferita al
messaggio stesso per condizionamento
Condizionamento: uno stimolo (es. oggetto pubblicizzato)
inizialmente neutro diventa capace di suscitare una
risposta positiva o negativa per essere stato associato con
qualcosa che solitamente suscita una risposta positiva o
negativa (una bella donna, un bambino, una festa).
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione: via periferica
QUALE MACCHINA TI PIACE DI PIÙ?
10
La persuasione: via periferica
L’ATTRATTIVA DELLA FONTE
Effetti sui processi di persuasione dovuti ad un’attrazione
esercitata dalla fonte sul destinatario. Persuasione di
ordine affettivo e generalmente espressa con una reazione
emotiva e con un giudizio di valore.
Effetti positivi di:
• piacevolezza (bellezza, apparenza fisica, cura, simpatia…)
• familiarità
• similarità (somiglianza tra fonte e destinatario per età, genere,
professione, opinioni…)
Effetto su processi di identificazione
Importanza presenza della fonte
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione: via periferica
LA COMPETENZA DELLA FONTE
È importante che la fonte sia competente nel campo a cui
fa riferimento il messaggio.
…ma funziona anche in
generalizzata - effetto alone)
altri
campi
(competenza
esp. Montmollin et al. (1982)
messaggio sui pericoli dell’abuso di aspirina
manipolazione fonte: medico vs. avvocato
stesso effetto persuasivo sull’opinione dei soggetti
effetto competenza generalizzata = prestigio della fonte
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
11
La persuasione: via periferica
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione: via periferica
LA FIDUCIA
Il ricevente accorda la propria fiducia solo se la sorgente
sembra obiettiva, disinteressata, senza intenzione di
manipolare o ingannare.
LIMITI ALLA SINCERITÀ:
distorsione del sapere: assunto che l’oratore conosca
meglio uno solo degli aspetti del problema e che si esprima
a favore di quell’aspetto
distorsione di rapporto: ci si attende che l’oratore esprima
opinioni sulla base del pubblico a cui si rivolge
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
12
La persuasione: via periferica
Esp. Eagly, Wood, Chaiken (1978)
discorso politico di un candidato su problema ecologico di
inquinamento industriale: bisogna chiudere immediatamente la
fabbrica?
Procedura
informazioni sull’oratore
(sostenitore causa ecologista vs. difensore interessi lavoratori)
informazioni sull’audience
(discorso a gruppo ecologisti vs. industriali)
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione: via periferica
Risultati
5
CAMBIAMENTO
ATTEGGIAMENTO
4,5
4
3,5
ORATORE
3
pro-ecologia
2,5
pro-lavoratori
2
1,5
1
0,5
0
ecologisti
industriali
PUBBLICO
Il cambiamento è massimo quando vengono disattese le
aspettative di ‘distorsione del sapere’ e ‘distorsione del
rapporto’
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
13
La persuasione: via periferica
L’EURISTICA DELLA FAMILIARITÀ
Effetto di mera esposizione: le persone preferiscono gli
oggetti familiari e a cui sono stati esposti più volte
Familiarità – connotazione positiva
Esp Zajonc (1968): esposizione a parole straniere come dilikli,
saracik le persone preferiscono parole a cui sono state già
esposte
Sentimenti positivi
conosciamo
e
rassicuranti
verso
ciò
che
Persuasione maggiore tramite ripetizione del messaggio
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione: via periferica
IL RUOLO DELLE EMOZIONI
Valutazione dell’oggetto di atteggiamento
emozioni e sentimenti
“se sono contenta vuol dire che mi piace”
tramite
Tutto ciò che viene valutato quando siamo di buon
umore risulta più positivo e piacevole di ciò che viene
valutato quando siamo di cattivo umore
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
14
La persuasione: via periferica
LA LUNGHEZZA DEL MESSAGGIO
Più il messaggio è lungo più sembra valido
Comunicazione puntigliosa
Fila per le fotocopie
‘posso passarle davanti che ho solo 5 copie?’ 60% si
‘posso passarle davanti che ho solo 5 copie e sono in ritardo?’ 94% si
‘posso passarle davanti che devo fare delle fotocopie?’ 93% si
“Più è caro migliore è”
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione
Via centrale
• il destinatario
messaggio
elabora
attivamente
il
contenuto
del
• attenta e consapevole ricognizione delle argomentazioni e
delle informazioni del messaggio
• generazione di argomentazioni o contro-argomentazioni
• argomenti convincenti pensieri positivi cambiamento
atteggiamenti
• argomenti deboli pensieri negativi messaggio non
efficace o controproducente (effetto “boomerang”)
• scarsa influenza di elementi contestuali, di contorno
Cambiamento profondo, duraturo, relativamente resistente a
successive modificazioni e, in generale, buon predittore del
comportamento futuro.
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
15
La persuasione: via centrale
ATTENZIONE AL MESSAGGIO
COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO
REAZIONE AL MESSAGGIO/ELABORAZIONE
ACCETTAZIONE
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione: quale via?
Il ruolo della motivazione
• Accuratezza
motivazione alla padronanza e all’accuratezza;
attenzione all’integrazione di tutte le nuove
informazione;
elaborazione di dati incongruenti
• Rilevanza personale
elaborazione profonda su oggetti di atteggiamenti che
ci riguardano personalmente
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
16
La persuasione: quale via?
Il ruolo delle capacità
• di elaborazione
Difficoltà a comprendere informazioni complesse
Argomentazioni forti e deboli hanno lo stesso effetto
se il destinatario non riesce a comprenderle
• di concentrazione
Ruolo dell’attenzione
La scarsa attenzione rende deboli le argomentazioni
forti e forti le argomentazioni deboli
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione: quale via?
I fattori di personalità
• elevato bisogno di cognizione
Provo soddisfazione nel riflettere per ore e ore
Preferisco i problemi complessi a quelli semplici
L‘idea di pensare in modo astratto mi affascina
• focalizzazione sull’immagine vs. sui valori
Influenza di messaggi che puntano al miglioramento dell’immagine
Influenza di messaggi che puntano ai valori
….
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
17
La persuasione
Esp. Petty, Cacioppo, e Goldman (1981)
Studenti universitari ricevevano un messaggio a favore
dell’introduzione di un ulteriore esame (posizione contraria alle
opinioni)
Disegno: 2 x 2 x 2
fonte (alta vs. bassa) x messaggio (forte vs. debole) x rilevanza (alta
vs. bassa)
Ad un gruppo veniva detto che il progetto era stato elaborato da una
prestigiosa commissione (fonte ad alta credibilità), ad un altro che il
piano era di un gruppo di studenti (fonte a bassa credibilità).
A metà dei partecipanti era presentato un messaggio contenente
argomentazioni di alta qualità (messaggio forte) e all’altra uno
sostenuto da argomenti di bassa qualità (messaggio debole).
Per una metà, l’eventuale cambiamento li avrebbe direttamente
coinvolti (alta rilevanza), per l’altra metà la modifica si sarebbe
realizzata dopo anni (bassa rilevanza).
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione
Risultati
Condizione di alta rilevanza:
I soggetti analizzavano in profondità il contenuto del messaggio;
il loro atteggiamento era influenzato dalla forza delle
argomentazioni (attivazione via centrale).
Condizione di bassa rilevanza:
I soggetti non approfondivano l’analisi del testo e rimanevano
influenzati dal prestigio della fonte (attivazione via periferica).
…una fonte dotata di credibilità è in grado di rendere
convincente anche un messaggio debole, a condizione che chi
lo riceve sia scarsamente motivato e, quindi, non vagli con
attenzione le argomentazioni contenute.
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
18
La persuasione
Nel modello è implicita l’idea che i due percorsi siano
contrapposti, escludendosi reciprocamente.
In alcune circostanze, può
parallelo dei due processi
elaborazione simultanea sia
esperienza attribuita alla
dell’argomentazione.
verificarsi un funzionamento
(Eagly & Chaiken, 1993):
di indici periferici (ad es.
fonte), sia della qualità
Effetti additivi o interattivi.
Ad es.
In momenti di incertezza l’indice periferico può offrire un aiuto per
l’interpretazione del messaggio, anche a chi percorre la via centrale.
La credibilità della fonte possono indurre delle aspettative e influire
sull’elaborazione sistematica del messaggio.
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione e l’emozione
Importanza dell’integrazione di aspetti emotivi e aspetti cognitivi.
La comunicazione persuasiva ad alto contenuto emotivo:
• influenza il grado di favorevolezza verso il messaggio
• riduce la resistenza al cambiamento
• porta all’elaborazione del testo in modo olistico piuttosto che analitico
• produce risposte emotive piuttosto che razionali e cognitive
Importanza di emozioni negative sul cambiamento di atteggiamento (es.
pubblicità contro l’abuso infantile; appelli alla paura…).
Utilizzo di vari registri ed elementi comunicativi (musica, immagini,
scene emotive…).
Limita le informazioni che il destinatario riesce a elaborare (via
periferica, euristiche…).
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
19
La persuasione e l’emozione
PRIMA REAZIONE EMOTIVA
(inconsapevole, lascia nel soggetto un’impressione globale)
INTEGRAZIONE
(Associazione della prima reazione con l’oggetto/messaggio;
ad es. tramite condizionamento)
VALUTAZIONE
(rilevanza personale e grado di favorevolezza )
SECONDA REAZIONE EMOTIVA
(segue l’elaborazione cognitiva; emozione ragionata)
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione e l’emozione
1 – Appello all’Ethos
Insieme di argomenti che fanno riferimento o appello all’autorità di
un testo, di una legge religiosa o morale, di un’istituzione. Autorità
della tradizione.
2 - Appello al Logos
Insieme di argomenti che fanno appello alla ragione o alla logica:
le conclusioni sono necessariamente dedotte dalle premesse.
Utilizzo della logica formale.
Utilizzo di un ‘sillogismo debole’ nel campo delle opinioni e degli
atteggiamenti: si traggono conclusioni sulla base di credenze
iniziali assunte come fatti.
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
20
La persuasione e l’emozione
3 – Appello al Pathos
Insieme di argomenti che fanno appello alle emozioni e ai
sentimenti.
IL BUON UMORE
• I sentimenti positivi producono atteggiamenti positivi
“sono felice, quindi mi piace”
• Le persone di buonumore hanno meno probabilità di
elaborare sistematicamente il messaggio persuasivo per via
centrale
• Utilizzo di euristiche
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione e l’emozione
Il BUON UMORE
Agisce sulla motivazione
Le persone di buon umore sottostimano il pericolo e si sentono
sicure e fiduciose
Se si associa l’elaborazione sistematica a un miglioramento dello
stato d’animo, anche le persone di buon umore si impegneranno a
riflettere sul messaggio
Agisce sulle capacità cognitive
Le persone di buon umore fanno fatica a concentrarsi
Le persone di buon umore fanno fatica ad elaborare i messaggi
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
21
La persuasione e l’emozione
APPELLO ALLA PAURA
Nella giusta misura paura e ansia aiutano le persone a elaborare
il messaggio.
La relazione tra paura e persuasione non è lineare.
All’aumentare della paura e dell’ansia non sempre il messaggio
risulta più persuasivo
esp. Janis e Feshbach (1953) sull’igiene orale
Avvertimenti chiari sui pericoli di una scarsa igiene orale (carie, malattie
secondarie, artrite..)
messaggio forte meno efficace del messaggio debole
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione e l’emozione
La strega cattiva di Sanpatrignano
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
22
La persuasione e l’emozione
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione e l’emozione
APPELLO ALLA PAURA
efficacia messaggio
relazione non lineare tra paura e persuasione
paura
Livelli troppo bassi di ansia portano il soggetto ad ignorare il
messaggio
Livelli troppo alti di ansia portano ad un evitamento difensivo
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
23
La persuasione e l’emozione
Perchè?
Paura come Drive il pericolo descritto dal messaggio aumenta
la probabilità che il destinatario cerchi un mezzo per evitarlo. Se il
messaggio indica un mezzo, il destinatario tende ad accettarlo.
Paura come Cue il pericolo è uno stimolo interno spiacevole
per l’individuo che cerca di farlo cessare evitando stimoli esterni
che l’hanno prodotto (fonte, messaggio, mezzo, problema
descritto...)
Quindi:
Messaggi troppo deboli non risvegliano il drive; messaggi forti
provocano rigetto ed evitamento perchè funzionano da cues.
C’è un grado ottimale di ‘appello alla paura’
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione e l’emozione
Effetti diversi su variabili diverse:
sull’ opinione: paura forte > paura debole
sul comportamento: paura debole > paura forte
Rilevanza:
L’appello alla paura è efficace se le persone pensano che le
conseguenze negative possano accadere a loro (rilevanza
personale)
Modalità:
Rimedio indicato: paura forte > paura debole
Nessun rimedio indicato: paura debole > paura forte
Fonte:
Fonte credibile: appello alla paura più efficace
Destinatario:
Destinatario poco ansioso: appello alla paura più efficace
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
24
L’immunizzazione
Quando l’individuo sa che sta per ricevere un messaggio
persuasivo aumenta la resistenza al messaggio.
L’avvertimento aumenta la capacità di controargomentare
• c’è una mobilitazione e un’attività cognitiva anticipatrice
Alcuni soggetti non cambiano quando avvertiti perchè hanno
già cambiato prima
• bisogno di approvazione
Alcuni soggetti cambiano quando avvertiti
• elasticità e apertura mentale
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
L’immunizzazione
Quando l’individuo sa che sta per ricevere un messaggio
persuasivo aumenta la resistenza al messaggio.
L’avvertimento aumenta la capacità di controargomentare
• c’è una mobilitazione e un’attività cognitiva anticipatrice
Alcuni soggetti non cambiano quando avvertiti perchè hanno
già cambiato prima
• bisogno di approvazione
Alcuni soggetti cambiano quando avvertiti
• elasticità e apertura mentale
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
25
L’immunizzazione
Principio di vaccinazione:
bisogna sottoporre gli individui a una moderata minaccia contro le
proprie credenze per renderli capaci di resistere a forti attacchi nel
futuro (McGuire, 1961; 1964)
Esp. truismi culturali (credenze che non vengono mai contestate)
Confronto 3 gruppi: immunizzazione di supporto (argomenti in favore
dei truismi); immunizzazione di difesa (argomenti contro i truismi);
controllo (nessuna argomentazione)
Solo con ‘immunizzazione di difesa’ individui resistono meglio a un
successivo attacco esterno contro i truismi.
Nessuna differenza tra ‘immunizzazione di supporto’ e ‘nessuna
immunizzazione’.
Immunizzazione aumenterebbe la capacità di controargomentare.
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
L’immunizzazione
Esperimenti di immunizzazione, ad es., con:
• ragazzi adolescenti per vaccinarli contro il vizio del fumo e
contro le pressioni sociali a iniziare a fumare
• bambini - per vaccinarli contro l’efficacia degli slogan
pubblicitari
• adulti - per vaccinarli contro l’effetto di campagne politiche
diffamatorie
• con consumatori - per migliorare l’efficacia del messaggio
pubblicitario
• …
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
26
La persuasione subliminale
Tecniche subliminali:
sistemi usati per trasmettere un messaggio tramite
immagini o suoni molto brevi o nascosti che l’individuo non
è in grado di percepire in modo consapevole.
Es. “bevi Coca-Cola” incremento vendita (1957)
I METODI SUBLIMINALI HANNO EFFETTO?
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione subliminale
effetto priming
esp. Murphy e Zajonc (1993)
valutazione gradevolezza di ideogrammi
presentazione di un volto (allegro vs. arrabbiato) in
modo subliminale
presentazione ideogramma da valutare
Risultati:
valutazione più positiva di ideogramma preceduto da
volto allegro.
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
27
La persuasione subliminale
Esp. Greenwald (1991)
Ametà del campione ascolta audiocassette per la memoria
metà del campione ascolta audiocassette per l’autostima
Risultati: nessun effetto su memoria o autostima dei partecipanti
Bmetà del campione che ascolta audiocassette per la memoria pensa di
ascoltare audiocassette per l’autostima
metà del campione che ascolta audiocassette per l’autostima pensa di
ascoltare audiocassette per la memoria.
Risultati: aumento del fattore nominato non di quello manipolato.
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
La persuasione subliminale
Non ci sono prove di effetti potenti di tecniche subliminali:
• i risultati non sono stati replicati e non si sono rivelati
affidabili;
• gli effetti subliminali si producono con una gamma ristretta
di stimoli (semplici);
• riguardano bassi livelli di elaborazione;
• eventuali effetti vengono eliminati dall’elaborazione conscia
• effetti più deboli di quelli ottenuti con tecniche sopraliminali;
• gli effetti subliminali si producono in laboratorio ma
difficilemente nel contesto reale;
• gli effetti subliminali non attivano comportamenti contrari ai
propri valori, desideri, personalità.
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
28
Gli atteggiamenti e
il comportamento
Atteggiamenti e comportamento
Gli atteggiamenti influenzano le azioni
ATTEGGIAMENTO
AZIONE
positivo
avvicinamento
negativo
evitamento
Le azioni influenzano gli atteggiamenti
AZIONE
ATTEGGIAMENTO
avvicinamento
positivo
evitamento
negativo
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
29
Azioni Atteggiamenti
Le nostre azione e i nostri ruoli generano atteggiamenti.
Lieberman (1956) - osservazione sull’evoluzione della carriera
di operai
Operai promossi caposquadra consonanza atteggiamento
dirigenti
Operai promossi cariche sindacali posizioni più intransigenti
studenti coinvolti in giochi di ruolo atteggiamenti coerenti
con il ruolo assunto
troviamo simpatiche le persone che aiutiamo e antipatiche
quelle che trattiamo male
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
Azioni Atteggiamenti
ELABORAZIONE SUPERFICIALE
Quando si elabora in modo superficiale, si basano gli
atteggiamenti su associazioni con azioni.
A livello superficiale anche azioni prive di sensi e movimenti
muscolari possono influenzare l’atteggiamento
piace ciò che viene associato al sorridere, all’annuire, al trarre
a sé
non piace ciò che viene associato al corrucciamento, al
diniego e a movimenti di distanziamento
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
30
Azioni Atteggiamenti
Priester, Cacioppo e Petty (1996)
Presentazione di parole senza senso begrid, plicen, triwen…
Compito: valutare il livello di piacevolezza delle parole mentre si tirava verso
di sé o si allontanava da sé una barra di metallo
Risultati: le parole presentate mentre si tirava la barra vennero giudicate più
piacevoli delle parole presentate mentre si spingeva la barra
Interpretazione:
Tirare la barra verso a sé comportamento di avvicinamento
Spingere la barra lontano da sé comportamento di evitamento
Dal comportamento inferisco l’atteggiamento
avvicinamento atteggiamento positivo
allontanamento atteggiamento negativo
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
Azioni Atteggiamenti
Wells e Petty (1980)
Emissione di un messaggio in cuffia durante un esercizio
Compito:
simulare la corsa attraverso i gesti dell’annuire
simulare la pedalata in bicicletta attraverso lo scuotere della testa
Risultati: maggiore accettazione del messaggio durante la corsa che
durante la pedalata
Interpretazione:
Dal comportamento inferisco l’atteggiamento
gesti dell’annuire atteggiamento positivo
gesti del diniego atteggiamento negativo
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
31
Azioni Atteggiamenti
TEORIA DELL’AUTOPERCEZIONE (Bem, 1972)
Quando si è consapevoli delle proprie azioni, si possono fare
inferenze dirette dall’azione all’atteggiamento
Il soggetto ha un vertice auto-osservativo
Gli atteggiamenti vengono inferiti dall’osservazione dei propri
comportamenti e delle situazioni in cui vengono messi in atto
Valutazione dei fattori situazionali
Es. valutazione del proprio livello di religiosità dopo aver pensato alla
frequenza di pratiche religiose (Salancik, & Conway, 1975)
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
Azioni Atteggiamenti
Le associazioni superficiali tra azioni e atteggiamenti funzionano solo
su materiale non rilevante per le persone
annuire aumenta la piacevolezza di parole senza senso ma non di
materiale significativo
I meccanismi di autopercezione
atteggiamenti rilevanti
non
entrano
in
gioco
su
Le associazioni superficiali tra azioni e atteggiamenti funzionano solo
se non ci sono conseguenze concrete per le persone
Es. donne che dovevano giudicare delle foto di uomini dopo feed-back
sul loro battito cardiaco. Il feed-back funziona solo se non pensano di
dover uscire veramente con quegli uomini
Le associazioni superficiali tra azioni e atteggiamenti funzionano solo
se l’elaborazione non può essere più profonda o se non abbiamo
altre informazioni disponibili
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
32
LA DISSONANZA COGNITIVA
Psicologia cognitivista (Anni ’50 - ’60)
Individuo come ricercatore di coerenza
Lo stato di incoerenza fra credenze o sentimenti è di per
sé motivante al ripristino della coerenza tramite
cambiamento dell’atteggiamento
Modelli della coerenza cognitiva di Festinger (1957) e
Heider (1958)
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
LA DISSONANZA COGNITIVA
Leon Festinger (1957)
Le persone sono motivate al mantenimento e alla ricerca
della coerenza fra le proprie conoscenze, opinioni,
credenze e i propri comportamenti.
L’eventuale incoerenza fra ciò che si pensa e ciò che si fa
crea uno stato di disagio che deve essere in qualche
modo eliminato.
Questo stato di tensione è detto dissonanza cognitiva.
Per eliminarlo occorre modificare
comportamento o l’opinione dissonante.
o
il
proprio
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
33
LA DISSONANZA COGNITIVA
Comportamento: “io fumo”
Credenza: “il fumo nuoce alla salute”
DISSONANZA
RIDUZIONE DELLA
DISSONANZA
“il fumo non fa poi così male”
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
LA DISSONANZA COGNITIVA
La dissonanza si articola in 4 fasi
1- LA PERCEZIONE DELL’INCOERENZA
L’individuo deve rendersi conto dell’incoerenza tra i propri
atteggiamenti e le proprie azioni.
La dissonanza si manifesta quando il comportamento ha effetti
evidenti
La dissonanza si manifesta quando il comportamento ha effetti
negativi
2- L’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
L’individuo deve fare attribuzione interna
Se il comportamento è percepito come causato da forti pressioni
esterne (premi irresistibili o temibili punizioni), l’individuo non
prova dissonanza
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
34
LA DISSONANZA COGNITIVA
3- L’ATTIVAZIONE FISIOLOGICA
La dissonanza cognitiva viene esperita come uno stato
spiacevole di attivazione fisiologica
esp. con monitoraggio fisiologico su partecipanti indotti a scrivere
un saggio contrario vs. in linea alle loro opinioni
4- ATTRIBUZIONE
L’individuo non solo deve esperire uno stato spiacevole di
attivazione ma deve anche attribuire tale stato al
comportamento.
Se il disagio viene attribuito ad altri fattori (esterni), la
dissonanza non si verifica e non porta a cambiamenti del
comportamento.
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
LA DISSONANZA COGNITIVA
Un dollaro per una menzogna
Procedura
Somministrazione di un esperimento noiosissimo
Richiesta di aiuto al partecipante per convincere altri studenti a
sottoporsi all’esperimento parlando positivamente del compito
Disegno sperimentale
Gruppo1: ricevono la ricompensa di 1 $ per mentire
Gruppo 2: ricevono la ricompensa di 20 $ per mentire
Gruppo controllo: non devono mentire
Variabile dipendente
Giudizio sulla gradevolezza dell’esperimento
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
35
LA DISSONANZA COGNITIVA
14
gradevolezza
esperimento
12
10
8
6
4
2
0
controllo
1$
20 $
Risultati
Chi aveva parlato bene dell’esperimento per un solo dollaro (scarsa
ricompensa) giudica l’esperimento più positivamente di chi mente per
20$ (ricompensa significativa)
Non si può attribuire il comportamento a fattori esterni dissonanza
cambiamento di atteggiamento
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
LA DISSONANZA COGNITIVA
“Ho sofferto per ottenerlo, quindi mi piace”
Si ama ciò per cui si soffre
Cambio di atteggiamento per giustificare la fatica e lo
sforzo
Esp Axson & Cooper (1985)
3 settimane di addestramento per riduzione del peso
Gruppo 1: compiti percettivi molto difficoltosi
Gruppo 2: compiti facili
Risultati: il gruppo 1 perde in media circa 4 Kg, il gruppo 2 pochi
Hg
“se ho fatto così fatica, perdere peso è importante per me!”
Effetti duraturi
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
36
LA DISSONANZA COGNITIVA
Giustificazione post-decisionale
Ogni volta che si prende una decisione e si compie una
scelta si rinuncia alle alternative
Rischio del rimpianto
Paradosso del “meno è meglio”
Nella
fase post-decisionale, si rafforzano gli
atteggiamenti positivi verso le proprie scelte e si
screditano le alternative
Es. si valuta molto meglio un prodotto dopo averlo
acquistato
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
LA DISSONANZA COGNITIVA
Lo sforzo di giustificare e risolvere l’incoerenza porta
l’individuo a prendere in considerazione argomentazioni
e contro-argomentazioni prima trascurate
L’elaborazione delle informazioni è più approfondita
Il nuovo atteggiamento, formatosi per ridurre la
dissonanza, è generalmente solido e immune da
successive modificazioni
Il cambiamento di atteggiamento è di lunga durata
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
37
LA DISSONANZA COGNITIVA
LE ALTERNATIVE
Non sempre la dissonanza cognitiva si risolve con un
cambiamento di atteggiamento
L’individuo può:
- minimizzare
l’incoerenza,
comportamento
banalizzando
il
- minimizzare l’incoerenza con giustificazioni ‘razionali’
- tentare un’attribuzione esterna
- ridurre lo stato di attivazione e disagio fisiologico
(alcol, droga…)
- riaffermare la propria identità positiva
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
LA DISSONANZA COGNITIVA
Rubo e rubare è sbagliato
DISSONANZA
Ho rubato solo una volta e una
cosetta di poco valore
MINIMIZZAZIONE
Sono costretta a rubare perché
guadagno troppo poco per
vivere dignitosamente
ATTRIBUZIONE
ESTERNA
Bevo alcolici perché sono a
disagio
ATTENUAZIONE
ATTIVAZIONE
Sono a disagio non perché
rubo ma perché temo che
qualcuno mi veda
ATTRIBUZIONE
DELL’ATTIVAZIONE A
CAUSE ESTERE
Anche se rubo sono una brava
persona e non farei del male a
nessuno
AUTOAFFERMAZIONE
Rubare non è sbagliato
Cambiamento di atteggiamento e
riduzione della dissonanza
38
Atteggiamenti Azioni
Sono gli atteggiamenti a guidare ciò che una persona farà
Gli atteggiamenti predicono il comportamento
atteggiamento positivo avvicinamento
atteggiamento negativo evitamento
Cambiare l’atteggiamento è un
comportamento del comportamento
passo
verso
il
Es. cambiare l’atteggiamento negativo verso gli extracomunitari può
ridurre comportamenti discriminatori
A volte ci sono
comportamento
incoerenze
tra
atteggiamento
e
“predico bene e razzolo male”
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
Atteggiamenti Azioni
In che modo gli atteggiamenti influenzano il comportamento?
A- PER VIA DIRETTA
Gli atteggiamenti guidano il comportamento in modo automatico
• focalizzando l’attenzione - restringono il campo di attenzione
delle persone orientandolo verso informazioni coerenti con
l’atteggiamento
• distorcendo la percezione - informazioni coerenti con
l’atteggiamento sono più salienti e ‘visibili’ di informazioni
incoerenti
• distorcendo l’interpretazione - i dati ambigui vengono interpretati
in modo coerente con l’atteggiamento; le informazioni incoerenti
vengono
svalutate;
le
informazioni
coerenti
vengono
sopravvalutate
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
39
Atteggiamenti Azioni
In che modo gli atteggiamenti influenzano il comportamento?
B- PER VIA INDIRETTA
Teoria dell’Azione Ragionata (Fishbein e Ajzen, 1975)
credenze
atteggiamenti
norme
intenzioni
comportamentali
L’atteggiamento influenza il comportamento
attraverso la mediazione dell’intenzione
Sono le intenzioni
comportamenti
che
traducono
gli
comportamenti
dell’individuo
atteggiamenti
in
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
Atteggiamenti Azioni
Valutazione della credenza
atteggiamenti
Forza della credenza
(la pasta contiene carboidrati)
intenzioni
Credenza della norma
(gli italiani mangiano pasta)
COMPORTAMENTO
(è importante mangiare
carboidrati)
norme
Motivazione verso la norma
(per essere un vero italiano devi
mangiare pasta)
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
40
Atteggiamenti Azioni
Teoria del comportamento pianificato (Ajzen, 1985)
aspettativa
x
valore
atteggiamenti
assunzione
x
motivazione
norme
intenzioni
comportamento
controllo del
comportamento
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
Atteggiamenti Azioni
atteggiamento
intenzione
monitoraggio
pianificazione
contiene informazioni comportamentali. Intenzioni
più specifiche (o su azioni da svolgersi in un futuro
prossimo) contengono informazioni
comportamentali più dettagliate rispetto a intenzioni
generali (o su azioni lontane nel futuro)
progettazione di tutte le fasi intermedie necessarie
allo svolgimento del comportamento e al
raggiungimento dell’obiettivo
traccia delle intenzioni non ancora portate
a buon fine; valutazione dell’efficacia del
comportamento
comportamento
il comportamento continua fino al raggiungimento
dell’obiettivo; se non si riesce a raggiungere i propri
scopi il comportamento viene modificato o
abbandonato
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
41
Atteggiamenti Azioni
Quando gli atteggiamenti influenzano l’azione?
gli atteggiamenti vengono resi accessibili in maniera
deliberata: se pensiamo ad un determinato atteggiamento
il suo influsso sul comportamento aumenterà
gli atteggiamenti vengono resi accessibili attraverso
l’autoconsapevolezza: se pensiamo a noi stessi in modo
consapevole è probabile che gli atteggiamenti centrali per
la nostra identità diventino salienti
gli atteggiamenti vengono resi accessibili in maniera
automatica: l’uso frequente di un atteggiamento lo rende
accessibile e influente
a.a. 2008/2009 FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - Psicologia Sociale – Simona Sacchi
42