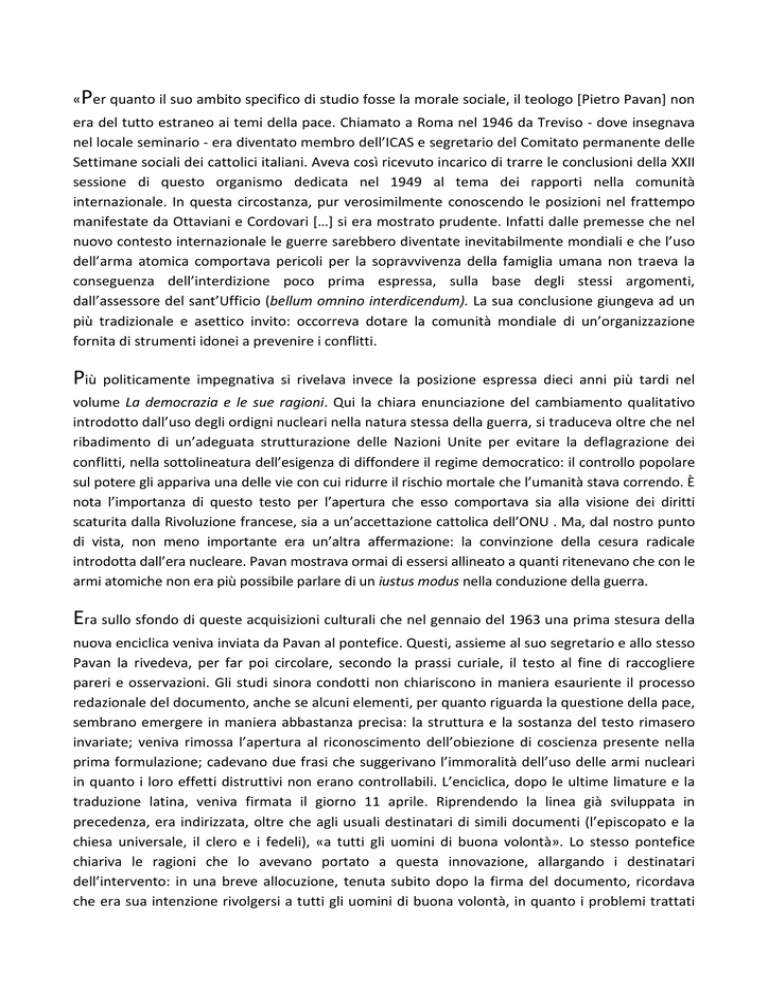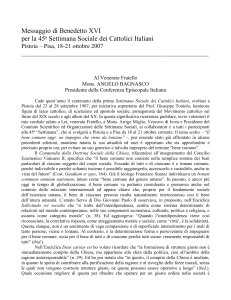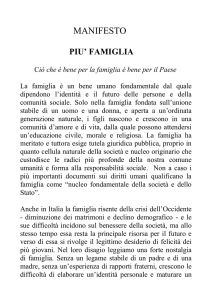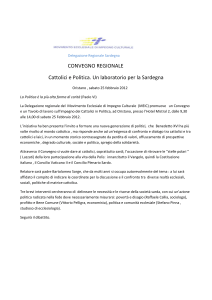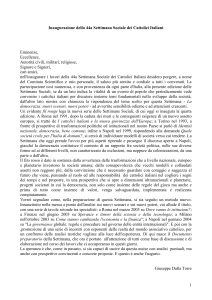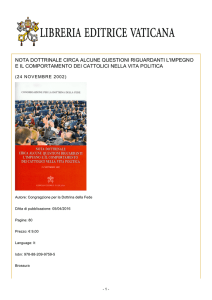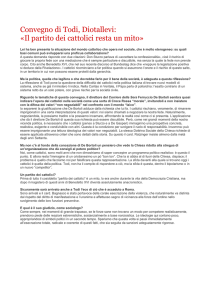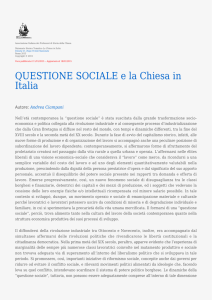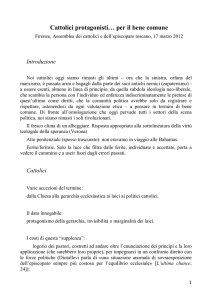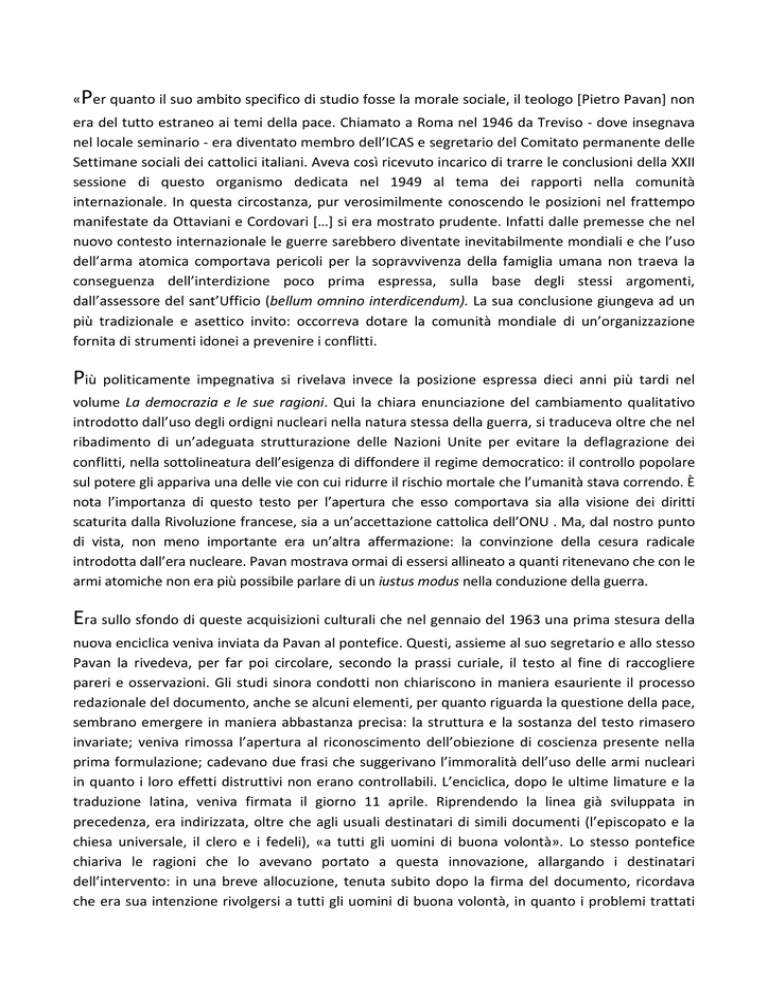
«Per quanto il suo ambito specifico di studio fosse la morale sociale, il teologo [Pietro Pavan] non
era del tutto estraneo ai temi della pace. Chiamato a Roma nel 1946 da Treviso - dove insegnava
nel locale seminario - era diventato membro dell’ICAS e segretario del Comitato permanente delle
Settimane sociali dei cattolici italiani. Aveva così ricevuto incarico di trarre le conclusioni della XXII
sessione di questo organismo dedicata nel 1949 al tema dei rapporti nella comunità
internazionale. In questa circostanza, pur verosimilmente conoscendo le posizioni nel frattempo
manifestate da Ottaviani e Cordovari […] si era mostrato prudente. Infatti dalle premesse che nel
nuovo contesto internazionale le guerre sarebbero diventate inevitabilmente mondiali e che l’uso
dell’arma atomica comportava pericoli per la sopravvivenza della famiglia umana non traeva la
conseguenza dell’interdizione poco prima espressa, sulla base degli stessi argomenti,
dall’assessore del sant’Ufficio (bellum omnino interdicendum). La sua conclusione giungeva ad un
più tradizionale e asettico invito: occorreva dotare la comunità mondiale di un’organizzazione
fornita di strumenti idonei a prevenire i conflitti.
Più politicamente impegnativa si rivelava invece la posizione espressa dieci anni più tardi nel
volume La democrazia e le sue ragioni. Qui la chiara enunciazione del cambiamento qualitativo
introdotto dall’uso degli ordigni nucleari nella natura stessa della guerra, si traduceva oltre che nel
ribadimento di un’adeguata strutturazione delle Nazioni Unite per evitare la deflagrazione dei
conflitti, nella sottolineatura dell’esigenza di diffondere il regime democratico: il controllo popolare
sul potere gli appariva una delle vie con cui ridurre il rischio mortale che l’umanità stava correndo. È
nota l’importanza di questo testo per l’apertura che esso comportava sia alla visione dei diritti
scaturita dalla Rivoluzione francese, sia a un’accettazione cattolica dell’ONU . Ma, dal nostro punto
di vista, non meno importante era un’altra affermazione: la convinzione della cesura radicale
introdotta dall’era nucleare. Pavan mostrava ormai di essersi allineato a quanti ritenevano che con le
armi atomiche non era più possibile parlare di un iustus modus nella conduzione della guerra.
Era sullo sfondo di queste acquisizioni culturali che nel gennaio del 1963 una prima stesura della
nuova enciclica veniva inviata da Pavan al pontefice. Questi, assieme al suo segretario e allo stesso
Pavan la rivedeva, per far poi circolare, secondo la prassi curiale, il testo al fine di raccogliere
pareri e osservazioni. Gli studi sinora condotti non chiariscono in maniera esauriente il processo
redazionale del documento, anche se alcuni elementi, per quanto riguarda la questione della pace,
sembrano emergere in maniera abbastanza precisa: la struttura e la sostanza del testo rimasero
invariate; veniva rimossa l’apertura al riconoscimento dell’obiezione di coscienza presente nella
prima formulazione; cadevano due frasi che suggerivano l’immoralità dell’uso delle armi nucleari
in quanto i loro effetti distruttivi non erano controllabili. L’enciclica, dopo le ultime limature e la
traduzione latina, veniva firmata il giorno 11 aprile. Riprendendo la linea già sviluppata in
precedenza, era indirizzata, oltre che agli usuali destinatari di simili documenti (l’episcopato e la
chiesa universale, il clero e i fedeli), «a tutti gli uomini di buona volontà». Lo stesso pontefice
chiariva le ragioni che lo avevano portato a questa innovazione, allargando i destinatari
dell’intervento: in una breve allocuzione, tenuta subito dopo la firma del documento, ricordava
che era sua intenzione rivolgersi a tutti gli uomini di buona volontà, in quanto i problemi trattati
riguardavano l’intera umanità. In tal modo Giovanni XXIII riprendeva quell’esile filo che da settori
della cultura cattolica degli anni Trenta ai firmatari dell’Appello di Stoccolma aveva legato la pace
alla buona volontà degli uomini? In mancanza di testimonianze precise sulla questione, basta
segnalare che il magistero assumeva ora, e dunque proponeva a livello della chiesa universale,
un’impostazione che in precedenza era rimasta confinata in ambiti minoritari. Non bisognava
tuttavia dimenticare che per Roncalli la questione della pace poteva essere risolta solo
ripristinando l’ordine voluto da Dio per il consorzio umano. Ma, accanto a questa eredità della
tradizione intransigente, asseriva anche che la sua concreta costruzione richiedeva l’apporto di
coloro che, pur non illuminati dalla fede, operavano sorretti dalla ragione e dall’onestà naturale.
Dunque la chiesa si rivolgeva anche a loro, per sollecitarne la collaborazione nella soluzione di un
problema che a tutti interessava.
E in effetti il testo faceva appello alla «ragione» come il dato comune di cui tutti gli uomini
potevano ricorrere per l’organizzazione della pace. Tuttavia si può registrare un’evidente
oscillazione linguistica. Il richiamo faceva ora riferimento al termine ratio ora all’espressione recta
ratio, reintroducendo così la primazia della ragione illuminata dalla fede. Per esempio a proposito
del disarmo si asseriva da un lato che tale obiettivo «è reclamato dalla retta ragione» e nella riga
successiva si proclamava che è «reclamato dalla ragione». Che non si trattasse di un’oscillazione
casuale lo dimostra il fatto che essa ritorna in uno dei passi cruciali della Pacem in terris, dove si
indicava, distinguendo tra errore ed errante e tra ideologie e movimenti politici e sociali e
culturali, che sui temi trattati dall’enciclica vi poteva essere un largo terreno di intese tra cattolici e
non cattolici. Da un lato infatti si precisava che proprio la «ragione» era il terreno comune di
incontro tra tutti gli uomini. Ma dall’altro lato si affidava alla «retta ragione» di cui erano
depositari i cattolici il compito di sceverare se le istanze dei non cattolici corrispondevano o meno
alle giuste aspirazioni della persona. […] Si ha come l’impressione di una remora a portare fio in
fondo quel cambiamento di cui pure si avvertivano chiaramente i termini. Da un lato emergeva la
consapevolezza di un passo da compiere: abbandonare la pedante dettatura dei criteri di
moralizzazione della guerra per immettere la chiesa all’interno della storia, facendole assumere
concretamente una funzione di costruzione della pace attraverso lo stimolo del dialogo tra uomini
pericolosamente schierati si posizioni contrapposte. Dall’altro sembra di avvertire un timore o una
riserva nel trattare le ovvie conseguenze di questo passo: tralasciare le rivendicazione di un
possesso esclusivo – grazie al controllo della Rivelazione – di una verità assoluta che si proponeva
come misura e criterio anche della vita politica internazionale».
Tratto da D. MENOZZI, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei
conflitti, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 266-269.