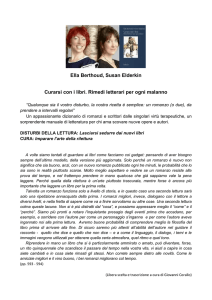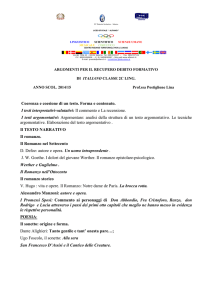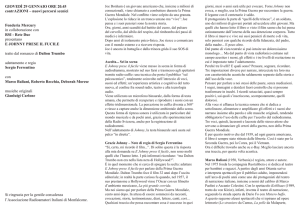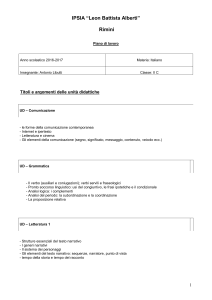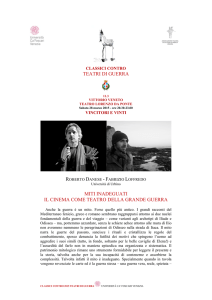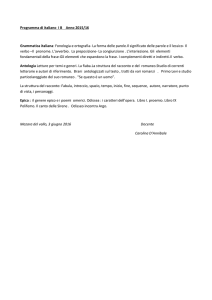caricato da
common.user21524
Eclissi di Trumbo: Maccartismo e Hollywood

POSTFAZIONE a “Eclissi” di Dalton Trumbo (DMG Edizioni, 2018) Mauricio Dupuis Trumbo nella tempesta degli albori del maccartismo Le deposizioni dell’ottobre 1947 davanti alla commissione del Congresso degli Stati Uniti, voluta dalla presidenza Truman, che indaga su presunte “attività antiamericane” (HUAC: House Un-American Activities Committee), portano a notorietà oltre la stretta cerchia degli addetti ai lavori lo scrittore quarantenne Dalton Trumbo, e con lui un gruppo di professionisti poco conosciuti al grande pubblico (diversi registi, molti sceneggiatori, oltre ad attori), ma fino ad allora parte integrante della creatività del cinema hollywoodiano. Di punto in bianco, col cambio di politica post-seconda guerra mondiale in cui l’Unione Sovietica, da alleato necessario nella vittoria contro il nazifascismo, torna ad essere il nemico pubblico numero uno, le istituzioni statunitensi si preparano a sferrare un attacco durissimo verso tutto quanto odori di progressismo. A partire dagli anni del New Deal rooseveltiano il Partito comunista americano trova aperture per radicarsi nella vita culturale, e l’alleanza coi sovietici ad un certo punto non fa che confermare la spinta di sinistra; nascono negli anni Trenta sindacati di categoria anche nel mondo dello spettacolo, che difendono i diritti delle varie maestranze, e uno dei gruppi più attivi è proprio quello degli sceneggiatori cinematografici. Tutto muta alla fine della guerra, quando l’FBI apre indagini molto più pressanti che portano all’istituzione di commissioni parlamentari sulla presunta infiltrazione progressista nei vari aspetti della vita americana. Non poche sono, in effetti, le spie sovietiche scovate in punti nevralgici delle strutture statali e corporative degli Stati Uniti. I segreti militari in special modo sono appetibili oltre cortina, e il timore degli americani che tali informazioni trapelino a vantaggio del nemico è obiettivamente fondato. Nata come doveroso controllo dopo il secondo conflitto mondiale, la situazione però sfugge di mano diventando fortemente manichea e senza reale utilità, colpendo nel mucchio anche personalità il cui ruolo viene sopravvalutato. Viene messa in discussione e poi punita la libertà di pensiero dei singoli interessati, fino a rovinare o limitare migliaia di carriere di successo o comunque molto promettenti. Sebbene il fenomeno passato alla storia come “maccartismo” 1 abbia toccato in minima parte l’industria di intrattenimento hollywoodiana, il fatto stesso che il cinema sia una forma espressiva di larga diffusione - capace quindi di arrivare a grandi masse di utenti - spinge le autorità a considerarlo pericoloso perché facile veicolo di messaggi considerati tendenziosi. La nuova censura va ad aggiungersi al più importante controllo creativo in atto già ai primordi della fase sonora, il cosiddetto ˝Codice Hays˝, coniato nel 1930 e usato concretamente tra 1933 e 1967. Il Production Code - questo il suo nome ufficiale - è un regolamento (auto) censorio che consiglia modalità di attuazione in fase di sceneggiatura e poi in regia in merito a comportamenti sociali, sfera intima e sessuale, relazioni extraconiugali, figli illegittimi e altri temi considerati sensibili. Un compromesso al ribasso, ma che le Case di produzione accettano apparentemente senza eccessive rimostranze. Sebbene il Codice non sia sanzionatorio, di fatto incanala la creatività del Dipartimento di scrittura verso una direzione in cui critica politica e sociale e tematiche cosiddette progressiste sono poste in secondo piano rispetto all’intrattenimento e al ritratto più edificante delle condotte sociali. Una visione prettamente ludica e disimpegnata, quindi. Ciò porta come conseguenza alla nascita, nelle Case di produzione, di un Dipartimento di scrittura simile a una batteria pre-addestrata e priva di autonomia creativa, a cui si aggiunge il fatto di essere sottopagata e con diritti sempre più limitati. Questo appiattimento del talento di scrittori capaci anche di scrivere romanzi e lavori teatrali genera molto malumore e vari casi di incomprensione. Diversi autori di primo piano, come Francis Scott Fitzgerald, che vedono nell’industria un modo di guadagnare ma anche di applicare il proprio talento in una forma d’arte di massa, sono ben presto allontanati perché poco adattabili al sistema. Restano i molti scrittori di mediocre levatura ma più consci delle modalità di lavoro, trattati come impiegati che si limitano a mettere su carta stereotipi forniti dalla produzione, con contratti a volte settimanali o a cottimo, senza garanzie per il futuro. Viene decisa, negli anni Trenta, la formazione di un sindacato, la Screen Writers Guild, l’associazione degli scrittori cinematografici (in parallelo si forma la meno progressista Screen Actors Guild), a cui lo stesso Trumbo si iscriverà già nei primi anni. La corporazione incontra da subito molti problemi coi produttori. In particolare Irving Thalberg (1899-1936), giovane capo della Metro-Goldwyn-Mayer, dichiara guerra a questa forma organizzata e decide di assoggettare gli sceneggiatori a contratti che fanno capo direttamente a lui, favorendo inoltre la nascita di un sindacato parallelo meno connotato da rivendicazioni progressiste. La crescente preminenza del sindacato sceneggiatori è una delle ragioni dello scontro che avverrà dopo la guerra, e che si tingerà di politica. Gli sceneggiatori in seguito presi di mira per le loro posizioni politiche sono tra l’altro accusati di aggirare il Code in modo surrettizio, per promuovere le idee politiche del partito comunista o anche solo genericamente di sinistra. Tra i “testimoni ostili” della commissione congressuale in quell’ottobre 1947 c’è, come detto, Dalton Trumbo. Insieme ad altri nove colleghi (in tutto otto scrittori, un regista - Edward Dmytryk - e un produttoresceneggiatore - Adrian Scott) verrà messo sotto accusa, processato e in seguito arrestato per non aver risposto in modo corretto - dal punto di vista della commissione - alle domande sulla sua affiliazione alla SWG e al Partito comunista americano (CPUSA); non solo Trumbo evita di rispondere, ma anzi contrattacca con grinta. Quando il presidente del Committee, John Parnell Thomas, gli rivolge la canonica domanda sull’affiliazione al sindacato sceneggiatori, Trumbo risponde: «Mi pare evidente che una domanda di questo tipo miri a identificarmi con il Sindacato sceneggiatori, per poi identificarmi con il Partito comunista americano, così che si possa distruggere il sindacato […] A mio avviso questa domanda ha un doppio fine […] che è quello di stabilire un legame tra il Sindacato e il Partito comunista americano. […] I diritti dei lavoratori all’inviolabilità dell’affiliazione ai sindacati sono stati conquistati a prezzo di sangue e con un grande costo in termini di fame. La Sua domanda costringerebbe ogni lavoratore americano vicino a un sindacato a identificarsi qui come tale, e a essere soggetto a future intimidazioni. Per questi motivi la domanda è a mio avviso incostituzionale. […] Credo di avere il diritto di sapere quali sono le prove che giustificano una simile domanda».2 E, a proposito di prove, Trumbo richiama alcuni dei suoi lavori all’attenzione della Commissione, esprimendosi come segue: «Presidente, ho portato qui con me le versioni integrali di una ventina di miei lavori sceneggiati a Hollywood negli ultimi anni. Sono a vostra disposizione in modo che possiate indicarmi i punti sovversivi che vi avrei inserito. [Sono lunghi] in media dalle 115 alle 160 o 170 pagine». Il presidente Thomas risponde con l’incredibile: «Troppe pagine, non le vaglieremo».3 Frase che non merita ulteriori commenti, se non quello di conclamare un chiaro partito preso da parte dell’istituzione congressuale, che evidentemente non è stata creata per indagare in modo oggettivo ma semplicemente per colpire alcuni bersagli che sarebbero serviti da esempio per gli altri. E lo scopo, se si pensa ai successivi decenni di guerra fredda, sarà pienamente raggiunto. Gli Hollywood Ten (i “dieci di Hollywood”) sono quindi gli irriducibili che al momento delle deposizioni non compiono delazioni su colleghi, conoscenti o addirittura amici. Si tratta, oltre a Trumbo, degli sceneggiatori John Howard Lawson, Lester Cole, Herbert Biberman, Ring Lardner jr, Alvah Bessie, Albert Maltz, Samuel Ornitz, del produttore e sceneggiatore Adrian Scott e del regista Edward Dmytryk. Solamente per mettere in luce la svolta a 180° su questi - e molti altri - professionisti, si può accennare che negli anni immediatamente precedenti molti di loro avevano ottenuto pubblici riconoscimenti per lavori in seguito considerati “sovversivi”. Ring Lardner jr vince l’Oscar nel 1943 per Woman of the Year (La donna del giorno; regia di George Stevens, con Spencer Tracy e Katharine Hepburn. Lardner vincerà, dopo la fine della “caccia alle streghe”, un ulteriore premio per M.A.S.H. di Robert Altman). Albert Maltz ottiene la candidatura per Pride of the Marines (1945, C’è sempre un domani; regia di Delmer Daves) e verrà premiato - sotto falso nome - nel 1951 col Writers Guild Award per Broken Arrow (ancora regia di Daves). Alvah Bessie scrive Objective: Burma! (1945, Obiettivo Burma; regia di Raoul Walsh), opera alla quale collabora anche Lester Cole. John Howard Lawson è alle prese invece su Blockade (1938, Marco il ribelle; regia di William Dieterle). Edward Dmytryk ottiene la candidatura all’Oscar per la regia di Crossfire(1947, Odio implacabile, prodotto da Adrian Scott per la RKO) che ha in totale cinque nomination nelle categorie più importanti (film, regia, sceneggiatura e attori protagonisti) proprio in concomitanza con la messa in stato d’accusa durante le audizioni congressuali. Trumbo, infine, è candidato per Kitty Foyle (1940) di Sam Wood. Si vede quindi che, a livello di riconoscimenti, per tacere della qualità di diverse pellicole (anche rispetto al riscontro al botteghino) alle quali i Dieci prendono parte, questi uomini sono parte integrante del sistema; e fino alla svolta politica anti-sovietica Usa sotto la presidenza Truman, dopo l’alleanza in chiave anti-nazista con l’Urss (la conferenza di Yalta è del febbraio 1945, appena due anni prima) a livello ufficiale non ci si preoccupa affatto della formazione, l’adesione sindacale o il pensiero politico dei professionisti operanti nel cinema. I Dieci diventano un simbolo della libertà di espressione e del diritto alla libera associazione dei cittadini (diritti sanciti dal Primo emendamento alla Costituzione americana, qui però non tenuto in debito conto), ma sono comunque rinviati a giudizio, condannati nel 1948 a un anno di reclusione e, dopo aver tentato un inutile ricorso in appello, effettivamente condotti in prigione. Trumbo è assegnato alla casa correzionale di Ashland, nel Kentucky, dove tra il 1950 e il 1951 sconta dieci mesi dei dodici previsti, due dei quali infatti saranno condonati per buona condotta. Ironia della sorte, per il ben più odioso reato di corruzione, di lì a poco anche l’interrogante senatore J. Parnell Thomas finirà in carcere, trovandosi per un periodo nel penitenziario di Danbury, nel Connecticut, contemporanemente a Lester Cole e Ring Lardner jr. Al processo Thomas si avvale del Quinto emendamento - che protegge il diritto del cittadino di non auto-accusarsi in un’indagine - per non rispondere alle domande (i Dieci si appellano invece al Primo, più rischioso ma considerato più logico nel loro caso). La conseguenza però non è limitata al carcere, ma si traduce in un ostracismo che proseguirà, a seconda dei casi, per i successivi 15-20 anni. Professionisti ben pagati, prolifici e importanti nel giro produttivo tra gli anni Trenta e Quaranta, di colpo diventano reietti da espellere dal consesso creativo, da inserire nella Blacklist, la lista nera. Uno dei Dieci, il regista Edward Dmytryk, che ha collaborato con Trumbo ai tempi della RKO, non regge al carcere e, preoccupato per il proprio futuro professionale, scrive una lettera di abiura. Passato un breve periodo di “esilio” (gira due film in Inghilterra), al suo ritorno negli Stati Uniti il regista si ripresenta di fronte al Committee e cita ventisei nomi di colleghi simpatizzanti di sinistra. Inizia così, poco dopo, una seconda carriera molto prolifica con le Majors e con gli attori più in voga: dirige tra gli altri Bogart in The Caine Mutiny (1954) e The Left Hand of God (1955), Gable in Soldier of Fortune (1955), Liz Taylor in Raintree Country (1957), Brando in The Young Lions (1958). Perde molti degli amici e i colleghi di un tempo, ma in compenso rientra trionfalmente nel sistema. Spirito combattivo, anche nel periodo di limbo tra le udienze di fine 1947 e il carcere Trumbo riesce a piazzare alcuni lavori, grazie ad amici che mettono il nome al posto suo. Se Trumbo riesce a sopravvivere per anni scrivendo, - sebbene con guadagni molto inferiori a prima - gli altri otto irriducibili degli originali Ten hanno più difficoltà o addirittura si vedono stroncare del tutto la carriera; tra questi Samuel Ornitz che, dal 1945 alla morte - avvenuta a causa di un cancro nel 1957 - non avrà più al suo attivo alcun credit cinematografico. Altri blacklisted, ostracizzati in seguito, trovano rifugio e lavoro in Europa, in particolare in Inghilterra (Donald Ogden Stewart, Carl Foreman),4 dove riescono a sbarcare il lunario operando sotto pseudonimo, o in Francia, dove ad esempio il regista Jules Dassin - autore di classici del noir come The Naked City dirige Rififi (1955), enorme successo per la cinematografia transalpina. Trumbo porta a termine in questo periodo il suo unico lavoro completo per il teatro, The Biggest Thief in Town (1949), rappresentato anche a Londra. Commedia in tre atti, è una satira sociale intrisa di umorismo nero, che si sviluppa attorno a un’impresa di pompe funebri. Attaccata dalla critica newyorkese dopo un buon successo nelle rappresentazioni in provincia, viene messa in scena dall’esperto Herman Shumlin e rimane in cartellone dal 30 marzo al 9 aprile 1949; ne sono interpreti Thomas Mitchell e Walter Abel. L’impresario Leo Sabinson chiede all’autore una commedia per l’anno successivo, ma il verdetto della Corte suprema decreterà il carcere e Trumbo non potrà dare seguito alla richiesta; The Biggest Thief in Town resterà l’unico lavoro originale di Trumbo per il palcoscenico (solo abbozzato rimane, agli inizi degli anni Sessanta, Morgana). Inoltre, dopo la condanna, la MGM revoca il contratto in essere e Trumbo si ritrova privo di sicurezza nell’impiego - peraltro ben retribuito grazie a un contratto di pochi anni prima - e quindi di entrate economiche. Alla conclusione del periodo di detenzione, - è rilasciato il 9 aprile 1951 come altri dei Dieci, Trumbo si trova a dover fare i conti con un margine di possibilità di lavoro nel cinema sempre più ristretto, visto che un buon numero di fidati sodali è finito a sua volta sulla lista nera. In una lettera all’amico scrittore Nelson Algren (1909-81), datata 15 giugno 1951 compare nella raccolta epistolare Additional Dialogue - , l’autore spiega le modalità di lavoro in queste condizioni e propone al collega un “metodo”: Io scriverei una storia che secondo me sarebbe possibile vendere e te la spedirei. Tu la spediresti al tuo agente di Hollywood come cosa tua. Se fosse venduta mi trasferiresti la mia parte di liquido sotto il nome da nubile di mia moglie. Per quanto riguarda le tasse, dovresti denunciare d’aver percepito l’intera somma e detrarre da essa la parte rimessa a mia moglie, in veste di pagamento per prestazioni letterarie oppure per aver acquistato direttamente da lei una proprietà letteraria. Nella nostra cartella delle tasse mia moglie registrerebbe i soldi come provenienti da te, e avremmo adempiuto a tutte le istanze legali. […] Ho pensato che, se sei soddisfatto della percentuale, la tua parte di bottino potrebbe arrecare gli stessi vantaggi anche a te. Non c’è bisogno di aggiungere che, in un piano del genere, la segretezza è di primaria importanza per il successo. Se ti inviassi un [soggetto] originale, potresti star certo che nessun altro lo ha letto. Sono sicuro che tu saprai essere ugualmente discreto nel tuo campo. Se hai scrupoli morali quanto a questa procedura in relazione al cinema, fammi il piacere di scordarteli. Hollywood è un immenso bordello, e qualsiasi progetto che permetta a uomini normalmente onesti di cavar fuori dei soldi per i loro fini personali, è più che degno di lode.5 Nel novembre 1951, Trumbo si trasferisce con la famiglia a Città del Messico, da dove cerca di riorganizzarsi. A causa delle precarie condizioni economiche è costretto a vendere il Lazy-T, il suo ranch in California. Nella corrispondenza con i prestanome, oltre al necessario vincolo di segretezza sull’effettivo autore dei lavori - tanto con l’esterno quanto tra il prestanome e l’agente che propone i soggetti ai produttori - un altro punto fondamentale è il linguaggio in codice. Per fare un esempio, Trumbo, dal Messico, chiede a un suo collaboratore di avvertirlo dell’avvenuta vendita di un soggetto inviando un telegramma riportante la seguente dicitura: Evelyn guarirà, dottore raccomanda 18 giorni di vacanza.6 Dove per “Evelyn guarirà” s’intende che il soggetto è stato venduto, “il dottore” è il compratore dello stesso, e la raccomandazione di “18 giorni di riposo” è la cifra (18 mila dollari) pattuita. Questo metodo serve nel caso in cui la polizia tenga sotto controllo le comunicazioni. Trumbo si fa indirizzare la corrispondenza presso nomi fittizi, come ad esempio “Dottor John Abbott”.7 Oppure, per rassicurare che il manoscritto è giunto a destinazione e subito consegnato all’agente, il prestanome risponde: Dr.John Abbott. Prescrizione ricevuta. Assolutamente magnifica. Fatta pervenire immediatamente. Cordiali saluti.8 La “prescrizione” è il lavoro di Trumbo stesso. Trumbo riesce comunque a scrivere adattamenti cinematografici per tutto il decennio, ma sempre sotto falso nome. Fa figurare altri come autori (Millard Kaufman, Ben Perry, Guy Endore, Sally Stubblefield) e si avvale di pseudonimi. Tra i nickname adottati ci sono il già citato John Abbott, Sam Jackson e forse quello che rimane il più noto, Robert Rich. Pubblica anche propri racconti dandone la paternità alla moglie, Cleo Fincher, anche questa volta con pseudonimo (C.F. Demaine) come ulteriore cautela per non attirare attenzioni. Nonostante l’Academy proibisca agli artisti sulla blacklist di concorrere a premi, Trumbo vince due Oscar che vengono accreditati a Ian McLellan Hunter (1915-91), per Roman Holiday (Vacanze romane, 1954, di William Wyler; in realtà Hunter collaborerà all’adattamento del soggetto originario dell’amico) e appunto al fantomatico “Robert Rich” per The Brave One (La più grande corrida, 1956, di Irving Rapper). La vittoria dell’Academy Award sotto falso nome (o col proprio nome assente dai credit) arride anche Michael Wilson e Carl Foreman per il famoso The Bridge on the River Kwai di David Lean nel 1958, e frequenti sono le candidature di sceneggiature scritte in realtà da autori blacklisted. Proprio le voci insistenti che Wilson e Foreman siano in realtà gli autori della superproduzione Kwai danno origine all’ondata di indignazione che dall’Europa parte verso la lista nera. Nel caso specifico lo sdegno è forte soprattutto in Francia, dal momento che l’Oscar viene assegnato al solo Pierre Boulle, autore del romanzo ma fino ad allora digiuno di sceneggiature, il che provoca evidenti dubbi sull’effettiva paternità dello script. Due anni prima, nella primavera del 1957, viene premiata la sceneggiatura di The Brave One. Il presunto autore, Robert Rich, non si presenta a ritirare l’Oscar. Così Bruce Cook, nella sua biografia su Trumbo, descrive il momento della premiazione: Notte degli Oscar, 1957. Deborah Kerr prende il biglietto dalla busta aperta e annuncia con voce alta e chiara che il vincitore “per il miglior soggetto originale è... Robert Rich!” Momento sacrale. Applauso! Jesse Lasky jr, sceneggiatore preferito di Cecil B. De Mille e a quel tempo vicepresidente della Screen Writers Guild, salta in piedi e si precipita lungo il corridoio per raggiungere il palco. Riceve il premio per conto di Rich, al quale si riferisce come “un mio caro amico”. Ne giustifica l’assenza dicendo che in questo momento è a fianco di sua moglie, che sta partorendo il loro primo figlio. Altri applausi. Lasky lascia velocemente il palco con in mano la statuetta. Lasky, tempo dopo, ricordando l’episodio nel suo libro What ever Happened to Hollywood? ammetterà che in realtà non aveva idea di chi fosse Robert Rich. Ma il nome gli suonava familiare, e lui pensava che un dirigente della SWG avesse il dovere di conoscere i suoi membri, e così... lo trasformò in un suo caro amico. Quanto al fatto che Rich fosse al capezzale della moglie, come Lasky ha asserito, be’, in quel momento gli sembrava la cosa più ovvia da dire. Il giorno dopo, comunque, quando si ha modo di controllare i registri della SWG, si scopre che non contengono nessun Robert Rich. Non è un membro del sindacato né mai lo è stato. Nessuno in realtà ha idea di chi sia o di come possa essere contattato.9 Fuori dagli Stati Uniti si ha la forte impressione che continuare a negare tante illustri figure professionali sia inutile, oltreché controproducente a livello di immagine. Si finisce col penalizzare artisti i cui lavori meritano addirittura dei premi, andando in qualche occasione a rafforzare sistemi produttivi stranieri, ad esempio quello inglese o addirittura, come lo stesso Trumbo ricorda, quello messicano. Ma l’Academy e l’industria cinematografica nel suo complesso, per il momento, non vi ravvisano alcuna contraddizione. Tornato a Los Angeles dopo qualche anno in Messico, Trumbo scrive per un periodo copioni a quattro mani per film di poco conto proprio insieme a Michael Wilson, amico oltreché collega anch’egli in lista nera. Abitando ambedue a Los Angeles, ma a diversi chilometri di distanza, i due comunicano sotto falso nome (in questo caso Trumbo si firma “Theodore Flexman”) scambiandosi il work in progress del momento attraverso corrieri. Raramente si preoccuperanno dell’effettivo risultato sullo schermo: si tratta di opere a cui sono costretti per ottenere il necessario per vivere, e questo metodo permette loro di finire un intero copione in una decina di giorni. Non mancano momenti di alta tensione, legati al fatto che lo scrittore è ufficialmente considerato un paria da parte del mondo del cinema e della politica: le lettere minatorie (con riferimenti frequenti e non certo gentili al suo essere uomo di sinistra) sono all’ordine del giorno, e nel 1956 Trumbo è anche vittima di un’aggressione, durante la quale riporta due costole fratturate e diverse escoriazioni. Per non attirare troppa attenzione su di sé, con la pericolosa conseguenza di portare alla luce la sua attività “clandestina” di sceneggiatore, decide di non denunciare l’accaduto. Per tutti gli anni Cinquanta la carriera di Trumbo prosegue su questa falsariga, senza apparente possibilità di tornare allo scoperto. I suoi tentativi di sensibilizzare contro la lista nera scrittori famosi, come testimoniano le lettere del 1957 inviate, tra gli altri, a Hemingway, Faulkner, Saroyan (suo ex collega di sceneggiature negli anni Trenta), Steinbeck e Thornton Wilder, si dimostrano vani. La cortina di dissenso che il maccartismo ha generato nell’opinione pubblica e nel sistema cinematografico nei confronti degli intellettuali progressisti è ancora ben salda, nonostante qualche crepa come quella già citata dei premi assegnati a sceneggiatori “fantasma”. Clandestinità, ma con picchi di lavoro talvolta a dir poco eccessivi. In una lettera del dicembre 1957 all’amico sceneggiatore Hugo Butler, - noto per aver scritto A Christmas Carol, 1938, e Lassie Come Home, 1943 - col quale Trumbo collabora in segreto per He Ran All the Way (1951, Ho amato un fuorilegge, l’ultimo film interpretato da John Garfield) prima che Butler stesso finisca nella blacklist, l’autore stila una lista dei lavori in corso in quel periodo. Si tratta di ben otto sceneggiature, tra cui una collaborazione con lo stesso Butler, un adattamento di romanzo per United Artists, un film con un’attrice molto nota, un altro che forse verrà prodotto e diretto da John Huston, uno prodotto dai fratelli King (coi quali Trumbo ha lavorato già per il noir Gun Crazy, altrimenti intitolato Deadly Is the Female,La sanguinaria, 1950 e per The Brave One), un soggetto originale per un attore noto, il rifacimento dei dialoghi di una pellicola tratta da un romanzo, oltre al lavoro più importante che sarà destinato a uno degli Studi principali e il cui credit sarà dato a un collega.10 L’attivismo a cui è costretto per racimolare il necessario per mantenere la famiglia non distoglie Trumbo dal prodigarsi in incontri pubblici a favore di cause in cui crede, con l’intento, graduale, di risvegliare un’attenzione benevola verso gli artisti “dimenticati” ai margini, come lui e tanti altri. Nel maggio 1958 scrive a Alvah Bessie, amico del gruppo dei Ten, in cui spiega come intende muoversi per provare a scalfire la nube di indifferenza che li circonda: C’è un altro motivo che dobbiamo iniziare a capire. Gli artisti di un mezzo di comunicazione di massa come il cinema hanno una vita pubblica e, come abbiamo visto, la loro sopravvivenza è legata all’approvazione del pubblico. Più di qualunque altro gruppo negli Stati Uniti, gli artisti di Hollywood dipendono dalle loro relazioni pubbliche. Non approvo questa situazione, dico semplicemente come stanno le cose. Ristabilire delle buone relazioni pubbliche per gli artisti di Hollywood inclusi nella lista nera è la condizione sine qua non per distruggere la lista, che ti piaccia o no. […] Fin troppo a lungo abbiamo avuto l’”onore”di riempire i borsellini altrui piuttosto che i nostri. [...] Dopo undici anni passati a cercare una vittoria su tutta la linea ora il problema è conseguirne una parziale, e quanto concedere per raggiungerla. Una vittoria limitata contro la lista nera sarà una sconfitta limitata per chi l’ha istituita.11 Qualcosa, comunque, inizia a cambiare. Nel dicembre 1957 Kirk Douglas prende in considerazione la possibilità di produrre un film tratto dall’opera di unblacklisted (Howard Fast, che tempo prima aveva abiurato il proprio passato per ottenere uno sconto di pena). Si tratta di un romanzo storico incentrato sulla figura dello schiavo trace Spartaco, che Fast scrive durante la prigionia nel 1951. Douglas, dopo il rifiuto di vari altri Studi, riesce a coinvolgere la Universal. Lo stesso Fast viene incaricato della sceneggiatura, ma la prima stesura si rivela fallimentare. Mancano poche settimane alla scadenza richiesta dalla Universal per prendere in considerazione seriamente il progetto, e serve urgentemente uno script. Douglas ha sentito parlare di un tale “Sam Jackson”, che sta scrivendo per la sua piccola casa di produzione, la Byrna Productions, la sceneggiatura del futuro Lonely Are the Brave (western crepuscolare del 1962 che verrà interpretato dallo stesso Douglas). Viene a conoscenza che dietro quel nome di fantasia si cela Dalton Trumbo. Decide quindi di contattarlo e proporgli la revisione, che in realtà si rivela una riscrittura. Lo Studio può così leggere e accettare il copione, che per il momento è firmato dal coproduttore, Edward Lewis, per evitare i problemi legati allo scomodo nome del vero autore. Nel maggio 1958 Douglas viene invitato da Nixon a Washington per probabili ragioni di convenienza, essendo l’attore un nome di spicco dell’industria. Il vicepresidente è infatti in procinto di candidarsi alle elezioni del 1960. Douglas vorrebbe cogliere l’occasione per ottenere una dichiarazione di apertura sulla lista nera da parte dell’uomo politico (Nixon, che sarà eletto dieci anni dopo, negli anni Quaranta aveva fatto parte della commissione che ascolta i Dieci e, come dice Trumbo in una lettera, aveva dato l’impressione di non approvare i metodi del presidente di commissione Thomas). L’incontro, fissato e rimandato, pare non sia infine avvenuto. Douglas decide di proseguire comunque, determinato a superare non solo gli ostacoli che un grande progetto comporta, ma anche la paura di rappresaglie una volta che la pellicola è in procinto di uscire nelle sale. Il film coinvolge attori di primo piano: Laurence Olivier, Tony Curtis, Peter Ustinov, Charles Laughton oltre allo stesso Douglas. Dopo l’iniziale affidamento della regia a Anthony Mann, il film è portato a termine da un giovane Stanley Kubrick, che ha già lavorato con Douglas in Paths of Glory (Orizzonti di gloria) pochi anni prima. Ma l’importanza del film, come lo stesso Douglas ricorda, risiede nell’aver palesato il nome di Trumbo nei credit, rompendo così di fatto l’ostracismo nei suoi confronti. Complice una dichiarazione dell’ex presidente Harry Truman a favore dell’abolizione della blacklist, e col rischio contingente che Trumbo lasci il progetto a causa degli eccessivi cambiamenti richiesti da alcuni attori (Ustinov e Laughton in particolare) e da Kubrick, Douglas lo rassicura “prendendo il toro per le corna” e annunciando che, succeda quel che succeda, il suo nome sarà apertamente citato nei titoli ufficiali del film. “Sam Jackson” esce così di scena per sempre. I mesi precedenti alla prima proiezione di Spartacus sono comunque densi di problematiche, che minano in diverse occasioni l’agognata conclusione. Una forte campagna stampa taccia il film di filo-comunismo, arrivando a intravedere nella vicenda dello schiavo ribelle una metafora, tracciata dallo scrittore, del popolo che si deve unire per combattere lo Stato americano. All’interno della Universal girano voci preoccupate, mentre Douglas si trova in Messico a girare un altro western sceneggiato da Trumbo, The Last Sunset (L’occhio caldo del cielo). L’ufficio di censura propone inoltre tagli che snaturano in parte la pellicola in merito al messaggio “politico” (per quanto possibile le parti eliminate, tra cui una scena di stampo omosessuale tra Laurence Olivier e Tony Curtis, vengono riproposte in un’edizione director’s cut - o per meglio dire producer’s cut - degli anni Novanta), ma è un compromesso che riesce a evitare ulteriori dispute, visto che già il nome di Trumbo - ora accettato dalla Universal - è stata a lungo una questione molto controversa dal punto di vista dell’opportunità. Agitatori conservatori ben organizzati - Douglas cita l’American Legion - disturbano inoltre saltuariamente le proiezioni del film, che comunque riesce finalmente a iniziare la propria vita pubblica, ottenendo l’anno successivo quattro premi Oscar su sei candidature.12 Pochi mesi dopo Trumbo firma un altro kolossal, Exodus (1960; regia di Otto Preminger, tratto da una parte del lungo romanzo di Leon Uris). Il produttore-regista di origine austriaca sta lavorando allo script di Exodus con Albert Maltz, uno dei Dieci, quando viene a sapere che Kirk Douglas vuole presentare Trumbo come effettivo sceneggiatore di Spartacus. Dopo una sfuriata iniziale (Preminger non ritiene una buona idea l’esplicitazione degli autori, che ancora sono ufficialmente in disgrazia), a sorpresa licenzia Maltz e sceglie proprio Trumbo come sceneggiatore del suo film. Preminger sarà il primo ad annunciare pubblicamente nel gennaio 1960, sul «New York Times», che Trumbo sta collaborando con lui, sfidando quindi apertamente la censura del sistema. Sarà comunque Douglas, grazie al fatto che l’esordio diSpartacus sullo schermo avviene due mesi prima di quella del film di Preminger, a ottenere per Trumbo il primo titolo di testa dopo quindici anni. È però molto probabile che la mossa di Preminger abbia dissipato gli ultimi dubbi di Douglas e della Universal, tesi sostenuta da studiosi come Larry Ceplair e dalla famiglia Trumbo. Douglas anche molti decenni dopo sosterrà di aver sferrato lui stesso il colpo di grazia alla lista nera, suscitando qualche polemica. Questo dittico di primo piano, a livello produttivo e spettacolare, riporta finalmente alla luce il talento dello sceneggiatore, che d’ora in avanti non si nasconderà più. Ad ogni modo, le resistenze per il ritorno in auge degli scrittori emarginati inseriti nella blacklist sono ancora forti. È soprattutto Maltz a incontrare, suo malgrado, ostacoli. Nel 1960, in concomitanza con il clamore suscitato per il credit di Trumbo per Spartacus e Exodus, un nome di primo piano come Frank Sinatra deve rinunciare al progetto di portare sullo schermo The Execution of Private Slovik, basato sulla vicenda del primo soldato giustiziato per diserzione dalla fine della guerra civile, che prevede la sceneggiatura di Albert Maltz. 13 Sinatra è al centro di un’accesa polemica che lo vede accusato da certa propaganda conservatrice di essere un simpatizzante comunista, dal momento che l’attore-cantante sostiene John Kennedy alle elezioni presidenziali che si terranno nel novembre di quell’anno. L’intervento della famiglia Kennedy spinge Sinatra a desistere, visto che la stampa di destra - i giornali di Hearst, ad esempio hanno preso di mira l’artista per colpire Kennedy, che ne sta risentendo in qualche primaria. I problemi incontrati da Sinatra rischiano di ripercuotersi su Douglas e Spartacus, ma quest’ultimo progetto è già nella fase finale e questioni innanzitutto economiche - la Universal lo vede naturalmente come un prodotto da vendere, dopo avervi investito - fanno pendere l’ago della bilancia verso l’uscita nelle sale. L’errore di Sinatra è stato probabilmente di aver annunciato la collaborazione di un blacklisted al suo progetto in una fase ancora troppo precoce, mentre la bravura di Kirk Douglas sta nell’aver sviato l’attenzione sul reale autore dello script fin quasi alla conclusione del girato, dovendo solo rispondere, in fase iniziale, dell’iniziativa di trarre un film dall’opera di Howard Fast, comunista dichiarato; un autore che comunque aveva fatto pubblica ammenda per evitare ulteriori discriminazioni e che per questo, così come avviene con Dmytryk, non è visto del tutto di buon occhio dallo stesso Trumbo. Il resto della carriera dello scrittore è contraddistinto da altri adattamenti per film di peso, anche se non sempre del tutto riusciti, come The Fixer (L’uomo di Kiev, 1968, dal romanzo di Bernard Malamud) e The Horsemen (Cavalieri selvaggi, 1971, dall’opera di Joseph Kessel, film d’avventura con Omar Sharif e Jack Palance). Adatta e dirige inoltre Johnny Got His Gun (1971), versione cinematografica del suo romanzo più noto, che nonostante un premio al festival di Cannes e ottime recensioni, si rivela disastroso dal punto di vista commerciale (per una esaustiva analisi cfr. Larry Ceplair, Christopher Trumbo, Dalton Trumbo - Un radicale nella blacklist di Hollywood, DMG Edizioni 2017, capp. 23-25). Riscrive in seguito una precedente stesura della pellicola politico-cospirativa incentrata sull’assassinio di John Kennedy, Executive Action (1973; Azione esecutiva), molti anni prima di JFK di Oliver Stone. Il suo ultimo film è Papillon (1973, tratto dall’autobiografia del forzato Henri Charrière, con Steve McQueen e Dustin Hoffman), nel quale compare in un cameo all’inizio della pellicola. Solo negli ultimi mesi di vita (morirà nel settembre 1976) riceverà l’Oscar per The Brave One, mentre l’altro per Roman Holiday gli verrà riconosciuto postumo dopo una lunga disputa (cfr. Ceplair, Trumbo,Dalton Trumbo, cit., pp. 529-537). Trumbo, prima delle grane giudiziarie e del successivo lavoro poco gratificante, oscuro e sottopagato di ghost writer, per lungo tempo si muove a suo agio nel sistema produttivo degli anni Trenta e Quaranta, arrivando a essere uno degli sceneggiatori più pagati e riconosciuti. Inizia alla Warner Bros., dopo i primi racconti pubblicati su rivista e con all’attivo il suo primo romanzo, Eclipse. Del 1936 i primi lavori per il grande schermo: i B-movies Road Gang (regia di Louis King) e Love Begins at Twenty (diretto da Frank McDonald), in entrambi i casi sceneggiature scritte a partire da soggetti altrui. Dopo alcune altre fatiche per pellicole ormai dimenticate anche per la Columbia e la MGM, nel 1938 Trumbo inaugura l’importante sodalizio con la major RKO, dove incontra altri due dei futuri Hollywood Ten, il regista Dmytryk e il produttore Adrian Scott. Esordisce con Fugitives for a Night (regia di Leslie Goodwins). Segue Five Came Back (1939, La tragedia del “Silver Queen”; di John Farrow), film di cui scrive la terza stesura dopo quelle di Nathanael West e Jerry Cady; il soggetto verrà rifatto nel 1956 dallo stesso regista Farrow ma Trumbo, ormai in lista nera, non vedrà citato il suo originario apporto. Agli albori del nuovo decennio arrivano le pellicole con la star della casa di produzione, Ginger Rogers: il già citato Kitty Foyle e Tender Comrade (1943, Eravamo tanto felici; regia di Dmytryk). Proprio il lavoro per Tender Comrade si troverà al centro di polemiche durante le udienze della commissione del Congresso, alcuni anni dopo, quando la madre della Rogers lamenta la scrittura a suo dire “filo-comunista” di Trumbo. La stessa attrice ribadirà l’opinione materna nell’autobiografia del 1991 My Story. Le accuse mosse a Dmytryk, oltre che a questo film, si riferiranno soprattutto a Crossfire, che tratta il tema dell’antisemitismo. Trumbo vive il suo periodo più redditizio dal punto di vista economico a metà degli anni Quaranta col contratto stipulato con la MGM. In particolare scrive due pellicole di successo interpretate da Spencer Tracy: A Guy Named Joe (1943, Joe il pilota; regia di Victor Fleming, da questo soggetto Steven Spielberg girerà un remake nel 1989, Always) e la propagandistica Thirty Seconds Over Tokyo (1944, Missione segreta; regia di Mervyn LeRoy). Seguirà il bucolico Our Vines Have Tender Grapes (1945; Il sole spunta domani, regia di Roy Rowland). Trumbo è sotto contratto con la MGM, impegnato a scrivere un film con Clark Gable, Angel Flight (poi non realizzato), quando viene messo al bando dopo la famigerata Dichiarazione del Waldorf, in cui le case di produzioni si accordano per non assumere personale in odore di simpatie comuniste, facendo così il gioco della commissione congressuale. Quanto pretestuose fossero le accuse di anti-americanismo (etichetta senza significato sotto la quale si cela l’ostracismo verso chi porta avanti idee progressiste) lo si dimostra anche dal fatto che Trumbo collabora senza particolari problemi con professionisti notoriamente conservatori, come appunto lo sono i registi Fleming e LeRoy. Trumbo romanziere L’attività di sceneggiatore di successo mette in parte in ombra il fatto che Trumbo è per buona parte dell’inizio carriera un vero e proprio narratore. Dopo un certo numero di racconti apparsi su riviste tra il 1935 e il 1940 scrive quattro romanzi che resteranno per molti anni le sue uniche opere fuori dal contesto cinematografico. Tra questi, Johnny Got His Gun (1939, presentato in italiano da Bompiani prima con un altro titolo e poi col definitivo E Johnny prese il fucile) è l’opera letteraria che ottiene maggior riscontro, sia di vendite che di dibattito sul tema della guerra e dei suoi orrori. Oltre a ricevere il riconoscimento ufficiale dell’American Bookseller Award,14 il romanzo viene ristampato dopo la fine della seconda guerra mondiale e diviene opera-simbolo della non violenza soprattutto in concomitanza con i conflitti controversi a cui gli Stati Uniti prendono parte nei decenni successivi. È un’opera dalla storia politica complessa, che ha avuto letture contrastanti e che per questa ragione lo stesso scrittore, in accordo con l’editore, ha preferito non pubblicare durante il secondo conflitto. Nonostante la nomea di opera pacifista, lo stesso Trumbo ne traccia un giudizio controcorrente, - giudizio che si ripercuote su sé medesimo - in una lettera (mai spedita) all’FBI del dicembre 1943, rispondendo a una serie di reazioni suscitate dal libro che hanno messo in allarme il Bureau: Ho scritto un libro intitolato E Johnny prese il fucile, pubblicato tre giorni dopo lo scoppio della guerra in Europa. Nessuno che abbia letto attentamente i capitoli conclusivi l’ha definito pacifista; e io non sono mai stato un pacifista. Sono stato, più volte, definito comunista ma è un’etichetta cui ben pochi americani di coscienza, a cominciare dal Presidente [Roosevelt, ndr], sono riusciti a sottrarsi.15 Trumbo vuole intendere che personalmente non era contrario alla guerra, se necessaria - come in quel momento storico - a sconfiggere il nazismo, e vuole chiarirlo al Bureau che lo sta invece tenendo d’occhio per l’affiliazione al sindacato e più in generale per le sue idee progressiste. Oltre a riferire che compra obbligazioni di guerra, in un’altra parte della lettera l’autore accenna alla scarsa possibilità che paesi come la Francia collaborazionista e la Gran Bretagna (almeno sino ai tempi dell’altalenante politica del primo ministro Chamberlain verso la Germania hitleriana) siano alleati affidabili contro il nazismo. Intende dire così che l’unica possibilità reale, propria di una politica concreta (e così è stato, in effetti) è l’alleanza strategica con Stalin, oltre all’appoggio britannico dopo l’avvento di Churchill a Downing Street. E in particolare occorre adattarsi ai mutati eventi politico-militari, come sottolinea ancora Trumbo, che ritiene la data del 22 giugno 1941 (la sopraggiunta “Operazione Barbarossa”, l’attacco di Hitler all’Unione Sovietica) lo spartiacque per appoggiare in modo convinto l’intervento bellico statunitense. Ambientato durante la prima guerra mondiale, scritto ai primordi del secondo conflitto mondiale quando ancora è fresco il ricordo della guerra civile spagnola,Johnny viene ampiamente recuperato - in special modo dai giovani e dal movimento contro la guerra - durante i combattimenti in Corea a inizio anni Cinquanta e soprattutto durante il conflitto (la “sporca guerra”) in Vietnam, tra i Sessanta e i Settanta. Lo stesso scrittore dirigerà un proprio adattamento cinematografico che sarà la sua unica prova da regista, dopo che in un primo tempo, attorno al 1964, se ne è interessato il grande autore spagnolo Luis Buñuel, al tempo residente in Messico. Il romanzo è il lungo monologo interiore di Joe Bonham, un soldato orribilmente ferito durante la prima guerra mondiale. La narrazione è strutturata come un flusso di coscienza, dalla forma non convenzionale visto che la punteggiatura è quasi assente, in costante equilibro tra realismo ricordi d’infanzia e adolescenza dello stesso autore - e onirismo. A poco a poco si capisce che a parlare è l’unica parte ormai rimasta del corpo del soldato: la mente. Il titolo deriva da un verso (“Johnny get your gun”) di una canzone patriottica, Over There, scritta nel 1917 da George M. Cohan. Washington Jitters (1936), la seconda opera, è una satira politica sul New Deal. Narra la vicenda di Henry Hogg, di mestiere disegnatore di insegne, che viene mandato a scrivere il nome del nuovo coordinatore dell’ASP (Piano di Sviluppo Agricolo) sulla porta dell’ufficio amministrativo. Hogg è un uomo normale, il genere di persona piena di buon senso che chiunque direbbe capace di ripulire ciò che non va nella politica di Washington, se solo gliene fosse data la possibilità. Questo momento arriva, forse in modo un po’ eccessivo, in un giorno qualunque di lavoro. Non c’è ancora nessun coordinatore per il Piano Agricolo, ma il reporter Harvey Upp, arrivato nell’ufficio, intervista Hogg credendolo il nuovo dirigente. Upp rimane molto colpito dall’eloquio semplice e chiaro dell’uomo. Di lì a poco il suo nome è su ogni giornale del paese, dipinto come uomo del New Deal che dice cose banali ma tutto sommato sensate. Una cosa tira l’altra, le assurdità si susseguono, finché Hogg viene effettivamente nominato coordinatore per il Piano di Sviluppo Agricolo ed è salutato in tutto il paese come l’uomo destinato a portare gli Stati Uniti fuori dalla palude. Alla fine, Henry lamenta la perdita della sua innocenza dicendo: «Non sono più un pittore di cartelli, anzi non sono neppure più un uomo, non sono altro che un politico». Il romanzo viene terminato nel novembre 1935, ma passano molti mesi prima della pubblicazione, avvenuta nel settembre dell’anno successivo. Il ritardo è dovuto al fatto che il manoscritto, appena consegnato all’editore, finisce nelle mani di una compagnia teatrale che ne organizza una riduzione per le scene, progetto poi rimasto sulla carta.16 The Remarkable Andrew (1940), ultimo romanzo concluso, è scritto in concomitanza con la stesura di un soggetto di Trumbo effettivamente prodotto dalla Paramount, per la regia di Stuart Heisler e l’interpretazione di un giovane William Holden (l’attore, non contento del regista, ad un certo punto della lavorazione richiede che sia Trumbo stesso a prenderne le redini - sarebbe stato quindi il suo debutto alla regia -, ma lo sceneggiatore declina l’offerta affermando che nella produzione di un film ci sono gerarchie da rispettare). Dopo Johnny Get His Gun, scritto appena un anno prima, è difficile per Trumbo trovare un soggetto che ne sia all’altezza, e infatti l’opera non è del tutto riuscita, in bilico tra satira politica e parti fantastiche. Lo scrittore torna a Shale City, dove aveva ambientato Eclipse e parte di Johnny. Protagonista è Andrew Long, contabile amministrativo che scopre degli ammanchi di denaro probabilmente avvenuti per mano del sindaco e di due suoi sodali. Quando questi ultimi vengono a sapere che Andrew sospetta di loro, trovano il modo di rivoltare l’accusa verso il giovane. Viene svolta un’indagine puntigliosa sulla vita di Andrew - le sue letture, opinioni, ogni suo pensiero - da parte di un comitato di cittadini (lo scrittore ha ancora nella memoria la Lega della Lealtà nata durante la prima guerra mondiale nella cittadina dove è cresciuto, Grand Junction in Colorado). Andrew Long viene giudicato colpevole, a meno che non riesca a provare la propria innocenza. La vicenda assume un tocco surreale con la presenza del fantasma dell’ex presidente Andrew Jackson che cerca di infondere coraggio al giovane, trovando inoltre il modo di lanciarsi in dichiarazioni retoriche contro la guerra (siamo nel 1940, Trumbo al momento è del parere di non intervenire nel conflitto mondiale; opinione che cambierà, come detto, dopo l’aggressione tedesca all’Unione Sovietica). Molte pagine sono inoltre spese in una sorta di retorico seminario svolto da uno dei personaggi sui “veri valori americani”. La vicenda principale torna negli ultimi capitoli, in cui Andrew si difende con successo davanti ai concittadini. Il libro rileva chiaramente la propria natura di soggetto cinematografico più che di romanzo concepito come tale, con strizzatine d’occhio alla retorica e al surreale di alcuni film di Frank Capra, ma non è un mix dei più riusciti, confermando la difficoltà di Trumbo nel scindere ormai la sua attività cinematografica da quella di narratore tout court. Nel corso della seconda guerra mondiale mette in cantiere una serie di romanzi sulla storia americana, di cui scriverà qualche frammento anche in carcere. Il progetto sarà accantonato durante il periodo di clandestinità. Passeranno molti anni prima che Trumbo torni a cimentarsi in un’opera di narrativa, che rimarrà incompiuta: Night of the Aurochs. In quest’ultimo testo - pubblicato postumo nel 1979 - l’autore mette in scena, con l’espediente della prima persona, una sorta di autobiografia di un nazista di fantasia, Ludwig Richard Johann Grieben. L’edizione pubblicata, curata da Robert Kirsch, propone i dieci capitoli conclusi, un riassunto di altre parti per mano di Trumbo e frammenti abbozzati sparsi. Si prospettava un’opera piuttosto corposa, ma che purtroppo è rimasta compiuta solo per un quarto. In compenso nel periodo di silenzio nella narrativa scrive alcuni brevi pamphlet di stampo politico-sociale. Il primo è Harry Bridge (1941), storia di un sindacalista (1901-90) preso di mira dallo Smith Act, emendamento all’Alien Registration Act (legge varata nel 1940 in chiave anti-nazista e anti-fascista, ma che colpirà in special modo persone di sinistra). La sostanza della legge colpisce i cittadini stranieri, che vedono limitate certe attività associative considerate potenzialmente sovversive. Si colpiscono in particolare attività sindacali (nel caso specifico, Bridge, di nazionalità australiana, era il leader della union degli scaricatori di porto di San Francisco). Dopo le esperienze dei processi e del carcere, ne scrive il resoconto come pretesto per una più generale disquisizione sulla libertà d’espressione in The Time of the Toad (1949; il titolo deriva da un concetto espresso da Émile Zola in un articolo initolato Le Crapaud: il rospo - Toad in inglese -, appunto). Segue un’altra forte critica allo Smith Act nel racconto dell’esperienza giudiziaria di alcuni simpatizzanti comunisti californiani in The Devil in the Book (1956). Ritorna sulla vicenda propria e dei suoi colleghi dell’epoca dei Ten in Honor Bright and All That Jazz, lungo articolo apparso su «The Nation» nel 1965 e poi ripubblicato nel 1972 assieme ai due precedenti scritti di denuncia. Nel 1970 è invece la volta di un’ampia selezione di lettere degli anni 1942-1962 curata da Helen Manfull, Additional Dialogue, che si può definire quasi un’autobiografia del periodo più significativo e tormentato della sua vita: la seconda guerra mondiale, i processi, il lavoro in clandestinità, fino all’emersione agli inizi degli anni Sessanta. Gli anni di formazione fino a Eclipse Trumbo nasce a Montrose, Colorado, il 5 dicembre 1905. La famiglia è presumibilmente originaria della Svizzera e poi dell’Alsazia-Lorena. Il cognome passa da Trummelbach, a Trumbach, a Trumbeau fino al trasferimento in Inghilterra, dove assume la sua forma finale. 17 Da qui, nel 1736, l’antenato giunge negli Stati Uniti, installandosi in Virginia. Dopo altri spostamenti sempre più verso ovest, la famiglia passa per il Kentucky fino a stabilirsi in Colorado. Quando Dalton ha due anni, la famiglia si trasferisce a Grand Junction, una cittadina del Colorado che più avanti servirà all’autore come modello per la Shale City di Eclipse. Il padre Orus (1874-1925) si cimenta in varie professioni, da quella di venditore di scarpe nel negozio locale Benge’s a quella di agricoltore e apicoltore, ma senza grande successo. La famiglia si sposta a Los Angeles in cerca di miglior sorte ma, ben presto, il padre rimane di nuovo disoccupato e oltretutto si ammala gravemente. Sua madre Maud Tillery è impiegata nell’ufficio amministrativo di un autosalone e non riesce da sola a mantenere le due figlie ancora piccole e il figlio ormai maggiorenne agli studi. Dalton lascia l’università e inizia a lavorare nel panificio industriale Davis Perfection Bakery, posto che manterrà per nove anni raggiungendo anche una posizione di responsabilità, soffrendo per la frustrazione delle sue ambizioni letterarie ma acquisendo, dal contatto diretto con la miseria causata dalla crisi, un’acuta consapevolezza sociale. Nel dicembre 1925 Orus Trumbo muore dopo una straziante malattia (lo scrittore renderà in qualche modo omaggio al padre in un passaggio di E Johnny prese il fucile). I turni di notte consentono comunque a Dalton di frequentare alcuni corsi universitari anche se mai in modo sistematico. Rimasta vedova precocemente, Maud sarà un punto di riferimento per il figlio al quale darà un’educazione religiosa come cristiano scientista. Dalton si distaccherà comunque presto dalla religione, anzi in qualche modo incolpando la madre di aver seguito troppo pedantemente i precetti del proprio culto e non aver almeno tentato di salvare la vita al padre. La religione scientista più ortodossa, infatti, rifiuta le cure mediche; Orus muore senza aver ricevuto la visita di un medico se non in prossimità del decesso. In extremis, per evitare la futura autopsia, la madre accetta che un dottore visiti il marito e all’uomo è così diagnosticata l’anemia perniciosa. Orus è ormai però un malato terminale. Come afferma lo stesso Trumbo nella biografia di Cook, la magra consolazione è che il padre sarebbe morto comunque, perché la cura sarebbe stata scoperta solo qualche anno più tardi. Con la madre il rapporto diventa conflittuale e in sostanza tornerà normale solo molti decenni più tardi. Il posto di lavoro al panificio industriale non lo allontana comunque dal suo obiettivo: diventare uno scrittore. Nel 1932 inizia a pubblicare racconti su «Vanity Fair» e sull’«Hollywood Spectator», del quale diviene poi caporedattore abbandonando l’impiego ormai divenuto alienante. Il giornale, comunque, non gli pagherà mai un salario sufficiente. Trumbo lascia lo «Spectator» nel 1934 e, un anno più tardi, viene assunto prima come lettore e in seguito come sceneggiatore presso la Warner Bros grazie a Frank Daugherty, sua vecchia conoscenza al giornale. Pubblica in questo periodo il suo primo romanzo completo, dopo alcuni altri tentativi lasciati incompiuti (se ne contano diversi, ma vari frammenti sono rientrati nelle opere successive). Eclipse esce grazie a una casa editrice inglese, il cui proprietario Lovat Dickson è un australiano cresciuto in Canada. Consegnato il manoscritto nel 1934, in prossimità della pubblicazione lo stesso Trumbo scrive alla sua agente letteraria Elsie McKeogh per richiedere l’aggiunta della dedica al nonno materno, Millard F. Tillery (1857-1935) e alla nonna, Huldah. Nonostante la richiesta non ottenga risultati, probabilmente perché il romanzo è già in procinto di andare in stampa, la lettera, datata dicembre 1934, è degna di nota perché sottolinea in parte l’aspetto autobiografico del racconto, mettendo in luce il ruolo vigoroso del nonno nella formazione della parte del Colorado in cui la vicenda si muove. Il vecchio Tillery aveva infatti partecipato alle bonifiche delle terre e ricoperto il ruolo di sceriffo per dodici anni in un luogo non ancora del tutto civilizzato. La dedica sarà reintrodotta nell’edizione del 2005, pubblicata in occasione del centenario della nascita dello scrittore e a settant’anni dalla prima pubblicazione. La cittadina del Colorado in cui la vicenda si svolge è in realtà, come detto, Grand Junction. I personaggi sono riflessi di persone realmente esistite, la cui vicenda è riportata grossomodo fedelmente o con alterazioni giustificate dalla creazione letteraria. Proprio a causa dell’eccesso di identificazione con persone reali, la cittadina reagisce con stizza al ritratto impietoso che ne fa l’ex concittadino. Si tenga conto in particolare che l’uomo che funge da modello per il protagonista è ancora in vita e, a causa della crisi economica, non versa in buone condizioni. Eclipse è il tipo di romanzo che ogni scrittore vorrebbe come proprio esordio. Nel caso specifico dell’autore, rimane sicuramente superiore - forse perché più personale - alla coppia di romanzi che seguiranno. La vicenda narrata è divisa in tre parti. Al centro c’è John Abbott che, quando lo incontriamo nel 1926, è l’uomo d’affari di maggior successo di Shale City. Il suo grande magazzino, l’Emporio, «il più grande tra Denver e Salt Lake City», produce floridi affari. La sua banca prospera. È l’uomo più rispettato e ammirato della città. Diversi personaggi locali lo cercano per chiedere consiglio su questioni di lavoro e investimenti: c’è il concorrente Harry Twinge, la beghina locale Violet Budd, la tenutaria del bordello Maria Telsa, il rappresentante Bill Hitchcock, il giovane impiegato Phil Haley. Abbott stesso non è comunque esente da problemi: vuole disperatamente liberarsi della moglie per poter sposare Donna Long, una donna intelligente e attiva che è la sua vice all’Emporio. I due portano avanti da anni una relazione che la moglie di Abbott ha appena scoperto. In un capitolo centrale di questa parte Abbott è a colloquio con il professor Hermann Vogel, una sorta di “voce della coscienza” che, con riferimenti storici e sociali non sempre semplici da decifrare fuori dal contesto statunitense, lo mette in guardia dalla troppa adulazione che in città si riversa su di lui (come si vedrà, Vogel sarà profeta, seppur condannato a un trattamento da Cassandra). La prima parte si chiude con un colpo di scena. La seconda sezione del romanzo (che si svolge negli anni 1928-29) vede Abbott tornare da un viaggio sulla costa orientale. È pieno di ambizioni e idee, pianifica di migliorare la città, provando a renderla ancora più moderna ed efficiente. Sente di avere una sorta di “missione”, che la sua condizione economica abbiente lo mette in grado di poter adempiere per il bene della sua comunità. Tra questi piani c’è anche la costruzione della nuova piscina pubblica, che Abbott finanzia dopo il tragico annegamento di un ragazzo nel fiume. La piscina viene inaugurata alla vigilia del rovescio azionario del 1929. Nella terza sezione (1930-33) John Abbott affronta la Grande Depressione, quando i suoi affari iniziano a declinare paurosamente. Allo stesso tempo si assiste alla caduta, fisica e psicologica, del protagonista e con lui del mondo che aveva immaginato e provato a rendere concreto per la propria generazione e quelle successive. Nel capitolo 8 del secondo Libro è citato di sfuggita Babbitt, romanzo del 1922 di Sinclair Lewis ambientato nella cittadina fittizia di Zenith. Eclipse può essere definito un “Babbitt al contrario”. Mentre George Babbitt perde la propria identità quando viene inghiottito dal successo, John Abbott trova se stesso solo dopo il fallimento. Nel gruppo di uomini d’affari della Zenith di Babbitt, Abbott è come personalità più vicino a Samuel Dodsworth, protagonista di un altro romanzo di Lewis, Dodsworth (1929). È uomo di bell’aspetto, onesto e intelligente, di buoni propositi. In effetti Abbott è il tipico modello di capitalista illuminato: un filantropo, un uomo che accetta le responsabilità del suo benessere. Ed è questo che Trumbo riesce a realizzare in Eclipse: attacca con successo l’etica degli affari come punto di forza, presentando Abbott allo stesso tempo come campione e vittima del capitalismo della piccola città. Come afferma Bruce Cook, «John Abbott non è una caricatura. È un uomo a tutto tondo con la sua profondità, degno di ammirazione, e tuttavia distrutto dal sistema che accetta e dalla città nella quale crede».18 Uno degli scopi della scrittura di Trumbo è presentare un quadro della vita di Grand Junction, il flusso e riflusso degli eventi, le frustrazioni e le passioni soffocate. Ma non solo. Basti considerare le conversazioni tra Abbott e Hermann Vogel. Quest’ultimo è una sorta di via di mezzo tra un erudito amatoriale e un filosofo, persona incline a vedere le cose con uno sguardo freddamente intellettuale. È anche una sorta di alter ego di Trumbo stesso, o comunque il personaggio che più si avvicina al pensiero dello scrittore su Abbott e sugli abitanti della cittadina. Vogel inoltre presenta delle curiose somiglianze col Trumbo più maturo, spesso caustico nelle proprie opinioni (all’epoca della stesura Trumbo non ha ancora trent’anni, e sceglie come proprio contraltare nel romanzo il giovane reporter Freddy Kilner). Rivolgendosi a John Abbott, per esempio, Vogel dice: «Temo che morirai di piedistallite, vecchio mio, proprio com’è capitato al tuo archetipo».* E il suo archetipo, gli dice Vogel, è Napoleone, che si è espresso chiaramente affermando: “I vostri legittimi re possono essere sconfitti venti volte e tornare comunque ai loro troni. Ma io non sono che un soldato parvenu… e il mio trono poggia sui miei trionfi in battaglia”. Come afferma Cook: «(...) così veniamo invitati a vedere John Abbott come un uomo d’affari parvenu, uno che dentro la società e il sistema deve di continuo guadagnarsi il suo posto sul piedistallo con nuovi trionfi nel campo degli affari, e gesti di filantropia sempre più clamorosi. Dovesse vacillare, dovesse fallire nel produrre successi, verrebbe gettato nella polvere e non gli sarebbe nemmeno concessa la grazia dei Cento giorni che il destino ha offerto a Napoleone. (…) [Calandosi nella normalità di una cittadina del Colorado in pieno sviluppo la] grande legge del “cosa-hai-fatto-per-me-di-recente” prevale, e quando Abbott non riesce più a soddisfare l’insaziabile Moloch di Shale City, pochi gli mostrano un briciolo di compassione». 19 Nemmeno il suo amico Vogel, l’intellettuale immigrato, prova pietà per lui: «Io amo l’America», mormorò Hermann Vogel. «E non voglio tornarmene a casa. Non adesso, per lo meno. Non mi perderei questi momenti di gloria per tutto l’oro del mondo. È come… come immergersi in un bagno purificante. È come spulciare un cane, e veder cadere morti un milione di minuscoli insetti che lo hanno reso infelice Dio solo sa per quanto tempo. Ecco cosa succede all’America, amico mio. Le pulci vengono scacciate dal corpo della politica. Se ogni tanto una formica come te, o un ragno come me, ci rimangono secchi… be’, è un deplorevole incidente, ma un sacrificio che possiamo fare volentieri. Io, dal canto mio, sono quasi in estasi all’idea». Con allusioni e consigli come questi, e in una scena apertamente radicale nella quale un giovane “rosso” arringa la folla in un angolo di strada e canta l’Internazionale mentre gli sbirri lo portano via, Eclipse dimostra di essere un romanzo molto più spinto a sinistra di quanto ci si possa aspettare da Dalton Trumbo in questa fase della sua vita. Vediamo quindi che nel 1934, all’età di ventinove anni, l’autore è già fortemente avviato sulla strada del progressismo. Il protagonista di Eclipse è modellato direttamente dalla realtà. William J. Moyer (1859-1943) è un uomo d’affari di Grand Junction, un commerciante di cui il John Abbott di Trumbo è un fedelissimo ritratto. Il grande magazzino di Moyer, “The Fair”, chiude durante la Depressione, e la sua banca non riesce a ripartire dopo la chiusura del 1933. Anche la sua indole è molto coerente con quella di Abbott: mente aperta, generosità, grande impegno filantropico. Risponde a verità la donazione di una piscina alla città di Grand Junction, chiamata Moyer Natatorium, ed è proprio Elizabeth Trumbo, la sorella dello scrittore - all’epoca una bimba di sei anni - a farvi il primo tuffo nel giorno dell’inaugurazione. Tenendo conto di altri particolari, - il matrimonio traballante, le voci di una relazione duratura con una sua impiegata - la somiglianza è netta. Il popolo di Grand Junction che lo conosce ben sa che, punto per punto, John Abbott semplicemente è Moyer. E in molti si risentono di questo fatto, in primo luogo a causa di un particolare importante in cui Moyer differisce da Abbott: il commerciante è ancora vivo quando il romanzo viene pubblicato. Venendo a conoscenza del libro Moyer potrebbe quindi rimanerne ferito, il che urta, anche a distanza di anni, la sensibilità dei suoi concittadini. Lo stesso primo biografo di Trumbo, Bruce Cook, ben quarant’anni dopo gli eventi si scontrerà con un “muro di gomma” da parte di abitanti di Grand Junction che hanno conosciuto le persone descritte (con nomi diversi) nel romanzo. Il figlio del venditore di scarpe Benge - che sarebbe il figlio del Twinge del romanzo - è molto esplicito a questo riguardo nella breve conversazione con Cook. Nel visitare la biblioteca pubblica, però, il biografo si accorge che l’interesse per quelle vicende è ancora forte, se le copie presenti del romanzo sono sempre prenotate... In molti a Grand Junction considerano il John Abbott di Trumbo alla stregua di uno sgarbo nei confronti di W.J. Moyer. Tra questi c’è il vecchio capo dell’autore al Grand Junction Sentinel, Walter Walker, che nel romanzo corrisponde a Stanley Brown. Trumbo gli spedisce una copia autografata di Eclipse poco dopo la pubblicazione. Nella lettera acclusa, a proposito del romanzo osserva: In quanto a Eclipse, spero che non ti arrabbierai se vi troverai personaggi che potresti riconoscere. Sono convinto che tutti i romanzi si fondino su realtà che l’autore distorce per scopi narrativi, per assecondare le sue intenzioni. Non pretendo che i ritratti tracciati in Eclipse siano reali, anche se tu, ne sono sicuro, ravviserai almeno alcune caratteristiche dei loro contraltari nella vita reale. Non chiedo scusa, sebbene confessi di aver avuto qualche scrupolo. Ma il lavoro è compiuto, mi ha preso un bel po’ di tempo, e da quando ho saputo che una o due copie sono già arrivate a Grand Junction non ha senso tentare di nasconderlo. Ti allego una copia della recensione che è apparsa nello spocchioso supplemento letterario del «Times» di Londra, una recensione che, come puoi facilmente indovinare, mi ha reso estremamente felice. 20 Come dice Cook, la lettera, che termina «con stima, Dalton», potrebbe più francamente firmarsi «con ansia, Dalton», visto che il trentenne Trumbo è chiaramente a disagio all’idea della reazione di alcuni abitanti della cittadina in cui è cresciuto, e del proprio mentore Walter Walker in particolare. Il suo ex direttore, l’uomo che in sostanza l’ha avviato alla scrittura e allo stesso tempo lo incoraggia a considerare di dedicarsi alla carriera politica (lo farà, di fatto, anche se non per la via che prospettava Walker), risponde a Trumbo un mese dopo. Scrive più con dolore che con rabbia: Mio caro Dalton, […] non occorre dire che Eclipse ha causato un gran numero di commenti in città. Mentre nella tua lettera dici che non pretendi che i ritratti inseriti in Eclipse siano reali, tuttavia la gente che vive in una città adoperata come scenario per un romanzo o un racconto è incline ad accettare come reale ogni personaggio che pensa di riconoscere. Naturalmente, non provo sentimenti di rabbia nei tuoi confronti per via del libro. Dopotutto, è una tua precisa scelta quella di utilizzare la cittadina in cui hai vissuto per dimostrare il tuo talento, se ritieni che sia la cosa giusta. Inoltre, vedendola da un punto di vista egoistico, posso dire che non avrei motivo di lamentarmi visto che sono trattato molto correttamente nel libro. In tutta franchezza, però, con tutto il rispetto e l’affetto che ho per te e l’ammirazione per il tuo talento, mi dispiace che tu abbia sentito l’esigenza di rendere pubblica la vicenda proprio adesso. L’unica personalità coinvolta nel libro che mi spinge a dire questo è W.J. Moyer. Non gli si fossero accumulate contro sventure così pesanti e frequenti, e se non fosse ancora vivo, questo mio dispiacere sarebbe considerevolmente minore. Non posso esserne certo, ma credo che il libro sia ispirato da una qualche convinzione, vera o immaginaria, che tu o la tua famiglia abbiate subito un grande danno da parte di questa comunità e forse dall’uomo che tu chiami John Abbott, e in tal caso certamente non tenterò di condannare la tua opera. con stima, W.W. Il pensiero diffuso nella cittadina del Colorado è che Trumbo abbia scritto il romanzo sull’onda del risentimento, ed è probabile che ciò sia vero, almeno nelle sue linee generali. Walter Walker non erra, in altre parole, nel presumere che Eclipse sia ispirato dalla sensazione che Dalton Trumbo e la sua famiglia avessero subito «un grande danno da parte di questa comunità». In effetti soprattutto il padre di Trumbo, Orus, era stato trattato malamente, avendo a carico moglie e tre figli ancora molto giovani. Cook si chiede: «Ma, nello specifico, ciò è stato provocato dall’uomo chiamato John Abbott? Questa interpretazione - molto popolare a Grand Junction - non sta in piedi. Lascia presumere che il ritratto che Trumbo fa di Moyer come John Abbott manchi di empatia, cosa che non è vera. Trumbo lo presenta anzi come l’uomo di maggior decoro in città, una persona fortunatamente libera dall’ipocrisia che domina. Eclipse è un genuino sforzo di comprendere un uomo e il suo rapporto con la città nella quale vive». 21 Qual è allora la ragione secondo la quale gli abitanti di Grand Junction si mostrano irati col libro e con l’autore? Lo stesso Trumbo, conversando con Cook, afferma: «In realtà ciò che odiavano del libro è il fatto che si trattasse di un attacco nei loro riguardi, nei riguardi di una città falsa. Tutti potevano prendere tanto da un uomo, leccargli così apertamente il culo, e poi girargli le spalle come se niente fosse. Ed è questo che non mi è andato giù».22 L’interesse verso Moyer si può leggere anche come spunto autobiografico. Trumbo lo collegava idealmente al padre Orus, maltrattato in varie occasioni dalla cittadina, col licenziamento dal negozio di calzature Benge come apice, dopo anni di fedele servizio; evento che ha costretto la famiglia a emigrare verso la California. L’autore vede questo passaggio della vita del genitore come l’inizio della sua fine, avvenuta in effetti dopo pochi anni a Los Angeles. «Forse posso aver reagito a questo fatto in modo meno corretto di quanto avrei potuto. Ma quando ho riflettuto sul destino che è toccato al signor Moyer dopo la Depressione - ne ero al corrente seguendo la vicenda sul giornale di Grand Junction - ho potuto concludere che è in pratica la stessa circostanza: si tratta di un uomo distrutto», afferma ancora Trumbo.23 Solo nel 2005, a settant’anni dall’uscita e nel centenario della nascita dello scrittore, un’associazione di biblioteche del Colorado decide di ripubblicare il romanzo sancendo così una sorta di riappacificazione col suo antico esponente cittadino. Shale City continuerà a essere luogo simbolico importante nella creazione di Trumbo, dal momento che tornerà anche in altri romanzi, primo fra tutti Johnny Got His Gun. La trasfigurazione letteraria sopravvive nel tempo grazie alla creazione narrativa, mentre i modelli reali, col passare degli anni, sbiadiscono insieme al ricordo degli ultimi che hanno vissuto quell’epoca. Il riferimento quindi a persone e luoghi di Grand Junction del periodo appena precedente alla stesura (il plot segue l’arco temporale 1926-1933) oggi appare come un mero esercizio, ma viene svolto con scrupolo nella prefazione all’edizione originale Mesa County Public Library Foundation, alla base di questa edizione italiana. Si illustrano così i corrispettivi reali di molti personaggi e luoghi che appaiono nel romanzo. Il protagonista, John Abbott, come ricordato, è basato su William J. Moyer, proprietario di un emporio di successo chiamato “The Fair Store” (qui ribattezzato semplicemente “The Emporium”), aperto dopo il suo arrivo a Grand Junction nel 1890, diventato presto di discreta grandezza. Lui e la moglie Ida non hanno figli, ma crescono come tale il nipote William Weiser (nel romanzo è Gerald Abbott). Tra le benemerite azioni filantropiche verso la cittadina, Moyer fa costruire una piscina pubblica nel 1922, in memoria di un giovane, figlio di un suo impiegato, annegato nel Colorado River. Il vero Moyer muore non più molto abbiente dopo la crisi dovuta alla Depressione: il negozio è chiuso da tempo, così come la banca da lui fondata (situazioni riprodotte nel romanzo, anche se l’Emporio va incontro a una fine si può dire definitiva anche come luogo fisico). Il negoziante di scarpe, Bertram M. Benge, fondatore di Benge’s, ditta tuttora in attività a Grand Junction, è il modello per Harry Twinge; il padre dello scrittore lavora in questo negozio per molti anni, prima di venirne licenziato. Violet Budd, la beghina sempre in prima fila per qualche battaglia moralistica, si chiamava Emma Budilier. Il reverendo Forsythe è lo Slocum del romanzo, mentre Maria Telsa “la zoppa” (Stumpy Telsa) si chiamava “Broken Jaw Nell” Paige, il cui soprannome derivava da un’ampia ferita alla mascella provocata da uno sparo (nel romanzo i colpi feriscono le gambe, da cui il nomignolo). L’Hermann Vogel del romanzo è basato sul professore di storia Hydle, ma è anche la “voce” di Trumbo stesso, mentre l’autore si raffigura nell’apprendista reporter Freddy Kilner. Il giovane Phil Haley, che Abbott assume all’Emporio dopo un furto perpetuato “per necessità” nella banca cittadina, in realtà è Bernard Woolverton. Il tuttofare italiano “Me-catch-me-kill” (qui reso “Chiappammazza”) era un tizio conosciuto come “Old Santa Claus Smith”. La signorina Eva Septimus, insegnante, è ricalcata su Julia Taylor (docente di latino) e sulla comproprietaria di appartamento di Belle Lay (la vera Donna Long), una certa signorina Wilson. L’energico Henry Wilhelm, animatore della YMCA, si chiamava Webber. Fred Best è Harold Wolverton. Walter Goode è D.B. Wright, anch’egli agente immobiliare come il suo corrispettivo. Art French è Sterling D. Lacy. Richard Maesfield, ricordato in un flashback da Abbott come “vittima” del progresso di Shale City, si chiamava J. Talbott. La Mildred Wessingham del romanzo è Edith Wickersham (vera la vicenda del ricatto a Moyer/Abbott). Hermann Schonk è A.E. Carleton. Merle McClintock, che lavora al «Sentinel», è il modello di Claudia McQuaid. Il dottor Lawrence, medico personale di Abbott, è il dottor Day. La caffetteria della signora Alloway è in realtà quella della signora Glessner. George Boone, infine, è Bill McGuire, vero assistente direttore del “Fair Store”. L’autore immette varie considerazioni autobiografiche, sparse tra diversi personaggi. Esplicitamente, data l’età, si immedesima in Freddy Kilner, giovane reporter (Trumbo ha svolto la stessa attività negli anni di Grand Junction); Gerald Abbott viene definita persona dall’ottima oratoria (l’autore era “campione” giovanile di questa disciplina); il racconto degli assegni di Phil Haley è un evento narrato dallo stesso Trumbo a Cook e riportato nella biografia dell’autore. Per finire il professor Vogel ha molti aspetti curiosamente anticipatori del Trumbo maturo. NOTE (1) Termine coniato dal nome del senatore conservatore repubblicano Joseph McCarthy, che riveste un ruolo importante tra gli anni 1950 e 1954 ma non nella prima fase (dal 1947) in cui è coinvolto Dalton Trumbo. (2) Tratto da Sciltian Gastaldi, Fuori i rossi da Hollywood! - Il maccartismo e il cinema americano, Torino, Lindau, 2004, pp. 99100. (3) Fuori i rossi..., op.cit., pp. 98-99. (4) Stewart è un drammaturgo oltreché sceneggiatore, e al cinema vince l’Oscar per The Philadelphia Story (1940; Scandalo a Philadelphia, regia di George Cukor, con Katharine Hepburn e Cary Grant). È entrato nella blacklist nel 1950. Foreman scrive il classico e premiato western High Noon(1952; Mezzogiorno di fuoco, regia di Fred Zinnemann, con Gary Cooper). Proprio durante le riprese del celeberrimo film è chiamato dal Committee. Prima di vedersi incriminato e farsi portare via il passaporto, riuscirà ad approdare a Londra. (5) Dalton Trumbo, Lettere dalla guerra fredda - Il dramma del maccartismo narrato da un grande sceneggiatore cinematografico, Milano, Bompiani, 1972, pp. 54-55 (traduzione di Franca Pirozzi di un’edizione parziale di Additional dialogue, 1970). Qui, come in altri passi tratti dalla medesima edizione, la traduzione originaria è aggiornata tenendo conto del testo inglese. (6) Lettere dalla guerra fredda, op.cit., p.72. (7) Oltre al nome del protagonista del suo primo romanzo Eclipse, “John Abbott” è anche quello di un personaggio di A Man to Remember, film RKO scritto da Trumbo nel 1938, per la regia di Garson Kanin. (8) Lettere dalla guerra fredda, op.cit., p.74. (9) Bruce Cook, Dalton Trumbo, New York, Charles Scribner’s Sons, 1977, pp. 259-260 (ed.it. L’ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo, Milano, Rizzoli, 2016, pp. 329-330; traduzione di Mauricio Dupuis e Cecilia Martini). (10) Lettere dalla guerra fredda, op.cit., pp. 179-180. Di questi progetti degli anni 1957-58 vanno in porto Terror in a Texas Town (Il terrore del Texas, United Artists), la “ripulitura” del film di John Huston Heaven Knows, Mr.Allison (L’anima e la carne) e il film con Anna Magnani Wild Is the Wind (Selvaggio è il vento). Per i fratelli King lavora al non realizzato Mr. Adam. (11) Ibid., pp. 185-186. (12) La vicenda è narrata dallo stesso Douglas in I am Spartacus! Making a Film, Breaking the Blacklist, Open Road Media, 2012 (ed.it. Io sono Spartaco!, Il Saggiatore, 2013). Solo Douglas e pochissime altre persone sanno che Trumbo è il reale autore del copione, e così sarà anche durante la fase di montaggio. Douglas narra, a testimonianza di questo, che lo scrittore viene portato alla Universal in incognito (nascosto sotto un lenzuolo nel sedile posteriore di un’auto) a visionare un primo montaggio grezzo del film. (13) Il film in questione sarà girato nel 1974, ma con diversi integranti al progetto. (14) Premio che dal 1950 si chiamerà National Book Award. (15) Trumbo, Lettere dalla guerra fredda, op.cit., pp. 8-9. (16) Bruce Cook, Dalton Trumbo, op.cit., pp. 96-97 (ed. it., pp. 125127). (17) Ibid., p. 25 (ed.it., pp. 37-38). (18) Ibid., p. 80 (ed.it., p. 106). (19) Ibid., p. 81 (ed.it., pp. 106-107). (20) Il passo della lettera, in Cook, Dalton Trumbo, op.cit., pp. 82-83 (ed.it., p. 108). La recensione non firmata del supplemento letterario del «Times» questo riporta riguardo il romanzo: «(...) In Eclipse Dalton Trumbo ha fatto di più che scrivere un romanzo ben costruito e interessante sulla vita moderna. Grazie alle implicazioni della vicenda giunge a criticare l’etica, sociale e commerciale, di una media città americana. Nei suoi ultimi giorni John Abbott richiama la nostra compassione; ma non ne riceve - con una singola eccezione - dalle molte persone che hanno tratto beneficio da lui. Una volta che il suo prestigio inizia a scemare, uomini e donne che così altruisticamente ha aiutato gli si rivoltano contro. È nella trattazione dell’abbandono che poggia la sostanza dell’attacco di Trumbo. È pur vero che uno dei personaggi secondari, Hermann Vogel, dà voce a quelle che sono probabilmente le opinioni dell’autore stesso, ma le sue analisi sono meno efficaci rispetto al fatale sviluppo della vicenda. Trumbo è con ogni evidenza ammiratore dei romanzi di Sinclair Lewis e potrebbe forse meritare, un giorno, di esserne degno successore». (21) Cook, Dalton Trumbo, op.cit., p. 84 (ed.it., p. 110). (22) ibid., p. 84 (ed.it., pp. 110-111). (23) ibid., p. 84 (ed.it., p. 111).