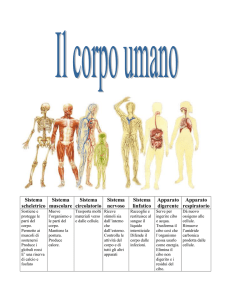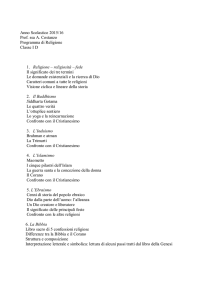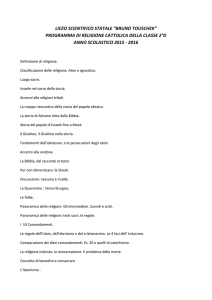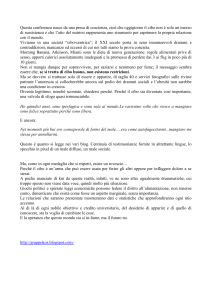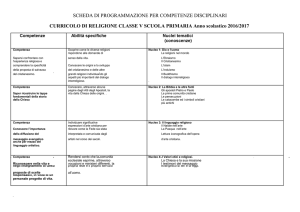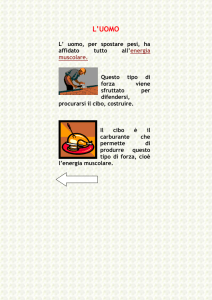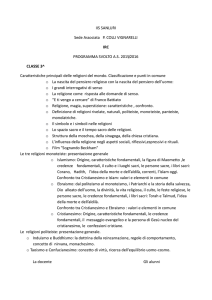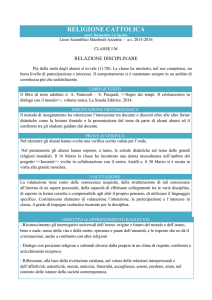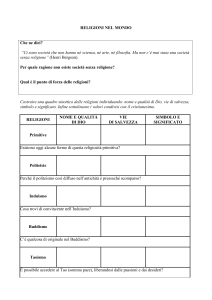caricato da
common.user12537
Cibo e Religioni Monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Islam

FOCUS I Il cibo nelle tre religioni monoteiste l rapporto delle religioni con il cibo è spesso complesso e regolato da norme dettagliate. In questo dossier analizzeremo il cibo nelle tre religioni monoteiste del Mediterraneo. Ebraismo. Per gli ebrei, come abbiamo accennato nella UD 4.6, è regolato da una serie di leggi piuttosto complesse. Nella Bibbia ci sono prescrizioni molto dettagliate al riguardo, regolamentate e ampliate dai rabbini lungo i secoli. «Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse loro: “Parlate agli Israeliti dicendo: Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Potrete mangiare ogni quadrupede che ha l’unghia bipartita, divisa da una fessura, e che rumina. Ma fra i ruminanti e gli animali che hanno l’unghia divisa, non mangerete i seguenti: il cammello, perché rumina, ma non ha l’unghia divisa, lo considererete impuro; l’iràce perché rumina, ma non ha l’unghia divisa, lo considererete impuro; la lepre, perché rumina, ma non ha l’unghia divisa, la considererete impura; il porco, perché ha l’unghia bipartita da una fessura, ma non rumina, lo considererete impuro”» (Levitico 11). Inoltre sono proibiti tutti gli animali selvatici e i rapaci, quelli che strisciano, i crostacei, i molluschi e i frutti di mare. Le prescrizioni alimentari ebraiche sono contenute nei 613 comandamenti (mitzvòt) che proibiscono, tra l’altro, di mangiare insetti (154°), di bere sangue (167°) e, ovviamente, di essere golosi (169°). È anche vietato mescolare le carni con latte e derivati, cosa che vale anche per l’uso degli oggetti di cucina. La carne degli animali considerati puri può essere consumata solo se prima viene macellata ritualmente (kashèr), immersa nell’acqua per mezz’ora, quindi sotto sale per un’ora e poi risciacquata. Discorso analogo vale anche per le bevande: ad esempio, sono proibiti i vini provenienti da vigneti non kashèr.1 Tutte queste prescrizioni formano la kasherùt, cioè l’insieme delle regole alimentari della cucina ebraica, che esprime anche il modo di vivere e di essere ebrei. U na r ic e t ta e b r ai ca: ORECCH IE D I H AM AN Per 25/30 dolcetti: 300 g di farina, 150 di zucchero, 2 uova, ½ bustina di lievito, 2 cucchiai d’olio, sale. Per il ripieno: marmellata del gusto preferito, succo d’arancia, pinoli. Preparate la pasta amalgamando la farina, zucchero, uova, olio, un pizzico di sale, buccia grattugiata del limone e lievito. Fate riposare 10 minuti. Intanto ammorbidite la marmellata con un po’ di succo d’arancia e amalgamatela con un po’ di pinoli. Stendete la pasta a sfoglia (spessore di 1/2 cm), ritagliatevi tanti dischetti (diametro 8/9 cm). Su ognuno mettete al centro un po’ di marmellata e chiudete a triangolo in modo che si veda un po’ di ripieno. Cuocete in forno caldo a 190° per circa 15 minuti. 1 Per l’elenco dettagliato dei cibi kashèr in Italia vedi http://www.morasha.it/pagineoro/prodotti.html. Per Pesach, la Pasqua ebraica, che ricorda la liberazione dall’Egitto, la tradizione prevede tutta una serie di preparativi molto particolareggiati. Per gli otto giorni della festa (fissata in primavera, secondo il calendario lunare) in casa non deve esserci nessun cibo lievitato (chametz). Per questo la ricerca delle briciole di pane da bruciare il giorno della vigilia, che avviene la sera prima e coinvolge l’intera famiglia, ha un valore «rituale». Sempre alla vigilia, in ricordo dell’uccisione dei figli degli egiziani, i primogeniti digiunano. Avviene prima della festa anche il banchetto con azzimi, erbe amare e altri cibi detto Seder, che comprende l’Haggadah (il racconto della fuga) a ricordo del pasto fatto nei tempi antichi.2 Cristianesimo. Nella tradizione cristiana non sono previste regole particolari riguardanti gli alimenti; il discorso si basa sulla libertà e responsabilità personali, piuttosto che sulla legge e le regole. In questo modo il cristianesimo si differenzia dalle altre due tradizioni monoteistiche anche per una visione di completa libertà nei riguardi del cibo, svincolato dalle rigide regole ebraiche e islamiche, ma anche dal vegetarianismo e da altre forme simili. Ciò non toglie che il cibo, soprattutto con il banchetto eucaristico in cui il pane e il vino hanno assunto un significato sacramentale, ha un ruolo centrale nel cristianesimo. Gesù stesso, di fronte alle critiche dei suoi correligionari che accusano i discepoli di non rispettare le regole imposte dall’ebraismo, risponde che è più importante rispettare i comandamenti di Dio che certe regole della tradizione, ridotte a pura formalità: «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro» (Marco 7,14). Questa forte presa di posizione di Gesù contro una tradizione che non comprende più il vero spirito della Legge (Torah) ha condotto il cristianesimo a distinguersi da un ebraismo troppo formale. Questo, all’inizio, non ha mancato di provocare forti contrasti (cf. Atti degli apostoli 15,22-30), ma alla fine è prevalsa la linea di non imporre alcuna regola sul cibo, così come su altre tradizioni ebraiche (per esempio la circoncisione per i maschi). L’unica proibizione legata al cibo, presente nel cristianesimo, è il divieto di mangiar carne al venerdì, il giorno della morte in croce di Gesù; ma dal 1966, questo divieto nella tradizione cattolica è stato limitato ai venerdì di Quaresima, al Mercoledì delle Ceneri e al Venerdì santo, in questi due giorni accompagnato anche dal digiuno. Nella tradizione ortodossa, invece, l’astinenza dalle carni è tuttora prescritta per tutti i mercoledì e venerdì dell’anno. In U na r ic et ta cr i s t i an a: I dolc i di san Fr ancesco Ingredienti: 200 g di farina; 200 g di mandorle; 150 g di miele; 2 albumi; una noce di burro; un pizzico di lievito in polvere; cannella; sale e pepe. Si impasta, si stende a sfoglia spessa, si taglia a rombi e si cuoce in forno caldo per 15 minuti. Questa ricetta è detta dei dolcetti di san Francesco o mostaccioli. Racconta la Leggenda perugina che li preparò per lui la nobile romana Jacopa dei Settesoli. Informata sulle sue gravi condizioni di salute, Jacopa arrivò ad Assisi e gli portò i dolcetti. «Ed egli riuscì appena ad assaggiarli perché le forze ormai lo abbandonavano». Sorella morte arriverà per lui due giorni dopo, il 4 ottobre 1226. Famiglia Cristiana, 14 dicembre 2014, 18 2 Cf. M. Salani, A tavola con le religioni, EDB, Bologna 2007. alcuni movimenti di derivazione cristiana, come gli Avventisti del Settimo Giorno, è espressamente proibita la carne di maiale. Per quanto riguarda le bevande, nessuna è proibita, ma si raccomanda di usare tutti gli alcolici con moderazione (Luca 21,34). Islam. Come accennato nell’UD 4.14, per quanto riguarda il cibo la tradizione islamica riprende in gran parte quella ebraica, di cui conserva le caratteristiche principali. Anche nell’islam il cibo deve essere halal, cioè «lecito»: «Vi è proibito l’animale trovato morto, il sangue, la carne di maiale, […] l’animale soffocato, l’animale morto per una botta o per una caduta o per un colpo di corno...» (sura 5,3). Sono invece espressamente proibiti (harâm): aquile, tigri, lupi, leoni, cani, gatti, topi, scimmie, balene, tartarughe, carnivori, maiali (e tutti i suoi derivati), animali morti di morte naturale, e tutti gli animali non macellati ritualmente e non consacrati ad Allah, crostacei, carne cotta nell’alcool. La macellazione rituale prevede che l’animale venga sgozzato, così che il sangue scoli completamente dal suo corpo. Nella cucina islamica ha un posto importante l’agnello. Nel Giorno del Sacrificio (Aid el Kabir) si ricorda la fede assoluta nel Dio unico, al quale Abramo era disposto a sacrificare Ismaele (e non Isacco, come vuole la tradizione biblica). Il sacrificio del primogenito, che Dio poi sostituisce con un montone, è ricordato con una preghiera comunitaria in moschea e un banchetto in famiglia a base di agnello, macellato secondo le regole rituali. Una parte dell’animale viene destinata ai poveri. Per quanto riguarda il fumo e l’alcol, il Profeta proibì l’assunzione di bevande inebrianti perché turbavano l’ordine pubblico, soprattutto durante i pellegrinaggi, ma si discute ancora oggi se il Profeta volesse proibire l’ubriachezza o semplicemente l’assunzione di ogni tipo di bevanda fermentata e ogni tipo di fumo. insieme • Per approfondire il tema del rapporto delle tre religioni monoteiste con il cibo si consigliano i tre libretti di M. Salani, A tavola con le religioni: ebraismo, cristianesimo e islam, EDB, Bologna 2015. U na r ic e t ta mu s u l m an a: I dolcetti di Ramadan Ingredienti: 1 kg di farina; 2 kg di miele; 300 g di sesamo; 150 g di burro; 1 uovo; 1 cucchiaino di aceto; 1 cucchiaino di acqua di fiori d’arancio; 1 cucchiaino di cannella; un pizzico di zafferano, 15 g di lievito; sale; olio per friggere. Impastare la farina con metà semi di sesamo, l’uovo sbattuto, l’aceto, la cannella, lo zafferano, il burro sciolto in un bicchiere di acqua tiepida. Suddividere l’impasto in tanti panini e lasciarlo riposare per 20 minuti. Stendere la pasta, tagliare delle strisce, formare delle trecce e unire le due estremità. Farle friggere nell’olio (chiedere l’aiuto di un adulto) e poi immergerle nel miele sciolto assieme all’acqua di fiori d’arancio. Infine cospargere le trecce di semi di sesamo.