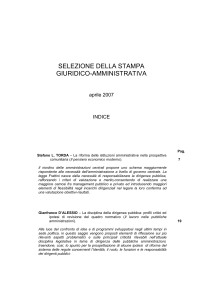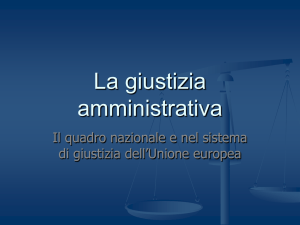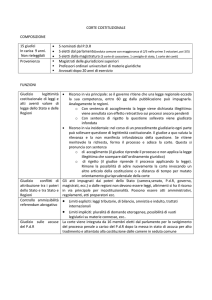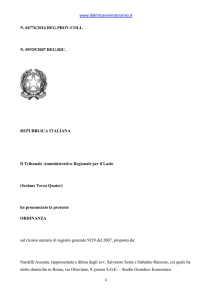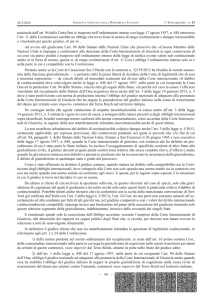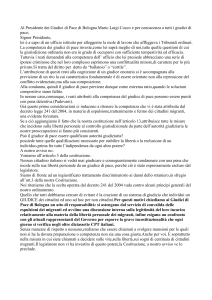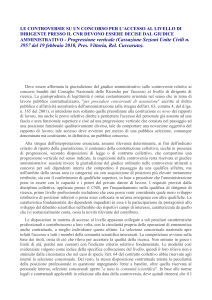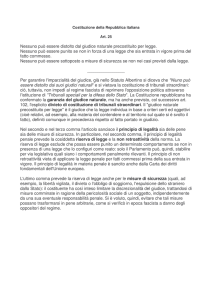caricato da
common.user2272
Diritto Amministrativo: La Formazione del Sistema di Tutela

PARTE I Capitolo 1 La formazione del sistema I pilastri fondamentali del sistema delle tutele giurisdizionali nei confronti dell’amministrazione sono stati eretti nella seconda metà del diciannovesimo secolo, con le leggi del 1865 e del 1889. Con la prima è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario (l’unico allora esistente) per la soluzione delle controversie coinvolgenti l’amministrazione pubblica; è stata cioè operata la scelta della tutela giurisdizionale, abbandonando il precedente sistema della tutela amministrativa contenziosa. Con la seconda è stato creato un organo collegiale, la IV Sezione del Consiglio di Stato, che sarà in seguito riconosciuto come organo avente natura giurisdizionale; è stato cioè affiancato al giudice ordinario il giudice amministrativo, dando così luogo al sistema binario. Su tali pilastri poggia ancora oggi il sistema della giustizia amministrativa. Ovviamente, vi sono stai notevoli cambiamenti nel tempo. Sezione prima: La scelta giurisdizionale 1. L’abolizione dei Tribunali ordinari del contenzioso amministrativo Realizzata nel 1861 l’unità d’Italia, il Parlamento pose immediatamente mano all’unificazione della legislazione amministrativa; e, alla soluzione del problema della tutela dei cittadini nei confronti dell’amministrazione. Originariamente, non si ammetteva, per via di un’interpretazione rigorosa del principio della separazione dei poteri, che l’amministrazione potesse essere “trascinata” davanti agli organi giurisdizionali. Il problema della tutela dei cittadini era stato risolto facendo ricorso al sistema del “contenzioso amministrativo”, che era stato introdotto in Italia al tempo della conquista napoleonica, sul modello del sistema francese. Le controversie con l’amministrazione erano devolute ai Tribunali del contenzioso amministrativo, organi collegiali aventi natura amministrativa e inseriti, sia pure con qualche garanzia di indipendenza, nella organizzazione del Potere esecutivo. Nel Regno di Sardegna, tali Tribunali erano, in primo grado, il Consiglio di Governo, e, in secondo grado, il Consiglio di Stato, o, nelle materie di contabilità pubblica, la Corte dei conti. Dopo l’unità (con l’espansione del Regno di Sardegna), rimasero transitoriamente in vigore i sistemi di tutela degli Stati preunitari. Il dibattito parlamentare postunitario si concentrò sul mantenimento o, alternativamente, sull’abolizione del sistema del contenzioso amministrativo. Nell’esperienza dell’Europa continentale si era nel frattempo affermato un modello alternativo: con la costituzione belga del 1831 le controversie con l’amministrazione erano state deferite al giudice (ordinario), al pari di ogni altra controversia. A questo modello si ispirarono coloro che aderivano alle tesi del c.d. costituzionalismo liberale; che aveva tra i suoi principali obiettivi l’abolizione del contenzioso amministrativo e l’affermazione della “giurisdizione ordinaria e universale”. Il dibattito parlamentare sul sistema delle tutele nei confronti della p.a. non poté essere concluso, per l’imminenza della guerra contro l'Impero austro-ungarico (3° guerra d’indipendenza). Furono concessi i pieni poteri all’Esecutivo, il quale approvò la legge n. 2248/1865, di unificazione amministrativa, utilizzando i testi in discussione dinanzi al Parlamento. Insieme all'amministrazione locale, alla sicurezza e alla sanità pubbliche, ai lavori pubblici, disciplinava il Consiglio di Stato e il contenzioso amministrativo. Inoltre, detta legge, disponeva l’abolizione dei Tribunali ordinari del contenzioso amministrativo; stabiliva che “tutte le cause per contravvenzioni e tutte le cause nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico” fossero deferite al giudice (ordinario). 2. I tratti essenziali della riforma del 1865 Qualsiasi diritto soggettivo, vantato dal cittadino nei confronti dell'amministrazione, aveva acquisito la tutela giurisdizionale, e non doveva più limitarsi ad ottenere tutela solo in sede di contenzioso amministrativo. Nella locuzione “diritto civile o politico”, erano compresi tutti i diritti soggettivi. La cognizione del giudice (ordinario) era pertanto estesa a qualsiasi controversia su diritti soggettivi. Il principio della separazione dei poteri, superato quanto all’ambito della giurisdizione, tornava ad avere rilievo nella previsione delle azioni esperibili e dei poteri di decisione del giudice. Il giudice non poteva annullare, revocare o modificare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi; se li riteneva non “conformi alle leggi” li disapplicava, ossia non ne teneva conto nella decisione. Inoltre, era stabilito l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione del giudice. Tale obbligo, sul quale si aprì una forte polemica tra gli studiosi, non era presidiato da alcuna sanzione. Il vuoto sarà poi colmato con la legge del 1889. La riforma, riferendosi a diritti soggettivi, lasciava numerose controversie con l’amministrazione fuori dall’ambito della giurisdizione; ed essendo stati aboliti i Tribunali del contenzioso amministrativo, tali controversie potevano essere risolte solo mediante i ricorsi amministrativi. Era inoltre prevista la possibilità di esperire il ricorso (straordinario) al Re, che veniva deciso dal Consiglio di Stato. In definitiva, con la legge del 1865, era stata assicurata la tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi, e si era lasciata per gli altri “affari” amministrativi quel tanto di tutela che poteva essere assicurata dalla stessa amministrazione attiva in sede di ricorsi amministrativi, ordinari e straordinario; non più con il sistema del contenzioso amministrativo. 3. L’attuazione della riforma Tra i giuristi del tempo si ebbe netta la sensazione che fosse stato risolto in modo completo e definitivo il problema della tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione. Vi era, infatti, la convinzione che la tutela giurisdizionale potesse essere predicata solo a garanzia dei diritti soggettivi: in assenza di diritto soggettivo non era concepibile alcun intervento del giudice. Il carattere parziale della riforma apparve a tutti evidente a ragione del modo timido e restrittivo nel quale essa fu attuata. Da un lato il giudice ordinario non fece alcunché per conferire alla sua azione quell’ampiezza e quell’efficacia che la legge avrebbe consentito. D’altro lato il Consiglio di Stato, che aveva il compito di risolvere i conflitti di attribuzione, tra organi amministrativi e giurisdizionali, contribuì a ridurre l’ambito della tutela giurisdizionale. Il Consiglio di Stato iniziò ad elaborare la tesi secondo cui, quando la controversia riguarda provvedimenti amministrativi essa non può avere ad oggetto diritti soggettivi; e quindi non rientra nell’ambito della giurisdizione. Tale interpretazione era in contrasto con la legge, che considerava l’ipotesi di controversie riguardanti diritti e ad un tempo coinvolgenti provvedimenti amministrativi, ma essa doveva corrispondere a convinzioni radicate ed estese, se si considera che, trasferita, nel 1877, alla Corte di cassazione di Roma la competenza a risolvere i conflitti di attribuzione, l’orientamento cambiò poco. Si riconosceva al giudice (ordinario) la giurisdizione quasi esclusivamente in tema di attività di diritto privato (atti iure gestionis) dell’amministrazione, con esclusione dell’attività di diritto pubblico (atti iure imperii). Nella veste di Tribunale dei conflitti, la Corte di cassazione di Roma (che decideva a Sezioni Unite), avrebbe potuto assumere un atteggiamento diverso, affermando la giurisdizione in tutti i casi in cui la controversia riguardava diritti soggettivi, e non negandola quando la controversia coinvolgeva provvedimenti amministrativi. Se non lo fece è perché anch’essa aveva convinzioni di fondo, che non erano molto diverse da quelle del Consiglio di Stato. L’attuazione riduttiva della riforma rese chiaro che, non solo gli interessi non riconosciuti come diritti soggettivi, ma anche questi ultimi, quando su di loro svolgeva qualche influenza un provvedimento amministrativo, rimanevano privi di tutela giurisdizionale. 4. Il quadro teorico La riforma del 1865, sul piano teorico, si scontrava con la visione allora prevalente dei rapporti tra l’amministrazione e il cittadino. L’amministrazione era intesa come autorità, espressione della sovranità: i suoi organi dovevano poter perseguire l’interesse pubblico senza trovare ostacoli di sorta. Nella sfera entro la quale si esercitava il potere non vi era posto per i diritti dei cittadini: sussistevano, più nelle convinzioni teoriche che nel diritto positivo, due sfere separate e non sovrapposte, l'una riservata al potere dell’amministrazione, l’altra riservata ai diritti dei cittadini. Le due sfere erano delimitate dalle leggi, dalle quali potevano derivare, in modo rigorosamente alternativo, o il “potere amministrativo” o il diritto soggettivo del cittadino. Nel primo caso si escludeva che dalla legge (le “leggi amministrative”) potessero derivare “diritti nel senso proprio e strettamente giuridico di questa parola”; ne potevano derivare semplici “interessi”. Quindi, i diritti civili e politici, fondati sulle “leggi politiche e civili”, non potevano collidere con il potere amministrativo, fondato a sua volta sulle “leggi amministrative”; cosicché la tutela dei diritti non poteva che essere limitata ai casi in cui l’autorità amministrativa agiva in violazione delle leggi civili e politiche, senza potersi estendere alla violazione delle leggi amministrative. Le leggi amministrative attribuivano poteri all’amministrazione, e ciò escludeva necessariamente la contemporanea attribuzione di diritti ai cittadini. L’assenza di diritti soggettivi comportava l’assenza di tutela giurisdizionale. Sembrava necessario che le controversie relative alla sfera, caratterizzata dall’esistenza (e dall’esercizio) di poteri amministrativi, fossero sottratte alla cognizione del giudice e lasciate alla cognizione dell’amministrazione, che vi provvedeva mediante l’esame e la decisione dei ricorsi amministrativi. Di contro, le leggi civili e politiche attribuivano diritti soggettivi ai cittadini, e di conseguenza non attribuivano poteri all’amministrazione. In questo caso veniva assicurata la tutela giurisdizionale. L’enorme numero di conflitti di attribuzione dimostra che il quadro teorico era profondamente difettoso. Valutando la riforma del 1865 si può convenire con il Salandra, il quale riteneva che con essa, che costituiva la prima risposta unitaria al problema della tutela nei confronti dell'amministrazione, fu dato rilievo alle libertà civili, personali e patrimoniali. 5. Il movimento per lo “giustizio nell’amministrazione” Nell'allora generalmente condiviso, ma obiettivamente inadeguato, impianto teorico che le fece da supporto, sta il limite della riforma del 1865. Il mondo politico, si rese presto conto di non aver prestato sufficiente attenzione alla tutela dei “diritti minori”, o “diritti meno perfetti”, o “diritti che sono subordinati alle considerazioni della utilità pubblica”, ossia ai “diritti” nascenti dalle "leggi amministrative”. Nel corso degli anni tali “diritti minori” erano venuti crescendo di numero e di rilievo economico, in dipendenza dell’allargamento delle funzioni amministrative e della sfera dei poteri discrezionali. L’esigenza di una nuova riforma si manifestò nelle aule parlamentari quasi immediatamente dopo il 1865, e venne rapidamente crescendo nel tempo. L’accelerazione ulteriore fu dovuta ad un accadimento politico, che di per sé era del tutto estraneo al problema della giustizia amministrativa. Nel 1876 cadde il Governo della Destra, durato ininterrottamente dall’Unità. L’allontanamento dal Governo comportò tuttavia una rinnovata attenzione al problema della tutela nei confronti dell’amministrazione, tanto che gli uomini della Destra lo inserirono al primo posto del loro programma politico. Si determinò un movimento per la "giustizia nell’amministrazione”, i cui uomini di punta furono Marco Minghetti e Silvio Spaventa. Si riteneva di porre un freno ai favoritismi e alle parzialità allargando la possibilità di reagire contro gli atti dell’amministrazione: si chiedeva di “completare l’opera del 1865 ”, con la quale il legislatore, “abolendo radicalmente la giurisdizione amministrativa, privò molti interessi di qualsiasi garentia di giustizia, e lasciò molti diritti senza più giudice in balia dell’amministrazione”. Completare la riforma del 1865, non stravolgerla: nonostante la timida prova che aveva fornito il giudice (ordinario), nessuno pensava che si potesse tornare indietro rispetto alla soluzione con tale legge affermata; la quale, per aver compiuto l’unificazione amministrativa, prese ad essere considerata “come una tavola fondamentale” e fu portata “sul piano del mito”. Sezione seconda: La giustizia nell’amministrazione 1. Le leggi Crispi del 1889 Al problema dell’estensione della tutela giurisdizionale, fu data soluzione per opera di un Governo almeno formalmente riferibile alla Sinistra, e presieduto da Francesco Crispi. Fu varata la legge n. 5992/1889. In effetti, veniva modificata l’organizzazione interna del Consiglio di Stato, già allora autorevole organo amministrativo, con l’istituzione, accanto alle prime tre, della Quarta Sezione, denominata “per la giustizia amministrativa”. Quest’ultima, era chiamata a “decidere i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione ed alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali”. I caratteri di quello che era destinato a divenire il processo amministrativo: ricorso di impugnazione di atti o provvedimenti, per farne valere i vizi di legittimità, a tutela di “interessi” individuali, diversi dai diritti soggettivi. La scelta della tutela (soltanto) successiva all’azione amministrativa, nella forma della impugnazione di “atti e provvedimenti”, sembrava adeguata ad assicurare la giustizia nell’amministrazione, e ad evitare i favoritismi e le parzialità, senza intralcio per il normale svolgimento dell’attività amministrativa. Coerentemente con questa impostazione vennero sottratti alla nuova forma di tutela gli “atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio di un potere politico”. La nuova legge indicava espressamente i motivi di ricorso, fissando la causa petendi del giudizio, e contemporaneamente ponendo la base per l’elaborazione della disciplina dell’invalidità dei provvedimenti amministrativi, risolvendola nella annullabilità per vizi di legittimità. Non veniva invece approfondita la nozione di “interesse”: non si sapeva bene in cosa esso consistesse dal punto di vista giuridico; ed era sufficiente, per identificarlo in concreto, che non risultasse essere diritto soggettivo. Al sindacato di legittimità si aggiungeva, in limitati casi, il sindacato di merito: uno dei casi riguardava l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al “giudicato” dei tribunali ordinari. Veniva finalmente sanzionato il frequente inadempimento di tale obbligo. Con una legge successiva furono attribuite funzioni di decisione di controversie, relative ad atti di amministrazioni locali, ad un organo amministrativo sedente presso la Prefettura, la Giunta provinciale amministrativa; organo che, dopo la Costituzione del 1948, sarà dichiarato costituzionalmente illegittimo per via della sua composizione, che non ne assicurava l’indipendenza e la imparzialità. Si era passati, senza averne consapevolezza, dal sistema monistico del 1865, con la tutela giurisdizionale interamente affidata ad un solo giudice, al sistema dualistico, per il quale la tutela nei confronti dell'amministrazione è divisa tra due differenti ordini giudiziari, il giudice ordinario e (quello che diventerà) il giudice amministrativo. 2. La cognizione e i poteri della Quarta Sezione Mentre la legge del 1865 aveva negato che il giudice potesse annullare gli atti dell’amministrazione, anche ove li reputasse illegittimi, la legge del 1889 conferiva alla Quarta Sezione proprio e solo il potere di annullamento. Il “giudizio” amministrativo si manifestava come il reciproco e l'opposto del giudizio ordinario. L'impressione che si ebbe della legge del 1889 era quella di aver colmato le “lacune” della legge del 1865, sia sotto il profilo dell’ambito della cognizione (avendo aggiunto la tutela degli interessi a quella dei diritti), sia sotto il profilo dei poteri di decisione (avendo aggiunto il potere di annullamento ai poteri di disapplicazione e di condanna pecuniaria). Per la seconda volta si ebbe l'illusione di aver risolto definitivamente il problema della giustizia amministrativa. Non si riflette a sufficienza sui vuoti di tutela che residuavano; e che, purtroppo, in buona parte, si sono tramandati fino ai nostri giorni, e soltanto con l’approvazione del Codice del processo amministrativo possono ritenersi interamente colmati. Il risultato allora conseguito fu la generalità della tutela, salva la zona franca degli atti politici: era data tutela per ogni controversia che il cittadino avesse nei confronti di una qualunque amministrazione. Ma la tutela assicurata non era mai piena e completa, dato che i mezzi di tutela esperibili dinanzi al giudice e dinanzi alla Quarta Sezione non erano cumulabili: se la controversia riguardava diritti soggettivi, si potevano esperire le azioni di accertamento e di condanna al pagamento di somme di danaro; se concerneva interessi, era possibile proporre soltanto l’azione costitutiva di annullamento. L’obiettivo della pienezza della tutela non fu centrato. 3. La natura giuridica della Quarta Sezione. La tesi della doppia tutela La legge del 1889 non utilizza mai i termini “giurisdizione” e “sentenza”: usa i termini “competenza” e “decisione”. Nelle intenzioni del legislatore, concordanti con le concezioni teoriche del tempo, il “controllo” sull’attività amministrativa e l’annullamento degli atti amministrativi non potevano essere attribuiti se non ad un organo appartenente all’amministrazione. Nella Relazione dell’Ufficio centrale del Senato si sottolineava che “il nuovo istituto non è un tribunale giudiziario speciale o eccezionale, ma rimane nella sfera del potere esecutivo”. Per conciliare il carattere amministrativo della Quarta Sezione con il carattere sostanzialmente giurisdizionale della sua funzione, si parlò di “controllo giurisdizionale dentro l’amministrazione stessa contro l’abuso dei suoi organi, con sufficienti garantite di giustizia”, accogliendosi quindi una nozione ampia (e non tecnica) di giurisdizione. Il riconoscimento della natura giurisdizionale della Quarta Sezione e, quindi, delle “decisioni” da essa adottate, permise alle Sezioni Unite di fissare il criterio di riparto (tra giurisdizione del giudice ordinario e “competenza” della Quarta Sezione) sulla causa petendi, ma soprattutto le permise di trasformare la Quarta Sezione da organo amministrativo in organo giurisdizionale. Alle Sezioni Unite, spettava sia di “regolare la competenza tra l'autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa quando l’una o l’altra siano dichiarate incompetenti”, ossia di decidere i conflitti negativi di attribuzione; sia di “giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonché della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere”, ossia di decidere i conflitti di giurisdizione, positivi e negativi. A fronte di decisioni della Quarta Sezione affermanti la “competenza” della Sezione medesima, le Sezioni Unite, “per impedire qualunque usurpazione delle attribuzioni” affidate all’autorità giudiziaria, non avevano altro mezzo (trattandosi di conflitto positivo di attribuzione) che trasformare il conflitto di attribuzione in conflitto di giurisdizione, con la conseguente possibilità di annullare, per incompetenza o eccesso di potere, le decisioni stesse della legge sui conflitti, sul necessario presupposto che tali decisioni fossero sentenze e che la Quarta Sezione fosse una giustizia speciale. La presa di posizione delle Sezioni Unite sul criterio di riparto fondato sulla causa petendi fu l’occasione di un dibattito dottrinale sulla possibilità di assicurare ai diritti soggettivi, oltre la tutela risarcitoria affidata al giudice ordinario, anche la tutela di annullamento, affidata al giudice amministrativo. Questo tentativo, che auspicava la doppia tutela, e si fondava sull’idea che il diritto soggettivo potesse essere fatto valere (anche) come (semplice) interesse, vide la dottrina divisa, e fu affondato dalle Sezioni Unite con le sentenze Laurens e Trezza. Fu posto fine alla doppia tutela. 4. La legge e il regolamento del 1907 La natura amministrativa della nuova istituzione era servita a disinnescare il problema di una tutela giudiziaria accordata in assenza di diritti soggettivi, ossia della tutela giurisdizionale attribuita ad interessi che si riteneva che non avessero, per definizione, riconoscimento giuridico. Di rilievo è l’atteggiamento di Spaventa, data la sua qualità dì Presidente della Quarta Sezione: egli parlò di giurisdizione, ma come funzione attribuibile all’amministrazione, esercitata dall’amministrazione come “forma nuova" del “supremo diritto d’ispezione” del Governo sugli atti dell’amministrazione; forma nuova, dato che l’esercizio di tale potere era condizionato dalla richiesta dei privati, “che vi hanno direttamente interesse, ma procede con tali forme processuali e con tale efficacia d’imperio sopra qualunque arbitrio amministrativo, quale può derivargli dall’autorità del Re, nel cui nome, come del capo supremo dell’amministrazione, la nuova magistratura rende giustizia”. Tale “giurisdizione” doveva necessariamente avere carattere oggettivo: non serviva a “definire controversie nascenti dalla collisione di diritti individuali e omogenei”, ma era diretta a “conoscere solamente, se il diritto obbiettivo sia stato osservato. L’interesse individuale offeso è solamente preso come motivo o occasione per l'amministrazione stessa per il riesame dei suoi atti”. Il carattere oggettivo della giurisdizione, era affermato da molti autorevoli studiosi, perché consentiva di superare il binomio diritto soggettivo-tutela giurisdizionale, eludendo il reciproco rapporto di necessaria implicazione, che si riteneva tra loro esistente: il processo di diritto oggettivo prescinde dalla considerazione (e dalla tutela) di situazioni giuridiche soggettive. Partendo da una nozione più rigorosa di giurisdizione, e riconoscendo il carattere (autenticamente) giurisdizionale della Quarta Sezione, la riconosciuta possibilità di tutela giurisdizionale in assenza di diritto soggettivo costituiva un problema, dato che, in conseguenza della sua tutelabilità in sede giudiziaria, “si dilegua l'idea dell'interesse puro e si converte in un’entità giuridica”: “l’affermare l’interesse scevro di diritto come materia del giudizio contenzioso amministrativo, è affermazione contraria ai principi di ragione, al concetto della giustizia e giurisdizione, e perfino alla legge di libertà”. Sorse così l’esigenza di individuare una forma di interesse, che non fosse mero interesse semplice (o di fatto), privo di rilievo giuridico, ma non fosse nemmeno un diritto soggettivo e si cominciò a prefigurare “un interesse legittimo, cioè corrispondente a un diritto obiettivo”, con il quale si trova in “rapporto occasionale”. Così, la giurisdizione della Quarta Sezione poteva non venire intesa più come giurisdizione di diritto obiettivo. L’orientamento della Quarta Sezione si andò spostando verso un modello di processo di diritto soggettivo, finalizzato cioè alla tutela di situazioni soggettive; e contemporaneamente la dottrina prese ad approfondire la nozione di interesse legittimo. La legge del 1907, e il regolamento di procedura, non fecero altro che sanzionare definitivamente, non solo il carattere effettivamente giurisdizionale della Quarta Sezione, ma anche il carattere soggettivo del processo che dinanzi ad essa si svolgeva. 5. L’introduzione della giurisdizione esclusiva e altre riforme prima della Costituzione La legislazione del 1907 non si dimostrò esauriente. Restavano molti problemi irrisolti. Molto presto il Governo sentì il bisogno di istituire una Commissione di altissimo livello acciocché fornisse proposte di riforma. Le proposte vennero elaborate: concernevano la tutela contro il silenzio, la competenza promiscua delle due Sezioni del Consiglio di Stato, l’individuazione di materie da riservare alla giurisdizione di un solo ordine giudiziario, senza che fosse necessario distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Successivamente, vennero accolte le due ultime proposte, e venne tralasciata la prima. Con la legge del 1923, si rese perciò promiscua la competenza della Quarta e della Quinta Sezione; si consentì al Consiglio di Stato di decidere in via accidentale anche questioni concernenti diritti soggettivi, tranne quelle relative allo stato e alla capacità; lasciando peraltro al giudice ordinario la cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali; soprattutto si creò la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Furono cioè individuate alcune materie, nelle quali si riteneva più difficile che in altre distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi; e si attribuirono le controversie relative a tali materie “all’esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tra tali materie aveva importanza soprattutto il rapporto di pubblico impiego. Con la legge del 1923, si creò un secondo criterio di riparto della giurisdizione, un criterio speciale, fondato sulle materie, rispetto al criterio generale, fondato sulle situazioni giuridiche soggettive. Con tale criterio si rinunciava al principio fissato nel 1865, per il quale alla tutela dei diritti soggettivi provvedeva il giudice ordinario. Purtroppo tele legge si limitò a creare la giurisdizione esclusiva ma non dettò una disciplina propria del processo relativo; cosicché la tutela dei diritti soggettivi fu compressa nello stretto ambito del processo amministrativo, con la possibilità di esercitare la sola azione di annullamento. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, nel tempo, eliminato qualche strozzatura: ha consentito la proposizione del ricorso entro i termini di prescrizione, anziché entro i termini di decadenza, quando la controversia attiene a diritti soggettivi; ma non ha mai intrapreso la strada della costruzione di un processo adeguato alla tutela congiunta delle situazioni di diritto e di interesse legittimo, ossia un processo di giurisdizione esclusiva. Anzi la differenziazione dei termini per la proposizione del ricorso a seconda che vengano impugnati atti paritetici (lesivi di diritti) o atti autoritativi (lesivi di interessi legittimi) dimostra che, anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva, la giurisprudenza non ha inteso superare la distinzione tra le due situazioni soggettive. Con il testo unico della legge comunale e provinciale, è stata integrata la disciplina dei ricorsi amministrativi. Capitolo 2 L’evoluzione del sistema La ricerca dei mezzi di tutela dei cittadini nei confronti dell’amministrazione è stata un problema politico di rilievo centrale dall’unità alle leggi Crispi del 1889. Da allora il problema è diventato tecnico-giuridico; le riforme successive, tra le quali spicca l’introduzione della giurisdizione esclusiva, sono state dettate dall’esigenza di ovviare a talune pesantezze o lacune del sistema. L’evoluzione del sistema è dovuta quasi esclusivamente all’opera della giurisprudenza, affiancata dalla dottrina. L’interesse per la giustizia amministrativa è risorto a livello politico nel corso dell’elaborazione del testo costituzionale. Nei decenni successivi alla Costituzione il legislatore è intervenuto con l’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, e, nel 2000, per dettare alcune opportune disposizioni sul processo amministrativo. Nel 2009 è stata conferita delega al Governo per procedere al riassetto del processo amministrativo, e nel 2010, è stato approvato il Codice del processo amministrativo. Sezione prima: L’impatto costituzionale 1. La “costituzionalizzazione” del sistema La Carta costituzionale, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, contiene alcune disposizioni riguardanti la giustizia amministrativa ed altre, più generali, che fissano principi sulla magistratura in generale e sulla tutela giurisdizionale. Nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente fu perseguito l’obiettivo di riaffermare l’unicità della giurisdizione, affidando tutte le controversie con l’amministrazione al giudice ordinario. I costituenti preferirono lasciare immutate le linee fondamentali del sistema, quale si presentava all’epoca. È stato sanzionato con norma costituzionale il sistema dualistico, ripartendo le controversie con l’amministrazione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, secondo il criterio delle situazioni soggettive, conservando altresì la giurisdizione esclusiva “in particolari materie indicate dalla legge”. Mentre si è vietata l’istituzione di giudici speciali ed è stata prescritta la “revisione”, entro cinque anni, degli “organi di giurisdizione” esistenti, sono stati fatti salvi sia il Consiglio di Stato che la Corte dei conti. Viene sancita la doppia vocazione funzionale di entrambi: il Consiglio di Stato resta quindi “organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela di giustizia nell’amministrazione”; la Corte dei conti è contemporaneamente organo di controllo e organo di giurisdizione “nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”. I magistrati di entrambi gli istituti vengono considerati “giudici delle giurisdizioni speciali”, in quanto si collocano fuori dall’ordine giudiziario. E ciò anche se, per quanto riguarda il Consiglio di Stato (e i Tar), è loro da riconoscere una giurisdizione generale in tema di interessi legittimi: essi sono giudici speciali esercenti una giurisdizione generale. Per quanto attiene ai giudici amministrativi, la Costituzione, prescrive l’istituzione di “organi di giustizia amministrativa di primo grado”. Tale prescrizione sarà attuata solo negli anni ’70, con l’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali. In attuazione dello Statuto della Regione siciliana, è stato istituito il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, istituto corrispondente, quanto alle funzioni, al Consiglio di Stato. Il disegno costituzionale del sistema della giustizia amministrativa, per quanto attiene ai giudici e al riparto della giurisdizione, riflette sostanzialmente il sistema che si era formato nel tempo. È stata riprodotta perfino la norma, di origine giurisprudenziale, che limita il ricorso in Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai “soli motivi inerenti alla giurisdizione”, impedendosi in tal modo che la Cassazione (o eventuale altro organo giudiziario) possa svolgere la necessaria generale azione nomofilattica, che non può che essere unitaria ed universale. I commentatori hanno criticato il testo costituzionale, ritenendo che esso abbia conferito un superiore valore giuridico ad un sistema che già allora non veniva da molti considerato soddisfacente. 2. Le “aperture” costituzionali Diversa valutazione deve farsi in ordine ad altre disposizioni costituzionali, soprattutto a quelle relative all’esercizio della funzione giurisdizionale. Si tratta di norme che riguardano qualsiasi giurisdizione, si applicano quindi anche alle giurisdizioni amministrative. Tra i diritti dei cittadini, viene solennemente riconosciuto a ‘tutti” la possibilità di “agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”; nonché il “diritto inviolabile” alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. Viene ribadito che “contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi”. Gli interessi legittimi vengono accostati ai diritti soggettivi. È il testo cost. che per primo adopera la locuzione “interessi legittimi”. Sia l’utilizzazione della locuzione, sia soprattutto l'accostamento della figura a quella del diritto soggettivo, hanno dato un contributo decisivo a quel movimento dottrinale, teso a dimostrare il carattere sostanziale (e non solo processuale) della situazione giuridica soggettiva, conosciuta come interesse legittimo. Il riconoscimento dell’interesse legittimo come situazione soggettiva che trova tutela nel (e non nasce con il) processo, ha conseguenze notevoli sia sul piano teorico che su quello pratico: sancisce definitivamente il carattere di processo di diritto soggettivo e di processo di parti che il processo amministrativo aveva da tempo acquisito. Inoltre riapre la discussone sull’oggetto del processo amministrativo, pacificamente (o quasi) identificato nell’atto amministrativo impugnato. Infine apre la strada all’affermazione, della risarcibilità delle lesioni inferte dall’amministrazione all’interesse legittimo. Il testo costituzionale riafferma la generalità della tutela nei confronti dell’amministrazione: vengono meno, sia le limitazioni connesse con la non impugnabilità di alcune categorie di atti (es. gli atti politici) sia quelle derivanti dall’esclusione della sindacabilità degli atti sotto alcuni profili (di solito sotto il profilo dell'eccesso di potere). La tutela giurisdizionale “non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti” (art. 113, comma 2). Questa disposizione, si può ritener attuata, ma solo sul versante del processo amministrativo, con l’entrata in vigore del Codice, a condizione che esso venga inteso alla luce della legge di delega, che auspica la soddisfazione della pretesa della parte vittoriosa: al di là del significato da attribuire all’espressione “particolari mezzi di impugnazione”, non si può non riconoscere che la Costituzione aveva voluto assicurare fin dal 1948, oltre alla generalità, anche la pienezza della tutela giurisdizionale. Il che comporta che, nelle controversie con l’amministrazione, debbano poter essere esperibili tutte le azioni che, in via generale, sono esperibili nelle controversie tra privati; superando in tal modo la strana situazione precedente, per cui il giudice ordinario non può né annullare atti amministrativi né condannare l’amministrazione ad un facere e a un dare specifici (limitazione tuttora persistente), e il giudice amministrativo non poteva emettere ogni tipo di sentenza. 3. L’opera della Corte costituzionale Intensa e proficua è stata l’opera della Corte cost. a partire dagli anni ’60, sia con riferimento ai giudici amministrativi speciali, sia, più tardi, con riguardo alla disciplina del processo amministrativo. Il panorama dei giudici speciali si era andato arricchendo di numerose figure nei decenni precedenti la nuova Costituzione. L’inadeguata composizione di tali organi giudicanti e la rozzezza della disciplina del processo che dinanzi a loro si svolgeva hanno determinato il disfavore dei costituenti per i giudici speciali. Tuttavia il legislatore non ha dato seguito al dovere di attuarne la revisione entro il termine indicato. L'inerzia del legislatore ha spinto la Corte cost. ad eliminare molti di tali giudici speciali. Così sono stati eliminati: i Consigli di Prefettura, le Giunte Provinciali amministrative, i Capitani di porto. Indicativa è la vicenda del contenzioso elettorale amministrativo: per tradizione i ricorsi elettorali venivano decisi rispettivamente dai consigli comunali e provinciali. La Corte costituzionale, che aveva precedentemente ritenuto di carattere giurisdizionale tale attività decisoria, dichiarò costituzionalmente illegittime le norme che disciplinavano il contenzioso elettorale amministrativo senza che fossero garantite l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo giudicante. Il legislatore ritenne di risolvere il problema, istituendo le Sezioni del contenzioso elettorale, come Sezioni specializzate dei Tar, composte da due funzionari statali e da tre membri eletti dai consigli regionali o provinciali. La Corte ha ritenuto che un collegio così formato violasse il principio di indipendenza del giudice. Il problema è stato poi risolto attribuendo la giurisdizione in tema di operazioni elettorali amministrative ai Tar. La Corte ha contribuito a far nascere i giudici parlamentari. Si è anche occupata della nomina governativa di alcuni dei magistrati del Consiglio di Stato. Ha ritenuto illegittima la designazione, da parte della Giunta regionale, di alcuni membri del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, in quanto essi duravano in carica quattro anni e potevano essere riconfermati. La questione di costituzionalità si è posta anche per quei consiglieri del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, che sono nominati per le Sezioni di Trento e Bolzano dai rispettivi Consigli provinciali. La questione è stata dichiarata infondata dal giudice amministrativo. La Corte si è poi occupata della disciplina del processo amministrativo, è più volte intervenuta sulla tutela cautelare; ha riconosciuto valore costituzionale alla regola del doppio grado di giudizio; ha stigmatizzato il sistema probatorio, ma solo con riferimento al processo di pubblico impiego; ha introdotto l’opposizione di terzo ordinaria; ha sottolineato l’importanza del principio del contraddittorio; ha individuato i limiti costituzionali all’espansione della giurisdizione esclusiva. 4. La istituzione dei Tribunali amministrativi regionali Nel 1971, sono stati istituiti i Tribunali amministrativi regionali “quali organi di giustizia amministrativa di primo grado” con circoscrizione regionale. La sede dei Tribunali è nel capoluogo di Regione; in alcune Regioni sono state istituite Sezioni staccate. L’istituzione di organi di primo grado si era resa urgente a seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle Giunte provinciali amministrative, che fungevano da organi di giustizia amministrativa di primo grado, peraltro con giurisdizione limitata. I nuovi Tribunali hanno invece giurisdizione corrispondente a quella del Consiglio di Stato; per cui quest’ultimo, che era a volte giudice di appello (nei confronti delle Giunte) e più spesso giudice dì unico grado, è diventato giudice di appello. Residua un solo caso di giurisdizione in unico grado del Consiglio di Stato, e riguarda il ricorso per ottemperanza alle decisioni dello stesso Consiglio di Stato, quando esse non confermino le decisioni di primo grado. Inizialmente, venne riservata la presidenza dei Tribunali ai consiglieri di Stato, e venne creato il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, separato dal ruolo del Consiglio di Stato. Successivamente, la presidenza dei Tribunali è stata estesa ai magistrati amministrativi regionali e sono stati inseriti in un unico ruolo i magistrati del Consiglio di Stato e quelli dei Tar. Tuttavia è stata mantenuta la separazione tra qualifiche: alla qualifica di consigliere di Stato i consiglieri dei Tribunali amministrativi possono accedere solo in ragione della metà dei posti disponibili ed abbiano almeno quattro anni di servizio nella qualifica. I restanti consiglieri sono scelti, per un quarto, con pubblico concorso, e, per l’altro quarto, con nomina del Governo. Con la legge del 1982 è stato istituito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, la cui composizione è stata oggetto di revisione. Esso ha nella sostanza le stesse funzioni che il Consiglio superiore della magistratura svolge per i magistrati ordinari. Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato con decreto del Pdr, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. La legge del 1971 ha ripetuto letteralmente le formule del testo unico sul Consiglio di Stato. Si è voluto che i Tribunali neo-istituiti non percorressero vie giurisprudenziali diverse da quelle segnate dal Consiglio di Stato; allo stesso obiettivo era finalizzata la presidenza riservata ai consiglieri di Stato. Ciononostante, i Tribunali, hanno fornito un rilevante contributo di innovazione. 5. Le novità della legge del 1971 e la riforma dei ricorsi amministrativi Alcune innovazioni sono state apportate alla disciplina processuale. La legge del 1971 ha tentato di dettare una disciplina processuale che, sebbene elementare ed incompleta, potesse fornire una guida per i nuovi organi giudicanti, riproducendo, chiarendo o modificando la disciplina elaborata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Innovazioni effettive riguardano la giurisdizione: l’attribuzione ai giudici amministrativi delle controversie in materia di operazioni elettorali relative alle elezioni amministrative; l'estensione della giurisdizione esclusiva ai ricorsi relativi a rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici. In sede di giurisdizione esclusiva, “nella materia relativa a diritti”, al giudice amministrativo è stato attribuito il potere di “condannare l’amministrazione al pagamento di somme, di cui risulti debitrice”. Si ha un primo allargamento dei poteri di decisione, non più limitati all’annullamento dei provvedimenti impugnati. L’innovazione più rilevante riguarda l’appello: coerentemente con il principio del doppio grado di giudizio, l’appello è stato disegnato secondo lo schema del gravame, e non secondo quello dell’impugnazione in senso stretto; anche se era previsto il rinvio al giudice di primo grado nel caso in cui il giudice d'appello rilevava un difetto di procedura o un vizio di forma della decisione. Il giudice d’appello ha la stessa cognitio causae del primo giudice: il gravame è infatti “impugnazione illimitata, con effetto devolutivo”. Una modifica di grande rilievo rispetto alla disciplina precedente riguarda l'impugnabilità dei provvedimenti non definiti: si è consentito in tal modo l’esercizio dell’azione giurisdizionale, prescindendo dalla previa impugnazione dei provvedimenti stessi con ricorso amministrativo (ordinario) e dalla conclusione del relativo procedimento. È stata poi dettata una disciplina organica siti ricorsi amministrativi, compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Nonostante il rilevante impatto, la legislazione del 1971 non ha dato luogo ad una riconsiderazione globale e sistematica dei mezzi di tutela nei confronti dell’amministrazione, né ha introdotto una disciplina processuale esauriente. Sezione seconda: Verso il sistema attuale 1. L’opera della giurisprudenza Il Consiglio di Stato, nel lungo periodo in cui è stato giudice sostanzialmente unico, ha esercitato la sua giurisprudenza pretoria per chiarire, e più spesso integrare, la lacunosa disciplina processuale; talvolta forzando il significato letterale delle norme scritte. L’entrata in scena dei Tar ha creato nuove sollecitazioni per una ripresa in grande stile della giurisprudenza pretoria. Va rilevato infatti che il Consiglio di Stato, essendo l’unico giudice di secondo grado (insieme al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), e non essendoci altro giudice con funzione di nomofilachia, ha avuto l’opportunità di raccogliere i fermenti, talvolta contraddittori, talaltra felici, provenienti dai giudici di primo grado. Si è verificato un rinvigorimento della giurisprudenza pretoria del Consiglio di Stato, con allargamento della legittimazione ad agire e il riconoscimento della impugnabilità di taluni atti, per l’innanzi ritenuti non impugnabili. È stato ritenuto che il giudice amministrativo possa disapplicare i regolamenti. L’evoluzione maggiore si è avuta a proposito del processo cautelare: è stato affermato il carattere decisionale delle ordinanze di sospensiva e se ne è conseguentemente consentito l'appello; è stato individuato un metodo per garantire che tali ordinanze fossero effettivamente eseguite dall'amministrazione; è stata estesa la tutela cautelare avverso i provvedimenti negativi ed è stato riconosciuto che “l’effettività della tutela interinale possa essere realizzata anche mediante strumenti diversi e ampiamente eccedenti la pura e semplice paralisi degli effetti formali dell’atto impugnato”. Da ultimo è stato affermato che “i diritti soggettivi, pur se relativi e di natura patrimoniale, possono ottenere piena ed effettiva tutela giurisdizionale, anche d’urgenza”, da parte dei giudici amministrativi. È stata anche riscritta la disciplina del processo di ottemperanza, del quale sono stati sottolineati: il carattere giurisdizionale, struttura contenziosa, natura cognitoria, funzione non semplicemente esecutiva. È stata affermata la necessità che la sentenza di ottemperanza sia passata in giudicato; è maturato l’orientamento che consente l’ottemperanza anche in presenza dì atti elusivi del giudicato; è stata riconosciuta l'appellabilità delle sentenze di ottemperanza; è stata affermata la necessità della notifica del ricorso per ottemperanza. In ordine al silenzio, viceversa, la giurisprudenza ha continuato ad oscillare, tra un orientamento che lo individua quale oggetto del giudizio e un orientamento che lo considera semplice presupposto processuale; con conseguenze assai diverse. Il punto più elevato e convincente dell’evoluzione giurisprudenziale è stato raggiunto nel 1978, ma non si è poi consolidato. Sul problema è poi intervenuto il legislatore nel 2000, nel 2005 e infine con l'art. 117 del Codice. In tema di azione risarcitoria, è stato ritenuto il carattere non autonomo della medesima che sarebbe ammissibile solo se sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento (illegittimo e) lesivo. È stato altresì chiarito che in appello è ammissibile l’integrazione del contraddittorio, nei confronti delle sole parti necessarie, e che si applica l’art. 345 c.p.c. per quanto riguarda l’ammissione di nuovi mezzi di prova; che la rinuncia al ricorso estingue il processo solo a seguito della presa d’atto da parte del giudice; che l’eccezione di prescrizione di crediti nei confronti dell’amministrazione può essere sollevata soltanto in primo grado. Sono stati chiariti alcuni aspetti processuali del regolamento di competenza. Sono stati recepiti i nuovi orientamenti della Corte di cassazione in tema di giudicato interno e di giudicato implicito. La giurisprudenza ha voluto puntare all’obiettivo (ma non sempre) dell’effettività della tutela giurisdizionale. Su tutti questi argomenti è intervenuto poi il Codice del processo amministrativo. 2. Le novità dell’ultimo trentennio del secolo ventesimo Sul piano legislativo, non si sono avuti altro che interventi episodici', nonostante la dottrina abbia sempre più spesso reclamato una riforma complessiva e vi siano anche state iniziative governative e parlamentari orientate in quel senso, ma mai pervenute a risultato. Gli interventi legislativi hanno riguardato, da un lato, l’ambito della giurisdizione, con l’aumento delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, dall'altro, il processo, ricercando, per le controversie ritenute particolarmente delicate, forme processuali semplificate o riti accelerati, tali da consentire tempi ridotti per giungere alla sentenza. L’allargamento della giurisdizione esclusiva è proseguito secondo una linea costante: in materia edilizia; in ordine agli accordi amministrativi; in tema di tutela della concorrenza; sui provvedimenti dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in tema di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche. Si è venuto in tal modo ampliando il criterio di riparto delle giurisdizioni tra giudice ordinario e giudice amministrativo, fondato sulle materie anziché sulle situazioni giuridiche soggettive. Tale diverso criterio è stato ritenuto a lungo migliore di quello fissato dall’art. 103 Cost.; tanto che la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, lo ha proposto come criterio generale, sostitutivo del criterio basato sulle situazioni giuridiche soggettive. Il tentativo di riforma costituzionale non ha avuto seguito, e questo non può considerarsi un evento negativo. Nel 1998, è stato operato un duplice spostamento: le controversie relative al rapporto di lavoro (privatizzato) con gli enti pubblici sono state assegnate al giudice ordinario, senza distinzione tra controversie su diritti e su interessi legittimi; viceversa le controversie in materia di servizi pubblici, di edilizia e di urbanistica sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Sono state devolute alla giurisdizione esclusiva le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da qualsiasi soggetto tenuto all’applicazione della normativa comunitaria o al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica. Il legislatore, si è poi preoccupato di stringere i tempi processuali per la soluzione di determinate controversie. Il campo di elezione dei riti accelerati è stato inizialmente individuato nelle controversie relative ai lavori pubblici. La materia è ora ordinata nel Codice. Forme speciali o termini abbreviati sono poi in vigore per il contenzioso elettorale, per le controversie in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per i provvedimenti di espulsione degli stranieri, per il diritto di accesso agli atti amministrativi, e così via. L'ampia serie degli interventi settoriali è poi culminata nella legge n. 205/2000. Un chiarimento importante è venuto dalla Corte cost. in tema di diritti costituzionalmente protetti: sconfessando un orientamento della Cassazione (sui diritti resistenti), la Corte ha rilevato che non esiste “alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario escludendone il giudice amministrativo- la tutela dei diritti costituzionalmente protetti”. 3. La legge n. 205/2000 Fondamentale è la l. 205/2000. Anche se è ben lontana dall’avere realizzato una riforma organica del processo amministrativo, tuttavia ha introdotto alcune innovazioni utili a garantire una maggiore effettività nella tutela giurisdizionale amministrativa. La legge è il risultato di un’elaborazione parlamentare incompleta. I temi sui quali il legislatore è intervenuto, tralasciando quello relativo al riassetto delle giurisdizioni, riguardano il processo, con particolare attenzione alla fase cautelare, nonché i riti speciali ed accelerati. In ordine al processo, sono state dettate norme di razionalizzazione: la più rilevante sembra quella che prescrive di raccogliere insieme, attraverso il mezzo tecnico dei motivi aggiunti, le controversie tra le stesse parti, relative a tutti i provvedimenti connessi con quello impugnato con il ricorso introduttivo del processo. Il quale diventa un contenitore in cui si riversano (le controversie relative a tutti) i provvedimenti (anche di autorità diverse) riguardanti la medesima operazione amministrativa complessa, e che consente che si pervenga a conoscere del complessivo rapporto intercorrente tra la parte pubblica e le parti private. Quanto ai riti speciali, va sottolineata l'introduzione di un rapido processo “avverso il silenzio” dell’amministrazione: la prima giurisprudenza che si è formata sul nuovo istituto non ne ha sottolineato la capacità di assicurare una tutela efficiente nei confronti di una grave disfunzione amministrativa, l’ingiustificata inerzia; la quale, oltre che gli interessi privati, lede l’interesse pubblico. Sono poi state introdotte più discipline processuali speciali, il cui tratto comune è la riduzione della durata del processo. Ciò che colpisce è che tutti i riti a durata ridotta sono strettamente collegati alla richiesta di tutela cautelare: non è sufficiente che il processo riguardi talune materie sensibili; occorre che sia presentata l’istanza cautelare. Si tratta di un collegamento privo di giustificazione. In relazione alla giurisdizione esclusiva, sono state dettate norme, che, da un lato, hanno allargato i poteri istruttori e decisori del giudice, e, dall’altro, hanno reso uniforme un modello processuale in precedenza carico di molte varianti. Infine, una innovazione di grande rilievo attiene ai poteri del giudice amministrativo, o, se si preferisce, alle azioni proponibili: sia in sede di legittimità, sia in sede esclusiva, è stata resa proponibile dinanzi al giudice amministrativo l’azione risarcitoria. La l. 205/2000, ha sotto molti profili anticipato la disciplina stabilita con il Codice del processo amministrativo. 4. Il processo amministrativo prima del Codice Le due leggi fondamentali, del 1865 e del 1889, rispondono a logiche tra loro diverse e, malgrado le opinioni dei loro autori, non compongono un quadro armonico e, nemmeno tendenzialmente, completo dei mezzi di tutela nei confronti dell’amministrazione. Nonostante alcuni tentativi, è mancata successivamente al legislatore la volontà di intervenire sulla disciplina in modo organico. La dottrina ha sempre auspicato l’adozione di un testo completo ed esauriente, in linea con le disposizioni e i principi costituzionali. Viceversa gran parte della disciplina processuale risultava ancora contenuta in un testo, non solo risalente al 1907, e quindi assai arretrato, ma avente anche natura forse regolamentare (e non legislativa), e quindi in probabile contrasto con gli artt. 101 e 108 Cost. Non sono mancati tentativi di porre rimedio ad una simile situazione, ma nessuno è andato a buon fine. La disciplina della giurisdizione e del processo è cosi rimasta disorganica e non del tutto appagante fino all’approvazione del Codice, nonostante che una legge sulla procedura fosse stata annunciata con la legge del 1971. Non c'è dubbio che la giustizia amministrativa, con l’istituzione dei Tribunali amministrativi, sia stata posta, almeno dal punto di vista geografico, a portata di mano degli utenti; con la conseguenza di un grande incremento dei ricorsi, ma questo ha comportato un ulteriore problema, rimasto finora irrisolto, salvo qualche palliativo: l'insufficienza numerica dei magistrati amministrativi, che è la causa principale dell’anormale durata dei processi. Nemmeno il Codice ha posto rimedio a questo grave problema. 5. Il dibattito teorico sulla giurisdizione amministrativa Negli ultimi tempi, si è riavviato il dibattito sul principio dell’unitarietà della giurisdizione e, in relazione ad esso, sull’architettura stessa della magistratura e dei corpi che la compongono; architettura non chiara e non soddisfacente. L’intera magistratura si articola in un ordine giudiziario e in altri corpi svolgenti anch’essi funzioni giurisdizionali. Il primo raccoglie i giudici ordinari; gli altri costituiscono i giudici speciali; speciali in quanto collocati fuori dall'ordine giudiziario. Tuttavia giudici speciali possono avere giurisdizione generale, ove l’ambito della loro cognizione sia determinato in forza di criteri generali (situazioni giuridiche soggettive, natura delle norme invocate, natura delle parti o di una di esse) e non del criterio per materie. In questa prospettiva l’insieme dei giudici amministrativi può essere considerato un corpo di giudici speciali, aventi giurisdizione generale; mentre i giudici contabili appaiono come giudici speciali con giurisdizione speciale. Sono tuttavia possibili ricostruzioni diverse: ad esempio, è stato ritenuto che il sistema disegnato dalla Costituzione contempli “quattro organismi distinti e precisamente il giudice ordinario, il giudice amministrativo, il giudice contabile e il giudice militare”. Ciascuno di tali “complessi giurisdizionali, nel suo ambito ed in rapporto agli altri, può definirsi ‘ordinario’: sia perché tutti dotati di competenza generale nei rispettivi settori, sia perché previsti ed istituiti dalla Costituzione”. La magistratura si presenta “articolata in quattro distinti ordini. L’unitarietà della giurisdizione si realizza non sul piano strutturale (istituendo un unico ordine giurisdizionale), ma su quello funzionale, con l’inserimento nella Costituzione di una serie di disposizioni e principi comuni a tutte le magistrature”. In dottrina periodicamente ritorna l'aspirazione alla ricomposizione unitaria del sistema organizzativo giudiziale, che, in sede di Assemblea costituente, era stato fortemente sostenuto da Piero Calamandrei. Recentemente, in modo più articolato, il principio dell’unità della giurisdizione, o, meglio, la “dicotomia” unità funzionale-pluralità organizzativa, è stata letta nel senso che “la Costituzione riconosce e prevede una serie di giurisdizioni distinte tra loro per struttura, poteri e competenza, ma ammette un solo tipo di magistrato indipendente”. L’Autore ritiene che alcune disposizioni riguardanti i consiglieri di Stato possano compromettere la loro indipendenza. Va rammentato che la nomina governativa è stata ritenuta costituzionalmente legittima; mentre sugli altri aspetti non vi sono allo stato né convincimenti unanimi né prese di posizione della Corte costituzionale. Si deve aggiungere che, comunque interpretato, il sistema è difettoso, almeno sotto due profili: il controllo sulla giurisdizione dei singoli corpi o “ordini” di giudici è affidato ad uno di essi, sia pure al massimo livello, e ciò ha dato luogo e continua a dare luogo a contrasti giurisprudenziali non facilmente ricomponibili; manca un organo giudiziario con funzione generalizzata di nomofilachia, sicché su medesimi argomenti si possono determinare orientamenti diversi presso i vari corpi giurisdizionali, in contrasto con il principio, nella sua prospettazione funzionale, dell’unitarietà della giurisdizione, e con quello dell’unità dell’ordinamento. La difettosa architettura del sistema complessivo è emersa anche recentemente, con la dichiarazione di incostituzionalità della composizione dei Tribunali regionali delle acque, che ha portato ad un passo dalla loro soppressione ed alla soppressione anche del Tribunale superiore. Il principio dell’unità funzionale (anche se non organizzativa) della giurisdizione è stato riaffermato recentemente sia dalla Corte di cassazione sia dalla Corte costituzionale; le quali Corti hanno, per vie diverse, affermato la necessità della translatio iudicii, dal giudice carente di giurisdizione al giudice che della giurisdizione sia dotato. Altro tema caldo del dibattito, attuale anche dopo l’approvazione del Codice, è quello relativo al riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Il criterio originario, fondato sulle situazioni soggettive del ricorrente, è stato nel tempo sostituito dal criterio fondato sul potere autoritativo dell'amministrazione, come si ricava sia dalla degradazione del diritto soggettivo, sia dalla regola della carenza di potere/cattivo esercizio del potere, introdotta dalla Cassazione nel 1949; ed è stato doppiato da altri criteri, ad esempio in tema di contenzioso elettorale, di sanzioni pecuniarie e in tutti i casi di giurisdizione esclusiva. Poiché tali casi si sono andati moltiplicando, si è determinata una situazione confusa, e probabilmente non rispettosa del dettato costituzionale. L’opinione di moda, almeno fino alla sentenza della Corte cost. n. 204/2004, era che il riparto per materie fosse da considerare migliore di quello per situazioni soggettive. È da ritenere, invece, che non si possa fare a meno di un criterio generale di riparto: se si ritiene inadeguato il riferimento alle situazioni soggettive dei privati o dell’amministrazione, si può utilizzarne un altro (natura delle norme, o delle fattispecie, o della parte resistente), e lasciare alle materie il ruolo di criterio eccezionale. D’altronde l’esperienza degli ordinamenti più vicini al nostro è in questo senso. Sul piano processuale l’attenzione è stata rivolta al funzionamento in concreto delle riforme più rilevanti, con particolare riguardo all’atteggiamento che il giudice amministrativo è andato via via adottando a proposito del risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi. Finora l’atteggiamento non sembra ispirato a larghe aperture. Un altro tema di forte attualità, attiene alla misura della sindacabilità delle scelte di discrezionalità tecnica effettuate dall’amministrazione. La dottrina non è concorde: c’è chi spinge perché nel processo amministrativo possa essere sindacata fino in fondo ogni scelta tecnica, in modo da consentire la piena tutela ogniqualvolta la scelta non sia veramente discrezionale; e c’è chi punta verso un sindacato più limitato, temendo che il giudice amministrativo possa trasformarsi in amministratore. L’iniziativa legislativa è ripresa nel 2009. Da un lato è stata introdotta una speciale azione per reagire contro le p.a. e i concessionari di servizi pubblici che si discostino dagli standards qualitativi ed economici prefissati o che violino le norme preposte al loro operato. Si tratta del ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. La dottrina non assegna grande rilievo a tale azione, dato che essa sfocia in una sentenza con la quale il giudice ordina all’amministrazione o al concessionario “di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Non sembra che questo nuovo mezzo offra maggiore tutela. 6. Il Codice del processo amministrativo e i suoi correttivi Con la l. 69/2009, è stata conferita delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo. Tra i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega spicca il seguente: disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 1. riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni; 2. riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l’ordinamento vigente; 3. disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice; 4. prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa. Quest'ultimo criterio è importante, perché consente di raggiungere la pienezza della tutela nei confronti dell’amministrazione. Il Governo, per l'attuazione della delega ha inteso avvalersi del Consiglio di Stato, presso il quale è stata costituita una Commissione, alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre a consiglieri di Stato, magistrati di T.A.R., esperti esterni, rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato. Il testo elaborato dalla Commissione è stato poi rivisto in sede governativa, purtroppo nel segno della continuità con la tradizione anteriore, e quindi, depennando le disposizioni più innovative. La delega è stata infine attuata con il d.lgs. del 2010, recante l’approvazione del Codice del processo amministrativo. Il nuovo testo legislativo, finalmente, dopo circa 120 anni, reca una disciplina organica del processo amministrativo, estesa anche a risolvere i problemi di giurisdizione e ad attuare nel modo pieno i principi costituzionali del giusto processo. Non si tratta di una disciplina pienamente soddisfacente, né pienamente rispondente ai criteri di delega: rimangono alcuni tratti non condivisibili, ma, complessivamente valutata, si può a ragione parlare di raggiungimento di un testo di portata storica. Sono richiamati (e attuati) i principi del giusto processo; è stato tentato un chiarimento del criterio di riparto della giurisdizione; è stato ampliato il ventaglio delle azioni proponibili, fino a ritenere che si sia attuata la regola della atipicità delle azioni, secondo la quale si può chiedere al giudice qualsiasi pronuncia che sia utile per la soddisfazione della parte vittoriosa; è stata rielaborata la disciplina dell’istruttoria processuale; riordinate le impugnazioni ed è stato rivisto il processo di ottemperanza. I difetti, le lacune e le disposizioni non condivisibili potranno essere eliminati o corretti nei prossimi due anni, secondo previsione della legge di delega. Sono infatti intervenuti due decreti correttivi: - d.lgs. 195/2011 con il quale sono state corrette imperfezioni formali e sono state apportate integrazioni. Modifiche sostanziali hanno riguardato la disciplina del giudizio di ottemperanza, l’elenco delle materie a cui si applica il rito abbreviato, l’elenco delle materie di giurisdizione esclusiva e delle materie riservate alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, sede di Roma. - d.lgs. 160/2012 oltre ad ulteriori correzioni formali, è stata profondamente rivista la disciplina della competenza; ed è stata precisata la disciplina dell’azione di condanna al rilascio di provvedimenti. Si può oggi sostenere che il processo amministrativo dispone finalmente di una disciplina organica e tendenzialmente completa. PARTE II Capitolo 1: Il giudice amministrativo 1. Il Consiglio di Stato e lo sua composizione Il Consiglio di Stato, è definito come “organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione”. Assoluta indipendenza dell’istituto e dei suoi componenti di fronte al Governo, pur costituendo un organo ausiliario di esso. Le funzioni giurisdizionali sono state esercitate, tradizionalmente, da tre Sezioni, frutto di uno sviluppo graduale. Con la l. n. 133/2008, il legislatore ha invece rimesso al Presidente del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio di presidenza, annualmente, la competenza ad individuare quali sezioni svolgono attività consultiva e quali l’attività giurisdizionale. Ci si trova di fronte ad un organo complesso, composto da organi permanenti (il Presidente, le Sezioni, l’Adunanza Generale, l’Adunanza Plenaria) e da organi temporanei o straordinari (commissioni speciali). Il presidente, è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sulla scorta del parere formulato dal Consiglio di Presidenza, fra i magistrati amministrativi che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, funzioni direttive. Compiti principali del presidente: - Istituzionale: potere di convocare e presiedere le riunioni dell’Adunanza Plenaria e dell’Adunanza Generale; stabilire la composizione delle Sezioni consultive e giurisdizionali ed assegnare i ricorsi/pareri alle singole Sezioni, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Presidenza. Quale membro di diritto di quest’ultimo, ne presiede le riunioni e nomina l’ufficio elettorale per la scelta degli altri componenti del Consiglio. - Amministrativo: potere di adottare tutti i provvedimenti relativi ai magistrati ed ai funzionari delle segreterie, ed uno specifico potere di proposta in tali materie al Presidente del Consiglio dei Ministri e, tramite quest’ultimo, al Capo dello Stato. Esercita, infine, il potere di vigilanza su tutti gli uffici del Consiglio di Stato e sui magistrati ed è titolare dell’azione disciplinare. Il presidente è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da un segretario generale, scelto tra i consiglieri di Stato, mediante il conferimento di un incarico quinquennale contenuto in un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta (vincolante) del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza. L’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, quale organo collegiale con funzioni unicamente consultive, è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da tutti i consiglieri in servizio. Ha competenza in materia di pareri sui progetti di legge, testi unici, regolamenti e per le questioni, di rilevanza generale o di massima, sulle quali il presidente, le singole Sezioni ritengano necessario un pronunciamento dell’organo in parola. Sempre con riguardo all’attività di natura consultiva, il presidente del Consiglio di Stato può formare commissioni speciali, qualora la questione da risolvere non sia riconducibile ad una Sezione consultiva ordinaria, sulla base del criterio di riparto per materia. L’Adunanza Plenaria, con funzioni esclusivamente giurisdizionali, è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali. È prevista la possibilità, su richiesta, di investire l’Adunanza Plenaria ad opera della Sezione che ritenga necessario un pronunciamento su un punto di diritto che ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali; o il deferimento del Presidente per “la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza o per dirimere contrasti giurisprudenziali”. A tali due ipotesi, è stata aggiunta la possibilità della sezione di rimettere la decisione laddove ritenga di non condividere un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria. Detta rimessione viene disposta con ordinanza motivata, sulla quale l’organo collegiale si pronuncia riguardo all’intera vicenda salvo che non ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire, per il resto, il giudizio alla sezione remittente. L’Adunanza Plenaria, può, infine, laddove la questione sia di particolare importanza, “enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia non ha effetto sulla sentenza impugnata”. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ha funzioni di giudice di appello avverso le pronunce di primo grado del T.A.R. Sicilia, nonché funzioni di natura consultiva, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale. Detto consiglio ha sede a Palermo, ed il Presidente è designato dal Presidente del Consiglio di Stato tra i Presidenti di Sezione. 2. I Tribunali amministrativi regionali e la loro composizione Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i Tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino Alto Adige per il quale è contemplata, una diversa disciplina in ordine alla composizione ed alla nomina dei magistrati. Ogni T.A.R. è formato dal presidente, dai consiglieri, dai primi referendari e referendari. Il Collegio giudicante esercita le proprie funzioni con la presenza del presidente e di due magistrati. In mancanza del presidente, il Collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità. Spetta al presidente dirigere i lavori della prima Sezione laddove il Tribunale si articoli in più Sezioni, predisporre il calendario delle udienze e la ripartizione delle cause, nonché stabilire la composizione dei collegi giudicanti sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Presidenza. Un rilievo particolare merita la Regione Trentino-Alto Adige, nella quale esercitano le funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (T.R.G.A.). Già nello statuto, è contemplata una Sezione con ordinamento speciale, con sede a Bolzano, che può considerarsi un vero e proprio Tribunale autonomo, al punto che i relativi conflitti di competenza con il T.R.G.A. di Trento vengono risolti dal Consiglio di Stato. Per la composizione della Sezione autonoma di Bolzano sono stati individuati dei criteri in grado di garantire la compresenza di giudici di lingua italiana e tedesca. Gli otto magistrati sono nominati con decreto del PdR per una metà su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e, limitatamente al gruppo linguistico tedesco, con il consenso del Consiglio provinciale di Bolzano; per l’altra metà vengono proposti dal Consiglio provinciale. Per quanto concerne la soluzione di controversie aventi ad oggetto il sindacato su provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parità tra gruppi linguistici, questa è attribuita in maniera inderogabile ed in unico grado alla Sezione autonoma di Bolzano. 3. I magistrati amministrativi e la loro organizzazione L’accesso alla qualifica di “referendario” (primo livello della carriera di magistrato amministrativo) è subordinato al superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami, la cui partecipazione è riservata a soggetti appartenenti a categorie predeterminate, i quali abbiano svolto per un certo periodo di tempo pubbliche funzioni, o siano dotati di determinati requisiti professionali. Dopo quattro anni di anzianità nella qualifica, in presenza di un giudizio di non demerito, ad opera del Consiglio di Presidenza, è possibile conseguire la nomina a primo referendario; con ulteriori quattro anni di anzianità i primi referendari conseguono la nomina a consigliere T.A.R., secondo la medesima procedura. Per la nomina a consigliere di Stato, si tiene conto del seguente criterio per ricoprire i posti vacanti: a) in ragione della metà, riservati a consiglieri di Tribunale amministrativo, con quattro anni di anzianità nella qualifica, che ne facciano domanda; b) in ragione di un quarto nominati dal Governo, chiamato a scegliere tra professori ordinari di materie giuridiche, avvocati abilitati alle magistrature superiori, con quindici anni di anzianità di effettivo esercizio di attività professionale, ovvero tra dirigenti generali o equiparati dei ministeri, degli organi costituzionali o di altre pubbliche amministrazioni, nonché tra magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d’appello o equiparata; c) in ragione di un quarto ricoperti da candidati che superano un concorso per titoli ed esami teorico-pratici riservato a magistrati amministrativi, ordinari, militari, della Corte dei conti, avvocati dello stato, funzionari della carriera direttiva dello Stato, in possesso dei requisiti richiesti. È stabilito il principio dell’unicità di accesso sia per il T.A.R. che per il Consiglio di Stato. Tra le garanzie riconosciute ai magistrati amministrativi vi è: - Inamovibilità: mantenimento della sede e delle funzioni assegnate che possono venire meno solo in presenza di una specifica deliberazione del Consiglio di Presidenza la quale, necessariamente, deve acquisire il consenso dell'interessato. - “unicità di accesso e di carriera”. In attesa di riforma, l’autogoverno dei giudici amministrativi è affidato ad un unico organismo, denominato Consiglio di Presidenza, composto da undici magistrati (oltre a quattro supplenti, due del T.A.R. e due del Consiglio di Stato) amministrativi di cui uno di diritto (Presidente del Consiglio di Stato) e dieci rappresentanti elettivi scelti da collegi elettivi separati dai consiglieri di Stato (per un numero pari a quattro più due supplenti) e dai magistrati T.A.R. (per un numero pari a sei più due supplenti). Nonostante un’ordinanza di inammissibilità emanata dalla Corte cost. con riferimento alla mancanza di una componente laica all'interno del collegio, il legislatore ha pensato di colmare tale lacuna prevedendo, quattro componenti di estrazione parlamentare (due eletti dal Senato e due dalla Camera) tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o avvocati con iscrizione all’albo da oltre venti anni. I membri elettivi (sia laici che togati) del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Numerose sono le competenze assegnate al Consiglio di presidenza, tra cui l’adozione di tutti i provvedimenti in materia di assunzione, assegnazioni di sede e di funzioni, promozioni, conferimenti di uffici direttivi ed ogni altro profilo connesso allo stato giuridico dei magistrati amministrativi, nonché il conferimento a questi ultimi di incarichi estranei alle loro funzioni; la determinazione delle piante organiche del personale dei T.A.R. e l’eventuale divisione di questi ultimi in Sezioni; l'individuazione dei criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro e l’emanazione del parere obbligatorio concernente la nomina del segretario generale e dei segretari delegati. Questi ultimi formano l’Ufficio del segretariato generale del Consiglio di Presidenza che la legge individua nel segretario generale del Consiglio di Stato, al quale è demandato il compito di coadiuvare il presidente per l’attività preparatoria e durante le sedute, soprattutto per quanto concerne la funzione verbalizzante. Capitolo 2: Gli altri giudici delle controversie con l'amministrazione 1. Il giudice ordinario: cenni Nell’esercizio delle sue funzioni, il giudice ordinario incontra due limiti: 1- secondo i1 criterio di riparto, spettano a tale giudice le controversie aventi ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi (limite esterno); 2- a tale giudice non è consentita l’emanazione di sentenze costitutive nei confronti di atti amministrativi, ritenuti espressione della potestà dell’autorità emanante (limite interno). Conseguentemente al divieto di annullamento, revoca o sospensione dei provvedimenti amministrativi, in nome del principio della separazione dei poteri, è attribuito al giudice ordinario il potere di disapplicazione, consentendogli, così, di decidere la controversia a prescindere dagli effetti dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo ed inidoneo a comprimere il diritto soggettivo di cui si chiede la tutela. In altre parole, per verificare la fondatezza della pretesa dell’attore, qualora la lesione sia riconducibile al provvedimento amministrativo, il giudice può accertarne incidentalmente l’illegittimità. Dopo lunghe discussioni, avutesi sui vizi che possono determinare la disapplicazione dell’atto amministrativo, è stato riconosciuto il sindacato su ogni tipo di vizio, compreso quello sull’eccesso di potere. Tuttavia, accanto alla figura tradizionale di disapplicazione in via incidentale, concernente la maggioranza delle fattispecie, si è configurata, in sede teorica, un’ulteriore tipologia di disapplicazione c.d. principale, laddove l’oggetto del giudizio è concentrato prevalentemente sull’invalidità del provvedimento dal quale dipende la lesione del diritto soggettivo. Tutto questo si verifica allorché la determinazione amministrativa non risulta dotata di imperatività ed esecutorietà, come nel caso dei diritti fondamentali non cedevoli, o nelle ipotesi di provvedimenti emanati in carenza di potere. Si è venuta ad affermare, la convinzione secondo cui, avanti al giudice ordinario, non sarebbe possibile proporre azioni volte ad ottenere qualsiasi modificazione dell’atto amministrativo da questi conosciuto. Di conseguenza, il divieto di emanare sentenze che comportino l’annullamento, la revoca o la sospensione dei provvedimenti sottoposti al sindacato del giudice fa si che all'attore venga inibita non solo la possibilità di esercitare azioni costitutive, ma anche di condanna e possessorie. L’eventuale accoglimento della domanda, determinerebbe un’indebita sostituzione dell’organo giudicante nell'esercizio del potere riservato all'autorità, ritenuto inammissibile dall’ordinamento processuale affermatosi con le riforme del sec. XIX, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale impostazione restrittiva è stata, tuttavia, parzialmente superata con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni possessorie nei confronti della p.a. in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto giuridico controverso risulti disciplinato dal diritto privato, o il provvedimento amministrativo risulti emanato in carenza di potere. Si è discusso sulla possibilità o meno di ammettere le azioni cautelari in grado di sospendere l'efficacia delle determinazioni amministrative. Dette azioni sono consentite nei soli casi in cui non ci si trovi di fronte ad un provvedimento amministrativo, mentre i poteri decisori del giudice ordinario vengono limitati alla semplice condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni causati al destinatario dell’atto, nelle ipotesi in cui questo conservi la giurisdizione. Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad una inversione di tendenza della stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha cominciato ad individuare delle eccezioni alla regola ricordata, con riferimento a quelle fattispecie riconducibili alla tutela di diritti ritenuti indegradabili in quanto riconducibili alla categoria dei diritti fondamentali, a garanzia dei quali è consentita la proposizione di azioni cautelari, strumentali alla salvaguardia del diritto fatto valere in giudizio. Lo stesso legislatore, cominciando a dare concreta attuazione all'art. 113 Cost., è venuto individuando una serie considerevole di ipotesi in cui i limiti contenuti nella legge abolitiva del contenzioso non trovano applicazione, dando luogo ad una giurisdizione piena del giudice ordinario, il quale si trova nella condizione di annullare, sospendere o riformare l’atto amministrativo nell'ambito di un sindacato che si estende ben al di là dell’esclusiva tutela del diritto soggettivo nelle forme tradizionali ricordate. È il caso: - dell’opposizione a sanzioni amministrative; - degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera; - dei provvedimenti di espulsione (nonché delle controversie in ordine alla convalida o revoca del permesso di soggiorno o del ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari); - del ricorso per la tutela giurisdizionale dei dati personali da presentarsi al Tribunale civile da parte dell’interessato avverso i provvedimenti dell’Autorità Garante per la riservatezza dei dati personali; - delle determinazioni emanate in materia di obiezione di coscienza. Parzialmente diverso è, invece, il caso della materia del pubblico impiego, attribuita alla giurisdizione ordinaria. Da un lato, è stato riconosciuto al giudice il potere di adottare “nei confronti delle p.a. tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati”; dall’altro, gli atti amministrativi presupposti possono essere disapplicati e l’eventuale impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa non determina la sospensione del processo avanti al giudice ordinario. Con riguardo al patrocinio delle amministrazioni statali, queste ultime sono difese ex lege dall’Avvocatura dello Stato con sede presso ciascun distretto di Corte di appello. L’art. 25 c.p.c., inoltre, prevede una deroga alla competenza territoriale, in quanto attribuisce la competenza al giudice del luogo ove è presente l’Avvocatura dello Stato, affermando così il criterio del foro erariale. Per quanto concerne gli atti introduttivi del giudizio, questi devono essere notificati all’amministrazione resistente in persona del Ministro competente, presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice adito. Infine, per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario può esperirsi il giudizio di ottemperanza. L’esecuzione forzata si svolge secondo le forme del processo di esecuzione previsto dal codice di procedura civile. Da tempo la giurisprudenza ha ammesso l’esecuzione in forma specifica nei confronti di un soggetto pubblico, senza che ciò determini alcuna ripercussione sul piano della giurisdizione. Tuttavia, continuano a permanere delle eccezioni in materia di espropriazione forzata dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile appartenenti allo Stato o agli enti territoriali. Anche per l’espropriazione di crediti dell'amministrazione si è assistito a vari cambiamenti che hanno portato, in un primo momento, a superare la tradizionale inapplicabilità dell’istituto in parola per i crediti connessi a rapporti di natura pubblicistica, come nel caso delle entrate tributarie. Nell’ultimo decennio si è assistito, comunque, ad una cospicua emanazione di leggi speciali, volte a reintrodurre limiti alla espropriabilità di beni e crediti appartenenti ai pubblici poteri. 2. Gli altri giudici speciali a) Il giudice contabile La Costituzione ha riservato alla Corte dei conti la funzione giurisdizionale “nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge". Rientrano nella giurisdizione contabile i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici funzionari, il contenzioso pensionistico, i giudizi di conto, i giudizi a istanza di parte in materia contabile. Si riconduce il sindacato della Corte dei conti nell’ambito di una giurisdizione piena come tale non sottoposta ad alcun limite per quanto concerne l’accertamento di atti, fatti e comportamenti. Allo stesso tempo, il giudice contabile esercita un sindacato, da un lato, esclusivo, riferito cioè sia ai diritti soggettivi che agli interessi legittimi, dall’altro, sindacatorio, in virtù del quale è possibile estendere il processo anche ad altri soggetti non chiamati a parteciparvi. A seguito dell’istituzione delle Sezioni regionali, è stato realizzato il principio del decentramento della giurisdizione contabile, così come è stata attribuita alle prime tre Sezioni centrali la funzione di giudice di appello. Ad esse si aggiunge una Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana. Presso ogni Sezione opera un procuratore regionale con funzione di pubblico ministero, mentre a livello centrale tale funzione è svolta dal procuratore generale o da un vice procuratore generale. Alle Sezioni Riunite giurisdizionali, composte da tutti i magistrati appartenenti alle varie Sezioni e presiedute dal Presidente della Corte dei conti, è demandato il compito di dirimere i conflitti di competenza, ovvero le questioni di massima ad esse deferite dalle Sezioni giurisdizionali regionali, centrali o su iniziativa del procuratore generale. La competenza territoriale segue il criterio della residenza anagrafica per quanto concerne i casi in materia pensionistica, mentre per i giudizi di responsabilità occorre fare riferimento al luogo dove sono situati i beni o a quello in cui si è verificato il fatto dannoso. Il Collegio delle Sezioni regionali è composto da tre magistrati, compreso il presidente, mentre quelle centrali giudicano con la presenza di cinque magistrati, fatta eccezione per le Sezioni giurisdizionali riunite che invece ne prevedono sette. Il giudizio di responsabilità amministrativa ha inizio con l'esercizio della relativa azione da parte del procuratore regionale il quale, autonomamente o in presenza di una denuncia o di un rapporto, avvia il procedimento volto ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie ipotizzata. A tal fine, la legge attribuisce al procuratore ampi poteri in materia istruttoria. L’istruttoria può concludersi con una proposta di archiviazione, o con l’atto formale di promozione dell’azione rappresentato dall’atto di citazione. In tale seconda evenienza, il procuratore deve invitare il presunto responsabile a dedurre, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni, deduzioni o documenti. Entro 120 giorni (prorogabili) dalla scadenza del termine per la proposizione delle deduzioni deve essere depositata nella segreteria della Sezione la citazione, pena la sua nullità. La citazione verrà notificata agli interessati unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, steso in calce alla stessa. Al Collegio spettano i medesimi poteri istruttori attribuiti al procuratore regionale ed il giudizio si conclude con un’udienza pubblica in cui le parti, tramite i rispettivi legali, svolgono le proprie tesi difensive. Qualora non vengano disposti in sede dibattimentale ulteriori incombenti istruttori, il giudizio si conclude con una sentenza di condanna o di assoluzione del responsabile. Nella prima ipotesi, il Collegio può esercitare il potere riduttivo mediante il quale, tenuto conto delle circostanze, viene ridotta l’entità del danno da rifondere a carico del responsabile. L’esecuzione della sentenza ha luogo tramite la stessa amministrazione beneficiaria della somma liquidata nella pronuncia che accerta la sussistenza del danno erariale. Nel caso di dubbio sulla concreta attuazione delle statuizioni giudiziali è ammesso ricorso, avanti al medesimo collegio che ha emanato la sentenza. L’obbligo degli agenti contabili di presentare il conto giudiziale, è il presupposto che giustifica l’attivazione del giudizio di conto. È un giudizio necessario che si instaura a prescindere dall’esistenza concreta di una controversia. La semplice trasmissione del conto “costituisce l’agente in giudizio”. Qualora ciò non avvenga è previsto un giudizio per la resa del conto, su iniziativa del procuratore regionale, volto a realizzare l’adempimento cui è tenuto l’agente. La regolarità del conto giudiziale, previo esame del consigliere relatore e giudizio favorevole del procuratore, è dichiarata con decreto presidenziale di discarico del contabile. È una fase più propriamente amministrativa, in assenza di contraddittorio, come tale non riconducibile ai procedimenti giurisdizionali. Nell’ipotesi di richiesta di condanna del procuratore, invece, ha inizio la vera e propria fase contenziosa, con la fissazione di un’udienza di discussione nella quale è consentita la difesa dell’agente contabile personalmente o tramite il proprio legale. Tale giudizio termina con una decisione che, se sfavorevole, determina la condanna del responsabile delle violazioni accertate. Avverso detta pronuncia di condanna, entro 30 giorni dalla sua notifica, l’agente può presentare ricorso -opposizione contabile- presso la segreteria della Sezione che ha emanato la decisione, determinando, così, una sorta di prosecuzione del giudizio di conto. Anche in questo caso viene tenuta un’apposita udienza, in cui ha luogo il contraddittorio tra opponente e procuratore, destinata a concludersi con una nuova decisione. Decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che siano stati formulati rilievi da parte dell’amministrazione o degli organi di controllo previsti dall’ordinamento, il giudizio si estingue. Il giudizio pensionistico, ha ad oggetto le controversie sulle pensioni civili e militari degli iscritti alle casse di previdenza, nonché quelle relative alle pensioni di guerra. È un giudizio da ricorso, che prescinde dall’impugnazione degli atti e dei provvedimenti dell’amministrazione, finalizzato all’accertamento del diritto patrimoniale alla pensione fatto valere dal ricorrente. Dal momento che il diritto alla pensione è ritenuto imprescrittibile, il ricorso può essere proposto senza limiti di tempo e va notificato, pena la sua inammissibilità, presso la sede dell’amministrazione o dell’ente competente all’erogazione della pensione. Nei successivi 30 giorni il ricorso deve essere depositato unitamente alla prova delle avvenute notifiche. La causa viene decisa da un giudice monocratico, in funzione di giudice unico, appartenente alla Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio. Con istanza separata, o con domanda specifica inserita nel ricorso principale, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato od ogni altra misura cautelare in grado di salvaguardare la situazione soggettiva che si intende tutelare nel corso del giudizio. Tuttavia, in materia cautelare, il giudice monocratico non è competente e la pronuncia su tale specifico profilo è rimessa al collegio. Al termine dell'udienza di discussione, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, il giudice monocratico definisce il giudizio con sentenza che può essere emessa anche in forma semplificata. Detta pronuncia è esecutiva, a meno che non ne venga disposta la sospensione dal giudice di appello con ordinanza non impugnabile e, nel caso di mancata osservanza da parte dell’amministrazione al dictum del giudice, può chiedersi l’intervento della stessa Sezione giurisdizionale regionale, titolare dei medesimi poteri attribuiti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorsi cinque anni senza che sia intervenuta una pronuncia sul ricorso, si applica anche ai giudizi pensionistici l’istituto della perenzione automatica. Giudizi ad istanza di parte: contenziosi azionati da privati per la tutela di diritti patrimoniali nei confronti delle amministrazioni, quali i ricorsi per contestazioni fra contabili, i ricorsi contro ritenute cautelari, ricorsi per rimborso quote inesigibili, ricorsi in materia di determinazione e corresponsione dell’aggio esattoriale o del compenso dovuto ai tesorieri. Avverso le sentenze della Sezione regionale giurisdizionale è ammesso appello alle Sezioni giurisdizionali centrali, o a quella di appello per la Regione siciliana, entro sessanta giorni dalla relativa notifica. È un giudizio tipicamente devolutivo, caratterizzato dal principio del divieto di ius novorum. L’atto di appello, sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, deve essere notificato a tutte le parti sostanziali del rapporto giuridico controverso e non solo a quelle che formalmente hanno partecipato al giudizio di primo grado. La proposizione dell’appello sospende in automatico l’esecutività della sentenza di primo grado, a meno che il procuratore regionale non avanzi una richiesta, adeguatamente motivata, di provvedere alla provvisoria esecuzione, sulla quale la Sezione di appello è chiamata a pronunciarsi. All’esito della discussione viene emessa una sentenza, seguendo le stesse modalità del giudizio di primo grado. Tali decisioni sono impugnabili avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione, esclusivamente per motivi inerenti la giurisdizione, nonché mediante ricorso per revocazione da proporsi, ad opera delle parti o del pubblico ministero, nei confronti del medesimo giudice che ha emanato la sentenza. b) Il giudice tributario: cenni La risoluzione delle liti tra cittadini ed amministrazione finanziaria o altri enti impositori è affidata ai giudici speciali del contenzioso tributario. Tale scelta si spiega soprattutto con l’esigenza di non aumentare il carico di lavoro dei giudici ordinari ed amministrativi. Il sistema attuale si articola in Commissioni tributarie provinciali, quali organi di primo grado con riferimento agli atti emanati dai soggetti con sede nell'ambito provinciale, e Commissioni tributarie regionali che esercitano le proprie funzioni quali giudici di seconda istanza. Avverso le pronunce di queste ultime è ammesso ricorso in Cassazione. Ogni Commissione si articola in Sezioni ed ogni Sezione è composta da un presidente, un vice-presidente e da almeno quattro giudici tributari, dotati di una particolare qualificazione professionale. Nel 1992 è stato istituito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, quale organo di autogoverno dei giudici tributari. Si può proporre ricorso avverso gli atti impositivi concernenti tutti i principali tributi, compresi i tributi comunali e locali non previsti dalla normativa previgente. Sono parti del giudizio il ricorrente e l’Ufficio del ministero dell’economia e delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato, in qualità di creditore e debitore del rapporto d’imposta in contestazione. È previsto il potere di sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato da parte del giudice tributario, potere, quest’ultimo, riconosciuto solo in via amministrativa all’Intendenza di Finanza. Entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado può proporsi appello alla Commissione tributaria regionale, seguendo le stesse modalità del procedimento di primo grado; in tale sede non possono essere proposte domande nuove e di regola non potrebbero essere disposti nuovi incombenti istruttori. Sono stabilite tutte le ipotesi in cui le pronunce delle Commissioni possono essere impugnate in Cassazione, e sono disciplinati i casi che possono condurre ad una revocazione della sentenza. Infine, è disciplinato il giudizio di ottemperanza in materia tributaria laddove l’amministrazione non provveda a dare attuazione a quanto stabilito dalle sentenze delle Commissioni tributarie passate in giudicato. c) Il giudice delle acque pubbliche I Tribunali regionali delle acque pubbliche, istituiti presso otto Sezioni di Corte di appello, composti, oltre che dai magistrati ordinari assegnati alla Sezione, dal Presidente, da tre esperti (che esercitano un mandato di cinque anni e possono essere riconfermati) iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello. Ad essi spetta la giurisdizione in materia di diritti soggettivi e per questo possono considerarsi, oltre che per la loro composizione, un'articolazione del giudice ordinario nei confronti degli atti dell’amministrazione emanati in tale materia. Più in particolare, i Tribunali regionali giudicano sull'utilizzazione delle acque; sui limiti dei corsi e dei bacini; sui diritti relativi a derivazioni ed utilizzazione di acque pubbliche; sulle indennità e sui risarcimenti per occupazioni totali, parziali, permanenti o temporanee di fondi ed espropriazioni occorrenti per l’esecuzione o la manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione e utilizzo delle acque; risarcimento danni derivanti dall’esecuzione di opere idrauliche da parte dell’amministrazione; appello contro le sentenze del giudice unico pronunciate a seguito della proposizione di azioni possessorie, nonché sulle denunce di nuova opera e di danno temuto, in materia di acque pubbliche. Il giudizio segue le regole del processo civile, attribuendo al collegio i medesimi poteri cognitori e decisori spettanti al giudice ordinario. Avverso le sentenze dei Tribunali regionali, tranne nei casi stabiliti, può essere proposto appello al Tribunale superiore delle acque, con sede a Roma e composto oltre che dal Presidente, nominato fra i magistrati ordinari con qualifica corrispondente a procuratore generale della Corte di Cassazione, da quattro consiglieri di Cassazione, quattro consiglieri di Stato e tre esperti nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore, tutti nominati per un mandato di cinque anni e rinnovabili nell’incarico. Al Tribunale superiore va riconosciuta natura mista in quanto svolge funzione di giudice ordinario quando si atteggia quale organo di secondo grado nei confronti delle sentenze emanate dai Tribunali regionali, mentre nelle altre materie di sua competenza, attinenti anche ad interessi legittimi, si atteggia come giudice amministrativo. Più in particolare, è titolare, in unico grado, di una competenza generale di legittimità per i ricorsi volti a censurare i provvedimenti emanati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, tra cui quelli diretti alla realizzazione di opere idrauliche e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le decisioni direttamente incidenti sul regime delle acque o sulla loro potabilità. In tali ipotesi il Tribunale superiore provvede ad emanare sentenze di annullamento, mentre non gli è consentito pronunciare sentenze di accertamento o di condanna fatta eccezione per la condanna alle spese. È attribuita inoltre alla cognizione del Tribunale superiore delle acque una competenza speciale di merito sui ricorsi avverso le contravvenzioni alle norme di polizia demaniale e su quelli concernenti le decisioni di riduzione in pristino dello stato dei beni del demanio idrico, unitamente ad una competenza in materia di diritti di pesca. Infine, ha competenza sia in grado di appello che in sede di legittimità anche per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione. Le regole del processo, per quanto non previsto espressamente, sono quelle che regolano il giudizio avanti il Consiglio di Stato. È possibile instaurare il giudizio entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento lesivo, secondo lo schema classico del processo amministrativo. L’appello avverso le sentenze dei Tribunali regionali delle acque è proponibile entro trenta giorni dalla notifica della pronuncia dell’organo di primo grado, o entro sei mesi dal deposito della sentenza. In caso di mancata esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione soccombente, il relativo giudizio è di competenza del Consiglio di Stato nell’ipotesi in cui la sentenza sia stata emessa dal Tribunale superiore quale giudice di appello, mentre negli altri casi la competenza è dello stesso Tribunale superiore. Infine, contro le pronunce del Tribunale superiore delle acque è ammesso ricorso per revocazione, nonché ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sia per violazione di legge che per difetto di motivazione. d) I giudici parlamentari In seguito alla modifica del regolamento della Camera dei deputati, per la prima volta è stato affermato il principio secondo cui “i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima” seguono la disciplina prevista per la tutela giurisdizionale dei dipendenti di tale ramo del Parlamento. Il nuovo regolamento prevede due organi interni, ai quali viene affidato il contenzioso: il Consiglio di giurisdizione, con competenza delle controversie di primo grado e la Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza cui vengono attribuiti i giudizi in appello. In alcuni casi le funzioni di appello vengono svolte direttamente dall’Ufficio di presidenza anziché dalla Sezione giurisdizionale. Gli organi sono composti da deputati, in possesso di determinate qualifiche in grado di garantirne la professionalità e l'indipendenza, nominati dal Presidente della Camera il quale provvede ad individuare, oltre ai membri effettivi, i supplenti. Il procedimento ricalca quello previsto per lo svolgimento del giudizio avanti al giudice amministrativo, da ritenersi pertanto quale modello di riferimento nelle ipotesi di lacuna della normativa. Organi giudicanti similari esistono presso il Senato della Repubblica. Nonostante le novità introdotte da tale disciplina, permane in dottrina un certo scetticismo nei confronti della autodichia degli organi costituzionali la quale, oltre ad evitare il controllo di legittimità della Corte costituzionale per tutta una serie di determinazioni di uno dei due rami del Parlamento, parrebbe non in linea con il diritto comunitario in quei settori di attività della Camera avente rilevanza esterna. Tuttavia, la giurisprudenza, anche recentemente, sembra non tener conto delle critiche formulate in sede teorica e persiste nel declinare la propria giurisdizione allorché provvedimenti della Camera dei deputati vengono sottoposti al suo sindacato, arrestandosi di fronte alla giurisdizione domestica di quest’ultima, dichiarando nel contempo l’improponibilità della questione di costituzionalità, in ossequio al consolidato orientamento del giudice delle leggi. È stata esclusa perfino la ricorribilità in Cassazione avverso le “sentenze” dei giudici parlamentari, dato che, trattandosi di giurisdizione domestica, sarebbe assente la terzietà del giudice, e non potrebbero tali organi essere considerati giudici speciali, se non in senso formalistico. Inversione di tendenza: viene affermata la competenza dell’Ufficio di Presidenza a giudicare dei ricorsi in materia di stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza, disciplina dei dipendenti “nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentati da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima”. Sono state apportate modifiche volte a consentire un adeguamento del sistema di giurisdizione domestica con i principi dell’art. 6, Convenzione dei diritti dell’Uomo. 3. L’arbitrato: cenni e rinvio Art. 12 del Codice: “Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”. Sembra trovare accoglimento, sia pure parzialmente, la soluzione prefigurata dalla dottrina più sensibile che nell'ultimo decennio si è impegnata a superare l’intransigenza della giurisprudenza nel ribadire la propria avversione all’utilizzazione dell’arbitrato per la soluzione di controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione. Tale preclusione muoveva dalla considerazione che risultavano compromettibili in arbitri esclusivamente quelle fattispecie altrimenti attribuite alla competenza del giudice ordinario, come tali concernenti questioni ritenute disponibili dalle parti. L’estensione dei casi di giurisdizione esclusiva ha probabilmente indotto il legislatore a riprendere in considerazione gli spunti ed i fermenti che si erano registrati in dottrina, cogliendo l'occasione delle nuove disposizioni in materia di processo amministrativo per aggiungere l’arbitrato tra i rimedi predisposti dal nostro modello processuale. La scelta operata dal legislatore non risolve completamente i problemi i quali si ripropongono anche in seguito alle novità introdotte. 1- Quello del giudice competente a dirimere le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del lodo arbitrale. Appare difficile escludere la competenza per l’impugnazione delle pronunce dei collegi arbitrali in capo alla Corte d’Appello, in base alla disciplina di cui all’art. 828 c.p.c. Seguendo tale impostazione, tuttavia, si potrebbe profilare una sorta di deroga in tema di riparto delle giurisdizioni, posto che, proprio attraverso l’impugnazione del lodo, la cognizione della controversia viene di fatto ad essere spostata dal giudice amministrativo al giudice ordinario, rischiando un possibile contrasto con gli artt. 25 e 103 Cost. 2- Permangono tuttora delle incertezze in ordine al tipo di situazioni soggettive cui estendere la previsione dell’art. 12, tenuto conto della possibilità di attrarre, all'interno della formula “controversie concernenti diritti soggettivi”, anche fattispecie per lungo tempo escluse dal novero delle posizioni tutelabili dall’ordinamento. È questo il caso del risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi, in relazione al quale la compromettibilità in arbitri risulterà strettamente connessa alla riconduzione o meno di tale pretesa alla nozione di diritto soggettivo, operazione, quest’ultima, non proprio agevole sulla scorta delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte cost. n. 204/2004, che ha fornito una ricostruzione della tutela risarcitoria in linea con l'art. 103 Cost., dinanzi alla volontà esplicita del legislatore di attribuirne la cognizione al giudice amministrativo. Una volta affermata ad opera dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la necessaria pregiudizialità dell’azione di annullamento rispetto a quella volta al ristoro dei danni arrecati dall’azione illegittima dei pubblici poteri, non si intuiscono i vantaggi discendenti dal possibile ricorso all’arbitrato per la quantificazione delle misure risarcitorie da riconoscere alla parte vittoriosa avanti al giudice amministrativo, dal momento che a quest’ultimo l’ordinamento assegna la competenza a svolgere tale valutazione, senza dar luogo ad inutili duplicazioni di procedimenti. 3- Non meno problematica appare la compromissibilità in arbitri, in deroga alla giurisdizione esclusiva, di quelle fattispecie che possono essere ricondotte alla c.d. attività negoziata della pubblica amministrazione. Ed infatti, sia che si verta nelle ipotesi di accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento finale, ovvero di convenzioni tra enti pubblici o accordi di programma tra diversi enti pubblici/locali, la possibilità di identificare dei veri e propri diritti soggettivi risulterà strettamente correlata alla qualificazione in termini privatistici o pubblicistici degli istituti in esame. Con la conseguenza che solo nella prima ipotesi risulterà applicabile la disciplina ex art. 12 del Codice. Non è da escludere, se non addirittura auspicabile, un futuro intervento del legislatore, volto a definire con maggiore precisione i contorni ed i limiti applicativi dell'istituto preso in considerazione, allo scopo di risolvere ex ante questioni suscettibili di interpretazioni troppo distanti, come tali ostative ad una proficua utilizzazione delle potenzialità tipiche della procedura arbitrale anche per la risoluzione di controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione. Capitolo 3: L’ambito della giurisdizione dei giudice amministrativo l. Il riparto di giurisdizione Il nostro sistema di giustizia amministrativa, si caratterizza per la presenza di due giudici, uno ordinario, competente a giudicare della lesione dei diritti soggettivi, e l'altro amministrativo, competente a giudicare della lesione degli interessi legittimi. Il problema di questo sistema dualista è sempre stato quello di fissare il criterio sulla base del quale determinare il giudice competente. Il punto controverso è sempre stato quello di capire se il riparto dovesse fondarsi sul criterio del petitum o della causa petendi (o petitum sostanziale). In base al primo criterio il giudice competente viene individuato in ragione del tipo di pronuncia richiesta. Più nello specifico, se si chiede l'annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, il giudice competente è il giudice amministrativo; se si chiede una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni, il giudice competente è il giudice ordinario. L’applicazione del criterio del petitum determina quali conseguenze che: 1. il diritto soggettivo leso può essere fatto valere come interesse legittimo attraverso la richiesta di annullamento del provvedimento illegittimo; 2. il sistema di giustizia amministrativa è in grado di offrire una doppia tutela in quanto è possibile alternativamente (in teoria anche cumulativamente) rivolgersi al giudice amministrativo per contestare le modalità di esercizio del potere e al giudice civile per far valere, invece, le conseguenze patrimoniali sfavorevoli derivanti dall’esercizio del potere amministrativo. In base al secondo criterio (causa petendi) la giurisdizione si radica sulla base della natura della situazione giuridica che si assume lesa. Se ad essere leso è un diritto soggettivo, il giudice competente è quello ordinario; se ad essere leso è un interesse legittimo, il giudice competente è quello amministrativo. L’applicazione del criterio della causa petendi comporta che: a) non vi può una doppia tutela poiché ogni situazione giuridica soggettiva ha la tutela sua propria, affidata ad un giudice diverso; b) ogniqualvolta il giudice travalica le proprie attribuzioni si pone una questione attinente alla giurisdizione. Affermatosi il principio secondo il quale il criterio di riparto risiede nella causa petendi o petitum sostanziale, giurisprudenza e dottrina hanno dovuto affrontare il successivo problema di individuare ulteriori criteri sulla cui base qualificare una lite tra pubblica amministrazione e privato in termini di controversia concernente la lesione di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo. Le principali strade percorse a tal fine hanno fatto leva su: a) la teoria della degradazione dei diritti; b) la distinzione tra carenza di potere e scorretto esercizio del potere c) la distinzione tra norme di relazione e norme di azione; d) la distinzione tra potere discrezionale e potere vincolato; e) la natura meramente dichiarativa di determinati atti amministrativi. a) Secondo la teoria della “degradazione dei diritti soggettivi in interessi legittimi”, accolta dalla giurisprudenza verso la fine degli anni 40, i diritti soggettivi colpiti dall'esercizio delle potestà amministrative degradano in interessi legittimi, con conseguente competenza del giudice amministrativo a conoscere della relativa controversia. La teoria della degradazione ha suscitato e suscita tuttora forti perplessità. Alla base di essa vi è un problema processuale, quello di capire quale sia il giudice competente nell’ipotesi in cui il provvedimento illegittimo abbia prodotto effetti su un diritto soggettivo del privato. Problema che venne risolto affermando per l’appunto che il diritto soggettivo degraderebbe, quando colpito dagli effetti connessi all’adozione del provvedimento, ad interesse legittimo, con conseguente competenza del giudice amministrativo. L’effetto di degradazione del diritto ad interesse, viene a mancare, a giudizio della giurisprudenza, in una serie di ipotesi il cui tratto comune è costituito dal fatto che, ancorché si sia in presenza di poteri amministrativi, il diritto del privato è per sua natura “non degradabile” ad opera di provvedimenti della p.a. L’indegradabilità viene solitamente ricavata dalla giurisprudenza: dalla disciplina della fattispecie, che riconosce al soggetto un diritto sottratto ad ogni apprezzamento della pubblica amministrazione; dalla natura privatistica del rapporto nel cui ambito sono presenti sia diritti soggettivi sia atti amministrativi; dal rango costituzionale del diritto soggettivo intercettato dall'esercizio del potere amministrativo. Quest’ultimo gruppo di casi è il più rilevante in quanto la mancata produzione dell’effetto di degradazione deriva dal particolare rango del diritto spettante al privato e, più in particolare, dalla sua natura di diritto riconosciuto e protetto come fondamentale da una previsione di livello costituzionale. Muovendo da tale premessa si è venuta enucleando la categoria dei diritti cosiddetti resistenti o non degradabili in quanto costituzionalmente garantiti. Di recente la Corte Costituzionale, ha messo in discussione la categoria dei diritti degradabili affermando che il giudice amministrativo è “idoneo ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa”. Da ciò sembrerebbe discendere l'impossibilità di aderire a qualsiasi tesi che, muovendo dalla categoria dei diritti definiti variamente indegradabili o resistenti o, usando la terminologia più recente, incomprimibili, predichi limiti assoluti alla giurisdizione amministrativa allorquando l’esercizio del potere amministrativo produca i propri effetti sui summenzionati diritti. b) Le Sezioni Unite hanno adottato il criterio di riparto basato sulla formula “carenza di potere scorretto esercizio del potere”. Secondo tale criterio, si ha carenza di potere quando si contesta la stessa esistenza del potere amministrativo, mentre si ha scorretto esercizio del medesimo quando si contesta il suo illegittimo esercizio. Nel primo caso la controversia riguarda il diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario; nel secondo caso la controversia riguarda l’interesse legittimo e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Il criterio di riparto è arrivato pressoché immutato fino ai giorni nostri. Il criterio di riparto basato sulla distinzione tra carenza e scorretto esercizio del potere è stato poi ulteriormente precisato dalla Cassazione nel senso che, per verificare se vi sia carenza di potere, non si deve guardare unicamente all’esistenza o meno della norma attributiva del potere; bisogna invece avere riguardo e valutare l’esistenza in concreto di quei presupposti giuridici e fattuali che la norma stessa fissa al fine di consentire l’esercizio del potere. Secondo tale orientamento, il potere si ritiene inesistente (con conseguente esclusione della degradazione del diritto soggettivo) non solo nei casi di mancanza della relativa attribuzione, ma anche quando manchino i presupposti per il suo esercizio. Ad esempio, se per l'adozione di un certo provvedimento è richiesto dalla legge il presupposto dell’urgenza, ma tale presupposto non ricorre nella fattispecie concreta, non si ha cattivo esercizio di un potere esistente, ma carenza di potere. Ed ancora, se per l’esercizio del potere è stabilito un termine perentorio, il detto esercizio oltre il termine concreta un’ipotesi di carenza di potere. c) Altro criterio di riparto della giurisdizione è quello, di origine dottrinale, basato sulla distinzione tra norme di relazione e norme di azione. In base a detto criterio si ritiene che si sia in presenza di una norma d’azione quando la relativa disciplina è volta a tutelare in via diretta l'interesse pubblico; che si sia in presenza di una norma di relazione quando la relativa disciplina è volta a tutelare in via principale l’interesse del privato. Da ciò scaturiscono alcune conseguenze sul piano sostanziale e processuale: nel primo caso (esistenza di una norma d’azione) il privato è titolare di un interesse legittimo e dunque la controversia appartiene al giudice amministrativo; nel secondo caso (esistenza di una norma di relazione) il privato è titolare di un diritto soggettivo e dunque la controversia appartiene al giudice ordinario. In materia di aiuti comunitari si è stabilito che le controversie sono di diritto soggettivo, e quindi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinino direttamente e automaticamente obbligazioni di diritto pubblico, senza alcun margine di valutazioni e apprezzamenti discrezionali; sono di interesse legittimo, e quindi spettano al giudice amministrativo, allorquando l’erogazione dei contributi non discenda automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti, ma costituisca esercizio di una funzione discrezionale disciplinata da norme di azione e non di relazione. La dottrina maggioritaria ha criticato tutto ciò, sostenendo che la distinzione tra norme d’azione e norme di relazione sarebbe meramente descrittiva, nulla dicendo sui connotati delle norme dell’una e dell’altra categoria e sul modo di riconoscerle; essa riproporrebbe tutti i problemi e le incertezze che caratterizzano la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. d) Sempre in tema di criteri di riparto assume un certo rilievo la questione della distinzione tra attività vincolata e attività discrezionale. In proposito vi è un primo orientamento dottrinale volto a ritenere che si abbia esercizio di potere amministrativo ogniqualvolta vi sia la produzione unilaterale di effetti giuridici o ogniqualvolta vi sia una competenza riservata alla p.a. di assumere determinazioni produttive di effetti giuridici. In questa prospettiva, non ha alcun valore, ai fini dell’identificazione dei casi in cui si ha esercizio di potere, la distinzione tra attività amministrativa vincolata ed attività amministrativa discrezionale. Tanto che l’atto sia vincolato quanto che sia discrezionale è sempre la decisione della p.a. a produrre l’effetto giuridico indipendentemente dal consenso del destinatario. Dunque vi è una tendenziale equivalenza tra attività unilaterale della p.a. ed esercizio delle potestà amministrative. Esiste però un diverso orientamento dottrinale il quale ritiene invece che di esercizio del potere da parte della p.a. si possa parlare solo nell'ipotesi in cui la relativa attività abbia carattere discrezionale. Secondo tale orientamento, quando vi è attività interamente vincolata della pubblica amministrazione, quest’ultima altro non deve fare se non accertare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e la fattispecie astratta prevista dalla norma: una volta accertata tale corrispondenza, l’assetto di interessi che si deve avere nel caso concreto è già interamente predeterminato dalla norma, sicché l’atto della p.a. appare come mero momento ricognitivo di una volontà già cristallizzata nella norma che disciplina il caso concreto. Viceversa nel caso di attività discrezionale si può parlare di esercizio del potere, dal momento che la p.a. con la propria decisione definisce in ragione della cura dell’interesse pubblico un assetto di interessi non interamente ricavabile dalla norma e dunque produce effetti giuridici innovativi in modo autoritativo. Se si accede a questa ricostruzione, ne discende che a fronte dell’attività vincolata, pur unilateralmente esercitata, il privato vanti non interessi legittimi ma diritti soggettivi; mentre a fronte dell’attività discrezionale, essendoci in questo caso esercizio di potere amministrativo, il privato non può che vantare interessi legittimi. Da ciò discende che nel primo caso la competenza a giudicare della lesione della posizione del privato spetta al giudice ordinario, mentre nel secondo caso spetta al giudice amministrativo. I diversi orientamenti, divergono sul significato stesso da attribuire al concetto di potere: mentre il primo orientamento ritiene che il potere sia la capacità di produrre unilateralmente effetti giuridici, il secondo ritiene che il potere sia la capacità di produrre unilateralmente effetti giuridici innovativi nel senso che tali effetti non debbono già essere interamente predeterminati da altra fonte. Con riguardo alla giurisprudenza, il Consiglio di Stato si è andato orientando nel senso che, se “la presenza di elementi discrezionali esclude normalmente la giurisdizione del giudice ordinario”, il carattere vincolato dell’attività non basta viceversa per affermare la sussistenza di un diritto soggettivo, potendo esserci doveri giuridici a carico dell’amministrazione ai quali non corrisponda alcun diritto a favore di privati. La giurisprudenza più recente annette rilevanza alla distinzione tra attività discrezionale e vincolata ai fini del riparto di giurisdizione soprattutto in relazione ad alcune fattispecie quali in particolare il potere della p.a. di imporre prestazioni patrimoniali a privati (potere impositivo), le obbligazioni pubbliche aventi ad oggetto somme di denaro erogate a vario titolo in favore dei privati; la materia dell’iscrizione agli albi professionali. In questi casi viene di solito riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario. e) Rilievo ha anche la qualificazione di alcuni atti amministrativi come atti dichiarativi o meramente ricognitivi (di un assetto di interessi già predeterminato dalla norma). Gli atti in questione sono intesi in termini di atti vincolati onde rimarcare lo stretto nesso esistente tra il carattere “meramente dichiarativo” di un atto e l’assenza di discrezionalità amministrativa. La casistica in proposito è abbastanza ricca: sono stati definiti "atti vincolati a carattere meramente dichiarativo” il provvedimento di decadenza dalla concessione edilizia per decorso dei termini indicati nell’atto; il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione al commercio dopo la scadenza del relativo termine; l’atto di acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo; il procedimento di accertamento dello stato di invalidità civile, con la conseguenza che l'azione giudiziaria volta a contestare il diniego da parte della pubblica amministrazione dei connessi benefici “non costituisce impugnativa dell’atto amministrativo, ma richiesta di un autonomo accertamento dei presupposti del diritto”. È comunque orientamento costante quello in base al quale l'atto dichiarativo privo di discrezionalità non produce degradazione ad interesse legittimo del diritto soggettivo. 2. Le situazioni giuridiche soggettive dei privati Le situazioni giuridiche soggettive, che il privato può vantare nei confronti della p.a. e della relativa attività, sono il diritto soggettivo e l’interesse legittimo. Ciò si ricava soprattutto: - dall’art. 113 il quale recita che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa; - dall’art. 24 in base al quale tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; - dall’art. 103 in base al quale il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della p.a. degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Oggi ciò risulta confermato nel Codice (art. art. 7, comma 1. Il fatto che il privato può vantare diritti soggettivi ed interessi legittimi ha comportato che in dottrina e in giurisprudenza si sia posta una serie di problemi di non poco conto. In primo luogo si è posta la questione di definire le caratteristiche dell’interesse legittimo quale situazione giuridica soggettiva e dunque di individuare in particolare quale ne sia l’oggetto e quali le forme ed i modi di protezione. In secondo luogo si è posta la questione di capire quando il privato possa vantare nei confronti della pubblica amministrazione e della relativa azione un diritto soggettivo o un interesse legittimo. Infine, si è posta la questione di definire il criterio in base al quale individuare il giudice competente. 3. L’interesse legittimo quale situazione correlata alla potestà Altro dato controverso sta nell’affermazione che l’interesse legittimo è situazione giuridica soggettiva correlata all’esercizio delle potestà amministrative o, secondo altra prospettiva, è situazione giuridica soggettiva (l’unica) utilizzabile a fini di tutela nei confronti dell’esercizio delle suddette potestà. Le potestà in questione hanno questo di caratteristico: che per il tramite del loro esercizio è possibile produrre effetti giuridici unilaterali di tipo limitativo o ampliativo nei confronti degli interessi del privato. Si pensi in relazione alla prima ipotesi al decreto di esproprio, il quale estingue il diritto di proprietà del privato, ed in relazione alla seconda al provvedimento concessorio di utilizzazione di un bene demaniale, a seguito del quale sorge in capo al privato un vero e proprio diritto soggettivo. Dagli esempi fatti si ricava in primo luogo che gli interessi dei privati, i quali sono oggetto dell’esercizio delle potestà amministrative, nel senso che su di essi si producono i relativi effetti giuridici, possono avere sul piano dell’ordinamento generale tanto la consistenza di un diritto soggettivo quanto la consistenza di un interesse di fatto. Tali interessi, quale che sia la loro consistenza sul piano dell’ordinamento generale, non possono essere comunque utilizzati per tutelare il titolare nei confronti dell'esercizio delle potestà amministrative atteso che queste, se legittimamente esercitate, non trovano limiti in detti interessi (definiti interessi finali o interessi sostanziali od anche interessi al bene della vita) ben potendo questi ultimi, ove le esigenze di cura dell’interesse pubblico lo giustifichino, risultare sacrificati (come nel primo esempio) o rimanere insoddisfatti (come nel secondo esempio). Se tutela del privato ci deve essere, essa allora non può che collocarsi in quello spazio all’interno del quale le potestà trovano i propri limiti e dunque nello spazio costituito dalle regole giuridiche che disciplinano le potestà medesime la cui inosservanza dà luogo al fenomeno della illegittimità dei provvedimenti e più in generale dell’azione amministrativa. Questo spazio non può essere occupato in primo luogo dai diritti soggettivi sui quali si scaricano gli effetti delle potestà amministrative, perché se ci fossero diritti soggettivi a fronte delle predette potestà, atteso che tali diritti sono protetti dall’ordinamento in modo pieno e diretto, impedendo cioè ogni lesione da parte di terzi, la loro sussistenza equivarrebbe a negare la sussistenza di ogni e qualsiasi potestà che possa esplicarsi nei loro confronti e che possa legittimamente pregiudicarli (ossia limitarli o sacrificarli del tutto). Ma lo spazio in questione non può essere occupato neanche dagli interessi del privato la cui soddisfazione richiede un provvedimento favorevole e dunque costitutivo di situazioni giuridiche soggettive “nuove”, sia perché questi interessi risultano, prima dell’adozione del relativo provvedimento, meri interessi sia perché essi possono rimanere legittimamente insoddisfatti. Stando così le cose è necessario disporre di una situazione giuridica soggettiva diversa dal diritto soggettivo al fine di tutelare il privato di fronte al non corretto esercizio del potere amministrativo e questa situazione è, per l'appunto, l’interesse legittimo il quale è sempre collegato ad un interesse finale del privato. Dunque correlare strettamente l’interesse legittimo alle potestà amministrative, come la dottrina fa, significa riconoscere esattamente che, se si vuole avere tutela di fronte alle predette potestà, occorre contrapporre ad esse una peculiare situazione giuridica di vantaggio. Si può sinteticamente dire che l’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva attiva che fronteggia un’altra situazione giuridica soggettiva attiva costituita dalla potestà amministrativa. Affermando ciò, si può ancor meglio apprezzare la differenza tra l’interesse legittimo e il diritto soggettivo. Mentre il primo è situazione giuridica soggettiva attiva, collocata a fronte di un’altra situazione anch’essa attiva, il diritto soggettivo è situazione giuridica soggettiva attiva a fronte della quale non possono che collocarsi situazioni giuridiche soggettive passive (obblighi e doveri). La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato nell’ambito della categoria dell’interesse legittimo, una distinzione: - oppositivi: se gli effetti dell’esercizio delle potestà amministrative si configurano come sacrificativi rispetto all’interesse finale (es. decreto di esproprio). In questo caso il privato ha interesse ad opporsi all’esercizio delle potestà amministrative; - pretensivi: se gli effetti dell’esercizio delle potestà amministrative si configurano come ampliativi dell’interesse finale. In questo caso il privato ha interesse a che le potestà amministrative vengano esercitate in senso per sé favorevole. L’interesse legittimo oppositivo è collegato ad un interesse finale che ha di regola, sul piano dell’ordinamento generale e prima dell’esercizio delle potestà, la consistenza di un diritto soggettivo, mentre l’interesse legittimo pretensivo è collegato ad un interesse finale che ha di regola, sul piano dell’ordinamento generale e prima dell’esercizio delle potestà, la consistenza di un mero interesse che ambisce, proprio attraverso l’esercizio delle potestà medesime, ad acquisire un’autonoma rilevanza giuridica (si pensi all’interesse dell’imprenditore ad avere dei contributi finanziari da parte della pubblica amministrazione). La distinzione ha un mero valore descrittivo nel senso che descrive il diverso atteggiarsi dell’interesse finale, che è sempre collegato all’interesse legittimo, a fronte dell’esercizio delle potestà amministrative, ma non ha valore concettuale. 4. L'interesse legittimo ed il suo oggetto: orientamenti recenti Per comprendere le caratteristiche dell'interesse legittimo, ed in particolare quale sia il suo oggetto, ovvero l’interesse protetto, occorre partire dal fatto che lo spazio entro cui si colloca l’interesse legittimo è quello rappresentato dai limiti posti normativamente all’esercizio delle potestà amministrative. Se questi limiti non sono superati o, per meglio dire, non sono violati, le predette potestà sono esercitate in modo del tutto legittimo e altrettanto legittimo è l'eventuale sacrificio o l’eventuale non soddisfazione imposti, in ragione delle esigenze di cura dell’interesse pubblico, agli interessi finali del privato. Se però i suddetti limiti risultano superati o, per meglio dire, violati, le potestà amministrative risultano esercitate in modo illegittimo e, dunque, non tollerabile si palesa l’eventuale sacrificio o l'eventuale non soddisfazione imposti agli interessi finali. Dunque: dal sacrificio degli interessi finali nasce sempre un bisogno di tutela. Solo che: nel primo caso tale bisogno non supera la soglia del giuridicamente rilevante e dunque non può ricevere protezione alcuna, atteso che le potestà sono conferite al fine della cura dell’interesse pubblico e in quanto tali possono legittimamente ledere o lasciare insoddisfatti gli interessi privati; nel secondo caso il bisogno di tutela del privato è giuridicamente rilevante in quanto il sacrificio imposto all’interesse finale o la sua non soddisfazione avvengono attraverso un esercizio illegittimo delle potestà amministrative e dunque avvengono oltrepassando quel limite (la legittimità dell’azione amministrativa) al di qua del quale non vi è tutela giuridica. Un primo orientamento, muovendo dalla constatazione che al superamento dei limiti posti all’esercizio delle potestà amministrative si determina un illegittimo sacrificio o un’illegittima non soddisfazione degli interessi finali e che d’altronde questi ultimi non possono ricevere contro di esse protezione piena e diretta, afferma che l’interesse legittimo non può che consistere nella pretesa al corretto esercizio delle potestà amministrative o con altra terminologia nella pretesa alla legittimità del provvedimento amministrativo. Tale pretesa costituisce dunque l’interesse che è oggetto di protezione da parte dell’interesse legittimo. Secondo questo orientamento l'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta al privato avente carattere strumentale: di vantaggio perché tutela attivamente il privato nei confronti dell'azione amministrativa illegittima; strumentale perché comporta l’eventuale ed indiretta tutela dell’interesse finale. A questa posizione si è obiettato che la pretesa al corretto esercizio del potere, ovvero alla legittimità del provvedimento amministrativo non può costituire l’oggetto dell’interesse legittimo ove questo sia riconosciuto come situazione giuridica soggettiva: se è infatti proprio di ogni situazione giuridica soggettiva quella di spettare al singolo e di tutelare un suo interesse, l’interesse al corretto esercizio del potere, ovvero alla legittimità del provvedimento, è un interesse che in via generale si appunta in capo a tutti i soggetti dell’ordinamento (compresa la p.a.). Per superare questa obiezione coloro che aderiscono alla ricostruzione descritta hanno fatto leva proprio sul collegamento tra l’interesse legittimo e l’interesse finale: quest’ultimo, pur non costituendo l’oggetto della protezione offerta dall’interesse legittimo, costituisce un presupposto del medesimo; dunque, se quest’interesse risulta appuntarsi in capo ad un particolare soggetto, la posizione di quest’ultimo è differenziata rispetto a quella degli altri soggetti e di conseguenza egli ha un interesse suo proprio alla pretesa al corretto esercizio del potere ovvero alla legittimità del provvedimento amministrativo. Vi è un altro orientamento il quale definisce in modo diverso l’interesse legittimo ed il suo oggetto. Questo orientamento muove dalla constatazione che la legittimità dell’azione amministrativa rappresenta il limite della protezione che ordinamento giuridico riconosce all’interesse legittimo, nel senso che quest’ultimo è protetto solo nell’ipotesi in cui la predetta azione presenti la caratteristica di essere illegittima. Se c’è azione amministrativa legittima non c’è protezione; superato questo limite c'è la protezione. Da qui la conseguenza che ciò che rappresenta un limite alla protezione non può trasformarsi nell’oggetto della protezione medesima e, dunque, nell’oggetto dell'interesse legittimo. Su questa base si innesta un ragionamento il quale si sviluppa attraverso i seguenti passaggi: posto che gli interessi finali del privato possono risultare sacrificati o non soddisfatti in seguito all’esercizio delle potestà amministrative; posto che questo sacrificio o questa non soddisfazione possono avvenire in via del tutto fisiologica, se le predette potestà sono esercitate correttamente, in quanto la legittimità costituisce il limite della protezione dell'interesse legittimo; posto che l’unico modo per evitare tale sacrificio o tale non soddisfazione sta nella circostanza che le pubbliche amministrazioni adottino un provvedimento avente un contenuto favorevole rispetto agli interessi finali del privato; ne consegue che la tutela che l'ordinamento può accordare a fronte dell’esercizio delle potestà, nell’impossibilità di riconoscere agli interessi finali una tutela diretta, non può che consistere nella tutela dell’interesse al provvedimento favorevole, ovvero al comportamento favorevole della pubblica amministrazione rispetto agli interessi finali. Combinando il limite della protezione dell’interesse legittimo con il suo oggetto si possono avere allora i seguenti casi: provvedimento sfavorevole ma legittimo (non c'è tutela perché la legittimità costituisce il limite della protezione dell’interesse legittimo); provvedimento favorevole ma illegittimo (non c’è lesione dell’interesse legittimo o per meglio dire del suo oggetto); provvedimento sfavorevole ed illegittimo (c’è lesione dell’interesse legittimo). Un terzo orientamento definisce l’interesse legittimo come la posizione di vantaggio concessa ad un soggetto dell'ordinamento in ordine ad un interesse ad un bene della vita oggetto di potere amministrativo. Prosegue poi asserendo che detta posizione di vantaggio consiste nell’attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del potere amministrativo in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene. Di questa definizione merita di essere sottolineato il ruolo assunto dall’interesse finale (interesse al bene della vita): l’interesse finale, infatti, è l’oggetto dell’interesse legittimo ma, dal momento che detto interesse può essere oggetto di esercizio del potere amministrativo, risulta tutelato e tutelabile nella misura in cui detto esercizio non avvenga nel rispetto dei limiti ad esso posti dall’ordinamento giuridico. Il carattere peculiare di questa ricostruzione sta nel fatto che tra il diritto soggettivo e l’interesse legittimo non vi sono differenze né in ordine alla loro natura (sono entrambi situazioni giuridiche soggettive) né relativamente al loro oggetto perché tanto nell’un caso (il diritto soggettivo) quanto nell’altro (l’interesse legittimo) l’oggetto è costituito dall’interesse ad un bene della vita. La loro differenza sta nel grado della tutela nel senso che, mentre il diritto soggettivo consente la realizzazione in via immediata e diretta dell’interesse al bene; l’interesse legittimo, in quanto consistente di un complesso di poteri di influenza sull’esercizio del potere amministrativo, non può mai far conseguire l’interesse al bene della vita (interesse finale) se non per il tramite dell’esercizio del potere e in quanto questo glielo consenta. Vi è poi una quarta posizione, la quale definisce l’interesse legittimo come una situazione giuridica soggettiva che si colloca a fronte del potere discrezionale e che ha alla base un interesse sostanziale consistente nella possibilità di conservare o di acquisire un bene della vita. La peculiarità di questa ricostruzione sta nel fatto che l’oggetto dell’interesse legittimo è un interesse sostanziale ovvero un bene della vita: tale interesse però non s’identifica con l’interesse finale, sul quale si producono gli effetti dell’esercizio delle potestà, bensì con quell’interesse che nel diritto privato è denominato chance. Posto che la chance è un bene giuridico, che è oggetto di tutela nel diritto privato, l’interesse legittimo può ben assumere quest'ultima come suo oggetto. 5. Considerazioni sugli orientamenti esaminati Ancora oggi non vi è accordo in dottrina sulla definizione dell’interesse legittimo e soprattutto sul suo oggetto. Se l’interesse legittimo è situazione giuridica soggettiva, ciò significa che non è ammissibile che il suo oggetto ovvero l’interesse protetto risulti leso senza che il titolare avverta il bisogno di tutela e, dunque, la necessità di spendere la situazione giuridica a lui riconosciuta. Deve esistere un rapporto di reciproca corrispondenza tra lesione dell’oggetto e bisogno di tutela. Se le diverse teorie vengono esaminate da questa prospettiva, ci si accorge che la posizione, la quale sostiene che oggetto dell'interesse legittimo è la pretesa al corretto esercizio del potere amministrativo, perlomeno in una ipotesi non soddisfa il suddetto rapporto di corrispondenza. Si pensi al caso in cui l’esercizio delle potestà amministrative avviene in modo illegittimo e tuttavia il provvedimento adottato attraverso tale esercizio sia favorevole al privato e al suo interesse finale. In tale evenienza, se si assume che l’oggetto dell’interesse legittimo vada individuato proprio nella pretesa al legittimo esercizio del potere amministrativo, ne dovrebbe discendere come si sia in presenza di una lesione dell'interesse legittimo senza però che il privato avverta alcuna esigenza di tutela e dunque l’esigenza di utilizzare la sua situazione giuridica soggettiva a tale fine. Per quanto riguarda le altre teoriche invece, quale che sia l'oggetto dell'interesse legittimo che ciascuna assume, il rapporto di corrispondenza che si è posto quale parametro di valutazione risulta rispettato: sia che l'interesse protetto venga individuato direttamente nel bene della vita, sia che venga individuato nel provvedimento o comportamento favorevole della pubblica amministrazione, sia che venga individuato nella possibilità di conservare o acquisire un bene fatto oggetto di esercizio del potere amministrativo, l’esistenza di un provvedimento illegittimo ma favorevole rispetto all’interesse finale non è tale da integrare una lesione dell’interesse legittimo (e del suo oggetto). Nel primo caso perché l’interesse al bene della vita è soddisfatto; nel secondo caso perché vi è provvedimento o comportamento favorevole; nel terzo caso perché la chance di acquisire un bene della vita è anch'essa soddisfatta. In aggiunta alla posizione della dottrina, va segnalata quella della giurisprudenza. Quest’ultima, dopo una fase iniziale in cui non riconosceva all’interesse legittimo natura di situazione giuridica soggettiva, è orientata a riconoscere tale natura dividendosi semmai sul problema dell’oggetto, pur se risulta maggioritario l’orientamento tendente a rinvenire tale oggetto nella pretesa al corretto esercizio del potere. Va anche detto che la Cassazione, ha aderito senza riserve alla tesi che vede in detto interesse una situazione giuridica soggettiva avente ad oggetto l'interesse ad un bene della vita fatto oggetto dell’esercizio del potere amministrativo. Se in dottrina esistono divergenze in ordine alla definizione dell'interesse legittimo, consenso vi è invece su altri elementi che attengono alla predetta situazione giuridica soggettiva. Ciò vale in particolare per i poteri che ineriscono alla medesima e che possono essere esercitati dal titolare a fini di tutela. Tali poteri sono individuati: nei poteri di partecipazione al procedimento amministrativo (presentazione di memorie e documenti che la p.a. ha l'obbligo di valutare ove pertinenti all’oggetto del procedimento; accesso agli atti del procedimento medesimo), nel potere di esperire i ricorsi amministrativi e nel potere di proporre il ricorso in sede giurisdizionale. Più dibattuto è invece il problema concernente il modo di individuazione dell’interesse legittimo ossia il problema di capire quali, tra i molteplici interessi che l’esercizio delle potestà amministrative può toccare, assuma tale qualità. Sul punto la dottrina maggioritaria è oggi concorde nel ritenere che, intanto si può individuare la presenza di un interesse legittimo, in quanto vi sia una base normativa. Tale posizione è coerente con l’asserita natura di situazione giuridica soggettiva dell’interesse legittimo. Atteso che ogni situazione giuridica soggettiva è tale in quanto prevista e riconosciuta da una norma, a questa regola non può sfuggire l’interesse legittimo e, posto che quest’ultimo è sempre correlato all’esercizio delle potestà amministrative, se ne trae la conseguenza che, ai fini dell’individuazione dell’esistenza dell’interesse legittimo, occorre volgere lo sguardo alla norma attributiva delle potestà per individuare quali interessi sono presi in considerazione ai fini dell’esercizio delle potestà medesime. Sennonché si riconosce che questa non è una operazione agevole. In alcuni casi infatti, in base al tipo di potestà attribuita alla pubblica amministrazione dalla norma, è agevole procedere a questa individuazione (si pensi alla norma attributiva del potere espropriativo). In altri casi il discorso è sicuramente meno agevole (si pensi al potere di rilascio del permesso di costruire a fronte del quale, se appare chiara la rilevanza in termini di interesse legittimo dell’interesse di colui che richiede il permesso, meno sicuro è se, a fronte del predetto potere, si collochino altri interessi legittimi quali, ad es., gli interessi di coloro che risiedono nelle vicinanze del luogo dove si vuole edificare). In tali casi si ritiene che la ricerca della presenza dell’interesse legittimo debba farsi non attraverso il solo riferimento alla norma attributiva del potere, ma allargando l’indagine all’intera disciplina in relazione al quale è riconosciuto il potere medesimo. 6. Il problema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo sino alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 500/1999 Per lungo tempo gli interessi legittimi non erano considerati risarcibili. La situazione muta dopo la sentenza della Corte di cassazione 500/1999. Sul tema si è consumata negli anni una lunga battaglia. Alla base dell'orientamento giurisprudenziale tradizionale, in primo luogo vi era una particolare interpretazione della locuzione “danno ingiusto” di cui all'art. 2043 c.c. Quest’ultimo, stabilisce che chiunque cagioni ad altri con dolo o colpa un danno ingiusto è tenuto a risarcire il danno medesimo. Ebbene, secondo l’orientamento tradizionale della Cassazione, per danno ingiusto era da intendersi solo quello derivante dalla lesione di un diritto soggettivo. Quindi: posto che l’interesse legittimo è situazione giuridica diversa dal diritto soggettivo, i danni che si determinavano a seguito della sua lesione da parte della p.a. e dei relativi atti illegittimi non integravano uno degli elementi (l’ingiustizia del danno) della fattispecie risarcitoria. Non realizzandosi la fattispecie non si potevano produrre gli effetti ad essa connessi dalla norma ossia la nascita in capo alla p.a. dell’obbligazione risarcitoria. A questa ragione se ne affiancava un'altra di tipo processuale: anche a volere considerare risarcibili i danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo, la relativa controversia non poteva trovare un giudice competente a risolverla. Infatti, trattandosi di danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo, di questi non poteva conoscere il giudice ordinario in quanto giudice dei diritti soggettivi lesi dalla p.a.; ma sulla controversia non poteva pronunciarsi neppure il giudice amministrativo in quanto sprovvisto (all’epoca) del potere di pronunciare nei confronti della pubblica amministrazione una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, essendo consentita soltanto l'adozione di sentenze di annullamento del provvedimento illegittimo. Il concorso di queste due ragioni determinava un sorta di sostanziale immunità della pubblica amministrazione nei confronti dei danni arrecati al privato nello svolgimento illegittimo della propria funzione. In presenza di detto orientamento giurisprudenziale, l’unico spazio nel quale far valere una pretesa risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione era dato dal ricorrere di due condizioni: da un lato un provvedimento illegittimo adottato dalla pubblica amministrazione; dall’altro un interesse finale colpito dal provvedimento avente sul piano dell'ordinamento generale, indipendentemente cioè dall’esercizio della potestà amministrativa, la consistenza di un diritto soggettivo. In tale evenienza, infatti, per effetto dell’annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo, il provvedimento perdeva ab origine ogni efficacia, mentre il diritto soggettivo estinto o limitato si ricostituiva in capo al titolare con effetto anch’esso retroattivo. Da ciò la conseguenza che l’incisione del diritto soggettivo, avutasi per il tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento illegittimo ed il suo annullamento, integrava gli estremi di un comportamento illecito della p.a. a fronte del quale si poteva chiedere il risarcimento dei danni subiti in sede di giurisdizione ordinaria. In questo caso ad essere risarciti non erano i danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo come tale, quanto piuttosto i danni derivanti dalla lesione del diritto soggettivo (preesistente) ricostituitosi, attraverso un faticoso iter processuale, in capo al privato a seguito della sentenza di annullamento del provvedimento illegittimo da parte del giudice amministrativo. Laddove invece detto interesse finale non avesse avuto tale consistenza, nulla avrebbe potuto chiedere il privato. Detto in altri termini: se il privato vantava un interesse legittimo oppositivo, collegato ad un interesse finale avente la consistenza di diritto soggettivo, poteva aspirare quantomeno ad una tutela risarcitoria del diritto soggettivo dopo l’annullamento del provvedimento illegittimo; se il privato vantava a fronte dell’esercizio delle potestà amministrative un interesse legittimo pretensivo, collegato ad un interesse finale non avente la consistenza di un diritto soggettivo, non poteva aspirare ad alcun risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittimo o tardivo esercizio delle potestà medesime. L’esistenza di un’area assai vasta, nell’ambito della quale alla p.a. veniva garantita una sostanziale irresponsabilità nei confronti dei danni arrecati al privato nello svolgimento illegittimo delle attività di diritto pubblico, era situazione non tollerabile per più di una ragione. Nessuna norma della Costituzione era tale da garantire il privilegio della irresponsabilità all’azione di diritto pubblico della pubblica amministrazione. Semmai, si potevano trarre indicazioni di segno opposto. Al di là di ciò, vi sono altri fattori che hanno concorso in modo decisivo a mettere in crisi l'orientamento tradizionale della Cassazione e a favorire la svolta compiuta nel 1999 con la sent. n. 500. In primo luogo si deve ricordare come la Cassazione, nell’ambito dei rapporti tra privati, avesse iniziato a risarcire danni derivanti dalla lesione di interessi a rigore non qualificabili come veri e propri diritti soggettivi. Nell’assumere tale orientamento, essa, pur senza una affermazione o una teorizzazione esplicita, aveva di fatto cambiato la propria lettura dell’art. 2043 c.c. Fino a quando infatti ad essere risarciti, anche nei rapporti tra privati, erano solo i danni derivanti dalla lesione di diritti soggettivi, risultava evidente come l’illecito previsto nel suddetto articolo fosse considerato tipico, tale cioè da potere essere utilizzato per mantenere immune dai danni il titolare di una situazione giuridica soggettiva (il diritto soggettivo) prevista e tipizzata in altre norme. Ma nel momento stesso in cui ad essere risarciti diventavano anche gli interessi che non hanno la consistenza di diritti soggettivi, ma che tuttavia vengono dalla giurisprudenza ritenuti meritevoli di tale tutela in ragione della loro rilevanza sociale, si è di fatto abbracciata una diversa interpretazione dell’art. 2043 c.c.: più precisamente l’illecito disciplinato comincia ad essere considerato atipico, e dunque la locuzione danno ingiusto sta a significare non più soltanto danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo, bensì anche danno derivante dalla lesione di un qualunque interesse tuttavia meritevole di considerazione e tutela. Da ciò una conseguenza a dire poco paradossale e comunque inaccettabile: mentre nei rapporti tra privati, vengono risarciti sia danni derivanti dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva tipica, qual è il diritto soggettivo, sia danni derivanti dalla lesione di un interesse non avente la consistenza di un diritto soggettivo, nei rapporti tra privati e p.a. i danni derivanti dalla lesione di un interesse legittimo, il quale è comunque una situazione giuridica soggettiva, non erano tali da integrare il requisito della ingiustizia. Insomma: l’interesse legittimo, che è certamente una situazione giuridica soggettiva con una tutela minore di quella accordata al diritto soggettivo, ma è pur sempre una situazione giuridica soggettiva riconosciuta nella Costituzione, finiva per valere meno, ai fini della tutela risarcitoria, di interessi che, pur non essendo qualificabili in termini di situazioni giuridiche soggettive, trovavano nei rapporti tra privati la predetta tutela. Un secondo fattore che ha concorso a mettere in crisi il tradizionale orientamento di chiusura nei confronti della risarcibilità degli interessi legittimi è stato la formazione e il progressivo consolidamento dell’ordinamento comunitario, anche e soprattutto in termini di primazia e di prevalenza sugli ordinamenti interni. Infine, un terzo fattore che ha favorito il mutamento giurisprudenziale in tema di risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo si deve ad un intervento del nostro legislatore e più in particolare all’emanazione del d.lgs. 80/1998. Con tale decreto, per un verso, sono state ampliate le materie di giurisdizione esclusiva e, per altro verso, è stata prevista la possibilità per il giudice amministrativo di condannare in sede di giurisdizione esclusiva l’amministrazione, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno ingiusto. Seppure la norma richiamata non menzionasse gli interessi legittimi e si riferisse alle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essa è stata interpretata dalla dottrina, ma anche dalla giurisprudenza, come norma applicabile anche all’ipotesi dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi e, dunque, come una inequivocabile opzione legislativa a favore della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione degli interessi legittimi. La sent. n. 500, nell’aprire alla risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell'interesse legittimo, ha affrontato ed offerto soluzioni alle molte questioni sia di ordine sostanziale sia di ordine processuale che il tema poneva. Iniziando l'esame dalle questioni processuali, nella sent. n. 500 i giudici avevano posto due regole molto chiare: - per un verso il giudice competente a risolvere le controversie in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo era stato individuato nel giudice ordinario, con la sola eccezione delle controversie rientranti nelle materie di giurisdizione esclusiva spettanti al giudice amministrativo; - per altro verso il rapporto tra l’azione di annullamento del provvedimento illegittimo, dalla cui adozione si fosse originato il danno, e l’azione risarcitoria era stato risolto nel senso di escludere che quest'ultima fosse subordinata al previo esperimento con successo dell’azione di annullamento, sicché le due azioni potevano essere proposte alternativamente ovvero pendere contemporaneamente (l’una dinanzi al giudice amministrativo, l’altra dinanzi al giudice ordinario). Tra le questioni sostanziali affrontate nella sentenza merita di essere ricordato l’esplicito abbandono da parte dei giudici sia della necessaria correlazione tra danno ingiusto e lesione del diritto soggettivo, sia della tesi della tipicità della fattispecie disciplinata dall'art. 2043 c.c. Con riferimento al primo punto la Cassazione riconosce che non vi è alcun argomento ricavabile dall'art. 2043 c.c. da cui si possa desumere l’applicabilità della disciplina soltanto ai danni derivanti dalla lesione del diritto soggettivo. Con riferimento al secondo punto la Cassazione afferma che la locuzione danno ingiusto non va correlata ad una situazione giuridica soggettiva tipizzata in altra norma: essa va invece interpretata come una clausola generale che offre protezione nei confronti dei danni arrecati anche ad interessi che, pur non essendo riconosciuti da altra norma in termini di situazione giuridica soggettiva, tuttavia appaiono meritevoli di tutela e protezione da parte dell’ordinamento giuridico, la cui selezione spetta al giudice attraverso “un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto e cioè dell’interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato e dell’interesse che il comportamento lesivo dell’autore del fatto è volto a perseguire”, così da “accertare se il sacrificio del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore della condotta, in ragione della sua prevalenza”. Dunque, a giudizio della Cassazione, l’illecito disciplinato dall’art. 2043 c.c. è atipico nel senso che non offre protezione soltanto nell’ipotesi di danni derivanti dalla lesione del diritto soggettivo, ma anche ad interessi non aventi la consistenza di diritto soggettivo nel caso siano riconosciuti degni di protezione. L’art. 2043 c.c. non è norma secondaria, norma cioè volta a dare protezione nei confronti dei danni che si sono prodotti in relazione a situazioni giuridiche soggettive (quali i diritti) previste da altra norma (primaria), bensì è essa stessa norma primaria in quanto volta a proteggere anche interessi che non trovano espresso riconoscimento e tipizzazione in altra norma. Si apre, così, lo spazio per la risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo. Tutto ciò, ha portato la Cassazione a prendere posizione sull’interesse legittimo e sulla sua definizione asserendo che detto interesse consiste in una “posizione giuridica di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo consistente nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene”. La Cassazione fa propria una particolare teoria dell’interesse legittimo, ossia quella teoria che individua l’oggetto dell’interesse legittimo nell’interesse al bene della vita. L’avere assunto tale definizione di interesse legittimo segna tutto il successivo sviluppo del ragionamento della Cassazione. Se, infatti, l'interesse legittimo ha ad oggetto di protezione l'interesse al bene della vita, pare evidente come, intanto si potranno avere dei danni risarcibili, in quanto si dimostri la effettiva spettanza in capo al privato dell'interesse al bene medesimo. Tale circostanza, nel caso degli interessi legittimi oppositivi, discende ipso facto dalla acclarata illegittimità del provvedimento: se quest’ultimo è illegittimo, ciò vuol dire che l’interesse al bene della vita non poteva né doveva essere sacrificato e, dunque, esso spettava al privato. Altrettanto però non può dirsi nell’ipotesi di interessi legittimi pretensivi: perché in questo caso, la provata illegittimità del provvedimento (di diniego), specie se a carattere discrezionale, che ha impedito la realizzazione dell’interesse al suddetto bene non equivale all’accertamento della sua spettanza. La conseguenza di tale impostazione è che, mentre la lesione dell’interesse legittimo oppositivo da parte di un provvedimento riconosciuto illegittimo è condizione necessaria e sufficiente per ottenere il risarcimento dei danni patiti, viceversa la lesione dell’interesse legittimo pretensivo è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno. In tale caso occorre infatti accertare non solo l’illegittimità del provvedimento di diniego che ha impedito la realizzazione dell'interesse al bene della vita da parte del privato: occorre provare anche che al privato spettasse l'adozione di un provvedimento contenente un assetto di interessi tale da realizzare il suo interesse al bene della vita. In tale ultima ipotesi, dunque, ai fini del risarcimento del danno, il giudice non dovrà limitarsi ad accertare l’illegittimità del provvedimento di diniego ma dovrà anche, per mezzo di un giudizio che viene definito prognostico, verificare se, sulla base della normativa disciplinante la fattispecie e secondo un criterio di normalità, al titolare dell’interesse legittimo spettasse l’adozione del suddetto provvedimento. La scissione tra interessi oppositivi e pretesivi è il prodotto dell’avere aderito ad una certa definizione dell’interesse legittimo. Le maggiori perplessità si annidano nel fatto che se il giudizio prognostico di cui parla la Cassazione può aversi con relativa sicurezza solo nell’ipotesi di potestà amministrative integralmente vincolate, quando cioè si tratta di accertare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella normativamente prevista, il discorso si fa più complesso nell’ipotesi di potestà amministrative aventi carattere discrezionale. Posto che in tale caso la valutazione discrezionale comporta la ponderazione degli interessi secondari con l’interesse pubblico primario e che tale valutazione è riservata in via esclusiva alla stessa p.a. nel senso che non potrebbe essere fatta da nessun altro giudice, il giudizio prognostico non può che convertirsi in un giudizio di mera probabilità circa il fatto che la pubblica amministrazione avrebbe potuto orientarsi nella direzione di assumere un provvedimento favorevole per il privato. Ma, se così è, il giudizio prognostico si converte, da giudizio volto ad accertare in positivo la spettanza dell’interesse al bene della vita, in un giudizio in negativo volto a accertare la non improbabilità che l’azione amministrativa si sarebbe potuta orientare in una certa direzione, volto in definitiva ad accertare l’esistenza di una chance, donde la conseguenza che ad essere risarcita non è la lesione dell'interesse al bene della vita, bensì la lesione della chance. Per tale via si finisce però per aderire ad un'altra teorizzazione dell'interesse legittimo: a quella che definisce unitariamente tale interesse come la situazione giuridica soggettiva consistente nella possibilità di conservare (nel caso di interessi oppositivi) o di acquisire (nel caso di interessi pretensivi) un bene della vita. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo di cui all’art. 2043 c.c. la Cassazione ha affermato che, affinché si abbia risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo, non è sufficiente il mero dato della illegittimità del provvedimento amministrativo dalla cui adozione si sia prodotto il danno. Occorre che accanto a questo dato vi sia l’elemento soggettivo della colpa. L’indagine su tale elemento deve però avvenire non con riferimento al funzionario agente, bensì con riferimento alla pubblica amministrazione come apparato. Tale indagine risulterà avere esito positivo quando sia accertato che l’adozione e l’esecuzione del provvedimento illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sent. n. 500/1999, lasciavano aperti numerosi problemi processuali e sostanziali, la cui soluzione veniva quindi affidata al legislatore e alla giurisprudenza. 7. La risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale La cognizione delle questioni risarcitorie è oggi attribuita espressamente al giudice amministrativo nel Codice. L’art. 7, comma 4, stabilisce che sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali, pure se introdotte in via autonoma. L’art. 30, comma 6, ribadisce che di ogni domanda di condanna al risarcimento del danno per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi, conosce esclusivamente il giudice amministrativo. Dal punto di vista processuale il quadro che emerge dall’art. 30 del Codice, è il seguente: a) non vi sono pregiudizialità tra azione di annullamento del provvedimento e azione di condanna al risarcimento del danno; b) tale ultima azione può dunque essere proposta autonomamente entro il termine di decadenza di 120 giorni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da quest'ultimo; c) se l'azione di annullamento è stata proposta, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o comunque sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza; d) ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2058 c.c., il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno in forma specifica; e) nella determinazione del risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e comunque esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti (ossia in particolare l’azione di annullamento e la tutela cautelare); f) per il risarcimento del danno prodottosi a seguito dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (danno da ritardo) il termine per la proposizione della domanda risarcitoria non decorre sin quando perdura l’inadempimento, ma trascorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere il suddetto termine inizia a decorrere. Il quadro che si è tratteggiato chiude definitivamente la lunga querelle che ha opposto il giudice ordinario ed il giudice amministrativo sulla c.d. pregiudizialità tra l’azione di annullamento e l’azione risarcitoria. Oggi, dopo l'introduzione del Codice, si può definitivamente affermare che il giudice amministrativo è l’unico giudice competente a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo; tale domanda può essere proposta anche in via autonoma, indipendentemente cioè dalla proposizione dell’azione di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo causativo del danno. Il quadro che si è descritto ha trovato definitiva consacrazione da parte del Consiglio di Stato. Quest’ultimo nell’Adunanza Plenaria n. 3/2011 ha ribadito come, alla luce delle disposizioni del Codice sistematicamente ricostruite, ed in particolare del comma 3 dell’art. 30, nessuna pregiudizialità in rito vi sia tra azione di annullamento ed azione risarcitoria. Ha poi precisato che, pur in mancanza di siffatta pregiudizialità, tuttavia tra le due azioni vi è una sorta di dipendenza sostanziale. Con tale espressione si fa riferimento alla circostanza che la mancata proposizione dell’azione di annullamento può determinare effetti sul risarcimento nel senso che tale omissione costituisce un fatto concreto da apprezzare, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, per escludere il risarcimento dei danni (o limitarne il quantum) evitabili in tutto o in parte per effetto del giudizio di annullamento. 8. La giurisdizione esclusiva e il riparto per materie: cenni e rinvio In sede di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo è competente a giudicare sia della lesione dell’interesse legittimo sia della lesione del diritto soggettivo. Dunque, in tale caso muta anche il criterio del riparto di giurisdizione: al criterio della causa petendi si sostituisce quello basato sulle materie. L’introduzione della giurisdizione esclusiva è antecedente all’entrata in vigore della Costituzione anche se quest'ultima si è poi occupata della predetta giurisdizione. Ai sensi dell’art. 103 infatti il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della p.a. degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La giurisdizione esclusiva ha posto e pone essenzialmente due ordini di problemi. - In primo luogo, atteso che la Costituzione parla di “particolari materie”, si è posto soprattutto di recente, a seguito del notevole incremento delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, il problema se esista un limite quantitativo all’espansione della giurisdizione in questione. - In secondo luogo vi è la questione dei criteri sulla cui base perimetrare le materie indicate dal legislatore. Con riguardo al primo problema l'unico dato certo è che non sarebbe costituzionalmente legittimo, attraverso l’attribuzione progressiva di materie al giudice amministrativo, eliminare del tutto ogni competenza del giudice ordinario rispetto alla tutela dei diritti soggettivi. Ma il problema ovviamente non è questo. Esso invece riguarda più realisticamente l'ipotesi che la giurisdizione esclusiva acquisti un rilievo preponderante. In altri termini, il punto è se esistano limiti quantitativi all’espansione della giurisdizione esclusiva, superati i quali si può dire che il sistema di giustizia amministrativa si atteggi in forme non legittime dal punto di vista costituzionale. La dottrina, o meglio una parte di essa, nel registrare l’intento del legislatore ordinario di concentrare il più possibile le controversie tra p.a. e privati davanti al giudice amministrativo, ha indicato come strada maestra quella di una (non difficile) modifica della Costituzione che, superando il carattere dualista del nostro sistema di giustizia amministrativa, lo renda monista incentrandolo sul giudice amministrativo. Con riferimento al secondo problema va detto che, se il criterio di riparto della giurisdizione basato sulla natura della situazione giuridica che si assume lesa ha comportato e comporta notevoli incertezze applicative, non per questo la sua sostituzione con il criterio di riparto basato sulle materie si presenta priva di problemi. Delimitare con esattezza le materie, infatti, intese come blocchi di discipline organiche relative ad un determinato settore della vita in cui si svolgono rapporti tra p.a. e privati, è tutt’altro che operazione agevole. Anche l’applicazione di questo criterio di riparto, in presenza di un incremento delle materie di giurisdizione esclusiva, è probabilmente destinata ad accrescere il contenzioso relativo all’individuazione del giudice competente. Entrambe le questioni sono state affrontate dalla Corte costituzionale. Dopo il suo intervento, la Consulta ha preso posizione proprio sul problema dei limiti, quantitativi e qualitativi, che il legislatore ordinario deve rispettare nel disciplinare, ampliandola, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla base delle norme costituzionali. La Corte ha chiarito in proposito che l’art. 103 Cost. “non ha conferito al legislatore ordinario un’assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva”, ma gli ha conferito un potere “che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie”. Precisamente, le materie che possono essere devolute alla giurisdizione esclusiva devono essere caratterizzate “ dalla circostanza che la p.a. agisce come autorità”; devono essere materie che, in assenza della previsione legislativa che le devolve al giudice amministrativo esclusivo, “contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità”. Non sono insomma sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva, secondo la Corte, né la partecipazione della p.a. al giudizio né il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia”. Con riguardo alla materia dei servizi pubblici, la Consulta ha ritenuto che la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie ricadenti in tale settore, esorbiti dai limiti dell’art. 103, poiché “la ‘materia' così individuata prescinde del tutto dalla natura delle situazioni soggettive in essa coinvolte”; oggetto di giurisdizione esclusiva possono essere solo i casi nei quali l’amministrazione pubblica “agisce esercitando il suo potere autoritativo”. Capitolo 4: Le forme della giurisdizione 1. Premessa Vi sono diverse “giurisdizioni” (o “competenze") del giudice amministrativo: giurisdizione di legittimità, giurisdizione esclusiva e giurisdizione di merito. Per giurisdizione s’intende il differenziato ambito di poteri di cognizione e di decisione assegnato al giudice medesimo. 2. La giurisdizione generale di legittimità Il modello generale di poteri di cognizione e di decisione del giudice amministrativo, era quello del giudizio impugnatorio-cassatorio, un giudizio di verifica prevalentemente formale e documentale della legittimità degli atti dell’Amministrazione pubblica. Il ricorso davanti al Consiglio di Stato era quindi configurato come un’impugnazione “per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante”. Conseguentemente, i poteri di cognizione e di decisione del giudice amministrativo erano funzionali a questo tipo di azione e, inevitabilmente, limitati dai suoi angusti confini di giudizio di annullamento di atti. In altri termini, il potere di cognizione e di decisione del giudice amministrativo di legittimità non aveva come suo oggetto l’accertamento della lesione della situazione giuridica soggettiva (di interesse legittimo) lamentata dal ricorrente, né aveva come suo scopo immediato la riparazione o la reintegrazione della lesione ingiustamente patita dal ricorrente. Nel giudizio di legittimità, infatti, oggetto dell’accertamento del giudice era inteso, tradizionalmente, l’atto amministrativo e la sua eventuale illegittimità, mentre il fine del sindacato giurisdizionale consisteva nell’eventuale annullamento dell’atto illegittimo. La tutela della situazione giuridica soggettiva del ricorrente, intesa come riparazione di una sua ingiusta lesione, era effetto soltanto indiretto della pronuncia costitutiva di annullamento dell’atto impugnato. Rispetto a questa tradizionale ricostruzione della giurisdizione di legittimità, molta strada e stata percorsa dalla giurisprudenza e dalla (pur non univoca) dottrina. L’art. 1 del Codice afferma, senza operare distinzione alcuna tra le diverse forme di giurisdizione del giudice amministrativo, che “la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”. Seppure da ciò dovrebbe derivare, nonostante le previsioni del Codice, la inutilità di perpetuare le distinzioni fra diversi tipi di “giurisdizione” del giudice amministrativo, occorre comunque ricordare le caratteristiche tradizionali della giurisdizione generale di legittimità. E solo conoscendo i tratti salienti di quel modello processuale che si potrà verificare, alla luce delle previsioni legislative più recenti, se esso possa ritenersi ancora vitale, ovvero se costituisca ormai un pur glorioso cimelio. La giurisdizione generale di legittimità nasceva come una giurisdizione "limitata". 1- Limitata quanto al potere di cognizione che non solo non poteva estendersi alle valutazioni di merito (o di opportunità) dell’Amministrazione, ma che non poteva neppure giungere sul limitare delle valutazioni tecniche. Nell’esercitare il proprio sindacato di legittimità, al giudice amministrativo era precluso il giudizio sul fatto. 2- Il giudice amministrativo di legittimità poteva svolgere un’indagine quanto all’esistenza (o meno) di determinati fatti, ma non poteva spingersi oltre nel sindacare la correttezza delle valutazioni che di quei medesimi fatti l’Amministrazione pubblica aveva effettuato nell’emanare un provvedimento amministrativo. Il massimo risultato che si riuscì a raggiungere fu quello di ammettere un sindacato estrinseco delle valutazioni o degli apprezzamenti di fatto compiuti dall’Amministrazione, una verifica circa l’astratta coerenza di tali valutazioni ed il rispetto della clausola generale della ragionevolezza. Dal punto di vista intrinseco, o interno, tali valutazioni si ritenevano riconducibili alla sfera del merito amministrativo o della discrezionalità amministrativa o, ancora, della discrezionalità tecnica, e come tali si ritenevano insindacabili, sottratte ad una verifica del giudice amministrativo di legittimità. 3- Limitata quanto ai poteri istruttori. Nell’esercizio del suo sindacato, il giudice amministrativo disponeva di un limitatissimo numero di mezzi di prova. È con il Codice che si è avuta una vera e propria svolta sul punto, giacché esso ha conferito al giudice amministrativo, anche nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, poteri istruttori decisamente ampi. 4- Limitata quanto ai poteri di decisione del giudice, che disponeva soltanto di poteri di annullamento dell’atto amministrativo impugnato, ma non anche del potere di riformare o sostituire il provvedimento impugnato; e neppure di pronunciare sentenze dichiarative o di condanna dell’Amministrazione ad un facere o ad un dare. Non poteva il giudice neppure accertare cosa in concreto spettasse al ricorrente a seguito dell’annullamento dell’atto impugnato. Anche quest’ultima limitazione dei poteri di decisione del giudice amministrativo di legittimità pare possa dirsi, almeno in parte, superata a seguito della novella del 2000 e, soprattutto, del Codice. Da un lato, infatti, risulta comunque implicitamente ammessa l’azione di accertamento. Ciò lo si ricava: dalle previsioni di cui all’art. 7, commi 1 e 4, che devolvono alla giurisdizione di legittimità le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo riguardanti provvedimenti, atti, accordi, omissioni o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere; dalle previsioni dell’art. 31, che disciplina l’azione avverso il silenzio; dalle previsioni di cui all’art. 34, comma 1, nella parte in cui dispongono che “in caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda, condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”. Tali previsioni -lette congiuntamenteattribuiscono al giudice amministrativo il potere di emanare sentenze dichiarative e di accertamento di un obbligo dell’Amministrazione. Lo stesso art. 7, comma 4, comprende, tra le controversie devolute alla giurisdizione di legittimità, anche “quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”, e l’art. 30 disciplina analiticamente l’azione di condanna, prevedendo che “sussistendo i presupposti previsti dall’art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”. Viene attribuito, dunque, al giudice di legittimità, unitamente al potere di annullamento, e non in via necessariamente consequenziale al suo esercizio, anche il potere di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ingiusti, e non solo con una condanna al pagamento di una somma di danaro (risarcimento per equivalente), ma anche con una condanna ad un facere o ad un dare specifici (reintegrazione in forma specifica). Queste previsioni, hanno ridefinito i caratteri del modello processuale tradizionale. Alterando profondamente i poteri del giudice di legittimità, infatti, si trasforma quel giudizio da un giudizio impugnatorio-cassatorio sull’atto, in un giudizio anche risarcitorio, finalizzato alla riparazione dell’ingiusta lesione cagionata alla parte ricorrente da quell’atto illegittimo. Conseguentemente, l’ampliamento dei poteri di decisione del giudice porta con sé un sensibile ampliamento dello stesso oggetto del giudizio, che non può più neppure definirsi, a rigor di logica (e di termini), come giudizio di (mera) legittimità. Se infatti il giudice non è più chiamato soltanto ad annullare un atto amministrativo a seguito dell’accertamento della sua eventuale illegittimità, ma è investito anche del potere di disporre la reintegrazione dell’eventuale pregiudizio subito dal ricorrente, in ragione dell’illegittimo atto impugnato, è di tutta evidenza che l’accertamento del giudice amministrativo, oltre ad avere ad oggetto la legittimità (o meno) di un atto, dovrà estendersi alla verifica della sussistenza di tutti gli altri presupposti necessari a fondare la pretesa risarcitoria del ricorrente e, in primo luogo, la sussistenza (ed entità) del pregiudizio lamentato. Conseguentemente, l’accertamento del giudice sul fatto non sarà più limitato ma dovrà essere "pieno", onde consentire il c.d. giudizio di spettanza del ricorrente alla pretesa risarcitoria. I poteri di decisione del giudice amministrativo, infine, non sono più i soli poteri di annullamento di atti amministrativi illegittimi, ma anche poteri di accertamento e di condanna. Occorre rilevare, però, che il modello impugnatorio-cassatorio, ha condizionato notevolmente e per lungo tempo, la posizione della giurisprudenza amministrativa sulla costruzione del nostro processo amministrativo. Significativa riprova di ciò è la posizione espressa da parte della giurisprudenza amministrativa in tema di pregiudiziale amministrativa, laddove ha ritenuto che la domanda di risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi dovesse essere subordinata alla tempestiva proposizione di una domanda di annullamento del provvedimento amministrativo assunto come illegittimo e produttivo del danno ingiusto. Rifacendosi ad una lettura assai tradizionale della giurisdizione di legittimità, infatti, il Consiglio di Stato ha continuato a ritenere che “la tutela degli interessi legittimi del cittadino nei confronti della p.a. è in via primaria una tutela impugnatoria che passa per l’annullamento dell’atto amministrativo”. Nonostante l’autorevole ed opposta lettura che ne hanno prospettano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l’ipoteca del modello impugnatorio-cassatorio sulla giurisdizione di legittimità ha continuato a fare sentire il suo peso. Ora la questione sembra definitivamente superata dall’art. 30 del Codice, ma con una soluzione di compromesso: tale articolo, infatti, ammette la proposizione di un’azione di condanna in via autonoma, ma fissa un termine decadenziale di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Come si vede, anche nel Codice continuano ad emergere, in maniera latente, le due opposte concezioni del giudizio amministrativo di legittimità. La crisi dei modelli processuali ed il loro superamento anche nei fatti non sono sufficienti a decretarne la morte. Lo stesso Codice, ad esempio, mantiene ancora in vita quella particolarissima forma di “giurisdizione” amministrativa che è la giurisdizione di merito, nonostante il suo sostanziale mancato esercizio (fatta eccezione per il giudizio di ottemperanza) ed i consistenti dubbi di legittimità costituzionale contro di essa avanzati. 3. La giurisdizione di merito La giurisdizione di merito ha costituito storicamente la prima forma di “giurisdizione” amministrativa, il primo nucleo della giustizia amministrativa. Dalla istituzione della IV Sezione, la “giurisdizione” di merito iniziò il suo rapido ed inesorabile declino. In primo luogo, la giurisdizione di merito è eccezionale, costituendo una deroga alla giurisdizione generale che è (o meglio, che era) quella di legittimità. Essa può esercitarsi solo nelle controversie riconducibili alle materie tassativamente stabilite dalla legge; e tali materie non sono suscettibili di estensione analogica per il carattere eccezionale delle norme in questione. Attualmente, l’art. 7, comma 6, del Codice, dispone che “il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall’art. 134”. Quest’ultimo articolo prevede soltanto cinque tipologie di controversie, aventi ad oggetto: a) l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell’ambito del giudizio di ottemperanza; b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa; c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall’art. 123 relativo alle sanzione alternative; d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico. Oltre ad essere eccezionale, la “giurisdizione” di merito è aggiuntiva rispetto alla giurisdizione di legittimità. Tale cognizione di merito si aggiunge e non si sostituisce a quella generale di legittimità, dovendo il giudizio di legittimità precedere quello di merito. Ciò che da sempre è meno pacifico, in dottrina, è quali siano i caratteri aggiuntivi della “giurisdizione” di merito rispetto a quella di legittimità. L'interrogativo di fondo, che non è mai stato univocamente risolto in dottrina, atteneva a cosa dovesse intendersi per giurisdizione “anche in merito”, oscillandosi fra la tesi di una giurisdizione aperta alla piena cognizione dei fatti oggetto della controversia ed una cognizione che si estendeva invece a valutazioni di opportunità amministrativa. In realtà, storicamente, le materie attribuite alla giurisdizione propria del Consiglio di Stato si prestavano ad un giudizio che si estendeva naturalmente ad una piena cognizione dei fatti oggetto della controversia, in rapporto alle norme giuridiche da applicare; il giudizio di merito inteso invece come giudizio di opportunità amministrativa costituiva, invece, un aspetto residuale. In talune delle materie della giurisdizione di merito, era addirittura impossibile anche astrattamente ipotizzare una valutazione di opportunità del provvedimento impugnato. Nonostante ciò il profilo del giudizio di opportunità ha sollecitato la dottrina molto di più che non la concezione del giudizio dì merito come giudizio sul fatto. Forse perché il primo impulso naturale e spontaneo è quello di fare ricorso al significato che il vocabolo “merito” ha nel diritto amministrativo sostanziale, accezione che porta a ritenere che il giudice possa o addirittura debba procedere ad acclarare l’opportunità, la convenienza, l’utilità, l’equità dell’attività amministrativa. L’accentuazione di tale profilo ha addirittura portato a dubitare della natura giurisdizionale dell’attività del giudice amministrativo e si è parlato di attività giurisdizionale solo in senso formale, di giurisdizione mista a legislazione, di giurisdizione mista ad attività amministrativa. In realtà, si deve ritenere che la “giurisdizione” di merito si differenzia da quella di legittimità, non per la diversa natura del sindacato (o addirittura del potere) esercitato dal giudice amministrativo, quanto per i maggiori poteri decisori che gli vengono riconosciuti: questo stesso giudice, infatti, nell'esercizio della giurisdizione di merito può, non solo annullare l’atto amministrativo impugnato, ma anche riformarlo, ovvero “può sostituirsi all’amministrazione”. Il Codice, dispone che, nei casi di giurisdizione di merito, il giudice, ove accolga il ricorso e nei limiti della domanda, “adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato”. Prima dell’introduzione del Codice, un'altra rilevante differenza tra la giurisdizione di legittimità e la giurisdizione di merito era data dai maggiori poteri istruttori riconosciuti in questa seconda evenienza al giudice amministrativo: erano consentiti, infatti, tutti i mezzi di prova ammessi dal processo civile, sempre che fossero compatibili con i caratteri della giurisdizione amministrativa. L’incremento dei poteri istruttori e di quelli decisori portano inevitabilmente con sé uno straordinario ampliamento della cognizione del giudice di merito rispetto a quello di mera legittimità. Ed era poi questo, il tradizionale tratto distintivo della giurisdizione di merito. L’attribuzione di così ampi poteri istruttori e di altrettanto ampi poteri di decisione consente, infatti, al giudice amministrativo di esercitare un sindacato del fatto senza limitazione alcuna, un sindacato non limitato cioè al mero accertamento dei fatti ma esteso all’autonomo apprezzamento e valutazione di quei fatti e quindi, in sostanza, della concreta rispondenza del provvedimento agli interessi pubblici previsti dalle norme e perseguiti in concreto dall’Amministrazione. Nonostante queste straordinarie potenzialità la giurisdizione di merito è stata rapidamente sopraffatta dalla giurisdizione generale di legittimità e, con l’eccezione del giudizio di ottemperanza, è stata quasi completamente dimenticata. Alla base dello scarso rilievo che viene oggi riconosciuto a questa “giurisdizione” c’è l’idea, o forse la sensazione, che nel nostro ordinamento i casi di giurisdizione di merito rappresentino essenzialmente un residuo storico e qualcosa di sostanzialmente anomalo rispetto ai connotati propri della funzione giurisdizionale modernamente intesa. Due recenti e significativi interventi legislativi sembrano andare in direzione diversa e lasciare qualche apertura ad un differente orizzonte per la giurisdizione di merito. Il riferimento è sia alle norme che hanno introdotto la c.d. class action pubblica, sia alle norme che il Codice dedica al processo in materia di appalti pubblici. 4. La giurisdizione esclusiva (nel suo assetto tradizionale) In un primo tempo la giurisdizione esclusiva e quella di merito praticamente risultavano coincidenti. Essa, infatti, per taluni rapporti e determinate materie preesisteva alla legge abolitrice del contenzioso, per altri fu istituita in seguito, ma sempre venne considerata come giurisdizione non soltanto esclusiva del Consiglio di Stato, ma anche estesa al merito, cioè comprensiva di tutti quei poteri che fossero in concreto necessari alla reintegrazione dei diritti o delle situazioni di interesse menomate dai comportamenti illeciti e dagli atti illegittimi dell'Amministrazione pubblica. Se questo quadro fosse rimasto immutato, oggi non vi sarebbe ragione alcuna di distinguere fra le due giurisdizioni (di merito ed esclusiva). Con il r.d. del 1923, invece, i caratteri dell’esclusività della cognizione del giudice amministrativo e della totale sottrazione di quelle materie alla cognizione del giudice ordinario, vennero sanciti in modo esplicito ma, al contempo, vennero definitivamente dissociati dall’idea di una giurisdizione piena (o di merito). La riforma del 1923 non ha dato vita ad un’autonoma figura di giurisdizione amministrativa, distinta dalla giurisdizione generale di legittimità o da quella (eccezionale) di merito. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, infatti, non è una terza specie di giurisdizione rispetto a quella di legittimità ed a quella di merito. Nella giurisdizione esclusiva il giudice pronuncia ora come giudice di legittimità, ora come giudice di merito, a seconda che le materie in essa confluite siano state attribuite al giudice in cognizione piena o limitata. Essa non è neppure un tertium genus di giurisdizione distinta, quanto alla sua natura, sia dall'Autorità giudiziaria ordinaria, sia da quella del giudice amministrativo. L'aver reso “esclusivo” il potere del giudice amministrativo, relativamente alla cognizione ratione materiae di una serie di controversie è dipeso dall’esigenza di concentrazione e specializzazione, ma non ha prodotto l'effetto di modificare, per quelle materie, il tipo o i contenuti della tutela giurisdizionale che alle diverse situazioni giuridiche soggettive riserva l’ordinamento giuridico. Ed è per questo che si è a ragione affermato che la giurisdizione esclusiva rappresenta un “ibrido” in cui il giudice può assicurare diverse tutele, conoscendo contemporaneamente di interessi e diritti. Secondo la tradizionale prospettazione, la ragione dell’istituzione della giurisdizione esclusiva andrebbe ricercata nella circostanza per cui, in talune materie, diritti soggettivi ed interessi legittimi si intersecano e si aggrovigliano in tal modo che, con difficoltà, il giudice riuscirebbe a pronunciarsi nei limiti della propria giurisdizione, senza invadere il campo che gli è precluso, mentre poi la pronuncia resterebbe comunque monca non avendo completamente esaurito le questioni che sorgono dalla complessità del rapporto, né avendo in tal modo pienamente riparato al torto subìto dal privato. Di qui la necessità per il privato di rivolgersi, sia al giudice ordinario che al giudice amministrativo, con dispendio di tempo e di denaro, spesso senza poter ottenere piena giustizia e con il pericolo di pronunce contraddittorie dei giudici aditi. Ragione ulteriore dell'iniziativa legislativa, poi, fu rinvenuta nel fatto che l'attività dell’Amministrazione, nella sua concreta unità, che non può prescindere dall’interesse pubblico, non poteva essere sindacata, senza un’artificiale frantumazione in due giudizi diversi, almeno in quelle materie in cui il rapporto esige di essere esaminato nella sua inscindibile essenza. In queste materie, fu anche osservato, si richiede al giudice una specializzazione tecnica, una conoscenza specifica, nonché una diretta esperienza dell’attività amministrativa. Si ritenne quindi che ragioni eminentemente pratiche abbiano indotto il legislatore ad istituire la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. Ma tali ragioni pratiche, non avevano portato all’edificazione di una “giurisdizione” unitaria quanto a poteri di cognizione e di decisione del medesimo giudice. In altri termini, seppure le controversie rientranti nelle materie in questione erano tutte attribuite alla cognizione dello stesso giudice, quest'ultimo esercitava una cognizione differenziata in relazione alla diversa natura delle situazioni giuridiche soggettive controverse. In sede di giurisdizione esclusiva, le diverse posizioni soggettive dell'interessato, devono essere distinte e tutelate, in base alla loro effettiva consistenza”. La distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi, infatti, se ha perduto rilievo ai fini della determinazione del giudice competente, continua a sussistere per quanto attiene ai poteri di cognizione e di decisione del giudice amministrativo, il quale continua a conoscere degli interessi legittimi secondo i suoi normali poteri; e dei diritti soggettivi solo in “sostituzione” del giudice civile. Il processo amministrativo “esclusivo”, ha subìto il pesante condizionamento del modello processuale impugnatorio proprio della giurisdizione di legittimità non solo quanto alla tutela degli interessi legittimi, ma anche per la tutela dei diritti soggettivi che, in sostanza, perdevano le azioni, le garanzie processuali, i mezzi di prova che il processo davanti al giudice ordinario avrebbe invece dovuto assicurare loro. Sul piano più propriamente processuale, quindi, la riforma del 1923 non solo non ha assicurato pienezza di tutela alle situazioni di interesse legittimo ma, addirittura, ha comportato un affievolimento delle garanzie di tutela originariamente previste per i diritti soggettivi, pure devoluti in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nel tempo, grazie anche a significativi interventi della Corte costituzionale, sono stati in parte attenuati questi “vizi di origine” del processo esclusivo, soprattutto con riferimento ai poteri cautelari ed ai limiti della istruzione probatoria. Tali innovazioni non hanno dato i risultati sperati. A tutt’oggi infatti continua ad esser vero che il magistrato amministrativo non giudica, nelle materie di giurisdizione esclusiva, come giudica il magistrato ordinario. La res in judicum deducta è tendenzialmente la illegittimità dell’atto impugnato; su questo cade l’accertamento, su tale oggetto si forma il giudicato. Non si può però imputare alla giurisprudenza amministrativa l’intera responsabilità per la mancata evoluzione della giurisdizione esclusiva in termini di pienezza di tutela. Seppur tenendo ferma la distinzione tradizionale tra la tutela erogabile nei confronti dei diritti soggettivi e quella riservata agli interessi legittimi, il giudice amministrativo si è dato carico di assicurare maggiore tutela ai diritti soggettivi affrancandosi dai condizionamenti del processo impugnatorio. Ciò in un processo a tappe che vide in un primo tempo garantiti solo i diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e poi, anche i diritti a contenuto non patrimoniale. Gli interventi della giurisprudenza amministrativa e di quella costituzionale, tuttavia, se hanno riconquistato le necessarie garanzie dì tutela ai diritti soggettivi, hanno al contempo ulteriormente radicato la differenza di tutela fra questi ultimi e gli interessi legittimi. È solo a tutela di diritti soggettivi, infatti, che il giudice non restringe l'area della propria cognizione alla legittimità dell’atto da essa posto in essere, ma si spinge ad indagare il rapporto giuridico controverso. La rappresentazione tradizionale della giurisdizione esclusiva, si riteneva anche confortata dalla Carta costituzionale. In particolare dall’art. 103, comma 1, infatti, verrebbe ricavata l’imprescindibilità della distinzione tradizionalmente ritenuta tra le due situazioni soggettive, nel senso della necessaria corrispondenza con le rispettive forme e modi di tutela assicurati dal giudice ordinario e dal giudice amministrativo. In realtà, una lettura aderente ai caratteri dello Stato democratico, avrebbe potuto svelare la varietà di significati attribuibili alle disposizioni costituzionali e le interpretazioni alternative che esse consentono. In particolare, nell’art. 24 Cost., il richiamo ai diritti soggettivi ed agli interessi legittimi ben può essere letto come una garanzia di totalizzazione della copertura giurisdizionale e, in questo senso, interpretato non in funzione di un obiettivo di discriminazione e separazione, bensì di completezza ed assolutezza della tutela. Questa prospettiva però, è restata inascoltata e, soprattutto a livello di elaborazione giurisprudenziale, è restata granitica la differenziazione delle garanzie di tutela assicurate alle diverse situazioni giuridiche soggettive nell'ambito della medesima “giurisdizione” esclusiva. Prima delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 80/1998, l’attenzione della maggior parte degli studiosi e dello stesso legislatore, nei suoi sporadici interventi nel dibattito, si è prevalentemente incentrata sul dato quantitativo delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva. Non avvedendosi, invece, che si impone uno strettissimo parallelismo tra il profilo dell’ampiezza (delle materie) della giurisdizione esclusiva e quello della qualità e sostanza della tutela giurisdizionale. Aspetto questo ben percepito, invece, dal legislatore più recente che ha affrontato congiuntamente i due aspetti. 5. (Segue): le materie originariamente devolute alla giurisdizione esclusiva Fatta eccezione per le controversie di minore importanza, era quella del pubblico impiego l’unica materia di giurisdizione esclusiva che non fosse anche di giurisdizione di merito e, nonostante si trattasse di un’unica materia, essa costituiva uno spazio di giurisdizione amplissimo, soprattutto dal punto di vista quantitativo, rappresentando le controversie relative all’impiego pubblico una buona metà del carico di lavoro dei nostri giudici amministrativi. Anche questa materia di giurisdizione esclusiva, però, è venuta a perdere gran parte della sua importanza. A seguito delle riforme legislative che hanno disposto la privatizzazione dei rapporti di lavoro con le P.A., infatti, tutte le controversie comunque riguardanti il rapporto di impiego sono state restituite alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Sono incluse nella giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Residuano alla giurisdizione del giudice esclusivo le controversie relative ad alcune importanti categorie di pubblici dipendenti, il cui rapporto di servizio è rimasto in regime di diritto pubblico. Del nucleo originario delle attribuzioni della giurisdizione esclusiva, non resta ormai quasi nulla. A quel corpus, tuttavia, si sono aggiunte nel tempo numerosissime materie e rapporti. Si pensi alla competenza esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative alle concessioni di beni e servizi, fossero esse relative a beni demaniali, o relative a servizi pubblici, o nell’ipotesi in cui la controversia riguardasse l’applicazione di una clausola contrattuale. Erano rimesse al giudice ordinario le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Venivano tradizionalmente ad aggiungersi quelle controversie aventi ad oggetto la determinazione e liquidazione degli oneri di urbanizzazione e costruzione e le sanzioni amministrative contro gli illeciti in materia di abusivismo edilizio. Da un lato, però, tali materie erano comunque suscettibili di sindacato esteso “anche al merito”; dall’altro lato, la stessa previsione normativa, sia pure non espressamente, è stata in seguito sostituita. Notevole importanza rivestivano poi i ricorsi avverso i provvedimenti emanati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con esclusione delle azioni di nullità e di risarcimento del danno per le quali era competente la Corte d’appello, nonché quelli emanati dalla stessa Autorità in materia di pubblicità ingannevole; le controversie in materia di contratti di appalto di beni e servizi stipulati dalle Amministrazioni pubbliche; i ricorsi contro gli atti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; i ricorsi contro gli atti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 6. (Segue): il d.lgs. n. 80/1998 e la recente giurisprudenza costituzionale Notevole rilevanza, hanno avuto, in tema di giurisdizione esclusiva, le previsioni di cui agli artt. 33 e 34 del d.lgs. 80/1998, che hanno dato una prima applicazione al criterio di riparto “per materie omogenee”. L'art. 33 del d.lgs. n. 80/ 1998 devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità. Secondo l’elencazione contenuta nel comma 2 dell’articolo citato, tali controversie erano quelle: concernenti l’istituzione modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi; tra amministrazioni pubbliche e gestori comunque denominati di pubblici servizi; in materia di vigilanza e controllo di tali soggetti; aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie e delle controversie in materia di invalidità. L'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 devolveva invece alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, materia che dalla medesima norma veniva intesa come tutti gli aspetti dell’uso del territorio. Nulla innovando, comunque, né quanto alla giurisdizione del giudice delle acque, né quanto alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di esproprio. Le previsioni del d.lgs. n. 80/1998 hanno dato luogo ad una serie di contrasti in giurisprudenza, oltre che in dottrina, quanto alla loro portata e quanto alla ridefinizione concreta degli ambiti propri della giurisdizione esclusiva. L’individuazione della nozione dì “pubblico servizio” e di “uso del territorio" ai fini delle norme in questione è stata lungamente dibattuta, dando luogo a numerosi conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, che hanno coinvolto anche la Corte costituzionale. Quanto alla materia dei servizi pubblici, le posizioni assunte dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione hanno mostrato un sotterraneo conflitto. Il contrasto, infatti, non era da ricercarsi tanto nelle soluzioni concrete cui le varie pronunce sono addivenute, quanto nel fondamento teorico che si poneva alla base delle diverse posizioni. Infatti, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione si è delineata espressamente l’esistenza di due tipi di interpretazione, una di tipo pubblicistico ed una di tipo privatistico; e le si è legittimate entrambe, affermando che entrambe le interpretazioni, dato il carattere polisenso dell’espressione “pubblico servizio”, erano in qualche modo accettabili. La Cassazione, tuttavia, ha fissato il discrimine fra le due interpretazioni sulla base del dettato costituzionale ed ha assunto che solo una di esse potesse ritenersi accettabile. In realtà, però, la norma costituzionale non milita affatto in tal senso. Ciò, perchè il dubbio interpretativo in questione attiene eminentemente alla definizione di che cosa sia pubblico servizio, definizione che non trova alcuna accoglienza nella nostra Carta fondamentale. Tanto che la stessa Cassazione ha concluso, sia pur con formula dubitativa, che il significato preciso della nuova materia di giurisdizione esclusiva, indicata dall’art. 33 come pubblici servizi, doveva essere tratto soprattutto dal contenuto di questa disposizione normativa; disposizione che non si è ispirata ad una nozione soggettiva di servizio pubblico, ritenendo che esso possa essere svolto anche da soggetti privati, ed ha invece recepito la nozione oggettiva di servizio pubblico. Ma anche l’assunzione della nozione oggettiva di pubblico servizio non consente -ed è questa la diversità di impostazione tra Cassazione e Consiglio di Stato- che sia definibile come servizio pubblico ogni attività privata soggetta a controllo, vigilanza o mera autorizzazione da parte di una PA. Il servizio pubblico, nell’interpretazione che ne offre la Cassazione, consiste in quell’attività indirizzata istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell’Amministrazione pubblica. Il criterio distintivo pare possa essere individuato nella distinzione tra servizi che il privato, imprenditore, rende all’Amministrazione, per i bisogni dell’Amministrazione come apparato, ed i servizi viceversa che il privato, incaricato dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, renda direttamente ai soggetti terzi, ai soggetti privati. In quest'ottica per esempio il trasporto ferroviario, l’erogazione di energia elettrica e gas, il servizio postale, il servizio di telecomunicazioni, sono tutti servizi resi alla collettività e come tali rientrano nei servizi pubblici di cui all’art. 33. Viceversa, i servizi privati resi alle Amministrazioni pubbliche, e cioè quei servizi che le Amministrazioni chiedono di ricevere da prestatori privati per proprie esigenze di funzionamento, non sono destinati a soddisfare esigenze della collettività e, come tali, non rientrano nel novero dei servizi pubblici. E ciò -contrariamente a quanto assume la Cassazione- non perché agli uni o agli altri si applichino norme di diritto pubblico o di diritto comune: la giurisdizione esclusiva infatti è affrancata dalla necessità di distinguere tra diritto pubblico e diritto privato, ma per il fatto che mentre alcuni sono servizi resi nell’interesse del pubblico, della collettività, e come tali sono servizi pubblici, gli altri sono servizi resi nell’interesse (proprio) dell’Amministrazione e come tali non sono servizi pubblici. Questo criterio che non contrasta con le linee di fondo della giurisprudenza di Cassazione, né contrasta con le soluzioni accolte dall’Adunanza Plenaria, sembra, anche allo stato attuale, una possibile e non troppo illogica chiave di lettura. Anche per sopire detti contrasti interpretativi, il legislatore aveva precisato che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture svolti da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”. Non meno difficoltoso si è rivelato il compito di perimetrazione della materia urbanistica ed edilizia. Infatti, l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 nel prevedere che la materia dell’urbanistica “concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio” si caratterizzava, sul piano letterale, per la sua sinteticità e per l’estrema ampiezza della formula adottata, sia nel delimitare l’ambito della materia, fornendone una autonoma definizione, sia nell’indicare le controversie che, nel detto ambito, assumono rilevanza ai fini della sussistenza della giurisdizione esclusiva. Sotto il primo profilo, può constatarsi che la norma, nel definire la “materia urbanistica” non recava distinzioni, né forniva esemplificazioni, ma con espressione di “estrema latitudine” disponeva che sono compresi nell’ambito della materia urbanistica “tutti gli aspetti dell’uso del territorio”. Nella sua assolutezza, quindi, la formula adottata dal legislatore “si presta ad essere intesa come volta ad abbracciare la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso”. Sotto il secondo profilo, del pari onnicomprensivo era il riferimento alle controversie attribuite al giudice amministrativo: vi rientravano, infatti, purché attinenti alla materia urbanistica, le controversie che fossero determinate da atti, provvedimenti o comportamenti della P.A., il che “sembra esaurire tutta la gamma delle attività giuridicamente rilevanti della P.A.”. Queste difficoltà ed i dubbi di costituzionalità degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80/1998 sono stati esaminati dalla Corte costituzionale con le sent. nn. 204 e 281/2004, con le quali è stato ridisegnato (e significativamente ridotto) l’ambito della giurisdizione esclusiva. La Corte costituzionale ha quindi precisato che la particolarità delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva implica che tali materie “devono partecipare della medesima natura” di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità “che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisce quale autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo”. A dire della Corte, cioè, “il legislatore ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero, pur sempre, in quanto vi opera la P.A.-autorità, la giurisdizione generale di legittimità”. Tale soluzione è stata accolta in dottrina con molte critiche, tanto che si è addirittura giunti a dubitare della stessa sopravvivenza della giurisdizione esclusiva. Assai rilevante è stato l’intervento manipolativo che ha operato la Corte sul testo degli artt. 33 e 34. In primo luogo, infatti, la Corte ha ritenuto incostituzionale l’art. 33, nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “‘tutte le controversie in materia di pubblici servizi’ anziché le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, o relative a provvedimenti adottati dalla p.a. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla l. 241/1990, o, ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto “incostituzionale l’art. 33, nella parte in cui individua esemplificativamente (“in particolare”) controversie nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità”. Di minore portata, anche se significativa, la modifica all’art. 34. Tale previsione è stata ritenuta incostituzionale nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” della p.a. e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Le controversie concernenti i comportamenti meri della pubblica amministrazione in materia di urbanistica ed edilizia sono quindi state restituite alla cognizione del giudice ordinario, ad eccezione di quei comportamenti che siano riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. 7. (Segue): gli attuali confini della giurisdizione esclusiva Il legislatore del 2010 non ha introdotto novità di rilievo; piuttosto, esso, da un lato, ha recepito i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte cost. e, dall’altro, ha cercato di sistemare in maniera organica le numerose ipotesi di giurisdizione esclusiva già previste nel nostro ordinamento, le quali, hanno continuato ad aumentare notevolmente di numero. Art. 7, comma 1, del Codice: “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”. Ai sensi del comma 5, “nelle materie di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”. Infine, ai sensi del comma 7, “il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi”. In queste disposizioni è ben presente l’eco delle sentenze della Corte costituzionale esaminate. Per quanto concerne, invece, le materie attualmente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esse sono elencate dall’art. 133 del Codice, che prevede ben ventisette ipotesi. L’elenco, non è tassativo, giacché il comma 1 dell’art. 133 fa salve “ulteriori previsioni di legge”. Fondamentali sono le ipotesi concernenti le controversie in materia di: - diritto di accesso ai documenti amministrativi; - pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, o relative a provvedimenti adottati dalla p.a. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, o relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, assicurazioni e mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, trasporti, telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità; - procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolti da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; - atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa ed ablativa; - atti, provvedimenti, accordi e comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; - rapporti dl lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Sembra che alla limitazione dei caratteri “intrinseci” della giurisdizione esclusiva, imposta dalle pronunce della Corte costituzionale, abbia corrisposto un notevole aumento delle ipotesi di questa stessa giurisdizione, che sono divenute a tal punto numerose da farla sembrare, di nuovo, la più importante tra le forme di giurisdizione rimesse al giudice amministrativo. 8. I poteri di piena, giurisdizione del giudice esclusivo Innovazioni incisive, vi sono state anche in relazione all’ambito dei poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo. Quanto ai poteri istruttori, l’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 80/1998 consentiva all’interprete di superare il limite posto da norme ormai risalenti alla cognizione piena dei fatti della controversia e quindi, oltre che alla verifica della loro esistenza, a quella del loro corretto apprezzamento e della loro valutazione da parte dell’Amministrazione pubblica. Ciò è avvenuto grazie al consistente ampliamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo rispetto a quelli tradizionali della giurisdizione generale di legittimità, un ampliamento che già prevedeva l’ammissibilità nel processo amministrativo di tutti “i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica, esclusi l’interrogatorio formale ed il giuramento”. In questo modo il giudice é stato fornito di strumenti idonei ad assicurare un effettivo sindacato sul fatto, ossia sulla valutazione e sull’apprezzamento dei fatti operato dall’Amministrazione pubblica, come era stato riconosciuto dalla stessa giurisprudenza secondo cui “ciò che è precluso al giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità è la diretta valutazione dell’interesse pubblico concreto relativo all'atto impugnato: dunque, del merito dell’atto amministrativo. La c.d. discrezionalità tecnica, invece, è altra cosa dal merito amministrativo. L’applicazione di una norma tecnica può comportare valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento, quando la norma tecnica contenga dei concetti indeterminati o comunque richieda apprezzamenti opinabili. Ma una cosa è l’opinabilità, altra cosa è l’opportunità. La questione di fatto, che attiene al presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo non si trasforma -soltanto perché opinabile- in una questione di opportunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di merito. Ciò è confermato anche dalle acquisizioni della Corte di cassazione”. Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto la sussistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra l’ampliamento dei mezzi di prova e la pienezza della cognizione del fatto, rilevando come “l’esperibilità della consulenza tecnica nel processo del lavoro pubblico, così come successivamente per le materie di giurisdizione esclusiva piena, è strumentale al più completo accertamento del fatto”. Questo ampliamento della cognizione del giudice, risultava strumentale alla funzione propria del giudizio di giurisdizione piena che non è, come nella tradizionale giurisdizione di legittimità, l’annullamento di un atto amministrativo illegittimo. La funzione di quel giudizio è quella di assicurare la reintegrazione, anche in forma specifica, delle situazioni giuridiche soggettive di cui il ricorrente assume la lesione e, quindi, in sostanza, di assicurare al ricorrente il conseguimento concreto della utilità o del bene per il quale egli agisce in giudizio. A differenza di quanto accade nel tradizionale giudizio di legittimità, dove l'accertamento del fatto da parte del giudice è preordinato (e si limita) alla sola verifica della correttezza formale e sostanziale dell’esercizio della funzione amministrativa, nel giudizio di piena giurisdizione la verifica sul corretto esercizio della funzione amministrativa costituisce solo uno dei momenti dell’accertamento giudiziale, dovendo esso poi proseguire per verificare la concreta fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente nei confronti dell’Amministrazione pubblica e la sussistenza dei presupposti per una sua reintegrazione. L’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 80/1998, prevedeva già che il giudice potesse disporre “anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno”. È innegabile che esso abbia introdotto una generale azione di condanna dell’Amministrazione pubblica; è del pari innegabile che tale potere di condanna non fosse limitato alla pronuncia risarcitoria in forma generica e quindi alla condanna al pagamento di una somma di danaro; azione già prevista, sia pure con il limite della condanna “al pagamento delle somme di cui (l’Amministrazione) risulti debitrice”, dall’art. 26, comma 3, della legge istitutiva dei T.A.R. L’art. 35, comma 1, infatti, consentiva già al giudice di disporre una condanna alla reintegrazione, anche in forma specifica e, quindi, una condanna dell’Amministrazione ad un dare, ad un facere e ad un praestare specifico. Si è trattato di una profonda rottura del tradizionale sistema di giustizia amministrativa, seppure limitata ad alcuni blocchi di materie. Questa soluzione ha trovato conforto nella più autorevole giurisprudenza di Cassazione, secondo cui con le previsioni dell’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, “risulta compiuta dal legislatore una decisa scelta nel senso del superamento del tradizionale sistema del riparto della giurisdizione in relazione alla dicotomia diritto soggettivo interesse legittimo, a favore della previsione di un riparto affidato al criterio della materia, in particolare, per il giudice amministrativo, viene delineata una nuova giurisdizione esclusiva: nuova, perché nel contempo esclusiva, nel significato tradizionale di giurisdizione amministrativa indifferentemente estesa alla cognizione degli interessi legittimi e dei diritti, e piena, in quanto non più limitata all’eliminazione dell’atto illegittimo, ma estesa alla reintegrazione delle conseguenze dannose dell’atto, perché comprensiva del potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto”. La Cassazione, aveva ritenuto che non potesse “negarsi che la suindicata disciplina incide in modo significativo sul tema della risarcibilità degli interessi legittimi, sia sotto il profilo strettamente processuale, sia sotto quello sostanziale". Con riferimento al profilo processuale, si era osservato “che l’opzione a favore di un’estensione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, per la cui individuazione rileva la materia e non la individuazione della posizione giuridica soggettiva in termini di interesse illegittimo o diritto soggettivo, determina una sensibile attenuazione della generale rilevanza della distinzione fra le due figure”. In secondo luogo, sempre secondo la Cassazione, “la scelta, compiuta dal legislatore, di realizzare davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, con cognizione estesa indifferentemente agli interessi legittimi ed ai diritti soggettivi, in riferimento a vasti e rilevanti settori della vita sociale ed economica, la concentrazione di una tutela potenzialmente esaustiva per la posizione soggettiva lesa dall’esercizio illegittimo della funzione pubblica, sembra implicare la volontà di equiparare quanto a tutela giurisdizionale, le due posizioni (che gli artt. 24 e 113 Cost., pongono su un piano di pari dignità), e di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale”. Ed anche la Corte costituzionale ha adottato una simile prospettiva riconoscendo che, nel far salvo dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale l’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, l’attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria costituisce “uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio e/o conformativo, da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della P.A.”. E l’attribuzione di tale potere giurisdizionale trova giustificazione, da parte della Corte costituzionale, non soltanto nella pienezza della “dignità di giudice” che si è riconosciuta al giudice amministrativo, ma anche nella esigenza di pienezza della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive. La Corte infatti ha riconosciuto che essa “affonda le sue radici nella previsione dell’art. 24 Cost., il quale garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri”. Se le previsioni dell’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998 avevano raggiunto questo risultato, se cioè esse consentivano l’inverarsi di una giurisdizione “piena” appariva già allora evidente come ci si trovasse di fronte ad una “giurisdizione” amministrativa assolutamente diversa dalla giurisdizione esclusiva tradizionale. La tradizionale giurisdizione esclusiva, non era una terza specie di competenza rispetto a quella di legittimità ed a quella di merito, in quanto in essa il giudice amministrativo pronunciava ora come giudice di legittimità, ora come giudice di merito. Nella “nuova” giurisdizione esclusiva, invece, si era già in presenza di una “giurisdizione” del tutto diversa ed autonoma: sia da quella generale di legittimità, sia da quella tradizionale di merito. Un modello processuale del tutto nuovo, in cui il giudice amministrativo era già titolare di amplissimi poteri istruttori ed era al contempo investito di peculiari e penetranti poteri di condanna. Questi caratteri della “nuova” giurisdizione esclusiva sono stati mantenuti del tutto fermi anche dal nuovo Codice. 9. L. 205/2000 e le prospettive di unificazione delle diverse “giurisdizioni” nell’unico modello processuale della giurisdizione piena Il comma 3 dell’art. 7 della legge istitutiva dei T.A.R., attribuiva alla giurisdizione del giudice amministrativo “tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”. Tale previsione, trasformava le caratteristiche della giurisdizione generale di legittimità non meno di quanto non l’avesse fatto l’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998 per la giurisdizione esclusiva. Anche nella giurisdizione di legittimità, infatti, si superava l’angusta prospettiva del giudizio di annullamento e si apriva quel giudizio all’eventuale risarcimento dei danni. Ebbene, questo dato, unito all’ampliamento dei mezzi istruttori anche nella giurisdizione di legittimità, sia pure in maniera più contenuta, lasciava intravedere un marcato processo di avvicinamento dei due modelli processuali risultanti dalle recenti riforme. Secondo la prospettiva della giurisdizione piena quando la fattispecie illecita sia integrata da un provvedimento amministrativo, il giudice della giurisdizione piena, ma il discorso vale in astratto per qualsiasi giudice che conosca della responsabilità, non può non conoscere in via principale dell’atto dei pubblici poteri da cui origina la lesione. In caso contrario si verificherebbero gravi inconvenienti sia dal punto di vista dell’effettività della tutela assicurata al cittadino, sia per la PA. resistente, che potrebbe essere chiamata a risarcire pregiudizi in realtà inconsistenti che si ricollegano alla lesione di interessi c.d. procedimentali o strumentali. La sintesi tra questi punti già portava ad affermare che il giudice della giurisdizione piena, anche nell'esaminare un provvedimento amministrativo, doveva essere e non poteva che essere giudice del rapporto, nel senso che avrebbe dovuto valutare della legittimità dell’atto non in astratto ma con specifico riferimento alla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal ricorrente ed alla sua fondatezza e, quindi, al danno che in concreto e sotto il profilo sostanziale quel provvedimento, che si assume illegittimo, era effettivamente in grado di produrre. Ogni tentativo di conservare al giudice della piena giurisdizione le vesti di giudice dell’atto, avrebbe riproposto interrogativi insolubili e inconvenienti non evitabili. L’impossibilità di configurare un’azione di annullamento autonoma e distinta dalla tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dal ricorso di piena giurisdizione, costituiva, nell’assetto normativo immediatamente previgente alla introduzione del Codice, il principale e persistente tratto di discriminazione più netta tra la tutela offerta in sede di giurisdizione esclusiva e quella che era invece azionabile davanti alla giurisdizione generale. L’elemento differenziale stava proprio nel carattere unitario che contraddistingue il sistema delle azioni nella giurisdizione piena; sistema che si costruisce tutto attorno al cardine dell'azione di condanna alla riparazione (anche in forma specifica) delle ingiuste lesioni subite dal ricorrente. Nella giurisdizione generale di legittimità, invece, il giudizio continuava a fondarsi sull’articolazione delle azioni di cui all’art. 26 della legge istitutiva dei T.A.R., cui si era poi affiancata quella prevista dall'art. 21 bis della medesima legge. Il giudizio, quindi, restava rigidamente caratterizzato da un modello processuale tutto finalizzato ad un generale sindacato di legittimità dell’azione amministrativa che si esercitava facendo ricorso all'azione di annullamento o, in caso di silenzio dell'Amministrazione, ricorrendo alla (nuova) azione avverso il silenzio. L’azione di condanna al risarcimento costituiva, invece, azione meramente “eventuale” e sussidiaria, prevista come rimedio ulteriore ed aggiuntivo ove la sentenza costitutiva di annullamento (o quella di condanna a provvedere) non risultasse sufficiente a ristorare la lesione della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente in giudizio. Le questioni relative all’eventuale risarcimento, del resto, erano relegate dallo stesso legislatore fra “gli altri diritti patrimoniali consequenziali” alla pronuncia principale, che restava appunto quella sulla legittimità dell’azione amministrativa. Non vi era dubbio, però, che questo tratto differenziale fra giurisdizione generale e giurisdizione piena si fondava più sui limiti derivanti da un’interpretazione letterale delle norme che non su una corretta interpretazione della ratio che aveva ispirato il legislatore. Tale interpretazione letterale, infatti, trovava suo unico cardine nella affermazione del nesso di pregiudizialità necessaria tra azione di annullamento e domanda di risarcimento del danno. Trattandosi però di un’interpretazione la cui condivisibilità era fortemente contestata non solo da autorevole dottrina, ma dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, si era portati a ritenere che, in prospettiva, questo tratto differenziale fra le due “giurisdizioni” sarebbe venuto prima o poi a cadere. E la legge di delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo poteva essere un'utile occasione in tal senso, nell’ambito del riordino del sistema delle azioni processuali. 10. Il Codice del processo amministrativo: il modello unico processuale della giurisdizione piena realizzato soltanto in parte Il nuovo Codice del processo amministrativo ha realizzato solo in parte il modello unico processuale di giurisdizione piena. Le novità più importanti riguardano la giurisdizione generale di legittimità. L'art. 7, comma 4, del Codice mantiene ferma la devoluzione alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo anche delle controversie “relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma” e che, a mente dell’art. 30, comma 2, questa forma di tutela comprende anche, sussistendone i presupposti, il risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c. Seppure il Codice non prevede espressamente un’azione di accertamento autonomamente attivabile innanzi al giudice amministrativo, quest’ultima sembra comunque potersi considerare implicitamente ammessa attraverso una lettura congiunta delle disposizioni contenute nell’art. 7, commi 1 e 4, nell’art. 31 e nell'art. 34, comma 1, lett. c), dello stesso Codice. Infine, si è cercato di dare rilievo alle nuove disposizioni contenute nell’art. 63 del Codice, che consentono ora al Giudice, anche nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, di disporre tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi soltanto l’interrogatorio formale ed il giuramento. Queste disposizioni sembrano deporre nel senso di configurare anche la giurisdizione generale di legittimità come una giurisdizione piena e di carattere eminentemente soggettivo, volta, cioè, in via principale ed immediata, ad offrire tutela alle situazioni soggettive incise dal potere amministrativo autoritativo, consentendo al giudice, dal punto di vista istruttorio, un pieno accesso a tutti i fatti che hanno dato origine alla controversia e, dal punto di vista dei poteri decisori, di rendere pronunce davvero satisfattive dell’interesse del ricorrente, in base al principio di pienezza e di effettività della tutela. All’interno dello stesso Codice permangono numerose altre disposizioni che sembrano, invece, continuare ad ispirarsi a quel modello “tradizionale” della giurisdizione generale di legittimità. L’antica e significativa questione della pregiudizialità amministrativa è stata risolta con una soluzione di compromesso per nulla condivisibile, che, in realtà, sembra implicare un ritorno al passato della giurisdizione di legittimità. Seppure, infatti, l’art. 7, comma 4, del Codice ammette, in termini generali, l’azione in via autonoma per il risarcimento del danno derivante da ingiusta lesione degli interessi legittimi, l'art. 30, comma 2, dello stesso Codice pone, al riguardo, un termine perentorio brevissimo, di soli 120 giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo; ed il comma 5 dello Stesso articolo aggiunge che “nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”. Capitolo 5: La competenza l. I criteri generali di distribuzione della competenza All’interno della giurisdizione amministrativa, la competenza è attribuita sulla base dei seguenti criteri: il grado, il territorio e la materia; è nell'esame di tali criteri che si esaurisce lo studio della competenza del giudice amministrativo. 2. La Competenza per grado La competenza in base al grado è quella che disciplina il riparto della cognizione giurisdizionale fra giudici di grado diverso appartenenti al medesimo ordine giurisdizionale. Fino all’istituzione dei TAR, nel nostro sistema di giustizia amministrativa non si poneva alcun problema di riparto di competenza in ragione del grado di giudizio, esistendo un unico grado di giurisdizione amministrativa ed un unico giudice amministrativo: il Consiglio di Stato. Il criterio del grado, è ora disciplinato dal Codice, il cui art. 4 dispone, in termini generali, che “la giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato”. Il successivo art. 5, comma 1, individua come organi della giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali ed il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige. Il Consiglio di Stato, invece, viene riconosciuto come “organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa” (si dispone poi che “avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato”). Il criterio di competenza per grado trova alcune eccezioni, sia per quanto riguarda un’ipotesi di competenza in unico grado del Consiglio di Stato, sia per quanto riguarda la giustizia amministrativa nella Regione siciliana. Quanto all'ipotesi di giurisdizione in unico grado del Consiglio di Stato il riferimento è al giudizio di ottemperanza ove esperibile in unica istanza. Quanto alle peculiarità del sistema di giustizia amministrativa della Regione siciliana, si dispone che “gli appelli avverso le pronunce del tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione”. 3. La competenza territoriale Una delle più significative novità introdotte dal Codice rispetto all’assetto normativo previgente risiede nel carattere inderogabile della competenza territoriale dei tribunali amministrativi regionali, mentre ai sensi dell’art. 31 della legge n. 1034/1971 questa competenza era -salvo le ipotesi di competenza funzionale- sempre derogabile. L’art. 13 del Codice, che ne reca la disciplina, definisce tale competenza “inderogabile” nella sua stessa rubrica. Con il d.l. n. 160/2012, il comma 4 è stato sostituito ed integrato da un comma 4-bis ai sensi del quale “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”. Rimane ferma, ai sensi del successivo art. 14, la inderogabilità della competenza funzionale; ma, occorre rilevare, che il comma 4 dell’art. 13 estende la nuova regola della inderogabilità della competenza di cui agli artt. 13 e 14 anche in ordine alle misure cautelari. La ragione di queste norme sembra doversi ravvisare nella intenzione del legislatore di impedire che le parti -ed, in particolare, il ricorrente- possano “scegliersi” arbitrariamente, e per motivi dettati dalla mera convenienza, il proprio giudice amministrativo di primo grado (“forum shopping”) e di risolvere anche i conflitti di competenza derivanti dalla pluralità di atti impugnati con il medesimo ricorso. In effetti, nell’assetto normativo anteriore al Codice, il ricorrente aveva la possibilità di proporre il ricorso presso il tribunale amministrativo regionale da lui preferito, il quale, in caso di richiesta di misure cautelari, avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla stessa, anche se palesemente incompetente ed anche nella ipotesi in cui fosse stato sollevato regolamento di competenza. La nuova disciplina, pur potendo risultare apprezzabile nell’intento di scoraggiare le pratiche appena descritte suscita, tuttavia, qualche perplessità, perplessità attenuata ma non fugata dalle modifiche consistenti intervenute in materia con il d.l. n. 160/2012. La disciplina del Codice sulla competenza, infatti, da un lato, pare tradire una discutibile filosofia di fondo del Codice, che guarderebbe con un certa “diffidenza” alle parti private del processo amministrativo e ai propri difensori, enfatizzando invece eccessivamente il ruolo del giudice e finendo così per orientare lo stesso “nuovo” processo amministrativo in termini “oggettivi”. Dall’altro lato, questa nuova scelta del legislatore può determinare possibili vulnus di tutela nella fase cautelare a danno del ricorrente, nel caso in cui quest’ultimo ed il suo difensore abbiano adito il tribunale amministrativo regionale non competente. In realtà, la previgente disciplina, anche a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 205/2000 nell’art. 31 della legge n. 1034/1971, risultava bilanciare in maniera più appropriata e meno “drastica” le opposte esigenze del rispetto della competenza territoriale prevista dalla legge a garanzia dell’amministrazione resistente e del controinteressato, i quali sempre potevano avvalersi dello strumento del regolamento di competenza, e della effettività della tutela nella fase cautelare a garanzia del ricorrente, a fronte delle note ed oggettive difficoltà che pur sempre possono sorgere -anche alla luce della nuova disciplina- nella individuazione del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. La previgente disciplina, inoltre, nel fare salva, al contempo, la libertà delle parti in ordine alla scelta circa il giudice innanzi al quale il processo si sarebbe dovuto celebrare, non poneva in realtà alcun dubbio di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 25, comma 1, e 125, comma 2, Cost., giacché nei processi (e nelle giurisdizioni) di tipo “soggettivo”, il cui archetipo è offerto dal processo civile -e nell’ambito dei quali dovrebbe essere annoverato anche il processo amministrativo- le parti, salvi taluni casi tassativamente indicati dalla legge, possono sempre stabilire per accordo il foro innanzi al quale svolgere il processo. Per quanto concerne i criteri generali per la determinazione della competenza territoriale dei tribunali amministrativi regionali, può dirsi che il criterio principale è quello contenuto non nel primo, ma nel secondo periodo del comma 1, giacché ivi è scritto che il tribunale ammini strativo regionale “è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di p.a. i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”. Ne deriva che, per individuare il tribunale territorialmente competente, occorre, prima di tutto, verificare se il provvedimento o l’atto o l’accordo o il comportamento di una p.a., indipendentemente dalla collocazione territoriale della sua sede, producano effetti immediati e diretti che siano limitati ad un solo ambito territoriale regionale. In caso positivo, sarà territorialmente competente il tribunale che ha sede in tale Regione, anche se la p.a. autrice del provvedimento, dell’atto, dell’accordo o del comportamento abbia la propria sede in un diverso ambito territoriale regionale. Questa previsione è giustificata dall’intento di non crescere oltremodo il carico di ricorsi davanti al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, nella cui circoscrizione hanno sede la maggior parte delle p.a. nazionali. Solo se non ricorre tale ipotesi sarà territorialmente competente, ai sensi del comma 1, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha la propria sede la p.a. autrice del provvedimento, dell’atto, dell’accordo o del comportamento. Il criterio previsto dal primo periodo del comma 1 coincide, in realtà, con quello previsto dal comma 3 con riferimento agli atti dei soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che abbiano efficacia ultraregionale: anche in questo caso, infatti, sarà territorialmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto pubblico. Diversamente, per gli atti delle amministrazioni dello Stato che abbiano efficacia ultraregionale, ai sensi dello stesso comma 3, la competenza territoriale, indipendentemente dalla sede dell’amministrazione agente, spetta al T.A.R. del Lazio, sede di Roma. In conclusione, il Codice ha accolto, in linea di massima, quella dottrina che, già nella vigenza della legge n. 1034/1971, aveva affermato, nei casi dubbi, la preminenza del criterio della efficacia dell’atto sul criterio della sede dell’autorità agente. Conformemente a quanto già previsto della legge n. 1034/1971 ed agli orientamenti della giurisprudenza formatisi al riguardo, l’art. 47, comma 1, del Codice afferma che “non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata”. La stessa disposizione, peraltro -e a differenza del precedente assetto normativo- fa salve le ipotesi di competenza funzionale ai sensi dell’art. 14. Quindi, le questioni in esame, ove non concernano ipotesi di competenza funzionale, sono risolte dal presidente del tribunale con ordinanza motivata non impugnabile e, quindi, non trova in loro confronto applicazione la disciplina prevista dall’art. 15 del Codice (concernente il regolamento di competenza), ad eccezione dei soli commi 8 e 9 nel caso in cui siano state disposte misure cautelari. Per contro, ove tali questioni concernano ipotesi di competenza funzionale, troverà in loro confronto applicazione la disciplina prevista dall’art. 15 (e, sembrerebbe, anche quella prevista dall’art. 16). 4. Criteri derogatori: il foro speciale dei pubblico impiego I criteri generali cui si è fatto cenno sono derogati in una serie di ipotesi. Per quanto riguarda i pubblici dipendenti il comma 2 dell’art. 13 riconferma la tradizionale regola, di favor in loro confronto, per cui le controversie di lavoro riguardanti questi ultimi -o meglio: riguardanti i soli dipendenti pubblici il cui rapporto di servizio è rimasto in regime di diritto pubblico- sono attratte alla competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio. Al riguardo, occorre rilevare che l’art. 135 del Codice, che elenca, al comma 1, le controversie devolute alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, precisa, al comma 2, che tale competenza funzionale non si estende alle controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, che quindi rimangono disciplinate, sotto il profilo in esame, e diversamente dal previgente assetto normativo, dalla ordinaria competenza territoriale ai sensi dell’art. 13, comma 2. Al contrario, ai sensi del comma 1, e ai sensi dello stesso comma 2 dell’art. 135, restano devolute alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, “le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE” (Servizi di Informazione e di Sicurezza). 5. Connessione, litispendenza e continenza di cause L’atto amministrativo impugnato non si presenta sempre isolato, ma variamente collegato con altri atti, sia precedenti che successivi, sia della medesima che di altre autorità. Potrebbe accadere, che il ricorso proposto avverso uno o più atti amministrativi risulti, quanto all’oggetto dell'impugnativa, in tutto o in parte coincidente con altro ricorso già pendente davanti ad altro giudice amministrativo: si parla in questi casi di connessione soggettiva. Continua a mancare anche nel Codice, una disposizione che preveda la confluenza in un’unica sede delle liti oggettivamente connesse, in deroga ai criteri generali e speciali richiamati. Nel Codice, soprattutto dopo il secondo correttivo, è stata inserita una disposizione secondo la quale la competenza territoriale si stabilisce in base “al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere”, cioè al provvedimento lesivo, con attrazione della competenza relativa agli atti presupposti, a meno che si tratti di atti normativi o generali (art. 13, comma 4-bis). Allo stesso modo di quanto accade per la connessione, il Codice nulla dice per i casi di litispendenza. In questo caso, però, la posizione della dottrina, secondo cui può comunque applicarsi in via analogica il disposto dell’art. 39, comma 1, c.p.c., che adotta il criterio della prevenzione (la competenza spetta al giudice adito per primo), è stata accolta in giurisprudenza. I giudici amministrativi, infatti, ritengono che, se in sede di trattazione di un ricorso risulta che il ricorrente ha già proposto contro lo stesso provvedimento altro ricorso che è pendente davanti ad un diverso T.A.R., il giudice successivamente adito deve con sentenza dichiarare la litispendenza e disporre con separata ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo anche questa regola pretoria sembra potersi ritenere valida pure dopo l’introduzione del Codice. La giurisprudenza, se ha riconosciuto, in generale, che l’istituto in esame si applica pure nel processo amministrativo, ha spesso precisato i presupposti ed i limiti di tale ambito di operatività. Innanzitutto si ha litispendenza quando si verifichi la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa, e a tal fine è necessario che le cause proposte siano caratterizzate da eadem res, eadem persona, uguale petitum ed identica causa petendi, ed occorre che le cause stesse siano introdotte davanti a giudici diversi. Non sussiste invece litispendenza fra giudizi proposti davanti allo stesso giudice potendosi in quel caso applicare, sempre per analogia, l’art. 273, comma 1, c.p.c. che prevede la riunione dei giudizi. La continenza di cause, invece indica il rapporto tra due azioni, una delle quali più ampia, contiene in sé l’altra, essendo identici i soggetti e la causa petendi e con il solo petitum differente, perche in una di esse il petitum è maggiore e comprende in sé quello di un’altra. Si è però negata, in giurisprudenza, l’applicabilità al processo amministrativo delle regole sulla continenza di cause dettate dal codice di procedura civile; si è ritenuto infatti che non è ipotizzabile, data l’intrinseca differenza di ciascun atto amministrativo da ogni altro, che l’oggetto di un giudizio amministrativo possa essere ricompreso in un altro indirizzato contro un atto diverso. Si deve precisare però come questa conclusione restrittiva vale solo per i giudizi di annullamento di atti e non per gli altri giudizi o le altre pretese processuali che in sede di giurisdizione piena o esclusiva pure possono essere dedotti davanti al giudice amministrativo. Per quanto riguarda l’identificazione del foro competente nei giudizi di accertamento, la giurisprudenza, che in precedenza aveva affermato l’applicazione analogica dei principi generali anche in tali ipotesi, più di recente, con riferimento a domande di accertamento di diritti soggettivi di carattere patrimoniale che trovano titolo in rapporti contrattuali, e a domande di condanna al pagamento di somme di denaro deferite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha ritenuto applicabile il criterio previsto nell’art. 20 c.p.c. secondo cui per le cause relative a diritti di obbligazione è competente il giudice del luogo ove è sorta o si deve eseguire l’obbligazione dedotta in giudizio, salva per le amministrazioni statali l’applicazione dell’art. 25 c.p.c. Con specifico riguardo, però, ai giudizi risarcitori consequenziali ad un giudizio di annullamento, è stata affermata la competenza del “giudice di fronte al quale è portata l’impugnazione del provvedimento lesivo”, quand’anche la domanda di risarcimento del danno “sia stata avanzata con autonomo e successivo ricorso” proposto dopo la conclusione del giudizio di impugnazione. 6. La competenza funzionale La competenza funzionale si caratterizza per due elementi, uno necessario (il proprium) ed uno meramente eventuale. Sotto il primo profilo, tale competenza, ascritta ex lege in capo ad un determinato tribunale amministrativo regionale ed in relazione a determinate controversie, era -come è anche oraassolutamente inderogabile ad opera delle parti. Sotto il secondo profilo, la competenza funzionale poteva -e può anche ora- essere ascritta in capo ad un tribunale amministrativo regionale diverso rispetto a quello ordinariamente competente in base ai criteri che determinano la competenza territoriale. Nel nuovo sistema delle competenze realizzato dal Codice, la competenza funzionale, finisce per distinguersi dalla ordinaria competenza territoriale, una volta che anche quest’ultima è divenuta sempre inderogabile, soltanto nei casi in cui il tribunale amministrativo regionale individuato dalla legge come funzionalmente competente risulti (al contempo) diverso da quello che sarebbe territorialmente competente in via ordinaria. Ciò che non sempre avviene. La ragione principale che induce il legislatore a prevedere ipotesi di competenza funzionale risiede nell’esigenza che determinate tipologie di controversie, afferenti a particolari materie, risultino, per la delicatezza delle questioni che implicano, affrontate e risolte, già in primo grado, da una medesima giurisprudenza amministrativa. Le sempre più numerose ipotesi di competenza funzionale introdotte dal legislatore negli ultimi tempi, quasi esclusivamente a favore del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, hanno suscitato, sia in dottrina che in giurisprudenza, diversi dubbi in ordine alla loro legittimità costituzionale. Di recente, però, è intervenuta sul tema la Corte Costituzionale con la sentenza 237/2007, la quale, ha riconosciuto assai ampi margini di discrezionalità in capo al legislatore nel determinare nuovi casi di competenza funzionale. La stessa sentenza, non ha indicato espressamente i limiti “massimi” di una tale discrezionalità, che devono pur sempre sussistere. L'art. 14 del Codice prevede ben sei ipotesi di competenza funzionale. Una è quella che viene rimessa dal comma 2 al T.A.R. Lombardia, sede di Milano, per tutte le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Le ipotesi più rilevanti sono comunque quelle previste dal comma 1 dell’art. 14, che rimette alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sia le numerose tipologie di controversie analiticamente elencate nell’art. 135 dello stesso Codice, sia tutte le altre controversie relativamente alle quali “la legge” preveda la competenza funzionale di questo stesso tribunale amministrativo regionale. Quest’ultima previsione si appalesa ultronea e ridondante, almeno in riferimento a leggi future che eventualmente introducano nuove ipotesi di competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, sede di Roma: la sua valenza precettiva, piuttosto, potrebbe riferirsi ad altre ipotesi di questa stessa competenza anteriori al Codice, ma in esso non espressamente richiamate. Un’altra ipotesi importante, è la prima di quelle previste dal comma 3 dell'art. 14, che definisce “funzionalmente inderogabile” la competenza per i giudizi di cui al successivo art. 113, il quale ultimo disciplina il “ Giudice dell’ottemperanza”. Il ricorso deve essere proposto davanti allo stesso giudice amministrativo che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta, quando con esso si voglia conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato nonché delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi; la norma, peraltro, specifica, come deroga a tale regola generale, che la competenza è (sempre funzionalmente inderogabile) del tribunale amministrativo regionale anche per la attuazione dei suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. Laddove, invece, attraverso il ricorso di ottemperanza si voglia conseguire l’attuazione di: a) sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario; b) sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non è previsto il rimedio dell’ottemperanza; c) lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (ora, anch’essi espressamente previsti); allora il ricorso deve essere proposto al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza. Lo stesso comma 3 dell’art. 14 definisce “funzionalmente inderogabile” la competenza per i giudizi di cui all’art. 119 del Codice. Questa disposizione, però, appare poco comprensibile, perché l'art. 119, che disciplina il rito abbreviato, comune a determinate materie, non prevede, salve le ipotesi in esso incluse che coincidono con quelle contemplate anche dall’art. 135, alcuna indicazione circa la competenza di determinati tribunali amministrativi regionali; e lo stesso è a dirsi per il successivo art. 120, al quale rinvia lo stesso art. 119. In questi casi, dunque, non potrà che farsi ricorso agli ordinari criteri previsti dall’art. 13. Infine, sempre il medesimo comma 3 dell’art. 14 prevede, con una disposizione di chiusura, che “la competenza è funzionalmente inderogabile per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’art. 13”. A quest’ultimo riguardo, per ragioni di completezza, può rilevarsi che gli artt. 42, comma 4, e 130 del Codice dettano particolari disposizioni concernenti la competenza dei tribunali amministrativi regionali in riferimento, rispettivamente, ai rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale ed ai ricorsi elettorali. Sotto il primo profilo, è previsto che la cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda sia devoluta alla competenza del T.A.R, del Lazio, sede di Roma, o alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 14: in questi casi, la competenza territoriale si radica in capo al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, o in capo al tribunale amministrativo regionale dotato di competenza funzionale. Per quanto concerne, invece, i ricorsi elettorali, è prevista, quanto alle controversie concernenti le elezioni di comuni, province e regioni, la competenza del tar nella cui circoscrizione hanno sede tali enti territoriali; quanto, invece, alle controversie concernenti le elezioni ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, sede di Roma. 7. Il rilievo della incompetenza L’art. 15 del Codice, che disciplina non soltanto l’istituto del “regolamento preventivo di competenza”, ma anche quello del “rilievo dell’incompetenza”, recava nuove disposizioni che quasi nulla avevano in comune con quelle, previgenti dell’art. 31 della legge n. 1034/1971, che pure disciplinava il regolamento di competenza, disposizioni ulteriormente innovate dal d.l. n. 160/2012. Ciò dipende dalla circostanza per cui non soltanto la competenza funzionale, ma anche la competenza territoriale dei tribunali amministrativi regionali è ora espressamente definita come inderogabile. L’articolo 15 del codice, sostituito dal d.l. n. 160/2012, disciplina il rilievo dell’incompetenza stabilendo, al comma 1, che “il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado”, mentre il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 della legge n. 1034/1971 disponeva che “l’incompetenza per territorio non è rilevabile d’ufficio”. Nei giudizi di impugnazione, continua il comma 1 dell’art. 15, il difetto di competenza “è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza” e ciò a differenza di quanto disponeva il comma 9 del l’art. 31 della legge n. 1034/1971 secondo cui “l’incompetenza per territorio non costituiva motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale”. Il rilievo del difetto di competenza dei tribunali amministrativi regionali è, dunque, assoluto in primo grado e temperato in secondo grado: in questa ultima ipotesi, infatti, l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale non può essere rilevata di ufficio, ma può costituire un motivo di appello della sentenza di prime cure; e può costituire anche l’unico motivo di appello di tale sentenza, il quale, se accolto, determina per ciò solo l’annullamento della stessa, con rinvio al giudice di primo grado competente. Questa scelta del legislatore, seppure mira ad evitare problemi pratici, non appare coerente con gli artt. 13 e 14: difatti, avendo questi posto così tanta enfasi sul (nuovo) carattere sempre inderogabile della competenza dei tribunali amministrativi regionali, avrebbe dovuto conseguirne la (doverosa) rilevabilità di ufficio del difetto di competenza anche in grado di appello. Riguardo alle altre disposizioni concernenti il rilievo della competenza, il secondo comma dell’art. 15 prevede che “in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”, mentre, come si precisa al successivo comma 3, “in mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza”. Il rito è quello camerale ed il giudice provvede con ordinanza e, se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa potrà essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente ed in questo caso il processo continuerà davanti al nuovo giudice. Tendenzialmente, la riassunzione preclude alla parte che l’ha effettuata qualsiasi ulteriore contestazione della competenza e quindi anche la proposizione del regolamento di competenza. Ove la parte intenda invece contestare la decisione che pronuncia sulla competenza (senza decidere sulla domanda cautelare) potrà procedere con l’apposito rimedio del regolamento di competenza, rimedio cui può ricorrere anche il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente. L’ordinanza che si pronuncia sulla competenza unitamente e contestualmente decide sulla domanda cautelare può invece essere impugnata sia con il regolamento di competenza, sia con l’ordinario rimedio dell’appello avverso le ordinanze cautelari. La domanda cautelare in pendenza del regolamento di competenza si propone al giudice indicato come competente dal giudice originariamente adito che decide in ogni caso, anche se i suoi provvedimenti, ove dichiarata la incompetenza, perderanno efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza. La domanda cautelare potrà comunque essere riproposta al giudice dichiarato competente. 8. Il regolamento preventivo di competenza La disciplina della competenza si chiude con l’art. 16 del Codice (anch’esso interamente sostituito dal recente d.l. n. 160/2012), che, in ragione del suo contenuto, deve essere letto in maniera congiunta con l’art. 15. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all’art. 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Il successivo comma 2 disciplina il rilievo, “anche di ufficio”, prevedendo che nel caso di regolamento richiesto di ufficio dal giudice indicato come competente dal giudice originariamente adito, l’ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti . Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento o entro sessanta dalla sua pubblicazione. PARTE III Capitolo I: Il modello processuale 1. Nozioni preliminari Processo: iter sequenziale nel quale, o mediante il quale, si svolge l’operazione logica del giudizio. Giudizio: operazione logica consistente nella soluzione della controversia (o lite). Il processo può avere struttura e funzione diverse, ma consiste comunque in una sequenza di atti, esercizio di poteri del giudice e delle parti, disciplinati in modo (più o meno) rigoroso nelle forme e nei termini. Possono esservi diversi modelli di processo. Ciascun modello deve offrire garanzie di equità e di efficienza, in attuazione del principio (o del modello) del giusto processo, così come tratteggiato dall'art. 111 Cost. Le garanzie di equità sono dirette a consentire che il processo si svolga in modo tale da assicurare (almeno in teoria) la soluzione esatta della controversia. Le garanzie di efficienza servono a che la tutela giurisdizionale sia piena e tempestiva. Considerando il processo amministrativo, il suo modello fondamentale è il processo di cognizione che si svolge dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, in primo grado, e dinanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in appello. 2. Profili funzionali Ogni processo è finalizzato a rendere giustizia. Vi sono due modi diversi per giungere a tale risultato: - costruire il processo idoneo per un giudizio inerente alla semplice applicazione della legge nel caso concreto - o costruirlo per un giudizio che si articoli intorno agli interessi dei soggetti che controvertono, ossia che serva a dare tutela alle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nella controversia. Nel primo caso si parla di processo di diritto oggettivo (e l’esempio principe è il processo penale); nel secondo caso si parla di processo di diritto soggettivo (e l’esempio più rilevante è il processo civile). Il processo amministrativo, risponde all'archetipo del processo di diritto soggettivo, in quanto è finalizzato alla tutela delle situazioni soggettive che il cittadino vanta nei confronti della p.a.: in linea generale alla tutela degli interessi legittimi; in “particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”. Il modello processuale che si addice alla tutela di situazioni soggettive è il processo di parti: in cui le parti, e non il giudice, hanno il potere di darvi inizio, di farlo proseguire, di fornire le prove ed eventualmente di farlo terminare senza che il giudizio sia reso. Quando non sono coinvolti interessi generali e come tali indisponibili, il processo di parti comporta che esse abbiano la piena disponibilità del processo; possono, cioè, non solo provocarne l’inizio e la fine, ma possono condurlo a loro piacimento, secondo i loro interessi, per quanto riguarda sia la prospettazione reciproca delle tesi, nel cui contrasto si articola la controversia, sia la allegazione dei fatti sui quali si fondano, sia infine la prova dei fatti allegati. Il processo risponde in tal caso al modello dispositivo. Il processo amministrativo è un processo dispositivo. Nel passato il modello presentava qualche deviazione soprattutto in tema di acquisizione e di valutazione delle prove (si parlava di sistema dispositivo con metodo acquisitivo). 3. Posizione e poteri delle parti Il processo amministrativo, come processo di parti, è caratterizzato da una peculiare distribuzione dei poteri tra giudice e parti; al giudice si lascia la decisione della controversia e la direzione del processo, alle parti è lasciata l’intera (o quasi) iniziativa processuale. Il modello processuale è caratterizzato dai seguenti principi o regole fondamentali: — principio della domanda: principio generale, che riguarda cioè qualsiasi modello processuale; ma nel processo dispositivo acquista un significato più intenso: non solo il giudice non può attivarsi ed aprire il processo senza una domanda di parte, ma egli è tenuto a dimensionare il giudizio esattamente sulla domanda/e di parte: deve pronunciarsi su tutte e solamente sulle domande di parte. L’attore (ricorrente), con la domanda esercita il suo diritto (o, meglio, potere) di azione e determina l’oggetto del giudizio, fissando così i limiti dell’oggetto della decisione del giudice. Inoltre, è la parte che, nel giudizio vertente sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, rappresenta, attraverso i motivi di ricorso, i vizi di legittimità sui quali il giudice deve pronunciarsi. Il giudice non può, di sua iniziativa, prendere in considerazione vizi diversi da quelli prospettati dalla parte: è vincolato alla domanda di parte; — principio dell’impulso di parte: il processo inizia e prosegue solo se la parte (una delle parti) adotta appositi atti di impulso. A prescindere dalla domanda iniziale (ricorso) occorre un atto di fissazione per ogni udienza (di discussione del ricorso), così come un atto di richiesta per ogni operazione istruttoria che il giudice debba compiere. Solo per l’istruzione probatoria sussiste un potere del giudice non condizionato in toto dalla richiesta di parte; ed è ciò che determinava il carattere (o metodo) acquisitivo del processo amministrativo. Nella prassi il giudice esercita tale potere in casi eccezionali; ed oggi, nonostante i poteri d’ufficio siano rimasti, si ritiene che essi possano essere esercitati solo se le parti senza colpa non siano riuscite a raggiungere la piena prova dei fatti. Il principio dell’impulso di parte è assunto in modo tanto assoluto da apparire paradossale: non è sufficiente la proposizione del ricorso per consentire al giudice di fissare la (prima) udienza; ogni volta che una udienza sia stata celebrata, occorre presentare una nuova istanza perché il giudice possa fissare una (nuova) udienza: a seguito dell’esecuzione dell’istruttoria, prima della l. 205/2000, occorreva presentare una nuova istanza di fissazione, anche se nessuna udienza era stata celebrata. Dopo tale legge, con l’ordinanza che decide sui mezzi istruttori il giudice deve fissare la data della successiva udienza. Tutto ciò è eccessivo: sarebbe più semplice che il ricorso iniziale avesse anche il significato di domanda di fissazione di udienza; — principio della disponibilità del processo: il processo amministrativo non termina necessariamente con la formulazione del giudizio e l’emanazione di una sentenza che dirima la lite; può terminare in altri modi: per ragioni obiettive (cessazione della materia del contendere; difetto sopravvenuto di interesse) o per atti (rinuncia) o inerzia (perenzione) delle parti. La parte attrice (ricorrente) può rinunciare al ricorso in ogni fase e grado del processo, perfino in grado di appello e dopo aver ottenuto una sentenza di primo grado favorevole. A differenza di quanto avviene nel processo civile, la rinuncia non ha bisogno di essere accettata dalle controparti; è sufficiente che venga loro notificata e che esse non si oppongano. Se invece il processo attiene a diritti soggettivi, è necessaria l’accettazione delle controparti. Anche la perenzione (estinzione del processo per inattività delle parti protratta per un determinato periodo di tempo: di norma, un anno) si fonda sul carattere dispositivo del processo; ma essa è riferibile al principio dell’impulso di parte, nel senso che il mancato compimento di atti di procedura non solo non fa avanzare il processo ma, a lungo andare, ne determina l’estinzione; — principio di non contestazione: principio per il quale il giudice è tenuto a prendere in esame e decidere solo le questioni effettivamente controverse, ossia quelle in cui alle affermazioni di una parte si contrappongono affermazioni contrarie delle altre parti. La materia del contendere (thema decidendum) è solo quella in cui vi è contestazione. Corollario di questo principio è il dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova (thema probandum) i fatti non espressamente contestati. Il principio si fonda, oltre che sul carattere dispositivo del processo, sul dovere di lealtà e probità, per il quale le parti devono collaborare e circoscrivere la materia del contendere, anche in armonia con il generale principio di economia processuale. Tale principio comporta l’onere di contestazione: la parte che intende far decidere dal giudice una qualsiasi affermazione delle altre parti deve contestarne la fondatezza. 4. Posizione e poteri del giudice Al giudice spetta, oltre che la formulazione del giudizio, la direzione del processo: egli adotta, su istanza di parte, i decreti di fissazione delle udienze; e, anche d’ufficio, i decreti e le ordinanze istruttorie e di integrazione del contraddittorio, i decreti di presa d’atto della rinuncia, della cessazione della materia del contendere, della estinzione del processo e della (maturata) perenzione; eventualmente pronuncia la sospensione e l’interruzione del processo; adotta i decreti e le ordinanze cautelari e, in caso di controversie concernenti diritti soggettivi patrimoniali, anche decreti ingiuntivi; pronuncia le sentenze di merito e di rito. Nel processo amministrativo vige il principio di collegialità: i poteri di decisione e di direzione del processo spettano, salve le ipotesi indicate dalla legge, al collegio giudicante. Non è contemplata la figura del giudice istruttore, né è prevista una fase istruttoria. Questo principio, si è andato nel tempo ammorbidendo. A seguito della legge istitutiva dei T.A.R., gli “incombenti istruttori” possono essere disposti, oltre che dal collegio, anche dal presidente o da un magistrato delegato (fuori udienza), salve la verificazione e la consulenza tecnica. Con la legge del 2000, e poi con il Codice, la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto del presidente o di un magistrato da lui delegato. In caso di estrema gravità ed urgenza il presidente può, con proprio decreto, disporre misure cautelari provvisorie, anche ante causam, che sono efficaci fino alla pronuncia del collegio. Il dato che caratterizzava il processo amministrativo, sotto il profilo dei poteri del giudice, era il metodo (o principio) acquisitivo; al giudice veniva riconosciuto il potere di acquisire le prove, prescindendo dalla iniziativa di parte. Il Codice ha mantenuto i poteri istruttori d’ufficio del giudice, ma ha affermato con chiarezza il principio dell’onere della prova, secondo cui la parte attrice deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa, così come la parte convenuta deve provare i fatti sui quali fonda le sue eccezioni: sulle parti grava l’onere di allegare e di provare i fatti, sia principali sia secondari; il giudice può intervenire d’ufficio soltanto se le parti non sono in grado, senza loro colpa, di raggiungere la prova piena. Il potere acquisitivo del giudice deve essere esercitato non a favore di una delle parti, giacché in tal caso verrebbe meno la terzietà e l’imparzialità. Nella prassi il metodo acquisitivo è stato delimitato: il giudice ritiene di non utilizzarlo allorché la prova può essere considerata nella disponibilità della parte che se ne può giovare. Il principio dell'onere della prova costituisce anche la c.d. regola di giudizio, la regola che il giudice deve seguire in caso di insuccesso dell’istruttoria, cioè nel caso in cui non sia stata raggiunta la piena prova dei fatti allegati dalle parti. Prima del Codice si faceva spesso riferimento al principio del libero convincimento del giudice, nel senso che la quaestio facti che non potesse essere decisa secondo le risultanze probatorie, doveva essere decisa secondo il convincimento del giudice, liberamente raggiunto. Un siffatto orientamento non può essere seguito, perché rischia di compromettere la posizione di terzietà e imparzialità del giudice e di introdurre schemi che, al più, attengono al processo inquisitorio. In base al Codice il principio del libero convincimento non trova collocazione (nemmeno) a proposito della valutazione delle prove: è stato infatti sostituito dalla diversa regola del prudente apprezzamento, in piena corrispondenza con la regola vigente nel processo civile. Il giudice amministrativo ha il potere di acquisire le prove, ponendo la loro esibizione o la loro formazione a carico della parte che ne abbia la disponibilità (in genere, l’amministrazione); ha il potere di valutare le prove acquisite al giudizio; ma nei casi dubbi deve applicare la regola di cui all’art. 2697 c.c., ossia la regola di giudizio dell’onere della prova; tenendo conto, nell’applicarla a carico della parte attrice o delle parti convenute, del comportamento della parte che della prova abbia (o debba avere) la disponibilità. L’onere della prova comporta due regole: una regola istruttoria, che attiene all’allegazione e alla prova dei fatti, e una regola decisoria, che attiene al modo di elaborare il giudizio nel caso in cui i fatti allegati siano rimasti incerti (non pienamente provati). Sezione seconda: Profili oggettivi e strutturali l. L’oggetto del processo in generale Il giudizio amministrativo è nato come (ed è tuttora, almeno di norma) giudizio di impugnazione di atti (o, meglio, provvedimenti) amministrativi. Esso risponde ad un tipo di tutela eminentemente reattiva, che presuppone che l’amministrazione abbia posto in essere atti o comportamenti che colui che si rivolge al giudice ritiene lesivi delle sue situazioni giuridiche soggettive. Come processo (relativo ad un giudizio) di impugnazione, il processo amministrativo può (di norma) essere instaurato solo dopo che un provvedimento sia stato adottato; riguarda la conformità del provvedimento impugnato alle norme che lo disciplinano; si conclude, se il ricorso viene accolto, con l’annullamento del provvedimento. Quindi, nel processo amministrativo, come in ogni altro processo di impugnazione, il provvedimento svolge il ruolo di presupposto processuale, di oggetto della cognizione del giudice, nonché di oggetto della decisione. Il processo amministrativo ha come suo oggetto (proprio e solo) l'atto amministrativo impugnato. Sono state però formulate anche tesi diverse: l’oggetto del processo è stato individuato volta a volta nella pretesa o nell’affermazione processuale dell’attore (ricorrente), nel potere di provocare l'annullamento dell’atto, o invece nel rapporto amministrativo. La stessa nozione di oggetto del processo è controversa, ed è perfino rifiutata da alcuni autorevoli processual-civilisti. Si tratta tuttavia di una nozione utile per valutare il tipo e il livello della tutela che il processo è idoneo ad assicurare, oltre che per impostare correttamente alcuni temi processali, quali la litispendenza e la modificazione della domanda. Per quanto attiene al processo amministrativo, inoltre, l'oggetto del processo è stato ed è al centro di tutti i tentativi compiuti in dottrina per conferire a tale processo una fisionomia non solo precisa ma anche accettabile sotto il profilo della effettività della tutela. Oggetto del processo, inteso come serie coordinata di atti ed operazioni finalizzati alla formazione del giudizio, non può essere altro che l'operazione logica del giudizio; oggetto del giudizio è la (soluzione di una) controversia, la quale si articola intorno all'affermazione processuale (o, se si vuole, alla pretesa) della parte attrice (ricorrente), in quanto contestata dalle affermazioni delle parti convenute; oggetto della controversia (o delle opposte tesi delle parti) è una o più questioni di diritto sostanziale, ossia la differente rappresentazione, in fatto e in diritto, di una situazione oggettiva sostanziale che coinvolge gli interessi delle parti. Siffatta situazione sostanziale è la res in iudicium deducta; è ciò su cui il giudice deve pronunciarsi. Risulta evidente che la materia del contendere è o può essere molto più ampia: essa si articola in questioni pregiudiziali di rito, in questioni preliminari di merito, oltre che nella questione principale di merito. La dottrina processualistica è divisa: secondo alcuni, accanto all’oggetto sostanziale, andrebbe collocato l'oggetto processuale del processo, attinenti rispettivamente alla fondatezza e all’ammissibilità della domanda; secondo altri (opinione preferibile) non esisterebbe un oggetto processuale unitario, né sarebbe configurabile una decisione (esplicita o implicita) sulla questione della ammissibilità della domanda, salva la formazione del giudicato (anche implicito). Ove si ritenga (come sembra corretto) che la nozione di oggetto del processo risponda all’esigenza di chiarire in che modo il diritto sostanziale si renda nel processo, tale nozione non può che essere dimensionata sulla questione principale di merito introdotta nel processo: l’oggetto del processo corrisponde alla res in iudictum deducta. 2. L'oggetto del processo amministrativo Un problema per il processo amministrativo è l’individuazione del suo oggetto tipico: si deve stabilire se esso è limitato al provvedimento impugnato o, più esattamente, alla questione concernente la sua legittimità, o se esso si estenda a questioni, collegate ma non coincidenti con la questione di legittimità dell'atto impugnato, e tuttavia anch’esse riguardanti la tutela delle situazioni soggettive di cui sono titolari le parti. Le due posizioni sono etichettate come processo (o, meglio, giudizio) sull’atto e come giudizio sul rapporto (amministrativo). La dottrina tradizionale è schierata sulla prima posizione, la quale appare piuttosto limitativa, già con riguardo all’oggetto della tutela giurisdizionale, quale stabilito dalle disposizioni costituzionali, che fanno esplicito riferimento alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive. Va peraltro osservato che non si può ritenere l’oggetto del giudizio esteso oltre l’atto (provvedimento) sol perché le questioni di legittimità sollevabili possono riguardare i presupposti, i fatti di legittimazione e il procedimento di formazione del provvedimento. Viceversa ciò che fuoriesce dalla questione di legittimità dell’atto impugnato è il c.d. contenuto conformativo della sentenza, ossia la parte del giudizio e della motivazione della sentenza con la quale il giudice traccia la via che l’amministrazione deve seguire nell’adozione degli “ulteriori provvedimenti”, necessari per riempire il vuoto provocato dall’annullamento giurisdizionale. Il contenuto decisorio conformativo si giustifica se l’oggetto del processo si allarga, oltre l’atto impugnato, a comprendere questioni attinenti alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive o, se si preferisce, al modo di esercizio (futuro) del potere amministrativo. Ci sono poi ipotesi in cui il processo amministrativo, anche al di fuori delle materie di giurisdizione esclusiva, non riguarda atti amministrativi ma semplici comportamenti: si pensi al processo sul silenzio o in tema di accesso ai documenti. Recentemente è stata aggiunta dalla giurisprudenza una nuova ipotesi di giudizio in assenza di provvedimento: è il processo avente ad oggetto la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) considerata come atto del privato dichiarante e non come provvedimento dell’autorità vigilante. In questi casi, mentre non si può indicare alcun provvedimento quale oggetto del processo, risulta evidente che il processo amministrativo, quanto meno in tali ipotesi, assicura la tutela di situazioni giuridiche soggettive. Coloro che sostengono la tesi secondo cui l’oggetto del processo è l’atto svolgono diversi argomenti, i più rilevanti dei quali sembrano essere: la non predicabilità (o inesistenza) di un rapporto giuridico corrente tra amministrazione e privato; l’inidoneità del processo amministrativo ad attribuire ad una o all’altra parte il bene della vita cui esse aspirano. Sul primo argomento si può osservare che, se per rapporto giuridico s’intende (restrittivamente) la relazione tra (titolari di) diritti soggettivi e (titolari di) obblighi (ed obbligazioni), risulta del tutto evidente che un tale rapporto non può essere (di norma) oggetto del processo amministrativo, per la ragione che le situazioni giuridiche soggettive che spettano all'amministrazione e al privato non sono quelle indicate, bensì rispettivamente poteri (o potestà) e interessi legittimi. Tuttavia, se si accoglie una nozione meno restrittiva di rapporto giuridico, intendendolo come relazione tra (titolari di) situazioni soggettive contrapposte ma concernenti un medesimo oggetto, allora è perfettamente predicabile il rapporto giuridico amministrativo (di diritto sostanziale) tra amministrazione e privati: ed è quindi possibile ritenere che sia questo rapporto (e non solo il provvedimento amministrativo che lo definisce) ad essere travasato nel processo, assumendo le sembianze e il ruolo di oggetto del giudizio. Sul secondo argomento è sufficiente rilevare che, se è vero che il processo amministrativo non è idoneo (di norma, e senza considerare il processo di ottemperanza) ad attribuire ad una delle parti il bene della vita cui aspira; è anche vero che questa inidoneità non dipende né dalla struttura del processo né dal suo oggetto, bensì dal modo di essere (nel diritto sostanziale) delle situazioni giuridiche soggettive (e, quindi, del rapporto giuridico), dedotte in giudizio. L’oggetto del giudizio amministrativo è il potere amministrativo, o, più esattamente, la legittimità degli atti (e dei comportamenti) che ne costituiscono esercizio, in funzione della tutela dell'interesse legittimo (o del diritto soggettivo) della (o delle) parte (parti) privata: è cioè il rapporto amministrativo, come dedotto nella domanda giudiziale. Con il che diventa evidente che il rapporto amministrativo non è (può non essere) dedotto in giudizio nella sua integralità, afferendo l’oggetto del giudizio ai profili di illegittimità dell’esercizio del potere, che, rappresentati (di norma) come vizi del provvedimento che definisce il procedimento, siano stati dedotti con l’atto introduttivo del processo (domanda giudiziale o ricorso). Quindi l’oggetto del giudizio, definito dalla parte attrice (ricorrente), non può essere modificato (allargato, integrato) dalle parti convenute, se non attraverso un apposito ricorso incidentale proponibile da parte dei controinteressati. A proposito del processo amministrativo, è corretto parlare di “unilateralità dell’azione”, dato che (a differenza di quanto accade nel processo civile) il rigetto del ricorso, richiesto dall'amministrazione resistente e dai controinteressati, non comporta l’accertamento della legittimità del provvedimento impugnato. Questa notazione non vale per le azioni risarcitorie né per l’azione di nullità. 3. Caratteri del processo Il processo amministrativo ha struttura molto semplice: manca una fase dedicata all’istruzione e si passa quindi, almeno di norma, direttamente dalla fase introduttiva, strutturata come vocatio iudicis, alla fase decisoria. Il processo si risolve ordinariamente in una sola udienza pubblica di discussione orale sulla materia del contendere. Si attuano in pieno i principi della concentrazione, della oralità e della pubblicità del processo. Se insieme al ricorso è proposta una domanda cautelare, quest’ultima viene esaminata in Camera di consiglio, ma è consentita la discussione orale, ove sia richiesta. Una struttura così semplice può aversi solo perché manca una vera e propria fase istruttoria; in particolare manca l’istruzione probatoria: l’acquisizione delle prove avviene su iniziativa di parte, anche a seguito di ordinanza del giudice, che può essere adottata anche fuori udienza. La mancanza di una fase istruttoria non significa che non ci sia istruttoria; inoltre molto spesso sulla quaestio facti non v’e contestazione. Nell’affrontare la decisione il giudice deve seguire un preciso ordine logico: egli “decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa”. Il giudizio può essere definito anch’esso con valore di regola processuale generale, con decisione: 1) sulle questioni di giurisdizione e competenza; 2) sulle questioni pregiudiziali attinenti al processo ci sulle questioni preliminari di merito; 3) sul merito della controversia. Da tale ordine logico si ricava che la decisione sul merito implica necessariamente, anche se non in forma esplicita (giudicato implicito), le decisioni sulla giurisdizione, sulla competenza, sulle pregiudiziali processuali e sulle preliminari di merito. Al rito ordinario sono stati recentemente affiancati una serie di riti speciali, ridisegnati dal Codice. La legge di riforma del 2000, e, sulla sua scia il Codice, hanno esaltato la rilevanza della connessione di cause, stabilendo che, pendente un processo, i successivi provvedimenti connessi all'oggetto del giudizio devono essere impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti: devono cioè essere introdotti nello stesso contenitore processuale. Così, da un lato, l’oggetto del giudizio si amplia e, dall’altro, si realizza una rilevante ipotesi di simultaneus processus. 4. Spunti di riflessione Il processo amministrativo, concepito originariamente come processo di impugnazione di atti e di verifica del modo di esercizio del potere, non ha mai perso questo suo fondamentale carattere, ma nel tempo si è andato adattando alle esigenze di un’effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive, superando l’originaria forma. Il processo di impugnazione non può assicurare nessuna tutela, quando non esiste un atto e tuttavia esiste lesione di situazioni soggettive: si pensi al problema dell’inerzia (silenzio). Con l'avvento (nel 1923) della giurisdizione esclusiva, la veste di processo di impugnazione è risultata troppo stretta per assicurare, da sola, piena tutela ai diritti soggettivi. Tuttavia il processo amministrativo non ha avuto modifiche profonde e sostanziali. Solo con la riforma del 2000 può ritenersi che sia iniziata una diversa fase evolutiva del processo concernente controversie di diritto soggettivo; ma i frutti, sul piano della struttura processuale, sono maturati soltanto con il Codice del 2010. Tuttavia il processo di impugnazione si è andato arricchendo e modificando, perdendo, da un lato, la sua rigida finalizzazione alla mera demolizione dell’atto, ed acquisendo maggiore elasticità quanto ai suoi presupposti processuali e alla sua struttura. Nel tempo, alla forma originaria si sono aggiunte altre forme processuali, idonee all’esercizio di azioni diverse da quella costitutiva-demolitoria; azioni di condanna ed azioni di mero accertamento. Il Codice ha, da un lato, allargato il ventaglio delle azioni proponibili anche in sede di giurisdizione di legittimità, ossia per la tutela degli interessi legittimi; dall’altro lato ha unificato la disciplina processuale per le tre forme di giurisdizione tradizionalmente proprie del giudice amministrativo, cosicché può dubitarsi che, a seguito del Codice, sia teoricamente corretto ritenere ancora sussistenti più forme di giurisdizione. Con il Codice il processo amministrativo ha ottenuto una disciplina in larga parte soddisfacente; tale da consentire la tutela piena ed effettiva nei confronti dell’azione e dell'inerzia della pubblica amministrazione. Capitolo 2: I principi del giusto processo Sezione prima: I principi strutturali o di equità l. Il giusto processo Con l. cost. 2/1999, è stato modificato ed integrato l’art. 111 Cost.: al vecchio testo sono stati premessi cinque commi, e nel primo di essi è stata inserita l'espressione “giusto processo”. La nozione di giusto processo (o di processo “equo” o “leale”), e la serie dei principi (o delle garanzie) in cui essa si articola, non era per l’innanzi né ignota sul piano normativo né estranea al concreto modo di essere del processo amministrativo. La recente modifica dell’art. 111 ha reso espliciti i principi già largamente attuati nella pratica processuale e già riconosciuti come aventi valore costituzionale; ma l’inserimento della nozione in una disposizione costituzionale ha stimolato, ulteriori perfezionamenti e garanzie. Al processo in generale sono dedicati i primi due commi del nuovo testo dell’art. 111, mentre gli altri commi aggiunti riguardano specificamente il processo penale. Il primo comma, secondo il quale “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”, si risolve nella determinazione di una riserva (da intendere come assoluta) qualificata di legge, nel senso che: a) la disciplina processuale deve essere stabilita con fonti di livello legislativo, e precisamente con leggi statali, e non può essere contenuta in fonti di livello diverso (ad esempio, in leggi regionali o in regolamenti); b) la disciplina legislativa deve modellare il processo secondo i principi del giusto processo. Per il processo amministrativo, la riserva di legge è pienamente rispettata soltanto a seguito dell’approvazione del Codice. Il comma 2 dell’art. 111, stabilisce che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. “Giusto processo” è una mera nozione riassuntiva o sintetica, comprendente tutte le garanzie di equità e di efficienza che sono prescritte per l’esercizio della funzione giurisdizionale. Volendo riunire in un quadro complessivo i principi del giusto processo ricavabili dall’intero testo costituzionale, si propone di distinguerli in: - principi strutturali, attinenti al processo in quanto tale. Attengono a questo gruppo i principi di precostituzione (art. 25 Cost.) indipendenza (art. 108), terziarietà ed imparzialità (art. 111) del giudice, il principio del contraddittorio paritario (art. 111), e il principio della necessaria motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111). - principi funzionali, riguardanti il processo come strumento di tutela giurisdizionale. Attengono a questo gruppo il principio della generalità della tutela giurisdizionale e della inviolabilità del diritto di difesa (art. 24), il principio della pienezza della tutela (art. 113), il principio della tempestività della tutela (art. 111). Si può aggiungere il principio della tendenziale massima accessibilità alla tutela nel merito come corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il quadro costituzionale è molto ricco, ed è perfettamente idoneo a configurare un modello di processo equo ed efficiente. “Il giusto processo” comporta che ogni modello concreto di processo configuri un equilibrio razionale tra garanzie di equità e di efficienza. Lo stesso modello di processo giusto o equo è nelle grandi linee, disegnato dagli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; dagli artt. 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dal Patto internazionale sui diritti civili e politici. 2. I principi riguardanti il giudice Rispetto al processo amministrativo il principio del giudice naturale, precostituito per legge, può ritenersi pienamente attuato: le regole sulla giurisdizione e sulla competenza consentono di evitare che il giudice possa essere scelto, volta a volta, da una delle parti. Non violano il principio i numerosi casi in cui, in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale dei Tribunali amministrativi, la competenza è attribuita in via funzionale al Tribunale del Lazio (o della Lombardia). Anche in questi casi, infatti, il giudice è precostituito per legge. Secondo la Corte costituzionale, poi, la competenza funzionale del Tribunale laziale, se rispondente a criteri rigorosi di ragionevolezza, non viola nemmeno l’art. 125 Cost., che impone la ripartizione su base regionale della competenza trai diversi organi di primo grado della giurisdizione amministrativa. La distribuzione delle controversie tra le Sezioni di uno stesso Tribunale amministrativo o tra le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato risponde a criteri precostituiti (almeno annualmente); anche se può dubitarsi che il principio del giudice naturale possa estendersi fino ad influire sulla ripartizione del lavoro all’interno di un organo giurisdizionale strutturalmente complesso. Il principio di indipendenza riguarda il giudice, inteso come organo giudicante, e comporta che esso debba essere posto al riparo da influenze estranee, soprattutto da influenze di altri poteri pubblici. In attuazione del principio di indipendenza i giudici amministrativi sono in regime di autogoverno: la loro scelta, la nomina, la carriera, i trasferimenti, le autorizzazioni allo svolgimento di attività extragiurisdizionali, sono funzioni gestite dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo corrispondente, per composizione e funzioni, al Consiglio superiore della magistratura. Lo status di magistrato amministrativo è sostanzialmente corrispondente, quanto alle garanzie di indipendenza, a quello di magistrato ordinario. 3. Sui principi di terzietà ed imparzialità I principi di terzietà e imparzialità riguardano il giudice come persona: l’ordinamento gli richiede di essere terzo, ossia equidistante, rispetto alle parti, ed imparziale nella decisione della controversia, ossia equidistante rispetto agli interessi coinvolti nel giudizio. Attenendo alla persona dei magistrati, tali principi sono in primo luogo principi di coscienza, che non possono essere imposti per legge; possono peraltro essere fissate regole che agevolino il mantenimento di condizioni di terzietà e imparzialità. Secondo la Corte costituzionale i principi di indipendenza e terzietà del giudice sono “elemento essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione, che si identifica nell’indipendenza istituzionale del giudice e nella sua posizione di terzo imparziale, qualunque siano le parti in giudizio, compresa la pubblica amministrazione”. Con legge è stato approvato un doppio elenco di comportamenti che i magistrati sono tenuti ad evitare. Nel secondo elenco viene elevato ad illecito disciplinare anche l’iscrizione o la partecipazione sistematica continuativa a partiti politici'. Nei confronti dei magistrati amministrativi si pone un problema particolare, dato che essi si occupano di controversie tra privati cittadini e amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono di numero chiuso e limitato, e ciascuna di esse è parte in numerosi giudizi. D’altro canto i magistrati amministrativi, come ogni altro cittadino, hanno spesso necessità di rivolgersi alle p.a.; e, nel tempo, può succedere che si stabiliscano rapporti di consonanza (o di dissonanza) che possono influire sulla terzietà del giudice. Per questa ragione è stato proposto un limite di durata della permanenza dei magistrati amministrativi nella stessa sede e stesse funzioni. Il principio di terzietà rispetto alle parti può, e forse deve, influire sui poteri attribuiti al giudice. Distinguendo tra poteri di direzione del processo e poteri di direzione del processo e poteri di giudizio (o che comunque sono suscettibili di incidere sulla soluzione della controversia), si può ritenere che, mentre per i primi (es. poteri di fissare le cadenze processuali) è opportuno lasciare al giudice ampia discrezionalità (senza che ciò possa contrastare con la riserva di legge), per i secondi (es. il potere di acquisire o di ammettere mezzi di prova e consulenze tecniche; di valutazione del comportamento processuale delle parti) è più opportuno (e forse necessario in base alla riserva di legge) che sia la legge a disciplinarli in modo per quanto possibile incisivo. A1 principio di terzietà può essere rapportato anche il principio della domanda, che si fonda sulla distinzione tra chi propone e illustra la controversia e chi la decide. Contrasta con tale principio l'azione iniziata d'ufficio, che si ha, ad es., in materia di usi civici. 4. La forza della prevenzione In relazione al principio d’imparzialità è stato più volte recentemente affrontato dalla Corte cost., con riferimento al processo penale, il problema della “forza della prevenzione”: un giudice, inteso come persona fisica, che si sia occupato una volta di una controversia, non può occuparsene una seconda volta, in altro grado o fase dello stesso processo, perché potrebbe essere influenzato dal suo precedente orientamento. La Corte cost., che ha fissato regole precise e rigorose per il processo penale, ha viceversa ritenuto (ragionevolmente) che il problema si pone in termini diversi, e meno drammatici, per il processo civile, e può essere risolto con gli istituti della astensione e della ricusazione. La stessa soluzione può essere accolta per il processo amministrativo. Sulla scorta dell’orientamento della Corte, la forza della prevenzione può avere un peso effettivo quando lo stesso magistrato si deve pronunciare esattamente sullo stesso oggetto: ciò non si verifica né tra processo cautelare e processo di merito, dato che nel primo caso la cognizione, oltre che sommaria, è allargata all’esame del danno (grave e irreparabile), derivante dalla durata del processo; né tra processo ingiuntivo e processo di merito su opposizione al decreto (nell’ambito della giurisdizione esclusiva su diritti patrimoniali), dato che esiste differenza tra la cognizione sommaria del primo e la cognizione piena del secondo; né è ipotizzabile tra processo ordinario e processo di ottemperanza, data la differenza di petitum e causa petendi e data la diversa estensione dei poteri del giudice. Può invece ipotizzarsi che sussista forza di prevenzione tra processo di primo e di secondo grado (nel caso che il magistrato venga trasferito dal Tribunale amministrativo al Consiglio di Stato), tra processo ordinario e processo di revocazione, tra processo ordinario e giudizio di rinvio e ancora tra processo ordinario e opposizione di terzo. È stato posto, per i consiglieri di Stato, il problema dell’eventualità che essi possano conoscere della medesima questione sia in sede consultiva sia in sede giurisdizionale (in caso di trasferimento dalle Sezioni consultive alle giurisdizionali): questo potrebbe essere un caso ulteriore di pericolo di prevenzione. Anche per esso possono valere i rimedi della astensione e della ricusazione. Fino all’entrata in vigore del Codice non era ritenuto applicabile l’art. 52 c.p.c.; per cui, in presenza di un’istanza di ricusazione, il giudizio principale non veniva sospeso, e il giudice ricusato poteva partecipare al collegio che decideva sulla sua ricusazione. Siffatta prassi, non rispettosa del principio di imparzialità, è stata superata dall’art. 18 del Codice, secondo il quale sulla istanza di ricusazione decide il collegio “previa sostituzione del magistrato ricusato”. L’imparzialità rappresenta un “connotato intrinseco dell’attività del giudice”; e che, ove essa dovesse mancare, “le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato”, e non avrebbero senso “né la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost.), né la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.)”. Il principio di imparzialità è in definitiva il canone essenziale del giusto processo riferibile al giudice: l’indipendenza e la terzietà non sono altro che presidi dell’imparzialità. Riguarda il giudice anche il dovere di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali. Questa regola, è rimasta a lungo inosservata dal giudice amministrativo, per quanto riguarda le ordinanze cautelari; ma ormai questa vecchia prassi e stata da tempo superata. Anche le sentenze in forma semplificata devono contenere la motivazione; la quale, peraltro, “può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” (art. 74 c.p.a.). 5. Principi riguardanti le parti Fondamentale, con riguardo alla posizione e ai poteri delle parti nel processo, è il principio del contraddittorio e il suo complemento essenziale della parità delle armi: ciascuna parte deve disporre di strumenti equivalenti per determinare il convincimento del giudice e, di conseguenza, il contenuto della decisione. Nel diritto sostanziale amministrativo i soggetti non hanno posizioni paritarie: i soggetti pubblici sono di norma titolari di poteri e i soggetti privati di interessi legittimi. C’è pertanto un notevole squilibrio, che non può in alcun modo riflettersi sul piano processuale; nel quale la parte pubblica non può che avere posizione e poteri del tutto equivalenti a quelli delle parti private. Nella concreta disciplina processuale la parità delle posizioni e il razionale svolgimento del dibattito tra le parti vengono assicurati dalla sequenza ricorso, controricorso, memorie scritte, repliche, discussione orale. Residua peraltro una prassi, secondo la quale la parte pubblica e i controinteressati possono costituirsi in giudizio e formulare le loro eccezioni anche durante l’udienza di discussione, che chiude il dibattito. Cosicché la parte ricorrente può trovarsi improvvisamente a dover contrastare tesi avversarie sulle quali non ha avuto modo di riflettere e di documentarsi. Il Codice non ha posto rimedio a questo inconveniente, dato che il termine per la costituzione delle “parti intimate” non ha carattere perentorio e la sua scadenza non determina alcuna decadenza. I poteri istruttori che il giudice può esercitare d’ufficio, sono da mettere in relazione con il principio della parità effettiva tra le parti: rispetto a controversie, i cui fatti sono con assoluta prevalenza nella disponibilità della sola parte pubblica, il potere del giudice di ricercare la prova può servire a riequilibrare nel processo la disparità delle parti in ordine alla conoscenza. È opinione universalmente condivisa che il confronto dialettico tra le parti costituisca il metodo migliore per giungere ad una decisione “giusta”; cosicché il principio del contraddittorio acquista valore centrale nel modello del processo giusto. Nel processo dispositivo non è necessario che il confronto dialettico si realizzi effettivamente, essendo sufficiente che sia assicurata a ciascuna delle parti l'effettiva possibilità di parteciparvi. 6. Completezza e continuità del contraddittorio Il contraddittorio, per essere tale, deve rispondere ai requisiti della completezza, ossia deve estendersi a tutti i soggetti interessati alla controversia, e della continuità, ossia deve riguardare ogni fase del processo. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, solo ad uno dei controinteressati. Questa regola, non può comportare che alcune parti necessarie del giudizio non partecipino a tutte le fasi del processo. Cosicché l’integrazione del contraddittorio deve essere disposta dal giudice tempestivamente; anche, se necessario, prima della decisione sulla istanza cautelare. Sotto il secondo profilo il contraddittorio deve essere integro per l’intera durata del processo: deve consentire che la dialettica tra le parti sia organizzata razionalmente e che “il dialogo” con il giudice sia continuo. Anche per la procedibilità delle istanze cautelari deve essersi perfezionata la notificazione del ricorso ai destinatari. Inoltre, il termine per la costituzione delle parti resistenti è un termine finale: nel caso in cui il ricorso contenga anche l'istanza cautelare, si può ritenere che le parti resistenti abbiano l’onere di costituirsi tempestivamente. Questa tesi potrebbe mettere l’attuale disciplina della fase introduttiva del processo amministrativo al riparo da problemi di legittimità costituzionale. Il contraddittorio deve sussistere sia nella fase istruttoria, in particolare nella formazione delle prove, sia nella formazione del convincimento del giudice. In linea generale si può affermare che nessuna decisione del giudice, sia istruttoria, sia di merito, possa essere adottata senza che le parti abbiano avuto modo di pronunciarsi preventivamente sulla questione da decidere. 7. Il contraddittorio nell’istruzione e nella decisione Sul piano istruttorio è necessario che l'ordinanza di acquisizione delle prove da parte del giudice sia preceduta dal (la possibilità di) dibattito sulla rilevanza o sulla superfluità delle prove da acquisire. Restando ovviamente la decisione al giudice. Quanto alla formazione del convincimento del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio comporta importanti conseguenze. Si pensi alle questioni rilevabili d’ufficio: la giurisprudenza più recente ed autorevole ha correttamente riconosciuto che, in un modello processuale fondato sul principio del contraddittorio, “la rilevabilità d'ufficio di una questione non significa che, per ciò stesso, tale questione possa essere decisa d’ufficio senza essere sottoposta al contraddittorio della parti”. Il Codice ha recepito tale regola (art. 73, comma 3). Per la stessa ragione del rispetto del contraddittorio il giudice non può decidere la controversia assumendo una soluzione diversa da quelle prospettate dalle parti (c.d. terza via) e sulle quali si è svolto il confronto dialettico. Se il giudice ritiene di scegliere la terza via, deve sottoporla preventivamente al contraddittorio tra le parti. Lo stesso può dirsi allorché il giudice voglia utilizzare il suo sapere privato, o intenda qualificare come notori determinati fatti, o voglia ragionare sulla base di presunzioni. Il rispetto pieno del principio del contraddittorio può anche appesantire l’iter processuale, ma è indubbio che esso consente di giungere ad una decisione più documentata e, soprattutto, più convincente. Nel processo amministrativo manca una prima udienza di essa si avverte la necessità, soprattutto per ragioni istruttorie. È anche auspicabile che i rinvii vengano sempre fatti ad udienza fissa. Sezione seconda: Principi funzionali o di efficienza. 1. Sulla generalità della tutela Il processo di diritto soggettivo serve a fornire tutela “giusta” alle situazioni giuridiche soggettive. La “giustezza” della tutela comporta che essa sia generale, piena e tempestiva. Il processo, è giusto, se risponde a queste fondamentali esigenze. La generalità della tutela è sancita dall’art. 24, comma 1, Cost.; e, con riferimento specifico alle controversie nei confronti dell’amministrazione pubblica, dall’art. 113 Cost.; secondo il quale contro gli atti della medesima “è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”. Non è rispettosa di questo principio la disposizione del Codice, secondo la quale “non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico” (art. 7). Oltre al diritto di azione, ha copertura costituzionale anche il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, il quale è anzi qualificato “diritto inviolabile”. L’esercizio dei diritti di azione e di difesa in giudizio comporta profili economici, soprattutto per le parti, che devono assicurarsi l’assistenza tecnica necessaria: la Costituzione assicura “ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” (art. 24); ma tali istituti non sono stati finora adeguati alle esigenze di un’effettiva tutela, nonostante la Corte costituzionale abbia riconosciuto che il diritto di difesa “è componente essenziale” del giusto processo. 2. Sulla pienezza della tutela Il processo deve assicurare ogni possibile forma di tutela, senza limitazioni che non siano giustificate da altri principi di pari rango costituzionale. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale nei confronti della p.a. tale principio è espressamente inserito in Costituzione, la quale prescrive che la tutela “non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione”. Il Codice dispone che le parti possano avvalersi, e il giudice amministrativo possa disporre, di tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione dell'interrogatorio formale e del giuramento. Sotto il profilo della pienezza della tutela, la disciplina del processo amministrativo è stata profondamente rivista, e sembra ormai adeguata al modello costituzionale del giusto processo. Il Codice non ha invece ridisegnato in senso riduttivo le innumerevoli cause di inammissibilità, irricevibilità, ed improcedibilità che impediscono, talvolta senza ragioni convincenti, che il processo possa chiudersi con la soluzione della questione di merito. 3. Sulla ragionevole durata del processo La tutela giurisdizionale, per essere effettiva, deve essere tempestiva. L’art. 111 Cost. demanda alla legge il compito di assicurare che il processo abbia una durata ragionevole. La durata eccessiva del processo può dipendere dalla disciplina processuale, ossia da come il processo è strutturato, ma può dipendere anche, ed in misura maggiore, dal modo in cui gli uffici giudiziari sono organizzati e dalle risorse di cui dispongono. Per entrambi l’intervento del legislatore ordinario è necessario, per il rispetto della riserva di legge e per la messa a disposizione delle risorse occorrenti. Quanto al processo amministrativo sono necessari soprattutto l’aumento delle risorse e la riorganizzazione degli uffici, dato che la disciplina processuale consentirebbe un andamento del processo svelto e privo di formalità superflue. Sono inoltre previsti riti processuali semplificati, abbreviati, accelerati, atti a soddisfare le esigenze di rapida soluzione delle controversie. Ciò che manca, e che dilata la durata del processo amministrativo, è l'adeguato numero di magistrati e di personale di segreteria. Anche l’uso di strumenti informatici e telematici può rendere più rapido il processo. Forse per porre un freno alle ricorrenti condanne della Corte dì Strasburgo per la eccessiva durata dei processi (anche amministrativi) in Italia, è stata emanata la legge 89/2001, la quale ha previsto uno speciale processo di competenza della Corte d’appello, per coloro che abbiano subito un danno, anche patrimoniale, per l’eccessivo protrarsi del processo. Per la valutazione della ragionevolezza della durata, la legge si è ispirata ai parametri fissati dalla Corte europea: “la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione”. Da ultimo, con il d.l. n. 83/2012 ha individuato la durata ragionevole del processo nei diversi gradi di giudizio, indicando in sei anni il termine ragionevole per la definizione del giudizio in modo irrevocabile, nonché i criteri di computo del termine e le ipotesi in cui non è riconosciuto alcun indennizzo. La suddetta legge trasforma peraltro quello che, secondo la Convenzione, è un diritto all’indennizzo in un diritto al risarcimento del danno. Ciò comporta che non si debba provare in giudizio soltanto la durata irragionevole del processo, ma altresì l’esistenza di un danno e il nesso di causalità tra la durata del processo e il danno subito. Da ultimo, con il d.l. n. 83/2012 ha individuato la durata ragionevole del processo nei diversi gradi di giudizio, indicando in sei anni il termine ragionevole per la definizione del giudizio in modo irrevocabile, nonché i criteri di computo del termine e le ipotesi in cui non è riconosciuto alcun indennizzo. PARTE IV Capitolo 1: La tipologia delle azioni proponibili 1. Azioni e situazioni giuridiche soggettive individuali L’azione: potere, attribuito a tutti i soggetti dell’ordinamento, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. L’azione è un diritto autonomo rispetto alle situazioni giuridiche soggettive che si intendono far valere in giudizio, ma occorre, pur sempre, che si lamenti la lesione e, quindi, si chieda la tutela di una situazione giuridica sostanziale. I caratteri dell’azione: generalità (potere di azione riconosciuto a tutti), autonomia, astrattezza. L’azione è autonoma dalla situazione giuridica sostanziale perché, una volta riscontrati i presupposti dell’azione, non rileva l’eventuale sentenza di rigetto della domanda ai fini della sussistenza del diritto di azione, ma solo ai fini della sussistenza della situazione giuridica sostanziale. L’azione, cioè, consente di adire il giudice per ottenere una sentenza di merito che la parte istante prospetta come favorevole; ma se la sentenza non fosse favorevole, la conseguenza non sarebbe la mancanza del diritto di azione, bensì soltanto della situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si invoca tutela, dal momento che il diritto di azione ha per contenuto la pretesa ad ottenere una sentenza nel merito, non una sentenza favorevole. La situazione giuridica soggettiva sostanziale sta sullo sfondo: l’istante ne deve affermare la lesione ed invocare la tutela per rendere ricevibile la domanda, ma non occorre, ai fini dello svolgimento del giudizio, che ne sia acclarata la sua esistenza e lesione; anzi, il processo tende proprio allo scopo di accertare l’esistenza e la lesione della situazione giuridica soggettiva che utilizza il meccanismo processuale, garantito dal diritto di azione, per ottenere tutela. Proprio l'autonomia del diritto di azione dalla situazione giuridica soggettiva sostanziale comporta che di essa si predichi l’astrattezza; dunque, l’esistenza del diritto di azione non dipende dall’esistenza (effettiva) della situazione giuridica soggettiva. L'autonomia induce alla generalità perché un diritto slegato dalla situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si invoca la tutela non può che essere attribuito a tutti. La Costituzione, non distingue, anzi parifica totalmente il diritto soggettivo e l’interesse legittimo, situazione giuridica, quest’ultima, rilevante nei confronti della p.a., con la conseguenza che il diritto di azione, con i suoi caratteri, non muta se, ad invocare tutela, sia il titolare di un interesse legittimo che si assuma leso. È da rilevare che è riduttivo il riferimento solo ai diritti soggettivi ed agli interessi legittimi, e non anche a tutte le altre possibili situazioni giuridiche soggettive che hanno diritto ad ottenere tutela. 2. Unicità ed atipicità del diritto di azione Il diritto processuale attuale ha abbandonato l’idea che debbano essere disciplinate le forme, le modalità ed i contenuti dell’azione attraverso la predisposizione di un articolato armamentario cui ricorrere per i bisogni della tutela. L’azione è una, atipica ed assume le fattezze della tutela di cui necessita la situazione giuridica soggettiva che si intenda far valere in giudizio, prevista dalle norme sostanziali. L’azione avrà contenuto reale reintegratorio, obbligatorio, di condanna, di costituzione di effetti giuridici, di accertamento etc., senza che occorra la previsione delle rispettive azioni. L’atipicità dell’azione diventa garanzia di tutela piena, completa ed efficiente, possibilmente satisfattiva di ogni situazione giuridica soggettiva prevista dalle norme sostanziali e, nel contempo, espressione di libertà ed autonomia. Ed il fondamento primo di questa impostazione viene colto al massimo livello, quello costituzionale che, all’art. 24, comma 1, sancisce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”9. Non avrebbe, quindi, senso prevedere la disciplina puntuale delle diverse azioni proponibili, cui sono collegati effetti tipici. Nello stesso solco si pone la recente giurisprudenza amministrativa che afferma, con riguardo all’ammissibilità di un’azione atipica nel processo amministrativo e segnatamente dell’azione di accertamento, che “l’assenza di una previsione legislativa espressa non osta all’esperibilità di un’azione di tal genere quante volte, come nella specie, detta tecnica di tutela sia l’unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell’interesse legittimo” e rileva che si tratta di una tecnica di tutela prevista dai principali ordinamenti europei e, qualora le azioni tipizzate non possano soddisfare le esigenze di tutela, l’ammissibilità trova fondamento nelle norme costituzionali immediatamente precettive dettate dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. per garantire la piena e completa protezione dell’interesse legittimo. E, quindi, la garanzia costituzionale impone di ammettere per gli interessi legittimi l’esperibilità dell’azione di accertamento autonomo, come previsto nel processo civile per i diritti soggettivi, non potendo contrastare tale conclusione “il principio di tipicità delle azioni, in quanto corollario indefettibile dell’effettività della tutela è proprio il principio dell’atipicità delle forme di tutela”. Secondo la previsione della legge delega sul processo amministrativo, al (probabile) scopo di “adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori” ha previsto l’inserimento dell’art. 28-bis “(Tipi di azioni). 1. Nell’ambito della giurisdizione amministrativa le parti possono proporre le azioni costitutive, dichiarative e di condanna idonee a soddisfare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”. La norma sembra riecheggiare la legge delega quando stabilisce che la disciplina delle azioni e delle funzioni del giudice deve prevedere le “pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”. Sennonché, nel testo approvato in via definitiva dal governo e che è divenuto il d.lgs. n. 160/2012, è stato eliminato l’art. 28-bis. Ma ciò non può portare alla conclusione che le azioni amministrative giurisdizionali siano solo quelle tipiche perché dagli elementi testuali che si traggono dalle altre disposizioni del Codice si può concludere per l’atipicità delle azioni. Infatti, la giurisdizione amministrativa “assicura una tutela piena ed effettiva” e il giudice, in caso di accoglimento della domanda, adotta, tra l’altro, le “misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” e dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza. Le previsioni del Codice e quelle costituzionali consentono di affermare che, conformemente a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, anche le azioni giurisdizionali amministrative sono atipiche, per cui va riconosciuta la possibilità per il ricorrente di chiedere al giudice amministrativo tutto quello che è indispensabile ad assicurare tutela piena, completa ed efficiente alla situazione giuridica soggettiva che si assume lesa. 3. La soluzione del Codice del processo amministrativo Sulla base dell’unicità ed atipicità del diritto di azione, risulterebbe del tutto “fuori tempo” e, comunque, controcorrente il Codice del processo amministrativo che, nell’articolato provvisorio approvato dalla commissione presso il Consiglio di Stato, addirittura tipizzava almeno otto azioni e, nella versione definitiva sono divenute cinque. Non è possibile però generalizzare un principio che vale per un processo e calarlo negli altri processi. Per il processo amministrativo, vanno considerati due profili che confortano la soluzione adottata dal Codice che ha tipizzato le azioni significative per la tutela dell’interesse legittimo, ma ha lasciato, comunque, spazio all’azione atipica. Infatti, sotto un primo aspetto, il processo innanzi ai Tar ed al Consiglio di Stato si misura con una parte fissa che è la p.a., espressione di un potere istituzionale che presenta qualità e caratteri diversi da un privato cittadino. Il processo civile, invece, vede schierati normalmente privati e, quando una delle parti è una p.a., sta in giudizio come un privato perché il giudice ordinario deve risolvere una controversia in cui si discute di diritti soggettivi, doveri e obblighi, non di interessi legittimi e esercizio del potere. E, anzi, per tutelare l’equilibrio e l’indipendenza tra il potere giurisdizionale e quello esecutivo, la legge del 1865 sull’abolizione del contenzioso amministrativo limitò i poteri decisori del giudice ordinario nei confronti degli atti amministrativi ed è storia nota quella dell’istituzione nel 1889 della Sezione IV del Consiglio di Stato cui fu attribuito il potere di annullare gli atti amministrativi perché nata da una “costola” dell’Amministrazione. Se l’evolversi del sistema e la previsione dell’art. 113, comma 3, Cost. consente al legislatore ordinario di stabilire quali organi giurisdizionali possano annullare gli atti amministrativi, attribuendo, quindi, il relativo potere anche al giudice ordinario, non si può dimenticare che il processo amministrativo interviene nei confronti del potere esecutivo ed è necessario precisare sino a dove possa spingersi il potere cautelare, istruttorio, cognitorio e decisorio dell’organo che giudica il potere istituzionale. Dire che il giudice amministrativo deve adottare le misure idonee a soddisfare l’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente è espressione di un importante principio che afferma e sottolinea il carattere soggettivo del giudizio amministrativo, ma va integrato e precisato con i poteri attribuiti al giudice nei confronti della p.a. Insomma, le esigenze di tutela nel processo amministrativo devono considerare l’equilibrio nei rapporti tra i poteri (giurisdizione e potere esecutivo) e al giudice vanno attribuite le conseguenti misure che può adottare verso la p.a.. In un processo nel quale la tutela dell’interesse legittimo deve armonizzarsi e combinarsi con il potere istituzionale della p.a., può essere utile precisare le azioni ammissibili, tipizzandone alcune, e lasciando uno spazio residuale ad altre azioni, pur ammissibili, ma non tipizzate. Essenziale, però, è che siano precisati i poteri che ha il giudice nei confronti della p.a. perché da essi si desumono le azioni proponibili e, in particolare, quelle atipiche, non espressamente previste dal Codice. Un secondo aspetto a sostegno della strada scelta dal Codice è la particolarità dell’interesse legittimo. Infatti, la (eventuale) previsione di una sola azione, atipica, nel processo civile, ne rimette il contenuto ai diritti soggettivi che, per così dire, le danno corpo e sostanza in un ambito ordinamentale nel quale vi è una disciplina positiva ed articolata dei diritti specificamente individuati. Manca, invece, una individuazione positiva degli interessi legittimi che vengono dedotti dal concreto della fattispecie, essendo rare le ipotesi in cui la norma li consideri espressamente in via astratta. E il concreto dell’agire dell’azione amministrativa che dà contenuto e spessore all’interesse legittimo ed è il giudice amministrativo che apprezza gli interessi che ritiene meritevoli di tutela innanzi a sé. Ciò significa che l’azione unica e atipica nel processo amministrativo dovrebbe “riempirsi” con interessi legittimi che non preesistono nella previsione normativa, ma che acquistano riconoscimento e tutela in concreto, con la conseguenza che, sul piano ordinamentale ed astratto, tale azione sarebbe un guscio vuoto. In sostanza, vi è una “tavola” positiva dei diritti soggettivi, ma non ve ne è una degli interessi legittimi. E, allora, è da condividere la soluzione del Codice del processo amministrativo. 4. Generalità sulle azioni ammissibili Prima del Codice del processo amministrativo non vi era normativa che disciplinasse i requisiti ed i presupposti sostanziali delle azioni che sono stati costruiti dalla dottrina, considerando il contenuto delle sentenze di merito che poteva adottare il giudice in conseguenza dell’accoglimento del ricorso. Le leggi sul processo amministrativo stabilivano la forma dell’atto introduttivo ed il suo contenuto essenziale, i termini per la proposizione del ricorso ed a chi dovesse essere notificato, ma non il diritto sostanziale alla base delle azioni che, per fare un parallelo con il processo civile, trovano regolamentazione nella parte sostanziale -nel c.c.- non nel codice di procedura civile. Il Codice ha disciplinato “le azioni e le funzioni del giudice” (comma 2, lett. b), art. 44), che, per la delega, devono assicurare, oltre alla snellezza e concentrazione, anche la “effettività della tutela”. E, così, per la prima volta, vengono disciplinate con legge, ancorché delegata, le azioni ammissibili nel processo amministrativo. La normativa viene dettata nel Capo II del Titolo III del Libro I (Disposizioni generali) ed ha natura sostanziale, come si coglie nell’azione avverso il silenzio che l’art. 31 regola sul piano sostanziale e l’art. 117 sul piano processuale. Nel codice sul processo amministrativo vi sono norme sostanziali e processuali che potrebbero porre problemi all’interprete nello stabilire quando si debbano applicare perché per le norme sostanziali non si può fare riferimento al principio processuale del tempus regit actum. La questione più rilevante che si è posta nell’affrontare il tema delle azioni ammissibili è, però, la diversità dello spazio dedicato ad esse nell’articolato licenziato dall’apposita Commissione presso il Consiglio di Stato (otto azioni) rispetto al testo del Codice (quattro azioni) nonché rispetto al secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 160/2012) perché l’eliminazione di alcuni articoli istitutivi delle azioni nella stesura definitiva ha fatto dubitare della loro ammissibilità. Il testo della Commissione licenziato nel 2009 riguardante il Codice del processo amministrativo prevedeva in sette articoli, azioni: di accertamento, avverso il silenzio, di annullamento, di condanna, di adempimento, esecutive e cautelari oltre a quelle desumibili dai poteri decisori attribuiti al giudice. Il Codice, nella versione approvata con il d.lgs. n. 104/2010, ha ridimensionato l’articolo dedicato alle azioni, portandolo a tre articoli (29-31) ed eliminando le azioni esecutive e cautelari nonché quelle di accertamento (generale) e di adempimento. La soppressione degli articoli che in via generale prevedevano le azioni esecutive e cautelari non è significativa di una limitazione della tutela perché il Codice disciplina espressamente in via specifica sia le misure cautelari (artt. 55 ss.) che il processo di ottemperanza (artt. 112 ss.), ma il problema si è posto per l’azione di adempimento. Lo stesso si è verificato per il secondo decreto correttivo che ha eliminato l’art. 28-bis che la Commissione aveva inserito per sancire l’atipicità delle azioni. In proposito, ho già evidenziato che la soppressione dell’art. 28-bis non comporta che siano ammissibili solo le azioni tipiche, sia per il chiaro pronunziato dell’Adunanza Plenaria, sia per le previsioni costituzionali e del Codice del processo amministrativo. Per la eliminazione nel Codice dell’azione di adempimento, prevista nell’articolato della Commissione, ha, ormai, posto rimedio il secondo decreto correttivo che ha aggiunto all’art. 34 del c.p.a. la seguente disposizione: “L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3, contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio”. L’azione di accertamento (generale), invece, è ammessa dalla giurisprudenza per cui la sua espunzione dal Codice non rappresenta più un problema’. Per stabilire quali siano le azioni ammissibili, posto che nel processo amministrativo vi sono anche le azioni atipiche, non è sufficiente esaminare le disposizioni del Codice espressamente dedicate alle azioni, ma anche quelle che riguardano le decisioni che può assumere il giudice in caso di accoglimento del ricorso, sia quelle che sono collocate nelle disposizioni generali (Libro I) e cioè l’art. 34, sia tutte quelle che sono disseminate negli altri libri del Codice. Così per le spese di giudizio, art. 26; le azioni esecutive, artt. 112 ss.; le azioni cautelari, artt. 55 ss.; l’accesso agli atti, art. 116; il subentro all’aggiudicatario nei contratti di lavori pubblici, servizi e forniture, art. 122; le operazioni elettorali, artt. 126 e ss.; ecc. Infatti, come prima della loro espressa previsione nel Codice, le azioni venivano individuate attraverso i poteri decisori attribuiti al giudice, così è necessario operare adesso perché i principi sulle azioni vanno di pari passo con quelli delle pronunzie del giudice. Nella logica del processo, le azioni proponibili e le pronunzie del giudice sono necessariamente correlate e alla previsione di una determinata tipologia di azione deve corrispondere un potere del giudice che possa soddisfare la domanda proposta e viceversa, anche se si è in presenza di poteri esercitabili di ufficio dal giudice. Le disposizioni sulle sentenze di merito vanno, altresì, messe in relazione con l’impianto complessivo del Codice, con riferimento particolare ai principi generali; quanto stabilito nella legge delega; gli artt. 24 e 111 della Costituzione; i diritti fondamentali dell’uomo, tra cui quello al “giusto processo” scolpito nell’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Le singole azioni saranno esposte raggruppandole in relazione agli effetti giuridici che si vogliono ottenere con la domanda e, quindi: azioni di mero accertamento, di condanna e costitutive. Sono di mero accertamento quelle dirette ad ottenere una pronunzia che dichiari l’esistenza e la “spettanza” della situazione giuridica soggettiva sostanziale per la quale si promuove il giudizio, senza alcun’altra conseguenza giuridica nei confronti delle altre parti del giudizio. Anche le azioni di condanna e costitutive sono dirette, pur sempre, ad ottenere una previa (sul piano logico) pronunzia di accertamento, ma si aggiungono ulteriori effetti. Nelle azioni di condanna, si chiede un ordine del giudice rivolto all’altra parte perché paghi un tantundem (azione di condanna al pagamento di somme di danaro o altre somme) o tenga (o non tenga) un determinato comportamento, consistente anche nell’adozione di un atto giuridico (azione di condanna ad un facere o un non face- re, generico o specifico); esse sono volte a stabilire un obbligo a carico della parte soccombente espressamente specificato ed imposto dal giudice. Con le azioni costitutive, si chiede che il giudice stabilisca direttamente la costituzione, modificazione o estinzione degli effetti giuridici, senza che sia necessario condannare la parte soccombente a tenere (o non tenere) un determinato comportamento, e può riguardare anche l’annullamento totale o parziale di un atto giuridico (azione di annullamento) ovvero la modificazione (azione che si può definire di riforma) o l’adozione di un atto giuridico (azione che si può definire di produzione). Prima della disamina delle singole azioni, occorre richiamare sinteticamente i principi che disciplinano i rapporti tra le azioni. L’art. 32 del Codice consente il cumulo nello stesso giudizio delle domande proposte in via principale o incidentale, con la precisazione che se sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, “salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV” e cioè le controversie che sono disciplinate con i “riti abbreviati”. È il giudice, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza, che qualifica l’azione “in base ai suoi elementi sostanziali” e, quindi, a prescindere dalla specifica indicazione del ricorrente principale o incidentale e, comunque, può sempre disporre la conversione delle azioni. Sezione seconda: Le azioni costitutive 1. Costitutive di riforma e di produzione Sono quelle azioni che attribuiscono al ricorrente il potere di chiedere al giudice di modificare l'atto amministrativo impugnato, di adottare un atto in sostituzione di quello emanato dalla p.a. o, comunque, di dettare in via diretta la regolamentazione del rapporto tra le parti litiganti. Il giudice, in questi casi, ha un potere cognitorio pieno che consente l’esame completo della fattispecie concreta, sotto ogni aspetto, per poi provvedere a stabilire direttamente l'assetto degli interessi. Un’azione siffatta è del tutto sconosciuta al processo civile perché comporterebbe la sostituzione della volontà del giudice alle scelte autonome delle parti. Nel giudizio amministrativo, in sede di giurisdizione di merito, è possibile agire per ottenere una sentenza che fissi le regole del rapporto attraverso l’emanazione di un atto amministrativo di riforma o di sostituzione di precedente atto o, comunque, di un atto amministrativo, senza che il contenuto sia preventivamente determinato dall’amministrazione, nemmeno sotto forma di obbligo. Un’azione così incisiva, che comporta la sostituzione del potere (e della volontà) del giudice a quello dell'amministrazione, è possibile perché quest’ultima esercita un potere discrezionale, soggetto a principi fissati dalle norme giuridiche e da regole di buona amministrazione oggettivabili, come tali verificabili, ed alle quali si adegua il giudice quando pronuncia la sentenza. L’amministrazione cioè, allorché si ponga come autorità, non è dotata di autonomia che consente la libera scelta dei fini purché non debordino in illecito; è dotata, invece, di discrezionalità che impone il perseguimento dell’interesse pubblico di cui è attributaria, risultante dalle norme e concretizzantesi nel procedimento, e che sfocia in una scelta basata sulla valutazione comparativa degli interessi, pubblici e privati, presenti nella specifica fattispecie, in relazione all’interesse primario, con applicazione, oltre che delle previsioni normative, delle regole di buona amministrazione. Ciò consente la verificazione del giudice che accerta il rispetto di questi principi e, in caso di loro violazione, adotta il regolamento di interessi ad essi conforme. Solo nelle materie espressamente previste dalla legge, ed attribuite alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo, il ricorrente può chiedere una sentenza costitutiva di riforma e di produzione dell’atto amministrativo. 2. Costitutive di annullamento ed ad effetto conformativo Originariamente, l’azione principe, se non l’unica, innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità è stata quella costitutiva di annullamento dell’atto impugnato per la quale il giudice amministrativo elimina direttamente il provvedimento con cessazione ex tunc degli effetti giuridici e, quindi, sin dal momento dell’adozione dell’atto amministrativo. Ancora oggi è l’azione di gran lunga prevalente nei giudizi amministrativi. L’effetto proprio dell’azione di annullamento, che comporta la necessità dell’impugnazione del provvedimento amministrativo da eliminare, è demolitorio e, pur rappresentando una diretta ingerenza del giudice sugli effetti giuridici dell’atto amministrativo che vengono rimossi, è stato considerato caratteristica propria del potere giurisdizionale che è esercitato, qualora venga accertato un vizio di legittimità, e non interferisce con l’attività di amministrazione perché gli manca la possibilità di dettare una regolamentazione diretta degli interessi in contesa che è rimessa alla p.a. che emana l’atto amministrativo, in sostituzione di quello ritenuto illegittimo. Il processo di annullamento è stato inteso ed attuato come un giudizio cassatorio che rappresenta una parentesi nell’azione amministrativa precedente e successiva al processo che quasi si inserisce nell’attività amministrativa. Questo potere giurisdizionale, è soltanto interdittivo ed impeditivo della produzione di effetti giuridici, anche se, sin dal momento dell’emanazione dell’atto amministrativo, è idoneo a mantenere inalterata la situazione effettuale precedente l’adozione dell’atto amministrativo; esso, quindi, soddisfa l’interesse del ricorrente che si oppone al mutamento della sua situazione giuridica soggettiva (interesse legittimo oppositivo), ma non consente di ottenere il bene della vita cui è correlato l’interesse legittimo pretensivo. Il Codice apre le azioni di cognizione con quella di annullamento: “l’azione di annullamento per violazione dì legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni”. Non vi è più il riferimento agli atti o provvedimenti perché il giudice amministrativo, decide sulle controversie “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere”. Sarebbe stato riduttivo indicare gli atti o provvedimenti amministrativi. Ora, si stabilisce soltanto che, in caso di accoglimento, il giudice “annulla in tutto o in parte il provvedimento amministrativo”, e che la sentenza deve contenere “l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa”. L’azione di annullamento non pare più una parentesi che si inserisce nell’azione amministrativa per consentirne la prosecuzione, in caso di accoglimento della domanda. L’incompetenza non determina la trasmissione dell’affare all’autorità competente, ma chiude la vicenda; certamente l'autorità amministrativa competente potrà riprendere l’azione amministrativa, ma non è il giudice che dà, per così dire, la palla all’amministrazione, per cui la controversia, definita con sentenza, non ha un necessario prosieguo nella successiva azione dell’autorità competente. L’annullamento per gli altri vizi non fa salvi gli ulteriori atti dell’autorità amministrativa a cui, invece, il giudice impartisce l’ordine di dare esecuzione alla sentenza. Insomma, l’idea è che l’azione di annullamento prevista dal Codice si connoti in modo diverso perché la sentenza, conformemente ai principi generali del Codice, deve assicurare una tutela piena ed effettiva secondo la Costituzione, il “diritto europeo” e la legge delega per la quale deve “soddisfare la pretesa della parte vittoriosa” e non fungere da misura cassatoria per la successiva azione amministrativa. Vi è, cioè, un’accentuazione e distacco dell’attività giurisdizionale rispetto all’azione amministrativa. Quest’ultima è necessaria e doverosa a seguito della sentenza di accoglimento, ma quale esecuzione della decisione del giudice, non più quale attività amministrativa fatta salva per il carattere della inesauribilità del potere. L’accoglimento dell'azione di annullamento soddisfa la pretesa della parte vittoriosa quando l’interesse fatto valere in giudizio sia oppositivo e, quindi, si appaga del mantenimento della situazione effettuale precedente all’intervento della (illegittima) azione amministrativa. È così tutelato l’ampio ventaglio degli interessi legittimi oppositivi, com’era prima, ma senza rimettere l’affare all’autorità competente o far salvi gli ulteriori provvedimenti che sono rimessi all'iniziativa dell’Amministrazione la quale deve solo dare esecuzione alla sentenza, eliminando gli effetti che si siano eventualmente prodotti medio tempore; e, quindi, non solo i titolari di diritti soggettivi, ma anche coloro che si oppongono al mutamento della situazione per la tutela di interessi che ricevono un vantaggio dal mantenimento della situazione quo ante. Per la tutela degli interessi legittimi pretensivi, la giurisprudenza, fermo il dispositivo di annullamento dell’atto impugnato, ha sino ad oggi utilizzato la motivazione per indicare le direttive dell’azione amministrativa di adeguamento al dictum del giudice, con il c.d. effetto conformativo cui deve uniformarsi l’Amministrazione nell’ottemperare il giudicato, adottando l’atto amministrativo che attribuisca il vantaggio al ricorrente (soddisfazione dell’interesse di pretesa al bene della vita). In questo modo, si realizza una tendenziale e possibile soddisfazione dell’interesse legittimo (pretensivo), per cui l’azione costitutiva di annullamento non si esaurisce nella mera eliminazione dell’atto impugnato, potendo porsi anche come propositivo del successivo assetto degli interessi, conseguente all’annullamento dell’atto. Ciò assegna alla motivazione della sentenza del giudice amministrativo un rilievo diverso dalla motivazione della sentenza del giudice civile. Quest’ultimo, infatti, conclude la sentenza con un dispositivo articolato e che precisa esattamente gli effetti che produce la decisione, assegnando alla motivazione soltanto il compito di spiegare le ragioni della regolamentazione degli interessi in contesa, disciplinata dal dispositivo. La sentenza del giudice amministrativo, invece, si conclude, in caso di accoglimento, con un dispositivo di mero annullamento dell’atto, rendendo necessario l'esame della motivazione per comprendere, non solo e non tanto le ragioni della decisione, ma soprattutto il profilo ricostruttivo e di riedizione del potere cui l’amministrazione è tenuta in esecuzione della sentenza. La motivazione, cioè, reca in sé non solo il perché della soluzione della lite in un determinato modo, ma anche la soluzione stessa. L’effetto conformativo della sentenza, dunque, si ricava dalla motivazione che ha una funzione diversa e più rilevante rispetto a quella della sentenza civile. Le azioni costitutive di annullamento, in conseguenza dell’effetto conformativo espresso dalla motivazione della sentenza, possono tendere anche a proporre l’assetto degli interessi satisfattivo della situazione giuridica soggettiva pretensiva, con ciò dando vita non solo all’azione di annullamento dell’atto, ma anche alla proposizione del futuro svolgimento dell’azione amministrativa, in un’azione mista, in parte costitutiva di annullamento e in parte propositiva. Quest’ultima può giungere anche ad una condanna ad un facere specifico all’emanazione di un determinato atto amministrativo, in presenza di uno stringente effetto conformativo della sentenza. Questa soluzione presenta due aspetti di criticità per una tutela efficace ed efficiente. Innanzitutto, è nella disponibilità del giudice precisare nella motivazione l’effetto conformativo perché può non farlo e, se decide di farlo, potrebbe non essere stringente al punto da imporre all’amministrazione di agire per la soddisfazione dell’interesse del ricorrente al bene della vita. Di poi, l’effetto conformativo, non solo va “interpretato”, ma può essere recepito in un espresso dictum del giudice, nel giudizio dì ottemperanza. È previsto che il giudice possa disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un Commissario ad acta già in sede di cognizione, così fissando nella sentenza le modalità di esecuzione, con soddisfazione dell’interesse del ricorrente. Questa disposizione valorizza l’autonomia della sentenza dalla successiva azione amministrativa che deve solo dare esecuzione alla decisione del giudice che può precisare, già in sede di cognizione, le misure per l’attuazione del giudicato e anche prevedere la nomina di un commissario, in caso di inadempimento dell’amministrazione. Si tratta, però, pur sempre di una possibilità di cui dispone il giudice. E, invece, la soluzione ottimale per la soddisfazione degli interessi legittimi pretensivi è la proposizione dell’azione di adempimento perché, rispetto all’effetto conformativo, frutto della giurisprudenza pretoria del giudice amministrativo, vi sono significative differenze, ai fini della tutela in quanto: a) è il ricorrente che può chiedere la condanna dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento richiesto o denegato, ed il giudice deve provvedere sulla domanda che diventa un capo autonomo del dispositivo; b) nel giudizio di cognizione interviene l’apposita pronunzia del giudice che condanna l’amministrazione all’adozione dell’atto, senza che si debba ricorrere al giudizio di ottemperanza per individuare la misura idonea a soddisfare l’interesse del ricorrente. La disposizione che introduceva l’azione di adempimento, prevista nell’art. 40 del testo elaborato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato, espunta in un primo momento dal Codice, è stata oggetto del secondo decreto correttivo che l’ha prevista. L’azione di annullamento è diretta ad ottenere questi effetti: accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e conseguente: 1) eliminazione dell’atto, accordo o “comportamento” riconducibile anche mediatamente all’esercizio del potere amministrativo; 2) retroazione degli effetti normalmente sino al momento dell’adozione dell’atto, accordo o “comportamento”; 3) effetto conformativo volto a disciplinare l’azione amministrativa in esecuzione della sentenza. L’effetto dell’eliminazione dell’atto, accordo o comportamento, è una conseguenza necessaria dell’accoglimento dell’azione di annullamento che si produce quando il ricorrente decide di proporre quest’azione ed il giudice accerti l’illegittimità dell’azione amministrativa. È un effetto indisponibile sia del ricorrente (se sceglie di promuovere un’azione di annullamento) sia del giudice. Invece, la decorrenza retroattiva degli effetti può non prodursi in tre ipotesi: - quando il “fatto”, intanto determinatosi, non sia ripristinabile (diniego di rilascio di passaporto che impedisca di partecipare ad un convegno in un Paese estero e che si sia già tenuto quando interviene la decisione del giudice); - quando è nell’interesse del ricorrente che l’annullamento non comporti la retroazione totale o parziale degli effetti; - quando il giudice ritenga che gli effetti ex tunc, parziali o totali, non soddisfino l’interesse del ricorrente e, anzi, si risolvano in una lesione del suo interesse. Il primo caso è una conseguenza del factum infectum fieri nequit, il secondo ed il terzo sono funzionali all’esigenze di tutela del ricorrente e nella disponibilità di quest’ultimo e del giudice. L’effetto conformativo trova impiego, di solito, quando viene in rilievo la lesione di un interesse legittimo pretensivo e il ricorrente può, al più, spingere, attraverso un’accorta esposizione dei motivi, verso la determinazione dell’effetto conformativo, ma se il giudice non lo coglie o non intende prenderlo in considerazione, il ricorrente non ha rimedio. È, dunque, un effetto nella disponibilità del giudice. Recente e non condivisibile giurisprudenza ha, però, ritenuto che l’eliminazione dell’atto non sia un effetto tipico e necessario dell’accertata illegittimità conseguente alla proposizione della domanda di annullamento e che il giudice può anche stabilire il solo effetto conformativo senza rimuovere l’atto illegittimo ed i suoi effetti, quando non sia utile all’interesse del ricorrente. Non pare accettabile tale soluzione perché l’azione di annullamento è tipica ed il suo effetto necessario è il venir meno dell’atto impugnato ritenuto illegittimo, non disponibile da parte del giudice, potendosi solo discutere degli altri due effetti: decorrenza temporale degli effetti di annullamento e effetto conformativo. Sezione terza: Le azioni di condanna 1. Azioni di condanna atipiche. L’azione di adempimento Il Codice non ha affermato la tipicità delle azioni e, anzi, ha introdotto un’azione atipica di condanna. Il comma 1 dell’art. 30 del Codice stabilisce che l’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione e, anche in via autonoma, “nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo”. Si apre così una dicotomia di azioni di condanna: quelle esercitabili contestualmente ad altra azione e quelle autonome. Queste sono disciplinate nell'art. 30 perché proponibili in via autonoma e, quindi, la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente pecuniario, a tutela degli interessi legittimi e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, dei diritti soggettivi. L’azione di condanna da proporre contestualmente si connota innanzitutto per l'ovvio profilo che non può essere proposta in via autonoma, ma insieme ad altra azione. Ciò porta ad escludere che la disposizione si riferisca alle azioni di condanna previste in altre disposizioni: alla condanna della p.a. ad esibire i documenti richiesti (condanna ad un facere specifico); alla condanna alla restituzione di un bene immobile occupato senza titolo; alla condanna a provvedere a seguito di silenzio della p.a.. A prescindere dal fatto che l’azione di condanna non può essere proposta autonomamente, non vi è l’individuazione normativa del contenuto di questa domanda atipica che va determinato con riferimento alle altre disposizioni del Codice e, in primis, a quelle riguardanti le sentenze di merito che il giudice può adottare. L’atipicità del contenuto trova specificazione nelle pronunzie che il giudice può assumere nel merito. L’art. 34 c.p.a. stabilisce i poteri decisori a fronte delle azioni proponibili e, quindi: a) l’annullamento degli atti impugnati (azione di annullamento); b) l’ordine all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere (azione avverso il silenzio); c) l’adozione di un nuovo atto o di modifica o riforma di quello impugnato, nella giurisdizione di merito (azione costitutiva di riforma e di produzione); d) la disposizione di misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese (azione di ottemperanza). Si è lasciata da parte la lettera c) dell’art. 34 perché dà un contenuto all’azione atipica di condanna. Infatti, tale disposizione prevede la condanna al pagamento di una somma di denaro “anche a titolo di risarcimento del danno”, “misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c.” e, soprattutto, l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”. Queste ultime misure, pur innominate, sono funzionalmente collegate alla soddisfazione (“idonee a tutelare”) della situazione giuridica fatta valere in giudizio. Ed allora l’azione di condanna, di cui al comma 1 dell’art. 30 c.p.a., può essere proposta, contestualmente ad altra azione, per ottenere le misure idonee a soddisfare l’interesse legittimo (o il diritto soggettivo nella giurisdizione esclusiva) di cui si lamenti la lesione in giudizio. Sulla base di questa disposizione e in linea con i principi Cost. (artt. 24 e 111), dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e del C.p.a. che proclama la tutela piena ed effettiva (art. 1 c.p.a.) e il giusto processo (art. 2 c.p.a.), si è affermata la possibilità di un’azione di adempimento diretta alla condanna dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento richiesto o denegato. Altra applicazione può individuarsi nella condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme in danaro di cui risulti debitrice, che è proponibile qualunque sia il fatto o l’atto generatore del debito e che trovava specifica previsione, per la giurisdizione esclusiva o di merito, nella l. 1034/ 1971. Quest’ultima è una domanda che, per i diritti soggettivi (nella giurisdizione esclusiva), può essere proposta anche in via autonoma. Per gli interessi legittimi può trattarsi solo di una domanda collegata e contestuale ad un’azione di annullamento o avverso il silenzio. Per l’azione di adempimento, il secondo decreto correttivo del Codice, d.lgs. 160/2012, ha espressamente aggiunto all’art. 34, comma 1, lett. c) che “L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitato nei limiti di cui all’art. 31, comma 3, contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio”. L’azione di adempimento è, dunque, diventata tipica ed i suoi caratteri sono quelli a) di un’azione di condanna non autonoma, ma da proporsi in connessione alle domande di annullamento del provvedimento di diniego o avverso il silenzio e b) che può essere accolta in presenza di attività vincolata o “quando non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”. Il primo profilo si spiega e si integra con quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 34 c.p.a. e cioè che “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. Il secondo aspetto tutela la sfera del merito amministrativo riservata alla p.a. È un’apertura verso l’azione di adempimento e la giurisprudenza potrà farle acquisire una matura e più efficiente configurazione, riducendo i limiti stabiliti dalla legge con interpretazione volta a rendere più effettiva la tutela degli interessi legittimi pretensivi. 2. Condanna al risarcimento del danno, anche informa specifica. La domanda di risarcimento del danno può essere proposta per equivalente pecuniario o in forma specifica (condanna ad un facere specifico) e, in quest’ultimo caso, se sussistono i presupposti dell'art. 2058 c.c. La questione che il Codice ha affrontato, anche se la soluzione non appare soddisfacente, è stata quella della possibilità di proporre la domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi in via autonoma ovvero solo contestualmente o a seguito del tempestivo ricorso per l’annullamento del provvedimento amministrativo lesivo. La dottrina e la giurisprudenza hanno ampiamente dibattuto il tema che ha visti divisi il giudice ordinario, fautore dell’autonomia dell'azione risarcitoria, e il giudice amministrativo, portatore della tesi della necessaria pregiudizialità dell'annullamento. Il problema è rilevante perché, se si ritiene il risarcimento dei danni possibile solo se venga annullato l’atto amministrativo, è essenziale il rispetto del termine di decadenza di sessanta giorni per promuovere il giudizio di annullamento (salvo il successivo esperimento dell'azione risarcitoria nel più ampio termine); viceversa, vale il termine prescrizionale quinquennale (se fatto illecito extracontrattuale), o decennale (se inadempimento contrattuale), ove non si ritenga pregiudiziale l’annullamento dell'atto amministrativo. Il contrasto tra la giurisprudenza del giudice amministrativo e del giudice ordinario è arrivato al punto di indurre la Corte di Cassazione ad affermare che è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. Si tratta di una dilatazione del sindacato delle Sezioni Unite che dovrebbero limitarsi a verificare i limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo e, invece, in questo modo, intervengono sulle regole che disciplinano l'azione di risarcimento dei danni innanzi al giudice amministrativo. Il Codice ha inteso risolvere la diatriba tra le giurisdizioni eliminando formalmente la pregiudizialità perché ha stabilito che la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi si può proporre anche autonomamente, ma: - entro il termine di decadenza di 120 giorni “decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”; o nel corso del giudizio di annullamento, fino a quando non è definito o entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento; - nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e “esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”. Viene pur sempre previsto un termine di decadenza, anche se di 120 giorni, e la pregiudizialità, da processuale, diventa sostanziale ampliando la portata dell’art. 1227, c. 2, c.c. per il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. Infatti, la giurisprudenza del giudice ordinario, pur mostrando di recente dei ripensamenti, ha ritenuto che non rientri nell’ordinaria diligenza del creditore la proposizione di un’azione giudiziaria o esecutiva poiché è attività gravosa ed implicante rischi e spese e, comunque, l’ordinaria diligenza del creditore non può consistere nel tenere comportamenti positivi. Il Codice, invece, rende rilevante, ai fini del risarcimento, il mancato esperimento degli strumenti di tutela, da intendersi per tali non solo la proposizione di azione di cognizione, ma anche cautelare. È controverso se l’istanza dell’interessato diretta ad ottenere dalla p.a. l’esercizio del potere di autoannullamento sia sufficiente ad integrare la diligenza del creditore e a non applicare l’esclusione del risarcimento del danno disposta dal comma 3 dell’art. 30 c.p.a. Altra decorrenza del termine è stabilita quando il ricorrente dimostri di aver subito danno per la “inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”: i centoventi giorni non decorrono fintanto che non si conclude il procedimento e, comunque, decorrono dopo un anno “dalla scadenza del termine per provvedere”. Il termine di decadenza di 120 giorni è stabilito per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, per i quali non possono che applicarsi i termini di prescrizione stabiliti dal codice civile. Ne consegue che, nelle materie di giurisdizione esclusiva, occorrerà distinguere tra le situazioni giuridiche soggettive, riproponendosi il problema che si è inteso superare con l’istituzione della giurisdizione esclusiva e cioè quello di stabilire la natura della situazione giuridica soggettiva se di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Il testo del secondo decreto correttivo del Codice, licenziato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato, allungava il termine da 120 giorni ad un anno, ma il d.lgs. 160/2012, non lo ha recepito. Il presupposto di tale domanda è il risarcimento del danno ingiusto e cioè si deve essere in presenza degli elementi della fattispecie illecita, come descritta dall’art. 2043 c.c. Ne consegue che la condanna ad un facere specifico, salva l’ipotesi dell’azione di adempimento e di altre azioni tipiche (così: accesso ai documenti amministrativi), resta pur sempre circoscritta alle ipotesi del fatto illecito oltre che, ovviamente, allorché la reintegrazione in forma specifica sia in tutto o in parte possibile. L’azione di condanna per fatto illecito incide sensibilmente sul processo amministrativo, perché il giudice deve valutare aspetti della controversia che non sono passati attraverso il procedimento amministrativo. Nell’azione costitutiva di annullamento dell’atto amministrativo”, che ha sempre rappresentato l’ordinario processo amministrativo, il giudice conosce dell’assetto degli interessi stabiliti dalla p.a. che nel procedimento ha acquisito i fatti e gli interessi, per cui gli elementi del giudizio, e particolarmente il fatto, giungono al processo già vagliati e formati dalla p.a. e il giudice ne verifica la legittimità attraverso gli atti del procedimento ed il provvedimento. Invece, nell’azione di risarcimento dei danni, il giudice deve accertare la presenza degli elementi richiesti dalla fattispecie risarcitoria in via diretta ed autonoma, senza che possa utilizzare il procedimento amministrativo che non può evidentemente acquisire fatti rilevanti ai fini dell’illecito, estranei alla sua attività funzionale al soddisfacimento degli interessi in contesa e, in primis, dell’interesse pubblico. Inoltre, il giudice deve procedere alla quantificazione del danno pure estraneo al procedimento amministrativo. Parte resistente nelle azioni di condanna può essere anche il cittadino, non necessariamente una p.a. 3. Condanna al pagamento delle spese di lite L’azione di condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, pur conseguenziale all’accoglimento o al rigetto del ricorso, è autonoma perché è conseguenziale e accessoria all’esito della lite, ma il giudice non può pronunziare la condanna alle spese, se non vi sia un'espressa domanda della parte. Il giudice amministrativo spesso usa compensare le spese di lite tra le parti, anche se i T.A.R. si stanno discostando da tale posizione e sono più frequenti i casi di condanna del soccombente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa. Per la quantificazione, il giudice dovrebbe seguire le tariffe forensi, ma, normalmente, la condanna viene stabilita forfettariamente, anche perché i difensori, di solito, non depositano la nota specifica, quando la causa passa in decisione. A seguito dell’abrogazione delle tariffe forensi, il Regolamento approvato con d.m. 140/2012, ha stabilito la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni, tra cui quella legale, individuando, per l’attività giudiziale 5 fasi, ognuna onnicomprensiva delle prestazioni rese, con determinazione di scaglioni di valore della controversia e dell’importo in un’unica previsione, per cui la quantificazione può intervenire agevolmente, pur in mancanza della nota specifica dei difensori. Il giudice amministrativo, quindi, dovrebbe applicare detti parametri, nel rispetto della legge. Le norme centrali in materia di spese di giudizio, sono quelle dettate nei due commi dell’art. 26 c.p.a. (“spese di giudizio”). Il Codice, in via generale, richiama con il comma 1 dell’art. 26 gli articoli del c.p.c.: - art. 91 per il quale il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari a favore dell’altra parte; - art. 92 ai sensi del quale il giudice può escludere la condanna alle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene “eccessive o superflue” e, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte al rimborso delle spese quando vi sia stata trasgressione al dovere di lealtà e probità e può, altresì, compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”; - art. 93 prevede la distrazione delle spese a favore del difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscossi gli onorari; - art. 94 relativo alla condanna di rappresentanti o curatori; - art. 96 per la responsabilità aggravata dove giudice può, anche d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, se ritiene sussistere la responsabilità aggravata; - art. 97 che riguarda la responsabilità di più soccombenti. Un criterio specifico per la liquidazione delle spese nel processo amministrativo è stato introdotto dal secondo decreto correttivo al Codice del processo amministrativo ove si è stabilito che si debba tener conto “del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2”. Il richiamo esplicito a detti articoli del c.p.c. e, soprattutto, all’art. 92, che consente al giudice di compensare le spese se vi sia soccombenza reciproca ovvero “altri gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” potrebbe indurre il giudice amministrativo ad abbandonare, nella maggior parte delle controversie, la strada della compensazione delle spese di lite. Perché accada ciò, occorrerebbe, soprattutto, che il giudice amministrativo prendesse coscienza del fatto che il soccombente paga le spese non per “punizione” o per sanzione, ma perché il processo deve dare a chi ha ragione “praticamente tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire” e, quindi, “tutto ciò che fu necessario al riconoscimento del diritto è concorso a diminuirlo e deve essere reintegrato al subbietto del diritto stesso, in modo che questo non soffra detrimento dal giudizio”, ivi comprese le spese affrontate per promuovere il giudizio. Non si intende trascurare il profilo della particolare aleatorietà della causa amministrativa rispetto a quella civile, ma la compensazione delle spese mortifica l’interesse economico del vincitore che vede depauperare il suo patrimonio del tutto ingiustamente perché, se ricorrente, è stato costretto a promuovere il giudizio per far valere le sue ragioni, se resistente o controinteressato, ha dovuto difendersi da un (ingiusto) processo. Ecco perché la compensazione delle spese di lite può intervenire motivatamente per “gravi ed eccezionali ragioni”. Il Codice ha, inoltre, attribuito, con il comma 2 dell’art. 26, al giudice il potere di condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di “una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte ha agito o resistito temerariamente in giudizio”, da versarsi nel bilancio dello Stato per la riassegnazione secondo la previsione dell’art. 15 delle norme di attuazione al c.p.a. La norma è tesa a scoraggiare iniziative giudiziarie temerarie. 4. Condanna all’accesso ai documenti amministrativi: cenni e rinvio I documenti amministrativi sono, di regola, accessibili e, in via di eccezione, segreti per la tutela di rilevanti e ben individuati e specifici interessi pubblici e del diritto alla riservatezza di terzi. Contro il rifiuto espresso della p.a. di visione o estrazione di copia dei documenti amministrativi o il silenzio-rifiuto che si determina a seguito del comportamento inerte della p.a. protrattosi per trenta giorni dalla richiesta, è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide, nel contraddittorio delle parti, con una procedura in Camera di consiglio e senza che sia necessaria l’assistenza del difensore, con i termini ridotti a metà. Il ricorso può essere proposto anche nel giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, con istanza depositata nel ricorso pendente, previa notifica alle altre parti. In questo caso, la decisione può essere assunta con ordinanza, separatamente dal giudizio principale o con la sentenza che definisce il giudizio. Il giudice ordina l’esibizione dei documenti richiesti, nella sussistenza dei presupposti stabiliti. Si tratta di un'azione di condanna ad un facere specifico perché il ricorrente, di fronte al rifiuto espresso o al comportamento inerte della p.a., può chiedere al T.A.R. di condannare l’amministrazione a mostrare i documenti richiesti. L’azione è ammessa non solo contro l'atto della p.a., ma anche contro il comportamento inerte, con le medesime conseguenze nel caso il giudice accerti la sussistenza dei presupposti e cioè l’ordine alla pubblica amministrazione di esibire i documenti richiesti. 5. Condanna a provvedere (silenzio): cenni e rinvio L’azione avverso il silenzio è definita come “accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”, ma è un”azione di condanna “all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni”. La decisione ha un’indubbia base di accertamento, ma si conclude con la condanna della pubblica amministrazione a provvedere. Non si può, però, definire un’azione di adempimento perché la condanna è ad un mero provvedere, non ad adottare l’atto amministrativo che soddisfa l’interesse del ricorrente. L’azione non muta la sua tipologia nemmeno se il giudice “può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio”, quando “si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”. Una tale pronunzia, pur rilevante per la soddisfazione dell'interesse al bene della vita, rappresenta un incisivo e pregnante effetto conformativo, ma la pronunzia del giudice è, pur sempre, di condanna a provvedere e non ad emanare l’atto amministrativo richiesto dal ricorrente. Può però proporsi contestualmente l’azione di adempimento. L’azione può essere proposta fintanto che perduri l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento con la possibilità di riproporre l’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. Il ricorso, proponibile anche senza previa diffida, è deciso con sentenza succintamente motivata. Il procedimento si svolge in Camera di consiglio ed i termini sono ridotti a metà. Sezione quarta: Le azioni di mero accertamento l. Azione di mero accertamento: questioni generali Nella giurisdizione generale di legittimità si è escluso che sia possibile un’azione di mero accertamento perché qui si tutela solo l’interesse legittimo che è una situazione relazionale all’esercizio del potere e l’affermazione della sua esistenza non reca soddisfazione all’interesse al bene. Il titolare del diritto soggettivo, infatti, può essere soddisfatto dalla decisione che accerti il suo diritto (al bene), in modo da poterlo far valere nei rapporti e negli eventuali successivi giudizi nei confronti delle parti del processo. L’interesse legittimo, invece, è situazione la quale nasce nel momento dell’esercizio (o non esercizio) del potere autoritativo e non c’è prima dell’esercizio del potere autoritativo o prima che, da parte del titolare dell’interesse legittimo, si dia inizio ad un procedimento amministrativo. Ne consegue che la sua soddisfazione passa necessariamente attraverso l’eliminazione degli effetti dell’azione autoritativa (interesse legittimo oppositivo) o nella produzione degli effetti dell’azione amministrativa (interesse legittimo pretensivo), non nella mera affermazione che il ricorrente è titolare dell’interesse legittimo. L’azione di mero accertamento per la tutela dell’interesse legittimo viene normalmente esclusa, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, anche se, in precedenza, si parlava di azione di mero accertamento nel caso in cui il giudice decideva sul c.d. silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. Ora, la questione è risolta dal diritto positivo che configura il ricorso avverso il silenzio come un accertamento dell'obbligo di provvedere e conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere, potendo il giudice anche “pronunciare sulla fondatezza della pretesa”. L’esclusione di un’azione di mero accertamento per la tutela dell’interesse legittimo non significa che nel giudizio amministrativo di legittimità non possano essere pronunciate sentenze di accertamento. Infatti, sono sentenze di accertamento quelle che si arrestano ai profili di “rito” (inammissibilità, irricevibilità, ecc.), di cessazione della materia del contendere, di perenzione, di sopravvenuta carenza di interesse, ecc.. A queste sentenze non sono correlate azioni di mero accertamento poiché queste ultime considerano l’istanza di tutela che è alla base della posizione del ricorrente e non attengono alla richiesta di tutela che induce a promuovere il giudizio. Quindi, se è corretto affermare che l’azione di mero accertamento mira ad ottenere una sentenza di accertamento, non è detto che ad ogni sentenza avente tale natura faccia capo un’azione così qualificabile, dal momento che l’area delle decisioni di accertamento è più estesa di quella dell’azione. Tale assunto presuppone che si aderisca ad una nozione di accertamento che prescinde dalla verifica della fondatezza dell’interesse fatto valere. Vi è, però, nella giurisdizione esclusiva l’esigenza di tutelare i diritti soggettivi con l’azione di accertamento. Tale azione è divenuta strumento efficiente di tutela, anche nella giurisdizione di legittimità, dopo la previsione normativa di atti amministrativi nulli che, non producendo effetti, portano alla soddisfazione dell’interesse con la mera dichiarazione dello stato viziato della nullità. Di poi, per la dichiarazione di inizio di attività, divenuta segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) con il d.l. 125/2010, convertito con l. 163/2010, il giudice amministrativo ha ritenuto soluzione legittima ed adeguata attribuire al terzo l’azione per la dichiarazione della mancanza degli elementi e presupposti per l’esercizio dell’attività “segnalata” dall’interessato, con conseguente privazione di legittimità ed efficacia della S.C.I.A. Si è creato così uno spazio per le azioni di accertamento anche nella giurisdizione di legittimità. La definitiva stesura del Codice ha mantenuto solo l’azione di accertamento delle nullità, eliminando quella generale. Non si può, però, pensare che i diritti soggettivi non possano essere tutelati, nella giurisdizione esclusiva, con l'azione dichiarativa e che debba ritenersi superata la giurisprudenza che, pretoriamente, ha costruito una sentenza di accertamento per assicurare efficiente tutela ai terzi lesi da una S.C.I.A. È da ritenere che le azioni di accertamento, già ammesse dalla giurisprudenza, non siano escluse dal Codice che ha inteso disciplinare espressamente solo l’azione di nullità; una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con: a) i principi generali del Codice sulla pienezza ed effettività della tutela; b) la delega che ha stabilito l’adeguamento delle norme vigenti alla giurisprudenza delle magistrature superiori e che si debba assicurare l’effettività della tutela; c) le disposizioni costituzionali; d) la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sul giusto processo. 2. Azione di nullità L’esclusione di un’azione di accertamento nella giurisdizione generale di legittimità è correlata all’affermazione della dottrina e della giurisprudenza amministrativa che l’unico stato viziato del provvedimento amministrativo sia l’annullabilità. Con la conseguenza che l’atto amministrativo, pur illegittimo, produce effetti, e, dunque, estinguendo i diritti soggettivi del destinatario, radica la giurisdizione del giudice amministrativo, non solo in caso di iniziali situazioni di interesse legittimo, ma anche in caso di un diritto soggettivo. Il giudice amministrativo, in casi eccezionali, ha individuato ipotesi di nullità dell’atto amministrativo, ma in materia di pubblico impiego, in cui, all’epoca, aveva giurisdizione esclusiva, quando un dipendente si fosse trovato a lavorare presso una pubblica amministrazione senza essere stato reclutato in base a concorso. Il Consiglio di Stato ha ravvisato, altresì, atti nulli, quando l’Amministrazione adotti provvedimenti palesemente in contrasto ed elusivi del giudicato, allo scopo di non costringere l’interessato ad un’impugnativa nel termine di decadenza ed a ripercorrere primo e secondo grado di giudizio: la nullità dell’atto consente direttamente al giudice dell’ottemperanza di incanalare l’azione amministrativa verso la corretta esecuzione del giudicato. Diversa, invece, la giurisprudenza del giudice ordinario che, attraverso il vizio della carenza di potere in astratto e, ancor più, in concreto dell’atto amministrativo, ha acquisito ambiti di giurisdizione perché, in presenza di tali vizi, l’atto non produce effetti e, quindi, non estingue i diritti soggettivi che l’interessato può far valere innanzi al giudice ordinario. La questione dell’ammissibilità di un’azione di accertamento della nullità dell’atto amministrativo, improduttivo di effetti giuridici, ha acquistato rilevanza a seguito della introduzione dell’art. 21 septies nella l. 241/1990. L’art. 21 septies, infatti, disciplina le ipotesi di nullità dell’atto amministrativo ravvisandole: - nella mancanza degli elementi essenziali - nel difetto assoluto di attribuzione nella violazione o elusione del giudicato, nonché “negli altri casi espressamente previsti dalla legge” (nullità testuali). In queste ipotesi, siccome l’atto non produce effetti, non vi è l’estinzione (o degradazione) dei diritti soggettivi, per cui l’interessato potrà far valere queste situazioni giuridiche soggettive innanzi al giudice ordinario, ad eccezione delle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che conosce anche dei diritti soggettivi. Quando si è in presenza di (iniziali) interessi legittimi, il titolare di quest'ultima situazione giuridica soggettiva potrà proporre anche un’azione di mero accertamento che dichiari la nullità dell’atto e la sua improduttività di effetti. Si pensi a chi impugni un’autorizzazione commerciale rilasciata ad un concorrente, ma priva degli elementi essenziali o adottata da soggetto (per es.: un dirigente dell’Amministrazione Provinciale) in difetto assoluto di attribuzione; qui potrà chiedere al giudice amministrativo che accerti la nullità dell’autorizzazione, improduttiva di ogni effetto. In sostanza, l’azione di accertamento potrà avere impiego nella giurisdizione generale di legittimità, nella misura in cui verranno individuate ipotesi di nullità dell’atto amministrativo, come tale improduttivo di effetti giuridici, e, pertanto, utilmente “aggredibile” con un’azione volta a dichiarare la nullità. Prima che intervenisse l’art. 31 del c.p.a. a disciplinare l’azione di nullità innanzi al giudice amministrativo, si è discusso dell’ammissibilità di una tale azione perché un atto nullo non può ledere interessi legittimi che sono correlati all’esercizio del potere e, se l’atto è nullo, non produce effetti e, quindi, non può esservi interesse legittimo. L’art. 31 c.p.a. dedica un solo comma all’azione di nullità da cui si ricavano queste regole: - è un’azione di accertamento; - il termine per la proposizione dell’azione è di decadenza ed è fissato in 180 giorni; - per la nullità degli atti amministrativi in violazione o elusione del giudicato, il termine è di prescrizione ed è fissato in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza; - la nullità dell’atto “può sempre essere opposta dalla parte resistente” per la quale il rilievo della nullità è imprescrittibile; - la nullità dell’atto “può sempre essere rilevata d’ufficio dal giudice”. Il ricorrente può proporre l’azione di nullità entro il termine decadenziale di 180 giorni per tutte le ipotesi descritte dall’art. 21-septies, legge 241/1990, ad eccezione dell’elusione e violazione del giudicato perché, in questo caso, il termine è decennale e di prescrizione. Nessuno dei due termini è in sintonia con la nullità assoluta per la quale il c.c. stabilisce l’imprescrittibilità che, però, viene recuperata per la parte resistente che “può sempre” opporre la nullità dell’atto e per il giudice che può sempre rilevarla d’ufficio. Questo quadruplo regime della nullità, imprescrittibile per la p.a., soggetto ad un termine decadenziale di 180 giorni o prescrizionale di dieci anni per il ricorrente è sempre rilevabile d’ufficio dal giudice richiama alla mente le considerazioni della dottrina che ha qualificato la nullità come strumento di ulteriore protezione degli interessi del cittadino già giuridicamente tutelati e, altresì, funzionale “principalmente alle esigenze di autoprotezione del potere”, perché non sempre l’equiparazione della fattispecie invalida a quella valida è protettiva dell’interesse pubblico specifico curato dall’amministrazione. Prima che intervenisse il c.p.a., la dottrina ha indicato termini differenziati per l’azione di nullità in relazione agli interessi che le ipotesi di nullità hanno inteso proteggere. Questo schema sistematico che si basa sulla frantumazione della categoria della nullità intervenuta in ambito privatistico, diversifica le posizioni dei titolari degli interessi. L’art. 31, comma 4, c.p.a. considera le diversità delle posizioni dei soggetti che si confrontano nel processo amministrativo. Il privato ricorrente al quale, con la nullità, si consente di agire nel termine di decadenza, come per l’annullabilità, ma di 180 anziché di 60 giorni, con l’eccezione riguardante l’elusione e la violazione del giudicato che può essere fatta valere nel termine di prescrizione di dieci anni per la tutela dell’assetto degli interessi stabilito dal giudice il quale dà attuazione all’ordinamento giuridico, nel superiore interesse pubblico della giustizia. L’amministrazione resistente la quale può sempre eccepire la nullità. Il giudice che, nello svolgimento della sua funzione, non può incontrare limiti al rilievo della nullità dell’atto che non può costituire un elemento di riferimento per definire il giudizio. La nullità è al servizio di una scala di valori che vede al primo posto l’amministrazione e il giudice, al secondo posto il cittadino che ha avuto il riconoscimento della sua situazione passata in giudicato e, al terzo posto, il cittadino titolare di un interesse legittimo. Rispetto ai quattro diversi regimi previsti dall’art. 31, comma 4, c.p.a. è da aggiungerne un altro. Bisogna, infatti, considerare i casi in cui il giudice amministrativo, nella giurisdizione esclusiva, conosca dei diritti soggettivi che si confrontino con un atto nullo. Nella giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo, in mancanza di previsione legislativa, ha stabilito che il diritto soggettivo possa essere fatto valere in giudizio nel termine lungo di prescrizione, anziché nei sessanta giorni a pena di decadenza. Il Codice conferma la giurisdizione esclusiva nelle materie indicate dall’art. 133, precisando che il giudice amministrativo conosce dei diritti soggettivi “pure ai fini risarcitori” , ma nulla dispone in ordine alle - diverse regole applicabili quando il ricorrente alleghi la violazione dei diritti soggettivi. Tale omissione, però, non può significare che il diritto soggettivo debba essere azionato nel breve termine di decadenza di sessanta giorni, con conseguente ingiustificata diminuzione di tutela della situazione giuridica soggettiva quando, anziché essere attribuita al giudice ordinario, venga conosciuta dal giudice amministrativo. Quindi, è da ritenere che i principi che la giurisprudenza pretoria del giudice amministrativo ha introdotto per la tutela dei diritti soggettivi conosciuti nell’ambito della giurisdizione esclusiva, continuino a trovare applicazione. La mancata considerazione nell’art. 31, comma 4, c.p.a. del diritto soggettivo leso da un atto nullo nelle materie di giurisdizione esclusiva è in linea con l’impostazione del c.p.a. che ha ignorato le diverse regole che il giudice amministrativo applica in presenza del diritto soggettivo fatto valere dal ricorrente. Ciò non può condurre alla conclusione che, per l’atto nullo, il diritto soggettivo debba essere azionato nel termine di decadenza di 180 giorni, perché l’interesse legittimo è soggetto, normalmente, al termine di decadenza di 60 giorni che viene allungato (180 giorni) per la rilevanza dei vizi che determinano la nullità dell’atto ed il diritto soggettivo che, normalmente, va fatto valere nel termine prescrizionale in sede di giurisdizione esclusiva, nei confronti dell’atto nullo vedrebbe il termine attratto nel regime decadenziale dei 180 giorni, con conseguente riduzione della garanzia di tutela. Il diritto soggettivo, attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, può essere azionato nel ricorso volto alla dichiarazione di nullità dell’atto nell’ordinario termine decennale di prescrizione. Pertanto, il diritto soggettivo riceverebbe la stessa considerazione dell’ipotesi di nullità conseguente all’elusione o violazione del giudicato e, nella scala dei valori, va collocato al secondo posto. Le deviazioni dal modello di base della nullità circa le diverse tutele interviene sui termini, ma non muta gli altri caratteri che distinguono in maniera netta questa difformità dal modello legale rispetto all’annullabilità. Infatti, la nullità dell’atto amministrativo è rilevabile d’ufficio dal giudice e l’azione è imprescrittibile per l’amministrazione ed è improduttivo di effetti nonché insanabile. L’improduttività di effetti dell’atto nullo vale anche per il cittadino il quale, decorso il termine di decadenza di 180 giorni, non potrà chiedere la dichiarazione di nullità al giudice e, quindi, non potrà conseguire la “certezza” della nullità e correlata inefficacia dell’atto, ma lo stato viziato non muta con tutte le sue conseguenze, per cui si può verificare l’effetto processuale dell’inoppugnabilità, ma ciò non incide sul regime sostanziale dell’atto nullo che è, pur sempre, quello dell’inefficacia. Il controinteressato, non viene considerato dalla norma ma, secondo la dottrina potrebbe sempre opporre la nullità che, invece, sarebbe difficile immaginarlo per l’amministrazione che, avendo dato causa alla nullità, non avrebbe interesse a sollevarla in giudizio. Al riguardo, le soluzioni possono essere diverse e, a favore dell’imprescrittibilità dell’eccezione da parte del controinteressato, si può addurre che: I) l’azione di nullità è imprescrittibile e se l’art. 31 c.p.a. non pone alcuna limitazione, il controinteressato può sempre opporla; II) l’amministrazione resistente può sempre opporla e se la previsione è dettata dal valore che si è voluto attribuire all’interesse di cui è portatrice la p.a., quello del controinteressato è, normalmente, omogeneo a quello dell’amministrazione, anche se è sorretto da altre motivazioni, per cui non si giustificherebbe un diverso trattamento. Contro questa tesi si può sostenere che: a) la mancata previsione nella norma non può attribuire ad una parte privata che si contrappone ad altra parte privata un potere che va a porre una disparità di posizioni; b) va preferita un’interpretazione conforme ai principi cost. del giusto processo, per cui non si può creare una sperequazione nelle condizioni di parità tra ricorrente e controinteressato. Seguendo questa seconda impostazione, il controinteressato potrebbe eccepire la nullità, nel termine di 180 giorni dalla piena conoscenza, notifica o comunicazione dell’atto. Insomma sarebbe stato preferibile stabilire la imprescrittibilità dell’azione, come normalmente accade nell’ipotesi di nullità. Problema diverso è da chi possa essere fatta valere la nullità. Secondo la giurisprudenza, da chiunque vi abbia interesse e, per il giudice amministrativo, si tratta di qualificare l’interesse meritevole di tutela che è operazione che compie normalmente, anche di fronte a un atto amministrativo che presenti lo stato viziato dell’annullabilità. Va condivisa l’affermazione della dottrina che ipotizza, per l’atto nullo, il “superamento del connotato dell’attualità dell’interesse”, per l’inefficacia che contraddistingue la nullità; richiedere l’attualità dell’interesse, significherebbe dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Non dovrebbe nemmeno richiedersi la concretezza della lesione dell’interesse per la stessa ragione, mentre occorre la titolarità della situazione giuridica soggettiva e, quindi, deve trattarsi di un interesse personale. 3. Tutela del terzo avverso la S.C.I.A. Per quanto riguarda la D.I.A. (oggi S.C.I.A.) si sono dibattute diverse tesi per l’azione che può esperire il terzo leso dall’attività svolta sulla base della S.C.I.A. Il terzo: a) dovrebbe proporre domanda di annullamento della determinazione formatasi tacitamente, siccome l'Amministrazione non è intervenuta a bloccare l’attività, autorizzandola implicitamente in virtù di una valutazione legale tipica; b) dovrebbe notificare atto di diffida all’Amministrazione ad esercitare il suo potere, anche in autotutela, e, in caso di provvedimento negativo o di inerzia, si apre la strada del giudizio amministrativo contro l’atto espresso o contro il silenzio rifiuto. Le tesi esposte sono mosse dal medesimo intento di individuare un atto da impugnare per ricondurre la questione nel “collaudato” alveo del giudizio dì annullamento. Di recente, evidenziato che la S.C.I.A. è un atto privato e che la sostituzione del provvedimento espresso con la dichiarazione dell’interessato non può diminuire le possibilità di tutela giurisdizionale del terzo controinteressato, il Consiglio di Stato ha individuato nell'azione di accertamento autonomo la tutela del terzo che può chiedere al giudice amministrativo di accertare che non sussistono i presupposti giuridici e/o di fatto per svolgere l’attività oggetto della S.C.I.A.; a seguito della sentenza favorevole di accertamento, grava, poi, sull’Amministrazione l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti della condotta posta in essere dal denunciante. Il ricorrente deve seguire le regole proprie del giudizio di legittimità quanto al termine (di decadenza di sessanta giorni), all’istruttoria, ecc. Quest’ultimo orientamento, che si va consolidando, apre il giudizio amministrativo di legittimità all’azione di accertamento che, in teoria e in astratto, diventa ammissibile, pur mantenendo ferma la struttura e le regole proprie del giudizio di annullamento che muta solo nella conclusione costituita da una decisione di mero accertamento. Ma, quasi contestualmente alla decisione del supremo consesso giurisdizionale amministrativo, il legislatore ha dettato per l’impugnativa della S.C.I.A. ad opera del terzo leso, la seguente regola: la S.C.I.A., la D.I.A. “non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31 commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 104/ 2010” (c.p.a.). La soluzione di diritto positivo non pare proprio in linea con quanto sostenuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e riapre la discussione perché sceglie la strada dell’azione avverso il silenzio, nel caso l’amministrazione non provveda. Sezione quinta: Le azioni collettive l. La giustiziabilità degli interessi meta-individuali È stata estesa la tutela anche a quelle situazioni meta-individuali ritenute meritevoli di tutela dall’ordinamento, cioè a quegli interessi che, sforniti del requisito della personalità, in quanto non riferibili esclusivamente ad alcun soggetto, divengono socialmente sempre più rilevanti. 2. La legittimazione speciale ex lege delle associazioni riconosciute Il primo passo verso la tutela degli interessi meta-individuali è stato compiuto con riferimento ai beni ambientali e alla c.d. consumer protection rispetto ai quali è stata prevista una vera e propria legittimazione speciale ex lege in capo a tutte quelle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, semplicemente sulla base del possesso di determinati requisiti (di rappresentatività e democraticità) specificamente indicati nelle rispettive leggi di riferimento. L’attribuzione del potere di agire in giudizio avviene, in questi casi, “in deroga all’ordinario processo di giuridicizzazione degli interessi di fatto in interessi legittimi, a prescindere, cioè, dalla dimostrazione della lesione di una posizione di vantaggio qualificata dall’ordinamento, del resto difficoltosa per gli interessi in questione, spesso non sufficientemente contemplati”. La tutela degli interessi superindividuali fa così assumere al processo amministrativo, le sembianze di un rimedio a carattere oggettivo, attribuendo, tra l’altro, agli organismi riconosciuti la veste e il ruolo di veri e propri pubblici ministeri privati. La posizione della giurisprudenza è, però, mutata nel corso degli anni, ampliando i confini della legittimazione ad agire anche a soggetti privi del riconoscimento. L’atteggiamento oggi prevalente ritiene che sia esclusa l'operatività di ogni automatismo, sia positivo che negativo, confermando in capo al giudice il dovere di effettuare, caso per caso, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del giudizio: non solo quindi con riferimento all’accertamento della inclusione dell’associazione ricorrente nell’elenco ministeriale di riferimento, ma anche “in relazione all’individuazione dell’ambito in cui riconoscere tutela, seppur con la prudenza richiesta dalla necessità di non creare spazi alla giustiziabilità di interessi non motivati con solidi e concreti riferimenti alla realtà sostanziale sottostante”. Alla stregua della più recente giurisprudenza amministrativa, si ritiene, ad es., che in materia ambientale la legittimazione spetti non solo alle associazioni di protezione a carattere nazionale, ma anche alle articolazioni regionali delle medesime, purché rappresentative dell’interesse pregiudicato dall’atto impugnato. Indici decisivi per la sussistenza della legittimazione vengono ritenuti dal giudice l’effettiva e non occasionale militanza del soggetto associativo a favore della tutela di determinati interessi diffusi, l’esistenza di una previsione statutaria che qualifichi detta protezione come compito istituzionale dell’articolazione territoriale dell’associazione, nonché la vicinanza spaziale della fonte del paventato pregiudizio ai beni giuridici protetti al centro principale dell’attività dell’associazione o della sua specifica struttura periferica. La giurisprudenza ha altresì precisato che non può affermarsi in via generale che non sussista la legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste per dedurre pretese illegittimità di natura urbanistica: tale principio dovrebbe infatti essere declinato caso per caso, in relazione alla natura e alla valenza precettiva degli atti amministrativi impugnati, non potendosi negare che, sul piano concreto, talvolta la tutela degli interessi ambientali possa richiedere anche l’annullamento di atti amministrativi generali, di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria, incidenti negativamente su valori squisitamente naturalistici. Il percorso seguito dalla giurisprudenza sembra quello di garantire l’ingresso al processo a tutti quei soggetti (associati o individuali) che, pur non dotati del riconoscimento ministeriale, vogliano far valere in giudizio la lesione di un interesse, per sua natura indifferenziato e di “respiro” ineludibilmente sociale, prospettandolo come meritevole di considerazione giudiziale. Devono essere segnalati anche quegli orientamenti interpretativi recenti del Consiglio di Stato, in base ai quali la nuova fisionomia assunta dagli enti territoriali a seguito della riforma del Titolo V Cost. e, in particolare, la lettura del combinato disposto di cui agli artt. 114 e 118 Cost., portano a desumere la loro funzione (affidata dall’ordinamento) di enti esponenziali rappresentativi degli interessi della collettività di riferimento, da cui implicitamente ricavare sic et simpliciter, sul solo presupposto del loro collegamento con la popolazione stanziata sul territorio, la legittimazione a ricorrere in seno al giudizio amministrativo avverso provvedimenti ritenuti illegittimi e connessi alla cura di interessi ad essi facenti capo. La suddetta linea interpretativa suscita alcune perplessità, soprattutto tenendo conto del fatto che la stessa giurisprudenza amministrativa è sempre stata chiara nel precisare che la legittimazione a ricorrere dei soggetti collettivi deve essere riconosciuta quando si faccia valere nel processo amministrativo un interesse proprio, riferito alla categoria di soggetti che tali organismi rappresentano in modo complessivo ed unitario e non quando, invece, tale interesse sia ascrivibile alla sfera giuridica individuale di uno solo o di una parte di essi. In altri termini, l’interesse sul quale poggia la legittimazione dei soggetti esponenziali di gruppi non occasionali non può corrispondere alla somma degli interessi individuali dei singoli aderenti, ma deve avere carattere collettivo. Se da un lato vi è dunque l’esigenza di trovare spazi di tutela adeguati a quegli interessi adespoti meritevoli di tutela, per evitare che tra gli spiragli delle norme, essi corrano il rischio di trovarsi confinati nella sfera del giuridicamente irrilevante, altra è ben diversa operazione è invece estendere i confini della legittimazione a ricorrere in ipotesi nelle quali questa carenza di tutela non sussista, finendo col sopraffare la sfera individuale ed espellere il singolo ricorrente dal processo, al cospetto di corpi collettori i quali rischiano di assorbire in tal modo la protezione che il singolo può trovare a partire da sé stesso. 3. L’ampliamento della giustiziabilitá degli interessi meta-individuali ad opera della giurisprudenza amministrativa L’ampliamento della legittimazione al ricorso, anche in capo a soggetti diversi da quelli normativamente ed espressamente riconosciuti come i naturali portatori in sede giurisdizionale, è stato possibile grazie delle operazioni interpretative, attraverso cui la giurisprudenza ha tentato di allargare le maglie del processo amministrativo, agendo sulla posizione soggettiva di base, applicando cioè a situazioni di vantaggio adespote e senza struttura (inidonee ad essere considerate nell’ambito di un processo modellato sulla tutela di situazioni individuali) i caratteri selettivi della legittimazione ad agire propria dei portatori di interessi legittimi. La "forza innovatrice” della giurisprudenza sembra oggi diretta a dilatare ulteriormente l’estensione delle situazioni meritevoli di considerazioni giurisdizionale, costituendo una sorta di contro-altare alle situazioni di legittimazione processuale individuate in via generale ed astratta dalla legge. Attraverso il richiamo al radicamento territoriale ed alla partecipazione organica alla procedura amministrativa, la giurisprudenza ha individuato una dimensione personale dell’interesse (debole), rintracciandola nell’effetto lesivo prodotto dal comportamento amministrativo su una posizione giuridica. Lo stesso criterio della c.d. vicinitas (o stabile collegamento) ha consentito, però, al Consiglio di Stato di interpretare restrittivamente la disposizione contenuta nella “legge ponte” urbanistica (art. 10 l. 765/1967), che consentiva a “chiunque” di ricorrere contro la licenza edilizia rilasciata ad altri soggetti, evitando che l’azione in essa contemplata potesse essere considerata come una nuova azione popolare. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, aveva poi completato l’iter di allargamento, estendendo l’applicazione del criterio alla materia ambientale. Risulta abbastanza evidente come, ragionandosi in termini di insediamento abitativo o più genericamente di localizzazione sul territorio interessato dal provvedimento impugnato, la posizione processuale del soggetto portatore di un interesse implicato con quello superindividuale - ad es. quello relativo alla salvaguardia dell’habitat ecologico di un certo luogo- tenda effettivamente (ed esclusivamente) a legittimarsi sotto il profilo (della personalizzazione) della lesione subita, la quale, attenendo ad un bene della vita pertinente “il luogo di vita e/o di lavoro” del ricorrente, finisce per rendere rilevante la situazione del soggetto differenziandola rispetto a quella indistinta e diffusa della collettività. L'operazione di ampliamento delle situazioni giustiziabili in sede processuale ha preso le mosse dal concetto di “stabile collegamento”, seguendo due direttrici fondamentali: - per un verso si è elaborata una configurazione più flessibile ed elastica del concetto di vicinitas, estendendo tale nozione anche a casi in cui la differenziazione della pretesa del ricorrente si caratterizza per avere un legame col bene “inciso” dall’azione amministrativa più tenue rispetto alla stretta contiguità geografica normalmente richiesta; - per altro verso -in questo caso l’operazione sembra più significativa dal punto di vista della configurazione oggettiva del processo amministrativo- si è tentato, in alcune decisioni, di estromettere dalla valutazione preliminare di ammissibilità del ricorso ogni profilo attinente alla dimostrazione concreta del pregiudizio subito dal ricorrente, prospettando sostanzialmente la vicinitas come elemento sufficiente a radicare ex se la domanda di proposizione del giudizio, a prescindere dalla valutazione del danno effettivamente subito dal singolo. In relazione invece al criterio della partecipazione organica, ovverosia riguardo alla eventualità di riconoscere alla partecipazione di un soggetto al procedimento amministrativo il valore di titolo di legittimazione per l’impugnazione della decisione o del provvedimento ad esso conseguente, va osservato che, nonostante gli importanti riconoscimenti riscontrabili nella recente normativa circa la sussistenza di precise garanzie procedimentali a favore dei soggetti portatori di interessi diffusi, la giurisprudenza amministrativa recente non sembra orientata a proiettare tali prerogative anche sul piano processuale, negando sostanzialmente la configurazione del procedimento amministrativo come possibile sede di coagulazione di interessi adespoti, o che almeno appaiono tali nel loro stadio iniziale, riconoscendo, così, il carattere “meramente ottativo” della connessione tra procedimento e processo. Tuttavia, su questo fronte, alcune interessanti aperture si sono registrate in relazione alla possibilità di sindacare, da parte del giudice amministrativo, il c.d. potere negativo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di archiviare denunce provenienti da imprese concorrenti o da associazioni di consumatori, (ritenute) lese dalla mancata stigmatizzazione da parte dell’amministrazione regolatrice di condotte anticompetitive. Ad un primo e tradizionale orientamento, secondo cui la posizione dei terzi lesi dalle determinazioni dell’Autorità non assume rilevanza giuridica autonoma rispetto all'esercizio di poteri preordinati ad una tutela oggettiva della concorrenza, si è contrapposto, di recente, un atteggiamento di maggior apertura del Consiglio di Stato, volto a riconoscere la legittimazione ad agire a gruppi di imprese concorrenti e soprattutto ad organismi associativi ritenuti, in ragione della loro finalità statutaria e della loro dimensione organizzativa, in grado di rappresentare gli interessi degli utenti del mercato. Dunque, il perseguimento da parte dell’Autorità dell’interesse pubblico alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica non esclude che anche soggetti terzi a quelli immediatamente lesi dai provvedimenti finali possano vantare interessi, pretensivi o oppositivi, suscettibili di protezione giuridica. Tale interpretazione sostiene dunque una visione dell’ordinamento nel quale il processo amministrativo è capace di porsi nelle condizioni di comporre le divergenze scaturenti, oltre che da relazioni bipolari (configurabili tra autorità amministrativa e destinatario dell’atto), anche e soprattutto da rapporti plurilaterali, quali risultanti di una relazione circolare tra potere pubblico, potere economico e libertà dei terzi (azionisti, consumatori, investitori, ecc.), adeguandosi ad un assetto sociale che si caratterizza sempre più per la presenza di un controllo sociale diffuso della collettività e al quale sembrano correlati corrispettivi obblighi pubblici di informazione, strumentali alla formazione di una conoscenza generalizzata sull'attività esercitata dai soggetti pubblici nella gestione delle problematiche connesse alla prevenzione del rischio. Sempre in riferimento a tale prospettiva va ancora rilevata l’importanza dei nuovi poteri di legittimazione a ricorrere attribuiti dalla recente normativa all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, titolata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, inquadrabili in un’ottica di potenziale “oggettivazione” del processo amministrativo, quanto meno a tutela degli interessi primari di maggior rilievo costituzionale. In particolare, a norma del nuovo art. 21-bis della l. 287/1990, l’Autorità, se ritiene che una p.a. abbia emanato un atto in violazione delle suddette norme, procede preliminarmente all’emanazione di un parere motivato, nel quale indica alla stessa amministrazione gli specifici profili delle violazioni riscontrate e qualora l’amministrazione non si conformi nei 60 giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Antitrust può presentare il ricorso, tramite l’Avvocatura dello Stato, entro i successivi 30 giorni. È una novità di grande rilievo, non solo perché attribuisce all’AGCM la possibilità di “monitorare” tutti i provvedimenti amministrativi suscettibili di contravvenire alle norme sulla concorrenza, ma anche e soprattutto per la ricostruzione generale della funzione del giudice amministrativo, il quale, attraverso questa forma di legittimazione pubblica all’azione “nell’interesse della legge”, vede indubitabilmente potenziata la sua funzione di garanzia della “giustizia nell’amministrazione” più volte evocata dalla Corte cost. a partire dala nota sentenza 204/2004. Nell’analisi del percorso teso ad evidenziare l’ampliamento della giustiziabilità degli interessi metaindividuali deve essere ricordata l’interpretazione offerta da alcuni giudici amministrativi circa l'incidenza del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, Cost. in seno al giudizio amministrativo, cui consegue il riconoscimento di un ruolo processuale a quegli stessi singoli ed alle loro formazioni sociali già impegnate nella gestione diretta di attività amministrative. In altri termini, in alcune decisioni dei tribunali amministrativi si precisa come tra le opzioni interpretative in materia di legittimazione a ricorrere si debbano privilegiare quelle “più avanzate", in grado cioè di garantire, a quegli stessi soggetti, cui viene rimessa l’iniziativa sul piano sostanziale, la più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale la funzione amministrativa, al fine di garantire un controllo sociale diffuso anche dopo il suo esercizio da parte dei poteri pubblici. 4. L’azione collettiva risarcitoria Il legislatore, ha di recente previsto l’istituzione di nuove azioni processuali destinate a rendere più efficace la giustiziabilità delle situazioni giuridiche a carattere multi-individuale, legate in particolare alle problematiche della consumer protection. Il riferimento è, in primo luogo, all’istituto dell’azione collettiva risarcitoria, che dovrebbe rappresentare, almeno sul piano teorico, il completamento e la chiusura di un sistema processuale di azioni collettive che rinviene, tra l’altro, nell’azione inibitoria un altro baluardo preposto alla tutela di situazioni a carattere multi-individuale. Appare improprio parlare di class action, dove è in genere il singolo individuo a proporre il giudizio (anche) nell’interesse di una pluralità di soggetti vertenti nella medesima situazione lesiva, e, in ogni caso, a prescindere da ogni legame associativo sussistente tra i singoli individui. Le modifiche introdotte recentemente intervengono proprio sul punto, restituendo all’azione di classe risarcitoria la natura propria di rimedio azionabile dal singolo (ciascun componente della classe), anche se non si esclude che l’azione possa essere esercitata tramite un comitato o un’associazione a cui lo stesso conferisce il mandato. La legittimazione ad agire viene attribuita ai soggetti indicati per richiedere al tribunale del capoluogo di regione in cui ha sede l’impresa l’accertamento delle responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a: “a) diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; b) diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”. Il decreto di modifica interviene anche sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno nel caso di violazione di interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, risarcimento in precedenza limitato invece alle sole ipotesi di violazione di diritti soggettivi. Si prevede inoltre che la domanda sia dichiarata inammissibile, oltre che nei casi di manifesta infondatezza e di conflitto di interessi, “quando il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe”. La giurisprudenza ha di recente precisato, da un lato, che è inammissibile, per mancanza del requisito dell’identità dei diritti individuali da tutelare, l’azione di classe promossa prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 140-bis del Codice del consumo dal decreto Crescitalia, chiarendo dunque l’irretroattività della novella nonostante essa disponga a favore della situazione del consumatore"; per altro lato ha specificato che l’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe è fondata su una delibazione sommaria ed è unicamente finalizzata ad una pronuncia di rito, idonea a condizionare solo la prosecuzione di quel processo di classe, senza impedire la riproposizione dell’azione risarcitoria anche in via ordinaria". La norma, nello stabilire il criterio per determinare il foro competente, indica espressamente “l’impresa” come unico soggetto che è possibile convenire in giudizio. Il ricorso a tale termine non pare possa intendersi nel senso di escludere tout court la p.a., almeno ogni qualvolta essa eserciti un’attività a carattere non autoritativo, come accade nell’ipotesi di gestione diretta di servizi pubblici. 5. L’azione per l’efficienza della pubblica amministrazione Nel quadro delle riforme per la “produttività del lavoro pubblico” vi è una nuova azione di classe pubblica nei confronti delle inefficienze delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Per evitare una sovrapposizione tra le due azioni, il legislatore ha individuato alcuni criteri di coordinamento. È sancita, infatti, l’impossibilità di proporre l’azione contro le inefficienze della p.a. avverso quelle condotte illegittime nei confronti delle quali sia già stato instaurato un giudizio o sia pendente un procedimento avviato da un autorità amministrativa di regolazione volto all'accertamento dei medesimi fatti peri quali si intende chiedere tutela. L’azione in questione si presenta come un rimedio a carattere residuale e sembra connotarsi in maniera peculiare rispetto all’azione collettiva risarcitoria sia con riferimento alla situazione soggettiva sostanziale azionata (ai requisiti della legittimazione ad agire), sia soprattutto con riguardo ad una sua possibile configurazione quale ipotesi di giurisdizione oggettiva. Scopo dell’azione è quello di “ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio” quando si siano verificati comportamenti di maladministration: a) violazione di termini o mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato dalla legge o da un regolamento; b) violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi o di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici dalle autorità di regolazione, e per le amministrazioni dalle stesse, sulla base delle linee guida emanate dalla Commissione per la valutazione la trasparenza e l’integrità della delle amministrazioni pubbliche. A fronte di tali comportamenti “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti” possono azionare il rimedio in questione non prima di aver rivolto all’amministrazione o al concessionario una diffida a provvedere, entro 90 giorni, al ripristino delle condizioni dì efficienza del servizio o della funzione amministrativa mal (o non) esercitata. Decorso inutilmente questo termine l'interessato può rivolgersi, entro un anno, al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, non per richiedere un risarcimento del danno, ma solo al fine di ottenere una sentenza di accertamento e condanna ad un facere, che ordini cioè in via generica all’amministrazione la rimozione delle cause e, se possibile, degli effetti del disservizio. Sembra che in questa prima fase il giudice non possa stabilire con valenza dispositiva e vincolante, le concrete modalità di riorganizzazione del servizio, riservate invece alla statuizione del giudice dell’ottemperanza nel caso in cui l’amministrazione non esegua in prima battuta l’ordine del giudice. L'oggetto diretto della tutela dell’azione collettiva pubblica investe, dunque, un bene pubblico, rappresentato dall’interesse all’esatta erogazione di un servizio o al corretto svolgimento di una funzione pubblica, che diventa individualmente azionabile dal fruitore della prestazione amministrativa nel momento in cui si configuri una lesione diretta, concreta, attuale dei suoi interessi. La protezione della situazione giuridica di chi agisce in giudizio rimane sullo sfondo, in quanto l’azione mira in primo luogo a sanzionare e correggere le inefficienze dell'amministrazione intimata; solo indirettamente si preoccupa di garantire la posizione soggettiva di chi abbia subito da tali inefficienze un ingiusto pregiudizio. Si può affermare che la tutela del soggetto privato si configura solo come “elemento accidentale” rispetto ad una situazione di interesse pubblico, che sembra rappresentare l’oggetto principale del giudizio e che diviene meritevole di accertamento (e rimedio) in sede giurisdizionale solo se la disfunzione non sia riconducibile a una oggettiva carenza di risorse del soggetto pubblico intimato. Questa azione, si propone di intervenire nell’alveo dei rapporti tra p.a. e cittadino, interagendo nello stesso processo di espletamento della funzione o di produzione del servizio e fungendo da incentivo esterno all’ottimizzazione dell’azione pubblica, per evitare che il soggetto “forte” scarichi sulla controparte il prezzo delle proprie inefficienze, inducendo quindi la p.a. a correggere eventuali storture e a perseguire comportamenti maggiormente virtuosi, strumentali alla soddisfazione degli interessi della collettività. Si pone in primo piano l’iniziativa processuale del singolo che agisce per sé e quale rappresentante degli altri amministrati che hanno subito un analogo pregiudizio per la natura generale della disfunzione caratterizzante l'azione lesiva. Proprio avendo riguardo al petitum dell’azione del singolo, finalizzato a ripristinare l’integrità di un bene omogeneo pubblico, sembra che la situazione di legittimazione processuale prospettata in questo caso non appaia in fondo molto diversa da quella che caratterizza un’azione popolare, se è vero -come sembra essere vero- che la lesione diretta, concreta, attuale degli interessi del singolo, abbia la semplice funzione di impedire che il ricorso possa essere intentato da un soggetto che non appartiene alla “classe” titolare del bene collettivo di cui si chiede tutela in giudizio. Le prime decisioni giurisprudenziali in materia di class action pubblica hanno confermato che l’unica fattispecie lesiva capace, allo stato di rendere concretamente applicabile la norma è quella riferita all’omessa emanazione di atti amministrativi generali obbligatori, in quanto permette l’esatta individuazione del comportamento esigibile, senza necessità di ulteriori specificazioni normative. In merito a tale fattispecie il giudice amministrativo ha precisato che la class action non sfugge ai comuni principi in materia di domanda giudiziale e, dunque, alla regola che questa debba essere sufficientemente determinata nel suo petitum, in relazione al contenuto dell’azione e alla sua finalità. La parte ricorrente, quindi non può limitarsi genericamente a richiedere l’emanazione di “atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo, ma dovrà dimostrare, quale elemento costitutivo essenziale della sua domanda l’obbligatorietà dei medesimi in relazione alla situazione di pregiudizio lamentata. Capitolo 2: Le parti 1. Concetti generali Nel diritto processuale, per parti si intendono i soggetti titolari del potere di costituire rapporti processuali, allo scopo di ottenere una decisione del giudice. Dottrina e giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto il carattere soggettivo del processo amministrativo, costruendolo come un processo di parti, retto dal principio dispositivo. Il processo amministrativo si configura, quindi, come processo di parti, volto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive. Con riferimento al concetto di parte come soggetto degli atti processuali, parte in senso formale o processuale è colui che propone la domanda e colui nei cui confronti la domanda è proposta. Nel processo amministrativo esse assumono rispettivamente la denominazione di ricorrente e resistente, trattandosi di un processo attivabile con ricorso, non solo quando debba farsi valere un interesse legittimo, ma anche quando si faccia valere un diritto soggettivo. L’atto introduttivo del processo amministrativo è, infatti, una vocatio iudicis, atto con il quale si chiama il giudice a provvedere sull’oggetto della domanda. Se il modello processuale tradizionale vedeva inevitabilmente contrapposto un soggetto privato (ricorrente) ad un soggetto pubblico (resistente), l’accresciuta complessità dell’organizzazione amministrativa e delle relazioni tra amministrazione e cittadini determina la possibilità che vi siano casi in cui si contrappongano due soggetti pubblici o due soggetti privati, nonché di processi a parti invertite, nei quali, cioè, il soggetto pubblico assume la veste di ricorrente e il privato quella di resistente. La nozione di parte in senso formale non dice nulla, tuttavia, in ordine al rapporto giuridico controverso. L’assetto degli interessi sottesi al rapporto dedotto in giudizio emerge solo quando si considerino le parti sotto l’aspetto sostanziale, quando, cioè, la parte è presa in esame come destinataria degli effetti del processo o della sentenza. Dal lato attivo è parte in senso sostanziale il titolare della situazione giuridica soggettiva che si fa valere in giudizio e della quale si lamenta la lesione per effetto dell’azione amministrativa; dal lato passivo è parte in senso sostanziale il soggetto cui è imputabile la lesione. La nozione di parte in senso sostanziale serve a determinare le giuste parti del processo, quelle, cioè, titolari del rapporto giuridico controverso. Si parla, a tal proposito, di legittimazione ad agire (a ricorrere) o legitimatio ad processum, con ciò intendendo la capacità di presentare il ricorso per la tutela di una situazione giuridica soggettiva. A tale nozione si affianca quella di legittimazione processuale o legitimatio ad processum, relativa, invece, alla capacità di stare in giudizio. La trattazione sin qui condotta ha delineato essenzialmente i due poli del rapporto processuale, non i soggetti del processo, che andrebbero individuati in tutti coloro i quali siano titolari di interessi sui quali la decisione del giudice andrà ad incidere. La possibilità per tali soggetti di partecipare al processo risponde ad esigenze di giustizia sostanziale e dipende dal modello processuale, quale risulta dalle disposizioni di diritto positivo. Il quadro generale della legittimazione processuale è, tuttavia, in forte movimento. 2. Le parti necessarie Nonostante gli interventi di riforma del sistema della giustizia amministrativa realizzati negli ultimi anni e culminati nel Codice, lo schema generale del processo amministrativo resta sostanzialmente modellato sul giudizio di tipo impugnatorio. Con riferimento a quel modello, per quanto concerne l’individuazione delle parti, sono possibili due opzioni teoriche: a) il criterio dell’atto, in base al quale sono parti la p.a. che ha emanato l’atto e il soggetto che ne chiede l’annullamento; b) il criterio soggettivo dell’interesse coinvolto nell’atto. Il Codice, sembra restare sostanzialmente aderente alla prima opzione, secondo cui sono parti necessarie: il ricorrente, la parte resistente, che normalmente è la p.a. che ha emanato l’atto o posto in essere il comportamento lesivo, e, i controinteressat ai quali l’atto si riferisce, stante l’obbligo di notificare il ricorso ad almeno uno tra essi “che sia individuato nell’atto stesso”. Pare, però, potersi rinvenire nell’impianto complessivo del Codice una pur limitata considerazione della seconda opzione, fondata sul criterio degli interessi coinvolti e più aderente alla realtà di un’amministrazione sempre più “partecipata”, tesa a coinvolgere nell’esercizio della funzione tutti i soggetti che vi abbiano interesse. Sarebbero parti necessarie tutti i soggetti nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale è destinata ad incidere, rispondendo, così, ad esigenze irrinunciabili di giustizia sostanziale. Il controinteressato pretermesso (al quale il ricorso non è stato notificato in quanto non nominativamente individuato nell’atto), è parte necessaria nel senso che questi è “una delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata”. Circa la questione dei rapporti tra procedimento e processo o, più precisamente, del rapporto tra partecipazione procedimentale e legittimazione processuale, il problema si pone non per il destinatario del provvedimento, legittimato ex se all’impugnazione, ma per le altre figure soggettive che a vario titolo partecipino al procedimento. Se, infatti, la disciplina del procedimento amministrativo ha il merito di consentire l’emersione degli interessi già prima del processo, non sembra, invece, chiarire se qualsivoglia coinvolgimento nel procedimento dia titolo ad essere parte nel processo. La correlazione tra procedimento e processo, tra forme dell’azione e forme della sua verifica giudiziale, appare un dato evidente ed esprime la realizzazione del principio dì legalità, nel senso di conformità all’ordinamento normativo sia sotto il profilo formale del rispetto delle regole procedimentali, che in relazione alla compatibilità sostanziale tra la norma attributiva del potere ed il suo esercizio. È il procedimento che offre al processo il materiale per il giudizio. Tra procedimento e processo non vi è, tuttavia, identità di funzione: il primo è la sede di individuazione e valutazione di tutti gli interessi rilevanti per l’esercizio del potere, il secondo la sede della tutela di uno degli interessi rilevanti che si assuma ingiustamente sacrificato. Ma, posta tale diversità, tra procedimento e processo, i modelli di rapporti ipotizzabili sono: a) quello della separazione; b) quello dell’alternatività; c) quello dell’integrazione. Se pare auspicabile l’affermazione di una corrispondenza biunivoca tra soggetti del procedimento e soggetti del processo, va evidenziato come interessi giuridicamente significativi vengano introdotti nel procedimento da soggetti che, rispetto ad essi, non possono considerarsi titolari o centri esponenziali esclusivi o comunque qualificati dei medesimi. In giurisprudenza si afferma, in generale, che non vi sia piena corrispondenza tra le “parti” del procedimento e le parti del processo, poiché, da un lato, la partecipazione procedimentale non costituisce ex se titolo di legittimazione processuale, dall'altro, la mancata partecipazione al procedimento non preclude la possibilità di assumere la veste di parte processuale. In questo senso, può sinteticamente affermarsi che, mentre per la partecipazione procedimentale è sufficiente un interesse semplice, per la legittimazione processuale è necessaria la titolarità di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, cioè di una situazione giuridica soggettiva di tipo sostanziale, della quale il soggetto abbia la disponibilità, cui corrisponde la titolarità dell’azione. Si badi, tuttavia, che può parlarsi di interesse semplice soltanto rispetto al ricorso avverso l’atto o il comportamento “finale”, non in relazione a situazioni endoprocedimentali. Si registra, infatti, da più parti in dottrina l’emersione della categoria degli interessi cc.dd. “procedimentali”, muniti sempre più spesso di una tutela specifica e differenziata. Si potrà, in ipotesi, invocare tutela giurisdizionale autonoma contro l’atto (endoprocedimentale) o il comportamento che abbiano, ad esempio, impedito la partecipazione al procedimento. Si tratta, tuttavia, di un ambito nel quale i confini della tutela non risultano del tutto determinati. 3. Il ricorrente Il ricorrente è sul piano formale colui che propone il ricorso e sul piano sostanziale il titolare della situazione giuridica soggettiva che si fa valere in giudizio. Il ricorrente sarà, pertanto, tipicamente, un soggetto privato nella cui sfera giuridica si determini una lesione per effetto di un provvedimento dell’amministrazione, ciò quando la controversia sia di tipo impugnatorio e si lamenti la lesione di un interesse legittimo; ovvero, a prescindere dall’eventuale impugnativa di un provvedimento, il titolare di un diritto soggettivo leso, nelle materie di giurisdizione esclusiva. Nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità potrà, inoltre, assumere la veste di ricorrente colui che lamenta una lesione derivante da un comportamento della pubblica amministrazione. Devono individuarsi come possibili ricorrenti anche gli enti esponenziali di interessi superindividuali, quando la legge espressamente riconosca in capo ad un soggetto giuridico la cura di interessi di gruppo. Per i casi in cui non vi sia una espressa disposizione di legge non è, invece, possibile offrire una soluzione univoca, data la pluralità dì posizioni in dottrina e giurisprudenza; tuttavia può registrarsi la tendenza a consentire l’accesso alla tutela giurisdizionale ad enti o associazioni esponenziali di interessi superindividuali, in presenza di particolari collegamenti, spaziali o procedimentali. La legittimazione processuale degli enti esponenziali forza, ma non supera, l’ordinario criterio di legittimazione, che resta legato alla titolarità di un interesse sostanziale in capo al ricorrente. Diverso è il caso, invece, delle azioni popolari, che si sostanziano nel riconoscimento per legge di una legittimazione processuale al quisque de populo, il quale, proponendo ricorso, fa proprio un interesse diffuso. I casi di azione popolare sono tassativamente previsti dalla legge. Si pensi al ricorso relativo alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni e Parlamento europeo e l’azione popolare che riconosce al cittadino, in quanto tale, la legittimazione a proporre azioni e ricorsi spettanti a Comuni e Province per la tutela di interessi della collettività di riferimento. Ipotesi controversa è, poi, il rapporto determinato dalla segnalazione certificata di inizio attività, disciplinata, in via generale, dall’art. 19, legge 241/1990. Tale modello dà vita ad un caso di autoamministrazione, per cui l’eventuale lesione della sfera giuridica soggettiva del privato titolare di un interesse contrario all’intrapresa dell’attività deriva dalla segnalazione del privato e non da un atto dell’amministrazione. Ciò ha determinato incertezze sulle possibilità per il terzo di assumere la veste di ricorrente. Diverse le tecniche di tutela costruite nel tempo: proposizione del ricorso avverso il comportamento inerte della p.a., proposizione del ricorso avverso un provvedimento espresso o tacito, sollecitato con atto di diffida, o, ancora, impugnativa della segnalazione del privato. Sul punto è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha escluso che la segnalazione certificata di inizio attività sia un provvedimento amministrativo a formazione tacita, costruendola come un atto privato, volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge e ha indicato, quale strumento per la tutela del terzo, l’azione di accertamento autonomo, volta a verificare la sussistenza dei presupposti giuridici per l’esercizio dell’attività oggetto della segnalazione con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all’autorità amministrativa. Sul punto è, però, intervenuto il legislatore, che ha escluso la praticabilità della soluzione costruita dalla Plenaria, indicando come unico rimedio l’azione avverso il silenzio di cui all’art. 31 c.p.a. Le ipotesi delineate riguardano i casi in cui a ricorrere sia un soggetto privato e ricalcano, dunque, lo schema classico del processo amministrativo. Ciò si giustifica nella giurisdizione generale di legittimità, nella quale si controverte dell’esercizio (o mancato esercizio) di un potere unilaterale e autoritativo, perché la titolarità del potere consente alla p.a. di realizzare direttamente l’interesse pubblico. In quest’ottica, mentre il privato titolare di interesse legittimo deve sollecitare l’intervento del giudice per tutelare la sua situazione giuridica soggettiva, tale intervento del giudice si palesa del tutto inutile per la p.a., che, attraverso l’esercizio unilaterale del potere, si impone ai destinatari della sua azione, con atti esecutivi ed esecutori, regolando il rapporto. 4. La pubblica amministrazione come parte ricorrente Nella giurisdizione esclusiva, possono fronteggiarsi diritti soggettivi ed obblighi, e quindi la p.a. può essere titolare di un diritto soggettivo nei confronti del privato. In questo caso la natura paritaria del rapporto dovrebbe escludere poteri di “autosoddisfazione" ed imporre il ricorso al giudice, ma in realtà ciò non è sempre accaduto perché l'attribuzione di una data materia alla giurisdizione esclusiva ha spesso determinato una marcata “pubblicizzazione” del rapporto, nel quale sono stati attribuiti alla p.a. poteri di autosoddisfazione tali da evitare l'intervento del giudice. La crescente rilevanza quantitativa delle materie di giurisdizione esclusiva impone alcune riflessioni sull’individuazione della parte ricorrente nelle ipotesi in cui si faccia valere un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, o si agisca per la condanna alla reintegrazione in forma specifica o al risarcimento del danno. Il problema si pone in tutta evidenza quando si considerino i rapporti nascenti da attività amministrativa di tipo consensuale. Oltre all'attribuzione espressa della giurisdizione esclusiva, in materia di accordi tra privati e pubblica amministrazione, si constata, infatti, come il giudice amministrativo stia diventando con sempre maggiore ampiezza il giudice dei rapporti consensuali della p.a. Ciò è in larga parte determinato dall’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di contratti pubblici e delle controversie in materia di servizi pubblici, urbanistica ed edilizia. Nelle controversie su contratti, accordi e convenzioni è agevole ipotizzare che la veste di parte ricorrente (e resistente) possa essere assunta sia dal privato, sia dalla p.a. Oltre che nei rapporti di tipo consensuale, l’amministrazione può assumere la veste di ricorrente nei casi in cui il privato chieda al giudice amministrativo -in giurisdizione esclusiva- l’emanazione di un decreto ingiuntivo. In base alle norme del c.p.c., il processo di cognizione si attiva mediante ricorso in opposizione da parte del soggetto ingiunto, che potrà essere la p.a.. anche se ciò rileva solo sul piano formale perché, sul piano sostanziale, è pur sempre il creditore opposto a dare impulso al giudizio. L’idea di un processo amministrativo “a parti invertite” forza in modo evidente il modello tradizionale del processo amministrativo. Nel Codice lo strumentario processuale si presenta senza dubbio arricchito ed in astratto idoneo ad offrire tutela anche alle ragioni della p.a. nei confronti del privato, ma è evidente che il giudice amministrativo, nella giurisdizione esclusiva su rapporti di tipo paritario, sia chiamato a mutare il tradizionale approccio e il modo di risoluzione della controversia, ancora largamente modellato sulla giurisdizione generale di legittimità. Non mancano, tuttavia, casi in cui, anche al di fuori della giurisdizione esclusiva, possa assumere la veste di parte ricorrente un soggetto pubblico. In via generale ciò accade in tutti i casi in cui il rapporto processuale si instaura tra due soggetti pubblici. Una particolare ipotesi di soggetto pubblico come parte ricorrente è contemplata dall’art. 35 del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, che ha, infatti, introdotto l’art. 21 -bis della legge 287/1990, che abilita l’autorità garante della concorrenza e del mercato ad “agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”. Prescindendo dall’analisi dei molteplici profili problematici della disposizione, giova rilevare come la speciale legittimazione attribuita al l’AGCOM strida con la configurazione del processo amministrativo come processo di parti, alimentando il mai sopito dibattito sul carattere oggettivo della giurisdizione amministrativa. Il problema potrebbe, infine, porsi in relazione alla legittimazione degli enti territoriali per la tutela degli interessi dei propri amministrati. In merito, la giurisprudenza ha evidenziato come “al fine di individuare esattamente limiti e possibilità riconosciute agli enti territoriali ai fini della tutela degli interessi dei propri amministrati, debba farsi riferimento non solo all’elaborazione consolidata della giurisprudenza ma anche alle innovazioni normative sopraggiunte medio tempore e, soprattutto, ai nuovi profili di intervento riconosciuti ad ogni tipologia di figura soggettiva esponenziale di interessi omogenei ai sensi del decreto legislativo 198/2009”. In tali ipotesi va negata la sussistenza della legittimazione degli enti territoriali per il solo elemento della rappresentatività delle collettività ivi stanziate e va tenuto fermo il principio secondo cui la legittimazione, per le materie non direttamente conferite dalla legge, vada individuata secondo i criteri usuali, ossia quelli che discendono dall’analisi del tessuto ordinamentale. 5. La parte resistente La parte resistente può individuarsi nell’autorità che ha posto in essere provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio del potere che il ricorrente assume come lesivo o, più in generale, nell’amministrazione nei cui confronti si faccia valere una pretesa sostanziale, ancorché non collegata ad un atto amministrativo. Ai fini della valida instaurazione del giudizio è sufficiente la sola attività processuale del ricorrente, potendo (dovendo) il giudice amministrativo giungere alla decisione anche senza la costituzione in giudizio della parte resistente o di altra parte interessata. La p.a. intimata può, infatti, decidere di non comparire in giudizio, in quanto non grava su di essa alcun onere processuale di prospettare al giudice una situazione sostanziale in antitesi a quella illustrata nell’atto introduttivo del giudizio. La chiamata in giudizio da parte del ricorrente fa acquisire alla p.a. intimata la qualità di parte in senso formale, ma può accadere che il ricorrente non abbia correttamente individuato l’amministrazione resistente, avendo proposto ricorso nei confronti di un organo o di un soggetto diverso da quello cui l'atto sia imputabile o diverso dal titolare dell’obbligazione cui corrisponde la pretesa fatta valere. In questo caso all'amministrazione non è preclusa la costituzione in giudizio, per far valere la sua estraneità, ma il giudice concluderà nel senso della inammissibilità del ricorso a causa della irregolare instaurazione del contraddittorio. In realtà non è sempre agevole individuare esattamente l’amministrazione chiamata a resistere in giudizio, a causa della complessità dell’organizzazione amministrativa, nonché dei modelli di azione amministrativa. La regola generale è quella di considerare giusta parte resistente solo l'amministrazione che ha emanato l’atto finale del procedimento e non gli organi o i soggetti che abbiano preso parte a vario titolo dell’iter' procedimentale e che, di conseguenza, il ricorso vada notificato alla pubblica amministrazione cui l'atto sia imputabile. Ma accade talvolta che la lesione della situazione giuridica soggettiva sia determinata non dal provvedimento finale, ma da un atto che interviene nel corso del procedimento (es. diniego di nulla osta); in questi casi la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la proposizione del ricorso nei confronti degli organi o enti che abbiano posto in essere un atto endoprocedimentale, purché tale atto sia immediatamente lesivo e sia preclusivo rispetto alla prosecuzione stessa del procedimento, o assuma carattere vincolante per l'autorità preposta all’emanazione del provvedimento finale. Altro caso controverso è quello relativo all’attività di controllo: qualora il controllo abbia esito negativo e conduca all’annullamento dell’atto controllato, il ricorso potrà essere proposto contro l'amministrazione controllante, poiché è all’atto negativo di controllo che è riconducibile la lesione della situazione giuridica soggettiva; in caso di controllo positivo, questo viene assorbito nel procedimento di formazione dell’atto, pertanto il ricorso andrà proposto contro l’amministrazione che ha emanato il provvedimento. Nel caso di concorso di più amministrazioni, che si traduca in un atto complesso, nonché per i casi di concerto o intesa, l’atto è imputabile a ciascuna di esse, pertanto resistenti saranno congiuntamente tutte le amministrazioni cui l’atto è imputabile. Va fatto cenno, poi, al caso in cui una data funzione amministrativa sia trasferita da un’autorità ad un’altra. In questo caso, parte resistente sarebbe l'autorità cui la funzione è stata trasferita, perché parte del processo è l’autorità che ha poteri di disposizione in ordine all’atto impugnato, potendo mantenerlo o annullarlo d'ufficio. Parte della giurisprudenza ha, tuttavia, affermato che parte resistente è comunque l’autorità emanante, a prescindere da un successivo trasferimento di funzioni. Particolari problemi si sono posti in relazione alla legittimazione passiva dello Stato. Nonostante il legislatore abbia più volte ribadito che la chiamata in giudizio dello Stato dovesse essere effettuata nella persona del Ministro competente ratione materiae, si è dovuta attendere l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per sancire definitivamente tale regola. Si prevede che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali “promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere. Per le altre amministrazioni vale il principio secondo cui esse stanno in giudizio nella persona dei soggetti che ne hanno la rappresentanza per legge o per Statuto. Particolarmente controversa la questione in relazione alla rappresentanza processuale degli enti locali. Sul punto, può rilevarsi come detta funzione di rappresentanza sia attribuita, a mezzo di espressa previsione legislativa, rispettivamente al sindaco ed al presidente della provincia. Detti organi, dunque, titolari della rappresentanza sia politica che giuridica dei rispettivi enti, sono altresì attributari della funzione di stare in giudizio. Tale affermazione può -e deve- essere tenuta ferma solo in assenza di espressa disposizione statutaria. La giurisprudenza, infatti, ha di recente chiarito che, attraverso lo statuto, la rappresentanza in giudizio può essere legittimamente affidata ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell'ente. La titolarità della rappresentanza dell'ente, tuttavia, è problema diverso da quello della sussistenza, in capo al rappresentante, di un potere di libero esercizio della enunciata funzione. Le modalità di esercizio della rappresentanza legale dell’ente possono, tuttavia, formare oggetto di disposizioni statutarie, che attribuiscano a determinati soggetti un potere di porre in essere determinazioni preventive, in ordine alla opportunità dì promuovere liti giudiziali, ovvero di resistervi. Nello schema classico del processo amministrativo parte resistente è necessariamente una pubblica amministrazione. Non sembra fuoriuscire da tale schema il caso del c.d. organo indiretto della p.a., figura espunta nel testo definitivo, con la locuzione “il soggetto equiparato resistente”. La legislazione degli ultimi anni ha imposto in molti casi a soggetti privati concessionari di pubblico servizio di adottare per l’affidamento di lavori le stesse procedure seguite dai soggetti pubblici. Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che, nonostante si tratti sul piano soggettivo di una lite tra privati, il carattere oggettivamente amministrativo dell’attività esercitata dal concessionario debba indurre la giurisdizione del giudice amministrativo. In quest’ottica, il privato concessionario diviene parte resistente nel processo amministrativo, ma ciò non rappresenta una vera eccezione al principio che parte resistente debba essere un soggetto pubblico, perchè intanto assume tale ruolo, in quanto “esercita poteri spettanti alla p.a. e si riproduce, nel processo, la posizione sostanziale che vede confrontarsi il potere autoritativo e l’interesse legittimo”. Ciò che, invece, sembra scardinare lo schema ordinario del processo amministrativo riguarda i rapporti di tipo paritario e a contenuto essenzialmente patrimoniale, quando essi siano conosciuti dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. In questi casi assumerebbe la veste di parte resistente il privato “in senso proprio”, ma il giudice amministrativo sarebbe chiamato a reinterpretare gli strumenti processuali vigenti per far fronte alle esigenze di tutela dell’amministrazione contro il privato. 6. I controinteressati quali contradditori formali Sono controinteressati quei soggetti titolari di una situazione giuridica soggettiva di segno contrario rispetto a quella del ricorrente. L’art. 41 del Codice, dispone che in caso di azione di annullamento “il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso”; in caso d azione di condanna, anche in via autonoma, “agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo”. La posizione di controinteressato si determina perché il provvedimento impugnato ha attribuito una posizione di vantaggio e, pertanto, questi ha interesse alla sua conservazione. In questo senso i controinteressati si pongono nella medesima posizione della p.a. che resiste alla domanda diretta all’annullamento del provvedimento, proposta dal ricorrente. Va osservato, però, come, dal punto di vista sostanziale, l'interesse del controinteressato non sia diverso da quello del ricorrente, anzi deve considerarsi qualitativamente ad esso omogeneo, in quanto sono entrambi coinvolti nell’azione amministrativa e devono essere ugualmente considerati dall’amministrazione. Dovranno, quindi, considerarsi controinteressati coloro nei cui confronti l’azione amministrativa ha spiegato efficacia, determinando in modo diretto una posizione di vantaggio. Il controinteressato è titolare di un interesse sostanziale alla conservazione dell’atto e è parte necessaria nel processo amministrativo. Il concetto di parte necessaria conosce due distinte declinazioni riconducibili la prima al contraddittorio formale, ossia alla valida costituzione del rapporto processuale; la seconda al contradditorio sostanziale e specificamente alla validità della sentenza. Pertanto il rapporto processuale è validato e costituito se il ricorso è notificato ad almeno uno dei controinteressati formali mentre la validità della sentenza è condizionata dall’estensione del contraddittorio a tutti i controinteressati. Non per tutti i ricorsi è individuabile un controinteressato, potendo un atto amministrativo incidere sulla sfera giuridica soggettiva di un solo soggetto, senza recare vantaggio ad altri; inoltre, l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non implica la loro presenza effettiva nel processo. Per l’individuazione dei controinteressati, si stabilisce “è tale il soggetto che sia individuato nell’atto stesso”. Rispetto a tale formulazione, dovrebbero considerarsi litisconsorti necessari solo i soggetti espressamente menzionati nell’atto. Tale criterio si palesa eccessivamente formalistico, anche perchè farebbe dipendere l’ampiezza del contraddittorio dalle tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi. La formulazione legislativa suggerisce l’opzione secondo cui parti necessarie sono i controinteressati in senso formale, quelli individuabili sulla base del provvedimento impugnato. Ma l’elemento formale dell’espressa menzione nell’atto non può ritenersi condizione necessaria; la giurisprudenza ha, infatti, specificato, che la posizione di controinteressato è configurabile non solo quando il soggetto sia indicato nell’atto impugnato, ma anche se sia agevolmente identificabile dalla lettura dell’atto stesso. La giurisprudenza ha inteso privilegiare parametri oggettivi di identificazione dei contraddittori necessari. Ma tale interpretazione, se ha il pregio di restare aderente al dato normativo, non mostra, però, di accogliere le istanze della dottrina, che propone di individuare le parti necessarie rispetto a tutti gli atti del procedimento, sempre che in capo ai soggetti coinvolti nel procedimento sia riscontrabile una posizione giuridica qualificata. In realtà, la scelta dell'ancoraggio più o meno rigido al dato formale è frutto del bilanciamento di due esigenze contrapposte: da un lato, infatti, si avverte l’esigenza di ampliare l’ambito del contraddittorio, superando il criterio formale in senso stretto, dall'altro quella contrapposta di non rendere troppo gravosi gli oneri processuali della parte ricorrente nel breve termine di decadenza per la proposizione del ricorso. Non sempre i soggetti del rapporto amministrativo sono facilmente individuabili e tale consapevolezza emerge nella determinazione legislativa dell’ampiezza dell’obbligo di notifica ai controinteressati. L'art. 41 del Codice impone di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati, salva l’integrazione successiva del contraddittorio. Tutti i controinteressati in senso formale sono, dunque, parti necessarie, ma il giudizio è validamente instaurato con la notifica ad uno solo dei possibili controinteressati. 7. Il controinteressato Sostanziale, occulto o sopravvenuto In dottrina emerge che controinteressato in senso sostanziale è chiunque sia portatore di un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente, anche se non sia facilmente identificabile sulla base dell'atto. In altri termini, si è cercato in dottrina un criterio che consenta di far confluire nel processo tutti gli interessi toccati dall’esercizio della funzione. Anche la giurisprudenza ha elaborato un criterio sostanziale che considera controinteressati i soggetti titolari di interessi sostanziali e giuridicamente qualificati alla conservazione dell’atto, dunque confliggenti con la posizione del ricorrente. Tuttavia, tale criterio non riceve applicazione sistematica e la giurisprudenza afferma la contemporanea presenza sia dell’elemento formale (individuabilità sulla base del provvedimento) che dell'elemento sostanziale (titolarità di un interesse alla conservazione dell'atto impugnato). Sul presupposto della contemporanea ricorrenza dell’elemento formale e dell'elemento sostanziale, la giurisprudenza esclude dal novero dei controinteressati formali i soggetti che acquistano una posizione di vantaggio solo successivamente alla introduzione del giudizio (controinteressati occulti o sopravvenuti), atteso che l’esistenza di tali requisiti andrebbe verificata prima del giudizio. I controinteresati occulti o sopravvenuti sarebbero quei soggetti la cui posizione di vantaggio non si evince dal provvedimento impugnato o emerge solo a seguito dell’emanazione della sentenza di primo grado. La giurisprudenza esclude, del pari, i soggetti, pur se individuati espressamente nell’atto, la cui posizione si traduce in un interesse alla conservazione di un provvedimento a contenuto negativo e non nella attribuzione di un vantaggio (a contenuto positivo), nonché i soggetti titolari di situazioni soggettive coinvolte da atti amministrativi generali. Sul punto, va evidenziato come il criterio formale si palesi ancor più largamente inadeguato quando si consideri la recente evoluzione dei modelli di azione amministrativa. Particolari problemi si pongono in relazione ai modelli di amministrazione c.d. consensuale. L’art. 11 della l. 241/1990 tiene fermo il principio che gli accordi tra privati e p.a. possano concludersi “senza pregiudizio dei diritti dei terzi”. Non è agevole, tuttavia, desumere con chiarezza in quali casi e secondo quali modalità i “terzi” evocati dalla norma assumano la veste processuale di controinteressati. Sarebbero controinteressati quei “terzi” che siano pregiudicati dall’accordo, ma il coinvolgimento della sfera giuridica dei terzi stride con il concetto stesso di accordo. Da un punto di vista sostanziale, l’individuazione di terzi controinteressati rispetto all’accordo può emergere con riferimento alla loro partecipazione nella fase procedimentale antecedente alla conclusione dell’accordo endoprocedimentale o sostitutivo, o in quanto essi siano espressamente contemplati nella determinazione che l’organo procedente deve emanare prima della stipulazione dell’accordo. Non è priva di rilievo anche la disciplina processuale dettata dal Codice in materia di silenzioinadempimento; se, infatti, non sono configurabili controinteressati in un giudizio su un comportamento omissivo che si concluda con una pronuncia a contenuto meramente dichiarativo, ben diversa è la situazione nel momento in cui il giudice può esaminare la fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente. Nella seconda ipotesi sono senz’altro configurabili controinteressati in senso sostanziale, poiché l’oggetto del giudizio non è il mero inadempimento dell’amministrazione, bensì il provvedimento che l’amministrazione sarebbe tenuta ad adottare in seguito alla decisione di accoglimento del ricorso. Il tema del controinteressato in senso sostanziale acquisisce una rilevanza ancora maggiore quando si consideri l'ambito delle materie di giurisdizione esclusiva. Per tali materie, il giudizio non ha necessariamente carattere impugnatorio, pertanto, può strutturalmente mancare la possibilità di ancorarsi al criterio formale della individuabilità sulla base del provvedimento impugnato. Il controinteressato sostanziale non accede al processo in base alle regole processuali dettate per il controinteressato in senso formale, parte necessaria. Ciò non significa, tuttavia, che ai controinteressati sostanziali sia del tutto preclusa la possibilità di partecipare nel processo attraverso altri meccanismi processuali. Per il primo grado di giudizio al controinteressato in senso sostanziale non resta che ricorrere allo strumento dell’intervento volontario. Il codice (all’art. 28), stabilendo genericamente che “chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire”, non pone alcun limite alla individuazione di posizioni legittimanti e in questo senso rappresenta uno strumento surrettizio di integrazione del contraddittorio. La giurisprudenza ha, tuttavia, mostrato nel tempo aperture in favore di una lettura sostanziale della posizione del controinteressato per quanto concerne la legittimazione ad appellare e, più in generale in relazione alle impugnazioni. Secondo la giurisprudenza sono legittimati a proporre appello contro la sentenza di annullamento coloro che, anche se non siano stati propriamente controinteressati nel giudizio di primo grado, o vi abbiano partecipato in qualità di interventori volontari, abbiano tuttavia un apprezzabile interesse al mantenimento dell'atto impugnato. Si è, inoltre, riconosciuta la possibilità di proporre appello anche a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, purché si tratti di soggetti “portatori di una situazione di vantaggio in ordine ad un bene della vita dipendente dal potere amministrativo cui quel bene e soggetto, ma dotato di autonomia”. 8. Il principio dell’integrità dei contraddittorio e l’integrazione iussu iudicis Il contraddittorio esprime la posizione di eguaglianza delle parti del processo in ordine alla possibilità astratta di contribuire all’elaborazione del contenuto della sentenza. Esso mira, in via generale, a garantire che le parti di un processo siano poste in condizione di contribuire in modo paritario alla formazione della decisione del giudice, partecipando a tutte le fasi del processo. Il principio dell'integrità del contraddittorio esige, in generale, che prendano parte al giudizio tutti i soggetti sui quali la pronuncia del giudice è destinata a produrre effetti. Il principio è, quindi, soddisfatto se tutti i soggetti coinvolti siano messi in condizione di prendere parte al giudizio, perché il contraddittorio (effettivo) nel processo amministrativo è sempre e soltanto eventuale, potendo il giudizio giungere alla sua conclusione anche in assenza della costituzione in giudizio delle parti diverse dal ricorrente. D'altronde, trattandosi di un processo da ricorso, l’atto introduttivo non è una vocatio in ius ma una vocatio iudicis, ossia un atto con il quale si chiama il giudice a provvedere sull’oggetto della domanda. Nel processo amministrativo l'integrità del contraddittorio è affidata, in prima battuta, alla parte ricorrente, cui è affidato il compito di realizzare un contraddittorio “minimo” al momento della instaurazione del giudizio, mentre la partecipazione al giudizio degli altri controinteressati dipende da un ordine del giudice, volto ad integrare il contraddittorio. Art. 49: “Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”. Bisogna chiedersi, in primo luogo, se l’integrazione del contraddittorio iussu iudicis rientri nella piena discrezionalità del giudice amministrativo, o debba “colorarsi” di doverosità. Sembra che, in ossequio alle esigenze di completezza del contraddittorio, l’integrazione iussu iudicis debba intendersi come poteredovere del giudice, soprattutto se si consideri il rinnovato vigore del principio del contraddittorio per effetto dell'espressa menzione nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. e per la rilevanza ad esso conferita all'interno del Codice. In quest'ottica, va condivisa l’affermazione secondo la quale il rispetto del canone del contraddittorio assuma il valore di precetto anche nei confronti del giudice, il quale dovrà ordinare l’integrazione del contraddittorio, per evitare di emanare una sentenza a contraddittorio non integro. La norma introduce, tuttavia, un vulnus alla pienezza del contraddittorio, stabilendo che il giudice non debba procedere alla sua integrazione “nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato”. In secondo luogo, è necessario chiarire quale ampiezza abbia tale potere-dovere. Bisogna stabilire, cioè, se l’ordine di integrazione del contraddittorio debba riferirsi ai soli controinteressati formali o se possa estendersi ai controinteressati in senso sostanziale. Il principio dell’agevole identificabilità dei controinteressati, teso evidentemente a limitare gli obblighi del ricorrente, è stato inteso dal giudice amministrativo come limite della propria funzione di integrazione del contraddittorio. In quest’ottica, la giurisprudenza del giudice amministrativo ha operato un sostanziale svuotamento della funzione integratrice affidatagli dalla legge disponendo (raramente) l’ordine di integrare le notifiche solo nei confronti dei controinteressati individuabili sulla base dell’atto. Lo strumento dell’integrazione iussu iudicis andrebbe, quindi, potenziato nella duplice direzione di ritenere doveroso per il giudice l'ordine di estendere le notifiche e di ampliare l’ambito di applicazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio anche ai controinteressati intesi in senso sostanziale. Nella direzione di un potenziamento degli strumenti di integrazione del contraddittorio sembra essersi mosso il legislatore con l’introduzione nel Codice dell’intervento per ordine del giudice. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritenga opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento secondo le modalità previste. Viene, così, introdotto il c.d. intervento coatto, mediante la previsione di un potere sicuramente discrezionale del giudice, il quale d’ufficio o su istanza di parte ordina l'intervento in funzione integrativa del contraddittorio. L’analisi degli orientamenti giurisprudenziali e l’esame delle disposizioni introdotte con il Codice non sembra aver accolto l’esortazione della dottrina “di fare del processo amministrativo un processo in cui si discuta della legittimità sostanziale”, partendo dal principio secondo cui non vi è sostanziale diversità tra l’interesse al bene del ricorrente e quello del controinteressato, il quale va individuato anche in base al criterio sostanziale di chi abbia comunque interesse alla contestazione. 9. I cointeressati Parti non necessarie del processo sono i cointeressati: soggetti titolari di un interesse della stessa natura di quello del ricorrente. Qualora più soggetti siano lesi da un provvedimento amministrativo, non è necessario che propongano ricorso congiuntamente, né sussiste l’obbligo di chiamarli in giudizio. Si afferma, in tal senso, che nel processo amministrativo non si diano ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato attivo. È stato osservato, tuttavia, che quando il giudizio non abbia carattere impugnatorio e si versi, dunque, nell’ambito della giurisdizione esclusiva su diritti, possano darsi casi di litisconsorzio necessario, quando la decisione non possa che pronunciarsi in confronto di più parti, e sussista, di conseguenza, l’obbligo per il giudice di integrare il contraddittorio. Ulteriori ragioni militano a favore della tesi che nega ai cointeressati la veste di parti necessarie. In caso di mancata partecipazione al giudizio da parte del cointeressato, questi non può subire un pregiudizio maggiore di quello cagionatogli dal provvedimento da lui non impugnato. Si osserva, infatti, che il rigetto del ricorso lascia inalterata la sfera giuridica soggettiva del cointeressato, il quale potrebbe ottenere un vantaggio dall’eventuale annullamento di un atto inscindibile. I cointeressati, dunque, accederanno al giudizio amministrativo solo in quanto propongano autonoma impugnativa, entro il termine decadenziale, avverso il provvedimento lesivo. Una diversa soluzione consentirebbe una ingiustificata elusione del termine di decadenza. La giurisprudenza in genere esclude che i cointeressati possano partecipare al processo attraverso lo strumento dell’intervento, poiché sono titolari di una posizione autonoma ed equiparata a quella del ricorrente e non dipendente dall’oggetto del giudizio. Ma se la ratio dell'esclusione è quella di impedire l'elusione del termine di decadenza, non vi è ragione per impedire l’intervento dei cointeressati quando sia proposto prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso. L’art. 28 consente l’utilizzo dello strumento dell’intervento per i cointeressati, ma conferma il necessario rispetto del termine per la proposizione del ricorso. 10. La difesa in giudizio delle parti Dinanzi al giudice amministrativo sussiste per le parti private l’obbligo del patrocinio di un avvocato, il quale dovrà essere abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per i giudizi di fronte al Consiglio di Stato. Se la parte non elegge domicilio nel comune dove ha sede l’ufficio giudiziario, il domicilio si intende eletto presso la segreteria dell’ufficio stesso. Il legale, dunque, assiste la parte in giudizio, ma non occorre che ne abbia la rappresentanza. Sebbene le norme processuali parlino indifferentemente di “procura” o “mandato”, si tratta di due concetti distinti: il mandato è il contratto tra i due soggetti coinvolti (avvocato e mandante); mentre la procura è il negozio unilaterale con cui il mandante (la parte) conferisce al procuratore i poteri necessari per l'espletamento del mandato. Sotto il profilo processuale ciò che viene in rilievo è, dunque, la procura perché è questa che determina la concreta misura dello ius postulandi (e dunque dei poteri) del difensore. La procura alle liti può essere generale o speciale. Il conferimento può avvenire a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, o, più di frequente, con una procura posta a margine o in calce al ricorso medesimo, o su un foglio separato ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce. Mentre nel caso di conferimento di procura generale il ricorso deve essere sottoscritto anche dal ricorrente, nel caso di procura speciale che conferisce al difensore la rappresentanza, il difensore è legittimato a sottoscrivere il ricorso in via esclusiva. Se la procura viene rilasciata con atto separato, deve contenere l’indicazione specifica del suo oggetto e degli elementi identificativi del provvedimento da impugnare o della pretesa fatta valere. In tema di procura alle liti il Codice, stabilisce espressamente che essa “si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto”. La procura non comprende, tuttavia, la proposizione delle impugnazioni, dovendosi ritenere applicabile l’art. 83 c.p.c., che stabilisce che la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo, salvo diversa statuizione. La procura si estingue “volontariamente” per revoca da parte del mandante o per rinuncia da parte del procuratore. Tali atti non hanno effetto “nei confronti dell’altra parte” finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore; né determinano l’interruzione del processo. Casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore: si tratta dei giudizi in materia di diritto di accesso, per i quali il privato può stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore e l’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato; dei giudizi in materia elettorale; dei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Si applicano, inoltre, le disposizioni relative al gratuito patrocinio per i non abbienti e al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie materia di lavoro. Al pari delle parti private, anche per le amministrazioni pubbliche nei giudizi amministrativi sussiste l’obbligo del patrocinio di un avvocato. Le amministrazioni statali sono rappresentate, salvo ipotesi eccezionali, dall’Avvocatura dello Stato, della quale possono avvalersi anche le Regioni, tranne che nelle controversie contro lo Stato stesso. Al di fuori delle ipotesi di difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, va osservato, in generale, che ogni amministrazione che sia dotata di una struttura legale interna deve, in via prioritaria, avvalersi di tale struttura per la difesa in giudizio. Soltanto in via gradata è ammesso il ricorso a professionisti esterni. Il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all’amministrazione, appare legittimo soltanto allorché siano rispettate alcune limitazioni di ordine normativo e giurisprudenziale. Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali, nel caso in cui lo statuto affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, quest’ultimo, ove ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, o attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro, salve ovviamente le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente può stare in giudizio senza il ministero di un legale. PARTE V Capitolo l: I presupposti e le condizioni dell’azione l. I presupposti processuali e le condizioni dell’azione I presupposti processuali “stanno prima” della decisione di merito, nel senso che si tratta di elementi necessari perché possa affrontarsi il merito, consentendo l’instaurazione del rapporto processuale, ma che non influenzano la concreta decisione; una volta accertata la sussistenza dei presupposti, il giudice può affrontare la decisione nel merito che, però, non è influenzata da essi. Gli effetti giuridici propri dei presupposti consistono nel permettere che si possa esprimere il giudizio sul merito che, non essendo influenzato dai presupposti, non è pregiudicato dalla mancanza dei presupposti stessi. Ciò comporta che la carenza dei presupposti non impedisce la riproposizione della domanda, non essendo intervenuta alcuna decisione in merito. Dunque, i presupposti, così intesi, hanno una connotazione giuridica precisa che li rende utili per la conoscenza ai fini della scienza giuridica. Le condizioni dell’azione stanno pur esse prima della decisione nel merito ma, a differenza dei presupposti, attengono alla pretesa e quindi sono espressione di regole sostanziali, con la conseguenza che la loro mancanza incide sulla pretesa sostanziale, non consentendo di ottenere una sentenza favorevole. Ciò impedisce la riproposizione della domanda. Sia i presupposti che le condizioni dell’azione “stanno prima” della decisione in merito, ma i primi sono disciplinati dalle norme processuali e il loro difetto consente di riproporre l’azione, mentre le seconde sono regolamentate dalle norme sostanziali riguardanti la pretesa, per cui se non ci sono, si consuma anche l’azione che non è riproponibile, ancorché il giudice non abbia emesso una decisione sul merito. I presupposti processuali devono sussistere al momento in cui il ricorso viene proposto, valendo a consentire l’instaurazione del rapporto processuale; le condizioni dell’azione devono sussistere anche al momento della decisione, riguardando la pretesa sostanziale. I presupposti processuali, riguardano: la giurisdizione e la competenza; la capacità ad essere parte e la capacità processuale. Le condizioni dell’azione: la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso; gli atti impugnabili; il silenzio. 2. La giurisdizione e la competenza: cenni e rinvio La giurisdizione è l’insieme dei poteri cognitori, cautelari, istruttori e decisori che vengono attribuiti ad un ordine giurisdizionale. Nelle controversie in cui è parte la p.a., vi sono due ordini giurisdizionali che hanno giurisdizione in via generale: il giudice ordinario ed il giudice amministrativo. L'erronea individuazione del giudice comporta una pronunzia di difetto di giurisdizione. Le norme disciplinanti il riparto hanno natura processuale e riguardano la corretta instaurazione del rapporto processuale, per cui costituisce un presupposto la cui mancanza consente la riproposizione dell’azione innanzi al giudice avente giurisdizione. La competenza è una misura organizzativa per distribuire, in base a regole predeterminate, la giurisdizione tra i diversi giudici che compongono il medesimo ordine giurisdizionale. Sono le norme processuali a regolare la competenza ed il suo difetto comporta che il giudice concretamente adito dichiari la propria incompetenza, senza pregiudicare la pretesa sostanziale perché questo presupposto riguarda la corretta instaurazione del rapporto processuale, non il merito della controversia, consentendo all’interessato di riproporre la domanda innanzi al giudice competente. Nel giudizio amministrativo di primo grado (per il secondo grado non si pone problema di competenza perché il giudice è unico, il Consiglio di Stato, con sede in Roma), la competenza tra i diversi T.A.R. è regolata essenzialmente per territorio, ed è, altresì, divenuta inderogabile con l’entrata in vigore del Codice. Ad ogni modo, l’errore nell’individuazione del T.A.R. competente rimane privo di conseguenze in ordine alla tutela della situazione giuridica soggettiva che viene fatta valere innanzi al T.A.R. competente, senza alcuna preclusione, purché intervenga la tempestiva riassunzione innanzi al competente T.A.R. 3. La capacità di essere parte e la capacità processuale Le parti possono stare in giudizio solo se hanno la capacità cioè l'attitudine ad essere soggetti di un rapporto giuridico processuale e, quindi, sono dotate di capacità processuale, innanzitutto, le persone fisiche e giuridiche, ma anche le altre figure soggettive che vanno considerate soggetti di diritto come le associazioni non riconosciute, gli enti di fatto, gli “organismi di diritto pubblico” di matrice comunitaria. Dunque, la capacità ad essere parte è la trasposizione in chiave processuale della capacità giuridica. Se non si è soggetti di diritto non si può ricorrere, né resistere, né assumere le vesti delle altre parti del giudizio. La mancanza di tale presupposto non consente al giudice di affrontare il merito, ma deve fermarsi a constatare che non vi è una parte che possa avere l’attitudine ad essere titolare del diritto di azione. In questo caso, è difficile pensare agli effetti propri del presupposto processuale e cioè alla possibilità di ripetere la domanda quando la carenza della capacità ad essere parte riguardi il ricorrente dal momento che, se non è soggetto di diritto, non potrà lamentare la lesione di una situazione giuridica soggettiva di cui non potrà mai essere soggetto attivo (o passivo). Invece, sarà possibile riproporre la domanda se il difetto della capacità ad essere parte riguardi le altre parti, individuando la figura soggettiva cui, ad esempio, va attribuito il comportamento lesivo. La capacità processuale, invece, è la capacità a stare in giudizio che coincide con la capacità di agire, di esercitare i propri diritti. Dovranno osservarsi le regole proprie di ogni figura soggettiva che disciplinano la possibilità giuridica di far valere le proprie ragioni, quale che sia la posizione processuale in giudizio. Anche qui si è fuori dalla considerazione del merito della controversia, dovendo il giudice valutare la capacità processuale dei soggetti che costituiscono il rapporto processuale e la mancanza di questo presupposto consente di riproporre la domanda. La ripetizione della domanda nell’ipotesi della mancanza della capacità ad essere parte o della capacità processuale sarà nella pratica inattuabile in presenza di azione volta a tutelare la lesione di interessi legittimi. 4. La legittimazione ad agire e le legittimazioni formali La legittimazione ad agire individua il soggetto cui spetta il diritto di azione ed il soggetto nei cui confronti va esercitata l'azione. Il soggetto legittimato ad agire coincide normalmente con il titolare della situazione giuridica sostanziale, ma vanno considerate le ipotesi in cui è possibile far valere in giudizio un rapporto intercorrente tra altre persone (azione di surrogazione ex art. 2900 c.c.), per cui non può procedersi alla totale assimilazione tra legittimazione attiva e titolarità della situazione giuridica sostanziale. La verifica della legittimazione va fatta in relazione all’affermazione del ricorrente, dal momento che è legittimato chi affermi di aver subito la lesione della situazione giuridica soggettiva, non chi l’abbia effettivamente subita perché quest’ultima è la conclusione del processo. Il giudizio, infatti, tende ad accertare proprio se vi sia stata effettivamente l’illegittima lesione della situazione giuridica sostanziale, mentre la legittimazione si muove sul piano dell’individuazione dei soggetti che devono assumere il ruolo delle parti nel processo. Quindi, si procede alla verifica della legittimazione in base a quanto affermato dal ricorrente e senza che ciò possa pregiudicare o influenzare la decisione nel merito. La legittimazione ad agire, però, non ha il trattamento del presupposto. Infatti, se si affermi che il ricorrente non ha legittimazione attiva, questi non può riproporre l’azione perché il giudice ha escluso che sia il soggetto cui spetti il diritto di azione. L’assenza di legittimazione attiva esclude la possibilità di esercitare l’azione e di ripeterla, per cui incide sulla pretesa sostanziale, non consentendo di poter ottenere una sentenza favorevole nel merito. Il difetto di legittimazione attiva, impedisce la riproposizione della domanda e, quindi, è da ascrivere tra le condizioni dell’azione e non tra i presupposti. Si può obiettare che il soggetto effettivamente legittimato potrebbe riproporre la domanda, ma si tratta di altro soggetto e, quindi, di altro ricorrente. A diversa conclusione si deve giungere per il difetto di legittimazione a contraddire: qui il ricorrente ha male individuato il resistente o il controinteressato per cui, in astratto, è possibile che il soggetto che assuma di aver subito la lesione ripeta la domanda nei confronti di colui che è legittimato passivo, secondo gli effetti propri del presupposto sempre, ovviamente, se sarà in concreto consentito, stante il termine di decadenza di sessanta giorni per la tutela dell'interesse legittimo. In conclusione, la legittimazione avrebbe un doppio trattamento: quello delle condizioni dell'azione per la legittimazione ad agire; quello dei presupposti, per la legittimazione a contraddire. L’individuazione del legittimato ad agire non incontra difficoltà quando si sia in presenza di un interesse individuale e differenziato appartenente ad una figura soggettiva che lo voglia far valere in giudizio. La nostra società presenta interessi, economici e non, che trascendono la sfera dei singoli e che possono trovare un punto di aggregazione in un ente esponenziale (pubblico) che lo cura come specifico interesse pubblico (ordini professionali che curano gli interessi collettivi delle rispettive categorie professionali) o possono essere diffusi tra i soggetti, appartenendo a tutti indistintamente. In quest’ultimo caso, può accadere che se ne renda interprete un gruppo, più o meno esteso, che si organizzi in un'associazione, una figura soggettiva che coltivi lo specifico interesse, anche se il medesimo interesse sia già curato dallo Stato come interesse pubblico. Questi fenomeni aggregativi volti alla tutela di interessi che, altrimenti, presenti allo stato diffuso non avrebbero uno specifico soggetto che li curi, sono molto presenti nella realtà contemporanea e si è posto il problema della loro legittimazione ad agire per la tutela degli interessi di cui sono portatori. In alcuni casi è intervenuta la legge per attribuire la legittimazione attiva, come per le associazioni protezionistiche, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi della legge istitutiva del ministero dell’ambiente, dopo l'intervento di decisioni contrastanti della giurisprudenza circa la legittimazione. La tesi che esclude la legittimazione attiva fa perno sul fatto che degli interessi generali ed indifferenziati non possono trasformarsi in interessi legittimi perché inseriti nei fini statutari ed istituzionali di questi organismi, ma vi è, ormai, una tendenza a ritenere legittimate le figure soggettive che, in base alla formalizzazione nello statuto o in altro atto costitutivo, pongano gli interessi, per i quali invocano tutela, tra i loro fini fondanti. Va, però, detto che sembra andare verso una soluzione opposta il legislatore che, dopo la legge istitutiva del ministero dell’ambiente, ha seguito il principio della formalizzazione “amministrativa” anche per le associazioni di utenti di servizi pubblici a cui il giudice amministrativo pare adeguarsi. 5. L’interesse al ricorso L'interesse al ricorso è: l’utilità concreta che la sentenza favorevole può recare alla situazione giuridica soggettiva di cui si affermi la lesione; l’elemento necessario in un processo istituito per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive ed esalta il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa perché riconosce l’azione e ne consente il promuovimento solo a colui che ne ha interesse, che ritrae, cioè, una concreta utilità dalla sentenza favorevole: l’azione è data per la tutela della situazione giuridica soggettiva e solo se la decisione favorevole può recare un’obiettiva utilità il ricorso è ammissibile; una nozione che pone in relazione due profili: utilità della sentenza favorevole e lesione dell’interesse sostanziale. L’interesse al ricorso deve essere: - personale, deve riguardare direttamente il ricorrente; - diretto, cioè la lesione deve derivare immediatamente dal provvedimento impugnato o, nei giudizi nei quali non vi è impugnativa di atti amministrativi, dal comportamento contestato; - attuale, per cui occorre che la lesione dell’interesse: a) sia già avvenuta; b) non richieda l’emanazione di provvedimenti successivi; c) non dipenda da avvenimenti futuri ed incerti; d) venga “riparata” dalla sentenza; e) sussista al momento della decisione. Quando il giudice dichiara la carenza di interesse al ricorso, non valuta il merito della controversia, ma considera un profilo che attiene alla pretesa, perché stabilisce che l'eventuale sentenza favorevole non è in grado di soddisfare l'interesse sostanziale che si assume leso. Un tale giudizio non consente la riproposizione della domanda. L’interesse a ricorrere deve sussistere sino al momento della decisione. Dunque, si annovera tra le condizioni dell’azione. 6. Gli atti impugnabili Sino alla legge sui T.A.R., il ricorso era ammesso solo contro l’atto amministrativo definitivo e cioè occorreva che l’interessato doveva previamente esperire i ricorsi in via gerarchica sino all’ultimo grado della gerarchia, prima di rivolgersi al giudice amministrativo. Non occorreva che il provvedimento fosse definitivo se: emanato già da un’Autorità al massimo grado della gerarchia amministrativa (Ministro); adottato da organi non soggetti a gerarchia (organi collegiali), dichiarati definitivi dalla norma. Dopo la legge sui T.A.R., può essere impugnato anche un atto non definitivo, essendo divenuta facoltativa la previa presentazione di ricorso gerarchico, peraltro possibile per un solo grado. Quando è necessario impugnare un atto amministrativo nel giudizio di annullamento per la tutela dell'interesse legittimo, è da considerare che non tutti gli atti amministrativi sono impugnabili perché, per esserlo, devono produrre effetti all’esterno e ledere l’interesse del ricorrente in via personale, diretta ed attuale; altrimenti non è possibile chiederne l’annullamento. L’impugnabilità rileva sotto il profilo dell’interesse a ricorrere ed allora è impugnabile il provvedimento amministrativo che decide in ordine all'interesse pubblico di cui l’amministrazione è attributaria e produce effetti nei confronti dei destinatari dell’atto e dei terzi, per cui il provvedimento deve essere efficace, non potendo il ricorrente chiedere l’annullamento di un atto inefficace che non lede in maniera attuale l’interesse sostanziale. Non sono impugnabili gli atti endoprocedimentali, accessori, prodromici, preliminari, istruttori, che svolgono nel procedimento una funzione, per così dire, preparatoria del provvedimento su cui “scaricano” eventuali profili di illegittimità. È consentita l’impugnativa anche di atti non aventi natura provvedimentale poiché il principio è l’ammissibilità di domande di annullamento di atti che, comunque, rechino al ricorrente una lesione personale diretta ed attuale dell’interesse sostanziale. E, viceversa, non è ammessa l’impugnativa di provvedimenti, se favorevoli, perché non lesivi dell’interesse sostanziale. Ciò spiega perché nei procedimenti concorsuali (nel pubblico impiego, nelle gare ad evidenza pubblica), normalmente è impugnabile l’atto conclusivo del procedimento che approva gli atti e nomina i vincitori o aggiudica l’appalto, mentre il soggetto escluso deve impugnare l’atto che lo ha messo fuori concorso, stante l’immediata lesività dell’interesse sostanziale. Non sono impugnabili: - gli atti esecutivi che eseguono materialmente quanto stabilito in un precedente provvedimento, di per sé lesivo e, quindi, immediatamente impugnabile e che continuerebbe a produrre effetti; - gli atti conseguenziali o presupponenti, se mero svolgimento di atti presupposti, non impugnati, ed ai quali sono legati da un nesso di presupposizione così intimo che non possono produrre effetti se venga meno l’atto presupposto; in questo caso, l’annullamento dell'atto presupposto ha effetto caducante sugli atti conseguenziali. Gli atti conseguenziali sono, invece, impugnabili (e devono essere autonomamente impugnati) se producono una serie di effetti distinti rispetto all’atto presupposto. L'efficacia, però, va considerata sempre in relazione alla lesione dell'interesse; - gli atti regolamentari che, contenendo norme generali ed astratte, non determinano una lesione attuale e concreta dell’interesse dei possibili destinatari: sono impugnabili insieme agli atti che applicano le norme poiché solo allora sorge l’interesse al ricorso; - gli atti confermativi di precedenti atti perché il loro annullamento non soddisferebbe l’interesse la cui lesione è stata già prodotta dagli atti confermati non più impugnabili per decorso del termine di impugnativa; - gli atti di proroga se il ricorso riguarda l’assetto degli interessi determinato dall’atto prorogato (non impugnato); l’impugnazione è ammissibile, se si assume l’illegittimità, in sé, della proroga. L’indicazione degli atti è esemplificativa; non è esclusa l’individuazione di altre figure nel fluire dell’esperienza amministrativa. Nel giudizio di annullamento per la tutela dell’interesse legittimo, la mancata impugnativa dell'atto amministrativo o la impugnativa di atto non lesivo della situazione giuridica soggettiva (non impugnabile) rende il ricorso inammissibile. Anche in questo caso il giudice non decide sulla sostanza della controversia, ma su una questione che “sta prima" del merito. L’impugnabilità attiene all'interesse al ricorso e, quindi, alla pretesa, per cui devono considerarsi condizione dell’azione. 7. Il silenzio Quando nel giudizio di annullamento era necessario impugnare l’atto amministrativo, i meri comportamenti della p.a. e la sua inerzia privavano di tutela l’interesse legittimo, specie quando il ricorrente ambisse ad un provvedimento che gli consentisse di ottenere soddisfazione del suo interesse al conseguimento di un bene della vita (interessi legittimi pretensivi). La prima dottrina, nel tentativo di offrire tutela all'interesse legittimo anche quando l’amministrazione non adottava alcun provvedimento, ha qualificato l’inerzia come provvedimento: tacito, implicito, presunto, ritenendo che l’assimilazione del silenzio all’atto potesse superare il dato formale della necessaria impugnativa del provvedimento amministrativo. Il silenzio veniva così costruito come atto di rifiuto, provvedimento negativo. La considerazione, però, della funzione amministrativa, dell'esercizio (doveroso) del potere, dei caratteri dell’azione autoritativa della p.a. ha indotto la dottrina ad affermare con chiarezza che il silenzio è un fatto “patologico” nel dispiegamento dell’azione amministrativa. Il silenzio può divenire significativo in relazione all’espressa previsione normativa che può attribuirgli effetti positivi (silenzio-assenso) o effetti negativi (silenzio-diniego). Nelle ipotesi di effetti tipizzati del silenzio, l’interessato potrà ricorrere al giudice amministrativo chiedendo l’annullamento del silenzio-assenso o del silenzio-diniego, con le medesime problematiche, quanto a questa seconda evenienza, delle sentenze di annullamento dell’atto negativo. In mancanza di espresse previsioni normative che tipizzino il silenzio, la regola è che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio della p.a. “equivale a provvedimento di accoglimento della domanda”, ad eccezione dei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità ed i casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché quando la legge qualifichi il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti, individua, con decreto, gli atti ed i procedimenti per i quali il silenzio non vale accoglimento. In presenza di silenzio non significativo, l’interessato può chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo di provvedere quando l’amministrazione non concluda nei termini il procedimento amministrativo. Si parla in tale ipotesi di silenzio-inadempimento o silenzio-rifiuto che è così disciplinato positivamente: il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all'Amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, stabilito in trenta giorni, qualora le Amministrazioni non abbiano determinato, in via generale, il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento. Capitolo 2: Lo svolgimento del processo di primo grado Sezione prima: La fase introduttiva I. Il ricorso introduttivo Anche nel processo amministrativo vige il principio della domanda e dell’impulso di parte. La domanda giudiziale assume, nel processo amministrativo, la forma del ricorso, proveniente dalla persona che invoca la tutela, ed è indirizzata al giudice competente. Il ricorso varia in ragione del tipo di azione che viene esperita. Il c.d. secondo correttivo ha inteso rafforzare (dandone concretezza) i principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali di parte di cui all’art. 3, c. 2, sostituendo l’art. 40 dedicato alla indicazione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio che si conferma essere il ricorso stante la perentorietà della formula di cui al successivo art. 41, c. 1. Infatti, pur senza modificare il contenuto del ricorso rispetto alla precedente disciplina, la novità legislativa oltrepassa il mero dato formale della “risistemazione” in lettere degli elementi (minimi) del ricorso, come sino a questo momento comunemente ricostruiti (ossia l’intestazione, l’epigrafe, le ragioni di fatto e i motivi di diritto su cui si fonda la domanda, l’indicazione dei mezzi di prova, le conclusioni, la data e la sottoscrizione). Nella versione attuale l’art. 40 afferma in termini di doverosità che i sette elementi del ricorso devono essere tutti presenti nell’atto di ricorso e, soprattutto, devono essere “distintamente” contenuti nell’atto introduttivo del giudizio. La doverosità di tale previsione è scolpita dal successivo c. 2 che appunto sanziona con la inammissibilità la violazione del mancato rispetto della indicazione “distinta” dei sette elementi del ricorso. Analoga “sanzione” è prevista anche per il mancato rispetto della previsione che impone la “indicazione specifica” dei motivi di ricorso. Nello specifico l’art. 40, dunque, ora prevede (appunto “distintamente”): “a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l'indicazione dei mezzi di prova; f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione della procura speciale”. A tali indicazioni va comunque sempre aggiunta, pena l’applicazione della prevista sanzione pecuniaria, la dichiarazione del valore della causa ai fini della quantificazione del “contributo unificato” che ha sostituito l’imposta di bollo, e la “pec” (indirizzo di posta elettronica certificata) del difensore. Il ricorso va, quindi, indirizzato al giudice che si intende adire e che sarà costituito dal Tribunale amministrativo individuato secondo le regole della competenza. La denominazione del giudice cui è rivolto il ricorso costituisce un elemento necessario (sebbene non espressamente previsto a pena di nullità) in quanto le controparti devono essere poste in grado di conoscere presso quale autorità giudicante verrà instaurato il rapporto processuale. Il T.A.R. che non si ritiene competente deve rilevarlo d’ufficio. Ad ogni modo la mancata o erronea indicazione, nell’intestazione del ricorso, della sede staccata o del capoluogo regionale non sembrano costituire, però, invalidità in quanto la distinzione tra le sezioni va intesa come mera suddivisione organizzativa di uffici, irrilevante sotto il profilo della competenza. In tali ipotesi, il giudice adito, anche se erroneamente indicato, deve solo ordinare la rinnovazione della notifica per consentire alle parti di costituirsi presso la sede in cui il ricorso è stato correttamente depositato. Nell’epigrafe del ricorso, vanno inseriti “gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto”. Vi deve essere il codice fiscale e la partita Iva, nonché per le persone giuridiche l’indicazione dell’organo che ha la rappresentanza in giudizio. Vi deve anche essere l’indicazione delle parti alle quali il ricorso è notificato, le quali, pertanto, devono essere chiaramente evincibili dall'epigrafe del ricorso e non solo nella relata di notifica. Occorre indicare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito del fax del difensore a cui gli interessati intendono ricevere le comunicazioni. La parte può eleggere domicilio nel comune ove ha sede il Tribunale adito. In mancanza, si intende che il domicilio sia stato eletto presso la segreteria del T.A.R. adito. Le modifiche del domicilio eletto devono poi essere notificate perché abbiano rilevanza giuridica. L’epigrafe deve contenere “l’indicazione dell’oggetto della domanda, compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza”. Non occorre che siano riportati tutti gli estremi identificativi dell’atto impugnato, essendo sufficiente che esso possa essere in qualche modo identificato in maniera inequivocabile anche sulla base di elementi diversi dalla data o dal numero di protocollo. Prima dell’introduzione dell'istituto dell’accesso ai documenti amministrativi, il privato, anteriormente all’instaurazione del giudizio, non era posto nella condizione di conoscere gli estremi identificativi dell’atto che si assumeva lesivo, ed era diffusa, pertanto, la prassi della proposizione del ricorso c.d. al buio. Il ricorrente, nell’ipotesi in cui intenda far valere, nei confronti dell’atto impugnato, motivi di illegittimità derivata da altri atti connessi o presupposti, sarebbe tenuto, di regola, ad indicarli espressamente nell’epigrafe del ricorso. L’identificazione degli atti impugnati deve essere operata in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal ricorso complessivamente considerato e da ogni altro elemento utile, e, dunque, anche dall’indicazione delle ragioni di fatto e dai motivi di impugnazione prospettati, nonché dalle conclusioni rassegnate, ed ancorché l'atto impugnato sia stato indicato in modo non preciso o erroneo. Il Codice, nel richiedere l’indicazione della data in cui il provvedimento è stato notificato, comunicato o conosciuto, ha recepito la giurisprudenza che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, equipara la data della conoscenza ufficialmente ricevuta mediante la notifica del provvedimento a quella della conoscenza aliunde. Nell’ipotesi di azioni di accertamento, sganciate dalla proposizione in via contestuale dell'azione di impugnazione di un atto amministrativo, l'epigrafe non conterrà, ovviamente, indicazioni sul punto. Qualora si tratti, però, del rito avverso il silenzio di cui agli artt. 31 e 117 del Codice, il ricorso dovrebbe indicare, almeno, gli elementi d’identificazione del comportamento omissivo dell'amministrazione che si intende censurare, e, quindi, la prova dell’istanza inviata all'amministrazione, non essendo più necessaria la notifica dell’atto di diffida per l’azionabilità di questo tipo di giudizio. Considerata poi l'estensione dei poteri cognitori e decisori del giudice amministrativo, che può decidere anche sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, è evidente che il ricorso introduttivo dovrà essere arricchito di “informazioni” sulla fondatezza della (istanza e quindi) della domanda giudiziale. L’esposizione sommaria dei fatti consiste nella narrazione, chiara e sintetica, ma completa, in ossequio al principio della domanda, della realtà fattuale che è alla base dell’emanazione del provvedimento impugnato o, comunque, del comportamento tenuto dall’amministrazione che il ricorrente, secondo il suo punto di vista, assume lesivo della situazione soggettiva azionata in giudizio. La specificazione dei motivi di ricorso è espressamente prevista dalla legge a pena di inammissibilità, stante la perentorietà del c. 2 del citato art. 40. Anche se, dunque, non si dice espressamente che devono essere sintetici, comunque i motivi di ricorso devono oggi essere (oltre che distinti, anche) specifici. I motivi di ricorso, pertanto, devono essere contenuti nell’apposita parte del ricorso dedicata ad essi, risultando pro futuro vietata ogni commistione tra esposizione in fatto e motivi appunto “in diritto” ossia enucleanti gli articoli di legge o di regolamento che si assumono violati. I motivi di ricorso sono diretti, in sostanza, a qualificare giuridicamente la vicenda pregiudizievole della sfera giuridica del ricorrente (già esposta nel loro svolgimento storico), riconducendo i “fatti” ad un parametro legale che si assume violato. L’introduzione di un espresso obbligo di specificazione dei motivi di ricorso scaturisce dall’esigenza di elidere il rischio dei c.d. “motivi intrusi” che hanno, in concreto, ampliato moltissimo negli ultimi anni le ipotesi di errore revocatorio proprio per la difficoltà dei giudici e delle controparti di individuare correttamente tutti i motivi. Attraverso l’enunciazione dei motivi di ricorso, in sostanza, colui che agisce in giudizio individua la causa petendi, intesa come ragione o titolo posto a fondamento della domanda prospettata al giudice adito. Spetterà all’elaborazione giurisprudenziale l’individuazione (in concreto) del limite di “adeguatezza” della specificità dei motivi; ma, se contenuti nella parte in fatto, la inammissibilità sarà certa in quanto tale allocazione è in violazione dell’obbligo della indicazione “distinta”. In ogni caso il “motivo” non specifico non dovrebbe poter fondare (l’interesse a proporre) una azione in revocazione visto che nel giudizio rescissorio il motivo intruso andrebbe comunque dichiarato inammissibile. Nello specifico, va osservato che nelle azioni (costitutive) volte ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, il ricorrente assume che l’atto sia illegittimo, o che esso sia viziato da incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, e che sia pertanto “annullabile”. Al di là dei (pochi) casi di giurisdizione di merito, nei quali il parametro di riferimento è esteso anche alla verifica dell’opportunità dell'atto impugnato, nella giurisdizione generale di legittimità le censure sollevate dal ricorrente nei motivi di ricorso corrispondono, dunque, di regola, all’allegazione di altrettanti vizi del provvedimento impugnato. Al riguardo, però, va osservato che non tutti i vizi che colpiscono il provvedimento si traducono in motivi di ricorso; così come non sempre ogni motivo di ricorso costituisce un vizio dell'atto. Da un lato, infatti, va precisato che il ricorrente è arbitro della controversia, nel senso che è libero di isolare, e far valere in giudizio, anche solo alcuni vizi da cui è colpito il provvedimento; così come può domandare al giudice un annullamento parziale dell'atto impugnato. In tali casi il giudice, in ossequio al principio dispositivo, dovrà astenersi, a meno di non incorrere in un vizio di ultrapetizione, dal rilevare motivi ulteriori e diversi da quelli dedotti dal ricorrente, o dall’adottare una sentenza di annullamento totale del provvedimento. Dall’altro lato, va osservato che, nella pratica redazione di un ricorso, la suddivisione “in motivi” prospettata dal ricorrente non corrisponde sempre all’indicazione di altrettanti vizi dell’atto impugnato, in quanto a volte alcuni dei motivi sono inidonei ad individuare una precisa censura, costituendo un “arricchimento” progressivo sul piano argomentativo di un medesimo vizio. Può accadere, inoltre, che vengano prospettate, quali motivi diversi di ricorso, diverse figure sintomatiche dell'eccesso di potere: se non si accoglie l'idea dell’autonoma rilevanza giuridica di tali figure sintomatiche, il ricorso risulterà fondato su un unico motivo di ricorso. In ogni caso, si ritiene che i motivi di ricorso non possono essere dedotti in forma del tutto generica, senza che, cioè, risulti alcuna specificazione del vizio di legittimità in cui sarebbe incorsa l’autorità amministrativa; né in forma ipotetica, in modo, cioè, da configurare un vizio dell’atto in base a mere supposizioni, a meno che ciò non derivi dalla mancata conoscenza del testo del provvedimento che viene, pertanto, impugnato “al buio”, ossia soltanto sulla base degli “effetti” noti al ricorrente. In quest’ultimo caso non sarà necessario proporre ulteriore ricorso contro l'atto formale conosciuto o emanato in corso di giudizio e avente quelle connotazioni individuate nella prospettazione originaria, in quanto il ricorso si intende proposto contro l’atto espresso ancorché abbia una veste formale diversa da quella ipotizzata in ricorso. Si ritiene adeguata la deduzione, quale unico motivo di ricorso, della invalidità riflessa che colpisce l’atto amministrativo per incostituzionalità della legge costituente il presupposto normativo sottostante all'emanazione dell'atto medesimo. L’omessa indicazione, o l’indicazione erronea o lacunosa, degli articoli di legge violati non rendono però nullo il ricorso, a meno che non sia possibile in alcun modo, individuare le specifiche censure mosse al provvedimento impugnato. Né il motivo di ricorso può essere successivamente “integrato” e sanato dalla presentazione di una memoria successiva che lo specifichi e magari anche lo ampli. In ogni caso non assume rilevanza la qualificazione del vizio data dalla parte, a cui il giudice non è affatto vincolato; più precisamente, l’errore in cui incorre il ricorrente nell’individuazione della fonte vincola il giudice solo quando sia la fonte stessa ad essere denunciata di illegittimità o, nel caso di una fonte primaria, su di essa sia formulato il sospetto di incostituzionalità, mentre, al contrario, sussiste l’obbligo di ricercare se effettivamente sussista la regola invocata e da quale fonte debba essere rinvenuta. Le diverse caratteristiche dei vizi di legittimità degli atti amministrativi, sotto il profilo del tipo di giudizio (sintetico o sintomatico) che impongono al giudice, non rendono agevole l’individuazione del contenuto minimo dell’onere di allegazione che il ricorrente deve soddisfare perché la domanda possa considerarsi ritualmente proposta. Per quanto riguarda la violazione di legge, il vizio può dirsi adeguatamente individuato dal riferimento alla disposizione violata; ma se l’indicazione è errata, ciononostante il ricorso sarà ammissibile se dal contesto generale è desumibile il dato normativo della cui inosservanza il ricorrente si duole. Per quanto riguarda l’eccesso di potere, il richiamo alle figure sintomatiche e i limiti al sindacato sulla discrezionalità amministrativa non devono far pensare ad un’ampia elasticità in ordine alle modalità di deduzione di tali censure. Se, infatti, il ricorrente svolge censure che impongono apprezzamenti di fatto, tali fatti devono essere indicati e non genericamente asseriti come esistenti. Quanto detto subisce qualche attenuazione a seguito delle modifiche in tema di annullabilità del provvedimento. Alla stregua di quanto disposto dall’art. 21 octies, infatti, per ottenere l’accoglimento del ricorso e, quindi, l’annullamento del provvedimento, il ricorrente è tenuto a dimostrare che il provvedimento è vincolato e in ogni caso, secondo un orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, che in assenza della violazione delle regole procedimentali di cui si duole, il provvedimento avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato. Secondo un indirizzo giurisprudenziale più rigido, il ricorrente dovrebbe allegare in giudizio gli elementi che avrebbe fornito all’amministrazione in sede procedimentale e solo in tal caso sorgerebbe in capo all’amministrazione l’onere di dimostrare che tali elementi non avrebbero mutato il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato. In dottrinaria è stata poi sostenuta l’insufficienza della allegazione dei soli vizi formali a sorreggere il ricorso senza l’allegazione di altri vizi sostanziali, essendo i primi assorbiti e superati dall’accertamento che il giudice svolgerebbe su questi ultimi. In ogni caso, non vi è ancora un’esatta definizione dei rapporti tra l'azione esercitata e i motivi dedotti a sostegno dell’azione medesima. Infatti, alla tesi che costruisce l’azione unicamente in funzione della proposizione dell’impugnazione di un atto, anche se diverse sono le censure prospettate, si contrappone un'altra tesi che individua un’azione per ciascuna censura proposta anche se è impugnato un solo atto. La giurisprudenza mostra di adagiarsi a volte sulla prima impostazione, come emerge dalla prassi dell’assorbimento dei motivi; altre volte sulla seconda, come in tema di ricorso incidentale e di legittimazione ad appellare in relazione ai diversi capi della sentenza. Il ricorso si chiude con la rassegnazione delle conclusioni, ove si indica il provvedimento richiesto al giudice. Le conclusioni, che racchiudono, dunque, quella che viene considerata la “domanda in senso stretto”, sono modulabili in relazione al tipo di azione esercitata. E così potranno aversi richieste di annullamento (anche parziale), di accertamento, di condanna, così come, nelle ipotesi di giurisdizione di merito, di riforma o sostituzione dell’atto impugnato. Nell’ipotesi di azioni miste, o di cumulo di più azioni, il ricorso presenterà conclusioni complesse, consistenti in più domande giudiziali. Il ricorso può sempre contenere, oltre alla richiesta di condanna alle spese della lite, anche domande accessorie, volte a stimolare gli incidenti cautelari o gli adempimenti istruttori e gli altri incidenti processuali quali la questione di legittimità costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. È stato anche chiarito dalla giurisprudenza nella vigenza della disciplina precedente che un’istanza non espressamente proposta dal ricorrente può ritenersi implicitamente dedotta in giudizio qualora sia in rapporto di necessaria connessione con il petitum e la causa petendi e non costituisca una estensione dell'ambito di riferimento. Il ricorso va sottoscritto in modo autografo dal difensore, con indicazione della procura speciale o dal ricorrente se esso sta in giudizio personalmente nei casi previsti e limitatamente al giudizio di 1°grado. La procura ad litem non è un elemento necessario per la validità del ricorso, potendo essere rilasciata anche a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio. Nella prassi è però frequente che essa venga rilasciata a margine o in calce al ricorso medesimo, ovvero su foglio separato ma materialmente congiunto (ad es. spillato) all’atto cui si riferisce. In questi casi la firma autografa del ricorrente è autenticata dallo stesso difensore. Quanto al regime delle invalidità, è prevista la nullità del ricorso nei casi di difetto di sottoscrizione o nei casi in cui l’inosservanza delle prescrizioni dettate nell’art. 40 determini incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda. Tali nullità, dopo il c.d. primo correttivo, sono rilevabili d’ufficio (fermo quanto previsto dall’art. 39, c. 2, che contiene il rinvio esterno al c.p.c.) in quanto determinano l'inammissibilità del ricorso e (nel silenzio della norma) dovrebbero continuare a essere non opponibili dalla parte che vi ha dato causa, e, nell’ipotesi di prescrizioni la cui violazione non determina la nullità del ricorso ma mere irregolarità, “il collegio può ordinare che il ricorso sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato”. La costituzione in giudizio dell’intimato determina comunque la sanatoria sia delle irregolarità di cui al c. 2, sia della nullità della notificazione per raggiungi mento dello scopo anche se la parte si costituisce al solo fine di eccepire della invalidità, con salvezza, però, dei “diritti acquisiti anteriormente alla comparizione”, come, ad esempio, del diritto di eccepire (altri) vizi del ricorso (originario) che ne determinano l’inammissibilità; e comunque non si estende anche ai vizi “dipendenti” da quelli appunto sanati. Il Codice, nel prevedere poi che la rinnovazione della notificazione è disposta solo se “l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificatore”, detta una regola opposta alla disciplina processualcivilistica che consente invece al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione in caso di convenuto contumace e di vizio della notifica. 2. Ricorso collettivo, ricorso cumulativo, pluralità delle domande, conversione delle azioni e riunione dei ricorsi Si parla di cumulo di azioni quando la domanda giudiziale è proposta da più soggetti attraverso un unico atto introduttivo (cumulo soggettivo); o quando in un unico atto introduttivo sono racchiuse più domande giudiziali (cumulo oggettivo). Il cumulo (soggettivo e oggettivo) di azioni è ammesso anche nel processo amministrativo. Quando più soggetti agiscono mediante un unico atto introduttivo del giudizio, si ha un ricorso collettivo. Quando, invece, con un unico atto si impugnano provvedimenti (formalmente) diversi, anche provenienti da amministrazioni diverse, che però disegnano congiuntamente un effetto lesivo per il ricorrente, si ha un ricorso cumulativo. Vi sono dei limiti individuati da dottrina e giurisprudenza in ordine alla proponibilità di ricorsi collettivi e ricorsi cumulativi. Il ricorso collettivo si realizza, oltre che nell'ipotesi in cui più soggetti impugnano lo stesso provvedimento, anche quando più soggetti impugnano un atto plurimo (pluralità di provvedimenti diretti a persone diverse), chiedendo, ciascuno, l’annullamento della parte che lo pregiudica (cioè del singolo provvedimento che lo concerne); nonché quando più soggetti, che si trovano nella medesima posizione giuridica (vantando identica situazione giuridica soggettiva), propongono, con un’unica azione, la medesima domanda giudiziale. Al fine, però, di evitare che l’azione cumulativa finisca per rivelare, in corso di causa, situazioni di conflitto d’interesse fra i vari ricorrenti, divenendo contraddittoria e difficilmente “scindibile”, il ricorso collettivo è esperibile solo a condizione che non vi sia conflitto d’interessi (attuale) fra i ricorrenti; e a condizione che la causa petendi (titolo su cui si fonda la domanda giudiziale) ed il petitum (contenuto della domanda, il fine che si persegue con l’azione) siano comuni a tutti i ricorrenti. Le condizioni di ammissibilità e di ricevibilità riguardanti ciascun singolo ricorrente non si comunicano agli altri; così come l’iniziativa processuale di un ricorrente non può giovare né pregiudicare la posizione dei consorti. Il ricorso cumulativo, si realizza, oltre che nell’ipotesi di impugnazione di provvedimenti diversi, anche quando si propongono più domande giudiziali differenti come, ad esempio, nell’ipotesi in cui si esercitano contestualmente un’azione impugnatoria e un’azione di condanna; e in ogni caso quando l’atto introduttivo del giudizio si fonda su più causae petendi. La giurisprudenza, pur ritenendo che l’ammissibilità dei ricorsi cumulativi debba essere valutata in termini di ragionevolezza o di giustizia sostanziale, in ogni caso richiede che i provvedimenti impugnati siano “connessi” o comunque che le controversie abbiano un qualche collegamento tra loro mentre invece la dottrina era favorevole alla proponibilità, nello stesso processo e con unico atto introduttivo, di più domande (contro lo stesso soggetto) anche non altrimenti connesse (“litisconsorzio facoltativo improprio”, fondato sulla “connessione impropria”). Si possono verificare in concreto ipotesi di coesistenza di cumulo soggettivo ed oggettivo: in tal caso il ricorso sarà collettivo e cumulativo. Il cumulo oggettivo di azioni si può verificare anche in corso di giudizio. 3. Il termine per la proposizione del ricorso. La notificazione La notifica del ricorso contenente un’azione di annullamento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il termine “previsto dalla legge” che, di regola, è di sessanta giorni. Tale termine decorre, nel caso di impugnazione di atti per cui è richiesta la notifica individuale, dalla notifica (comunicazione) del provvedimento; o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell’albo, sempre che, ovviamente, la pubblicazione sia stata ritualmente eseguita. Per l’impugnazione di atti per i quali non sia prevista la notifica ad personam, la pubblicazione determina la presunzione assoluta di conoscenza solamente se tale forma di pubblicità sia espressamente prescritta dalla legge. Si ritiene che se il provvedimento ha come destinatari soggetti nominativamente indicati, o comunque individuabili in base al suo contenuto, deve essere, di regola, notificato personalmente a ciascuno di essi. Per questi ultimi, dunque, il termine per impugnare dovrebbe decorrere dall’avvenuta comunicazione o notifica del provvedimento, e non dalla sua eventuale pubblicazione. La piena conoscenza del provvedimento è equipollente alla comunicazione o alla notificazione dello stesso. Da essa, dunque, decorre il termine decadenziale per l’impugnazione certamente in tutte le ipotesi in cui non siano previste forme di notificazione o comunicazione personale o forme di pubblicazione a meno che queste forme non siano richieste come condizione di efficacia dell’atto. Più complessa è invece la soluzione adottata nell’ipotesi in cui siano previste forme di comunicazione o di pubblicazione del provvedimento in quanto, secondo una parte della giurisprudenza, il termine per l’impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell’atto se quest’ultima viene acquisita anteriormente alla pubblicazione mentre invece, secondo l’orientamento opposto, in caso di pubblicazione obbligatoria del provvedimento, il meccanismo della conoscenza non rileverebbe. Non è stato affrontato il problema se la conoscenza di un atto acquisita dal difensore nel corso del giudizio possa o meno far presumere la conoscenza dello stesso da parte dell’assistito. In ogni caso la prova dell’avvenuta conoscenza, da parte del ricorrente, del provvedimento impugnato, incombe su chi eccepisce la tardività del ricorso; la prova dell’avvenuta pubblicazione incombe sulla p.a. che eccepisce la tardività del ricorso; la conoscenza piena (nel silenzio della disciplina) dovrebbe continuare a ritenersi integrata con l’effettiva cognizione quantomeno degli elementi essenziali del provvedimento e della sua portata lesiva, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti, ove dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano ulteriori profili di illegittimità. Il termine decadenziale di sessanta giorni non opera in sede di giurisdizione esclusiva, laddove, in particolare, il ricorrente lamenti la lesione di un diritto soggettivo. In tal caso l’azione è proponibile entro l’ordinario termine di prescrizione del diritto che si fa valere. Al fine di discernere le ipotesi di operatività del termine decadenziale da quelle in cui dovrebbe operare il termine di prescrizione, la giurisprudenza distingue fra cc.dd. “atti autoritativi” ed “atti paritetici”. Sono paritetici gli atti posti in essere dall’amministrazione senza esercizio unilaterale di poteri autoritativi, e dunque in esecuzione di un rapporto obbligatorio. Per la domanda di risarcimento per lesioni di interessi legittimi, è previsto un termine di decadenza di 120 giorni “decorrente dal giorno in cui rifatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”. Per quanto riguarda l’azione di accertamento delle nullità previste dalla legge, il Codice fissa il termine di 180 giorni sebbene comunque la nullità dell’atto possa sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. In alcune ipotesi specifiche, il termine per la notifica del ricorso è più breve di quello ordinario di sessanta giorni, come, ad esempio, in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, o per i ricorsi elettorali per i quali è di trenta giorni. Esso, comunque, resta sospeso per il periodo feriale, corrente dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, salvo che per la proposizione delle istanze cautelari e per i giudizi proposti avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali. Esso è aumentato di trenta giorni se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, e di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa. È prevista, comunque, la possibilità di “rimessione in termini” per errore scusabile, in presenza del quale il giudice, anche d’ufficio, ritiene tempestivo il ricorso notificato tardivamente, ovvero autorizza il ricorrente a rinnovare le notifiche. L’istituto dell’errore scusabile è ora previsto e disciplinato nell’art. 37 che fa riferimento alla “presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”, scaturenti da difficoltà interpretative ed applicative di una norma nuova, dall’esistenza di contrasti giurisprudenziali, dallo stato di incertezza oggettiva sul termine o sulle forme di tutela processuale, e dalla presenza di un comportamento equivoco tenuto dall’amministrazione o di errori di notifica ascrivibili all’ufficio. La notifica del ricorso va effettuata, a pena di inammissibilità, all’amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato e ad almeno uno dei controinteressati, essendo ammessa l’integrazione successiva del contraddittorio. Se è proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso deve essere notificato anche agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai fini della instaurazione di un litisconsorzio necessario che, ove non correttamente instaurato, viene composto dal giudice attraverso l’emanazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Se intimata è un’amministrazione statale, il ricorso va notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato sito nella città ove ha sede il T.A.R. o la sezione staccata competente a decidere. Se intimata è un’amministrazione diversa da quella statale, il ricorso va notificato presso la sede della Stessa. Il ricorso va sempre notificato all'amministrazione in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale, ma è ritenuta equipollente la notifica all’organo che ha emanato l’atto, anche se diverso dal rappresentante. Circa la notificazione a mezzo posta va precisato che, per l’osservanza del termine, si deve far riferimento alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; e che l’avviso di ricevimento, costituendo prova dell’effettiva ricezione dell’atto da parte del suo destinatario, deve essere depositato a pena di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione. Solo nel giudizio cautelare è possibile provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste e fatta salva la prova contraria. Nell’ipotesi di irreperibilità o di rifiuto alla ricezione della copia dell’atto, la notificazione viene perfezionata con il ricevimento della raccomandata e non con la semplice spedizione. Per il destinatario la notifica s’intende perfezionata solo dalla (data di) ricezione dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario. Il Presidente del T.A.R. adito può autorizzare la notificazione del ricorso anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax. I “termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori”. Non è dunque necessario che il giudice, di volta in volta, precisi la natura dei termini che, appunto, salva diversa previsione, essendo perentori, non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno con l’accordo delle parti. La giurisprudenza ha precisato che la mancanza della firma del difensore munito di mandato nella copia notificata, quando questa sia presente sull'originale, non spiega effetti invalidanti del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale, essendo a tal fine sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notificazione è eseguita su istanza del difensore del ricorrente. Le invalidità della notificazione sono quelle individuate dalla giurisprudenza. Sarà invalida, dunque, la notifica se effettuata a persona o luogo diverso da quelli stabiliti dalla legge ma comunque collegati in qualche modo con persona destinataria, oppure se effettuata ad un’amministrazione statale nel suo domicilio reale. In tali casi la costituzione dell'intimato, sana il difetto di notifica. Dovrebbe invece ritenersi inesistente, e dunque insanabile con la costituzione dell’intimato, la notifica che manchi del tutto ovvero se effettuata a soggetto che non abbia alcun riferimento con il destinatario della notificazione Stessa. È stata esclusa la trascrivibilità del ricorso proposto al T.A.R. contenente la domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo, seppure anteriormente trascritto in quanto produttivo dell’effetto traslativo della proprietà dei beni immobili. 4. Il deposito del ricorso notificato e la costituzione in giudizio dei ricorrente Nel processo amministrativo l’instaurazione del “rapporto” tra organo giudicante e parti si realizza con la costituzione in giudizio. Per quanto riguarda il ricorrente, la costituzione si realizza con il deposito, presso la segreteria del giudice adito, dell’originale del ricorso con la prova delle avvenute notificazioni e della procura del difensore se conferita con atto separato dall’atto di ricorso. Il deposito del ricorso (e degli altri atti processuali soggetti a notifica), da effettuarsi entro trenta giorni dal momento in cui l’ultima notifica si perfeziona anche per il destinatario. In caso di mancato deposito del ricorso notificato, le altre parti notificate potrebbero presentare un autonomo ricorso, volto a provocare la declaratoria del giudice circa la mancata instaurazione del ricorso, anche ai fini dell’ottenimento del pagamento delle spese processuali eventualmente sostenute. Nell'ipotesi in cui, invece, il ricorso venga depositato fuori termine, il processo può dirsi formalmente instaurato, anche se irritualmente, con la conseguenza di consentire al giudice di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. È fatta salva la possibilità per il ricorrente di depositare l’atto anche prima che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario, evitando così ogni decadenza. In tal caso, però, la procedibilità del ricorso è condizionata all’ulteriore deposito del documento comprovante il perfezionamento della notificazione per il suo destinatario, anche se per tale ulteriore deposito non sia previsto alcun termine. Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento, rendendo inesistente la notificazione, preclude che la stessa possa essere rinnovata. È esclusa qualsiasi decadenza se il ricorrente non deposita copia dell’atto impugnato. Nella precedente disciplina, si prevedeva che unitamente al ricorso, o anche separatamente purché nel termine stabilito per perfezionare la costituzione, il ricorrente dovesse depositare anche la copia del provvedimento impugnato se in suo possesso “ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intende avvalersi in giudizio” sebbene poi la legge T.A.R. non prevedesse alcuna decadenza. Si dispone che l’amministrazione, a prescindere dalla circostanza che essa si costituisca o meno in giudizio, è obbligata, entro sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, a depositare l’atto impugnato nonché “gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio”. All’amministrazione evocata in giudizio non è mai preclusa la possibilità di produrre comunque proprie osservazioni in ordine agli incombenti ordinati dal giudice, restando in tale evenienza salva ogni possibilità per la parte avversaria di controdedurre alle osservazioni medesime e al giudice investito della causa di valutare nel suo libero convincimento la fondatezza delle tesi rispettivamente fatte valere dalle parti. Tale disciplina, è destinata a trovare una sempre più massiccia utilizzazione alla luce del disposto dell’art. 21 octies della l. 241/1990, introdotto dalla l. 15/2005, che esclude l’annullabilità per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. In questa prospettiva la prevista esibizione di atti e documenti potrebbe ricevere, in sostanza, un’applicazione certamente più ampia di quella che sinora ne era stata fatta in quanto si risolve in uno strumento indispensabile per l’amministrazione che intende evitare l’annullabilità dei provvedimenti impugnati. Nella prospettiva della salvaguardia del diritto di difesa del ricorrente, la previsione di cui all’art. 46 del Codice non è però pienamente soddisfacente in quanto il termine di sessanta giorni entro il quale il soggetto resistente deve perfezionare il deposito della documentazione non è qualificabile come perentorio, mancando qualsivoglia sanzione in caso di inottemperanza. In caso di inadempimento da parte dell’amministrazione, infatti, è sì previsto che “il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni” (art. 65 c. 3). Il deposito del provvedimento impugnato e degli atti e documenti in base al quale l'atto è stato emanato, se effettuato, costituisce un momento centrale per lo svolgimento del giudizio in quanto determina un “arricchimento" importante per la conoscibilità del materiale “istruttorio” su cui l’amministrazione ha fondato il proprio iter decisionale. Per questo motivo si prevede che dell’avvenuto deposito di tali atti e documenti venga data comunicazione alle parti costituite. Da tale comunicazione dovrebbe decorrere il termine decadenziale per la proposizione dei motivi aggiunti. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 73, le parti del giudizio hanno la possibilità di produrre documenti, memorie e repliche rispettivamente fino a quaranta, trenta e venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l’udienza di discussione. La presentazione tardiva di memorie e documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio ove la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile e nel rispetto comunque del diritto di difesa delle controparti su tali atti. L’art. 73 ora novellato, nel recepire un orientamento che si era già venuto a formare, prevede che le repliche sono da intendersi come risposte “ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza” di discussione e non della (mera) memoria di costituzione. Le memorie del ricorrente non possono comunque essere utilizzate per formulare domande nuove o estendere il thema decidendum, essendo ciò consentito nei limiti e con le modalità dei motivi aggiunti. Esse costituiscono lo strumento attraverso cui il ricorrente ribadisce le argomentazioni poste a fondamento delle censure sviluppate nell’atto introduttivo, anche “in risposta” alle eccezioni sollevate dalle altre parti del giudizio intimate e costituitesi. 5. La costituzione delle parti intimate Nel processo amministrativo, in quanto fondato sul principio dell’unilateralità dell'azione, non è (stato) previsto l’istituto della contumacia. Una volta perfezionatasi, dunque, la costituzione del ricorrente attraverso la notificazione dell’atto introduttivo e il deposito del medesimo unitamente al provvedimento impugnato se in possesso del ricorrente medesimo, diventa irrilevante il comportamento del soggetto resistente e degli (eventuali) controinteressati, nel senso che la loro costituzione non è un momento necessario (né per la instaurazione del rapporto processuale, né) per la prosecuzione del giudizio. La costituzione dell’Amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e delle altre parti intimate avviene mediante il deposito di un atto di costituzione o di una memoria difensiva (definita controricorso) entro sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso. Nel stesso termine possono fare istanze e indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti. Tale termine è considerato ordinatorio per le parti, cioè la loro costituzione in giudizio può avvenire anche oltre, e sino all’udienza di discussione; e dilatorio per il giudice, nel senso che, prima della scadenza del medesimo, non può essere fissata l’udienza di discussione del ricorso, a presidio del diritto di difesa delle parti diverse dal ricorrente. Documenti, memorie e repliche possono essere presentati, rispettivamente, quaranta, trenta e venti giorni liberi prima dell’udienza, per cui la costituzione all’udienza di discussione consente solo la difesa orale. In ogni caso la costituzione “tardiva” avviene nello stato in cui il processo si trova, con la conseguenza che la parte che si è costituita in ritardo non può eccepire la mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza nel termine previsto. È possibile, anche per le parti intimate, la presentazione tardiva di memorie e documenti, su richiesta di parte, eccezionalmente autorizzata dal collegio ove la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile e nel rispetto comunque del diritto di difesa delle controparti su tali atti. Le parti intimate possono formulare le proprie eccezioni per l’intero arco del processo, e, quindi, anche in memorie successive alla prima, ed anche in grado di appello, ad esclusione di quelle soggette a termini di decadenza, come l’eccezione di incompetenza che deve essere sollevata nell’atto di costituzione o comunque con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine; o l’eccezione di prescrizione che può essere fatta valere solo in primo grado e solo dalla p.a. Per quanto riguarda l’individuazione delle parti intimate, che possono costituirsi in giudizio mediante la sola formalità del deposito delle memorie e dei documenti, va precisato che tali dovrebbero essere considerate solo quelle che sono state destinatarie della notificazione del ricorso, e che quindi interloquiscono nel processo in base a questo titolo. Gli altri soggetti, tra cui andrebbe ricompreso anche il controinteressato pretermesso, potrebbero entrare nel giudizio solo attraverso la notificazione di un atto formale di intervento, anche se, accedendo ad una visione sostanzialistica circa la composizione soggettiva del processo amministrativo, tale atto dovrebbe essere considerato, nella sostanza, al pari della costituzione di una parte necessaria del processo. Nell’ipotesi di invalidità della notificazione del ricorso principale all’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato ovvero ad almeno uno dei controinteressati, la costituzione in giudizio di tali soggetti esplica comunque un effetto sanante. 6. La domanda di fissazione di udienza, ordine di fissazione dei ricorsi e priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione. Abbreviazione dei termini Il giudizio prende avvio concreto con il deposito della domanda di fissazione di udienza ad opera di una qualunque delle parti costituite presso l'Ufficio giurisdizionale adito. La domanda, formalmente presentata, con atto separato dal ricorso, al Presidente del Collegio e sottoscritta dal difensore, deve essere depositata, entro un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo per evitare l’estinzione del processo per perenzione, nella segreteria del giudice adito senza necessità di notificazioni alle controparti, e annotata su un apposito registro. Trasmessa unitamente al fascicolo di ufficio al Presidente che, con decreto, fissa la data di udienza nominando il giudice relatore, segna, dunque, il momento in cui l’onere dell’impulso processuale si trasferisce dalla parte al giudice, diversamente da quel che accade nel processo civile. A seguito di ciò, la segreteria del giudice adito provvede all’iscrizione della causa al ruolo d'udienza. La domanda di fissazione d’udienza è richiesta ora anche per la decisione della fase cautelare. Ove il giudizio non sia immediatamente definito con sentenza resa in forma semplificata all’esito dell’udienza camerale, l’udienza di merito, ove non indicata dal collegio nell’ordinanza cautelare è immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorità. La domanda di fissazione dell’udienza è ora espressamente definita “non revocabile” dalla parte che l'ha presentata nella prospettiva di arginare comportamenti dilatori e poco consoni agli obiettivi di efficienza processuale. Nel momento in cui la causa è inscritta al ruolo d’udienza, il decreto presidenziale di fissazione del giorno dell’udienza di discussione deve essere comunicato a cura dell’ufficio di segreteria almeno 60 giorni prima dell’udienza sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio nel domicilio eletto risultante dal fascicolo di causa. Ove la parte sia domiciliata presso la segreteria, l'ufficio provvederà a comunicare a sé medesimo l’avviso di fissazione dell'udienza. La normativa, fatte salve le ipotesi dei riti speciali, non stabilisce un termine massimo entro cui va fissata l’udienza di discussione, ma solo un termine minimo, ossia non prima di sessanta giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica. Nei casi d'urgenza, il Presidente del Tribunale adito può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal Codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, va notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all’amministrazione intimata e ai controinteressati ed il termine abbreviato comincia a decorrere dalla notificazione del decreto. La fissazione dell’udienza dovrebbe seguire l’ordine di iscrizione delle domande nel registro tenuto dal segretario. È previsto però che nelle ipotesi dichiarate urgenti, d’ufficio, su istanza di parte (attraverso la presentazione di apposite istanze di prelievo) o nei casi previsti dallo stesso Codice, la trattazione possa essere anticipata. Vi sono tre diverse ipotesi di anticipazione. 1- Le ipotesi in cui il ricorso deve essere fissato con assoluta priorità in caso di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture e con priorità nell’ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado e di pluralità di ricorsi vertenti su un’unica questione. In quest’ultimo caso, la deroga al criterio cronologico è subordinata alla duplice condizione della mancata contestazione dei “fatti” di causa da parte di tutte le parti e dalla “unicità” della questione di diritto per risolvere l’intera “controversia”. Il Collegio, qualora, in sede di esame del merito, rilevi l’insussistenza dei predetti presupposti, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie. 2- Si prevede la fissazione con urgenza nell'ipotesi di ricorsi in materia elettorale, e con sollecitudine a seguito dei diversi esiti della udienza camerale per la concessione delle misure cautelari. 3- Il Presidente può derogare al criterio cronologico per esigenze di connessione per materia, per esigenze di funzionalità dell’ufficio, ogniqualvolta sussista la necessità di udienze straordinarie e in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l’ordinanza esaminate e rinviato la causa al giudice di primo grado, sebbene la novella all’art. 105 abbia onerato le parti della riassunzione del processo entro novanta giorni al fine di evitare che proseguano d’ufficio giudizi cui le parti, dopo il giudizio di appello, possono non avere più interesse. Decorsi cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria del giudice adito notifica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere, a pena di perenzione del ricorso, alle parti ricorrenti di presentare una nuova istanza di fissazione d’udienza con la firma delle parti entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso medesimo. 7. L’integrazione del contraddittorio. L’intervento In presenza di più controinteressati, il ricorso è ammissibile purché sia stato notificato nel termine di decadenza all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati. Il giudice amministrativo, ravvisata nel corso del giudizio di primo grado l'esistenza di controinteressati non intimati, ordina con sentenza che il ricorrente, entro un termine perentorio, provveda ad integrare le notificazioni mancanti ai soggetti espressamente indicati dal giudice stesso e a depositare in giudizio le relative prove. Il mancato rispetto dell’ordine di integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso; così come la decisione finale, emessa in difetto dell’integrazione del contraddittorio, è affetta da vizio di procedura, rilevabile d’ufficio in appello dal giudice che deve annullarla con rinvio al giudice di primo grado. In ogni caso, l'intervento in giudizio delle parti che avrebbero dovuto ricevere la notificazione sana tali carenze. Se è proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso deve essere notificato anche agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai fini dell’instaurazione di un litisconsorzio necessario che, ove non correttamente instaurato, viene composto dal giudice proprio attraverso l’emanazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Se, dunque, in prima battuta al ricorrente viene affidato il compito di realizzare un contraddittorio “minimale” al momento della instaurazione del giudizio, nel corso del giudizio il dato normativo consente (anzi ora impone) di assicurare l’integrità del contraddittorio attraverso la chiamata in giudizio dei soggetti sui quali la decisione finale è destinata a produrre effetti. Proprio per rendere effettiva la tutela anche dei soggetti entrati nel giudizio in un momento successivo, si chiarisce che i soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti. Queste previsioni assumono una nuova consistenza a seguito della costituzionalizzazione del principio del contraddittorio nonché dell’introduzione, nel processo amministrativo, dell’istituto dell’opposizione di terzo, nel senso che ormai la verifica della pienezza del contraddittorio e la disposizione delle necessarie integrazioni devono essere considerate un vero e proprio potere-dovere del giudice, e dovrebbero interessare non solo i controinteressati in senso formale, individuabili sulla base dell'atto impugnato, ma anche i controinteressati in senso sostanziale. Sinora, però, l’ordine di integrazione emesso dal giudice ha dimostrato una limitata utilità nell’assicurare una piena e corretta instaurazione del contraddittorio, e ciò sia per la permanente adesione al requisito formale per l’individuazione delle parti necessarie del giudizio; sia per l’assenza nel processo amministrativo di un momento (un’udienza) preliminare specificamente dedicata alla verifica circa la correttezza (delle notifiche e) dell’instaurazione del contraddittorio, che, sovente, viene rilevata soltanto in sede di udienza di discussione. Per evitare il verificarsi di pregiudizi in capo alle parti del giudizio, ed anche pericolose diseconomie processuali, parte della giurisprudenza, aveva imposto l’integrazione del contraddittorio prima della decisione della domanda cautelare; sicché l’ordinanza di sospensione assunta prima dell’integrazione del contraddittorio sarebbe stata illegittima e annullata dal giudice dell’appello con restituzione degli atti al T.A.R. L'integrazione non deve essere ordinata se il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. In questi casi la causa è decisa con sentenza in forma semplificata e se il giudice dell’appello ritiene condivisibile tale decisione di primo grado, non annulla con rinvio, atteso che le parti non presenti in giudizio non hanno ricevuto alcun pregiudizio dalla pronuncia del giudice. Il soggetto “che non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”. Si distinguono diverse forme di intervento: - intervento in via principale - intervento adesivo autonomo - intervento adesivo dipendente Le differenze strutturali e funzionali del processo amministrativo rispetto al giudizio civile hanno condotto dottrina e giurisprudenza ad escludere non solo l’intervento principale, data l’impossibilità di configurare giuridicamente un interesse di un privato che sia al tempo stesso incompatibile e con l’amministrazione e con gli altri privati coinvolti dall’esercizio del potere amministrativo; ma anche quello litisconsortile, per il timore che l'intervento offrisse l’occasione per eludere il principio della perentorietà del termine per ricorrere. In questo secondo caso, è stato ritenuto ammissibile l’intervento del soggetto legittimato in via principale (il cointeressato) solo se ancora in termini e previa conversione dell’atto di intervento in ricorso in via autonoma; viceversa, dal lato passivo, ove non sussistono termini perentori per la costituzione in giudizio, con maggiore disinvoltura è stata accolta l’esperibilità dell’intervento da parte del controinteressato pretermesso. L’unica forma di intervento pacificamente ammessa nel processo amministrativo sin dalla precedente disciplina è l’intervento adesivo dipendente, ossia l’accessione al giudizio di colui che, avendo un qualche interesse, aderisce alle ragioni di una delle parti, che prende il nome di intervento ad adiuvandum allorquando l’interveniente aderisce alla posizione del ricorrente, e di intervento ad opponendum allorquando l’interveniente aderisca alla posizione della parte intimata o dei controinteressati (opponendosi, dunque, alle argomentazioni del ricorrente). Per individuare il titolo legittimante tale tipo di intervento si parla di “interesse derivato” o “riflesso” rispetto all’interesse (legittimo) tutelato in via principale, nonché di interesse di mero fatto; e ancora di interesse personale e diretto ma non attuale, o di interesse personale e attuale ma non diretto, o di interesse attuale e diretto ma di carattere non personale. Il linguaggio giurisprudenziale, in sostanza, evoca l’idea dell’esistenza di una sostanziale differenza tra la situazione legittimante l’intervento e l’interesse (legittimo) che trova tutela in via principale nel processo; anche se una definizione in via meramente residuale non consente una chiara identificazione degli elementi costitutivi della situazione medesima. Nella prospettiva di evitare l’elusione del termine di decadenza per la proposizione del ricorso si esclude anche che il cointeressato possa intervenire in giudizio ad adiuvandum. Nella vigenza della precedente disciplina, è stata riconosciuta la possibilità di intervenire anche ai soggetti titolari di una situazione giuridica soggettiva “autonoma e incompatibile”, che legittimerebbe il titolare, oltre che a proporre intervento, anche ad appellare o a proporre opposizione di terzo. È una situazione soggettiva di cui è titolare ogni soggetto nel momento in cui il riconoscimento (o il mancato disconoscimento) di un interesse materiale da lui avvertito dipende dal comportamento favorevole e legittimo dell’amministrazione; la quale decide la misura di quell’utilità sostanziale, cui il privato aspira, che rappresenta l’ottimale contemperamento dell'interesse pubblico e dell’interesse privato. La “autonomia” di cui parla la giurisprudenza in simili fattispecie sta ad indicare che l’interesse finale cui il privato aspira è differente tanto da quello del ricorrente quanto da quello del contro interessato perché si colloca in una posizione intermedia fra questi due poli estremi. I titolari di tale situazione soggettiva non possono, in sostanza, essere agevolmente astretti in alcuna delle categorie tradizionali delle parti del processo amministrativo, ma al tempo stesso devono poter ricevere una tutela piena ed effettiva della propria sfera giuridica. L’intervento, in queste ipotesi, rappresenta il momento in cui i soggetti titolari della situazione “autonoma” fissano la propria posizione di interesse nei confronti dell’oggetto del giudizio come individuato dalle affermazioni delle parti già costituite; di un interesse che risulta identificato nei suoi tratti distintivi e soggettivizzato sulla base delle indicazioni normative, in un momento, cioè, antecedente all’instaurazione del giudizio. In questa prospettiva l'intervento in giudizio diventa un validissimo strumento per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che sono coinvolti; ed anche per assicurare una maggiore stabilità alla sentenza dato che a questi soggetti viene riconosciuta la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo. Tale obiettivo dovrebbe oggi essere assicurato dalla previsione dell’intervento coatto iussu iudicis, sebbene gli artt. 28, c. 3 e 51 che lo prevedono sembrano configurare un potere discrezionale del giudice, che può disporlo d'ufficio o su istanza di parte. Nell’ordinare la chiamata in giudizio il giudice indica gli atti che all'interventore devono essere notificati. Ove il terzo non sia chiamato nel termine prescritto, il giudice dichiara il ricorso improcedibile. La costituzione dell’interventore avviene entro sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso. Per quanto riguarda l'intervento volontario nel giudizio, l’art. 50 stabilisce che l’atto di intervento, analogamente a quanto previsto per gli elementi del ricorso introduttivo, deve contenere l’intestazione (indicazione del giudice adito), l’indicazione delle generalità dell’interventore, le ragioni su cui si fonda l’intervento accompagnato dalla produzione dei documenti giustificativi, e la sottoscrizione del difensore. Quanto al contenuto dell’atto di intervento, è comunque costante l’orientamento secondo cui con lo stesso non si possa estendere il thema decidendum oltre i limiti fissati dal ricorrente mediante i motivi del ricorso principale; e tale principio vale tanto per l’intervento ad adiuvandum quanto per quello ad opponendum. Riguardo la forma processuale, l’atto di intervento deve essere notificato a tutte le parti processuali ed all'amministrazione resistente. La notificazione va effettuata nel domicilio eletto; e ciò tanto se si tratti di intervento ad adiuvandum e ad opponendum. L’atto di intervento, con la prova dell’avvenuta notifica, deve essere poi depositato presso la segreteria dell’organo giurisdizionale entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui l’ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. Il Codice, a differenza della precedente disciplina, sebbene non si occupi espressamente di fissare un termine decadenziale per la notifica dell’atto di intervento, comunque cerca quantomeno di soddisfare l'esigenza di non pregiudicare i diritti di difesa delle altre processuali, stabilendo che l’atto di intervento esperito da chi non è controinteressato né in senso formale né sostanziale, deve essere depositato fino a trenta giorni prima dell’udienza. Nel giudizio d’appello sono parti tutti i soggetti che tali sono stati (o avrebbero dovuto essere) nel giudizio di primo grado, e quelli intimati dall’appellante. Oltre a questi può intervenire chiunque ritenga di essere in qualche modo pregiudicato dalla sentenza; chiunque, cioè, sia legittimato a proporre la opposizione di terzo. Non possono intervenire, invece, coloro che avrebbero dovuto proporre ricorso in primo grado in qualità di cointeressati; o proporre appello in via principale in qualità di soccombenti. Costoro, non avendo tempestivamente impugnato, hanno prestato acquiescenza, rispettivamente, al provvedimento ed alla sentenza; e che per essi l’intervento costituisce un tentativo surrettizio di rimettersi in termini. 8. La proposizione di motivi aggiunti Un posto di primaria importanza deve essere riservato al ricorso per motivi aggiunti in quanto nel nostro processo, retto dal principio dispositivo, fondamentale è il profilo concernente la conoscenza del materiale documentale su cui si basa il provvedimento impugnato. Prima di arrivare a ritenere ammissibili detti ricorsi, vi sono stati notevoli interventi volti a superare le contrastanti decisioni sulla materia in questione. La proposizione di motivi aggiunti è stata dichiarata ammissibile in conseguenza della cognizione, da parte del ricorrente, di fatti o atti sopravvenuti alla proposizione del ricorso principale, in grado di far emergere la sussistenza di ulteriori vizi originari del provvedimento impugnato. Tale conclusione troverebbe conferma nel vincolo derivante dalla immodificabilità del petitum, così come individuato nell’atto introduttivo del giudizio, essendo solamente permesso l’eventuale arricchimento della causa petendi. Addirittura, in un primo momento, l’aggiunzione era ritenuta ammissibile solo in conseguenza della produzione documentale avvenuta in corso di giudizio. Solo successivamente è stato recepito l’orientamento volto a consentire la proposizione di motivi aggiunti dedotti in seguito alla cognizione extragiudiziale dell’invalidità. L’art. 43 del Codice stabilisce che “I ricorrenti, principale e incidentale possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, o domande nuove purché connesse a quelle già proposte”. L’espressione utilizzata dalla novella è così ampia da interessare tipologie di collegamento tra atti molto eterogenee tra loro, che spaziano dal collegamento tra atti del medesimo procedimento, a quello tra atto presupposto ed atto consequenziale, ovvero tra regolamento ed atto applicativo. La dottrina, si è dimostrata favorevole all'utilizzabilità di tale strumento anche nell'ipotesi di collegamento scaturente dal fatto che il nuovo atto si pone come riesercizio (su iniziativa della stessa amministrazione resistente o sollecitato dal giudice) del medesimo potere di cui l’atto inizialmente impugnato costituisca manifestazione. Analogo favore è mostrato con riferimento all’impugnazione di atti, adottati anteriormente a quello oggetto del ricorso principale e che di questo costituiscono l’antecedente giuridico (caso dell'atto procedimentale, presupposto o regolamentare). In tale ipotesi, infatti, la recente giurisprudenza ha recuperato e riaffermato l’indirizzo più risalente, favorevole a riconoscere l’utilizzabilità di questo strumento di concentrazione processuale anche per gli atti adottati prima del giudizio, ma conosciuti dalla parte privata interessata a gravarli soltanto nel giudizio medesimo in esito alle produzioni documentali effettuate in giudizio dalle parti resistenti. Nell’ipotesi in cui venga in gioco un atto di natura regolamentare in sede di giurisdizione esclusiva, resta salva, peraltro, la possibilità per il giudice amministrativo di fare ricorso all’istituto della disapplicazione. Se la concentrazione in un unico processo di più impugnazioni tra loro connesse permette di valorizzare al massimo il principio del contraddittorio, la posizione dei nuovi soggetti evocati in un giudizio già avviato potrebbe risultare penalizzata dalle attività già svolte in loro assenza. In questa prospettiva, parrebbe auspicabile attribuire ai “controinteressati sopravvenuti” i medesimi poteri riconosciuti agli interventori litisconsortili nel processo civile, per quanto attiene l’attività giudiziale svolta fino al loro ingresso nel processo pendente, ruolo che diversamente non avrebbero l'opportunità di svolgere mantenendo distinte ed autonome due fasi del giudizio tra loro comunque oggettivamente connesse. Inoltre, il meccanismo delineato dall’art. 43 permette altresì di coinvolgere i controinteressati occulti, difficilmente individuabili sulla base della prima domanda, riducendo, nel contempo, l’eventualità di successive opposizioni di terzo. L’art. 43 contribuisce a rimuovere dei dubbi, sorti in conseguenza delle disposizioni introdotte con la riforma del 2000. In primo luogo, il dilemma della doverosità o meno per l’interessato di utilizzare lo strumento dei motivi aggiunti; l’aver inserito l’inciso “possono introdurre con motivi aggiunti nuove domande” in luogo di “Tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso… sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”, consente di attribuire a questa forma di impugnazione il valore di una facoltà, anziché di un onere, il cui mancato rispetto comporterebbe l’inammissibilità del ricorso proposto in via autonoma contro gli atti connessi. Oggi l’art. 43 non demanda più alla valutazione discrezionale del giudice l’opportunità di riunire i ricorsi, optando al contrario per un vero e proprio obbligo di quest’ultimo di trattare congiuntamente le questioni sottoposte al suo sindacato. La nuova formula introdotta dall’art 43 non contiene elementi utili a superare l’interrogativo della natura accessoria o meno del ricorso per motivi aggiunti. Appare più persuasiva la tesi che induce ad escludere che ad esso vada attribuita sempre ed in ogni caso natura accessoria e, conseguentemente, che vada dichiarata l’improcedibilità del medesimo nell'ipotesi in cui il ricorso originario non sia suscettibile di essere deciso nel merito. La conformazione attuale dell’istituto induce, invece, a distinguere. L’accessorietà potrebbe, al limite, essere predicata con riguardo all’impugnazione di un atto meramente applicativo di quello originario proposta solo per far valere vizi di illegittimità derivata da quelli già dedotti nel primo ricorso, ma non anche nell’ipotesi in cui venga in questione un'impugnazione che sia suscettibile di essere proposta anche in forma autonoma. Inoltre, il legislatore non ha precisato se la forma dei motivi aggiunti possa essere utilizzata anche quando la competenza a conoscere dell’impugnazione del provvedimento sopravvenuto connesso spetti ad un T.A.R. da quello già adito, in quanto, se così fosse, si avrebbe una inedita (per il processo amministrativo) modificazione delle regole di competenza per ragioni di connessione. Ad una prima lettura le nuove regole in tema di inderogabilità della competenza territoriale (art. 13 del Codice), parrebbero prospettare degli ostacoli insormontabili, sebbene tale conclusione si ponga in diretto contrasto con i principi di concentrazione ed immediatezza a loro volta ben presenti al legislatore del 2010. Il rischio di attivazione di due contenziosi tra loro connessi avanti a due T.A.R. deve essere affrontato e risolto anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, ai sensi dell’art. 111 Cost., unitamente ai principi affermati agli artt. 1 e 2 del Codice. Più in particolare, parrebbe più opportuno ammettere la concentrazione di tutte le impugnazioni concernenti il medesimo episodio di vita avanti alla medesima autorità giurisdizionale. In questa prospettiva, dunque, spostandosi l’oggetto del giudizio da un mero sindacato sull’atto ad una valutazione di tutta la vicenda tra amministrazione ed amministrato, appare sistematicamente più corretta potendosi estendere anche al nostro modello processuale la regola di cui all’ art. 31 c.p.c. in tema di spostamento della competenza territoriale per le cause legate da un nesso di accessorietà. In tale evenienza, del tutto legittimo si presenterebbe il superamento della non derogabilità di detta competenza, sia in virtù del richiamo ai principi del processo civile in assenza di precise indicazioni sul piano positivo, sia in conseguenza dell’espressa statuizione da parte dello stesso legislatore che, inspiegabilmente, ha previsto detta deroga in sede di disciplina del ricorso incidentale all’art. 42 del Codice. Analoghe considerazioni potrebbero valere anche per il caso di integrazione della domanda originaria che comporti una richiesta differente ricadente in un rito diverso da quello chiamato a regolare il ricorso principale; pur trattandosi di un'eventualità abbastanza remota, merita sottolineare come per il silenzio inadempimento, l’art. 117, c. 5, del Codice preveda espressamente che, nel caso di emanazione del provvedimento richiesto nel corso della controversia volta ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, il processo deve proseguire “con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue cori tale rito”. Quanto agli adempimenti di natura formale, il ricorso per motivi aggiunti deve contenere, oltre ai requisiti propri di qualsiasi ricorso, anche l’indicazione degli estremi del giudizio nel quale si innesta. Il Codice ha precisato che “la procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto”. Il ricorso per motivi aggiunti va presentato entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso principale; se la conoscenza del provvedimento sopravvenuto avviene in prossimità dell’udienza di discussione, il giudice, per assicurare la pienezza della tutela, deve, se richiesto, rinviare a nuova udienza la discussione della causa. Anche in questo caso, l'intervento correttivo del legislatore si è rivelato risolutivo, laddove è detto inequivocabilmente che “ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, compresa quella relativa ai termini'”. Il ricorso va notificato all’amministrazione ed agli eventuali controinteressati, anche se non costituiti in giudizio, compresi quelli diversi dai soggetti già evocati in giudizio con il ricorso principale, entro l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni dalla avvenuta conoscenza del documento nuovo o dell’adozione del nuovo provvedimento. La nuova domanda va notificata presso il domicilio eletto dalle parti (già) costituite. L’originale dell'atto notificato, munito della prova dell’avvenuta notifica, va depositato presso la segreteria della sezione presso cui pende il ricorso originario. 9. Il ricorso incidentale e le domande riconvenzionali Il ricorso incidentale, è l’istituto attraverso il quale una delle parti del processo (prevalentemente il controinteressato) esercita il proprio diritto di difesa nelle forme indicate dall’art. 42 del Codice. È una vicenda che si colloca in un momento procedurale immediatamente successivo alla costituzione delle parti contro cui è stata proposta l’impugnazione. Queste ultime, possono esercitare il proprio diritto di difesa, proponendo “domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale”. Il ricorso incidentale è caratterizzato dal fatto che l'ordinamento processuale riconosce ad un soggetto diverso dal ricorrente principale (di regola il controinteressato), nell’ambito di un giudizio pendente, la facoltà di impugnare a sua volta il medesimo provvedimento già oggetto di contestazione. Detta possibilità si spiega con la necessità di assicurare al ricorrente incidentale la tutela della propria situazione soggettiva, in conseguenza della richiesta rivolta al giudice amministrativo -contenuta nel ricorso principale- di annullare il provvedimento gravato. Pur costituendo formalmente un’autonoma azione di impugnazione il ricorso incidentale è qualificato, secondo l’opinione prevalente, come un’eccezione in senso tecnico in quanto mira a paralizzare l’azione principale e a neutralizzare gli effetti derivanti dall’eventuale accoglimento del ricorso principale, favorendo la conservazione, in capo al controinteressato, dell'assetto degli interessi sancita dal provvedimento impugnato. Infatti, dalla fondatezza della domanda incidentale non dovrebbe mai derivare l’annullamento del provvedimento originariamente censurato, ovvero degli atti presupposti. Diversamente, se il ricorrente incidentale, oltre all’accertamento dell’inammissibilità della domanda principale chiede al giudice l’annullamento di parti diverse (o per motivi distinti) del provvedimento oggetto dell’impugnazione principale, ci troviamo di fronte ad una vera e propria eccezione in senso sostanziale. Qualora la “prova di resistenza” del provvedimento sia favorevole al ricorrente incidentale, dall’annullamento disposto dal giudice amministrativo discende una lesione più consistente rispetto a quella che ha dato luogo alla proposizione del ricorso principale. È questo il caso di un soggetto che, risultato vincitore in un concorso impugnato da altro candidato non vincitore sull'assunto dell’omessa valutazione di alcuni titoli, impugni a propria volta lo stesso provvedimento per far valere l’omessa valutazione di altri titoli in suo favore, in modo da ripristinare la preminenza nella graduatoria rispetto al ricorrente principale, concretizzando un’eccezione sostanziale, azionata nelle forme del ricorso incidentale. Allorché all’impugnazione incidentale viene attribuita una vera e propria valenza di domanda riconvenzionale, è di tutta evidenza l'allargamento dell’oggetto del giudizio delimitato dal ricorrente principale. Ed infatti, le censure prospettate nei confronti del medesimo atto impugnato da quest’ultimo, o nei confronti di altre determinazioni dei pubblici poteri, consentono all'interessato di introdurre un nuovo thema decidendum, che va ben oltre la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse. Parimenti, laddove l’estensione del sindacato del giudice ad altri atti o a parti diverse del provvedimento impugnato allo scopo di “ribaltare” gli esiti della (auspicata) pronuncia di annullamento dell'atto impugnato in via principale in senso favorevole al ricorrente incidentale, quest’ultimo può ottenere la tutela della propria situazione soggettiva in sede di rinnovazione del procedimento, mediante la “riproduzione” del medesimo assetto di interessi sfavorevole al ricorrente principale. Emblematica di tale orientamento, l’ipotesi di impugnazione, nell’ambito di un giudizio avverso un atto applicativo o per violazione dell’atto regolamentare, la cui legittimità viene messa in discussione in conseguenza della impugnazione incidentale. Quand’anche volto a modificare la domanda originariamente proposta dal ricorrente, il ricorso incidentale si pone in posizione “accessoria” rispetto all’oggetto del giudizio principale, in quanto strettamente collegato alle sorti del ricorso principale. Si tratta delle ipotesi in cui gli atti sono legati da un nesso di presupposizione e l'impugnazione incidentale dell’atto presupposto a quello impugnato in via principale viene effettuata dal controinteressato per neutralizzare o contrastare la pretesa del ricorrente e non per ottenere vantaggi ulteriori e diversi a quelli ottenuti dal provvedimento oggetto appunto del ricorso principale. Il ricorso incidentale va notificato entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso principale, al ricorrente principale (al legale nel domicilio eletto) e alle altre parti del giudizio. È un termine previsto a pena di decadenza in quanto attraverso il ricorso incidentale si propone un’autonoma azione di impugnazione. Va poi depositato, nella segreteria del giudice adito, con la prova delle avvenute notificazioni, nei trenta giorni successivi. La facoltà per il giudice amministrativo di definire, anche nel rito “ordinario”, la controversia immediatamente in forma semplificata, potrebbe vanificare la possibilità per le controparti di presentare ricorso incidentale. Per impedire il verificarsi di un inaccettabile vulnus al diritto di difesa delle parti, all’art. 60 del Codice è previsto che “se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni”. L’ultima parte di detta disposizione prevede che nell’ordinanza con la quale il Collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio venga fissata “contestualmente la data per il prosieguo della trattazione”. Una novità riguardante l’istituto, è la puntualizzazione inserita all’art. 42, c. 4, con riferimento al possibile spostamento della competenza del giudice originariamente adito, in virtù della proposizione del ricorso incidentale. In buona sostanza, il principio di concentrazione delle domande sembra subire un’eccezione unicamente nell’eventualità che il provvedimento oggetto di censura in sede incidentale imponga la proposizione del gravame avanti al T.A.R. Lazio, o presso altro T.A.R. funzionalmente competente. Anche sotto questo profilo, appare indirettamente confermata l’ammissibilità dell’impugnazione in via incidentale di determinazioni amministrative distinte rispetto a quella oggetto di contestazione da parte del ricorrente principale. Quanto all'ulteriore conseguenza fatta discendere dal carattere accessorio, o dipendente dal ricorso principale, discende che il ricorso incidentale possa essere esaminato solo nell’ipotesi in cui sia stata positivamente valutata la fondatezza del ricorso principale. Pertanto, il ricorso incidentale andrebbe considerato “inefficace” nell’ipotesi in cui il ricorso principale venga dichiarato inammissibile o nell’ipotesi di pronunzie processuali che precludano l’adozione di una decisione sul merito dell’impugnativa principale, nonché nell’ipotesi in cui il ricorso principale venga rigettato per infondatezza. In epoca recente tali conclusioni sono state sottoposte ad una consistente revisione soprattutto con riferimento alle modalità di decisione del ricorso incidentale, di legittimazione (attiva e passiva) e di oggetto del relativo giudizio. Con riferimento al primo aspetto, occorre sottolineare come, negli ultimi anni, la giurisprudenza abbia mutato il proprio orientamento rimettendo tale problema all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Quest’ultima, in un primo momento aveva ritenuto di dover mitigare la regola generale della preventiva delibazione del ricorso principale demandando al collegio giudicante la scelta dell’ordine delle questioni prospettate con entrambi i ricorsi al fine di individuare quelle decisive per risolvere la lite. Ancor più incisivo, sebbene criticabile sotto diversi profili, si è rivelato in tale circostanza l’orientamento del Supremo Collegio in relazione all’ordine di esame e alle sorti delle impugnative proposte, sia dal ricorrente principale sia dal ricorrente incidentale, per le controversie relative alle procedure di gara, in particolare quando ciascuna delle parti contesti all’altra la mancata esclusione delle rispettive offerte allorché (ma non solo) alla procedura selettiva abbiano partecipato soltanto due soggetti. In buona sostanza, in tali fattispecie l’effetto “paralizzante” del ricorso incidentale sul ricorso principale attraverso cui il controinteressato fa valere la illegittimità dell’ammissione dell’offerta del ricorrente non si verifica, avendo entrambe le imprese l’interesse strumentale all’indizione di una ulteriore gara, per cui andrebbero esaminati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, al cui contestuale accoglimento corrisponderà l’obbligo dell’Amministrazione di rinnovare la procedura di gara. Quale che sia, in definitiva, l’ordine di trattazione delle questioni, secondo i giudici di Palazzo Spada entrambi i ricorsi verrebbero sottoposti al sindacato del giudice adito, sancendo così il venir meno della equiparazione (sulla quale si era appoggiata la giurisprudenza più risalente in tema di ricorso incidentale c.d. “escludente”) del soggetto in tal modo escluso (a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale) rispetto a coloro che neppure hanno presentato l’offerta, con conseguente irrilevanza del numero di partecipanti al confronto comparativo. Da ultimo, l’Adunanza Plenaria è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi su tali profili ed in tale occasione ha rivisto profondamente le proprie posizioni. Più in particolare la domanda incidentale volta a contestare la legittimazione ad agire del ricorrente principale, censurando l’ammissione di quest’ultimo a partecipare alla procedura di gara, deve essere esaminata prioritariamente pur in presenza di censure del ricorrente principale finalizzate a tutelare il proprio interesse strumentale alla ripetizione della selezione pubblica. In conclusione viene affermata con convinzione la priorità logica del ricorso incidentale nei confronti di quello principale indipendentemente dal numero dei partecipanti alla gara, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente. Tale orientamento, tuttavia non sembra aver raggiunto un sufficiente grado di stabilità in quanto in due occasioni è stata oggetto di critica tanto dal giudice amministrativo di primo grado che dal giudice della nomofilachia. In entrambe le occasioni, tuttavia, si è arrivati a rimettere in discussione i principi di diritto sanciti dal Supremo consesso amministrativo in maniera atipica. Nel primo caso, infatti, è stata rimessa alla Corte di giustizia la questione concernente il possibile ostacolo rappresentato dalle affermazioni contenute nella decisione n. 4/2011 dell’Adunanza Plenaria all’applicazione dei principi della parità delle armi, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, così come introdotti dalle direttive comunitarie in materia di appalti. Ancor più atipico si presenta il contenuto della sentenza della Corte di cassazione, allorché il supremo consesso, per definizione competente a sindacare le decisioni del giudice amministrativo unicamente per questioni inerenti la giurisdizione, nel respingere la domanda ha tuttavia ritenuto di dover stigmatizzare i risultati cui è pervenuto il Consiglio di Stato in tema di priorità di esame del ricorso incidentale rispetto al ricorso incidentale. Ed invero, le Sezioni Unite sembrano invitare i giudici di Palazzo Spada a rimeditare ancora una volta i propri convincimenti, favorendo un’interpretazione della disciplina processuale in grado di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell’interpretazione delle regole del giudizio amministrativo secondo un criterio che tende ad allargare e non ad escludere le questioni sottoposte al sindacato del giudice, al quale è richiesto di contenere al massimo eventuali distorsioni della concorrenza e del mercato. Quanto al profilo della legittimazione attiva, i maggiori problemi sorgono in corrispondenza dell’attenzione che viene prestata all'applicazione effettiva del principio del contraddittorio. La giurisprudenza formatasi sulla scorta del dato normativo previgente ha aderito ad un’interpretazione restrittiva, secondo cui la proponibilità del ricorso incidentale andrebbe negata ai soggetti diversi dai controinteressati formali, ossia a coloro che, in quanto parti necessarie, sono i destinatari esclusivi della notificazione del ricorso principale. La dottrina, invece, valorizzando la portata espansiva del principio del contraddittorio soprattutto dopo l’introduzione dell’istituto dell’opposizione di terzo anche nel processo amministrativo, che ha valorizzato la posizione dei soggetti c.d. terzi, è sempre più favorevole ad ammettere la proposizione del ricorso incidentale da parte di tutti i controinteressati, formali e sostanziali, in linea con i tratti caratterizzanti il processo di parti. La giurisprudenza esclude poi che i cointeressati possano utilizzare il ricorso incidentale, così come tale rimedio risulta inutilizzabile per tutti coloro che abbiano prestato acquiescenza all’atto impugnato o abbiano lasciato trascorrere i termini per l’impugnazione dell’atto, poi gravato in via principale. La ragione di tali esclusioni va ravvisata nella natura del ricorso incidentale che continua comunque ad essere identificato come un rimedio che si innesta pur sempre in un processo già instaurato, risolvendosi in un strumento difensivo occasionato dal ricorso principale, prevalentemente diretto a paralizzare gli effetti di una eventuale decisione di accoglimento delle censure svolte con questo ricorso. Il ricorso incidentale, in sostanza, è volto ad ottenere, in capo ai soggetti che lo propongono, il vantaggio da essi già ottenuto, ma non è idoneo a determinare una riapertura dei termini per le impugnazioni di un provvedimento che sin dall’origine era percepito come pregiudizievole. In altri termini, non può attribuirsi all’istituto quell’ulteriore valenza che lo stesso assume nell’ambito del giudizio di secondo grado, laddove l’appello incidentale può assolvere alla funzione di veste “formale” di tutte le impugnazioni successive alla prima, realizzando così la concentrazione di tutte le domande proposte nel medesimo giudizio. È stata introdotta anche sul piano positivo la possibilità per l’amministrazione resistente, allorquando quest’ultima intenda difendere il proprio operato, di censurare atti emanati da altra autorità e, quindi, da essa non annullabile in via di autotutela. In applicazione della regola generale dell'accessorietà, legittimato passivo è considerato solo il ricorrente principale, anche perché in realtà l’amministrazione e gli altri controinteressati si pongono sullo stesso piano del ricorrente incidentale essendo portatori di un interesse, conforme, alla conservazione del provvedimento. In ogni caso, qualora l’impugnazione incidentale inerisca ad atti diversi da quelli che formano oggetto del ricorso principale, legittimata passivamente sarà certamente anche l’amministrazione che ha emesso tale atto; nonché tutti i soggetti controinteressati rispetto a tale atto, ancorché diversi dalle parti già evocate in giudizio. Nelle azioni di accertamento il ricorso incidentale costituirebbe, poi, secondo un certo indirizzo, la “veste formale” per la (proposizione della) domanda riconvenzionale in senso proprio. Su tutti questi aspetti, tuttavia, non sembra potersi evincere un appiglio in favore dell’uno o dell’altro orientamento, stante la più volte richiamata laconicità del testo legislativo sul punto. Il c. 5 dell’art. 42 afferma che nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi “le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo”. Dalla formulazione di tale disposizione, tuttavia emerge un’incongruenza che potrebbe comportare in futuro qualche problema di contrasto costituzionale. La scelta di subordinare la tutela di un diritto al rispetto di termini perentori di impugnazione lascia intravedere la possibilità di un’ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il diritto soggettivo venga azionato avanti al giudice amministrativo, anziché avanti al giudice ordinario. Anche il codice di procedura civile sottopone ad un regime di preclusioni molto stringente la proposizione di dette azioni, per cui, anche in virtù di detta similitudine, potrebbe giustificarsi la struttura del c. in esame. Sezione seconda: La fase cautelare 1. Dalla norma sulla sospensione del provvedimento impugnato alla misura cautelare atipica ed alle disposizioni del codice Prima della l. 205/2000, nel processo amministrativo era ammessa una sola misura cautelare e tipica: la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. La Corte cost., poi, con la sentenza n. 190/ 1985 aveva aggiunto la possibilità che il giudice amministrativo, nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, potesse adottare i provvedimenti d’urgenza che apparissero più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. L’apertura della Corte cost., però, non solo era estendibile a tutte le controversie in materia di pubblico impiego che non fossero patrimoniali ed alle altre materie di giurisdizione esclusiva ma, anche per il pubblico impiego, vedeva una scarsa applicazione da parte della giustizia amministrativa. Le norme che in precedenza regolavano la tutela cautelare erano scarne e si potevano racchiudere in questa disposizione: il giudice amministrativo sospende l’esecuzione del provvedimento amministrativo quando il ricorrente alleghi danni gravi ed irreparabili. La misura introdotta da quando è stata istituita la Sezione IV del Consiglio di Stato, era strumentale alla sentenza di annullamento che poteva adottare il giudice amministrativo: si poteva sospendere l'esecuzione dell’atto che, poi, con la sentenza poteva essere annullato, consolidandosi l’effetto della privazione interinale dell’efficacia ed eliminando gli effetti eventualmente prodottisi prima della sospensione. Le disposizioni sull’esercizio del potere cautelare e sul procedimento sono esatta manifestazione dell'idea che il legislatore aveva della sospensione: un incidente del processo amministrativo a carattere eventuale e di rara applicazione. Quando, però, si è avuta una forte domanda di giustizia amministrativa che ha reso impossibile definire il giudizio, il momento cautelare da incidente del processo è divenuto lo strumento per dare soddisfazione all’interesse del ricorrente, senza la necessità di attendere una sentenza che, se giungeva, arrivava tardi. Da qui le cure che la dottrina e la giurisprudenza hanno dedicato all’istituto che ha assunto una propria fisionomia modellata sulle necessità della tutela urgente da assicurare al ricorrente. La sospensione del provvedimento impugnato era l’unica misura ammissibile non solo nel giudizio di legittimità, ma anche nella giurisdizione di merito ed esclusiva. Il giudice amministrativo, pertanto, ha potuto utilizzare solo questo strumento cautelare in tutti i tipi di giudizio, anche nella giurisdizione esclusiva e pur in presenza di diritti soggettivi. L'istituzione della giurisdizione esclusiva non ha portato ad alcuna modifica della struttura del processo che è rimasto legato allo schema dell’annullamento del provvedimento impugnato, per cui, data la strumentalità della misura cautelare, non era pensabile un altro tipo di cautela. Ma la giurisprudenza ha dovuto operare nella direzione di dare una tutela effettiva alle situazioni giuridiche soggettive, adattando la sospensione alle esigenze che si venivano ponendo. La giurisprudenza amministrativa è andata nella direzione di ampliare la possibilità di tutela cautelare, per renderla effettiva. In un primo tempo, la sospensione dell’esecuzione è stata riferita esclusivamente agli effetti materiali, mitigando, nel tempo, il limite derivante dall’avvenuta produzione nel reale degli effetti giuridici con il distinguere tra esecuzione “istantanea” e “a carattere continuativo”. Era istantanea l’esecuzione che si risolveva nella produzione di effetti che non si protraevano nel tempo, mentre aveva carattere continuativo l’esecuzione che produceva effetti nel tempo. La giurisprudenza riteneva non sospendibili gli atti negativi poiché non producono effetti materiali ma poi ha cominciato a mutare orientamento interpretando diversamente la “esecuzione” su cui interveniva la sospensione. E si fa riferimento agli atti negativi in senso proprio che non determinano effetti innovativi sul reale perché già in precedenza, il Consiglio di Stato sospendeva i provvedimenti che negavano la conferma di situazioni di vantaggio attribuite da precedenti atti amministrativi e, quindi, determinavano l’effetto materiale di cessazione della situazione di vantaggio. Tali atti, ancorché negativi, determinano però necessità di modificazione del reale, producono cioè effetti materiali e, quindi, per essi la misura cautelare della sospensione è idoneo strumento di tutela urgente, pur nell’ottica che identifica esecuzione con effetto materiale. È dagli anni ’60 che comincia a divenire apprezzabile quantitativamente la giurisprudenza relativa alla sospensione degli atti negativi, per poi divenire imponente a seguito dell’istituzione dei T.A.R. che hanno comportato un notevole incremento del numero dei ricorsi, con conseguente dilatarsi dei tempi necessari per ottenere la decisione. Il tempo necessario ad ottenere la decisione nel merito non può andare in danno di colui che invochi tutela, per cui il giudice amministrativo, forte di questa idea di giustizia, si è spinto a sospendere diverse tipologie di atti negativi. La sospensione del provvedimento di esclusione dal concorso è stata determinata da considerazioni di ordine pratico: “l'esecuzione del provvedimento avrebbe causato l'esclusione della ricorrente dal concorso, mentre nulla poteva esservi in contrario a che la ricorrente intanto vi prendesse parte; salvo a considerare non avvenuta tale partecipazione nel caso di rigetto del ricorso”. Ma, una volta imboccata la via della sospensione degli atti negativi, si è passati a sospendere atti negativi di controllo, provvedimenti di esclusione alla partecipazione a gare di appalto, atti di non ammissione di studenti agli esami di maturità, ecc. La giurisprudenza più rigorosa, però, non è giunta a sospendere tutti gli atti negativi, ma soli quelli i cui effetti sono preregolati dalla norma o dagli atti endoprocedimentali secondo cui la sospensione toglie un limite alla negazione di effetti innovativi, ma non pone una regola degli effetti da produrre. Essa funge, quando la sospensione riguardi atti ad effetti innovativi, da ostacolo che impedisce la concretizzazione degli effetti, mentre quando va ad incidere su atti negativi, senza effetti innovativi, elimina l’ostacolo alla produzione degli effetti. Ma il giudice, nell’uno e nell’altro caso, non determina gli effetti dal punto di vista del loro contenuto perché la regola degli effetti non è stabilita dall’ordinanza. Ecco che è possibile la sospensione degli atti negativi quando gli effetti positivi sono già fissati dalla norma, dagli atti endoprocedimentali e non devono essere stabiliti nel loro aspetto contenutistico. La giurisprudenza, soprattutto del giudice di primo grado, però, ha sospeso tutti i tipi di atti negativi ed ordinato alla p.a. di riesaminare la questione alla luce dei motivi di ricorso o di specifici elementi, di fatto o di diritto, indicati nella motivazione o in altro modo, nell’ansia di assicurare una tutela urgente agli interessi legittimi pretensivi che, diversamente, avrebbero dovuto attendere i lunghi tempi necessari alla definizione del giudizio di merito. In sintesi, la giurisprudenza è passata dalla tutela cautelare dei soli interessi legittimi oppositivi, con il ritenere che la sospensione dell'esecuzione dovesse riguardare i soli effetti materiali dell’atto impugnato, alla tutela anche degli interessi legittimi pretensivi, seguendo la tesi che l’esecuzione attiene agli effetti giuridici in senso stretto, con conseguente ripercussione anche sugli effetti di adeguamento del reale. In sostanza, la misura cautelare ha seguito l’evoluzione del giudizio di merito che, attraverso l’effetto conformativo, è giunto a dare soddisfazione (anche) agli interessi legittimi pretensivi. Con il d.lgs. n. 80/1998 e con la l. n. 205/2000 è mutato il quadro della tutela innanzi al giudice amministrativo che ha visto accrescere i suoi poteri, non solo istruttori, ma soprattutto decisori con l’introduzione delle azioni di condanna al risarcimento del danno, anche in forma specifica. Necessariamente, la misura cautelare doveva adeguarsi, non potendo rimanere solo quella tipica di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato che, nella forma per così dire pura, è strumentale esclusivamente ad una sentenza di annullamento dell'atto. Con l’art. 3 della l. 205/2000, la misura cautelare diventa atipica; infatti, non si specifica quale sia il tipo di provvedimento cautelare che possa adottare il giudice, perché possono emanarsi le “misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”, così rendendo possibile qualunque provvedimento urgente strumentale alle decisioni che il giudice può assumere con la sentenza. Il Codice mantiene l’impianto sul contenuto atipico delle misure cautelari introdotto dalla l.205/2000, ma dedica ad esse diverse disposizioni dando loro il rilievo e l’importanza che hanno nel processo amministrativo. Queste disposizioni si riferiscono a ciò: - è di trenta giorni il termine finale di efficacia del provvedimento cautelare, quando viene dichiarato il difetto di giurisdizione o di competenza territoriale del giudice che lo ha emanato, o di sessanta giorni il dies ad quam dell'efficacia della misura cautelare disposta nel ricorso straordinario al PDR, in caso di opposizione delle altre parti alla trattazione in detta sede; - l’inderogabilità della competenza territoriale del giudice di primo grado, anche per l’adozione delle misure cautelari, fissando le regole cui deve attenersi il giudice, quando non riconosca la propria competenza e la possibile reiterazione della domanda cautelare al T.A.R., indicato competente dal T.A.R. preventivamente adito, nelle more della definizione del regolamento di competenza e, comunque, la riproposizione dell’istanza cautelare al giudice dichiarato competente; - la pronunzia di “provvedimenti cautelari interinali”, nelle more dell’integrazione del contraddittorio; la riduzione del termine per la fissazione dell’udienza di discussione, da sessanta a quarantacinque giorni, “su accordo delle parti”, “a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare”; - la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado e di secondo grado, ad opera del Consiglio di Stato, in caso di ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. Ulteriori disposizioni sono dettate per i “riti abbreviati relativi a speciali controversie”. Il Codice, quindi, detta la disciplina centrale con gli articoli da 55 a 62, e interviene puntualmente con specifiche disposizioni, in diverse fasi del processo, preoccupandosi di stabilire le regole da cui sono rette le misure cautelari. Il legislatore delegato, per la disciplina delle misure cautelari, non opera alcun rinvio ad altre norme di legge, né, soprattutto, al codice di procedura civile a differenza di quello che avviene in tante parti del Codice. L'istituto ha una sua peculiarità che lo distingue in maniera decisa dalle misure cautelari previste negli altri processi e, in particolare, da quelle previste dal codice di procedura civile, assegnandogli una sua piena matura autonomia. La misura cautelare non solo non è più un “incidente” ed una fase parentetica, a carattere eventuale e di rara applicazione, ma è uno snodo centrale del processo sotto due profili: a) per la celerità, efficacia ed efficienza della misura che può intervenire a tutela del ricorrente sia conservando inalterata la situazione in attesa della decisione di merito, sia anticipando quest’ultima, potendo il giudice adottare qualunque misura idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso; b) per costituire l’unica possibilità d’investire il giudice della conoscenza del ricorso prima che sia fissata l’udienza di discussione. 2. Le misure cautelari atipiche ed il carattere della strumentalità L’art. 55, c. 1, del Codice recita: “Se il ricorrente allegando di subire un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronunzia con ordinanza emessa in camera di consiglio”. Rispetto alla previsione dell’art. 3 della l. 205/2000, a parte marginali modifiche non rilevanti, vi è la soppressione, dopo il riferimento al pregiudizio grave ed irreparabile, di “derivante dall'esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte della amministrazione. La modifica è intervenuta perché la giurisdizione amministrativa concerne in via generale, non più il solo atto o il comportamento inerte, ma “l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”, per cui sarebbe stato riduttivo mantenere il contenuto della precedente disposizione, dal momento che la misura cautelare può investire qualunque aspetto della giurisdizione amministrativa. Da altro punto di vista, la disposizione conferma una linea di fondo del Codice diretta a contenere la giurisdizione sull’atto amministrativo, in precedenza aspetto dominante del processo amministrativo. La previsione all'art. 3 della l. 205/2000, ricalca la formula usata dall’art. 700 c.p.c., con la sostituzione di “provvisoriamente”, che figura nel codice di procedura civile, con “interinalmente”, e di “sul merito”, con “sul ricorso”. Sono mere varianti terminologiche. La collocazione, però, dell’art. 700 c.p.c. nell’ambito dei provvedimenti di urgenza è diversa dalla norma di cui qui si discute. L’art. 700 c.p.c. è misura cautelare, sì atipica, ma residuale, nel senso che tale azione può essere promossa solo quando non si possano richiedere i provvedimenti tipici, quali la denunzia di nuova opera e di danno temuto, il sequestro, ecc. Invece, la misura cautelare prevista dalla l. n. 205/2000 ed ora dal Codice, è sì atipica (perché non predeterminata), ma non residuale, bensì unica misura stabilita nel processo amministrativo. Ed unica, non solo tra le misure cautelari, ma anche per le tre giurisdizioni del giudice amministrativo e cioè quelle di legittimità, di merito ed esclusiva. E ciò perché, modellando il suo contenuto sulle decisioni, si adatta ai poteri decisori del giudice amministrativo, quali che siano e, quindi, a prescindere dal tipo di giurisdizione che esercita. La sua unicità, però, non comporta alcuna restrizione di mezzi cautelari; anzi, si può dire che essi vengono ampliati al massimo grado possibile, pur nelle limitazioni proprie di ogni misura cautelare. Qui, infatti, diventa diritto positivo il principio della strumentalità della misura cautelare che la dottrina aveva individuato come carattere ontologico di questi rimedi processuali. I provvedimenti urgenti hanno la loro ratio nella necessità di impedire che la durata del processo possa risolversi in danno di chi abbia subito un’illegittima lesione della sua situazione giuridica soggettiva: se fosse possibile un processo istantaneo, non ci sarebbe alcuno spazio per misure cautelari; sennonché, il processo deve avere una sua durata fisiologica perché deve assicurare il rispetto di alcune regole fondamentali quali il contraddittorio, l’istruttoria adeguata, che hanno necessità di svolgersi diacronicamente e che non possono essere “affogati” in una decisione immediata. Proprio la sua stessa ragion d’essere assegna un ruolo non autonomo alla misura cautelare che viene strettamente a correlarsi alla decisione di merito della quale si fa strumento nel disporre interinalmente gli effetti che successivamente saranno regolati dalla sentenza. Il giudice può anticipare gli effetti della decisione finale o assicurare che la situazione non venga modificata in attesa della disciplina degli effetti che sarà dettata dalla sentenza o determinare degli effetti quantitativamente minori rispetto a quelli che potranno stabilirsi a conclusione del processo, ma non potrà assegnare dei risultati e degli effetti qualitativamente diversi e quantitativamente maggiori e più ampi di quelli conseguibili con la sentenza. La strumentalità della misura cautelare si connota sul piano strutturale o formale e rappresenta la necessità che debba intervenire una sentenza, siccome il provvedimento giurisdizionale urgente produce effetti interinali sino alla decisione nel merito, nonché sul piano funzionale o sostanziale in relazione alla “qualità” e “quantità” degli effetti che non possono essere diversi o maggiori di quelli ottenibili con la sentenza. La strumentalità della misura cautelare è chiaramente scolpita dalla norma ove si afferma che può essere chiesta “l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”. Infatti, “interinalmente” e pagamento di “somma in via provvisoria” sottolineano la provvisorietà degli effetti della misura cautelare che cessano con la (necessaria) emanazione della sentenza (strumentalità strutturale) e l’assicurare “gli effetti della decisione sul ricorso” lega il contenuto degli effetti cautelari alla sentenza di merito (strumentalità funzionale). Inoltre, la norma, mentre assegna una varietà tipologica non predeterminata di provvedimenti cautelari assumibili poiché fa riferimento alle misure più idonee, pone un limite ben preciso all’ammissione delle misure cautelari: gli effetti della decisione sul ricorso (strumentalità funzionale). Quindi l’esaltazione della natura strumentale costituisce la ricchezza ed il limite della misura cautelare. 3. Le sentenze del giudice amministrativo modello delle ordinanze cautelari Il giudice amministrativo può: annullare l’atto amministrativo; ordinare all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine; condannare al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento; condannare la p.a. all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio; condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica; disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta, già in sede di cognizione; nella giurisdizione di merito, adottare un nuovo atto ovvero modificare o riformare quello impugnato. Ne consegue che in sede cautelare possono essere adottati: la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, strumentale all’annullamento dell’atto; la “ingiunzione a pagare una somma”, correlata o meno alla condanna risarcitoria; i provvedimenti anticipatori della reintegrazione in forma specifica e, soprattutto, i provvedimenti di contenuto atipico correlati a due profili: a) alla sentenza funzionale alla soddisfazione piena ed effettiva del ricorrente; b) alla misura idonea ad assicurare l’attuazione del giudicato, anche con la nomina di un commissario ad acta, sempre strumentale ad una sentenza di cognizione che può avere questo contenuto. Quanto alla giurisdizione di merito, i poteri decisori sono più ampi e giungono sino alla possibilità, non solo di modificare o riformare un atto amministrativo, ma di sostituirlo, per cui le misure cautelari possono consistere nell’adozione di un provvedimento, oltre che nella sua modifica o riforma. La modulabilità dei provvedimenti urgenti in relazione alla decisione assumibile dal giudice, fa si che muti la posizione del ricorrente nel chiedere la misura cautelare poiché è necessario specificare il tipo di provvedimento richiesto, dal momento che il giudice non può pronunziarsi oltre la domanda del ricorrente, stante il principio dispositivo vigente nel processo amministrativo. Nel prevedere l’emanazione di misure cautelari che appaiono più idonee, secondo le circostanze, non si consente al giudice di provvedere d’ufficio, snaturando così il carattere dispositivo del processo; mentre in precedenza il provvedimento cautelare era tipico ed il ricorrente poteva limitarsi a chiedere la sospensione, modulandosi poi gli effetti in relazione alla concreta controversia, ora la varietà delle misure cautelari impone la specifica richiesta del ricorrente. 4. Le ipotesi in cui la misura cautelare supera il nesso di strumentalità con la sentenza di merito Nel processo civile ordinario, si è stabilito che i provvedimenti cautelari mantengono i loro effetti anche se non venga iniziato il giudizio di merito (provvedimenti ante causam) o, se iniziato, per una qualunque ragione si estingua (provvedimenti sia ante causam che in causa), se: “emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c.”, “idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito”, “emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno tenuto ai sensi dell’art. 688”. Ciascuna parte, però, può iniziare il giudizio di merito e “l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”. Il legame di strumentalità strutturale (necessità che intervenga una sentenza di merito) si è sciolto perché le parti potrebbero decidere di non volere la sentenza e non attivarsi per ottenere una soluzione suscettibile di passare in giudicato. È rimesso alla volontà delle parti giungere o meno alla sentenza, esaltando il carattere dispositivo del processo. Insomma la strumentalità strutturale della misura cautelare è superata se lo vogliono le parti perché, diversamente, è mantenuta ed assicurata dalle disposizioni processuali, a favore di tutte le parti. Nel processo amministrativo si è verificata una situazione simile. Il legislatore, ha stabilito che “l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati” sono conseguiti ad ogni effetto se vengono superate le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, “anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Il che significa, ad esempio, che se il giudice amministrativo disponga, con la misura cautelare, per un aspirante avvocato non ammesso agli orali, che la Commissione ripeta la valutazione e, con il riesame, il candidato venga ammesso agli orali, superandoli, l’abilitazione professionale di avvocato è conseguita ad ogni effetto, senza che il giudice debba pronunziare sentenza nel merito per accertare se la (prima) valutazione della Commissione, negativa sugli scritti, sia illegittima o meno. Qui salta non solo la strumentalità strutturale (non occorre più la sentenza di merito) ma, forse, anche quella funzionale perché, per effetto della misura cautelare e del conseguente completamento della valutazione del candidato, si consegue l’abilitazione professionale che la sentenza non avrebbe potuto assegnare, dovendo il merito intervenire solo sulla legittimità della non ammissione. Inoltre, sempre a differenza del processo civile, non è rimessa alle parti la scelta di chiedere la sentenza di merito perché la disposizione è imperativa e la misura cautelare si trasforma in sommaria, acquisendo l’autorità di giudicato. Si può affermare che la provvisorietà, tipica del provvedimento cautelare, destinata ad esaurirsi con la decisione nel merito, assume più la funzione dei provvedimenti sommari in senso proprio e cioè aspira a diventare definitiva, senza che occorra la sentenza. È controverso in giurisprudenza se la norma riguardi esclusivamente i procedimenti finalizzati alla verifica dell’idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio (o l'accesso alla quale) sia subordinato all’espletamento di prove selettive, o sia applicabile anche ai concorsi che prevedano un numero predeterminato di vincitori. Altresì discussa è in giurisprudenza la stessa interpretazione della disposizione proprio nell’esempio dell’aspirante avvocato: si produrrebbero gli effetti stabiliti dall’art. 4 l. 168/2005 quando il candidato abbia superato le prove scritte e orali sulla base di: a) un’ordinanza cautelare favorevole non appellata dall’Amministrazione; b) un'ordinanza cautelare favorevole confermata in appello. In sostanza occorre che l’Amministrazione non contesti con l’appello la misura cautelare di primo grado ovvero che lo stabilisca il Consiglio di Stato, collegando l’effetto stabilito dalla legge alla definizione conclusiva della fase cautelare e cioè quando l’ordinanza non sia più appellabile o sia stata confermata. È stata rimessa alla Corte Cost. la questione di legittimità costituzionale della disposizione per violazione: della strumentalità strutturale e funzionale della misura cautelare, deducibile dal principio di uguaglianza, ragionevolezza e giusto processo; della garanzia dell'effettività del contraddittorio perché il controinteressato, se non interviene nella fase cautelare, non può partecipare al giudizio di merito che non si tiene; del giudice naturale precostituito per legge -quello di merito-; dell’impugnabilità in appello e del riesame che vengono, quanto meno di fatto, preclusi all’Amministrazione resistente ed al controinteressato, con la conseguenza che il T.A.R. può diventare giudice di unico grado, determinando disparità di potere di appello delle parti. La Corte Costituzionale ha deciso che la questione è infondata. Parte consistente della giurisprudenza amministrativa, prima della l. 168/2005, aveva seguito la medesima soluzione normativa nelle ipotesi di sospensione giudiziale della non ammissione all'esame di maturità e conseguente ammissione con riserva che porta ad un esito favorevole delle prove d'esame (l’esito positivo delle prove di maturità assorbe il giudizio sfavorevole sull'ammissione, determinando la superfluità della valutazione nel merito del ricorso e la sentenza non valuta la legittimità o meno della non ammissione, ma prende atto dell'esito favorevole delle prove di maturità). Altri casi sono quelli dell’ammissione giudiziale con riserva a concorsi pubblici, a gare o a procedimenti selettivi, anche se non si è in presenza di un orientamento costante. Occorre, altresì, tenere presenti le ordinanze cautelari che dispongono il riesame del provvedimento impugnato e che non riguardano solo settori dell'attività amministrativa ma ogni controversia e settore dell'attività amministrativa. Il giudice amministrativo, in sede cautelare, può ordinare all’Amministrazione di procedere al riesame sulla base dei motivi di illegittimità contenuti nel ricorso. L’Amministrazione riapre il procedimento ed esercita nuovamente il potere, adottando altro provvedimento, sostitutivo di quello impugnato sia quando il dispositivo dell’atto è il medesimo di quello impugnato che nell’ipotesi in cui soddisfi l’interesse del ricorrente. Nel primo caso, infatti, pur se il provvedimento presenti la stessa regolamentazione degli interessi stabilita con l’atto impugnato, si è in presenza del rinnovato esercizio del potere amministrativo che priva il ricorrente dell’interesse ad ottenere la sentenza nel merito, concludendosi il giudizio con una declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse e l'interessato, se lo ritiene, può impugnare il provvedimento di riesame. Nel secondo caso il giudizio si chiuderà con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, senza valutazione della legittimità del (primo) provvedimento impugnato. Dunque, se l'ordinanza cautelare disponga il riesame, il giudizio, comunque, viene definito con la misura urgente, non dovendo più il giudice, nella sede cognitoria e decisoria, valutare la legittimità del (primo) provvedimento. Nelle ipotesi descritte, la strumentalità della misura cautelare viene superata sul piano strutturale e, forse, anche funzionale, e trasformata in provvedimento sommario, non più provvisorio e interinale, ma definitivo. Il Codice ha ignorato questo problema. 5. I procedimenti Il Codice individua quattro tipi di provvedimenti cautelari: 1- l’ordinanza collegiale (art. 55 c.p.a.) 2- il decreto monocratico in causa (art. 56 c.p.a.) 3- il decreto monocratico anteriore alla causa (art. 61 c.p.a.) 4- l’ordinanza collegiale o il decreto interinale in attesa dell'integrazione del contraddittorio (art. 27, c. 2, c.p.a.). I primi tre tipi concludono procedimenti appositamente disciplinati dalla legge, mentre il quarto non ha un proprio procedimento. Quest’ultimo, può intervenire sia nel corso del procedimento relativo all’ordinanza collegiale che dei procedimenti riguardanti le misure monocratiche in causa ed ante causam perché, nelle more dell’integrazione del contraddittorio, evento che può determinarsi sia per le misure collegiali che per quelle monocratiche, “il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali” che assumeranno la forma dell'ordinanza collegiale o del decreto monocratico, a seconda che le adotti il collegio o il presidente. Il procedimento riguardante le misure cautelari collegiali può definirsi ordinario e necessario, sia perché la fase cautelare normalmente si svolge innanzi al collegio, sia perché, anche quando si seguano gli altri procedimenti, la fase cautelare di primo grado si conclude, comunque, con l’ordinanza collegiale. Infatti, i provvedimenti cautelari adottati con decreto monocratico debbono passare al vaglio del collegio ed hanno efficacia sino alla pronunzia di quest’ultimo che chiude la fase cautelare. Dunque, l'ordinanza collegiale chiude la fase cautelare e produce effetti (salvo l’esito dell'appello) sino alla sentenza che definisce il ricorso, mentre i decreti monocratici hanno efficacia interinale, al massimo sino all’ordinanza collegiale che definisce la fase cautelare. Efficacia, che si protrae sino alla conclusione della fase cautelare, hanno anche le misure provvisorie adottate, con decreto monocratico o ordinanza collegiale, nelle more dell’integrazione del contraddittorio. Presupposto processuale per ogni provvedimento cautelare è la verifica, anche d’ufficio, della competenza territoriale che, con il Codice, è divenuta inderogabile e la presentazione dell’istanza di discussione, salvo che debba essere fissata d’ufficio; quest'ultima, però, per la misura cautelare ante causam va depositata con il successivo ricorso. È forse eccessiva la previsione di due riti per i decreti monocratici: sarebbe stato sufficiente il solo decreto ante causam, semplificando i procedimenti. Invece, la doppia previsione renderà difficile, nel concreto, apprezzarne la diversità dei presupposti dell’urgenza, indicati per il decreto monocratico in causa nella “estrema gravità di urgenza”, e, per quello anteriore alla causa, nella “eccezionale gravità ed urgenza”, anche se correlata a non consentire, nel primo caso, “neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” e, nel secondo, “neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale” e, cioè, in sostanza, nemmeno la redazione del ricorso con l’esposizione dei fatti e l’articolazione dei motivi. 6. Il procedimento ordinario La domanda cautelare può proporsi con il ricorso o con istanza successiva alla presentazione del ricorso, indirizzandola al giudice presso cui pende la controversia. In questo caso occorre notificare l’istanza cautelare alle altre parti e, se queste ultime sono costituite, presso i difensori nel domicilio eletto e, quindi, depositarla presso la segreteria del giudice amministrativo. Sulla domanda cautelare, il giudice pronunzia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le altre parti possono depositare memorie e documenti “fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”. Il termine dei due giorni liberi può essere superato per la produzione dei documenti se il collegio “per gravi ed eccezionali ragioni” le autorizzi. Nella camera di consiglio, però, è ammessa comunque la costituzione formale delle altre parti (non la memoria), pur senza il rispetto del termine dei due giorni liberi ed i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. È prassi però che il ricorrente e le altre parti siano ammesse all’illustrazione della questione in camera di consiglio, anche se non vi sia richiesta di essere sentite. L'esame della domanda cautelare, precedentemente al Codice, era fissata alla prima camera di consiglio utile, decorsi dieci giorni dall’ultima notifica, e le altre parti potevano costituirsi anche il giorno fissato per l'esame della misura cautelare, depositando memorie e documenti. Era un’alterazione del contraddittorio “in condizioni di parità”, sia per il ricorrente che si trovava in camera di consiglio di fronte a documenti e deduzioni su cui doveva prendere posizione all’istante e senza la possibilità di consultare la parte per documenti non noti al difensore, che per le altre parti le quali avevano un termine ridotto per esporre le loro ragioni rispetto al ricorrente che aveva sessanta giorni, specie, poi, se il giudice decideva con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio. La previsione di un margine di tempo più lungo (venti giorni) per la fissazione della camera di consiglio e di un termine di due giorni liberi per il deposito delle memorie e dei documenti è tesa a riequilibrare il contraddittorio tra le parti. Il termine di venti giorni è dimezzato -dieci giorni- nei giudizi aventi ad oggetto le controversie indicate nel Titolo V del Libro IV. La giurisprudenza precedente il Codice, riteneva non necessaria la previa comunicazione formale ai difensori della data di trattazione, se il processo segue lo sviluppo stabilito dalla legge e cioè esame della istanza cautelare effettuata nella camera di consiglio che accede alla prima udienza pubblica successiva al deposito del ricorso, dopo la scadenza del termine allora di dieci giorni, ora di venti, dall’ultima notifica dell’atto introduttivo. Se, invece, la trattazione avviene in data diversa da quella legalmente stabilita, occorre l’avviso di comunicazione della data fissata per la camera di consiglio, da effettuarsi con i mezzi ordinari o anche con uso di mezzi alternativi, quali telefono, telegrafo e simili purché offrano adeguata garanzia dell’effettiva conoscibilità dell’atto. L’art. 136 del Codice ha stabilito che il difensore indichi nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intende ricevere le comunicazioni e che si presumono conosciute se pervenute con i detti mezzi. La trasmissione per e-mail o fax è senz’altro ammissibile. La fase cautelare, ritualmente introdotta, non impedisce il decorso del termine annuale di perenzione, sia nel caso in cui si sia conclusa con un provvedimento favorevole o sfavorevole all’interessato, sia nel caso in cui il giudice non si sia pronunziato; il decorso della perenzione è impedito solo dal deposito dell’apposita domanda di discussione che, peraltro, costituisce presupposto per la procedibilità della domanda cautelare, salvo che l’udienza di discussione debba essere fissata di ufficio. Il giudice pronunzia con ordinanza, immediatamente esecutiva e motivata. La motivazione deve riguardare anche i profili che inducano ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso. 7. Presupposti per la concessione della tutela cautelare.· pregiudizio grave ed irreparabile e fumus boni iuris Il ricorso non produce automaticamente effetti cautelari, dovendo intervenire un provvedimento espresso del giudice, salvo diverse disposizioni di legge come nel caso del ricorso nelle controversie degli appalti pubblici. Infatti, è previsto uno stand still period di 35 giorni dalla comunicazione ai concorrenti dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto in cui non si può sottoscrivere il contratto (quindi, dare esecuzione all’appalto) e, in caso di ricorso, con domanda cautelare, non può essere stipulato il contratto, sino a quando non venga decisa in primo grado la misura urgente. L'art. 55 del Codice richiede, come l’art. 3 della l. 205/2000, per l’accoglimento della domanda cautelare un “pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso” nonché “i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso”. Il pregiudizio ha ormai sostituito i danni, previsti dall’art. 21, l. 1034/1971, e viene ribadito che va considerato il fumus boni iuris, già prima della l. 205/2000 apprezzato dal giudice, pur in assenza di una specifica norma. Il pregiudizio pare rappresentare qualcosa di meno rilevante rispetto al danno che richiede, comunque, una quantificazione economica e, soprattutto, che esso appare svincolato dall’imminenza ed attualità che, viceversa, connota il pregiudizio nella formula di cui all'art. 700 c.p.c. che, appunto, deve presentarsi come “imminente ed irreparabile”. Quello che appare più significativo è la correlazione tra il pregiudizio ed il tempo necessario per definire il giudizio. Cioè, rispetto al riferimento dei danni gravi ed irreparabili derivanti dall’esecuzione dell'atto, la norma evidenzia come il pregiudizio vada apprezzato considerando il tempo necessario a giungere alla sentenza. Se, in precedenza poteva essere indicativo della ricorrenza dei danni gravi ed irreparabili la considerazione della tipologia degli atti amministrativi impugnati e degli effetti da essi prodotti, ora occorre por mente al pregiudizio derivante dalla durata del processo. In sostanza, un medesimo atto amministrativo può recare pregiudizio grave ed irreparabile, a seconda della durata del processo innanzi allo specifico T.A.R. investito del ricorso. E così, mentre per i giudici amministrativi di primo grado che hanno un basso tasso di contenzioso ed una durata non eccessiva dei processi occorrerà apprezzare con maggiore rigore il pregiudizio, viceversa per i T.A.R. i cui processi hanno considerevole durata il pregiudizio potrà dirsi quasi in re ipsa. Quanto al fumus boni iuris, la norma impone che la motivazione debba riguardare il pregiudizio e, appunto, i profili che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. È opportuno applicare la norma che impone la motivazione che è necessaria non solo perché connotato essenziale di ogni provvedimento giurisdizionale, ma anche per ragioni di trasparenza. L'assenza di motivazione assimila la fase di appello avverso le ordinanze dei T.A.R. ad un ulteriore primo grado, anche se accentrato, perché il Consiglio di Stato non ha modo di verificare l’iter argomentativo seguito dal primo giudice. Il vincolo sulla decisione di merito non può esservi se si considera che la misura cautelare viene decisa in base ad una sommaria cognitio e se si crede nel valore del contraddittorio che, nella fase cognitoria del processo, offre maggiori e diversi elementi, di fatto e di diritto, alla valutazione del giudice che ha il poteredovere di cambiare idea, eventualmente, sulla soluzione della controversia. Il giudice amministrativo, a differenza di quanto avveniva in precedenza, motiva le ordinanze cautelari. 8. La prestazione della cauzione L’art. 55 del Codice mantiene la possibilità di imporre la prestazione di una cauzione, qualora dalla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, aggiungendo il contenuto che deve avere il provvedimento che la impone. La prestazione della cauzione non può essere disposta quando la domanda cautelare “attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale”. Alla prestazione della cauzione è subordinata la concessione o il diniego della misura cautelare per cui può essere posta a carico sia del ricorrente, ma anche del resistente e del controinteressato. Il giudice deve stabilire l’entità della cauzione e “l’oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita” e può anche essere assolta mediante fideiussione. Quindi: a) ha carattere generale, salvo le espresse eccezioni; b) il presupposto della sua previsione è l’irreversibilità degli effetti derivanti dalla decisione sulla domanda cautelare; c) può essere prestata da tutte le parti, a seconda dell’accoglimento o del rigetto della misura cautelare; d) il giudice deve stabilire oggetto, modalità, termini ed entità della cauzione che può essere prestata anche con fideiussione. In realtà, è inesatta la disposizione che ne fissa il presupposto nella irreversibilità degli effetti derivanti “dalla decisione sulla domanda cautelare”. Infatti, essendo possibile disporre la cauzione anche se venga negata la misura cautelare, appare evidente che, in questo caso, nessun effetto irreversibile possa derivare dall’ordinanza del giudice, ma semmai dall’oggetto dell’impugnativa. L’imperfezione, però, non dovrebbe creare problemi nell'applicazione concreta dell’istituto, anche quando il giudice ritenga di rigettare la misura richiesta e disporre cauzione a carico del resistente o del controinteressato in conseguenza degli effetti irreversibili prodotti da quanto forma oggetto di impugnativa. Così, nell’ipotesi di appalto di servizi, con misura cautelare negata, ove la cauzione può essere stabilita rapportandola al possibile danno causato al ricorrente che illegittimamente risultasse non aggiudicatario; nel caso di ordinanza di demolizione di immobile, non sospesa, a garanzia del ristoro del danno sofferto dal ricorrente, qualora si accertasse l’illegittimità della (eseguita) riduzione in pristino. La cauzione viene disposta in base ad una valutazione diversa ed autonoma dall’accoglimento o dal rigetto della misura cautelare e cioè dall’irreversibilità degli effetti prodotti dall'ordinanza cautelare, in caso di accoglimento, o dal provvedimento (o accordo o comportamento) impugnato, qualora la domanda cautelare, nonostante la irreversibilità degli effetti, non venga accolta in considerazione di rilevanti interessi contrari, pubblici e/o privati, presenti nella fattispecie concreta. Può essere riformata in appello l’ordinanza del T.A.R., anche limitatamente alla sola cauzione disposta in primo grado, se non sussistano i presupposti previsti dalla legge. È difficile da definire quando non sia consentito disporre cauzione perché il legislatore, a parte i diritti fondamentali della persona, la esclude anche per gli “altri beni di primario rilievo costituzionale”. Il giudice, nel determinare l’importo della cauzione, l’oggetto, il termine e le modalità della prestazione deve stabilirli in modo da rendere possibile, per la parte gravata, la prestazione della cauzione, per cui non può essere rappresentata da una somma ingente, tenuto conto degli effetti irreversibili e della qualità delle parti, e non possono essere fissati termini impossibili da rispettare. Il diniego o l’accoglimento della misura cautelare sono subordinati alla prestazione della cauzione, per cui opera come una condizione sospensiva e cioè gli effetti dell’accoglimento o del rigetto non si verificano, se non venga prestata la cauzione. Ma bisogna distinguere tra l'accoglimento ed il rigetto. In caso di accoglimento della domanda la misura cautelare produrrà gli effetti stabiliti dal giudice, quando sarà prestata la cauzione. Quando venga respinta la domanda cautelare, gli effetti stabiliti dal provvedimento, dal comportamento della p.a. o dall'accordo e non dal giudice, si produrranno (riprenderanno a prodursi), se sarà prestata la cauzione. In questo secondo caso, la mancata prestazione della cauzione impedirà di porre in esecuzione il provvedimento impugnato o l'accordo ovvero di continuare nel comportamento pregresso, ma sarà necessario un espresso dictum del giudice se la misura cautelare satisfattiva dell’interesse del ricorrente sarà diversa dalla mera sospensione dell’esecuzione. Infatti, dovrà stabilirsi la misura più idonea “ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”. Ed allora qui sarà necessario che, nell’ordinanza di rigetto, venga stabilita la misura cautelare a valere, qualora non venga prestata la cauzione; da un lato, l’amministrazione non può dare esecuzione al provvedimento impugnato o all’accordo o continuare nel comportamento, prima della prestazione della cauzione e, dall'altro lato, sarebbero regolati gli effetti dell’accoglimento della misura cautelare, in caso di mancata prestazione della cauzione, con la determinazione, quindi, di due serie di effetti: alcuni immediati, altri differiti nel tempo ed eventuali (se non venga prestata la cauzione). Se, però, il giudice non si dia carico di predeterminare gli effetti per la mancata prestazione della cauzione, l’interessato dovrà agire in revoca della ordinanza di diniego per il fatto sopravvenuto, appunto, della mancata prestazione della cauzione. Così pure rifluiscono nella possibile revoca tutte le questioni relative all'esatta prestazione della cauzione. Il fatto che la legge disponga la subordinazione del diniego o dell’accoglimento della misura cautelare alla prestazione della cauzione, non significa però che, motivatamente e per ragioni di urgenza che non consentano ulteriore dilazione, il giudice non possa stabilire che gli effetti dell’accoglimento o del diniego della misura cautelare decorrano dall’adozione dell’ordinanza cautelare, disponendo per la risoluzione degli effetti in caso di mancata prestazione della cauzione, trasformando così la condizione da sospensiva a risolutiva. 9. Definizione dei giudizio nel merito in forma semplificata e disposizioni per la fissazione dell’udienza di discussione Decorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il giudice può definire, in camera di consiglio, la controversia con sentenza in forma semplificata. Vengono fissati dei presupposti perché il giudice possa immediatamente definire il giudizio, ma si tratta di profili il cui apprezzamento è soggettivo e possono avere una diversa rilevanza a seconda del giudice investito della controversia. Il giudice può definire il giudizio nel merito “sentite sul punto le parti costituite”. Si tratta di un adempimento processuale espressamente prescritto la cui inosservanza determina l'annullabilità della sentenza. In caso di omissione di questo adempimento, il giudice di appello deve procedere all’annullamento con rinvio al T.A.R. poiché si verifica la mancanza del contraddittorio rilevante per il corretto svolgimento del giudizio di primo grado. Insomma, questo presupposto pur avendo natura strettamente processuale, non ha una rilevanza formale, ma attiene a momenti di tutela sostanziale delle parti. Se una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione, non è possibile definire il giudizio con la sentenza semplificata, ma il giudice assegna un termine non superiore a 30 giorni per la proposizione del regolamento di competenza o di quello di giurisdizione e, negli altri casi, rinvia la causa per consentire l’attività processuale preannunziata dalle parti, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. Per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, il giudice accerta la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria. La conversione del giudizio cautelare in giudizio di merito è un rito molto utilizzato in diversi T.A.R. Il giudice è portato a decidere nel merito il ricorso non solo quando risulti la “manifesta” fondatezza o infondatezza (irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità), ma anche se, essendo agli atti tutti i documenti e presentandosi istruito il processo, può risolvere la lite con riferimento ad un profilo che ritiene assorbente e risolutivo o si tratti di questione non molto complessa. Ed infatti, per esaminare la domanda cautelare, il giudice deve studiare comunque il processo e, se riesce a cogliere il punto focale della vicenda, lo decide nel merito, con sentenza in forma semplificata. In questo modo, la durata del processo è veramente contenuta ed il giudice economizza il suo tempo perché non deve studiare lo stesso fascicolo due volte, quando decide la domanda cautelare e quando esamina il merito, e redige una motivazione sintetica. L'esame della misura cautelare costituisce, altresì, l’unica possibilità di investire il giudice della conoscenza del ricorso, prima che sia fissata l’udienza di discussione. Per quest'ultimo aspetto, il Codice non ha dato attuazione alla delega che, nel prevedere “l’estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica”, consente l’istituzione della figura di un giudice istruttore di prima udienza che dispone l’eventuale integrazione del contraddittorio, l’ammissione delle prove e la fissazione dell’udienza di discussione. È probabile che la fase cautelare verrà incontro alle esigenze sottese all’istituzione del giudice istruttore. In sede cautelare, il giudice, su istanza di parte, ordina l'integrazione del contraddittorio e assicura la completezza istruttoria, potendo, comunque, disporre, nelle more, le misure cautelari urgenti. Il ricorrente, già prima del Codice, chiedeva la misura cautelare in quasi tutte le controversie, anche allo scopo di ottenere una trattazione del merito a breve. Ora è l’art. 55, c. 10, del Codice che incoraggia questa prassi perché stabilisce che, qualora il T.A.R., in sede cautelare, ritenga che “le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito”; allo stesso modo può provvedere il Consiglio di Stato, trasmettendo, in caso di riforma dell’ordinanza di primo grado, la pronuncia al T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Qualora venga disposta la misura cautelare, viene fissata la data di discussione del ricorso nel merito; su accordo delle parti, in caso di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare, il termine per la fissazione dell’udienza di discussione è ridotto da sessanta a quarantacinque giorni. Queste disposizioni fanno diventare la camera di consiglio per l’esame della misura cautelare come un importante snodo per la integrazione del contraddittorio, l’acquisizione istruttoria e la fissazione ravvicinata dell’udienza di trattazione, rendendo, sotto quest’ultimo aspetto, residuale la segnalazione dell’urgenza del ricorso con l’apposita istanza di prelievo che non sempre la segreteria porta all'attenzione del presidente. La domanda di misura cautelare potrà, quindi, supplire alla mancata istituzione della figura del giudice istruttore, diventando una fase del processo quasi necessaria. Dunque, la misura cautelare può trasformarsi in strumento di efficace soluzione rapida e definitiva della controversia, facendo venir meno la sua funzione ontologica, rendendo superfluo il pregiudizio grave ed irreparabile nei casi di sentenza semplificata, assorbendo l’ordinario giudizio di cognizione che si renderà necessario solo per i processi particolarmente complessi. 10. La condanna alle spese Con la l. 205/2000, si è stabilito che, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità della domanda cautelare, il giudice “può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare”. Il provvedere “in via provvisoria” e come una mera possibilità (il giudice “può”) era legato alla natura della cautela che dura sino alla decisione sul ricorso, per cui la sentenza che definisce il merito diventa assorbente e sostitutiva del provvedimento cautelare anche per le spese che il giudice deve espressamente considerare. Si è criticata questa norma. Il Codice ha stabilito, in modo condivisibile, che “con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare”; dunque, il giudice “provvede”, non “può provvedere”, costituendo così un suo preciso dovere regolamentare la sorte delle spese di lite della fase cautelare e indipendentemente dall'esito della domanda cautelare, sia, quindi, se la rigetti e la dichiari inammissibile o irricevibile, sia che l’accolga. Inoltre si stabilisce che: “la pronunzia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza”. Si ha una valorizzazione della specificità ed autonomia della fase cautelare, per cui la condanna alle spese contenuta nell’ordinanza che chiude il procedimento cautelare può rimanere a carico della parte poi vittoriosa nel merito, salvo “diversa statuizione espressa nella sentenza”. Per le spese relative all’esecuzione delle misure cautelari si segue la stessa logica: il giudice provvede sulle spese di questa fase eventuale (che si rende necessaria in caso di mancata esecuzione anche parziale del provvedimento cautelare) e la liquidazione “prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza”. 11. L’adozione di misure cautelari con decreto monocratico in causa e anteriore alla causa ed i rimedi Il Codice prevede che, in caso di “estrema” gravità ed urgenza, tale da non consentire nemmeno di attendere la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può chiedere al presidente del T.A.R. o della Sezione cui il ricorso è assegnato, nello stesso ricorso o con istanza separata, di disporre misure cautelari provvisorie. È un meccanismo che, comunque, impone di redigere il ricorso, anche nel merito, nonché la notifica preventiva alle parti. La richiesta deve contenere, dunque, anche l’esposizione del fatto e dei motivi in che si sostanzia il ricorso, con la conseguenza che il deposito in segreteria della domanda cautelare comporta anche la pendenza della lite. Quindi, è un provvedimento adottato con causa già pendente. Inoltre il Codice stabilisce, sulle misure cautelari anteriori alla causa, che il ricorrente, in caso di “eccezionale” gravità ed urgenza, tale da non consentire di predisporre il ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie, può presentare al presidente del T.A.R. competente per il giudizio, previa notifica alle altre parti, istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda in corso di causa. In questo caso, non occorre redigere il ricorso, con l’esposizione del fatto e dei motivi, ma un atto che focalizzi l’eccezionale gravità ed urgenza del provvedere ed eventualmente indichi i punti salienti di illegittimità dell’azione amministrativa. Il ricorso, con la domanda cautelare, va notificato, in caso di accoglimento dell’istanza urgente anteriore alla causa, entro 15 giorni e depositato entro i successivi cinque giorni con l’istanza di fissazione dell'udienza; in ogni caso la misura concessa ante causam perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, restando efficaci i provvedimenti confermati o disposti in corso di causa. Qui si è di fronte ad una misura cautelare che interviene prima di introdurre il ricorso e che richiede al ricorrente la redazione di un’istanza meno impegnativa del ricorso, così velocizzando le operazioni per accedere alla tutela. Il decreto monocratico, in tutti e due i procedimenti, richiede la preventiva notifica del ricorso e della domanda cautelare o dell’istanza alle altre parti che, a differenza che nel processo civile, vengono avvertite che è stato chiesto un tale provvedimento. Da questo punto di vista, la altera pars è posta nelle condizioni di conoscere e può farsi audire dal presidente, anche se con un contraddittorio non pieno, data la ristrettezza dei tempi. Infatti, la necessità della preventiva notifica alle controparti della domanda cautelare volta ad ottenere le misure cautelari con decreto, consente al resistente o al controinteressato di presentare tempestivamente non solo documenti, ma anche memorie volte a contestare la sussistenza, sia della estrema od eccezionale gravità ed urgenza, sia del fumus boni iuris. Ciò spiega la ragione per cui è previsto, ove necessario, che il presidente possa sentire le parti, senza formalità, prima di adottare il decreto. Nell’uno e nell’altro procedimento, il presidente, verificati la competenza per territorio e il perfezionamento per il destinatario della notifica provvede, valutando la ricorrenza della estrema o eccezionale gravità ed urgenza. Si discute se l’organo monocratico debba esaminare, anche se molto sommariamente, il fumus boni iuris. Alla misura cautelare è coessenziale la valutazione del fumus boni iuris sia quando venga adottata da un organo monocratico che inaudita altera parte. E non sussiste violazione della prima regola di ogni processo e cioè il contraddittorio, espressamente richiamato ora nell'art. 111 Cost., perché esso viene solo differito in un momento successivo, data la “estrema gravità ed urgenza”. La questione si pone diversamente per i due tipi di decreto perché, se per quello in causa, vi è già il ricorso con l’esposizione del fatto e dei motivi, per il decreto anteriore alla causa è sufficiente un’istanza sommaria che potrebbe incentrarsi solo sull’eccezionale gravità ed urgenza; nel primo caso, l’organo monocratico è in grado di apprezzare i profili di illegittimità, nel secondo caso no. La possibile soluzione potrebbe essere questa: al presidente non è precluso prendere in esame anche il fumus boni iuris, quando sia possibile, specie se si sia in presenza di azione manifestamente viziata in rito, ma indagine preponderante e, di per sé, sufficiente è la valutazione della estrema o eccezionale gravità ed urgenza. Ed è forse per questo che, per la misura cautelare monocratica in causa, è stabilito che si provveda “con decreto motivato”, invece per quella ante causam, la norma prevede solo il decreto che dovrà, comunque, indicare la ricorrenza dell’eccezionale gravità ed urgenza perché, a prescindere dalla previsione normativa, non è possibile sfuggire a quanto prescrive l’art. 3 del Codice che impone la motivazione per “ogni provvedimento decisorio del giudice” e, soprattutto, al precetto cost. secondo cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. I decreti presidenziali cautelari provvisori hanno un’efficacia molto limitata nel tempo perché sono destinati ad essere sostituiti dall’ordinanza del collegio. Per il decreto in causa la camera di consiglio innanzi al collegio è fissata nel decreto ed è la prima successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione; il termine di dieci giorni dal deposito qui non rileva poiché il decreto monocratico è adottato quando il ricorso è già depositato. Il decreto di accoglimento è efficace sino alla camera di consiglio fissata, per cui “perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare” in detta camera di consiglio. Il decreto cautelare ante causam di accoglimento va notificato entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni, e perde effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare, da depositare nei successivi cinque giorni e, quindi, si seguono, per la fissazione della camera di consiglio, i termini del procedimento ordinario e, comunque, perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione. I procedimenti per i due decreti monocratici sono diversificati, ma, dopo l'emanazione del decreto e, per quello ante causam, il deposito del ricorso, si incanalano in quello ordinario per concludersi con l’ordinanza collegiale. I due decreti monocratici possono, in caso di “effetti irreversibili”, essere subordinati alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione. I decreti monocratici non sono appellabili; è possibile riproporre la domanda cautelare con il procedimento ordinario in caso di rigetto del decreto ante causam, mentre, per quello in causa, deve provvedere il collegio col procedimento ordinario; se vi è accoglimento, è possibile chiedere la revoca o la modifica dei decreti monocratici, con istanza di parte notificata. 12. I rimedi contro l’ordinanza.· a) l’appello; b) la revoca. L’esecuzione delle misure cautelari Il Codice stabilisce che, contro le ordinanze cautelari, l’appello al Consiglio di Stato va proposto entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza e, in mancanza di notifica, sessanta giorni dalla pubblicazione. L’appello va depositato entro trenta giorni dall’ultima notificazione ed è deciso in camera di consiglio, con ordinanza motivata che decide anche sulle spese della domanda cautelare. Il Codice ha dimezzato i termini per l'impugnativa dell'ordinanza cautelare rendendoli più appropriati ad un procedimento urgente e, opportunamente, fa partire il termine lungo dell'appello dalla pubblicazione. Il Consiglio di Stato può imporre cauzione e il procedimento è modellato su quello di primo grado, con possibilità di adottare decreti monocratici in causa, ma non decreti anteriori alla proposizione dell’appello. Il giudice d'appello deve verificare, anche d’ufficio, la giurisdizione e la competenza territoriale del giudice di primo grado. Il Codice ha ampliato le ipotesi della revoca o modificazione e della riproposizione della domanda cautelare respinta che possono proporsi “se si verificano mutamenti nelle circostanze” o se si “allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare”, ma, in tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Ancora, la revoca è stata estesa a tutte le ipotesi previste, per la revocazione delle sentenze, dall’art. 395 c.p.c. e cioè: 1. se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; 2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; 5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. Va, ovviamente, sostituita “sentenza”, con “ordinanza”. La revoca va presentata allo stesso giudice che ha adottato l’ordinanza revocanda. Se i provvedimenti cautelari non sono eseguiti, il Codice dispone che l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, “può chiedere al T.A.R. le opportune misure attuative” ed il T.A.R. esercita i poteri di cui dispone nel giudizio di ottemperanza, liquidando le spese. Il rito è molto semplificato e si svolge in camera di consiglio. Desta perplessità il fatto che si indichi come giudice dell’esecuzione solo il T.A.R. e non il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire in conformità alla previsione del giudizio di ottemperanza, ribadita per quest’ultimo dal Codice: il ricorso si propone “al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado”. La giurisprudenza dovrebbe applicare questo criterio anche all’esecuzione delle misure cautelari perché il giudice che ha disposto la misura cautelare è quello più adatto a fissare le modalità dell’esecuzione. 13. Il decreto ingiuntivo Con la l. n. 205/2000, si attribuiva al T.A.R. il potere di adottare decreti ingiuntivi “nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale”. Sennonché, la Corte costituzionale, con la sentenza 204/2004, dichiarava incostituzionale la parte del d.lgs., 80/1998 nella quale prevedeva che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli”, anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, eliminando, sostanzialmente, dalla giurisdizione esclusiva le questioni patrimoniali. Il Codice, nell’indicare le materie di giurisdizione esclusiva, mantiene la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi per i rapporti di concessione di beni e servizi pubblici. Ne consegue che l'adozione di decreti ingiuntivi da parte del giudice amministrativo diventa un evento raro. È però previsto dal Codice il procedimento per decreto ingiuntivo innanzi al giudice amministrativo. Vi è un richiamo ricettizio a quanto dispone il codice per il processo civile, con attribuzione al presidente del T.A.R. del potere di ingiungere il pagamento e la previsione che l’opposizione si propone con ricorso. È un’ipotesi diversa dalla “ingiunzione a pagare una somma” prevista per la misura cautelare atipica. Qui, infatti, il giudice non deve valutare i presupposti del pregiudizio imminente ed irreparabile e del fumus boni iuris, ma considerare se ricorrono le condizioni di ammissibilità e, in sostanza, “se del diritto fatto valere si dà prova scritta”. Quindi, l’ingiunto può, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, proporre opposizione al T.A.R. con ricorso e, se non interviene l’opposizione, il decreto monitorio acquista lo stesso valore di sentenza passata in giudicato. A differenza della misura cautelare che ingiunge il pagamento di una somma in danaro e che ha efficacia provvisoria, occorrendo sempre che si definisca il giudizio nel merito, per la tutela sommaria non cautelare non è necessaria la successiva definizione del giudizio con sentenza, perché la cognizione piena della controversia interviene solo se lo richieda il debitore ingiunto. Sezione terza: La fase istruttoria 1. Fase istruttoria e istruzione probatoria Nel sistema processuale s’intende in generale per istruzione probatoria l’insieme delle attività tese ad acquisire il materiale necessario per il giudizio. Attori di questa attività sono le parti, in capo alle quali grava l’onere di provare quanto dedotto o di offrire prova contraria; e il giudice al quale spetta non solo il potere di disporre l’ammissione delle prove richieste dalle parti, previa valutazione della loro ammissibilità, ma anche il potere di disporre il completamento dell’istruttoria, nonché il potere di valutare le prove acquisite ai fini del giudizio. La dottrina, sulla scia del processo civile, ha individuato: - l’istruzione primaria: attività svolta dal privato al di fuori del processo, in un momento anteriore alla sua instaurazione, finalizzata alla raccolta di tutti gli elementi essenziali per la domanda, e, dunque, funzionale all’adempimento dell’onere, posto in capo al ricorrente, di allegazione dei fatti principali e secondari di causa; - l’istruzione preparatoria: 'attività compiuta dal giudice sin dalla prima udienza, fino al momento in cui la stessa causa non viene rimessa al Collegio per la decisione, con esclusione dell’attività di acquisizione delle prove, cioè quella attività di impostazione e programmazione del giudizio che è “volta a delimitare in maniera definitiva l’oggetto della decisione”; - l’istruzione probatoria vera e propria: attività svolta dalle parti e dal giudice per la conoscenza dei fatti, volta a rendere possibile una pronuncia definitiva sulla base della conoscenza della realtà dei fatti su cui si fonda l'affermazione del ricorrente”. 2. Il sistema dispositivo con metodo acquisitivo La coesistenza nell'ambito dell’istruzione probatoria propriamente detta di diversi i soggetti -le parti ed il giudice- in ordine all’accertamento del fatto pone all’attenzione dell'interprete il problema relativo ai rapporti tra di esse e, prima ancora, ai rapporti tra realtà rappresentata nell'atto e realtà fattuale sottesa al processo. Nell’inquadrare detti profili, in primo luogo rileva la tipologia di processo, strettamente connessa alla stessa concezione che si ha del processo medesimo e delle sue finalità. Il sistema istruttorio della singola realtà processuale, infatti, si caratterizza diversamente a seconda se il processo venga inteso come uno strumento teso ad accertare i fatti nella prospettazione offertane dalle parti, limitandosi ad essa; o se esso sia (inteso come) volto ad accertare una verità assoluta, cioè l’effettiva verità; o, ancora, se esso sia finalizzato ad accertare la verità esterna, attraverso la collaborazione delle parti. Nel primo e nell'ultimo caso, esso si caratterizza come processo di parte, sebbene diverso sia il ruolo riconosciuto alle stesse al suo interno: nel modello dispositivo puro, è riconosciuta la piena sovranità delle parti nell’introduzione dei fatti della realtà esterna nel giudizio e, conseguentemente della piena disponibilità degli stessi anche in ordine alla prova; in quello misto (dispositivo attenuato con il metodo acquisitivo) -quale va inteso il processo amministrativo- si registra una confluenza degli aspetti dei due modelli richiamati, con la conseguenza che il potere di acquisizione delle prove viene riconosciuto tanto alle parti, quanto allo stesso giudice. Nel secondo modello, di tipo inquisitorio, i poteri in ordine all’acquisizione delle prove sono di spettanza al giudice. 3. La fase istruttoria Un’ulteriore caratteristica del processo amministrativo è rappresentata dall’assenza di una fase autonoma, governata da un giudice istruttore. E questo tanto nel previgente regime, quanto dopo l’emanazione del Codice che pure vi riserva l’intero Titolo III (Mezzi di prova e attività istruttoria), del Libro secondo sul “Processo amministrativo di primo grado”. In passato alcuni Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato avevano instaurato la prassi della c.d. “udienza istruttoria” nella quale venivano prese in esame le istanze presentate dalle parti e, conseguentemente, assunti dal Collegio i provvedimenti utili per la decisione del ricorso. Si trattava di una prassi che non trovava fondamento nella disciplina allora vigente, oggetto di numerose critiche anche sotto il profilo della lunghezza del processo, e che per certi versi è stata ripresa dal legislatore in sede di riforma nella previsione contenuta nell’art. 23 legge Tar ai sensi del quale “il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori”. Le ragioni di tale “inautonomia” procedurale vanno storicamente ricercate nelle caratteristiche proprie del processo amministrativo. Il sindacato del giudice amministrativo, infatti, era per certi versi assimilabile a quello di sola legittimità svolto dalla Corte di cassazione, rispetto al quale l’accertamento del fatto non era richiesto. Al giudice amministrativo -fatta eccezione per le ipotesi di giurisdizione di merito per le quali, accanto al rinvio al codice di rito, si precisava che le attività istruttorie svolte dal giudice dovessero essere finalizzate alla “scoperta della verità”- non nascendo come giudice del fatto ma come giudice dell’atto (proveniente da una p.a.), erano riconosciuti margini di intervento limitati alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato alla stregua degli accertamenti in fatto effettuati dalla stessa amministrazione e introdotti nel giudizio attraverso le c.d. prove precostituite, ossia di quelle (prove documentali) formatesi nel corso del procedimento e, dunque, anteriormente alla instaurazione del giudizio. Prove che il giudice ben poteva ritenere sufficienti per la verifica della legittimità o meno del provvedimento impugnato. Non è un caso, quindi, che il presupposto legittimante l’ulteriore attività istruttoria veniva individuato nell’incompletezza dell’istruzione dell’affare e nella contraddittorietà tra i fatti affermati nell’atto o provvedimento impugnato e i documenti. Nelle sue linee essenziali il sistema sommariamente richiamato ha trovato accoglimento anche in sede di codificazione, non senza problemi in ragione delle conseguenze che si vengono ad avere sulla stessa garanzia dell’azione. La regola generale prevede un onere, in capo alle parti, di depositare nel termine di trenta giorni per la parte ricorrente (art. 45) e di 60 giorni dalla notificazione del ricorso (art. 46) per le parti intimate, il ricorso (le memorie) e i documenti a sostegno del ricorso, nonché una copia del provvedimento impugnato. Ma la formulazione normativa esclude che detto termine possa essere considerato perentorio. Infatti, se da un lato la parte e l’amministrazione hanno l’onere di depositare, nei termini e con le modalità stabilite, i documenti e le prove in loro possesso a sostegno delle pretese avanzate in giudizio, dall’altro la sistematica codicistica riproduce schemi operativi che di fatto rischiano di frustrare quei principi generali posti a garanzia del diritto di azione e di difesa di cui il diritto alla prova costituisce il nucleo centrale. Basti pensare ai contenuti dell’art. 73 il quale dispone, infatti, che “le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”. Termini che possono essere ridotti fino alla metà in quelle ipotesi in cui, sussistendone l’urgenza, su istanza di parte il Presidente del Tribunale conceda un decreto di abbreviazione (art. 53). Si tratta di un termine diverso rispetto a quello contenuto nella disciplina previgente che invece prevedeva la possibilità di depositare documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza e memorie fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza, ma che comunque ha delle conseguenze sul processo, a partire dalla definizione della domanda che non si cristallizza con la proposizione del ricorso. L’art. 54 del Codice prevede, poi, che il Collegio, su richiesta delle parti possa, eccezionalmente, autorizzare il deposito tardivo di documenti e memorie, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile e, comunque, assicurando “il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti”. Produzione che, per gravi ed eccezionali ragioni, può essere autorizzata in camera di consiglio, nell’ipotesi in cui sia richiesta l’adozione di una misura cautelare collegiale, con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio della discussione, in deroga alla previsione che contempla, per il deposito di memorie e documenti, il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio. Mentre per gli altri procedimenti che si svolgono in camera di consiglio i termini previsti dall’art. 73 del Codice sono dimezzati. Da un lato la stessa definizione del thema decidendum viene protratta a ridosso dell’udienza di merito, ove non sia stata presentata, anche solo strumentalmente, una istanza volta a ottenere la emanazione di una misura cautelare, dall’altro emerge che si è di fronte ad un sistema che non garantisce che al momento della trattazione, in sede di udienza di merito, la causa sia compiutamente istruita. Alla mancata definizione dei confini della (fase) istruttoria non supplice neanche la disciplina relativa alle modalità operative per svolgere l’istruttoria, contemplate agli artt. 65 e 68 del Codice. In particolare l’art. 68 individua i termini e le modalità per svolgere l’istruttoria ponendo in capo al giudice (Presidente o magistrato delegato, o il collegio) l’onere di stabilire, in sede di ammissione dei mezzi istruttori, i termini da osservare, nonché il luogo ed il modo dell’assunzione, facendo, per quanto possibile, applicazione delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile, ma nulla dice circa il termine entro il quale ciò deve accadere. Come per il sistema previgente, il rinvio rende applicabili gli articoli da 191 a 201 c.p.c. in materia di consulenza tecnica, con esclusione delle disposizioni che contemplano la conciliazione in ragione della ritenuta indisponibilità della controversia. 4. I poteri delle parti e l’onere del “principio" di prova Nella sistematica del Codice viene confermata l’opzione per un modello dispositivo, cui fa da contraltare, sebbene in maniera molto più attenuata rispetto al passato, la scelta di un metodo acquisitivo. L’istruttoria ha inizio con la proposizione del ricorso ad opera del ricorrente il quale, con il suo deposito assieme ai documenti ed alla copia del provvedimento impugnato, oltre a delineare il thema decidendum, compie il primo atto con valenza istruttoria. L’art. 40 del Codice, che nella sostanza ripropone quanto disposto nel r.d. n. 642/1907, stabilisce che il ricorso deve contenere oltre alla indicazione dell’oggetto della domanda (lett. b), “l’esposizione sommaria dei fatti” (lett. c), “i motivi su cui si fonda” [il ricorso] (lett. d), “l’indicazione dei mezzi di prova” (lett. e) e dei “provvedimenti richiesti al giudice” (lett. f). Alla formulazione della disposizione sottostà un complesso di problemi riconducibili alla definizione dell’ambito oggettivo entro il quale si esplicitano gli oneri derivanti dalla scelta del metodo dispositivo, e soprattutto quale sia la loro effettiva estensione. In prima battuta il legislatore del Codice si è limitato a recepire in una norma il principio generale secondo cui l’onus probandi incumbit eius qui dicit, con una attenuazione riconducibile alla natura del processo ed alla posizione delle parti nel procedimento. Ed infatti, è la stessa formulazione del c. 4 dell’art. 45 a palesare la non assolutezza di tale principio e ciò in quanto il successivo art. 46, che contempla analoga disciplina per i controinteressati, pone in capo all’amministrazione l’obbligo di produrre, nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, “l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio”, riconoscendo tra l’altro al giudice uno specifico potere di ordinarne l’esibizione in caso di inadempimento da parte dell’amministrazione (art. 65, c. 3) nel termine e nei modi opportuni. Si intercetta, così, il problema dell’individuazione di un giusto bilanciamento tra poteri (dispositivi) della parte e poteri (acquisitivi) del giudice, la cui diversa configurazione è riconducibile, teoricamente, alla ricostruzione in termini soggettivi o oggettivi del processo, e cioè al suo essere uno strumento volto a tutelare le situazioni giuridiche soggettive coinvolte o alla conservazione dell’ordine giuridico. Si tratta di una questione complessa che intercetta il problema dell’oggetto del processo amministrativo e rispetto al quale il timido abbandono della concezione originaria, ancorata all’idea di un processo di pura legittimità, il cui oggetto non poteva che essere l’atto amministrativo (accertamento della legittimità) non è approdata ad un dato di certezza oscillando tra la situazione giuridica soggettiva di cui il privato chiede tutela e il rapporto amministrativo cristallizzato nel provvedimento. La prima questione che si pone, in relazione ai poteri della parte, riguarda l’estensione (oggettiva) dell’onere probatorio e cioè se essa sia tenuta o meno ad offrire una “piena” prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande o eccezioni e se, a monte, essa sia tenuta ad allegare solo i fatti principali su cui si fondano le sue pretese o anche i fatti secondari. In questo senso, stante la connessione dell’allegazione dei fatti alla disposizione della situazione giuridica dedotta in giudizio, l’opinione prevalente ha riservato in capo alla parte anche l’allegazione dei fatti secondari, e ciò trova conferma nel codice. Con riferimento alla prima questione richiamata, anteriormente alla emanazione del Codice, dottrina e giurisprudenza, attenuando il sistema dispositivo attraverso l’introduzione del metodo acquisitivo, hanno riconosciuto in capo alla parte l’onere del principio di prova. In tal modo non è stata addossata alle parti, anche in relazione alla loro posizione nella realtà extraprocessuale (procedimentale), la responsabilità della completezza dell’istruttoria, contrariamente a quanto previsto nel c.p.c., essendo necessaria l’allegazione di indizi idonei a fondare astrattamente la pretesa fatta valere in giudizio, cioè quello che la dottrina definiva “principio di prova” da ritenersi applicabile anche ai fatti secondari. La statuizione di tale regola non deve, però, indurre a ritenere che la parte possa limitarsi a fornire “solo” un principio di prova, basato su una presuntiva ricostruzione degli accadimenti che sorreggono la tesi esposta nel ricorso, ove la concreta posizione della parte non sia tale da giustificare tale atteggiamento. E indubbio, infatti, che, anche alla luce del dettato costituzionale, la regola del principio di prova da parte del ricorrente trova un limite per i fatti che sono nella piena disponibilità del ricorrente sul quale grava l’onere di una prova piena e concludente, non potendosi il principio di prova tramutarsi in uno svuotamento dell’onere probatorio e del connesso dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda, pena l’inammissibilità del ricorso. L’impianto normativo, e gli arresti giurisprudenziali, configurano un’impostazione che va nel senso di confermare la possibilità per la parte di disporre del proprio interesse, facendo salva, però, la tecnica del processo che contempla, accanto alle iniziative istruttorie delle parti, che possono concretarsi anche in vere e proprie istanze istruttorie, anche poteri d’ufficio del giudice che rispondono più che altro ad un principio di collaborazione e contribuiscono al mantenimento dell’uguaglianza sostanziale delle parti che, nonostante le garanzie introdotte con la legge sul procedimento amministrativo, risentono della posizione di autorità della p.a.. L’art. 63 del Codice sul punto, al c. 1, conferma l'applicazione del principio dell’onere della prova posto a carico delle parti, mitigato dai poteri del giudice di acquisire d’ufficio ulteriori elementi di conoscenza ritenuti utili ai fini del giudizio. Principio che viene ribadito anche al successivo art. 64, rubricato Disponibilità, onere e valutazione della prova, che al c. 1 ribadisce, e se si vuole esplicita, il portato del c. 1 dell’art. 63, stabilendo che spetta alle parti l’onere di fornire la prova (elementi di prova) dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni che sono nella loro disponibilità. Con obbligo per il giudice, salvo i casi previsti dalla legge, di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti dalle stesse non contestati, in linea con il disposto del c. 2 dell’art. 115 c.p.c., limitandone così il suo intervento acquisitivo soltanto a quelle ipotesi in cui gli elementi di prova, ritenuti necessari per la decisione della causa, non siano nella disponibilità della parte. Il disposto dell’art. 64 si pone in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza amministrativa in relazione al giudizio risarcitorio rispetto al quale, nonostante la titolarità da parte del giudice di ampi poteri nell’acquisizione del materiale istruttorio, è stato confermato che la parte interessata conserva l’onere, ai sensi dell’art. 2697 c.c. ritenuto applicabile anche al processo amministrativo, di allegare le circostanze e gli elementi posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio, specie quando gli stessi siano nella disponibilità della parte, ed in mancanza il giudice non ha il dovere di surrogarsi all’inerzia della parte onerata. In altri termini, in linea con l’impianto concettuale assunto a base della responsabilità dell’amministrazione, successivamente alla emanazione della sentenza n. 500/1999 della Cassazione, ha trovato piena applicazione il principio generale sancito dall’art. 2697 c.c. secondo il quale chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi la domanda. Di talché il privato che agisce in giudizio ai fini del risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi è tenuto a fornire la prova dell’esistenza del danno, non potendo limitarsi ad invocare il principio acquisitivo che, come detto, attiene “allo svolgimento dell’istruttoria e non alla allegazione dei fatti. Cosicché la limitazione dell’onere della prova, fondata sulla naturale ineguaglianza delle parti nell’ambito del rapporto amministrativo, viene meno con riguardo alla prova dell’an e del quantum dei danni (non patrimoniali) azionati in sede risarcitoria, poiché, in applicazione del c.d. criterio della vicinanza alla prova, grava sulla parte ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza e l’ammontare dei danni azionati in giudizio stante la relazione con la sfera soggettiva della parte che si assume lesa. 5. I poteri dei giudice e il principio di non contestazione Dunque, se in capo alla parte grava un onere probatorio circoscritto, ove la prova non sia nella disponibilità della parte, al solo principio di prova, occorre verificare entro quali limiti esso può essere bilanciato dal potere acquisitivo del giudice dei dati della realtà extraprocessuale, o meglio un potere di iniziativa per la ricerca dei fatti su cui fondare la propria decisione in modo da garantire che l’attività da esso svolta sia comunque finalizzata alla “scoperta della verità”. È presupposto per l’esercizio del potere acquisitivo la verifica della completezza del materiale probatorio, con i limiti previsti con riferimento al principio di prova, cioè che il potere del giudice di disporre l’integrazione non può supplire alla inerzia della parte. Ed infatti, dalla lettura del nuovo articolato emerge come il completamento dell’istruttoria effettuata dalle parti sia rimesso al giudice il quale, ai sensi dell’art. 65, c. 1, ne deve assicurare la completezza prima di tutto in base alle istanze presentate dalle parti che lui stesso è tenuto a valutare, onde verificarne la ammissibilità; e poi anche d’ufficio, ove ne rilevi l’insufficienza (art. 64, c. 3). In questo senso è possibile affermare che l’impianto codicistico conferma il giudice amministrativo come “signore della prova”. Quanto ai confini entro cui il giudice può esplicare il potere acquisitivo, va rilevato in primo luogo che all’interno del Codice nulla è detto in generale sulla tipologia, né sulla doverosità dello stesso. L’unica indicazione è desumibile dal c. 3 dell’art. 65 che configura come vincolato soltanto il potere del giudice di emanare l’ordine di esibizione del provvedimento e degli altri documenti in caso di inadempimento della p.a.; rimanendo negli altri casi, rimesso alla discrezionalità dello stesso che valuterà se esercitarlo o meno in relazione alla ritenuta compiutezza dell’istruttoria ed alla ammissibilità e rilevanza della prova richiesta. Del resto è lo stesso principio di disponibilità della prova a rappresentare un vincolo per il giudice in ordine all’accertamento del fatto, non potendo sostituirsi alle parti in relazione alla stessa scelta degli atti da sottoporre al giudicante. Va rilevato che la predetta valutazione non viene manifestata espressamente nel caso in cui risulti essere negativa, con evidente pregiudizio della parte che non viene messa nelle condizioni di conoscere le ragioni a base del rigetto delle istanze presentate, e ciò anche in contrasto con il generale principio di collaborazione consacrato all’art. 2 del Codice. Questo si pone per certi versi in linea con il sistema del processo civile nel quale si è riconosciuto che la motivazione del rigetto non debba essere espressa, potendo la ratio decidertdi che ha risolto il merito della lite valere come implicita esclusione del mezzo dedotto. Va detto, inoltre, che nel processo amministrativo la mancanza di un’udienza istruttoria di fatto pone nell’incertezza la parte che probabilmente soltanto nell’udienza di discussione nel merito potrà conoscere l’esito delle sue istanze istruttorie. Il c. 2 dell’64 prevede che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non contestati dalle parti costituite. Viene così introdotto, all’interno del processo amministrativo, il principio di non contestazione, così come statuito per l’ordinamento processuale civile, all’art. 115, nel testo modificato dalla legge n. 69/2009. Per intendere appieno la portata di questo principio nella configurazione tipica del processo amministrativo occorre distinguere l’ipotesi in cui la non contestazione sia riconducibile a una delle parti costituite nel processo, dall’ipotesi contraria, in quanto dall’esame della disciplina codicistica emerge la non equivalenza tra non contestazione e prova piena. Infatti, nel primo caso il principio di non contestazione trova piena applicazione, risultando un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, al quale non residua alcuna discrezionalità nei limiti in cui non emergano elementi in senso contrario; non così per i casi in cui la parte non sia costituita. La problematicità di una simile impostazione è evidente già solo ove si consideri che per la natura e la caratterizzazione del processo, la contestazione può avvenire fino alla costituzione delle parti (dell’amministrazione) che può esserci fino all’udienza di discussione, con la conseguenza che le parti potrebbero, tra l’altro, essere indotte anche a non costituirsi, con evidenti pregiudizi per la completezza del contraddittorio. In aggiunta alla costituzione delle parti, un ulteriore limite alla valenza dei fatti non contestati è rappresentato dalla insussistenza, che sta al giudice valutare, di elementi emersi nel corso del giudizio, che si pongano, comunque, in contrasto con le affermazioni non contestate. Del resto, se il principio dell’onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi debba essere desunta in via esclusiva dalle prove offerte dal soggetto in capo al quale l’onere probatorio grava, è lo stesso principio di acquisizione a confermare che le risultanze istruttorie concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice. Diversi sono i momenti di ingresso della prova nel processo. Nella fase iniziale, in cui rileva essenzialmente l’attività svolta dalle parti attraverso le allegazioni documentali, e le altre richieste istruttorie contenute nel ricorso. Nella fase intermedia -preliminare cioè all’udienza di discussione- e nella fase finale, trovano posto tanto l’attività delle parti, che possono depositare documenti nei limiti temporali visti in precedenza o presentare altre istanze istruttorie, quanto quella acquisitiva del giudice. Anche con riferimento a questi profili la disciplina codicistica non è particolarmente lineare. L’art. 65 contempla l’istruttoria collegiale (c. 2) e quella presidenziale (c. 1) che può anche essere svolta da un magistrato delegato dallo stesso Presidente. Magistrato che può essere surrogato o sostituito, previo provvedimento (decreto) del Presidente. I poteri istruttori sono ricondotti, con eccezione di alcune specifiche ipotesi tese a privilegiare l’istruttoria collegiale (C.T.U. e verificazione), in capo tanto al collegio quanto al Presidente ai quali spetta, ad es., l’ammissione delle prove richieste dalle parti. Deve ritenersi, comunque, che, proprio in ragione del generale potere del giudice di acquisire le prove ritenute utili ai fini del giudizio, anche il Presidente, sebbene non espressamente previsto, possa disporre d’ufficio l’acquisizione in generale dei mezzi di prova ritenuti necessari. Ma l’istanza di parte viene espressamente richiamata soltanto per le ipotesi di istruttoria presidenziale ed in relazione alla assunzione della testimonianza ed alla assunzione dei provvedimenti necessari per completare l’istruttoria che possono essere adottati dal Presidente o dal Magistrato da lui delegato, e cioè, presumibilmente, quei provvedimenti conseguenti alle istanze formulate o direttamente in sede di ricorso o successivamente, fino alla udienza di discussione. L’istanza motivata, può, in teoria, essere presentata dalla parte per ottenere anche prima, e fuori dell’udienza di discussione, i provvedimenti richiesti. Nell’ipotesi di istruttoria collegiale, invece, l’istanza di parte non è menzionata ed è altresì previsto che l’ordinanza istruttoria contenga anche la fissazione della successiva udienza di trattazione del ricorso (art. 65, c. 2). Comunque deve ritenersi che, anche per le ipotesi di istruttoria collegiale sia ammissibile una istanza di parte tesa ad introdurre nel giudizio quel singolo mezzo di prova. Inoltre, non viene chiaramente delineato l’ambito dei poteri spettanti al giudice, sia esso il Presidente o il collegio. Infatti, il legislatore si è limitato a confermare il già richiamato potere del giudice di chiedere, anche d’ufficio, chiarimenti o documenti (art. 63, c. 1), o di ordinare all’amministrazione l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni, ove questa non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti, ai sensi dell’art. 46 (art. 65, c. 3). Potere che si estende nei confronti dei terzi ai quali può ordinare l’esibizione in giudizio di documenti o quant’altro ritenga necessario, secondo il disposto degli artt. 210 ss. c.p.c., giungendo fino al punto di ordinare una ispezione, ai sensi dell’art. 118 c.p.c. (art. 63, c. 2). Per completare, il c. 5, dell’art. 63, pone in capo al giudice il potere di disporre, non è detto se anche d’ufficio, ma si ritiene possa giungersi ad una risposta positiva, l’assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal c.p.c., con esclusione dell’interrogatorio formale e del giuramento (art. 64, c. 3); nonché, fermo restando il principio dell’onere della prova, il potere di disporre, anche d’ufficio, “l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della p.a.” (art. 64, c. 3). 6. I provvedimenti istruttori Il sistema previgente contemplava che i provvedimenti istruttori fossero adottati in forma di ordinanza e ciò in analogia con i corrispondenti provvedimenti che nel processo civile competono al giudice istruttore. Impostazione confermata anche con la riforma del 2000, la quale ha stabilito l’applicazione all’ordinanza del regime previsto dal codice di rito. Alla luce delle disposizioni contenute nella disciplina codicistica pare confermata la scelta dell'ordinanza che è espressamente richiamata in relazione ai provvedimenti istruttori adottati dal Collegio. È stabilito che il giudice pronunci “ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie” e cioè in tutti i quei casi in cui il giudice non definisce nemmeno in parte il giudizio. Regola che nel silenzio del Codice potrebbe essere applicabile anche alle ipotesi in cui l’ammissione sia disposta dal Presidente o da un magistrato da lui delegato, sebbene delle perplessità potrebbero sorgere stante la natura prettamente collegiale dell’ordinanza che si contrappone al decreto che però, può essere pronunciato solo nei casi previsti dalla legge. L’ordinanza, deve contenere l’indicazione dei termini da osservare per l’espletamento dei relativi incombenti. 7. La regola di giudizio Ci si domanda quale sia la regola di giudizio; quali siano, cioè, i poteri del giudice rispetto alla valutazione delle prove prodotte in giudizio e, prima ancora, rispetto ai fatti incerti. Analogamente alla precedente disciplina, al giudice amministrativo viene riconosciuto il potere di influire sulla stessa ripartizione dell’onere della prova, ponendolo in capo a quella parte che, a suo avviso, può consentirgli di superare la situazione di incertezza. Sulle parti, inoltre, incombe un onere di collaborazione, la cui violazione ha sempre portato al riconoscimento della veridicità dei fatti affermati dal ricorrente, non potendosi il giudice esimere dal pronunciare. Ed è proprio alla luce di queste considerazioni che la dottrina ha individuato nel “libero convincimento” del giudice, “il fatale sbocco della logica globale del sistema istruttorio da esso elaborato”. A fronte della libertà di fatto riconosciuta al giudice di stabilire se vi sia o meno un principio di prova e della libertà di ripartire discrezionalmente l’onere della prova facendolo gravare sulla parte più vicina alla prova stessa, non poteva non riconoscersi pari libertà “nel valutare i risultati delle sue precedenti decisioni e valutazioni, l’irrigidimento dell’ultimo passaggio della catena introdurrebbe un elemento manifestamente incompatibile con i primi due: errore logico e contraddizione giuridica dai quali il nostro giudice desidera rifuggire”. Si precisa che “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere gli argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”. Si distribuisce tra le parti il rischio connesso alla mancata prova dei fatti. Quindi, così come per il processo civile, il giudice non solo valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento ma può prendere in considerazione anche quegli elementi che derivano dal mancato adempimento di un’istruttoria disposta, ossia qualora la p.a. non fornisca elementi idonei a confutare la veridicità degli stessi, non ottemperando a degli incombenti istruttori. L’unico limite va rintracciato nell’eventuale contrasto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa. In questo senso il comportamento processuale dell’amministrazione che si sottrae all’onere di cooperazione, omettendo ingiustificatamente di depositare gli atti richiesti, è valutabile liberamente dal giudice il quale può anche giungere a ritenere ammessi i fatti dedotti dalla controparte, ma questo non può considerarsi un effetto automatico e necessitato (pena la negazione dello stesso principio del libero convincimento del giudice) del non corretto e sleale comportamento delle parti, soprattutto ove dagli atti emergano elementi contrastanti. 8. L’istruzione probatoria nel giudizio di appello Nell’attuale sistema delineato dal Codice, non si ammettono domande nuove nel giudizio di appello, e conseguentemente si esclude l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini del giudizio, o che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” e in caso di ius superveniens. Il legislatore del Codice ha chiarito che il divieto di nuove prove vale sia per le prove costituende che per quelle precostituite, la cui produzione è subordinata, al pari delle prime, alla verifica in ordine alla sussistenza di una causa non imputabile che abbia impedito alla parte l’esibizione dei documenti in primo grado. Verifica che rientra nella competenza del Collegio. Inoltre, la proposizione di motivi aggiunti è ammessa soltanto qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado dai quali emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. 9. I mezzi di prova: delimitazione del tema I mezzi di prova sono mezzi processuali necessari a fornire la dimostrazione della esistenza di un fatto dedotto dalla parte. La dottrina processualcivilistica ha offerto diverse classificazioni dei mezzi di prova in ragione di vari criteri: - oggetto (prova diretta, prova indiretta, prova contraria); - efficacia (prova liberamente apprezzabile, prova legale); - intensità dell’efficacia (prova piena, prova di verosimiglianza, argomento di prova); - momento della formazione (prova precostituita, prova costituenda); - idoneità a rappresentare il fatto da provare (prova storica, prova critica). Con riferimento al processo amministrativo, la stretta connessione tra il momento probatorio e la tipologia processuale ha di fatto condizionato la costruzione dell’istruttoria processuale anche con riferimento agli stessi mezzi di prova ammessi. Infatti, è soltanto con il Codice che si ha un recepimento della disciplina processualcivilistica anche per il processo di legittimità. Il giudice amministrativo è autorizzato ad acquisire tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con la sola esclusione del giuramento e dell’interrogatorio formale. 10. I documenti I documenti rientrano fra i mezzi di prova del processo, rappresentando prove precostituite. Nel processo amministrativo, i documenti hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale ai fini probatori. Numerose sono le norme codicistiche che richiamano detto strumento che, anche nella sistematica del codice, conserva una efficacia probatoria prioritaria. Il documento è normalmente un enunciato scritto. La scrittura è solo la forma di documentazione prevalente, in quanto essa talora è integrata con documenti grafici o plastici, che rappresentano indirettamente certi fatti, mediante segni, piante o modelli. I documenti grafici presuppongono peraltro sempre un documento scritto, che comprenda quantomeno una legenda per decifrare i grafici. Il documento può essere prodotto in originale o in copia autentica. I documenti dichiarativi sono quelli che non rappresentano fatti, ma atti dell'uomo, volti a manifestare il suo pensiero. In questo caso la legge talora prevede che lo scritto sia richiesto addirittura quale condizione di validità della dichiarazione (ad substantiam), o quale mezzo di prova (ad probationem). I provvedimenti amministrativi sono normalmente esternati in forma scritta e talora si ritiene che tale forma sia richiesta ad substantiam. È stata comunque riconosciuta la possibilità che esistano anche provvedimenti impliciti e dichiarazioni silenziose. Al proposito occorre distinguere fra esternazione scritta e documentazione scritta di provvedimenti amministrativi. Le deliberazioni degli organi collegiali sono infatti provvedimenti ad esternazione orale destinati ad essere verbalizzati, venendo cosi a concretare una documentazione scritta. Nel caso di organi monocratici l’esternazione viene invece a coincidere con la documentazione scritta. Il documento, da un punto di vista del suo autore, può essere pubblico o privato. Quella di documento pubblico, è una nozione che ricomprende sia gli atti pubblici che gli altri documenti formati nell’esercizio di una attività pubblica non specificamente diretta alla documentazione. Nel codice civile è contenuta la disciplina dell'efficacia probatoria dell’atto pubblico e della scrittura privata, ma nulla è detto con riguardo a quei documenti pubblici, i quali sono tali per la loro provenienza da pubblica autorità, ma che non costituiscono atti pubblici, in quanto il documentatore non è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. Quindi diversa è l’efficacia probatoria che si riconnette al documento costituente atto pubblico, rispetto agli atti di certezza pubblica che possono essere esternati anche con documenti non costituenti atti pubblici. L'atto di certezza produttivo di conoscenza legale, assoluta o relativa, è nozione di diritto sostanziale, mentre l’atto esternato con documento facente fede fino a querela di falso, è nozione di diritto processuale, attiene cioè all’aspetto probatorio. Il primo contiene una dichiarazione di volontà, destinata a modificare la realtà giuridica, il secondo contiene una dichiarazione di verità, destinata ad una mera rappresentazione della realtà. Tale è il documento che contiene un atto pubblico, il quale costituisce piena prova della sua provenienza dal pubblico ufficiale, che se ne afferma autore sottoscrivendolo, nonché delle circostanze relative al tempo e al luogo della sua formazione. Lo stesso fa altresì piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti. Se poi le dichiarazioni che lo stesso attesta consistono in atti di certezza, la particolare forza probatoria del documento non può certo estendersi al contenuto della dichiarazione. Il problema dell’efficacia probatoria dei documenti si pone non tanto con riguardo ad atti pubblici, quanto con riguardo agli atti di certezza pubblica. I documenti costituenti atti pubblici sono infatti produttivi di certezze legali destinate a circolare nella realtà sostanziale, ma rilevanti altresì nel processo, cui si collega una presunzione iuris et de iure in ordine alle rappresentazioni in essi contenute, le quali possono essere superate solo mediante l’accertamento del falso. La gran parte dei documenti pubblici, che sono tali per la loro provenienza da una pubblica autorità, ma che non sono qualificabili come atti pubblici o comunque nella parte in cui non assumono tale rilievo e che contengono dichiarazioni o rappresentazione di fatti, pongono seri problemi per quanto riguarda la loro efficacia probatoria. Talora si è ritenuto che tali documenti facciano fede fino a prova contraria, in base alla vecchia teoria che si ricollega alla presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Tale tesi non sembra potersi condividere ed infatti il codice civile, nel capo dedicato alla prova documentale, non prende in considerazione documenti pubblici, i quali non siano atti pubblici secondo l'art. 2699 c.c. Pertanto deve ritenersi che ai documenti, non legalmente regolati, debba applicarsi il principio del prudente apprezzamento, che l'art. 2729 c.c. afferma con riguardo alle presunzioni semplici. Né è ragionevolmente possibile operare una sorta di analogia di tali documenti (pubblici) con le scritture private. Sotto questo profilo non va dimenticato che, a differenza dei privati, i pubblici poteri hanno talora la potestà di creare certezze giuridiche, destinate a circolare innanzitutto nella realtà sostanziale. Quando queste certezze, attraverso i documenti che le esternano, vengono acquisite al processo, anche se il documento non costituisce prova legale, ma liberamente apprezzabile, esse inevitabilmente verranno ad influenzare variamente il convincimento del giudice. Il riferimento è non tanto alle certezze legali, per lo più costituenti atti pubblici, ma alle certezze notiziali, quali, a titolo esemplificativo, gli acclaramenti, le relazioni di ispezione, di inchiesta, nonché le certificazioni improprie. In questi e negli altri casi in cui tali certezze sono documentate al fine di “rendere noto” qualche cosa, il fatto notiziato, qualora sia contestato, dovrà essere verificato mediante l’assunzione degli opportuni mezzi di prova. Al giudice spetta solo un giudizio sulla rilevanza del fatto ai fini della decisione. Non si esclude che talora vi siano certezze notiziali alle quali la legge riconnette una presunzione assoluta di conoscenza. E così la legge riconnette una presunzione assoluta di conoscenza del provvedimento dalla sua pubblicazione, se non sia richiesta la comunicazione individuale. Entro tali limiti la certezza notiziale è destinata ad operare come certezza legale. 11. La richiesta di (s)chiarimenti Il giudice può richiedere nuovi chiarimenti, con riguardo ai fatti introdotti nel giudizio dalle parti. La richiesta di chiarimenti deve essere effettuata all’amministrazione interessata in quanto soggetto pubblico e non in quanto parte, per cui la risposta non potrà provenire dal difensore e la stessa, dunque, “non si spoglia della sua qualità di parte per assumere quella di autorità collaborante col giudice”. I chiarimenti possono essere richiesti anche alla parte privata. Quanto ai contenuti, si tratta di dichiarazioni di conoscenza, che si ritiene debbano essere rese in forma scritta, ed essendo paragonabili in un certo senso all’interrogatorio libero delle parti, parte della dottrina ne ha suggerito l’assunzione in forma orale. I chiarimenti resi dall’amministrazione possono essere semplici, documentati o complessi a seconda che consistano in una relazione dell’amministrazione al giudice relativa a determinati fatti; in una relazione cui viene aggiunta una allegazione documentale; o, infine, in una relazione in cui vengono illustrati elementi tecnici. In nessun caso, però, possono essere utilizzati per superare una carenza istruttoria o un difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Ove l’amministrazione non provveda a fornire i chiarimenti richiesti intorno a fatti affermati dal ricorrente e da essa negati, il suo comportamento potrà essere valutato come ammissione dei fatti, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di mancata osservazione di un ordine di esibizione di documenti. Tale mezzo istruttorio viene spesso utilizzato in combinazione con la “richiesta di documenti”, da cui scaturisce una “richiesta di documentati chiarimenti” in ordine ai fatti di causa senza che ciò implichi la violazione del principio di terzietà, diritto di difesa e contradditorio. 12. La verificazione La verificazione è un mezzo istruttorio tipico del processo amministrativo che consiste nella richiesta, presentata dal giudice, di effettuare una verifica su alcuni profili dell’atto. Essa si caratterizza per la sua poliedricità, potendo comportare attività diverse quali ispezioni, sopralluoghi, esperimenti, esami tecnici e qualsiasi operazione necessaria per rispondere ai quesiti formulati dal giudice. L’origine di tale mezzo istruttorio sta nella ritenuta impossibilità per il giudice di avere una cognizione autonoma dei fatti oggetto del giudizio, potendoli conoscere solo attraverso le rappresentazioni ad esso fornite dalla stessa amministrazione parte in causa. Sotto un profilo soggettivo la verificazione era inizialmente limitata alla c.d. “amministrazione interessata”. Solo in un secondo momento essa è stata estesa prima all’amministrazione sovraordinata che esercitava poteri di controllo o di vigilanza su quella parte in causa; per poi giungere ad ammettere la possibilità per il giudice di avvalersi di organi tecnici di altre amministrazioni con competenze tecniche specifiche che, in ragione della loro distanza dalla vicenda processuale, garantivano una maggiore neutralità, e ciò in sostituzione dello strumento della consulenza tecnica per lungo tempo estranea al processo amministrativo. Le verificazioni dovevano svolgersi in contraddittorio dovendo le parti essere avvisate almeno 5 giorni prima del giorno e del luogo in cui si sarebbe effettuata la verificazione. Al fine di ampliare la garanzia del contraddittorio, nella prassi le ordinanze che disponevano la verificazione contemplavano la possibilità per le parti di farsi assistere da tecnici da loro incaricati, garantendo cosi anche una maggiore valenza probatoria della stessa verificazione i cui esiti, ove assunta nel contraddittorio delle parti, difficilmente si sarebbero potuti porre validamente in discussione ex post. Né il contraddittorio né la possibilità di farsi assistere da un consulente di parte sono contemplati dal Codice. Si dispone che la verificazione possa essere ordinata dal giudice qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, ma nulla è detto in ordine alla garanzia del contraddittorio da un punto di vista sostanziale. Infatti, se le ordinanze comunque sono comunicate alle parti nel termine stabilito, cioè di 5 gg., non è per le stesse contemplata la possibilità di farsi assistere da tecnici di fiducia. Nel Codice viene statuita una graduazione tra i due mezzi di prova. Ciò è in contrasto con il sistema processuale civile nel quale non esiste una gerarchia in ordine all’efficacia delle prove che sono rimesse all’apprezzamento (prudente) del giudice. Mentre la verificazione può, infatti, essere disposta nella generalità dei casi, il giudice può fare ricorso alla consulenza tecnica soltanto qualora lo ritenga indispensabile. La verificazione è disposta dal Collegio con ordinanza, nella quale deve essere individuato l’organismo che deve provvedere alla verificazione, autorizzandone eventualmente la delega, ma anche i quesiti formulati ed il termine entro il quale la verificazione deve essere compiuta e deve essere depositata la relazione conclusiva che può anche essere resa oralmente al giudice. Con riferimento ai profili soggettivi, si precisa che la verificazione è affidata ad un organismo pubblico estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche. Viene così confermato l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di affidare la verificazione ad una autorità diversa da quella parte del giudizio, a garanzia della terzietà ed imparzialità del verificatore che a differenza della previgente disciplina è, dunque, un esperto terzo, e non un organo della stessa amministrazione dalla quale proviene l’atto impugnato, assimilabile in qualche modo al perito. Si tratta di una previsione che costituisce puntuale applicazione del principio di imparzialità dell’istruttoria e garantisce la compatibilità con il principio del giusto processo. Se da un lato il verificatore ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne le ipotesi in cui sussista un giustificato motivo, dall’altro può essere ricusato dalle parti nei casi in cui abbia interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; o se si trova in una relazione di parentela o di affiliazione con una delle parti o alcuno dei difensori, o se sia convivente o commensale abituale; la previsione è estesa anche alle ipotesi in cui le situazioni di incompatibilità riguardino il coniuge; se il verificatore o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; o se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o abbia avuto altro coinvolgimento; o, infine, se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti, o amministratore o comunque soggetto interessato in una associazione che in qualche modo possa avere interesse; in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. La competenza a decidere sulla ricusazione spetta al giudice che ha nominato il verificatore. Sebbene non espressamente previsto, è da ritenere, che il verificatore debba astenersi nel caso in cui sussistano le summenzionate ragioni. A differenza della C.T.U., nella verificazione il funzionario incaricato dal giudice non è tenuto a prestare giuramento e gli esiti della sua attività, che consistono, in un accertamento tecnico di natura non valutativa, possono essere disattesi dal giudice attraverso una valutazione critica dalla quale si evincano gli elementi di cui si è avvalso per discostarsi dal parere espresso dal verificatore. 13. La consulenza tecnica d’ufficio In alternativa alla verificazione, e solo ove lo ritenga indispensabile, il giudice può disporre la consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.). Come per la verificazione, anche per la C.T.U. è prevista la nomina da parte del Collegio, al quale spetta la formulazione dei quesiti e la fissazione del termine entro cui il Consulente deve prestare giuramento. Nella stessa ordinanza, deve altresì essere individuato il magistrato che viene delegato per l’assunzione dell’incarico e la prestazione del giuramento da parte del Consulente. Per ciò che concerne i profili soggettivi, la C.T.U. può essere affidata tanto a dipendenti pubblici, quanto a professionisti iscritti negli albi o anche ad altri soggetti aventi particolare competenza. Albi che non sono diversi, almeno in base alle disposizioni codicistiche, da quelli previsti dal c.p.c. e ai quali il giudice potrà sempre far ricorso al fine di agevolare la scelta del consulente. In concreto il consulente tecnico è individuato con riferimento a istituti od organismi specializzati, o a una sede universitaria con riguardo ad una Facoltà, indicando nella persona del Preside il soggetto che potrà svolgere l’incarico direttamente oppure avvalendosi di un docente ritenuto particolarmente qualificato. Vi sono elenchi di professionisti qualificati nei quali sono inseriti i nominativi di coloro i quali vengono via via nominati. Il fatto di non attingere da un albo rende inapplicabili le disposizioni disciplinari sulla ripartizione degli incarichi. A garanzia dell’indipendenza e terzietà del consulente è previsto che non possano essere nominati consulenti coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. Come per il verificatore, il consulente è obbligato a prestare il proprio ufficio, ad eccezione dei casi in cui il giudice riconosca la sussistenza di un giustificato motivo e può essere ricusato dalle parti per i motivi di cui all'art. 51 c.p.c., e per gli stessi motivi ha l'obbligo di astenersi e può fornire oralmente i chiarimenti richiesti. Nel nuovo assetto normativo trova conferma la configurazione della consulenza tecnica non come un mezzo di prova propriamente detto, ma come un vero e proprio mezzo istruttorio a disposizione del giudice che, quando lo ritiene “indispensabile”, si avvale di un proprio ausiliario per acquisire nozioni della scienza o dell'arte delle quali sia sfornito o insufficientemente munito e, dunque, non uno strumento istruttorio per accertare la storicità o la verità di un fatto. Sotto il profilo oggettivo si è ritenuto che la consulenza tecnica miri, a differenza della verificazione, all’acquisizione di un giudizio tecnico, piuttosto che alla verificazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, ponendosi, così, la prima su un piano più propriamente valutativo, e la seconda su un piano conoscitivo, consistendo la verificazione, alla stessa stregua della perizia, in meri accertamenti effettuati per completare la conoscenza del fatto. Altra distinzione è quella operata dai giudici della Cassazione i quali hanno evidenziato l’esistenza di una duplicità della consulenza, individuabile da un lato nel cosiddetto consulente “deducente”, chiamato cioè ad effettuare una semplice valutazione di fatti già acquisiti ed asseverati, ed il consulente “percipiente”, chiamato non solo ad effettuare la valutazione ma anche a costituire esso stesso fonte di prova. Per ciò che concerne l’ambito di applicazione della consulenza tecnica, se da un lato è pacifico il suo utilizzo nei casi in cui all’ausiliario del giudice è demandata l’effettuazione di accertamenti strettamente vincolati, ben più articolata e complessa è l’ipotesi concernente l'applicabilità in quei casi in cui la scelta sia appunto qualificabile in termini di discrezionalità tecnica. La questione si ricollega al problema dell’opinabilità dei risultati cui le regole tecniche applicate nel caso concreto conducono o, se si vuole, alla distinzione tra regole tendenzialmente esatte, la cui applicazione porta ad un accertamento tecnico (di un fatto) da parte dell’amministrazione, e regole che per diverse ragioni sono prive di tale requisito (discrezionalità tecnica). Mentre nel primo caso l’ammissibilità della C.T.U. è stata riconosciuta da parte della giurisprudenza, sia pure con dei limiti, nel secondo l’opinabilità del risultato conseguente all’applicazione della regola tecnica ha condotto ad una ritenuta inammissibilità della stessa, vista come una inopinata sostituzione del giudizio di un soggetto terzo a quello dell’amministrazione e, quindi, della discrezionalità. Ma in realtà, ove si rifletta sulla natura stessa della discrezionalità tecnica, intesa quale accertamento di un fatto alla luce di norme tecniche compiute dall’amministrazione, è evidente come il momento della opinabilità non tocchi in alcun modo il procedimento attraverso cui la valutazione (accertamento) del fatto viene condotta dall'amministrazione, né tanto meno attenga alla determinazione da parte di quest’ultima del parametro (tecnico) posto a base della stessa valutazione. Con riferimento a questi due profili è possibile, infatti, individuare uno spazio di operatività della C.T.U., indipendentemente dalla considerazione della “esattezza” o meno della regola tecnica applicata. Spazio da individuarsi nella valutazione da parte del consulente di profili attinenti all’attualità del parametro (tecnico) applicato dall’amministrazione ed alla correttezza del procedimento applicativo, sempre nei limiti delle contestazioni mosse dalle parti. In questo senso, dunque, si è aperta la strada al sindacato della discrezionalità tecnica non solo per i profili estrinseci, ma anche per la verifica dei profili appena richiamati, ovviamente sempre nei limiti della domanda della parte. Una questione (quella sulla sindacabilità intrinseca della scelta compiuta dall'amministrazione) che si differenzia da quella concernente la sostituibilità della decisione del giudice fondata sull’esito della C.T.U. con quella resa dall’amministrazione. Tanto nel primo caso (sindacato intrinseco diretto, riferito cioè al criterio tecnico) quanto nel secondo (sindacato intrinseco indiretto, riferito al procedimento seguito dall’amministrazione e alla coerenza e correttezza dello stesso ragionamento seguito in base alle risultanze procedimentali) la sostituibilità (sindacato forte) può essere esclusa, limitando i poteri del giudice alla rilevazione dell’inosservanza della norma giuridica che impone la valutazione tecnica. In concreto, però, l’uso che la giurisprudenza ha fatto dello strumento della consulenza tecnica palesa un percorso non privo di esitazioni. 14. L’ispezione e l’esibizione L’ispezione è regolata dall’art. 118 c.p.c. e consiste in un’attività del giudice diretta a percepire determinati oggetti della cui conoscenza il giudice ha bisogno per esercitare la propria potestà. Essa presenta alcune analogie con l’esibizione. Tra i due mezzi si ritiene vi sia una differenza strutturale e funzionale. Da un punto di vista soggettivo l’esibizione può essere disposta dal giudice anche su istanza di parte. Da un profilo oggettivo, desumibile dal codice di rito, la prima è relativa a persone e cose in possesso di una parte o di un terzo, mentre l’esibizione concerne documenti o altra cosa di cui è necessaria l'acquisizione nel processo. L’ispezione pone particolari problemi di tutela dei diritti delle parti e del terzo, che non si evidenziano in termini diversi da quanto accade nel processo civile, anche se è a tale mezzo di prova non sarà riservato un significativo spazio. 15. La testimonianza Con la riforma il legislatore del Codice ha espressamente previsto la possibilità di esperire all’interno del processo amministrativo la prova testimoniale estendendo alla giurisdizione di legittimità la disciplina prevista per quella esclusiva. Il presupposto per detto esperimento è rappresentato dall’istanza della parte. A differenza di quanto avviene nel processo civile, però, la testimonianza è ammessa solo ove assunta in forma scritta, nelle forme previste dal c.p.c. che contempla, quale ulteriore presupposto per la sua esperibilità, l’accordo tra le parti. Per quanto riguarda il modo di deduzione, le incapacità, i divieti ed i limiti a deporre, la facoltà di astensione, l’intimazione, il giuramento, le modalità procedimentali, il confronto dei testimoni, le mancate comparizioni, il rifiuto di deporre, la falsità delle testimonianze, l’assunzione di nuovi testimoni vi è un espresso richiamo al codice di rito. La testimonianza può essere resa solo sulla conoscenza di fatti storici, per cui non è consentito porre ad oggetto di tale prova valutazioni, neppure di natura tecnica. Pertanto, è da ritenere che tale mezzo istruttorio sarà utilizzato prevalentemente nei giudizi di tipo civilistico, potendo il giudice amministrativo meglio servirsi della “verificazione” per la diretta cognizione dei fatti nell’ambito di giudizi di tipo impugnatorio. Si prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, possa disporre l’assunzione di una testimonianza scritta chiedendo al testimone di fornire nel termine fissato le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Inoltre, è previsto che la testimonianza scritta sia resa su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la compilazione, da notificare unitamente al modello. Al termine di ciascuna risposta deve essere apposta, dì seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone che deve essere autenticata da un segretario comunale o cancelliere di un ufficio giudiziario. Vi è la possibilità che il testimone venga sentito personalmente dal giudice dopo aver esaminato le risposte o le dichiarazioni rese. Possibilità che (pare) non possa essere ragionevolmente preclusa al giudice amministrativo, nonostante la naturale riluttanza a non ammettere nel processo prove non documentali, e ciò anche in ragione della possibilità ammessa dal Codice di disporre una audizione personale del verificatore e del consulente. 16. I mezzi di prova non ammessi (l’interrogatorio formale e il giuramento). L'interrogatorio libero. Si distingue tra interrogatorio formale e interrogatorio non formale. Il primo è volto a provocare la confessione dei fatti sfavorevoli alla parte e non è ammesso nel processo amministrativo; il secondo si configura laddove il giudice, in qualunque stato e grado del processo, eserciti la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti, in contraddittorio tra loro, per interrogarle liberamente sui fatti di causa. Quest’ultimo potrebbe trovare una sua valorizzazione nel processo amministrativo, specie in vista di una conciliazione della lite. Dunque, potrebbe collocarsi utilmente in una fase di istruzione preparatoria a fini non tanto probatori, ma quale occasione per programmare lo svolgimento del processo e favorire la conciliazione della lite che va inquadrata nell’ottica di una revisione da parte dell’amministrazione. La funzione preminente dell'interrogatorio libero delle parti è quella di favorire un chiarimento delle rispettive posizioni e conclusioni, rispetto all’oggetto della controversia. È escluso dal processo amministrativo anche il giuramento. Si tratta di una prova legale, che consiste nella dichiarazione con cui una parte asserisce come vero un fatto, nella forma solenne prevista dalla legge. Il codice civile prevede due diversi tipi di giuramento: il giuramento decisorio, quello che una parte deferisce all’altra “per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa”; il giuramento suppletorio quello deferito d’ufficio ad una delle parti “al fine dì decidere la causa", quando la domanda o le eccezioni non sono compiutamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova. 17. Gli altri mezzi di prova (atipici) Le prove atipiche, sono quelle prove non previste dalla legge. Dichiarazioni sostitutive di atto notorio: consistono in dichiarazioni rese a pubblico ufficiale “per” il processo. Esse, proprio in ragione dei contenuti, rappresentavano un mezzo surrettizio per introdurre in quest’ultimo la prova testimoniale, formatasi, inoltre, senza le garanzie del contraddittorio imposte dal codice di procedura civile. Si tratta di dichiarazioni alle quali non veniva riconosciuto alcun valore probatorio ritenendo che esse potevano costituire soltanto un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non consentiva di scalfire la puntuale attività istruttoria dell’amministrazione. Diversa la considerazione che a tale strumento potrà essere riservata alla luce della riforma operata con il Codice. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: la loro efficacia probatoria è ritenuta circoscritta nell’ambito del procedimento amministrativo, conformemente alle previsioni normative. Prove assunte in altro processo: sono valutate dal giudice come argomenti di prova. È innegabile che, nell’ambito del giudizio amministrativo, data la sua peculiarità, appare problematico ammettere de plano il valore probatorio delle prove assunte in altro processo alle quali correttamente, infatti, viene riconosciuto valore di indizio, sia pure nei limiti della garanzia del contraddittorio e del rispetto del connesso diritto di difesa. Perizia stragiudiziale: ha assunto rilievo crescente, soprattutto nel settore delle valutazioni tecniche svolte dall’amministrazione. In particolare, lo strumento della perizia giurata ha ricevuto un crescente utilizzo proprio nel settore concorsuale nel quale si registrano delle aperture rispetto alla tradizionale impostazione che vede il sindacato del giudice circoscritto all’ipotesi di illogicità, incoerenza o irragionevolezza e disparità di trattamento. Non mancano, infatti, ipotesi, sia pur limitate, nelle quali il giudice amministrativo ha ordinato il riesame delle prove concorsuali alla commissione giudicatrice, sulla base di una rilevata incongruità della valutazione delle stesse supportata in giudizio da una perizia giurata che in questo caso ha assunto il valore di vera e propria fonte di convincimento del giudice, e non di semplice elemento di integrazione della domanda. Accertamento tecnico preventivo: ritenuto ammissibile da una parte della dottrina, la cui necessità potrebbe manifestarsi già nell’ambito del giudizio cautelare. Sezione quarta: La fase decisoria 1. Premesse Dopo la discussione del ricorso il presidente del collegio giudicante dispone l’assegnazione (o spedizione) della causa in decisione. Tale atto segna il formale passaggio alla fase decisoria del processo amministrativo, che vede il collegio ritirarsi in camera di consiglio per discutere e decidere l’esito della causa. Assunta la deliberazione, è contemplata poi una serie articolata di atti ed operazioni successive volta a formalizzare e portare ad effetto quanto deliberato in camera di consiglio. Nella fase decisoria, ormai definito l’oggetto del giudizio, ad opera del ricorrente (eventualmente anche dei controinteressati-ricorrenti in via incidentale), nell’esercizio del potere di azione, svoltosi il contraddittorio tra le parti e conclusa l’attività di acquisizione e raccolta del materiale probatorio, ad iniziativa delle parti ovvero anche officiosa del giudice (metodo acquisitivo), il processo amministrativo s’indirizza verso il suo epilogo naturale: la formulazione del giudizio e l’emanazione della sentenza. La fase decisoria è quella terminale del processo amministrativo, in cui il giudice definisce il giudizio, pronunciandosi sulle questioni, in fatto e in diritto, costituenti la materia del contendere. Nell’ambito del processo, la fase decisoria presenta caratteri peculiari di indubbia autonomia e distinzione rispetto al complesso degli atti e delle operazioni ad essa precedenti. Mentre l'iter sequenziale di atti che precede la fase decisoria è funzionale alla “preparazione” ed “istruzione” del giudizio, e contempla atti sia del giudice sia delle parti; la fase decisoria racchiude, invece, soltanto (poteri ed) atti propri del giudice, insistendo essa in modo diretto sull’operazione razionale, propria del giudice, della elaborazione del giudizio, ossia sull’attività del soggetto giudicante che forma logicamente la decisione, o, se si preferisce, del giudice che “decide giudicando (cioè motivando)”, e giudicando, di regola, secondo il diritto. L’assegnazione della causa in decisione e l’autonomia che caratterizza la fase decisoria non escludono affatto eventuali “riaperture” dell'istruttoria e del contraddittorio che si manifestassero necessarie (ad esempio in ragione di eventi sopravvenuti) solo in camera di consiglio; anzi, i canoni costituzionali del giusto processo rendono in alcuni casi doverosa la riapertura dibattimentale. La disciplina della fase decisoria copre sia profili formali sia alcuni aspetti di carattere sostanziale. Quanto ai primi, la disciplina positiva va individuata nei principi processuali e nelle previsioni normative relativi alla regolare composizione del collegio giudicante, alle modalità di deliberazione, stesura e pubblicazione della decisione, nonché nelle norme sulla sentenza come atto processuale. Per ciò che attiene agli aspetti sostanziali, invece, rilevano soprattutto, oltre che le norme che descrivono i poteri decisori del giudice amministrativo, tutte le norme e principi che attengono all’iter logico di formazione del convincimento del giudice, ossia al modo di elaborazione razionale del giudizio da parte del giudice e, dunque, sono idonei ad influire sul contenuto sostanziale della decisione. 2. Profili formali: la formazione della decisione In base agli artt. 75 e 76 del Codice, il collegio giudicante, dopo la discussione del ricorso, si ritira in camera di consiglio per deliberare. Nella pratica dei T.A.R., il collegio giudicante non si ritira in camera di consiglio dopo la chiusura della discussione di ogni singolo ricorso, ma, per comodità di lavoro, di regola dopo la trattazione di tutte le cause chiamate alla medesima udienza. Sebbene l’art. 75 del Codice fissi a dopo la discussione la pronuncia della decisione, la giurisprudenza ritiene che l’indicazione temporale abbia carattere puramente ordinatorio e, di conseguenza, che siano valide anche sentenze deliberate molto tempo dopo la data dell’udienza di discussione della causa. Lo stesso art. 75, prevede che “la decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio. Dopo la discussione del ricorso in udienza, il presidente del collegio dispone l’assegnazione della causa in decisione, dichiarando chiuso il dibattimento. L'assegnazione della causa in decisione, da un lato preclude ai componenti del collegio giudicante la possibilità di esercitare il diritto di astensione; dall’altro determina la chiusura del contraddittorio e la fissazione della posizione processuale delle parti, che non possono più svolgere ulteriori attività difensive né modificare la materia del contendere. L’esercizio del potere di assegnazione della causa in decisione, deve essere esercitato dal presidente del collegio giudicante nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, i quali impediscono di spedire la causa in decisione laddove il difensore abbia dichiarato di rinunziare al ricorso o si sia riservato di proporre motivi aggiunti, a fronte della produzione di documenti da parte dell’amministrazione resistente o dell’adozione di provvedimenti amministrativi connessi all’oggetto del ricorso. Nelle ultime due ipotesi, anzi, è possibile affermare che la parte vanti un vero e proprio “diritto al (congruo) rinvio”. Per ragioni simili, in ossequio ai principi cost. del “giusto processo”, è necessario riportare la causa in udienza, ossia riaprire il contraddittorio e rinnovare la discussione (procedura di “rilettura"), dinanzi a una normativa sopravvenuta, o altra sopravvenienza, di diritto o di fatto, che appaia potenzialmente idonea ad incidere sulla decisione. Si pensi ad un fatto notorio o a un provvedimento amministrativo sopravvenuto (che appaia) satisfattivo dell’interesse del ricorrente, o che sia connesso con l’oggetto del ricorso già assegnato in decisione, dei quali il giudice venisse a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio (notorio giudiziale). Nella fase decisoria possono cioè verificarsi fatti “che è parimenti illogico ignorare o valutare senza la collaborazione delle parti”. Ritenere che la chiusura della discussione impedisca l’ingresso nel processo di siffatte sopravvenienze appare una soluzione rigida e poco coerente con la previsione normativa che ritiene modificabile la decisione fino al momento della sottoscrizione. Viceversa, ammettere che il giudice possa tener conto di circostanze ritenute decisive senza che su queste abbia potuto svolgersi il contraddittorio tra le parti appare, oltre che irragionevole, in contrasto con i canoni costituzionali del giusto processo. Lo stesso trattamento è espressamente riservato dal Codice alle questioni rilevabili d’ufficio di cui il collegio giudicante si avveda solo in camera di consiglio, al momento della decisione: “Se ritiene di porre a fondamento una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto nel verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”. In tutti i casi indicati la “giusta" riapertura del contraddittorio consente di impedire il formarsi della tanto criticata “terza opinione” del giudice (“terza via"), che si verifica allorché esso basi il proprio convincimento su questioni insorte solo in camera di consiglio e sottratte al contraddittorio preventivo delle parti, o su prove sulle quali le parti non abbiano potuto prendere posizione. Se nella fase decisoria, si verifica un fatto che impedisca al collegio che ha già assistito alla discussione di formarsi in modo regolare (morte, decadenza dall’incarico, o altro impedimento di un membro del collegio), la causa viene “rimessa a ruolo” ed assegnata ad altro collegio, totalmente o parzialmente diverso, dinanzi al quale si riapre il contraddittorio e si rinnova la discussione. Alla deliberazione della decisione in camera di consiglio possono prender parte solo i giudici componenti il collegio, che hanno assistito alla discussione, ciò vuol dire che la composizione del collegio giudicante non può contemplare, a di nullità della sentenza, un magistrato che non era presente all’udienza di discussione del ricorso. È questo il principio di immodificabilità del giudice . Se la causa si sia svolta in più udienze distanti l’una dall’altra, e la composizione del collegio non sia rimasta invariata nelle diverse udienze, la richiesta coincidenza va pertanto riferita all’ultima udienza: possono cioè partecipare alla fase decisoria soltanto i magistrati che abbiano preso parte all'ultima udienza di discussione. Corollario del principio di immodificabilità del giudice è rappresentato dalla regola secondo cui deve sussistere coincidenza, sempre a pena di nullità, tra i giudici che hanno preso parte alla deliberazione in camera di consiglio e quelli che la sentenza indica come componenti del collegio giudicante. Il principio di immodificabilità del giudice va esaminato anche da altro profilo. Il Codice, infatti, non si limita a regolare il profilo formale della composizione del collegio giudicante, ma, nella sostanza, mira anche a garantire che la formazione del giudizio e la decisione della causa siano opera di tutti i magistrati componenti il collegio giudicante, e soltanto dì questi: si prevede, infatti, che “La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti il collegio”. Secondo una prassi consolidata e diffusa presso i tribunali amministrativi, tuttavia, in camera di consiglio siedono tutti i magistrati della sezione, i quali assistono al dibattito relativo anche a ricorsi assegnati a collegi giudicanti dei quali essi non fanno parte. Ciò avviene perché, per comodità di lavoro, tutti i magistrati partecipanti all’udienza pubblica, dopo la discussione di tutti i ricorsi dell’udienza, si riuniscono nella stessa camera di consiglio, e ognuno di essi, con altri due, concorre a formare volta per volta il collegio dei tre per decidere ciascuno dei ricorsi. Tale prassi, è fondata su un’interpretazione delle norme processuali secondo la quale agli altri magistrati della sezione, estranei al collegio, pur essendo consentito di “presenziare materialmente” alla decisione dei magistrati componenti il collegio di volta in volta investito della questione, è vietato prendere la parola: essi devono limitarsi cioè ad ascoltare, senza “influenzare” i giudicanti. Tale impostazione, appare ora recepita e positivizzata dal Codice che prevede espressamente che “Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza”. 3. La deliberazione “Quando il giudice è un collegio si presenta il problema della combinazione delle singole attività dei suoi membri per formare la decisione”; si tratta di conciliare, “affinché si consegua il beneficio maggiore della collaborazione nel giudizio, l’uno col molteplice: infatti la decisione, la quale non può che essere una, deve risultare da più giudizi fusi insieme”. A tale conciliazione si provvede mediante due istituti: dibattito camerale e deliberazione. La disciplina processuale parla genericamente di deliberazione della decisione. La distinzione tra dibattito camerale e deliberazione, tuttavia, è senza dubbio conforme alla logica e alla pratica dei tribunali amministrativi, in cui la votazione è sempre preceduta “da un dibattito tra i componenti del collegio, perché è proprio sul confronto tra le diverse opinioni che deve scaturire l'espressione del voto, e devono essere indicati all’estensore della motivazione gli argomenti di questa”. Anzi, la prassi mostra che dei due momenti indicati, quello materialmente ineliminabile è proprio quello del dibattito camerale, dato che la votazione finale (“raccolta dei voti”) può anche essere formalmente omessa laddove il dibattito porti ad evidenza una chiara concordia da parte di tutti i componenti del collegio attorno alla soluzione da adottare. L’ordine del dibattito è fissato dal presidente, nell’esercizio dei suoi poteri di direzione, e avviene sulla base delle osservazioni e dei chiarimenti che il relatore aggiunge all’esposizione già fatta in udienza. Ciascun componente del collegio giudicante comunica ai propri colleghi il proprio punto di vista sulle varie questioni oggetto del giudizio. Il dibattito camerale consiste proprio in questa comunicazione reciproca e contestuale, “cosi che ciascuno formi definitivamente il proprio con la conoscenza del giudizio altrui e siano possibili quelle reciproche influenze, che realizzano appunto il beneficio della collegialità”. Concluso il dibattito, ciascuno dei giudici manifesta in maniera definitiva il suo parere (voto): in ciò consiste la votazione, o deliberazione in senso stretto. Anche il dibattito camerale consiste in una manifestazione di pareri; ma la votazione si distingue dal dibattito perché il voto è un parere definitivamente affermato (e non semplicemente “proposto”). La manifestazione del voto va fatta al presidente, il quale procede alla “raccolta dei voti"; il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio, infine il presidente; la decisione è presa a maggioranza assoluta dei votanti. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato “il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente”. Oggetto (o materia) del giudizio sono le “questioni”, ossia i dubbi attorno ai vari punti di fatto o di diritto oggetto della controversia. La questione non ha limiti minimi: se necessario possono essere isolati dal presidente, per farne una questione, anche punti di fatto o di diritto molto limitati, quali l’interpretazione di una puntuale disposizione di legge o l’attendibilità di una risultanza probatoria. Un limite massimo sussiste invece per le “questioni complesse”, che riguardano non solo un singolo punto di fatto o di diritto (questioni semplici), ma si estendono anche all’applicazione di una norma giuridica. Il limite massimo consiste in questo: la questione può essere proposta sull’applicazione di una norma giuridica, non sull’esistenza di un effetto giuridico che possa derivare dall’applicazione di diverse norme o principi. Per chiarire: la questione può senz’altro essere posta, ad esempio, sulla illegittimità del provvedimento per incompetenza, ma non genericamente sull’illegittimità del provvedimento amministrativo, quando il dubbio verta, oltre che sulla competenza dell’autorità emanante, anche sul difetto di presupposti e sulla ragionevolezza della motivazione. In questo caso dovrà votarsi su tre questioni distinte, e procedere alla raccolta dei voti in modo che la decisione collegiale costituisca realmente l'espressione di pareri convergenti dei votanti. Se nel corso del dibattito camerale vengono prospettate in ordine a una determinata questione più soluzioni, è possibile che alla prima votazione non si formi una maggioranza assoluta attorno ad una soluzione data. In tal caso si applica l'art. 276 c.p.c., ai sensi del quale il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così via, fino a che le soluzioni non siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva. È questo il sistema della formazione artificiale della maggioranza per esclusione progressiva delle soluzioni di minoranza. Una volta che la decisione sia stata deliberata in camera di consiglio e che il presidente abbia provveduto alla stesura e alla sottoscrizione del dispositivo, il relatore è incaricato della stesura della motivazione, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla ad altro giudice; il che avviene nei casi in cui il relatore si sia espresso contro la decisione e sia rimasto in minoranzao. Si tratta di un principio che consente al relatore rimasto in minoranza di essere esonerato dalla stesura della decisione, del che si dà atto formalmente in sentenza con l’indicazione, a fianco della sottoscrizione, della formula “estensore”. Oggi, a differenza del passato, esiste anche la possibilità, per il componente del collegio che sia rimasto dissenziente, di far risultare dal processo verbale le ragioni del suo disaccordo. Alla redazione della decisione deve procedersi “non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa": si tratta, peraltro, di un termine di natura puramente ordinatoria. La funzione specifica e logica della motivazione, di esternazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, comporta la necessità che la sua stesura rifletta l’iter logico di formazione della decisione. Completata la stesura della decisione, questa è sottoscritta dal presidente e dall’estensore. “La sentenza non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione”. Si ricava che la decisione redatta dall’estensore, prima di essere sottoscritta dal presidente, è in realtà ancora un “progetto di decisione”, suscettibile delle correzioni ed integrazioni che si rendessero necessarie, soprattutto al fine di adeguare in modo esatto la motivazione a quanto effettivamente deliberato in camera di consiglio. La giurisprudenza ha precisato che la decisione è modificabile fino al momento della pubblicazione della decisione, che ha luogo subito dopo la redazione e la sottoscrizione. In effetti è con la pubblicazione che si completa il processo formativo della decisione. Il Codice ha confermato il sistema della pubblicazione mediante deposito in segreteria; il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data della firma. La decisione è poi oggetto di comunicazione alle parti entro cinque giorni a cura del segretario, il quale vi provvede mediante il c.d. “biglietto di segreteria”, che può essere consegnato direttamente, o spedito con raccomanda, o notificato mediante ufficiale giudiziario. Le parti saranno così informate della avvenuta pubblicazione della sentenza. Il termine indicato non è perentorio in senso tecnico: alla sua inosservanza non si collega infatti la consumazione di alcun potere e la comunicazione è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza. Si ricorda infatti che a tal fine occorre la notificazione, e che, in difetto di questa, il c.d. termine lungo di impugnazione di sei mesi decorre dalla data della pubblicazione, indipendentemente dalla data e dall’esistenza stessa della comunicazione. 4. Profili sostanziali: la formulazione del giudizio La pronuncia nel merito spesso deve essere preceduta dall’esame e dalla decisione di questioni pregiudiziali. La disciplina del codice di procedura civile, prevede che in tali casi “il Collegio, sotto la direzione del Presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa”. Da ciò si ricava che le “questioni pregiudiziali" si trovano tutte nell’identica posizione di anteriorità logica rispetto al giudizio nel merito: tutte mirano a condizionarlo, o anche ad escluderlo. Nulla è detto in modo espresso circa i criteri cui informare l’ordine di esame delle varie questioni pregiudiziali. La dottrina processualcivilistica dominante, nell’ambito della generica categoria delle “questioni pregiudiziali”, ha distinto, dando la precedenza alle prime, le questioni preliminari di rito dalle questioni pregiudiziali di merito, che in senso proprio attengono agli elementi in base ai quali la domanda deve essere accolta o respinta nel merito. Nell’ambito delle prime, inoltre, ha isolato, riconoscendo ad esse precedenza assoluta, le questioni processuali; che, essendo relative all’esistenza dei presupposti di esplicazione della funzione giurisdizionale, condizionano la possibilità stessa di scendere all’esame delle questioni di merito. Tale criterio è applicato dalla dottrina anche per quanto riguarda il processo amministrativo. Si ritiene infatti che anche in questo processo l’esame delle questioni processuali debba avere la precedenza rispetto a quelle (anche pregiudiziali) di merito. A parere della dottrina, il criterio che distingue le questioni relative ai presupposti di esplicazione della funzione giurisdizionale dalle questioni più prossime al merito della domanda, consente di ordinare anche il rapporto tra le diverse questioni processuali: l’esame di quelle relative alla procedibilità e ricevibilità del ricorso dovrebbe in tal senso precedere tutte le altre; poi quelle relative alla giurisdizione, alla competenza e alle condizioni dell’azione; infine quelle relative alle cause di estinzione del processo. Quest’ultima soluzione, va parzialmente rivista alla luce della nuova disciplina posta dal Codice, ai sensi della quale, dopo la questione processuale del difetto di giurisdizione, ha un ordine vincolato la questione del difetto di competenza, essendo la competenza divenuta inderogabile e non potendo il giudice incompetente esaminare alcuna questione, nemmeno quelle cautelari. L’importanza che sia seguito l'ordine logico tra questioni processuali e di merito emerge non appena si consideri che tale ordine razionale non interessa solo il momento dell'esame delle questioni da parte del collegio giudicante, ma riguarda anche la motivazione della sentenza, nella quale “l’ordine della decisione deve essere puntualmente seguito” e fedelmente riprodotto. Il che acquista grande importanza in un sistema processuale caratterizzato dal doppio grado di giurisdizione, il quale impone di seguire l’ordine razionale di pregiudizialità, anche in vista della possibile impostazione dell’appello. La giurisprudenza, pur nell’adesione formale a tale indirizzo, ha considerato relative le indicazioni provenienti dalla dottrina. Per un verso facendo leva sulla rilevabilità d’ufficio delle questioni processuali; per altro verso facendo applicazione del criterio della “economia dei giudizi”, è giunta spesso a dare la precedenza alle questioni di più spedita soluzione. Spesso accade che tra più questioni pregiudiziali il giudice tenda a prendere in considerazione quella idonea a risolvere la controversia con una pronuncia di rito; anzi, in alcuni casi, il giudice amministrativo espressamente prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal resistente per giungere a un rigetto nel merito del ricorso (dunque invertendo l’ordine logico). A differenza delle questioni processuali, che mirano ad “escludere” il giudizio del giudice adito, le questioni pregiudiziali mirano dunque a “condizionare” la pronuncia sul merito. Il giudice della questione principale giudica incidentalmente, a meno che non si tratti di “cause pregiudiziali”, su tutte le “questioni pregiudiziali”, ossia su tutti i punti controversi la cui risoluzione sia necessaria per la soluzione della controversia principale, ancorché tali questioni esulino dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Per chiarire la portata di tale principio, è necessario soffermarsi sui concetti di questione pregiudiziale e causa pregiudiziale. Non si tratta di una distinzione logica, ma solo di una distinzione posta dalla disciplina processuale, che interviene per regolare la competenza del giudice e l’efficacia della decisione: la “causa pregiudiziale” altro non è che una questione che sfugge alla cognizione incidentale del giudice della questione principale, per essere riservata alla decisione in via principale e di altro giudice. Più precisamente: la “ questione pregiudiziale” attiene a un punto contestato che può essere deciso dal giudice (della questione principale) in via incidentale, e con efficacia limitata al giudizio in corso; la “causa pregiudiziale” attiene anch’essa a un punto pregiudiziale contestato, che però deve essere deciso in via principale in un autonomo giudizio di cui costituisce l’oggetto esclusivo. Nel processo amministrativo la “pregiudizialità civile” trova la sua disciplina nell'art. 8 del Codice, che riconosce al giudice amministrativo, “nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva”, la competenza di decidere le questioni pregiudiziali e incidentali relative a diritti soggettivi, escludendo però che le determinazioni su di esse abbiano carattere di giudicato. Tali disposizioni individuano contestualmente i casi in cui la decisione resta comunque sempre riservata al giudice ordinario: incidente di falso, stato e capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio). A parte questi ultimi casi, che sono “cause pregiudiziali” secondo quanto illustrato poc'anzi, la pregiudiziale civile resta di regola “questione pregiudiziale”. Costituiscono inoltre sempre “cause pregiudiziali”, secondo le regole generali, l'incidente di costituzionalità e le questioni relative all'interpretazione dei trattati comunitari. 5. Graduazione, accorpamento ed assorbimento dei motivi di ricorso Diverso problema è quello di stabilire se esista o meno un ordine che il giudice debba seguire nella trattazione delle questioni attinenti al merito. Restando sul piano dei principi generali del processo dispositivo il problema non dovrebbe porsi. Essendo il thema decidendum fissato dalle domande proposte dal ricorrente ed avendo il giudice il dovere di pronunciarsi su tutte (e solo) quelle, il problema dell’ordine di esame delle domande (di tutte le domande) dovrebbe essere privo di effetti consistenti sul piano della effettività della tutela offerta dal giudice. Un ordine nell’esame delle doglianze dovrebbe imporsi, cioè, solo nei casi in cui il ricorrente stesso manifesti un interesse in tal senso, avendo la possibilità di graduare i motivi, dichiarando l’interesse all’accoglimento di alcuni di essi solo in via subordinata, per l'ipotesi in cui altri motivi non vengano accolti. Il principio dispositivo, infatti, comporta che la parte possa disporre liberamente del ricorso sia nel suo complesso sia in parte, rinunciando solo ad alcuni tra i motivi proposti. Il problema in concreto si pone, tuttavia, in quanto la giurisprudenza sovente riconosce espressamente al giudice il potere di stabilire liberamente l’ordine di priorità dell’esame delle doglianze, e su ciò fonda la prassi dell’assorbimento dei motivi: una volta accolto il ricorso per un motivo il giudice cioè omette di esaminare le altre doglianze proposte dal ricorrente. Tale prassi è stata nel tempo gradualmente ridotta e temperata. Il panorama giurisprudenziale non è omogeneo. Accanto a decisioni che ritengono che l’assorbimento sia facoltativo, ve ne sono altre che affermano invece il dovere del giudice di esaminare le varie questioni secondo criteri di “economia dei giudizi", evitando ogni pronuncia che non sia necessaria ai fini dell’eliminazione del provvedimento impugnato, cosicché il giudice, una volta accertata la fondatezza di un motivo selezionato come prioritario rispetto ad altri, sarebbe tenuto a non pronunciarsi su questi ultimi, sottolineandosi che il motivo accolto provoca comunque l’eliminazione del provvedimento. Accanto a pronunce che ammettono l’assorbimento dei motivi d’impugnazione nelle sentenze di accoglimento si pongono talvolta anche sentenze di rigetto che si limitano ad affermare la legittimità dell’atto, rilevando semplicemente che esso è stato emanato in presenza di tutti i presupposti ed è ragionevole. L’assorbimento in alcuni casi è autorizzato dalla disciplina processuale (assorbimento “legale”: nel giudizio immediato, in cui il giudice può motivare, adottando sentenza in forma semplificata, con riferimento al punto ritenuto risolutivo; o in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, infondatezza, che consente di assorbire la questione di mancata integrità del contraddittorio) o appare giustificato, ancorché non espressamente previsto: nell’ipotesi in cui più motivi siano posti in relazione a diverse interpretazioni del provvedimento impugnato, ad esempio, è coerente ritenere che il giudice, selezionata razionalmente un’interpretazione e qualificato il provvedimento, esamini le sole censure che presuppongono quella interpretazione, assorbendo le altre. La dottrina ha evidenziato che l’assorbimento talvolta si spiega, e si giustifica, in quanto non ogni motivo proposto dal ricorrente è in ogni caso tale da rappresentare un autonomo vizio del provvedimento impugnato. Il capo di domanda, cioè, non coincide (materialmente) con il motivo di ricorso: capo di domanda è ogni (motivo o) gruppo di motivi che denuncia un autonomo vizio di legittimità. La dottrina ritiene che l’assorbimento sarebbe consentito solo nell’ambito di un gruppo di motivi che sotto diversi profili denunciano il medesimo vizio o, al massimo, anche tra capi di domanda fungibili o interdipendenti. Negli altri casi, invece, la prassi andrebbe fortemente limitata, facendo riferimento, ove si intenda continuare a farne uso, non alla generica idoneità della censura accolta a sorreggere l’annullamento dell’atto né al criterio di economia dei giudizi, ma ad un criterio che guardi all’effettività della tutela, cercando cioè di evitare pronunce che lascino spazio, nella riedizione del potere amministrativo successiva all’annullamento, a provvedimenti dell'amministrazione che, pur emendati dei vizi accolti dal giudice, possano riprodurre gli stessi contenuti sostanziali del precedente provvedimento (oggetto di censure assorbite). La stessa esigenza di economia processuale va considerata in un’ottica che va al di là del singolo processo: accogliere il difetto di motivazione e assorbire altre censure sostanziali, infatti, significa costringere il privato ad una nuova impugnativa e, dunque, favorire l’instaurazione di un altro processo per definire la stessa controversia sostanziale. Non desta particolari problemi, invece, l’accorpamento dei motivi di ricorso, inteso quale tecnica cui il giudice ricorre nell’esame dei motivi di ricorso, ai fini di un loro esame congiunto. Si tratta di un'operazione logica: il giudice seleziona razionalmente più censure proposte dalla parte in quanto tra loro simili o logicamente collegate. Qualora il ricorrente abbia sollevato, ad esempio, più profili del vizio di eccesso di potere, il giudice amministrativo tende a raggruppare l'esame di figure sintomatiche tra loro omogenee: ad esempio, i vari vizi della motivazione; il travisamento dei fatti con il difetto di istruttoria. 6. Valutazione delle prove e libero convincimento L’accertamento dell’esistenza (o inesistenza) dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle pretese fatte valere in giudizio costituisce un presupposto essenziale per la formulazione del giudizio e l’emanazione della sentenza. Nella fase decisoria, il giudice amministrativo procede innanzitutto alla valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio. Anche nel processo amministrativo trova applicazione il principio della libera valutazione delle prove, definito anche principio del libero convincimento del giudice. Tale principio attiene appunto al momento della valutazione del materiale probatorio e la sua vigenza comporta l’assenza di regole legali inerenti all’efficacia della prova. Nel processo amministrativo il principio vale ad escludere le prove legali: confessione e giuramento. La portata del principio non è tuttavia limitata a questo aspetto, richiedendo altresì, e soprattutto, che la valutazione dell’efficacia delle prove sia una valutazione razionale, compiuta in base a criteri obiettivi e verificabili: la valutazione delle prove non implica infatti assoluta libertà di apprezzamento del giudice né possibilità di arbitrio del giudice né che il giudice sia posto in una sfera riservata, sottratta ad ogni possibilità di controllo. È disposto, infatti, che il giudice “deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento”. Il principio del libero convincimento, si precisa nella regola della valutazione prudente delle prove da parte del giudice, che, se da un lato implica libertà nella determinazione dell’efficacia delle prove, dall’altro non identifica affatto un potere non sottoponibile a verifiche logiche né un potere di trascurare prove potenzialmente idonee all'accertamento dei fatti. Il prudente apprezzamento ricomprende, anche, i fatti notori e le massime di esperienza, nonché le regole della logica e parità di trattamento. Una recente dottrina ha rilevato che il principio del “libero convincimento” del giudice, usualmente riferito al momento della valutazione della prova, riguarda il momento immediatamente successivo alla valutazione della prova. Il giudice, infatti, prima valuta le prove, poi forma il suo convincimento, sulla base della valutazione operata. Più correttamente deve parlarsi, allora, di “prudente” valutazione delle prove (guidata da regole della logica) e di convincimento del giudice (questo sì) “libero”, in quanto spetta al giudice dichiararsi convinto dell’esistenza o inesistenza dei fatti così come provati o viceversa di applicare la regola di giudizio prevista per l'ipotesi di fatto (rimasto) incerto. L’importanza di questi due momenti e del nesso che li lega evidenziano altresì la necessità che il giudice esamini singolarmente tutte le prove acquisite, procedendo alla valutazione e motivazione analitica quanto meno dei mezzi effettivamente assunti a fondamento della decisione finale e senza fermarsi ad un richiamo generico al complesso delle risultanze probatorie. Si rende evidente l’esigenza, cioè, di un’adeguata motivazione in fatto sulle prove. Il principio del libero convincimento, è stato spesso oggetto di interpretazioni estensive, che ne hanno ampliato in modo eccessivo l’ambito applicativo: si è confuso, ad es., con la valutazione delle prove il diverso profilo dei poteri acquisitivi del giudice. Riguardo al problema dell’ammissibilità della prova raccolta in un diverso giudizio, ad esempio, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in numerose sentenze nel senso della possibilità di utilizzare tale prova “atipica” proprio attraverso il richiamo al principio del libero convincimento del giudice. Si tratta di un richiamo non pertinente: “una cosa è il giudizio sull’utilizzabilità di un elemento come mezzo di prova, altra la valutazione della sua forza probatoria”. Al riguardo è opportuno richiamare l’art. 11, c. 6, del Codice, che, in relazione alle conseguenze di una decisione che abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, prevede che, in caso di riproposizione della domanda davanti al giudice amministrativo munito di giurisdizione “le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova”. 7. La regola del giudizio Nel caso in cui l’istruttoria non abbia raggiunto il suo scopo funzionale, e dunque i fatti allegati dalle parti siano rimasti incerti, si pone il problema di individuare una regola che consenta al giudice di emettere comunque una pronuncia sul merito, cioè che gli consenta di accogliere o rigettare la domanda del ricorrente pur in mancanza della piena prova dei fatti. È questa la c.d. regola di giudizio. L’esigenza di questa regola si impone perché il giudice, in ragione della sua posizione istituzionale e della sua funzione, ha il dovere di decidere. Anche nel processo amministrativo trova applicazione la regola di giudizio dell’onere della prova. Tali previsioni pongono due regole: una istruttoria e una di giudizio. Esse, in sostanza, pur non enunciando espressamente la seconda regola, nel ripartire l’onere dello svolgimento dell’attività probatoria tra le parti, implicitamente distribuiscono tra le stesse parti il rischio della mancata prova dei fatti, e dunque fissano la regola di giudizio. Nel processo civile, essendo la prova dei fatti allegati normalmente nella piena disponibilità delle parti, il nesso tra regola istruttoria e regola di giudizio è ben espresso nella massima “provare o soccombere”. Il giudice non potrà mai trattare come esistente un fatto “non pienamente provato”. Da ciò consegue che, nell'ipotesi di incertezza circa l'esistenza della situazione di fatto allegata, e destinata a soccombere la parte che non sia stata in grado di soddisfare l’onere di prova gravante su di essa. Anche il processo amministrativo risponde all’archetipo del processo di parti. È processo dispositivo, con alcuni temperamenti che riguardano il metodo istruttorio, che ha carattere acquisitivo. L’applicazione della regola di giudizio dell’onere della prova nel processo amministrativo è operata tenendo conto del metodo acquisitivo, che si fonda sulla circostanza che le prove sono spesso nella disponibilità della sola parte pubblica. Nel processo amministrativo, il giudice ha il potere di acquisire le prove, ponendole a carico della parte che ne abbia la disponibilità (in genere l’amministrazione). Si pone dunque il problema di stabilire se l’eventuale intervento officioso del giudice sul piano probatorio, nell’esercizio dei suoi peculiari poteri, propri del metodo acquisitivo, possa riflettersi anche sulla regola di giudizio. Secondo la dottrina dominante l’onere della prova come regola di giudizio potrebbe nel processo amministrativo avere un’incidenza diversa rispetto a quella normale del processo civile. Ciò nel senso che il carico della dimostrazione dei fatti allegati dalle parti può essere fatto gravare dal giudice sulla parte “più vicina alla prova”, che può essere talvolta la parte contraria a quella che ha adempiuto all’onere di allegazione. Perciò la regola in tali casi condurrebbe: la parte (di solito il ricorrente) che abbia allegato il fatto, ma che sia stata dal giudice esonerata dal compito di provarlo, non potrà essere automaticamente investita della responsabilità della incertezza obiettiva attorno alla esistenza del fatto allegato solo perché la controparte non abbia ottemperato all’ordine istruttorio del giudice. In tali casi si ritiene che l’intervento del giudice sul piano istruttorio si rifletta anche sulla distribuzione tra le parti del rischio della mancata prova. L’intervento del giudice non determinerebbe una semplice inversione dell’onere della prova, ma la creazione di un onere diverso in capo all’amministrazione, contenente la rappresentazione di un fatto inverso a quello allegato dal ricorrente. 8. Valutazione del comportamento processuale delle parti Circa l’ingiustificata inottemperanza dell’amministrazione all’ordinanza istruttoria di esibizione di documenti ritenuti necessari o rilevanti ai fini della decisione della causa, la giurisprudenza non è univoca. A fronte dell’inottemperanza all’ordine di esibizione di documenti, infatti, a volte afferma che si deve ritenere provata l’affermazione del ricorrente, a volte desume dal comportamento processuale dell'amministrazione un “argomento di prova"; altre volte ha reagito diversamente, disponendo la reiterazione del provvedimento istruttorio o nominando commissari ad acta al fine dell'acquisizione coattiva dei documenti ritenuti imprescindibili ai fini del giudizio. Il primo indirizzo non va seguito: sembra infatti individuare nell’inottemperanza addirittura una prova legale (di creazione giurisprudenziale), o una confessione o un’ammissione da parte dell’amministrazione. Talvolta si è richiamata, in modo non pertinente, anche la regola di giudizio: ma una cosa è la prova dei fatti allegati dal ricorrente; altra è la regola che il giudice deve seguire nel caso in cui i fatti non siano pienamente provati. Da preferire è il secondo l'orientamento, il quale in modo corretto sottolinea che l'inottemperanza di per sé non ha mai valore di prova, ma rappresenta un elemento di valutazione ulteriore e sussidiario che deve concorrere con altri fatti probatori. Il dato normativo di riferimento è l’art. 64, c. 4, del Codice: “il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”. Gli argomenti di prova sono elementi da soli non sufficienti a formare il convincimento del giudice: sono infatti elementi di giudizio complementari, semplici mezzi di valutazione delle altre prove. Il comportamento processuale dell’amministrazione può quindi essere utilizzato dal giudice come mezzo per la valutazione della prova, non liberamente come fonte di prova. Da esso il giudice può trarre conseguenze utili a rinforzare e a rendere eventualmente concludente in via definitiva quanto già emergente dai dati probatori forniti dal ricorrente. L’inottemperanza all’ordine giudiziale di esibizione di documenti, ad esempio, contegno di per sé non direttamente rilevante ai fini della decisione, può assumere nel concreto un significato tale da influire sulla ricostruzione del fatto da parte del giudice. In definitiva: non esiste una norma che imponga al giudice di dover senz’altro considerare provati i fatti dedotti dal ricorrente, ove l’amministrazione che ne sia richiesta non esibisce i documenti. Tale inottemperanza e comportamento processuale da valutarsi da parte del giudice, senza che esso costituisca una circostanza che debba necessariamente condurre all’accoglimento del ricorso. L’applicazione della regola del giudizio sul fatto incerto, inoltre, non costituisce l'effetto normale e immediato della mancata ottemperanza dell’amministrazione all'ordinanza istruttoria. La regola di giudizio va applicata, infatti, in quei pochi e marginali casi in cui l’inottemperanza dell’amministrazione viene ad innestarsi su un quadro probatorio talmente scarno da rendere inutile ed improduttiva la sua valutazione quale argomento di prova. In tali casi, mancando altre prove da corroborare e valutare, infatti, l'argomento di prova non può operare sulla determinazione del convincimento del giudice. Capitolo 3 : Le impugnazioni Sezione prima: L’appello 1. Il doppio grado di giurisdizione nel processo amministrativo: le fonti Nel nostro sistema di giustizia amministrativa vige il principio del doppio grado di giurisdizione. A seguito dell’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali il Consiglio di Stato è diventato giudice di secondo grado o d’appello. Il sistema del doppio grado di giurisdizione presenta una particolarità in relazione alla Regione Sicilia. In questo caso infatti il giudice di secondo grado è il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Tale assetto è confermato dall’art. 100 del Codice, ai sensi del quale “avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia”. Il doppio grado di giurisdizione nel sistema amministrativo trova specifico riferimento nel testo costituzionale. L’art. 125 stabilisce che nelle Regioni sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo quanto stabilito da leggi della Repubblica. Molto si è discusso sul valore e sul significato da attribuire a questa norma ed in particolare sulla avvenuta costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione perlomeno nell’ambito della giustizia amministrativa. È preferibile aderire all’orientamento che attribuisce al doppio grado di giurisdizione nel sistema di giustizia amministrativa valore di principio costituzionale. Da qui la conseguenza che il Legislatore non potrebbe tornare in via generalizzata ad un sistema privo della suddetta garanzia senza con ciò stesso violare il dettato costituzionale. Aderire a questa impostazione non significa peraltro affermare una vigenza indiscriminata del principio in questione, nel senso che la sua presenza in Costituzione comporta necessariamente che tutte le questioni di rito e di merito in cui è scomponibile una controversia debbano essere soggette a riesame. Eccezioni ve ne possono essere a condizione, come la giurisprudenza del giudice amministrativo ha più volte ribadito, che la lite considerata in senso unitario non sia in via generale priva di una tale garanzia. La disciplina dell’appello è contenuta negli artt. da 91 a 105. Più precisamente: gli artt. da 91 a 99 dettano disposizioni sulle impugnazioni in generale; gli artt. da 100 a 105 contengono norme che si riferiscono in modo specifico al giudizio di appello. Per gli aspetti non disciplinati in questi articoli sono destinate a trovare eventualmente applicazione: a) le altre disposizioni del codice del processo amministrativo in virtù del rinvio interno contenuto nell’art. 38; b) le disposizioni del c.p.c in quanto compatibili stante il rinvio esterno di cui all’art 39, c. 1, del Codice. Infine è da ricordare che l’art. 9 del Codice sul difetto di giurisdizione, che non è inserito nel Libro II, detta tuttavia la disciplina di tale profilo anche per i giudizi di impugnazione e dunque trova applicazione al giudizio d’appello. A seguito dell’introduzione del Codice si dispone un nutrito corpo di norme che regolano l’appello. 2. Natura e caratteri dell’appello al Consiglio di Stato Il giudizio di appello nel processo amministrativo si atteggia come mezzo di impugnazione di tipo rinnovatorio. Detto mezzo, consente ad un giudice diverso di esprimere un nuovo giudizio sulla stessa questione decisa dal giudice di primo grado. L’appello si atteggia anche come un rimedio avente carattere impugnatorio. Si dice tale quello strumento il quale adempie alla funzione di consentire il riesame critico della sentenza da parte di un altro giudice ai fini del suo annullamento. Taluni, in tal caso, preferiscono parlare, anziché di mezzo di tipo impugnatorio, di rimedio in funzione di legalità. Tuttavia la sostanza del fenomeno è chiara: strumento che consente di censurare vizi della sentenza di primo grado. Nell’art. 101 sono disciplinati i contenuti del ricorso in appello. In esso si prevede che il ricorso in appello deve contenere: indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei cui confronti è proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna; l’esposizione sommaria dei fatti; le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata; le conclusioni; la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con indicazione della procura speciale. Il profilo più rilevante è quello relativo alle specifiche censure contro i capi di sentenza che l'atto d'appello deve contenere. Ciò significa che tale atto oggi debba essere costruito non limitandosi a riproporre le censure già esposte in primo grado, ma formulando una specifica critica della sentenza o delle argomentazioni che il giudice svolge per individuare le premesse che sorreggono la decisione. Tale circostanza indubbiamente attribuisce all’appello una struttura tipica del rimedio impugnatorio. Il fatto che un mezzo di impugnazione sia in via generale rinnovatorio, ma nel contempo presenti un carattere impugnatorio, non deve meravigliare. Posto infatti che tra il giudizio di primo grado e quello di secondo grado interviene necessariamente una nuova fattispecie giuridica costituita dalla sentenza, ne consegue che, quand’anche il diritto positivo voglia modellare il rimedio in senso rinnovatorio, non può non tenere conto di questo fatto e dunque non può non prevedere, ed anzi imporre come fa oggi l’art. 101, c. 1, del Codice, la critica della sentenza appellata. Un appello, il cui atto si limiti a riproporre le censure avanzate in primo grado contro il provvedimento, se vi è coincidenza tra ricorrente e appellante, o le difese svolte in primo grado, se l’appellante è stato resistente o controinteressato, dovrebbe essere dichiarato inammissibile. 3. Appello ed effetto devolutivo: le questioni che riemergono nel giudizio Altra caratteristica dell’appello in seno al processo amministrativo è rappresentata dall’effetto devolutivo. Con ciò si fa riferimento al trasferimento al giudice di secondo grado della stessa controversia decisa dal giudice di primo grado. L'effetto devolutivo si produce nei limiti del thema decidendum così come fissato dall’attività delle parti. Nel giudizio d’appello, non possono essere proposte nuove domande né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Si parla del divieto di ius novorum: è impedito l’ampliamento del thema decidendum sia proponendo nuovi motivi sia ampliando i motivi precedentemente dedotti. Eccezione: possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altri parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti amministrativi impugnati, è prevista però un’eccezione essendo consentito di proporre in appello nuovi motivi in presenza di fatti la cui conoscenza sia intervenuta dopo il giudizio di primo grado. In ogni caso nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere prodotti documenti nuovi, salvo che il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. L'effetto devolutivo inoltre non si verifica automaticamente per le questioni non esaminate dal giudice di primo grado o dichiarate assorbite. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o per la parte diversa dall'appellante con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine di costituzione in giudizio. Nei giudizi di impugnazione, e dunque in appello, il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado è rilevato solo se l’appellante abbia proposto specifico motivo d’impugnazione avverso il capo della sentenza che in modo esplicito od implicito abbia statuito sulla giurisdizione. Ciò significa che in ogni caso la decisione del giudice di primo grado comporta una preliminare pronuncia sulla sussistenza della giurisdizione: tale pronuncia può essere esplicita o implicita; ma comunque, affinché riemerga in appello, è necessario un’esplicita censura formulata dall'appellante o dall'appellato. La Corte di Cassazione, nel riconoscere che la statuizione di merito presuppone sempre una previa decisione, ancorchè implicita, sulla giurisdizione, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato, riduce la portata dell’art. 37 c.p.c., sostenendo che la questione non è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello per preclusione da giudicato implicito. Rimane aperta il problema dell’effetto devolutivo rispetto alla riemersione in appello delle questioni relative al ricorso introduttivo (inammissibilità, irricevibilità, nullità, ecc.) non affrontate dal giudice di prime cure. Ad oggi è stato orientamento pacifico in giurisprudenza che dette questioni, se non sono state decise in primo grado, possano essere esaminate anche d’ufficio in appello. In mancanza di dati normativi che regolano la problematica sembra plausibile ritenere che le suddette questioni potranno, anche dopo l’introduzione del Codice, essere rilevate d’ufficio in appello. Tuttavia la posizione espressa non può giovarsi ad oggi di orientamenti della giurisprudenza al riguardo. La proposizione dell’appello non sospende l’efficacia della sentenza di primo grado. Tale efficacia può essere sospesa su istanza di parte. Il giudice dell’impugnazione, valutati i motivi proposti dalla parte e qualora ritenga che dall’esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave ed irreparabile, dispone la sospensione dell'esecutività della sentenza medesima, nonché le altre opportune misure cautelari con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 4. Le decisioni di primo grado appellabili Possono essere oggetto di appello tutte le decisioni del giudice di primo grado che, indipendentemente dalla loro qualificazione in termini di sentenza, presentano un contenuto decisorio. E per converso si deve aggiungere che non possono essere oggetto di appello tutte le decisioni che, ancorché denominate sentenze, non presentano il suddetto contenuto. È grazie all’applicazione di questa regola che in passato, pur in assenza di un’esplicita previsione normativa, si è ammessa l’appellabilità delle ordinanze cautelari adottate dal giudice di primo grado proprio a motivo del loro contenuto decisorio. Comunque il punto maggiormente controverso in tema di decisioni appellabili era dato in passato dalle sentenze non definitive, dal momento che non vi era alcuna norma relativa al processo amministrativo. In sede di processo civile la regola dettata dal legislatore stabilisce non un obbligo di appellare le sentenze parziali, ma un semplice onere, di modo che la parte può scegliere se adire immediatamente il giudice di seconda istanza o farlo attendendo la risoluzione di tutte le questione controverse, formulando in questo secondo caso una esplicita riserva di appello. La soluzione fatta propria dal C.p.c. è oggi recepita dal Codice. Si prevede infatti che contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello o la riserva di appello, con atto notificato entro il termine e depositato nei successivi 30 giorni presso la segreteria del T.A.R. 5. La legittimazione ad appellare, le parti e l’intervento Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e dunque le parti necessarie. L’interventore può proporre appello solo se titolare di una posizione giuridica autonoma. Quando si parla di interventore che può proporre appello, purché titolare di una posizione giuridica autonoma, non può che riferirsi o a coloro che sarebbero stati legittimati a resistere in primo grado o a coloro che sono legittimati a reagire in virtù d una decisione di primo grado che li riguarda in quanto in quella sede interventori ad adiuvandum e ad opponendum. Le figure cui si è accennato sono le seguenti: a) il controinteressato pretermesso che ha partecipato al giudizio di primo grado attraverso l'intervento ad opponendum (in questo caso l’intervento vale come costituzione di parte necessaria); b) l’interventore che in primo grado si è visto, ad esempio, rigettare la domanda di intervento. Il Codice individua anche le parti alle quali va fatta la notifica dell’atto. In proposito si stabilisce che l'impugnazione deve essere: a) notificata nelle cause inscindibili, nelle quali ricorre dunque l’ipotesi di litisconsorzio necessario, a tutte le parti in causa; b) notificata negli altri casi alle parti che hanno interesse a contraddire. I soggetti che possono ricorrere in appello e resistere sono innanzitutto le parti del giudizio di primo grado e dunque quelle che vi hanno partecipato e quelle che, pur essendo state messe nella condizione di partecipare, non si sono costituite. Certamente a seconda del tipo di sentenza adottata dal giudice di primo grado può cambiare la posizione assunta nel giudizio di appello. E così, ad esempio, in caso di rigetto del ricorso la dislocazione delle parti non muta giacchè l’originario ricorrente in primo grado è appellante in secondo, mentre il resistente e il controinteressato continuano a resistere in quanto appellati. Viceversa in caso di accoglimento del ricorso questi ultimi sono appellanti in secondo grado mentre il primo assume la posizione di appellato. È anche possibile però, ove il giudice di primo grado accolga il ricorso soltanto in relazione ad alcuni motivi respingendone altri, che l'originario ricorrente sia nel contempo appellato ed appellante e che in questa stessa situazione vengano a trovarsi il resistente e l’eventuale controinteressato (ciò accade dunque quando vi sia vittoria parziale e dunque parziale soccombenza). In aggiunta alle parti del giudizio di primo grado, costituite e non, possono proporre appello anche coloro che non hanno partecipato al giudizio di primo grado non per scelta, ma a causa della circostanza che non siano stati messi nella condizione di poterlo fare. Si pensi al caso del controinteressato che non ha ricevuto la notificazione del ricorso (controinteressato pretermesso). Ed ancora si collocano nella medesima posizione anche i controinteressati occulti o successivi, quei soggetti cioè la cui posizione di interessati ad opporsi all’annullamento del provvedimento non si evince dal provvedimento impugnato ovvero matura soltanto dopo la sentenza di primo grado. Da quanto detto da ultimo discende una conseguenza importante in relazione alla legittimazione ad appellare: quest’ultima infatti non può essere definita unicamente con riguardo alla posizione processuale della parte in primo grado, ma deve essere valutata alla luce dell’interesse sostanziale di chi, pur non essendo stato parte nel giudizio di primo grado, propone appello. La stessa nozione di soccombenza, che pure è necessaria per proporre appello, va riconsiderata alla luce del fatto che vi possono essere appelli proposti da chi non risulta formalmente soccombente nel giudizio di primo grado. Per quanto riguarda la posizione di coloro che sono stati interventori ad adiuvandum e ad opponendum nel giudizio di primo grado, dalla circostanza che essi non sono legittimati a proporre il ricorso in primo grado, in quanto non titolari di una situazione giuridica soggettiva che a tanto li legittima, discende l’impossibilità che essi possano proporre appello, se non limitatamente a quei capi della sentenza che hanno pronunciato direttamente nei loro confronti ad esempio dichiarando irricevibile od inammissibile l’intervento. Comunque nel giudizio di appello è possibile esperire intervento nelle due forme consuete ad adiuvandum e ad opponendum con atto notificato a tutte le parti. 6. La proposizione del ricorso e lo svolgimento dei giudizio L’appello si propone con ricorso indirizzato al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in relazione alle sentenze del T.A.R. Sicilia al Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana e deve contenere gli elementi indicati nell’art. 101 del Codice. Il termine per la proposizione del ricorso in appello è in via generale (ma vi sono eccezioni rilevanti) fissato in 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ove la notifica della sentenza non vi sia stata, il termine per proporre appello è fissato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tuttavia ciò non accade quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non avere avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione. L’appello deve essere notificato nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza o in difetto presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altri parti, la parte che intende proporre l’impugnazione può presentare al presidente del Consiglio di Stato un’istanza corredata dall’attestazione dell’omessa notificazione per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell’impugnazione. Una volta notificato, il ricorso va depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato a pena di decadenza entro trenta giorni dall’ultima notificazione, decorrente dal perfezionamento della medesima verso il destinatario, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. Gli appellanti possono costituirsi in giudizio nel termine di sessanta giorni che decorrono dalla notifica dell’appello, presentando memoria di costituzione. Prima dell’entrata in vigore del Codice, il suddetto termine era considerato ordinatorio e non perentorio. Nel silenzio del Codice, che non qualifica come perentorio il termine per la costituzione della parte intimata, sembra doversi concludere nel senso dell'ordinatorietà del termine. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la parte voglia riproporre le domande o le eccezioni non esaminate o dichiarate assorbite in primo grado, deve farlo con memoria depositata entro il termine per la costituzione in giudizio a pena di decadenza. In questa ipotesi così il temine per la costituzione è da intendersi come perentorio nel senso che o la parte si costituisce entro il suddetto termine riproponendo con memoria la questioni non esaminate o dichiarate assorbite dal giudice di prime cure o perde la possibilità che la suddetta questione possa essere sollevata e decisa in appello. Infine per quanto riguarda l’intervento la relativa domanda deve essere notificata alle parti e deve essere depositata entro il termine di trenta giorni decorrenti dal momento in cui l’ultima notifica si è perfezionata per il destinatario. In relazione ai termini processuali occorre tenere conto di quanto disposto dall’art. 119 del Codice. La struttura di detto articolo è assai complessa. Nel c. 1 vengono elencati una serie di controversie nei cui giudizi si applicano le disposizioni contenute nell’articolo medesimo. Tali controversie sono quelle relative a: i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione e di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché relativi alla costituzione, modificazione o soppressione dì società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali; i provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri; i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli concernenti la formazione e il funzionamento degli organi; provvedimenti relativi alle procedure d’occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e quelli di espropriazione delle invenzioni adottate ai sensi del Codice della proprietà industriale; i provvedimenti del Coni e delle federazioni sportive; le ordinanze adottate in situazioni di emergenza e i conseguenziali provvedimenti commissariali; i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza; le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della p.a. in materia di impianti di generazione di energia elettrica, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione; i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione, nonché per la modifica e revoca delle medesime, nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia. In relazione alle queste controversie tutti i termini processuali ordinari, sono dimezzati salvo nei giudizi di primo grado quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’art. 62, c. 1, e quelli disciplinati dallo stesso art. 119. 7. L’appello incidentale L’impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo della sentenza. L’appello incidentale deve essere proposto dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti dell'impugnazione proposto da altra parte. Con l'impugnazione proposta ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (che dispone che le parti con le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno prestato acquiescenza alla sentenza) possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza, sancendo altresì che se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia. L’impugnazione incidentale proposta ai sensi dell’art. 334 c.p.c., deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionato nei suoi confronti la notificazione dell’impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, entro dieci giorni. Il codice disciplina due ipotesi. La prima si verifica allorquando vi siano più parti, tutte legittimate ad appellare. In tali ipotesi il Codice ha stabilito che la parte possa proporre appello incidentale ove altra parte abbia già proposto e notificato appello principale. Naturalmente in tale caso l’appello incidentale è nella sostanza un vero e proprio appello principale dal momento che la parte è pienamente legittimata in tal senso. Conseguenza di ciò è che il termine per la proposizione dell’appello è sempre di sessanta giorni. Esso decorre dalla notificazione della sentenza, nell’ipotesi in cui l’appello della parte più diligente venga notificato dopo la notificazione della sentenza; decorre invece dalla notificazione dell’appello proposto dalla parte più diligente se tale notifica cade anteriormente alla notifica della sentenza di primo grado. La seconda ipotesi disciplinata dal Codice, si riferisce al caso di parziale accoglimento del ricorso di primo grado e consente alla parte appellata -ma comunque vittoriosa sia pure parzialmente in primo grado- di formulare censure nei confronti della sentenza diverse da quelle formulate dall’appellante le quali se accolte dal giudice di appello avrebbero comunque consentito alla medesima di mantenere inalterata la posizione di vantaggio assicuratagli dalla sentenza di primo grado. L’esempio classico in proposito è quello dell’atto di approvazione della graduatoria di un concorso pubblico. Il primo degli esclusi impugna l’atto dinanzi al giudice amministrativo adducendo la mancata valutazione di alcuni titoli che, se correttamente presi in considerazione, gli avrebbero consentito di acquisire un punteggio tale da essere utilmente collocato nella graduatoria. Il giudice di prime cure ritiene fondato, e dunque accoglie, solo uno dei motivi prospettati, accoglimento che è comunque sufficiente per ottenere il vantaggio sperato e cioè l’immissione nella graduatoria, respingendo gli altri motivi. A questo punto il controinteressato, e cioè colui che è stato collocato utilmente nella graduatoria, ma all’ultimo posto, propone appello. Di fronte all’appello l’originario ricorrente propone a sua volta appello incidentale riproponendo i motivi rigettati in primo grado di modo che, ove il motivo accolto dal giudice di primo grado venga considerato non fondato dal giudice di appello, l’eventuale accoglimento in tale sede dei motivi rigettati in primo grado consentirebbe comunque al ricorrente in primo grado, appellato in secondo ma anche appellante incidentale, di conseguire una utile collocazione nella graduatoria. Se si ha presente ciò, è evidente come l'appello incidentale si presenti strettamente dipendente dall’appello principale: fino a quando questo non viene proposto non vi è ragione per proporre appello incidentale; se l’appello principale viene proposto, ma successivamente intervenga la rinuncia al medesimo, non vi è ragione di una pronuncia sull’appello incidentale. Quanto detto giustifica dunque la peculiare disciplina che il Codice ha dettato in relazione all’ipotesi che si è realizzata. Se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde di efficacia in quanto non avrebbe più motivo di essere decisa dal giudice di appello. Ed ancora è logico fare decorrere il termine per proporre l’impugnazione incidentale dalla notifica dell’impugnazione principale dal momento che è solo in questo caso che nasce l’interesse a proporre impugnazione incidentale. Infine sempre in tema i impugnazioni incidentali il Codice prevede che, in caso di mancata riunione di più impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre. 8. Le sentenze del giudice di appello Le sentenze che decidono la controversia nel merito possono essere di accoglimento o di rigetto del ricorso. In relazione a queste ultime è possibile che in sede di appello la sentenza del giudice di secondo grado corregga il quadro motivazionale della sentenza del giudice di primo grado senza che venga meno la qualificazione della prima in termini di sentenza di rigetto. Ciò accade ad esempio allorquando il Consiglio di Stato ravvisi una carenza di motivazione della sentenza impugnata e provveda ad integrare la motivazione con la propria sentenza. Se la sentenza è di accoglimento, è sempre presente, perlomeno logicamente se non cronologicamente, un momento rescindente ed un momento rescissorio. Nel senso che, posto che la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva e dunque dotata di imperatività, il giudice d’appello dovrà in senso logico procedere ad eliminare la sentenza di primo grado e poi ad adottare la sentenza che decide nel merito la controversia. Può accadere che il giudice d’appello rimette la causa al giudice di primo grado, o annulla la sentenza con rinvio. Ciò si verifica quando vi sia stato il difetto del contraddittorio o la lesione del diritto di difesa di una delle parti in seno al giudizio di primo grado. In tale ipotesi si debbono fare rientrare tutti i casi in cui vi sia stata la mancata instaurazione del giudizio di primo grado nei confronti di una parte necessaria, nonché la nullità della notificazione ad uno dei controinteressati (a condizione che siano valide le notificazioni effettuate al resistente e ad almeno uno dei controinteressati) o l’errata declaratoria della nullità del ricorso introduttivo. Sembrano integrare inoltre la violazione del contraddittorio o del diritto di difesa di una delle parti e dunque giustificare l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Si prevede l'annullamento con rimessione nel caso di nullità della sentenza di primo grado. Sembra doversi ritenere che l’ipotesi si realizzi quando la sentenza di primo grado risulti non esistente dal punto di vista giuridico in quanto non sottoscritta dal giudice. Infine l’annullamento con rimessione si verifica quando: a) il giudice di primo grado ha erroneamente declinato la giurisdizione; b) il giudice di primo grado ha pronunciato sulla competenza ritenendola erroneamente sussistente o erroneamente insussistente; c) il giudice di primo grado ha dichiarato erroneamente l’estinzione o la perenzione del giudizio. Vi sono anche ipotesi in cui il Consiglio di Stato decide senza rinvio, ancorché non vi sia nel Codice una disciplina esplicita al riguardo. Ciò accade quando il giudice d’appello riconosce il difetto assoluto di giurisdizione o quando si è in presenza della nullità insanabile del ricorso introduttivo o di cause impeditive o estintive del giudizio (ad esempio perenzione o decadenza). In questi casi si deve notare come l’annullamento senza rinvio sia la logica conseguenza del fatto che in siffatte ipotesi non ci poteva e dunque non ci può essere alcuna decisione sulla controversia. Sezione seconda: Le impugnazioni straordinarie contro le decisioni dei giudici amministrativi 1. La revocazione: nozione La revocazione è un mezzo di impugnazione. Essa viene tradizionalmente definita come un’impugnazione limitata o “a critica vincolata” in quanto esperibile solo per i casi tassativamente indicati nell’art. 395 c.p.c., con l’esclusione, quindi, della proponibilità dei motivi di nullità delle pregresse fasi processuali che vanno dedotte con i mezzi di impugnazione ordinari. 2. I casi di revocazione L’art. 106 del Codice fissa un rinvio ai “casi” e ai “modi” previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c. L’art. 395 c.p.c. prevede: 1. l'ipotesi della sentenza che sia l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra. Tale ipotesi, si verifica solo in presenza di un comportamento delle parti e dei loro difensori, nello svolgimento del giudizio così gravemente fraudolento che, oltrepassando i limiti della lealtà e probità, preclude al giudice l’accertamento corretto dei fatti allegati al giudizio facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Conseguentemente, vengono ritenuti (di regola) estranei a tale fattispecie alcuni comportamenti processuali ed extraprocessuali ritenuti inidonei a falsare l’accertamento da parte del giudice: ci si riferisce ad ipotesi quali l’omessa allegazione di circostanze o documenti utili alla difesa avversaria, l’allegazione di fatti non veritieri quando questi possono essere contestati dalla controparte nel corso del giudizio, il deposito di documenti o di motivi aggiunti nell’imminenza dello scadere dei termini processuali, il verificarsi di comportamenti in sede amministrativa integranti ulteriori vizi di atti già impugnati in sede giurisdizionale che devono essere fatti valere come ulteriori motivi di impugnazione; 2. l’ipotesi in cui la decisione si fondi su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, o in cui il riconoscimento o la dichiarazione di falsità, anteriore alla sentenza, sia stato ignorato dalla parte, la quale ha a disposizione il rimedio della querela di falso se tale vicenda si verifica nel corso del giudizio. Deve sussistere, in sostanza, un rapporto di causalità tra la prova falsa e la decisione impugnata per revocazione, nel senso che, senza la falsità della prova, la decisione finale avrebbe avuto un contenuto diverso. Ci si riferisce, in linea teorica, a tutte le prove ammesse nel tipo di giudizio che si conclude con la sentenza oggetto di revocazione. Non risulta però affatto precisato in cosa debba consistere il “riconoscimento” della falsità. A differenza della “dichiarazione”, infatti, il “riconoscimento” dovrebbe promanare da una delle parti processuali, e, precisamente, secondo la giurisprudenza prevalente, dalla parte a cui vantaggio la prova è stata utilizzata dal giudice. La dottrina prevalente ha espresso, però, alcune perplessità sul fatto che, dinanzi a prove raccolte nel giudizio e valutate dal giudice, si possa prescindere dall’accertamento giudiziale della falsità, trattandosi di materia sottratta al potere dispositivo delle parti, come è evidente, ad esempio, nel caso di una prova testimoniale in cui sono impegnati soggetti terzi. Poiché si ritiene che l'accertamento giudiziale della falsità debba essere contenuto in una decisione resa in un giudizio civile o penale e passata in giudicato in data anteriore alla domanda di revocazione, l’esperibilità della revocazione viene esclusa nell’ipotesi in cui la dichiarazione di falsità della prova sia contenuta in una sentenza inidonea ad acquistare autorità di giudicato sostanziale nei confronti dei soggetti contro cui è rivolta la domanda di revocazione; 3. l'ipotesi del ritrovamento successivamente alla sentenza di uno o più documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Si fa riferimento ai documenti in senso stretto, intesi quale supporto idoneo a fissare, eventualmente in forma anche non grafica, la percezione di un fatto storico al fine di rappresentarlo per l’avvenire, dal momento che solo per essi può propriamente parlarsi di “ritrovamento”. Il documento deve preesistere alla sentenza revocanda; deve essere rimasto estraneo alla cognizione del giudice non per un difetto di diligenza della parte nello svolgimento dell'attività difensiva; e deve essere decisivo, ossia idoneo a provocare una decisione diversa o più favorevole alla parte che agisce in revocazione o, comunque, una sostanziale modifica della valutazione di un punto decisivo della controversia. La giurisprudenza, ha precisato che il vizio revocatorio si verifica quando la parte che agisce in revocazione ha ignorato incolpevolmente per tutte le fasi del precedente giudizio inclusa la fase di appello (se si accoglie la tesi favorevole ad ammettere in appello il deposito di nuovi documenti), l’esistenza del documento o il luogo di conservazione dello stesso, o quando la controparte o un terzo in possesso del documento non abbia ottemperato all’ordine di esibizione o di ispezione, ove ammissibile, emanato dal giudice. Chi agisce in revocazione, oltre a dare prova della data del ritrovamento o del recupero del documento ai fini della decorrenza dei termini per la proponibilità del ricorso medesimo, deve depositare materialmente in giudizio il documento unitamente all’atto di ricorso, non essendo considerata sufficiente la sola indicazione di esso con contestuale richiesta di istruttoria per ottenerne l’esibizione; 4. l’ipotesi in cui la sentenza sia inficiata da un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. Il vizio revocatorio si verifica in presenza di una “svista materiale” del giudice sul contenuto materiale degli atti di causa tale da determinare una falsa rappresentazione della realtà. Tale svista deve essere tale da indurre ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, invece incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, o l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato, sempre che la questione attenga ad un punto di cognizione non controverso, ossia un punto sul quale la decisione finale non abbia espressamente pronunciato in quanto altrimenti si verterebbe in una ipotesi di errore di diritto. L'errore di fatto può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti al giudizio, ad esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili, nonché rispetto ad atti o documenti prodotti per la prima volta in sede di revocazione. Il vizio della decisione revocanda deve consistere in un errore a livello di percezione del sostrato materiale della fattispecie esaminata dall'organo giudicante. La differenza fra errore di fatto ed errore di giudizio ai fini della ammissibilità della revocazione emerge chiaramente in quelle pronunce che sottolineano la necessità che l’errore di fatto sia rilevabile dall'esame del fascicolo processuale in maniera oggettiva ed immediata, senza, cioè, richiedere alcuna ricostruzione dell’attività valutativa svolta dal giudice. L’errore di fatto va, altresì, distinto dall’errore di diritto, nel senso sia della mancata considerazione dell’esistenza di una norma (riconducibile alla falsa applicazione) sia di distorsione dell’effettiva portata di essa (riconducibile alla violazione di legge). La giurisprudenza amministrativa nel tempo ha favorito una applicazione estensiva del rimedio revocatorio per errore di fatto riconducendovi anche le ipotesi di omissione di pronuncia, ossia le ipotesi di omesso esame di motivi di ricorso e di eccezioni di inammissibilità contenute in atti difensivi. L’omissione di pronuncia può essere fatta valere come vizio revocatorio se è la risultante di un errore, nella formazione del giudizio, caratterizzato dai requisiti della incontestabilità, decisività e oggettiva rilevabilità. Su quest’ultimo punto la giurisprudenza ha precisato che l’errore di percezione sul sostrato materiale della realtà processuale dev’essere identificabile attraverso la motivazione della sentenza, nel senso che la “distrazione” dell'organo giudicante deve emergere proprio dal raffronto tra la realtà processuale e ciò che risulta invece espressamente dalla sentenza. Tale precisazione porta quindi a concludere che la omissione di motivazione, che ricorre quando domande o eccezioni siano state volutamente disattese dall’organo giudicante senza però che ne siano state enunciate le ragioni, si pone al di fuori dell’errore di fatto revocatorio. L’errore va considerato decisivo quando sussiste uno stringente nesso di causalità necessaria fra l’erronea supposizione e la decisione resa tale da poter affermare con ragionevole certezza che la seconda si fondi unicamente sulla prima. L’espansione del concetto di errore di fatto rilevante per la proposizione della revocazione rispetto ai confini segnati nel processo civile è stata dettata a volte dalla necessità di compensare la mancanza di un sindacato di legittimità in cassazione per le sentenze rese in grado di appello nel processo amministrativo. Ciò traspare con particolare evidenza in quei precedenti giurisprudenziali che hanno ricondotto nell’errore di fatto anche l’ipotesi della mancata considerazione di un giudicato di annullamento di un atto amministrativo a contenuto generale; nonché della mancata comunicazione al difensore costituito della data dell’udienza stabilita per la trattazione del ricorso che induce in errore il collegio circa la regolare costituzione del contraddittorio; 5. l’ipotesi della contraddittorietà della statuizione contenuta nella sentenza con altra sentenza precedente avente tra le parti autorità di giudicato. La giurisprudenza precisa che tale contraddittorietà si verifica solo nel caso in cui tra le due pronunce, rese in giudizi diversi, esista identità, oltre che nei soggetti, anche nell'oggetto, identità intesa quale ontologica concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima. Di talché è apparsa problematica la proposizione del rimedio revocatorio nell'ipotesi in cui la sentenza revocanda abbia pronunciato su questioni poste in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con quelle su cui ha statuito la precedente sentenza. Il giudicato idoneo ad operare con efficacia preclusiva al di fuori del giudizio in cui è stato reso e, quindi, a giustificare la domanda di revocazione è, secondo i principi generali, quello formatosi rispetto a decisioni che abbiano investito il merito del ricorso. Risultano escluse l’ipotesi del preteso contrasto con un giudicato interno formatosi nell’ambito dello stesso giudizio in cui è intervenuta successivamente la sentenza interessata dal ricorso per revocazione; l’ipotesi in cui una delle due sentenze sia stata emessa in sede di giudizio di ottemperanza, nonché, nell’ambito del giudizio amministrativo abbreviato, il contrasto tra dispositivo depositato nella segreteria e contenuto nella motivazione successivamente pubblicata, contrasto che, in quanto riguardante “parti della stessa decisione”, può essere risolto attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale del contenuto della motivazione considerata “cedevole” dinanzi alla asserita prevalenza del dispositivo. Poiché, inoltre, tale vizio, sussiste soltanto se la sentenza passata in giudicato non abbia pronunciato sulla relativa eccezione proposta da una delle parti nel corso del giudizio, la revocazione si configura per questo aspetto come proposizione di exceptio rei iudicata tardiva; 6. l’ipotesi di dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato, ossia l’ipotesi in cui il giudice abbia tenuto un comportamento scientemente a favore di una parte del giudizio in violazione del dovere di imparzialità. 3. Le decisioni revocabili Il ricorso per revocazione è esperibile sia contro le sentenze di primo grado sia di appello. Contro le sentenze del giudice di primo grado la revocazione è ammessa solo se i motivi di doglianza non possono essere più dedotti con l’appello, a consacrazione della tesi che vede tra revocazione e appello un rapporto di subordinazione della prima al secondo e non di concorrenza. Revocazione ordinaria, fondata su su circostanze evidenziabili già al momento dell’adozione della sentenza e sulla base del contenuto di questa, è assoggettata al regime generale dei termini per le impugnazioni e, se proposta, impedisce la formazione della cosa giudicata formale ai sensi dell’art. 324 c.p.c. Revocazione straordinaria è proponibile, entro un termine decorrente dalla concreta rilevabilità del vizio, anche oltre i limiti temporali previsti in linea generale per il passaggio in giudicato della sentenza in quanto basata sui motivi esteriori alla sentenza e dipendenti da fatti non conosciuti prima della formazione del giudicato. L’art. 395 c.p.c. trova applicazione alle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; l’art. 396 c.p.c. si occupa, invece, delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello, statuendo la revocabilità di queste per i motivi esteriori alla sentenza e dipendenti da fatti non conosciuti prima della formazione del giudicato e precisando che, se i suddetti vizi revocatori sono scoperti durante la pendenza del termine per la proposizione dell’appello, tale termine viene prorogato dal giorno dell’avvenimento. In sostanza nel processo civile ed anche nel processo amministrativo avverso le sentenze di primo grado ancora appellabili risultano inammissibili sia la revocazione ordinaria, sia la revocazione straordinaria se i vizi relativi sono scoperti durante la pendenza del termine per appellare. In entrambi i casi i motivi revocatori si convertono in motivi di appello. 4. I termini e la proposizione del ricorso Anche il giudizio per revocazione si propone, con ricorso, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla notificazione della sentenza o dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che ha accertato il dolo del giudice. In difetto della notificazione, la revocazione di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. deve essere notificata entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale disposizione non trova applicazione se la parte, che non si era costituita in giudizio, dimostri dì non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione. Nel termine perentorio il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato, salvo l’onere di estendere -a pena di inammissibilità- il contraddittorio a tutti gli altri controinteressati (ove esistenti) nel termine (parimenti perentorio) fissato dal giudice. Si tratta di previsioni del tutto analoghe a quelle stabilite per il giudizio di primo grado. Il ricorso per revocazione, va notificato, a scelta del ricorrente, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificarlo alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del T.A.R. o al presidente del Consiglio di Stato, un’istanza per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell’impugnazione. I vizi delle notificazioni (salvo le ipotesi di inesistenza) sono suscettibili di sanatoria con la costituzione del convenuto o con la rinnovazione della stessa spontaneamente o in esecuzione dell’ordine del giudice. Il ricorso, una volta notificato, deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, nel termine decadenziale di trenta giorni decorrenti dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. In applicazione del principio del simultanus processus, l'art. 96 (recante la disciplina della pluralità di impugnazioni avverso la medesima sentenza) stabilisce, con portata generale, suscettibile pertanto di trovare applicazione anche per il ricorso per revocazione, che tutte le impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza devono essere riunite per essere definite in un solo processo. Ove però tale regola non venga applicata, comunque la decisione di una di esse non determina la improcedibilità delle altre. Analogamente, sono ipotizzabili impugnazioni incidentali. L’impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo della sentenza (impugnazione incidentale impropria), risolvendosi in uno strumento di concentrazione processuale; con l’impugnazione (tardiva) possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza, statuendo che qualora l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, tale impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Anche nel giudizio di revocazione è possibile esperire intervento nelle due forme consuete ad adiuvandum e ad opponendum con atto notificato a tutte le parti. 5. Il giudizio di revocazione In tema di revocazione si registra un orientamento prevalente, volto a considerare, alla stregua della disciplina del codice di rito, legittimati ad esperire il rimedio revocatorio soltanto le parti formali del giudizio conclusosi con la sentenza revocanda; ed un orientamento minoritario favorevole, nell’ottica della piena attuazione del contraddittorio, ad allargare la legittimazione in capo a tutte le parti sostanziali del processo, ossia a tutti i soggetti i cui interessi vengono lesi dalla decisione revocanda, ancorché rimasti estranei al giudizio di merito non essendovi stati evocati. Il Codice detta una disciplina unitaria a tutte le impugnazioni in relazione alle "parti” cui va fatta la notifica dell’atto, ossia a tutte le parti in causa (ricorrente, resistenti, controinteressati) nelle cause inscindibili, nelle quali ricorre dunque l’ipotesi di litisconsorzio necessario; e negli altri casi “alle parti che hanno interesse a contraddire”, formula piuttosto generica e dunque di dubbia utilità. Il giudizio di revocazione si propone dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza revocanda, e dunque si propone al Tar per la revocazione delle sentenze del giudice di primo grado e al Consiglio di Stato per le sentenze di appello. Ancorché il ricorso per revocazione possa fondarsi anche solo su un errore dei sensi, e non di apprezzamento del giudice, va escluso che di tale giudizio possa conoscere la stessa persona fisica che ha pronunciato la sentenza impugnata, considerata l’esigenza di evitare la c.d. forza della prevenzione attraverso la predisposizione di meccanismi processuali capaci di garantire che il giudice non subisca condizionamenti psicologici tali da rendere probabile il venire meno della sua serenità di giudizio. Il giudizio si articola in due fasi. In un primo momento, il giudice, dopo aver valutato la sussistenza dei presupposti, si pronuncia sulla ammissibilità della domanda di revocazione (iudicium rescindens). Solo a seguito dell’esito positivo di tale accertamento, che porta alla eliminazione della decisione impugnata, il giudice procede a riesaminare nel merito la controversia già precedentemente decisa (iudicium rescissorium); anche se non è escluso che entrambe le fasi vengano decise con una unica sentenza. La fase rescissoria può concludersi anche con una sentenza interlocutoria qualora il giudice ritenga di non disporre di elementi sufficienti per la pronuncia definitiva e ritenga necessario effettuare nuovi adempimenti istruttori. Poiché la fase rescissoria riproduce lo stesso oggetto del precedente giudizio, è evidente che l'ammissibilità di tali adempimenti, così come la possibilità di un “arricchimento” dell’originario thema decidendum, conosce gli stessi limiti che sono stati illustrati con riferimento al giudizio di appello, di cui, secondo la dottrina dominante, la revocazione condividerebbe l’effetto devolutivo. Il ricorso deve contenere sia la richiesta eliminatoria che quella rinnovatoria, e, a prova di inammissibilità, deve indicare il motivo di revocazione e la prova dei fatti su cui esso si fonda e non sospende l’efficacia della sentenza di primo grado. Tale efficacia può essere sospesa su istanza di parte. Il giudice dell’impugnazione, valutati i motivi proposti dalla parte e qualora ritenga che dall’esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave ed irreparabile, dispone la sospensione dell’esecutività della sentenza medesima, nonché le altre opportune misure cautelari con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. La proposizione del ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto. Qualora la sentenza revocanda sia passata in giudicato, la proposizione del ricorso in revocazione non preclude l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, fatti salvi, peraltro, gli effetti delle pronunce di accoglimento emesse nel giudizio di revocazione sull’attività di ottemperanza dell’amministrazione. Se la sentenza oggetto del ricorso per revocazione è al contempo impugnabile anche con ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione, l'art. 398 c.p.c., dopo aver escluso che la revocazione determini una sospensione automatica dei termini per la proposizione del ricorso in cassazione o il procedimento se già pendente, assegna al giudice, dinanzi al quale è proposta la revocazione, il potere di sospendere i termini se ritiene l’impugnazione per revocazione non manifestamente infondata. In questo modo si assegna alla decisione che accoglie la domanda di revocazione una sostanziale portata estintiva del ricorso in cassazione. La sentenza emessa al termine del giudizio di revocazione è sottoposta agli stessi mezzi di impugnazione della sentenza revocata. Si esclude espressamente che tale sentenza possa essere impugnata a sua volta per revocazione. La giurisprudenza amministrativa, però, ha ammesso la revocazione per errore di fatto avverso una sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza di appello. Sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'intero quadro normativo, come risultante anche dagli interventi della Corte costituzionale che hanno ritenuto contraria all’art. 24 Cost. la mancata previsione nel c.p.c della revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto, è giunta a dimostrare che la preclusione alla utilizzabilità della revocazione non può valere per le sentenze del Consiglio di Stato in quanto queste sono ricorribili in cassazione solo per motivi di giurisdizione. Si tratta di casi nei quali, in altri termini, l’ordinamento non prevede ulteriori strumenti di impugnazione per far valere l’errore di fatto. 6. L’opposizione di terzo: nozione L’opposizione di terzo è un mezzo attraverso cui un soggetto, che non è stato parte formale di un giudizio, impugna la sentenza conclusiva di quel giudizio, passata in giudicato o comunque esecutiva, in quanto arreca un pregiudizio alla situazione giuridica soggettiva di cui è titolare. Attraverso l’opposizione di terzo colui che non è stato parte nel processo mira ad eliminare, o comunque a rendere a sé non opponibile, una sentenza che, pur non essendo suscettibile di esplicare nei suoi confronti efficacia diretta di giudicato in virtù dei limiti soggettivi fissati dall’art. 2909 c.c., assume nei suoi confronti una portata pregiudizievole nel momento in cui viene portata ad esecuzione a causa della esistenza di nessi di collegamento, sul piano sostanziale, tra la situazione soggettiva del terzo e quella su cui la sentenza ha statuito, secondo quanto si vedrà tra breve. Tale rimedio viene tradizionalmente annoverato tra i mezzi di impugnazione straordinari in quanto, al pari della revocazione, può essere proposto a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza che si impugna. L’opposizione di terzo, è ora formalmente inserita tra i mezzi di impugnazione del processo amministrativo, nella duplice forma della opposizione c.d. ordinaria e in quella c.d. revocatoria. Rispetto all’assetto previgente risulta ora espressamente prevista, accanto alla opposizione ordinaria, anche quella (c.d. revocatoria) esperibile dagli aventi causa e i creditori di una delle parti avverso la sentenza effetto di dolo o collusione a loro danno. 7. I soggetti legittimati; le sentenze opponibili; il giudice competente e i termini per la proposizione del ricorso L'inserimento dell’opposizione di terzo nella struttura del processo amministrativo è stato alquanto problematico. Sotto il profilo della legittimazione, rispetto alla idea, ormai accolta nel processo civile, che legittimati all’opposizione di terzo siano sia i litisconsorti necessari pretermessi sia i titolari di una situazione soggettiva autonoma e incompatibile rispetto a quella cui il giudice ha dato invece prevalenza nella sentenza opposta, l’art. 108 c.p.a., inspiegabilmente, limita solo a questi ultimi la legittimazione a proporre la opposizione di terzo. In tal modo i controinteressati formali pretermessi avrebbero soltanto il rimedio dell’appello ma sarebbero privi di rimedi nell’ipotesi di passaggio in giudicato della sentenza formatasi senza la loro (necessaria) partecipazione. Sul punto, però, adeguatamente sollecitato dalla dottrina che aveva evidenziato le criticità di una siffatta limitazione, è intervenuto il legislatore che, eliminando l’inciso “titolare di una posizione autonoma e incompatibile”, ha ampliato la platea dei soggetti legittimati all’opposizione di terzo ordinaria, volto a riallineare il processo amministrativo al processo civile rendendo possibile l’esperibilità dell’opposizione di terzo anche alla categoria del litisconsorte pretermesso così da assicurare il principio del contraddittorio; e mantenendo i limiti previgenti in relazione alla sola opposizione di terzo revocatoria di cui al c. 2 del citato art. 108. La legittimazione al rimedio oppositivo risulta, dunque, ampliata rendendo azionabile il rimedio oppositivo da parte di tutti i soggetti comunque non intervenuti nel processo, quando tale assenza non sia dipesa da una loro decisione, ma sia conseguenza di un'omissione rilevante, sia essa dovuta alla controparte, come pure alla mancata attivazione dei poteri d’integrazione del contraddittorio del giudice o derivante da vizi del procedimento amministrativo, per mancata corretta individuazione dei soggetti. L’opponente, pertanto, potrebbe oggi sia dedurre il mancato rispetto delle regole processuali sulla corretta instaurazione del contraddittorio; sia, quale titolare di una situazione soggettiva che non può ricevere soddisfazione contestualmente alla situazione soggettiva tutelata nella sentenza impugnata con l’opposizione in quanto entrambe hanno ad oggetto il medesimo bene, censurare l’ingiustizia della sentenza sotto il profilo della inosservanza delle regole sostanziali sulla prevalenza delle situazioni soggettive dedotte nel giudizio conclusosi con la decisione che si intende opporre. Speculari a questa impostazione si pongono il riconoscimento della legittimazione ad appellare soltanto alle parti formali del giudizio; nonché la legittimazione ad intervenire nel proposto giudizio di appello soltanto al titolare di una posizione giuridica autonoma, ossia a colui che sarebbe legittimato, successivamente alla conclusione del giudizio, a proporre appunto l’opposizione di terzo. Per ovviare all’assenza dell’opposizione di terzo tra i mezzi di tutela dei terzi nel processo amministrativo, la giurisprudenza ha sempre inteso in passato in senso assai ampio l’area della legittimazione ad appellare, estendendola, oltre alle parti c.d. formali del giudizio, anche ai controinteressati in senso tecnico pretermessi in primo grado; e, nelle posizioni giurisprudenziali più avanzate, anche ai controinteressati in senso sostanziale, ai controinteressati successivi nonché ai soggetti titolari di un interesse autonomo e incompatibile, ossia a tutte quelle categorie di soggetti che nello schema processualcivilistico sarebbero legittimati, invece, soltanto ad esperire la opposizione di terzo. Siffatta estensione, è venuta a creare delle parziali sovrapposizioni con l’area dei soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo, che non sembra completamente eliminata dalla nuova disciplina codicistica. L’esperibilità del rimedio oppositivo risulta esclusa, comunque, per i cointeressati, cui manca la qualità di litisconsorti necessari; ma ora è stata formalmente riconosciuta anche a tutti quei soggetti, quali creditori, aventi causa, titolari di rapporti pendenti, o comunque interessati dalla sentenza di riflesso e non in via diretta in virtù dell’esistenza di rapporti di derivazione dei diritti che possono legare il terzo ad una delle parti in causa, i quali, a causa dei limiti soggettivi e della estensione soggettiva del giudicato, non possono considerarsi estranei al precedente giudizio e che sono legittimati a proporre la opposizione di terzo c.d. revocatoria. La recentissima giurisprudenza ha precisato, al riguardo, che “esigenze di carattere sistematico ed ordinamentale portano ad escludere che la riforma dell'art. 108, e quindi l'estensione generalizzata della legittimazione a tutti i terzi, possa essere intesa come comprensiva anche delle situazioni soggettive disciplinate dal c. 2 dello stesso articolo. Ed in effetti, mentre in precedenza, nell'ambito del generale concetto di terzo rispetto alla sentenza, i due commi dell'art. 108 individuavano due diverse sfere di terzi, tra loro autonome e non intersecanti (ossia quella dei terzi titolari di una posizione autonoma e incompatibile, da un lato, e quella degli aventi causa e i creditori di una delle parti, dall'altro), dopo la riforma l'ambito della prima categoria appare tanto vasto da ricomprendere anche il secondo insieme, e quindi da fare ipotizzare che l'opposizione di terzo ordinaria possa essere proposta anche da creditori ed aventi causa, così superando i limiti probatori del dolo o della collusione che caratterizzano l'opposizione revocatoria. Tale lettura non appare però compatibile con l'assetto normativo, in relazione sia ad esigenze sistematiche che alle tecniche di tutela delle situazioni giuridiche. In relazione al primo profilo, deve osservarsi come la disposizione del c. 2 dell'art. 108 si ponga in rapporto di specialità rispetto a quella del primo, giustificando in tal modo la permanenza di una trattazione differenziata delle due situazioni; in relazione al secondo profilo, va evidenziato come la lettura estensiva ed omnicomprensiva dell'ambito applicativo del primo comma porterebbe ad una facile elusione dei termini decadenziali o addirittura prescrizionali di tutela, essendo sufficiente la trasmissione a titolo derivativo del rapporto controverso per legittimare una nuova azione da parte del nuovo titolare. Conclusivamente, deve affermarsi come, anche a seguito della riforma del c. 1 dell'art. 108 del codice del processo amministrativo, gli aventi causa e i ereditori di una delle parti solo legittimati a proporre opposizione alla sentenza unicamente nelle forme del c. 2 del detto articolo, fornendo quindi prova che la sentenza sia stata effetto di dolo o collusione a loro danno, senza potersi valere della diversa disciplina dell'opposizione ordinaria”. Il giudizio di “prevalenza”, su cui ruota il procedimento di opposizione, inerisce al legame fra atti, appartenenti a fasi procedimentali diverse in quanto successive o legate da un nesso di presupposizione, su cui ciascuno dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale fonda il proprio interesse protetto. Oggi, a differenza del passato, si prevede l’opposizione di terzo anche contro una sentenza del giudice di primo grado. La regola generale del processo civile, secondo cui l’opposizione di terzo va proposta dinanzi allo stesso giudice che ha adottato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento dinanzi a lui, è ora recepita anche nel processo amministrativo. Trattasi, secondo l’orientamento dominante, di competenza funzionale che non ammetterebbe deroghe o eccezioni neppure per motivi di connessione; e, secondo l’orientamento maturato nella giurisprudenza processualcivilistica, il giudice dell’opposizione rimarrebbe quello di secondo grado anche quando la pronuncia, oggetto dell'opposizione, sia meramente confermativa di quella di primo grado. Nel caso, però, dell’opposizione esperita avverso una sentenza del giudice amministrativo non passata in giudicato, tale regola subisce una deroga in ossequio al principio della prevalenza dei rimedi impugnatori ordinari su quelli straordinari. In sostanza se avverso la sentenza oggetto di opposizione è proposto appello, il terzo deve intervenire (proponendo, dunque, atto di intervento e non opposizione); e qualora la opposizione sia già stata proposta dinanzi al T.A.R., questo la deve dichiarare improcedibile, e, se il terzo non è ancora intervenuto, gli assegna un termine per provvedere. Nel caso, invece, di concorrenza tra revocazione e opposizione di terzo, accomunate dal medesimo carattere di rimedio rescindente, sembra preferibile la tesi favorevole alla prosecuzione separata dei due giudizi, salvo poi il coordinamento tra le relative sentenze alla stregua del criterio della prevalenza temporale. Ciò anche alla luce della particolarità delle fattispecie in cui ciascuno dei due rimedi impugnatori è chiamato ad operare nonché del fatto che esse possono pendere dinanzi a giudici diversi. Entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza vanno proposti i mezzi di impugnazione, o, nell’ipotesi di opposizione revocatoria, entro sessanta giorni dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la collusione. 8. Lo svolgimento del giudizio La forma dell’atto introduttivo, con cui il terzo si oppone ad una sentenza amministrativa, si ritiene debba essere quella del ricorso, che deve indicare la decisione giudiziale opposta ed essere notificato a tutti i soggetti che hanno partecipato al precedente giudizio. La parte rimasta estranea al giudizio denuncia (o la violazione delle regole sul contraddittorio o) la prevalenza della propria situazione soggettiva sostanziale rispetto a quella cui il giudice della sentenza opposta ha dato tutela. Il terzo opponente può richiedere nuovi mezzi istruttori; dubbia è, invece, la possibilità di proporre nuove domande anche nel caso in cui ad agire dovesse essere (ove ritenuto legittimato) il controinteressato pretermesso. La proposizione del ricorso in opposizione non determina la sospensione dell’esecutività della sentenza pronunciata inter alios e, quindi, non esclude che, nelle more del giudizio, l’attuazione della sentenza opposta determini un pregiudizio a quella situazione giuridica soggettiva sostanziale che l'opponente intende salvaguardare proprio attraverso la proposizione della opposizione di terzo. Analogamente a quanto previsto per gli altri mezzi di impugnazione, tale efficacia può essere sospesa su istanza di parte. Il giudice dell’impugnazione, valutati i motivi proposti dalla parte e qualora ritenga che dall’esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave ed irreparabile, dispone la sospensione dell’esecutività della sentenza medesima, nonché le altre opportune misure cautelari con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Tale facoltà si trasforma in onere se si segue l’orientamento maturato in seno alla giurisprudenza processualcivilistica secondo cui il verificarsi in via definitiva del pregiudizio comporta la inammissibilità del ricorso in opposizione per sopravvenuta carenza di interesse. Nell'ipotesi in cui l’amministrazione abbia comunque adottato atti amministrativi in esecuzione del dictum giudiziale, residuerebbe in capo all'opponente solo la possibilità di proporre un autonomo giudizio di impugnazione, destinato a refluire nel giudizio di opposizione eventualmente già proposto. L’eventuale ordinanza di sospensione, emessa secondo le regole procedurali della fase cautelare, dovrebbe, poi, a differenza del modello civilistico, ritenersi impugnabile. Secondo un’interpretazione l’accoglimento della istanza cautelare nel giudizio di opposizione determinerebbe l’estinzione del giudizio di ottemperanza in ipotesi pendente in relazione alla sentenza opposta per difetto (sia pure temporaneo) del presupposto dell’obbligo della P.A. di conformarsi alla statuizione del giudice amministrativo passata in giudicato; e, comunque, nel caso in cui il giudizio di ottemperanza sia arrivato a conclusione, si ritiene che l’accoglimento della opposizione di terzo travolga le attività esecutive poste in essere dal giudice o dal commissario. La sentenza che conclude il giudizio di ottemperanza può essere impugnata con l’opposizione di terzo per la parte a contenuto di cognizione. All’esito del giudizio, la sentenza che dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso in opposizione, o lo rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria. Nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, invece, appare opportuno distinguere in relazione ai motivi posti a fondamento dell’impugnazione. Se ad agire in giudizio dovesse essere il controinteressato pretermesso sembra difficile negare che la sentenza di accoglimento del ricorso superi i confini di una pronuncia rescindente e disponga, conseguentemente, la rimessione delle parti dinanzi al giudice di prime cure per l’esame nel merito. Negli altri casi, in cui non viene fatto valere il difetto di contraddittorio, non sembrano sussistere, invece, ostacoli normativi a che il giudice dell’opposizione si pronunci pure nel merito del ricorso. La sentenza resa nel giudizio di opposizione di terzo è soggetta, nel codice di rito, alle stesse impugnazioni alle quali poteva essere sottoposta la pronuncia impugnata; nel processo amministrativo va ricordato che avverso le sentenze dei Tribunali amministrativi l’opposizione va presentata dinanzi al medesimo giudice, per cui appare ammissibile ritenere che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione possa essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato medesimo. Sezione terza: La risoluzione delle questioni di giurisdizione 1. Le questioni di giurisdizione e la loro decisione Nel nostro sistema giuridico la protezione giurisdizionale degli interessi giuridicamente rilevanti che assumano consistenza di situazioni giuridiche soggettive è costituzionalmente necessaria: lo si ricava tanto dall’art. 24 Cost., quanto dall’art. 113 Cost. Mentre per i rimedi amministrativi rimane affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario determinare la consistenza dell’interesse alla cui protezione sono funzionali, altrettanto non può dirsi per i rimedi giurisdizionali: per questi, la Costituzione impone al legislatore ordinario di ancorare alla diversa consistenza della situazione giuridica soggettiva abbisognevole di protezione giurisdizionale il riparto di competenza giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo, potendo bensì devolvere a quest’ultimo anche controversie concernenti diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), ma ciò solo con riferimento a materie determinate e purché sussista la connessione con il potere autoritativo dell’amministrazione. A questa regola costituzionale del riparto di competenze, nonché all’interpretazione che a essa è stata fornita dalla Corte, si è uniformato l'art. 7 del Codice, che riconosce la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo sulle controversie concernenti gli interessi legittimi, nonché, in particolari materie individuate dalla legge, su quelle concernenti diritti soggettivi, e ciò a fronte di qualsiasi condotta dell'amministrazione che sia riconducibile anche mediatamente all’esercizio del potere amministrativo. La giurisdizione è delineata dalla Costituzione come funzione unitaria che si deve esprimere nel “giusto processo”. Il giusto processo, deve svolgersi dinanzi a un giudice terzo e imparziale; deve essere governato dal principio del contraddittorio, e dunque svolgersi nei confronti di tutti coloro che, dal suo esito, potrebbero essere incisi in una propria posizione giuridica e che per tale ragione in esso devono (poter) assumere la qualità di parti; nei confronti di tutte le parti necessarie deve essere egualmente garantito il diritto di difesa; il giusto processo deve infine condurre, in caso di esito favorevole al soggetto che l’ha promosso, a una protezione effettiva ed efficace della sua situazione giuridica soggettiva, ossia di quella posizione la necessità della cui protezione rappresenta la causa dell’instaurazione del processo e così dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Secondo una formula elaborata in sede dottrinale, la protezione giurisdizionale è effettiva ed efficace in quanto dia luogo all’attribuzione, al soggetto che la richieda, di tutto ciò che ha diritto di ottenere in base al diritto sostanziale, e ciò in forza di una pronuncia assistita dalla forza del giudicato materiale, in quanto tale tendenzialmente incontrovertibile. Si dice che il giusto processo deve sfociare nell'attribuzione tendenzialmente incontrovertibile, alla parte vittoriosa, del “bene della vita" che la legge sostanziale impone gli venga riconosciuto. Nel disegno cost., la funzione giurisdizionale garantisce la protezione effettiva ed efficace delle situazioni giuridiche soggettive che di protezione abbisognino e il suo esercizio è affidato a una pluralità di plessi individuati sulla base della diversa consistenza delle situazioni giuridiche soggettive per le quali la protezione giurisdizionale sia richiesta, rimanendo escluso -per il carattere unitario della funzione- che la proposizione di una domanda giudiziale a giudice appartenente a un plesso diverso da quello competente a pronunciare sulla sua fondatezza sia di per sé preclusiva della conseguibilità della protezione giurisdizionale. L’assetto delineato dalla Costituzione presuppone il riconoscimento che le situazioni giuridiche soggettive preesistono all’affermazione del bisogno di conseguirne la protezione giuridica in forza dell’esercizio della funzione giurisdizionale, e presuppone inoltre la riconducibilità generale delle situazioni giuridiche soggettive nelle due macro-categorie dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, alla protezione giurisdizionale di ciascuna delle quali è deputato un diverso plesso di giudici. Le questioni di giurisdizioni rappresentano dunque il modo in cui rileva nel processo giurisdizionale il problema della sussistenza e della consistenza delle situazioni giuridiche soggettive, e la loro soluzione che determina la fissazione dei limiti esterni della giurisdizione- sconta le difficoltà di individuare con sicurezza il confine tra interessi semplici e interessi giuridicamente rilevanti, da un lato, il confine tra interessi giuridicamente rilevanti integranti diritti soggettivi o interessi legittimi, dall’altro lato. In definitiva, i confini delle competenze giurisdizionali rispettivamente del giudice ordinario e del giudice amministrativo sono ancor oggi incerti perché incerto, alla luce del quadro fornito dalla giurisprudenza, appare il discrimen tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Se è sempre stato pacifico che il provvedimento emanato in carenza assoluta di potere, o in situazione di difetto assoluto di attribuzione, è qualificabile in termini di inesistenza-nullità, la giurisprudenza del giudice amministrativo è sempre rimasta ferma nel senso che laddove il potere sia astrattamente attribuito all’autorità emanante, ma sia stato in concreto esercitato in difetto delle condizioni o dei presupposti cui la legge ne subordina l’esercizio, il provvedimento con il quale esso viene esercitato è qualificabile in termini di illegittimità, suscettibile di essere fatta valere solo con il ricorso di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Secondo il giudice ordinario, invece, il provvedimento emanato nell’esercizio di un potere bensì attribuito all’amministrazione, ma in difetto delle condizioni e dei presupposti fissati per il suo esercizio, è qualificabile in termini di inesistenza-nullità e non produce perciò alcuna incisione sulla sfera giuridica del destinatario, spettando alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario. L'itinerario logico-argomentativo sviluppato dal giudice ordinario per affermare la competenza giurisdizionale del relativo plesso all’accertamento e alla conseguente pronuncia di nullità di un atto amministrativo per carenza (in concreto) di potere si presta (astrattamente) a essere applicato a fronte di ogni ipotesi in cui si faccia questione di nullità di un atto amministrativo, e dunque con riferimento alle cause di nullità diverse da quelle discendenti dalla violazione o dall’elusione del giudicato. Alla giurisprudenza del giudice ordinario si deve anche l’enucleazione della categoria dei diritti incomprimibili, o non degradabili in forza dell’esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione, identificati con i diritti fondamentali o a fondamento costituzionale: secondo l'orientamento seguito dal giudice ordinario la competenza giurisdizionale sulle controversie instaurare per la protezione di diritti fondamentali spetta unicamente al giudice ordinario ancorché siano stati emanati provvedimenti amministrativi, ritenuti non suscettibili di incidere sui diritti a fondamento costituzionale così da determinarne la “degradazione” dando luogo all’emersione di (meri) interessi legittimi. La Corte costituzionale, ha ritenuto non costituzionalmente illegittimo che il giudice amministrativo possa conoscere, nelle materie attribuite alla sua giurisdizione esclusiva, anche dei diritti fondamentali, e a tale principio la giurisprudenza della Corte di cassazione si è uniformata, ma l’orientamento del giudice ordinario volto ad affermare la competenza giurisdizionale del relativo plesso sulle controversie concernenti i diritti fondamentali continua a essere vitale relativamente alle controversie, nelle quali vengono in rilievo provvedimenti amministrativi, che non siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. È così profilabile una divaricazione (tra giudice ordinario e amministrativo) della competenza giurisdizionale sulle controversie nelle quali, in presenza di un provvedimento amministrativo, si agitino diritti costituzionali, a seconda che si tratti di controversie devolute o no alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: ove non sussista giurisdizione esclusiva, la competenza giurisdizionale spetta (secondo il giudice ordinario) al giudice ordinario quand’anche sia stato emanato un provvedimento amministrativo, posto che il potere autoritativo esprimentesi nel provvedimento non è suscettibile di menomare il diritto e dar luogo a una qualificazione in termini di interesse legittimo della situazione giuridica soggettiva per la cui protezione l’interessato agisce in giudizio. Non degradabili, e perciò resistenti all’esercizio del potere autoritativo, sembra siano anche i diritti fondamentali di seconda generazione, ossia i diritti, a rilevanza sociale, a prestazioni da parte della p.a. che siano connotate dalla rispondenza a standard ovvero qualitativamente elevate: si tratterebbe di diritti per la cui protezione sarebbe sempre competente il giudice ordinario. Ove si consideri che la giurisdizione si esprime nel “giusto processo”, è possibile ritenere che integri questione di giurisdizione anche quella attinente all’interpretazione -e applicazione- fornita dal giudice adito alle regole di diritto positivo che fissano in capo a lui la competenza giurisdizionale a decidere nel merito la controversia sottopostagli, che fissano, cioè, le condizioni e i presupposti per la decisione sulla fondatezza della domanda giudiziale. Così si giunge ad ampliare il genus delle questioni di giurisdizione, includendo in esso una species di questioni ulteriore, e di radicalmente diversa consistenza, rispetto a quella integrata dalle questioni immediatamente riconoscibili come tali (la cui soluzione conduce alla fissazione dei c.d. limiti esterni della competenza giurisdizionale): precisamente la species delle questioni ingenerate dall'interpretazione fornita dal giudice adito alle norme che a lui attribuiscono la competenza giurisdizionale a decidere sulla fondatezza della domanda (limiti interni della giurisdizione). Secondo un orientamento formatosi in epoca ormai risalente nella giurisprudenza delle Sezioni unite, integrano questioni di giurisdizione anche quelle che attengono all’errata composizione del collegio giudicante in relazione al numero dei suoi componenti o in relazione all’assoluta inidoneità di taluno di essi di far parte del collegio: si tratta di questioni che concernono i limiti di validità o esistenza della decisione, e che la giurisprudenza riconduce tra i “motivi attinenti alla giurisdizione” per far fronte all’assenza di un controllo di legittimità sulle sentenze rese dal Consiglio di Stato in grado di appello. Le decisioni sulle questioni di giurisdizione si distinguono in decisioni che la declinano oppure che la affermano. -Le pronunce declinatorie della giurisdizione possono negare la sussistenza della competenza giurisdizionale in assoluto oppure in senso relativo. Si avrà una sentenza declinatoria assoluta allorché si riconosca che nessun giudice è fornito di competenza giurisdizionale sulla controversia: il che si traduce nel disconoscimento della sussistenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, di una situazione giuridica soggettiva. Si avrà sentenza declinatoria in senso relativo allorché si riconosca che non il giudice adito, ma altro giudice è fornito di competenza giurisdizionale a decidere sulla domanda: il che si traduce nell’accertamento che la situazione giuridica azionata non ha la consistenza necessaria per radicare la competenza giurisdizionale del giudice adito. -Mentre le decisioni declinatorie della giurisdizione sono sempre e necessariamente esplicite, trasfuse cioè in statuizioni espresse, invece le decisioni che affermano la giurisdizione possono essere sia esplicite trasfuse cioè in una statuizione espressa- sia implicite. Si avrà decisione implicita sulla sussistenza della giurisdizione in ogni caso in cui il giudice abbia assunto una decisione espressa che presuppone implicitamente risolta, e quindi implicitamente decisa, la questione della spettanza in capo a lui della competenza giurisdizionale a decidere sulla domanda giudiziale. Tutte le sentenze che declinano la giurisdizione, tanto in senso assoluto quanto in senso relativo, pongono fine al processo incardinato dinanzi al giudice adito, e producono quindi, sotto questo profilo, il medesimo effetto. Poiché la legge processuale impone al giudice che accerti il difetto relativo di giurisdizione di indicare il diverso giudice in capo al quale ritiene che la competenza giurisdizionale sussista, sarà dinanzi a quello così individuato che l’interessato potrà rivolgersi per ottenere, laddove sussistano le condizioni volute dalla legge a tal fine, la pronuncia sulla sua domanda. Ciò significa che le sentenze che negano la competenza giurisdizionale del giudice adito affermando la competenza giurisdizionale di un diverso giudice non producono ineluttabilmente la mors della pretesa dell’interessato a ottenere una pronuncia sulla fondatezza della sua domanda giudiziale, e non sono idonee quindi, di per sé sole, a porre definitivamente fine alla controversia. 2. L’accertamento sulla sussistenza della giurisdizione. Il ruolo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione L’intensità, il grado e la frequenza delle questioni di giurisdizione suscettibili di profilarsi nel processo sono idonee a minare la certezza del diritto: inevitabilmente compromessa allorché non risulti nel momento stesso in cui si ravvisi la necessità di ottenere la protezione giurisdizionale di un interesse che si assuma avere consistenza di situazione giuridica soggettiva, se di situazione giuridica soggettiva si tratta, da un lato, quale ne sia la consistenza, e cosi a quale plesso giurisdizionale sia necessario rivolgersi, dall’altro lato. Non solo: poiché la risoluzione della questione della spettanza della competenza giurisdizionale in ordine a una determinata controversia è suscettibile di dilatare l’arco temporale necessario per giungere a una decisione sulla fondatezza della domanda giudiziale, ossia all’accertamento giudiziale di spettanza della protezione conseguibile con il processo, a entrare in gioco è anche la garanzia costituzionale del giusto processo, nell’accezione di processo di durata ragionevole. Le leggi processuali conoscono e disciplinano, diversi strumenti volti alla verifica della spettanza della competenza giurisdizionale nei casi concreti, ossia riguardo alle domande giudiziali di volta in volta formulate dagli interessati; e sono strumenti nell’elaborazione e definizione di quali ha acquisito rilievo centrale la ritenuta necessità di risolvere, in modo tempestivo e definitivo, i problemi attinenti alla sussistenza della giurisdizione e al suo riparto tra l’uno e l’altro dei diversi plessi cui è demandato l'esercizio della funzione. Si può constatare che il progressivo affinamento degli strumenti allo scopo predisposti dalle leggi processuali rappresenta il terreno nel quale si è realizzata la convergenza dell’impegno di tutti gli interlocutori necessari del processo formativo dell’ordinamento e delle sue regole: legislatore, giurisprudenza e dottrina sono orientati all’obiettivo di scongiurare la possibilità che la risoluzione delle questioni di giurisdizione incida necessariamente sulla ragionevole durata del processo, il cui approdo naturale è -dovrebbe essere- la decisione sulla fondatezza della domanda giudiziale, e così sulla meritevolezza della pretesa azionata. La soluzione delle questioni di giurisdizione integra necessariamente il dovere funzionale per il giudice investito di una domanda giudiziale, ovvio essendo che condizione necessaria per pronunciare sulla fondatezza di questa è l’accertamento della sussistenza della potestas iudicandi del giudice adito. Le questioni pregiudiziali devono essere decise prioritariamente rispetto a quelle di merito. La prima questione che a ciascun giudice si impone è quella della sussistenza della sua competenza giurisdizionale. Dal principio generale della decisione per gradi deriva la regola per cui ogni giudice è giudice della propria giurisdizione, è chiamato cioè a risolvere, prima di ogni altra, la questione della sussistenza e della spettanza a sé della competenza giurisdizionale a decidere sulla controversia che gli è sottoposta. La regola ha però una forza tale per cui nessun giudice può ritenersi vincolato dalla pronuncia sulla giurisdizione resa da un giudice diverso: è così possibile che giudici appartenenti a plessi diversi pervengano a decisioni opposte sulla medesima questione di giurisdizione, e ciò potrebbe condurre a rendere indefinitivamente incerta la questione tanto della sussistenza della giurisdizione, quanto della sua spettanza all'uno o all’altro plesso. Si giustifica così, anche sul piano logico, la scelta del nostro ordinamento di individuare un organo giurisdizionale al quale spetta di statuire, con forza vincolante e incontrovertibile per qualsiasi altro giudice, sulla giurisdizione, e specificamente sia sulla sua sussistenza, sia sulla sua spettanza, sia sulla corretta applicazione delle disposizioni processuali che fissano le condizioni cui rimane subordinato l’esercizio della potestas decidendi sulla fondatezza della domanda giudiziale. La funzione di statuire in tal senso è assegnata alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Spetta alle Sezioni unite di risolvere, statuendo con forza vincolante per ogni giudice e per le parti, sia le questioni sulla sussistenza della potestà giurisdizionale, sia le questioni sulla sua spettanza all’uno all’altro plesso; laddove riconoscano che nessun giudice è fornito di competenza giurisdizionale sulla domanda, a essere accertato sarà il difetto assoluto di giurisdizione, equivalente all'accertamento che quella azionata non è una situazione giuridica soggettiva; laddove invece riconoscano che la competenza giurisdizionale sussiste, le Sezioni unite dovranno determinare a quale plesso giurisdizionale essa spetta, con ciò definendo la consistenza della situazione giuridica soggettiva azionata. Le Sezioni unite possono risolvere sia conflitti reali di giurisdizione, che si profilano allorché vi siano pronunce giurisdizionali contrastanti sulla spettanza, in ordine a una medesima controversia, della competenza giurisdizionale dell’uno o dell’altro plesso, sia conflitti virtuali, che si profilano allorché si configuri la possibilità che un conflitto reale possa insorgere. I conflitti, poi, possono essere positivi, allorché giudici di plessi giurisdizionali diversi affermino di essere titolari di competenza giurisdizionale in ordine a una medesima controversia, oppure negativi, allorché la competenza giurisdizionale sia negata tanto dagli uni quanto dagli altri. “La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda”. Ciò significa che a seguito della statuizione delle Sezioni unite che fissa la competenza giurisdizionale in capo all’uno o all’altro giudice, il giudizio potrà proseguire innanzi al giudice di cui è stata accertata la competenza giurisdizionale, senza però che questo sia vincolato a riconoscere la titolarità in concreto, in capo alla parte, della situazione giuridica affermata, nonché a riconoscere che la domanda giudiziale è comunque proponibile: spetta sempre al giudice di merito accertare se la domanda giudiziale della parte, prima ancora che fondata, sia suscettibile di essere decisa nel merito per non sussistere ragioni a ciò ostative diverse da quelle concernenti la competenza giurisdizionale del giudice adito. Alle statuizioni delle Sezioni unite sulla giurisdizione -e solo a queste- viene riconosciuta un’efficacia che travalica i confini del processo in cui sono rese e che si esplica, diversamente da quanto riconosciuto proprio delle pronunce dei giudici di merito, anche nei confronti dei giudici di successivi processi nei quali sia riproposta la medesima domanda: si parla al riguardo di efficacia panprocessuale. Le Sezioni unite possono essere investite della funzione di statuire su una questione dì giurisdizione attraverso quattro diverse vie: la trafila delle impugnazioni, il regolamento preventivo di giurisdizione, la denuncia, in ogni tempo, dei conflitti, positivi o negativi, di giurisdizione, e il promovimento officioso, da parte del giudice, della questione. 3. La trafila delle impugnazioni Ciascun giudice deve verificare la sussistenza della sua potestas iudicandi nella controversia a lui sottoposta, la decisione al riguardo assunta da un giudice di primo grado è suscettibile di essere appellata al giudice di secondo grado, in applicazione della regola generale sull’appellabilità delle pronunce decisorie rese in primo grado. La sentenza del T.A.R. declinatoria della competenza giurisdizionale è suscettibile di essere appellata innanzi al Consiglio di Stato, il quale, ove ritenga sussistente la competenza giurisdizionale negata in primo grado, dovrà riformare la sentenza declinatoria del primo giudice e a questo rimettere la causa. Il Codice non reca alcuna disposizione che indichi e disciplini il meccanismo attraverso il quale, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che riformi la sentenza del T.A.R. declinatoria della giurisdizione, il giudizio verrà a essere nuovamente incardinato dinanzi al giudice di primo grado, limitandosi a stabilire che il Presidente del T.A.R. potrà (e non dovrà) fissare l’udienza di trattazione della causa, ritornata in primo grado a seguito di annullamento con rinvio, con priorità rispetto alle altre, senza essere vincolato al rispetto del criterio cronologico rappresentato dall’ordine di iscrizione delle istanze. Affinché il giudice di primo grado sia reinvestito del potere decisorio, è necessario che la parte, che alla pronuncia abbia interesse, presenti l’istanza di fissazione di udienza, ma è dubbio se l’interessato sia gravato, oltre che dell’onere di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione, anche dell’onere di riassumere il giudizio. Ove però si consideri che di un siffatto onere la legge processuale non parla, appare ragionevole escludere che esso sia ravvisabile, e cosi ritenere che l'interessato ad altro non sia tenuto, se non a presentare l’istanza di fissazione dell’udienza. Rimane però il deficit disciplinare integrato dall’assenza di disposizioni volte a fissare i termini entro i quali l’interessato deve provvedervi. Anche la pronuncia del T.A.R. che affermi la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo potrà essere appellata innanzi al Consiglio di Stato, che potrà confermarla o riformarla. Nel caso in cui riformi la pronuncia affermativa della giurisdizione resa in primo grado, il Consiglio di Stato declinerà la giurisdizione: o in senso assoluto, o in senso relativo, dovendo in questo secondo caso indicare il diverso giudice ritenuto giurisdizionalmente competente. La parte soccombente rispetto alla sentenza resa sulla questione di giurisdizione dal giudice d'appello potrà gravarsene con ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione. È da escludere che sia suscettibile di ricorso in cassazione per motivi di giurisdizione una decisione implicita del Consiglio di Stato sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò perché l’art. 9 del Codice impone di ritenere che solo la decisione implicita sulla (sussistenza della) giurisdizione assunta dal T.A.R. dia luogo, e integri, una statuizione implicita, come tale suscettibile di essere contestata con il rimedio dell’appello, in difetto del quale la statuizione implicita passa in cosa giudicata formale. In assenza di tempestivo appello contro la statuizione implicita sulla sussistenza della giurisdizione promanante dal giudice di primo grado, è escluso dunque che la questione possa essere ulteriormente sollevata, o decisa, in appello, essendo divenuta incontestabile: di qui l’impossibilità di ravvisare, nella pronuncia del Consiglio di Stato che decida il merito della causa (o altra questione di rito che presupponga positivamente accertata la spettanza della competenza giurisdizionale) una decisione implicita (e a fortiori una statuizione implicita) sulla giurisdizione, e cosi l’impossibilità di proporre, nei confronti della sentenza d’appello, il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione: ricorso che non potrebbe che essere dichiarato inammissibile, sia per difettare il presupposto della riconoscibilità di un capo (pur se implicito) di sentenza suscettibile di gravame, sia per la preclusione da giudicato implicitamente formatosi in esito alla pronuncia implicita resa in primo grado. Il termine per la proposizione del ricorso in Cassazione è di 60 giorni laddove la sentenza sia stata notificata, decorrendo dalla data della notificazione, o di sei mesi laddove la sentenza non sia stata notificata, decorrendo dalla data della sua pubblicazione. Il Consiglio di Stato può sospendere gli effetti della sentenza impugnata per cassazione, e disporre le altre opportune misure cautelari, su istanza di parte e purché sussistano ragioni di eccezionali gravità e urgenza. Nel riconoscere detto potere cautelare del Consiglio di Stato, il legislatore del processo amministrativo si è uniformato alla disciplina generale -che attribuisce al giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto del ricorso per cassazione il potere di disporne cautelarmente la sospensione dell’esecuzione- dettata dall’art. 373 c.p.c., così imponendo l’abbandono dell’orientamento giurisprudenziale formatosi nella previgente disciplina. Mentre l'art. 373 c.p.c. richiede, ai fini dell’esercizio in senso favorevole all’istante del potere cautelare del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, che l’esecuzione di questa possa cagionare grave e irreparabile danno alla parte ricorrente, invece l’art. 111 c.p.a. richiede allo scopo la sussistenza di casi di eccezionale gravità e urgenza: si tratta di una formula più rigorosa, che sembra assegnare al Consiglio di Stato un potere cautelare più limitato. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte cassa la decisione impugnata senza rinvio quando riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione; cassa invece con rinvio, “determinando il giudice competente”, nel caso in cui riconosca che la competenza giurisdizionale spetta a giudice diverso da quello originariamente adito, o nel caso in cui riconosca l’erroneità della sentenza declinatoria di competenza giurisdizionale pronunciata dal giudice la cui sentenza è stata oggetto del ricorso alle Sezioni unite. Il giudice del rinvio è investito del potere decisorio sulla controversia in forza di atto di riassunzione, il termine per la notificazione del quale è fissato in tre mesi dalla pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite (art. 392 c.p.c.). Tale disciplina dovrebbe ritenersi applicabile anche per il giudizio di rinvio che si debba svolgere dinanzi al giudice amministrativo, quanto meno nell’ipotesi in cui le Sezioni unite abbiano accolto il ricorso proposto contro una sentenza del Consiglio di Stato declinatoria della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, statuendone la spettanza a detto giudice. Laddove le Sezioni unite statuiscano per la spettanza al giudice amministrativo della competenza giurisdizionale su controversia originariamente radicata innanzi a giudice diverso, il giudice amministrativo viene investito del relativo potere decisorio in forza della “riproposizione del giudizio” da effettuarsi entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni unite. Lo strumento della riassunzione è strutturalmente e funzionalmente diverso da quello della riproposizione del giudizio. La riassunzione è strumento per la prosecuzione del medesimo rapporto processuale. La riproposizione del giudizio a un diverso giudice, invece, si caratterizza per l’instaurazione di un processo nuovo, nel quale non dovrebbero né operare le preclusioni maturate in altro processo, né essere utilizzabili le prove in altro processo acquisite. Si dovrebbe seguire la strada della riassunzione nel caso in cui le Sezioni unite statuiscano per la spettanza al giudice amministrativo della giurisdizione che esso aveva negato, e che si dovrebbe seguire invece la strada della riproposizione del giudizio nel diverso caso in cui le Sezioni unite statuiscano per la spettanza al giudice amministrativo della giurisdizione da esse disconosciuta in capo a un diverso giudice. 4. La trasmigrazione (traslatio iudicii) del processo dall'uno all’altro plesso giurisdizionale È possibile che venga a radicarsi innanzi al giudice amministrativo una controversia originariamente radicata innanzi a un giudice diverso: ciò può accadere a seguito di statuizione delle Sezioni unite, ma può accadere anche a seguito di sentenza declinatoria della propria giurisdizione pronunciata dal diverso giudice originariamente adito. Quando ciò accade, si verifica il fenomeno di trasmigrazione innanzi al giudice amministrativo di una controversia originariamente radicata innanzi a un diverso giudice, appartenente a un diverso plesso giurisdizionale. Detto fenomeno è denominato translatio iudicii transgiurisdizionale e rappresenta il precipitato logico necessario del principio dell’unitarietà della funzione giurisdizionale: unitaria essendo la funzione giurisdizionale, ed essendo il suo approdo naturale la decisione sulla domanda, l’errore (incolpevolmente) compiuto dalla parte circa l’individuazione del giudice giurisdizionalmente competente non può ridondare irreversibilmente in suo danno, ma deve esserle consentito di far trasmigrare il processo dinanzi al giudice fornito di giurisdizione con salvezza (almeno tendenziale) degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta innanzi al giudice sfornito di giurisdizione. È stabilito il termine perentorio di tre mesi che decorre, in caso di sentenza declinatoria del diverso giudice originariamente adito, dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, mentre decorre, in caso di statuizione delle Sezioni unite circa la spettanza della competenza giurisdizionale a giudice diverso da quello adito, dalla pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite. Lo strumento processuale in forza del quale si realizza la trasmigrazione innanzi al giudice amministrativo è individuato, nel c.p.a., nella riproposizione del giudizio: strumento diverso da quello della riassunzione. L’art. 59 realizza una sorta di contaminazione semantica tra i due strumenti, parlando bensì di riproposizione della domanda, ma disponendo che nel nuovo processo rimangono ferme le preclusioni e le decadenze maturate in quello concluso con la declinatoria di giurisdizione, e così applicando, al giudizio incardinatosi innanzi al giudice giurisdizionalmente competente, il regime proprio del processo riassunto; tuttavia distonica rispetto alla figura della riassunzione -e cioè della prosecuzione del medesimo rapporto processuale- è la disposizione recata dal c. 5, secondo cui nel nuovo processo le prove raccolte in quello conclusosi con la declinatoria di giurisdizione sono valutabili (solo) come argomenti di prova: il che appare suscettibile di incrinare la portata applicativa concreta del conclamato principio dell’unitarietà della funzione giurisdizionale. Il c. 3 art. 59 stabilisce che questo potere spetta al giudice dinanzi al quale il processo è riassunto; infine, il c. 4, stabilisce che l’inosservanza dei termini stabiliti per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio determina l’estinzione del processo: disposizione oscura, sia perché non si ravvisa una significativa dissonanza di significato tra riassunzione e prosecuzione del processo, considerato che è la riassunzione che realizza la prosecuzione del processo, sia perché gli unici termini che l’art. 59 fissa sono quelli di cui al c. 1, che letteralmente sono termini fissati per la riproposizione della domanda, e non per la riassunzione del processo. Sembra però che gli indici prevalenti, conducano a interpretare l’art. 59, legge n. 69/2009 nel senso che il legislatore abbia individuato, quale strumento in forza del quale si realizza la translatio, la riassunzione. Ed è questa una conclusione che si rafforza ove si consideri che l’art. 44, legge n. 69/2009, individua allo scopo, a valere quale principio/criterio direttivo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, un’unica strada, quella della riassunzione, percorribile tanto se la pronuncia sulla giurisdizione promani dalle Sezioni unite, quanto se promani invece da un giudice di merito: poiché il meccanismo per rendere concretamente possibile la translatio iudicii non può che essere il medesimo sia che la declinatoria promani dal giudice ordinario, sia che promani dal giudice amministrativo, sembra necessario concludere che l’ambiguità che connota l’art. 59, legge n. 69/2009 vada superata alla luce di quanto univocamente dispone l'art. 44, e che pertanto la translatio si realizzi in forza di riassunzione. E così, è escluso che la trasmigrazione della causa dal giudice giurisdizionalmente incompetente al giudice amministrativo si realizzi in forza della prosecuzione del giudizio (cioè con la riassunzione), essendo invece necessario riproporre il giudizio e quindi incardinare un processo strutturalmente nuovo, e le prove raccolte nel precedente giudizio possono essere valutate solo come argomenti di prova; le misure cautelari concesse nel precedente giudizio perdono la loro efficacia con il decorso di trenta giorni dal deposito della pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice che le ha pronunciate. Nel processo riproposto operano le preclusioni e le decadenze maturate nel precedente giudizio, salva la possibilità, per il giudice del nuovo processo, di concedere la rimessione in termini per scusabilità dell’errore. Il c.p.a., così come l'art. 59, l. n. 69/2009, non prende posizione sulla questione, sollevata già all'indomani della pronuncia della Corte costituzionale in tema di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, concernente la possibilità, in caso di trasmigrazione del processo, di mutamento della domanda giudiziale che sia identificata in base ai criteri tradizionali, e così facendo perno sul petitum formale: problema che si pone naturalmente allorché la declinatoria della giurisdizione concerna una domanda di accertamento o di condanna proposta innanzi al giudice ordinario, e una domanda di accertamento o di condanna non sia proponibile in via autonoma nel processo amministrativo, nonché nello speculare e opposto caso in cui la declinatoria concerna una domanda costitutiva proposta innanzi al giudice amministrativo e a essere ammessa, nel giudizio civile, sia solo una domanda di accertamento o di condanna. Era senz'altro auspicabile che il legislatore del c.p.a. introducesse una disciplina univocamente volta a dirimere i dubbi profilabili al riguardo, sancendo che quello cui occorre riguardare, in caso di trasmigrazione del processo, è non tanto la domanda originariamente proposta in quanto identificata da uno specifico petitum formale, quanto invece la domanda in senso sostanziale, intesa come “domanda di giustizia", ossia di protezione giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva che si afferma lesa a opera di un determinato soggetto. Pur non avendo disposto alcunché su questa problematica, sembra che proprio per aver impiegato, al fine di consentire la trasmigrazione dall’uno all’altro giudice, lo strumento della riproposizione del giudizio, specificando che ciò che è suscettibile di essere riproposto è, appunto, il giudizio e non la domanda in senso formale, l’art. 11 c.p.a. abbia inteso sancire che ciò che trasmigra è l’oggetto del giudizio, ossia la domanda di protezione della situazione giuridica soggettiva (o domanda di giustizia intesa in senso sostanziale). Tanto l’art. 59, l. n. 69/2009, quanto l’art. 11 c.p.a. stabiliscono che il giudice indicato come giurisdizionalmente competente dal diverso giudice che abbia declinato la competenza giurisdizionale del plesso cui appartiene, non è affatto vincolato dall’indicazione da questo fornita, potendo conseguentemente giungere anch’esso alla declinatoria della propria competenza giurisdizionale. Si potrebbe verificare, dunque, il caso di una doppia declinatoria, da cui conseguirebbe la necessità, per la parte che nondimeno aspiri a una decisione di merito, di seguire la trafila delle impugnazioni, da esperire naturalmente nei confronti della seconda sentenza declinatoria posto che il giudizio può essere riassunto o riproposto presso un diverso giudice solo a seguito del passaggio in giudicato della prima sentenza declinatoria. Ove ciò accadesse, sarebbe evidente sia il dispendio di mezzi processuali, sia l’incisione sul principio del giusto processo nell’accezione di processo a durata ragionevole: la legge processuale consente così che il giudice indicato come giurisdizionalmente competente nella sentenza declinatoria di un diverso giudice, e che ritenga di dover dubitare della propria competenza giurisdizionale, sollevi d’ufficio la questione di giurisdizione denunciando alle Sezioni Unite il conflitto (negativo) di giurisdizione; ciò è possibile, però, solo fino alla prima udienza. 5. Il regolamento preventivo di giurisdizione Tra i sistemi di verifica della giurisdizione nel corso del giudizio, l’ordinamento contempla il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ciascuna parte può richiedere, fino a che la causa non sia decisa nel merito in primo grado, che le Sezioni Unite della Corte di cassazione si pronuncino sulla questione di giurisdizione. Legittimate a ciò, sono solo le parti in senso sostanziale, ossia le parti nei confronti delle quali la sentenza deve essere pronunciata. La proposizione del ricorso per regolamento preventivo non determina la sospensione automatica del giudizio radicato innanzi al giudice della cui competenza giurisdizionale si dubiti, producendosi soltanto laddove questo ritenga che la questione di giurisdizione non sia manifestamente inammissibile o infondata. Allorché il giudizio amministrativo sia sospeso, per la pregiudiziale decisione sul regolamento ritenuto non manifestamente inammissibile né manifestamente infondato, il giudice potrà bensì esercitare i poteri cautelari che ordinariamente gli competono, ma soltanto laddove ritenga di essere giurisdizionalmente competente: in altre parole, la non palese implausibilità della questione è sufficiente a dar luogo alla sospensione del giudizio di merito, ma non è sufficiente invece ai fini dell’esercizio, da parte del giudice amministrativo, del potere decisorio cautelare, l’esercizio del quale è a lui possibile soltanto laddove ritenga che la questione di giurisdizione, pur plausibilmente sollevata con l’istanza di regolamento preventivo, sia suscettibile di essere risolta con l’affermazione della spettanza a lui della giurisdizione. Nel processo civile, la questione di giurisdizione può essere sollevata anche dall’amministrazione che non sia parte in causa: essa può chiedere attraverso il ricorso in Cassazione, in ogni stato e grado del processo, e “finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato”, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in considerazione dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa: ciò che l'amministrazione che non sia parte in causa può far valere per tale via, dunque, è il difetto assoluto di giurisdizione. A seguito del riconoscimento sia giurisprudenziale che normativo della riconoscibilità di una decisione implicita sulla giurisdizione costituente oggetto di possibile giudicato implicito, la facoltà del ricorso alle Sezioni unite, deve ritenersi preclusa laddove la questione di giurisdizione sia oggetto di decisione implicita coperta da giudicato implicito: il ricorso alle Sezioni unite, dunque, dovrà ritenersi precluso anche a fronte di giudicato meramente implicito sulla giurisdizione. È difficile ipotizzare che nel processo amministrativo possa profilarsi una questione di difetto assoluto di giurisdizione suscettibile di essere sollevata da un’amministrazione che non sia parte in causa, volta che il processo amministrativo si svolge sempre nei confronti di un’amministrazione, che è dunque necessariamente parte in causa. 6. I casi di ricorribilità in Cassazione “in ogni tempo" Si ammette la possibilità di risolvere “in ogni tempo” i conflitti attraverso la proposizione del ricorso in cassazione delle sentenze tra loro confliggenti. La contestazione può avere ad oggetto sia i conflitti, positivi o negativi, di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari; sia i conflitti, negativi, di attribuzione tra amministrazione e giudice ordinario. La giurisprudenza, ha precisato che la norma sottrae la proponibilità del rimedio ai limiti temporali fissati per le impugnazioni e, di conseguenza, ammette la proposizione del ricorso anche nel caso in cui una delle due decisioni tra loro confliggenti sia passata in cosa giudicata formale. Il ricorso alle Sezioni unite, è dunque idoneo a scalfire il giudicato formale, o, forse più esattamente, il giudicato formale caduto sulle pronunce tra loro confliggenti non osta all'esperibilità del rimedio: ciò è logico, perché il conflitto -che integra un contrasto- tra pronunce giurisdizionali integra una gravissima incisione al principio di certezza delle situazioni giuridiche, e l’ordinamento deve prevedere strumenti idonei a eliminarlo, senza che il loro esperimento possa essere precluso dalla circostanza che le pronunce confliggenti siano coperte da cosa giudicata formale. Naturalmente, perché si profili un conflitto è necessario che le pronunce tra loro in contrasto abbiano deciso una controversia identica; la giurisprudenza appare prevalentemente orientata nel senso di ritenere l’identità vada valutata sulla base del titolo della pretesa azionata, e non invece sulla base del petitum formale: le controversie decise dai diversi giudici le cui pronunce sono tra loro in conflitto possono essere identiche, dunque, anche allorché il rispettivo petitum formale sia diverso. Capitolo 4: La sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo Sezione prima: sospensione ed interruzione l. La sospensione Durante lo svolgimento dell’iter processuale si possono verificare atti o fatti di vario genere, di carattere accidentale, che costituiscono una deviazione rispetto al corso ordinario del giudizio. Si parla di “questioni incidentali” o di “incidenti” del processo. A seconda del prodursi o meno dell’effetto sospensivo, gli incidenti del processo si distinguono in due gruppi. incidenti che non sospendono il giudizio, che sono: il ricorso incidentale, l’intervento in causa, la riunione dei ricorsi, le misure cautelari, la domanda di ricusazione del giudice. incidenti che sospendono il giudizio, cioè determinano una pausa -temporaneo arresto- nello svolgimento del processo, che prende il nome di sospensione. La sospensione, dunque, a differenza della interruzione, attiene all’ufficio del giudice e non (direttamente o indirettamente) alla posizione delle parti; ha carattere volontario; deve essere disposta (e non semplicemente dichiarata) dal giudice, non integrandosi la fattispecie sospensiva in assenza del relativo provvedimento giurisdizionale. In dottrina è invalsa la distinzione tra sospensione propria e sospensione impropria. La prima si verifica allorché penda avanti al giudice civile o amministrativo altra causa la cui decisone risulti essere pregiudiziale rispetto alla causa incardinata innanzi al giudice amministrativo (si pensi alla sospensione facoltativa per pregiudizialità civile). La seconda è, invece, ravvisabile quando nel processo amministrativo si svolge una fase affidata alla cognizione di altro giudice. Per esempio il regolamento preventivo di giurisdizione, il regolamento di competenza. Quanto all’incidente di costituzionalità ed al rinvio pregiudiziale di interpretazione o di validità di norme comunitarie, la disciplina di tali meccanismi sospensivi non presenta particolarità di rilievo con riferimento al processo amministrativo. Peraltro tale disciplina risulta de plano applicabile al detto processo, atteso l’inequivoco disposto dell’art. 79, c. 1, del Codice: “La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea”. L’ampia definizione delle questioni pregiudiziali raccoglie tutte le questioni che condizionano, le sorti del giudizio, nel senso che la decisione finale non potrebbe essere adottata senza preventivamente portare a soluzione la questione che si assume come pregiudiziale. Talora l'emersione di un contrasto sulla questione pregiudiziale non determina la sospensione del processo, poiché al giudice della questione principale è consentito risolvere incidenter tantum, e quindi senza forza di giudicato, anche la questione pregiudiziale. Ciò avviene, nel processo amministrativo, con riguardo alle pregiudiziali civili. Nei rapporti tra giudizi amministrativi si è sempre ritenuto applicabile l’art. 295 c.p.c. il quale, onde evitare un contrasto tra giudicati, rimette la sospensione alla discrezionalità del giudice in ogni caso “in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Oggi tale applicazione è indirettamente confermata dall’art. 79 del Codice, in virtù del quale le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sono appellabili. È consolidato l’indirizzo secondo il quale l’applicabilità dell’art. 295 c.p.c. presuppone un nesso di stretta dipendenza e conseguenzialità logica tra due controversie, nel senso che il merito dell’una non può essere esaminato prima che venga definita da altro organo giurisdizionale la questione pregiudiziale; inoltre il vincolo di pregiudizialità deve riguardare l’intera res litigiosa dedotta con il ricorso. Dunque l’art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione del processo quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, postula non un mero collegamento tra due statuizioni, ma un vincolo di stretta consequenzialità, tale per cui l’altro giudizio, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione sia determinante, in tutto od in parte, per l’esito della causa da sospendere. Il Consiglio di Stato ritiene che la sospensione del giudizio, in quanto espressione dell’esigenza di ordine generale di ovviare a possibili contrasti fra giudicati trovi logica applicazione anche nel caso di pendenza di controversia promossa con ricorso straordinario al Capo dello Stato avente contenuto pregiudiziale; ciò stante il carattere definitorio della controversia stessa, del relativo provvedimento giustiziale, insuscettibile di annullamento, revoca o riforma da parte dell’amministrazione interessata. Questa posizione non trova però concorde la giurisprudenza, parte della quale esclude l'operatività dell’art. 295 c.p.c. facendo leva sulla natura amministrativa -e non giurisdizionale- del ricorso straordinario al Capo dello Stato. È comunemente esclusa, nel processo amministrativo, la sospensione su istanza di parte ex art. 296 c.p.c. Sennonché, il richiamo dell’art. 79, c. 1, del Codice alla normativa del c.p.c. quale disciplina “naturale” della sospensione processuale sembra mettere oggi in dubbio tale assunto. Quanto all’ipotesi in cui penda procedimento penale connesso al giudizio incardinato avanti al giudice amministrativo, si esclude la sospensione di quest’ultimo alla luce del principio di separazione dei processi incorporato dall'art. 2, c. 2, c.p.p.; tale norma, infatti, disconosce efficacia vincolante in altri processi alle decisioni del giudice penale che risolvano incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale. Allorché la sospensione venga effettivamente disposta, la riassunzione del giudizio deve avere luogo nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. Sussistono altre ipotesi nelle quali la sospensione è inevitabile, atteso che la disciplina positiva preclude al giudice della questione principale di conoscere anche di quella incidentale, rimettendo quest’ultima, in via categorica, alla cognizione di altro giudice. Il giudice amministrativo non può conoscere la legittimità di atti amministrativi ormai inoppugnabili, anche se per la questione sarebbe astrattamente competente: glielo impedisce il decorso del termine perentorio di impugnativa. In secondo luogo, tale giudice non può conoscere delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi, né delle questioni di interpretazione comunitaria. L’incidente di falso si verifica allorquando si deduce nel giudizio amministrativo la falsità di un documento rilevante ai fini della decisione. La falsità non può essere conosciuta dal giudice amministrativo, ma deve essere dedotta di fronte al giudice ordinario con l’apposito strumento della querela di falso. Si è allora in presenza di una causa anch’essa pregiudiziale, in quanto la questione stessa, pur mantenendo la propria funzione di antecedente logico-giuridico, forma oggetto di un autonomo giudizio. Sul piano procedurale, l'impugnazione di falso può avvenire in due possibili modi: - mediante la proposizione della querela di falso, ad opera della parte, in via autonoma, avanti al giudice ordinario; - o a seguito di preventiva richiesta rivolta dalla parte al giudice amministrativo perché stabilisca un termine per promuoverla. In entrambi i casi il giudice amministrativo sospende il processo in attesa che si pronunci il giudice ordinario. Ciò parrebbe imporre al giudice la sospensione, condizionandola alla sola prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso (che deve essere depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, potendo in difetto il presidente fissare l'udienza di discussione). Emerge tuttavia la sussistenza di un rilevante ambito valutativo riservato al giudice amministrativo, concernente la verifica che la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità. Ove tale verifica dia esito positivo il collegio pronuncia sulla controversia. Sembra perciò attuale la tesi secondo cui la sospensione non costituisca un vero e proprio automatismo: al giudice amministrativo è ancora consentito valutare la rilevanza del documento ai fini del decidere, anche se qualche dubbio attiene al suo potere di valutare la parvenza di fondatezza della denuncia di falsità. Al termine del giudizio di falso, la parte interessata a far valere la falsità del documento deve depositare la sentenza presso la segreteria del giudice. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna delle parti deposita la copia della sentenza nel termine di 90 giorni. Fintanto che permanga la causa di sospensione, quale essa sia, trova applicazione l'art. 298 del codice di rito, secondo cui non possono essere compiuti atti del procedimento (c. 1) e rimangono interrotti i termini in corso (c. 2). Quando sia cessata la causa di sospensione, quale essa sia, il giudizio amministrativo sospeso può essere riassunto mediante semplice presentazione della domanda di fissazione di udienza, senza che si possano applicare analogicamente né le norme per specifiche ipotesi in cui occorre l’atto di riassunzione, né l’art. 297 c.p.c. inerente alla riassunzione a seguito di sospensione per pregiudizialità nell’ambito del processo civile. Questa soluzione, è oggi convalidata dall’art. 80, c. 1, del Codice, che così dispone: “In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione”. 2. L'interruzione L'interruzione del processo consiste in una “situazione di stasi del processo a seguito di eventi involontari menomativi o esclusivi della capacità di stare in giudizio della parte, del suo rappresentante legale o del suo procuratore". Finalità dell'istituto è assicurare il pieno dispiegarsi del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti al cospetto di eventi che potrebbero pregiudicare l’uno o l’altro di tali indefettibili fattori della dinamica processuale. Il Codice assoggetta l’istituto dell'interruzione alle disposizioni del c.p.c. In base all'art. 299 (“Morte o perdita della capacità prima della costituzione”) “Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’art. 163 bis”. Poiché la detta disposizione opera nel processo amministrativo solo “in quanto compatibili o espressione di principi generali", non si deve tenere conto del riferimento normativo al giudice istruttore, né del richiamo ai termini dilatori di cui all’art. 163 bis, valevoli per il solo atto di citazione e non per il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo. L’art. 300 c.p.c. (‘Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace’), prescrive che quando “alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente”. Essa regola inoltre il dies a quo dell’interruzione: se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto dal momento dell’evento (alla morte della persona fisica è assimilata la morte presunta o la scomparsa di questa, ovvero l’estinzione della persona giuridica); - se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292 c.p.c.; - se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione. Dopo alcune perplessità interpretative, si è optato per l’estensione di queste previsioni anche al soggetto dichiarato fallito dopo la sua costituzione in giudizio. Si osserva che “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo". La disposizione sembra introdurre un automatismo, nel senso che l’effetto interruttivo coincide con l’apertura del fallimento a prescindere dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione della dichiarazione di fallimento ad opera del procuratore della parte fallita. Sintetizzando i tratti fondamentali della disciplina relativa alla posizione della parte, può affermarsi che: a) se la parte è costituita in giudizio, la dichiarazione relativa all'evento interruttivo deve provenire dal suo procuratore con formale dichiarazione in udienza o con atto notificato alle altre parti; dal momento in cui tali incombenti sono adempiuti inizia a decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione del processo. b) se la parte non è (ancora) costituita, l’evento provoca ipso iure l’interruzione, salva successiva presa di conoscenza (con atto meramente ricognitivo) da parte del giudice amministrativo. Quanto all’ipotesi sub a), va precisato che la regola enunciata non vale per l’interveniente il quale, non rivestendo la qualità di parte necessaria, non è titolato a chiedere l’interruzione del processo, di cui non ha la disponibilità. Fa eccezione l’automatismo legato al fallimento: il termine semestrale inizia a decorrere, per il ricorrente, dalla dichiarazione di fallimento. L’interruzione non ha luogo laddove la dichiarazione in pubblica udienza venga fatta da parte del soggetto nel cui interesse la norma non è posta. Quanto all’ipotesi sub b), la soluzione riferita, dominante in giurisprudenza, trova discorde la dottrina, temendosi da alcuni l’effetto distorsivo o paralizzante che potrebbe derivare dall'elevato numero di controinteressati che caratterizza alcuni processi innanzi al giudice amministrativo. Il problema potrebbe superarsi assumendo l’irrilevanza degli eventi interruttivi che colpiscano la parte non costituita una volta decorso il termine fissato in 60 giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso. Con riferimento alla parte pubblica non è infrequente che si verifichi una successione tra enti o un trasferimento di competenza da un’amministrazione ad un’altra, in qualche misura assimilabili alla morte della persona fisica. Nel processo amministrativo opera, altresì, l’art. 301 c.p.c. (“Morte o impedimento del procuratore”), riguardante alcuni accadimenti che si ripercuotono negativamente sulla posizione della parte pur non riguardandola personalmente: laddove, in pendenza di giudizio, sopravvenga la morte, radiazione o sospensione del patrocinatore, il processo è interrotto dal giorno dell’evento. La ratio della previsione è quella di impedire che la parte patisca pregiudizio per il venir meno del soggetto. Conseguentemente, non si ha interruzione laddove il decesso colpisca uno dei difensori munito di mandato disgiunto: la disposizione tutela l’esigenza di carattere pubblico di non privare la parte del ministero del difensore, obbligatorio per legge, mentre l’interesse della parte a fruire di due rappresentanti tecnici è essenzialmente privato e non incide sulle vicende processuali. Gli atti compiuti successivamente agli eventi indicati sono affetti da nullità. La parte interessata, verso la quale detti atti non spiegano alcuna efficacia, può eccepire lo stato viziante nella prima udienza o difesa successiva all’atto o notizia dell’evento interruttivo. Lo stesso art. 301 c.p.c. precisa ulteriormente che non costituiscono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa, nel caso che si tratti di eventi volontari e comunque conosciuti dalla parte, alla quale si fa onere di attivarsi perché sia posto rimedio (mediante ripristino della difesa tecnica) senza intralcio per il normale corso del giudizio, in modo da prevenire condotte artate e strumentali ad una indebita dilazione dei tempi processuali. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. All’eventuale omissione di tale parte più supplire la “parte più diligente” mediante la riassunzione, ossia notificando apposito atto a tutte le altre parti nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. Sembra compatibile con il nuovo regime codicistico il risalente orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo il quale, pur difettando l'atto di riassunzione, il giudizio interrotto a causa della morte di un difensore non si estinguerebbe qualora la parte colpita dall’evento lo prosegua tempestivamente mediante il deposito della procura al nuovo difensore prima dell’udienza di discussione già fissata in precedenza. Difatti ove l’udienza di discussione del ricorso sia stata già fissata, non avrebbe scopo il deposito dell’istanza prescritta dall’art. 80 del Codice. In caso contrario, l'istanza è senz’altro ritenuta necessaria in aggiunta alla costituzione del nuovo patrocinatore. L’estinzione del giudizio per mancata riassunzione può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Sezione seconda: Estinzione del processo - 1. Le cause di estinzione: premessa Il processo amministrativo si conclude, di regola, con la sentenza che definisce la controversia nel merito, o per ragioni attinenti al rito. Può però accadere che il processo venga ad estinzione, prima della sua naturale conclusione, per il verificarsi di alcune circostanze preclusive alla prosecuzione del rapporto processuale. Il riferimento è a tutti quei casi nei quali venga meno l’impulso processuale di parte o la stessa volontà della parte di proseguire nel giudizio instaurato. A questi casi, tradizionalmente, si aggiungono anche quelli che, indipendentemente dalla volontà o dall’impulso di parte, rendono non utile la prosecuzione del giudizio. Ci si riferisce a quei casi in cui il sopravvenire di circostanze di fatto o di nuovi atti dell’Amministrazione possono rendere ingiustificata la prosecuzione del giudizio. In tutte queste circostanze, l’ordinamento prevede l’estinzione del rapporto processuale in quanto non più necessario. L’estinzione opera di diritto o ad istanza di parte (a seconda dei casi), ma richiede sempre una pronuncia del giudice amministrativo che ne dia atto. 2. La rinuncia al ricorso La rinuncia agli atti del giudizio, che deve distinguersi dalla rinuncia all’esercizio del potere di azione, è disciplinata dall’art. 84 del Codice, secondo cui, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria; la norma, consente anche di effettuare la rinuncia mediante dichiarazione resa in udienza dall’avvocato (senza mandato speciale) e documentata nel relativo verbale. La rinuncia è quindi un atto di parte e, più precisamente, è un actus legitimus e non può essere sottoposto a condizione, termine o modo. Esso è anche un atto unilaterale recettizio e, quindi, se avviene mediante dichiarazione sottoscritta, deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza (formalità non necessaria ove essa venga dichiarata oralmente in udienza alla presenza delle altre parti del giudizio). Il Codice prevede che il processo si estingue solo se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano. Pur se il Codice tace, deve ritenersi che, anche a seguito di rinuncia ritualmente notificata, depositata e non opposta dalle altre parti, il giudizio non si estingua automaticamente, ma solo dopo la presa d’atto da parte del giudice, tanto è che questi, in caso di rinuncia, deve dichiarare estinto il giudizio. Lo stesso giudice, anche a prescindere da una rinuncia effettuata con queste formalità, può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La rinuncia può essere dichiarata anche per un ricorso in appello. In questo caso, con la sentenza che ne dà atto si produce l’effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio ritenga di compensarle. 3. La perenzione (o abbandono) del ricorso La perenzione (o abbandono) del ricorso opera l’estinzione del processo per inattività delle parti o, per meglio dire, per mancanza del necessario impulso processuale di parte. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine della perenzione non decorre dalla presentazione della istanza di fissazione dell’udienza e finché non si sia provveduto su di essa (ma salva la disciplina della perenzione dei ricorsi ultraquinquennali). Da ciò consegue che una volta proposta tempestivamente istanza di fissazione nel termine di un anno dal deposito del ricorso la parte non ha l'onere processuale della riproposizione dell’istanza (o del compimento di altro atto di procedura) entro l’anno successivo. L’onere, in capo alla parte interessata, del compimento di atti processuali per evitare la perenzione trova quindi applicazione solo nei casi in cui la istanza di fissazione di udienza abbia esaurito i suoi effetti e non sussista alcun ulteriore onere processuale in capo al giudice. Si pensi al caso della cancellazione della causa dal ruolo. In questi casi il termine annuale per la presentazione della nuova istanza di fissazione di udienza decorre dalla data in cui sono state comunicate alla parte, per l’appunto, la cancellazione della causa dal ruolo. L’estinzione del processo opera di diritto e può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio perento. Una disciplina particolare della perenzione opera per i ricorsi ultraquinquennali. Qui è previsto che, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione di udienza entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In mancanza, il ricorso è dichiarato perento. Inoltre, viene specificato che il ricorso è parimenti dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto se, in assenza dell’avviso, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito ed il ricorrente non dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione. Questo istituto, costituisce un meccanismo per verificare se, a distanza di anni dal ricorso, permanga un interesse alla prosecuzione del giudizio da parte del ricorrente o se la parte non intenda più coltivare tale iniziativa giurisdizionale e l’abbia ormai abbandonata. Per questa ragione il legislatore ha richiesto che l’istanza di fissazione di udienza in questo caso fosse atto di parte e non solo del difensore. 4. La mancata riassunzione o prosecuzione dei processo Ulteriore causa di anticipata estinzione del rapporto processuale è quella della mancata riassunzione del giudizio a seguito di un evento interruttivo del giudizio o della mancata prosecuzione a seguito di una sua sospensione necessaria. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. Se non avviene una tale prosecuzione, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. Per quanto riguarda la sospensione del processo, si dispone che, nei casi di sospensione necessaria del processo, se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa; mentre nei casi di sospensione facoltativa del processo l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. Il giudice dichiara estinto il giudizio se, in questi casi -ed in ogni altro caso previsto dal Codice- non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice. 5. La cessazione della materia dei contendere Il rapporto processuale si estingue poi quando sopravvengano circostanze di fatto nuove che rendano non più necessaria la prosecuzione del giudizio. Si pensi ai casi di cessazione della materia del contendere che si verifica quando l’amministrazione, in pendenza di giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento contro cui è stato proposto ricorso. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere si ha anche se il ritiro del provvedimento impugnato (o annullamento) è stato disposto da Amministrazione o autorità diversa da quella che lo aveva emanato, o a seguito di pronuncia giurisdizionale di altro giudice. Il ritiro deve soddisfare la pretesa avanzata in giudizio dal ricorrente e deve essere completamente satisfattivo della sua domanda di tutela. Per questa ragione, non può comportare cessazione della materia del contendere l'atto di revoca del provvedimento impugnato con effetti ex nunc, in quanto esso lascia impregiudicati gli effetti lesivi medio tempore prodottisi e di cui il ricorrente si duole. Allo stesso modo non determina la cessazione della materia del contendere l'annullamento parziale dell'atto impugnato, o un atto di ritiro che sostituisca il provvedimento impugnato con atto sostanzialmente confermativo di quello ritirato. Per le stesse ragioni, allorché il ricorso sia avverso il silenzio dell’Amministrazione (silenzio-rifiuto o silenzioinadempimento), il provvedimento sopravvenuto di rigetto della istanza che il ricorrente aveva in un primo tempo avanzato all’Amministrazione (senza ottenerne risposta) non determina la cessazione della materia del contendere, perché non ha contenuto satisfattivo; giustificando semmai la proposizione dei motivi aggiunti al ricorso originario, con i quali si contestino gli ulteriori profili di illegittimità che colpiscono il provvedimento positivo sopravvenuto. Nel caso di ricorso avente ad oggetto pretese patrimoniali anche di tipo risarcitorio, la cessazione della materia del contendere si verifica con la corresponsione di tutte le somme richieste, comprensive degli interessi e rivalutazione monetaria. Al riguardo, anzi, si precisa che quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori. 6. La carenza sopravvenuta di interesse La sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere si determina quando si realizza una situazione di fatto incompatibile con la permanenza dell’interesse al ricorso. In dottrina, tuttavia, molti dubitano della utilità sul piano teorico della distinzione di questa figura da quella della cessazione della materia del contendere. Tale distinzione è rimasta ferma anche nel nuovo impianto del Codice, il quale dispone che il giudice, anche a prescindere da una rinuncia di parte, può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Il giudice dichiara, anche di ufficio, improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. 7. Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità L'estinzione e l’improcedibilità possono essere pronunciate con decreto, depositato in segreteria che ne dà comunicazione alle parti, emesso dal presidente o da un magistrato da lui delegato. Ciascuna parte può proporre opposizione a tale decreto innanzi al collegio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, mediante atto notificato a tutte le parti. Il relativo giudizio si svolge in camera di consiglio ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, fissa l’udienza di merito; mentre in caso di rigetto le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, senza possibilità di compensazione. Questa ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Contro di essa può essere proposto appello, e l’udienza di discussione è fissata d’ufficio con priorità. L’estinzione e la improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano o vengono accertate all’udienza di discussione. Capitolo 5: I riti compatti Sezione prima: Il rito immediato 1. La decisione semplificata L’art. 74 del Codice disciplina forme, modalità, tempi e presupposti di assunzione della “decisione in forma semplificata”. La norma prevede che, “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”. Tale disposizione è ispirata all’obbiettivo di velocizzare la definizione di processi il cui esito appaia evidente. Quest’obbiettivo si risolve nella semplificazione di un elemento formale della sentenza, ossia della motivazione. L’art. 74 delimita il contenuto della motivazione della sentenza in forma semplificata; non può in nessun caso essere apodittica o inadeguata: la conformazione degli interessi stabilita dal contenuto precettivo della sentenza, cioè, deve essere adeguatamente giustificata sulla base di un discorso non solo manifesto, ma anche esaustivo e comprensibile, rimanendo altrimenti frustrata l’esigenza di tutela dell’interesse sostanziale della parte ricorrente vittoriosa, realizzabile solo attraverso una rigorosa determinazione, nella motivazione della sentenza, degli elementi e delle qualificazioni che hanno formato oggetto dell’accertamento giudiziale. Questo principio è particolarmente importante ai fini di una interpretazione della norma secondo Costituzione. I casi in cui un ricorso appaia “manifestamente” irricevibile, inammissibile, improcedibile, fondato o infondato sono, in realtà, assai pochi. Così, la stessa tardività della notificazione potrà qualificarsi come manifesta solo ove sia in atti la prova evidente che il termine di decadenza sia inutilmente decorso, sì che al giudice dovrà ritenersi preclusa la decisione in forma semplificata ove possa anche solo affacciarsi una contestazione sul momento in cui il ricorrente abbia avuto piena ed effettiva conoscenza dell’atto impugnato, che, ai fini della verifica sulla ricevibilità del ricorso, implica anche la piena conoscenza dell’esatto contenuto di detto atto. Ancora, la manifesta inammissibilità del ricorso potrà essere ravvisata nelle rare ipotesi in cui esso non sia stato notificato alla amministrazione resistente o ad almeno uno degli eventuali controinteressati; diverso è il caso in cui possano affacciarsi dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, sulla legittimazione attiva, sulla esistenza (o immanenza) dell’interesse a ricorrere, questioni sulle quali sarà quasi sempre doveroso garantire un adeguato confronto delle tesi difensive delle parti ed un discorso motivante tutt’altro che succinto. Codeste cautele il giudice deve adottare soprattutto in sede di decisione del merito della controversia. Quanto alla “manifesta fondatezza” del ricorso, è necessario che la motivazione dia adeguatamente conto, ancorché sinteticamente, della ragione, di fatto o di diritto, idonea a “risolvere” effettivamente la controversia, non già semplicemente a provocare l’annullamento dell’atto impugnato, vicenda, questa, che non necessariamente compone il dissenso che vede le parti contrapposte sul piano sostanziale. Cautele ancor maggiori devono essere impiegate allorché la sentenza succintamente motivata definisca il giudizio con pronuncia di rigetto. In questo caso, infatti, il riferimento “al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” non esime in alcun caso il giudice dall’esame analitico di tutti i motivi di ricorso, onde garantire la rigorosa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e, ovviamente, dal rendere una motivazione non apodittica ed adeguata ad esternare la giustificazione del decisum. Il giudice amministrativo può infatti decidere il giudizio con sentenza in forma semplificata ogniqualvolta il ricorso appaia manifestamente infondato, e l’avverbio “manifestamente” sta a significare che la condizione del ricorso debba risultare prima facie non debba cioè comportare l’esame di problematiche complesse, il che comporta che, in assenza di tali presupposti, la sentenza può essere impugnata per error in procedendo. Anche in questo caso, il riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo dev’essere esternato con precisione. L’art. 74 ammette anche che la sentenza possa essere motivata succintamente attraverso il riferimento “ad un precedente conforme”. Tale riferimento non presuppone tuttavia la preesistenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati; la conformità del precedente al decisum, infatti, costituisce elemento di completezza del discorso giustificativo proprio della motivazione: anche un orientamento giurisprudenziale minoritario o isolato può costituire un presupposto idoneo a giustificare la forma semplificata della decisione, a condizione, sempre, che il richiamo ad esso operato sia idoneo ad esibire le ragioni alla stregua delle quali il ricorso sia apparso al giudice “manifestamente” idoneo ad essere deciso secondo l’esito consacrato in sentenza. 2. Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare L’art. 60 del Codice prevede che, in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata. Codesta semplificazione coinvolge anche il rito poiché la decisione è assunta a seguito di concentrazione della fase cautelare con quella di merito, consentendo al giudice, in deroga al sistema accolto nel rito ordinario, di definire il giudizio direttamente in camera di consiglio, e non all’esito della celebrazione di un’udienza pubblica. La completezza del contraddittorio è essenziale poiché il processo, anche se definito con decisione in forma semplificata, non può non garantire l’esercizio del diritto di difesa di tutte le parti necessarie. Il principio della garanzia del contraddittorio postula solo il controllo della ritualità della notifica del ricorso ed il rispetto del termine concesso per la costituzione delle parti intimate per la discussione sull’istanza incidentale. Il giudice non è quindi onerato di una sorta di obbligo di salvataggio nei confronti delle parti che, ritualmente intimate, non abbiano perfezionato la costituzione in giudizio nel termine assegnato dalla legge o, pur avendolo fatto, non siano comparse alla camera di consiglio nel corso della quale possa maturare la scelta collegiale, discrezionale, di definire il merito della controversia con sentenza in forma semplificata. L’obbligo di osservanza del termine dilatorio di venti giorni dall’ultima notificazione è coerente con la previsione di cui all’art. 55, c. 5, del Codice, che impone al collegio di pronunciare sulla domanda cautelare nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione: è quindi di un termine dilatorio minimo. Il giudice non può peraltro definire il giudizio con sentenza in forma semplificata qualora una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione; in questi casi il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Tale previsione codifica l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale, secondo cui la facoltà del giudice di definire il processo alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare non è subordinata ad una specifica e concorde richiesta delle parti o ad una separata fissazione della discussione del ricorso perché è la stessa legge a prevedere che, in quella camera di consiglio, il giudice stesso possa definire immediatamente il processo con sentenza, e questo non implica una limitazione del diritto delle parti di chiedere ed ottenere un provvedimento interinale e cautelare. La Corte aveva precisato che l’unico limite stabilito a presidio del diritto di difesa consisteva nel divieto di definizione immediata del giudizio prima della compiuta decorrenza dei termini previsti per la costituzione in giudizio delle parti resistente e controinteressate, per la proposizione del ricorso incidentale, del regolamento di competenza e degli eventuali motivi aggiunti. La Corte costituzionale aveva peraltro precisato essere onere delle parti esternare nella stessa camera di consiglio il loro intento in proposito, avanzando apposita e motivata istanza di rinvio, non vincolante per il giudice, che poteva disattenderla solo in caso di irrilevanza od inammissibilità dell’attività difensiva invocata dalla parte. Il Codice, viceversa, non lascia alternativa al giudice: accertata la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di difesa, esso deve disporre l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissare contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. Sezione seconda: Il rito abbreviato 1. La riduzione alla metà dei termini processuali Viene prevista la riduzione dei termini processuali. L’art. 119, c. 2, del Codice così come l’abrogato art. 23-bis della legge Tar, stabilisce che tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati ad eccezione, nei soli giudizi di primo grado, di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti; non sono neppure dimezzati i termini per la proposizione dell’appello contro le ordinanze cautelari, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Non è più controverso quindi se l’esclusione dal regime della riduzione dei termini alla metà trovasse applicazione al solo ricorso principale di primo grado o, viceversa, anche al termine per proporre i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale; il Codice ha fatto proprio l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui l’abbreviazione dei termini costituisce essa stessa eccezione all’ordinaria durata dei termini processuali: pertanto, quella che appare come una “eccezione” al dimezzamento, prevista per il termine di proposizione del ricorso introduttivo, costituisce in realtà una delimitazione che il legislatore ha inteso tracciare del campo di operatività della deroga medesima, e quindi una riaffermazione delle regole generali. Sicché, la ratio alla base della scelta normativa di non estendere il dimezzamento al termine di notifica dell’atto introduttivo del giudizio riposa nell’esigenza di garantire il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito di difesa, che sarebbe risultato eccessivamente compresso per effetto dell’abbreviazione anche del termine de quo. Tale esigenza, riconosciuta anche per il ricorso incidentale, invero risulta sussistere anche nell’ipotesi in cui il ricorrente debba articolare nuove censure in corso di causa attraverso lo strumento dei motivi aggiunti. Dinanzi alla logica acceleratoria dell’art. 119, le eccezioni al dimezzamento dei termini vanno interpretate secondo canoni di rigida tassatività; deve ritenersi dimezzato, quindi, il termine per la proposizione dell’appello incidentale. L’art. 119, diversamente da quanto disponeva l’art. 23-bis della legge Tar, stabilisce che la deroga al dimezzamento di termini riguarda solo il termine per la notificazione del ricorso, sicché deve ritenersi dimezzato il termine per il deposito del gravame. 2. Ragioni di una disciplina acceleratoria L’art. 119 ha introdotto per alcune controversie tipicamente individuate un regime ispirato a particolare concentrazione tra la fase cautelare e quella di merito. La dottrina ha ritenuto che la ratio degli istituti acceleratori previsti da codesta norma risiede o nell’esigenza di evitare che l’azione amministrativa, in taluni settori, rimanga sub indice eccessivamente a lungo, o che la durata dei processi possa recare pregiudizio agli interessi pubblici perseguiti dai provvedimenti impugnati. Questa lettura della dottrina va intesa nel senso che esistono settori particolarmente “sensibili” dell’ordinamento giuridico che giustificano deroghe al rito processuale c.d. ordinario, sicché, in tali casi, non potrebbe ipotizzarsi la violazione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché la peculiarità del settore considerato dalla legge consentirebbe la fissazione di una disciplina specifica. Se questo è in astratto vero, va peraltro escluso che la deroga possa giustificarsi in considerazione della natura pubblica degli interessi coinvolti in tali giudizi poiché, in materia processuale, la legge non può differenziare il regime della tutela in considerazione dell’interesse particolare di una sola delle parti. L’art. 119 riproduce in parte la disciplina del previgente art. 23-ter legge n. 1034/1971; quanto all’ambito oggettivo, la norma si applica a processi impugnatori poiché l’elencazione contenuta al c. 1 menziona sempre “procedure” e “provvedimenti”, assunti nei vari settori individuati dalla norma. Non si tratta, quindi, di un’individuazione per materia, il che consente di sgombrare il campo dal dubbio se l’art. 119 sia una norma idonea ad influenzare il riparto della giurisdizione, sotto il profilo della introduzione di nuovi casi di giurisdizione esclusiva. Si è discusso, nel corso dei lavori preparatori del Codice, in ordine alla possibilità di ridurre il numero di materie cui il rito abbreviato si applica, ma si è preferito mantenere sostanzialmente invariato l’ambito oggettivo di tale rito. È stato attratto all’ambito oggettivo di tale rito il contenzioso contro i provvedimenti di applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti di collaboratori e testimoni di giustizia, per il quale le norme vigenti già prevedevano uno speciale rito abbreviato in tutto assimilabile a quello in esame. E stato chiarito che il rito speciale, quanto ai provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti, riguarda i provvedimenti tipici ed esterni di tali Autorità, che ne esprimono le funzioni, e non anche i provvedimenti “interni” inerenti al rapporto di servizio con i propri dipendenti. 3. Ambito oggettivo di applicazione del rito abbreviato a) Secondo la lett. a) dell’art. 119, c. 1, soggetti al rito differenziato sono i giudizi sui provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelli, di cui al successivo art. 120, c. 1 (cui si applica il c.d. rito accelerato), aventi ad oggetto gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. b) La lett. b) dell’art. 119 menziona i “provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti”. Secondo l’esperienza maturata nel vigore dell’abrogato art. 23-bis, legge Tar, si deve ritenere che la previsione di assoggettare i provvedimenti delle amministrazioni indipendenti al regime processuale differenziato intenda privilegiare gli obbiettivi di concentrazione e rapidità di definizione di processi che hanno ad oggetto funzioni di regolazione di settori dell’ordinamento e della vita sociale ed economica particolarmente rilevanti. La giurisprudenza aveva inoltre chiarito che la speciale disciplina processuale stabilita dall’art. 23-bis, nella parte in cui ha riguardo alle controversie involgenti i provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti, va circoscritta alle sole vertenze nelle quali è in contestazione l’esercizio delle funzioni che incidono sui settori alla cui vigilanza o regolazione gli organismi in questione sono istituzionalmente preposti e sui delicati interessi negli stessi coinvolti, senza applicarsi, quindi, alle controversie concernenti la ordinaria gestione del personale, che altrimenti, finirebbe col fruire di un non ragionevole privilegio non accordato ad altre categorie di pubblici dipendenti. Ora è la stessa lett. b) ad escludere che dall’ambito della norma i giudizi sugli atti relativi al rapporto di servizio dei dipendenti delle autorità indipendenti. c) La lett. c) menziona “i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali”. Il legislatore utilizza alternativamente i sostantivi “dismissione” e “privatizzazione”, alludendo sia alle fattispecie di alienazione di beni (mobili o immobili) sia a quelle che, con gergo usuale, vengono appunto indicate come operazioni di privatizzazione: operazioni che, a loro volta, consistono in dismissioni o alienazioni di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici in società. Il rito differenziato si applica inoltre ai provvedimenti di costituzione, modificazione e soppressione (o estinzione) di soggetti gestori di servizi pubblici locali. c-bis) Al rito abbreviato sono soggetti anche i giudizi sui “provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”. La norma è stata introdotta dall’art. 3, c. 6, del d.l. n. 21/2012. La necessità e l’urgenza del provvedimento originano dalla decisione, adottata dalla Commissione UE nel 2011, di deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea a seguito dell’apertura, del 2009, di una procedura d’infrazione (n. 2009/2255) in ordine alla disciplina generale italiana dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell’ambito delle società privatizzate nel corso degli anni ’90 -quali Eni, Enel, Finmeccanica e Telecom Italia-, ritenuta dalla Commissione lesiva della libertà di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali. Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato una apposita Comunicazione con la quale ha affermato che l’esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su criteri obiettivi, stabili e resi pubblici e se è giustificato da motivi imperiosi di interesse generale. Gli indirizzi contenuti nella predetta Comunicazione hanno costituito la base per l’avvio da parte della Commissione della procedura di infrazione nei confronti delle disposizioni del d.l. n. 332/1994, recanti la disciplina generale dei poteri speciali. Procedure di infrazione in materia di golden share hanno riguardato anche il Portogallo, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Germania. d) La lett. d) estende il rito abbreviato ai “provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri”. Questa norma concerne nomine di provenienza esclusivamente politica, che riguardano una varietà ampia di enti, deputati alla cura di interessi di rilievo sociale ed economico. È difficile quindi ravvisare un trait d’union idoneo a comprendere le nomine al vertice di tale multiforme quantità di enti nell’ambito di una ratio comune, che non può essere quella di privilegiare l’accelerazione dei giudizi in materia di nomine politiche, poiché in tal caso l’illegittimità costituzionale della norma in esame per disparità di trattamento nei confronti di situazioni analoghe e, più in generale, nei confronti degli incarichi di c.d. alta amministrazione, sarebbe evidentissima. e) La lett. e) ha ad oggetto “i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi”. Per la nozione di “ente locale” non può che farsi riferimento al t.u. n. 267/2000 che definisce tali: comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, consorzi cui partecipano codesti enti. Nella nozione di ente locale non sono comprese le regioni, non solo perché non comprese nella definizione dell’art. 2 del t.u. sugli enti locali, ma anche perché la dottrina prevalente ha ritenuto codesti enti estranei al peculiare novero delle cc.dd. autonomie locali. La norma, con riferimento ai provvedimenti di scioglimento, deve ritenersi applicabile ai provvedimenti che comportano l’estinzione degli organi rappresentativi, non anche agli atti che importano la soppressione tout court dell’ente, dovendosi ricordare che gli enti locali tradizionali (comuni e province) non possono essere soppressi con provvedimento amministrativo. La lett. e) prevede l’applicazione del rito abbreviato, oltre che alle controversie sui provvedimenti di scioglimento, anche a quelle sui provvedimenti connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. Si discute in dottrina circa la corretta interpretazione da attribuire all’aggettivo “connessi”: se cioè la norma si riferisca ai soli atti connessi ai provvedimenti di scioglimento, e quindi ai provvedimenti relativi alla nomina del commissario prefettizio ed agli atti di costui relativi all’indizione delle nuove consultazioni elettorali, o si estenda a qualsiasi provvedimento inerente la formazione ed il funzionamento degli organi degli enti locali, come ad es. al procedimento elettorale per la nomina del sindaco o del presidente della provincia. Deve ritenersi preferibile un’interpretazione che privilegi l’evidente intento del legislatore di concentrare e definire in tempi solleciti controversie che incidono non solo sulla capacità di funzionamento dell’ente locale, ma anche sul principio democratico in applicazione del quale si è formata la volontà popolare degli elettori. Così, il rito differenziato trova applicazione in tutte le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cessazione dalle cariche rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia nonché delle giunte, a seguito di mozione di sfiducia, ovvero di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia. f) Il rito abbreviato, ai sensi della lett. f), si applica inoltre ai “provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e” ai “provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale”. Ne consegue che il rito differenziato non può trovare applicazione allorché le procedure, di occupazione ed ablatorie, non siano finalizzate ad acquisire la disponibilità di superfici sulle quali debbano realizzarsi le opere anzidette. Sono inoltre indubbiamente compresi nella previsione normativa i provvedimenti amministrativi “sostanzialmente” ablatori, ossia impositivi di vincoli e misure limitative della sfera di godimento del diritto di proprietà, sempre ove finalizzati a consentire la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. g) Il rito abbreviato trova applicazione anche ai giudizi avverso “i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive”. La norma si raccorda alla previsione di cui all’abrogato art. 3 del d.l. n. 220/2003, che prevedeva l’applicazione del rito abbreviato ex art. 23-bis, legge Tar, alle controversie sugli atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo. h) Anche per le ordinanze emergenziali la lett. h) ha confermato l’applicabilità del rito abbreviato. i) Per le controversie relative al rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, la legge n. 124/2007 stabiliva espressamente l’applicabilità dell’abrogato art. 23-bis, legge Tar, previsione anch’essa riprodotta all’art. 119, lett. i). l) La lett. l) del c. 1 dell’art. 119 estende il rito abbreviato alle controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della p.a. in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al d.l. n. 7/2002, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti. Si tratta delle controversie relative al procedimento per il rilascio della autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza elevata, agli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché alle opere connesse ed alle infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi; il rito abbreviato si giustifica in ragione dell’esigenza di speditezza sottesa al dichiarato obiettivo di “evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale”. m) Il rito abbreviato trova applicazione, ai sensi della lett. m) del c. 1 del- l’art. 119, alle controversie sui “provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia”. Si tratta dei provvedimenti adottati dalla commissione centrale di cui all’art. 10 del d.l. n. 8/1991, già soggetti ad un regime processuale particolarmente celere. m-bis) Al rito abbreviato soggiacciono anche le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla legge n. 96/2010, compresi quelli sanzionatoti ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego. L’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale era stata concepita come un’autorità indipendente per la regolamentazione del settore postale, per adottare provvedimenti in materia di qualità e caratteristiche del servizio universale nel settore postale, di tariffe dei servizi regolamentati e di tutela della concorrenza nei servizi liberalizzati. L’Agenzia, istituita dal d.lgs. n. 58/2011, è stata soppressa dopo soli alcuni mesi con il c.d. decreto “salva Italia” (d.l. n. 201/2011) e le relative competenze sono state trasferite all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: sicché, le controversie sui provvedimenti adottati da quest’ultima Autorità nel settore postale ricadono comunque nella disciplina del rito abbreviato in forza della previsione generale sub lett. b). m-ter) Soggetti al rito abbreviato erano anche i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dal d.l. n. 70/2011. Anche questa Agenzia è stata soppressa dal d.l. n. 201/2011 e le relative attribuzioni sono state trasferite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta eccezione per quelle attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, affidate all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. m-quater) L’art. 1 del d.lgs. n. 195/2011 (c.d. “primo correttivo al codice”) ha, infine, assoggettato al rito abbreviato anche le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall’art. 36 ss. del d.lgs. n. 198/2006, allorché esse appartengano alla giurisdizione del giudice amministrativo. 4. Disciplina positiva del rito abbreviato Il rito disciplinato dall’art. 119 del Codice, non si discosta particolarmente dal modello introdotto abrogato art. 23-bis, legge Tar. Il c. 3 prevede che, salva l’applicazione dell’art. 60 (se cioè non sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare), il T.A.R. chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, ad un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. Se l’istanza cautelare viene rigettata, ed il Consiglio di Stato la riforma in appello, l’ordinanza del Consiglio di Stato è trasmessa esogeni al processo che potrebbero, in teoria, non condurre neppure all’annullamento (si pensi al sopravvenire di una causa di interruzione o di estinzione del processo). Ne consegue che detta ordinanza non può neppure ritenersi appellabile innanzi al Consiglio di Stato, in disparte ogni considerazione sulla possibilità pratica (e sulla opportunità) di ottenere una decisione d’appello nelle more della (già fissata) udienza di merito di prime cure; inoltre, nulla esclude che il risultato della delibazione sommaria che aveva condotto alla adozione della ordinanza di fissazione del merito “a breve” non possa essere sovvertito in sede di più approfondita valutazione del merito, anche alla luce delle difese medio tempore prodotte dalle parti ed acquisite dal collegio. Questa, quindi, è la differenza decisiva tra rito ordinario e rito abbreviato: nell’ambito del primo il giudice deve decidere sull’istanza cautelare (a meno che non ricorrano i presupposti per emettere la decisione di merito succintamente motivata), e, all’esito, il ricorso inizierà il suo normale periodo di giacenza (con l’unica differenza che, in caso di accoglimento della domanda interinale, il giudizio beneficerà della priorità nella fissazione del merito), mentre, con il rito differenziato, di regola, non vi sarà decisione cautelare, ma, in caso di positivo accertamento dei presupposti di fumus e di periculum, il collegio fisserà direttamente l’udienza di discussione (sempre che non si ravvisino, anche in questo caso, i presupposti per l’emissione di una sentenza succintamente motivata). La decisione sull’istanza cautelare, nei processi soggetti alla disciplina acceleratoria, è, quindi, solo eventuale, ed è subordinata alla ricorrenza di casi di “estrema gravità ed urgenza”, cioè di situazioni -da valutare caso per caso- in cui anche il decorso dello spatium di cui al c. 3 sia idoneo a privare irreversibilmente il ricorrente del vantaggio sperato dalla emananda sentenza. Appellabili sono, quindi, le ordinanze di rigetto dell’istanza cautelare, ossia le decisioni che hanno ravvisato la non ricorrenza dei presupposti per la fissazione dell’udienza di merito “a breve”, e le ordinanze che hanno accolto o negato la invocata cautela ai sensi del c. 4, e che hanno, quindi, ritenuto sussistente o non (oltre al fumus boni iuris) il requisito della estrema gravità ed urgenza. Il c. 6 dell’art. 23-bis disponeva che, nei giudizi soggetti al rito abbreviato, il dispositivo della sentenza fosse pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza, mediante deposito in segreteria. Peraltro, la giurisprudenza aveva affermato che l’omessa pubblicazione del dispositivo della sentenza concretizzasse unicamente un comportamento omissivo, eventualmente rilevante sul piano disciplinare, avendo la relativa incombenza finalità meramente acceleratorie del giudizio. Di certo, l’omessa pubblicazione del dispositivo non costituiva causa di nullità della sentenza. Ora, il c. 5 dell’art. 119 prevede che il dispositivo è pubblicato, sempre nel termine di sette giorni dalla decisione della causa, “quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza”, dichiarazione da attestarsi nel verbale d’udienza. L’art. 119 consente l’appello immediato avverso il dispositivo con riserva dei motivi, al dichiarato scopo di “chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo”; tuttavia, la mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi, così ammettendosi implicitamente che codesto appello può anche non essere accompagnato dall’istanza di sospensione, proponibile, anche per la prima volta, nei confronti della sentenza corredata della motivazione. Infine, il c. 7 dell’art. 119 estende esplicitamente la disciplina del rito abbreviato anche ai rimedi impugnatori ulteriori rispetto all’appello, quali la revocazione e l’opposizione di terzo. Sezione terza: II rito accelerato 1. La disciplina processuale di cui al Codice dei contratti pubblici L’art. 120 del Codice detta una disciplina speciale per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché dei connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ossia per i giudizi di cui all’art. 119, c. 1, lett. a). L’art. 120 in parte riprende ed in parte modifica il contenuto dell’art. 245 del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 53/2010. La disciplina del rito accelerato in materia di affidamento di contratti è arricchita da altre disposizioni introdotte dal d.lgs. n, 53/2010 nel Codice dei contratti pubblici, ma non recepite nel Codice del processo amministrativo; tra queste l’art. 11, c. 10-ter del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui la proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, con contestuale domanda cautelare, impedisce la stipula del contratto a far data dalla notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni (c.d. termine di stand stili processuale), a condizione che entro tale termine intervenga il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successiva. Si tratta di un effetto che cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare. Quanto a tale ultima disposizione, non è agevole comprendere quale possa essere il caso in cui il giudice fissi l’udienza di merito senza provvedere sulla cautela. Potrebbe trattarsi dell’ordinanza di cui al c. 3 del rito abbreviato disciplinato dall’art. 119; tuttavia, il c. 8 dell’art. 120 prevede che il giudice si pronunci interinalmente sull’istanza cautelare anche se dispone istruttoria, se concede termini a difesa o se solleva d’ufficio o vengono proposti incidenti processuali, di guisa che sembrerebbe espressamente previsto l’obbligo del giudice di pronunciarsi comunque, alla prima udienza utile, sull’istanza cautelare. L’unica ipotesi in astratto immaginabile è quella in cui la disponibilità della decisione sull’istanza cautelare è rimessa in via esclusiva al ricorrente, il che accade allorché egli vi rinunci espressamente; ma anche in questo caso non è detto che il giudice adotti un’ordinanza di fissazione del merito. L’introduzione di questo periodo è stata suggerita dal parere del Consiglio di Stato 15, secondo cui l’ordinanza di fissazione del merito a breve senza concedere la cautela rappresenterebbe “un accoglimento parziale della domanda cautelare ai soli fini della fissazione del merito, con reiezione della richiesta di sospensione degli atti impugnati e ciò determina la cessazione dello stand-stili". Il rilievo non pare convincente. Al di là della contraddizione implicita insita nell’accostare ad un accoglimento parziale un effetto, altrettanto parziale, di reiezione, se il giudice decide, in tutta autonomia, di non adottare la misura cautelare fissando il merito a 30 giorni, con conseguente cessazione della sospensione del termine dilatorio per la stipula del contratto, ogni amministrazione poco incline a procrastinare la stipula del contratto, pur in presenza dell'implicito (o esplicito) riconoscimento della sussistenza del fumus boni iuris, potrebbe stipulare il contratto e, in alcuni casi (si pensi agli appalti di forniture), anche eseguirlo, con frustrazione del diritto del ricorrente, ipoteticamente vittorioso, al subentro nel rapporto negoziale, ormai non più soggetto a declaratoria di inefficacia, e quindi con grave menomazione del diritto ad ottenere la reintegrazione in forma specifica, che il giudice può assicurare solo ove il rapporto non si sia perfezionato e non abbia avuto un grado significativo di esecuzione. Un secondo profilo di attenzione va all’ultimo periodo del c. 10-ter, che sostanzialmente codifica una prassi invalsa nel foro, spesso fonte di gravi abusi a latere partis ed a latere iudicis: il c.d. rinvio della cautela al merito; occorre prenderne atto, limitandocisi ad osservare che la richiesta in tal senso -che deve essere condivisa da tutte le parti costituite e presenti in udienza- è equiparata ex lege alla rinuncia implicita “all’immediato esame della domanda cautelare”. 2. L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale L’art. 6 del d.lgs. n. 53/2010 ha aggiunto al d.lgs. n. 163/2006 l’art. 243-bis, secondo cui, nelle materie contemplate nell’art. 120 del Codice, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L’informazione deve consistere in una comunicazione scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L’interessato può avvalersi dell’assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l’interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L’informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara. L’informativa non sospende il procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione, deve comunicare le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. La norma stabilisce espressamente che l’inerzia equivale a diniego di autotutela. L’omissione della comunicazione di cui al c. 1 e l’inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, o il silenzio-rigetto maturato in esito ad inerzia, non è impugnabile autonomamente e può essere contestato congiuntamente all’atto cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest’ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni; sin qui la disciplina del d.lgs. n. 53/2010. L’art. 3, c. 19, lett. b) ha sostituito l’ultimo c. dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 163/2006, stabilendo che “il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti”. L’istituto è frutto di una scelta politica del legislatore italiano. L’art. 1 della direttiva 2007/66/CE lasciava alla discrezionalità degli Stati membri la facoltà di recepire l’istituto dell’informativa preventiva sulla intenzione di proporre ricorso; il legislatore italiano ha optato per la introduzione di esso nel nostro sistema. La legge di delega, n. 44/2009, stabilisce espressamente il recepimento de quo, stabilendo che il Governo preveda che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell’imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela. Secondo il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato l’istituto sarebbe un potenziale strumento di deflazione del contenzioso, pur aggiungendo che la brevità del termine per proporre il ricorso svuota di contenuto tale pur apprezzabile intento. Il Consiglio di Stato aveva inoltre suggerito di non prevedere che la comunicazione del preavviso di ricorso non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, e ciò perché “in tal modo, si genera l’equivoco che sia sempre precluso l’esercizio dei poteri cautelari in autotutela”. Seguendo il suggerimento del Consiglio di Stato, il decreto n. 53/2010 ha escluso che l’eventuale adozione di atti di autotutela avvenga senza contraddittorio. Tuttavia, è lo stesso art. 7 della legge n. 241/1990 ad escludere che la comunicazione di avvio del procedimento (nella specie di autotutela) vada effettuata ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. E la stessa norma delegata a contemplare una procedura assai breve, imponendo all’amministrazione di comunicare le proprie determinazioni entro quindici giorni dalla ricezione del c.d. preavviso di ricorso, sicché le esigenze di celerità sono in re ipsa. Inoltre, garantire la partecipazione delle altre imprese alla procedura -necessariamente sollecita- di secondo grado, implica che una determinazione dell’amministrazione debba intervenire tenendo conto delle osservazioni di questi altri soggetti: il che pare in contrasto con il divieto di aggravare il procedimento in assenza di particolari esigenze istruttorie, sancito dall’art. 1 della legge n. 241/1990, e con l’esigenza di assicurare una tutela celere all’interessato. Il Governo, viceversa, ha disatteso il parere del Consiglio di Stato ove suggeriva di qualificare la condotta inerte dell’amministrazione come silenziorigetto, non impugnabile: era questo il senso della previsione, suggerita dal Consiglio di Stato, secondo cui l’inerzia “non è autonomamente contestabile”. Al contrario, il decreto delegato ha previsto espressamente l’onere di impugnativa di codesta ennesima forma di silenzio significativo e l’avverbio “autonomamente” è stato interpretato nel senso di imporre l’impugnativa dell’atto silenzioso di non luogo a provvedere congiuntamente all’atto cui si riferisce, o con motivi aggiunti. Unico contrappeso a tale forma di legittimazione dell’inerzia è la previsione che di essa si deve tenere conto ai fini della condanna alle spese di lite o ai sensi dell’art. 1227 c.c. Da segnalare che l’art. 120 del Codice ha uniformato il termine per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti -e quindi anche di quelli concessi per l’impugnazione del silenzio sul preavviso di ricorso- stabilendo che, per l’uno e per gli altri, il ricorrente dispone di trenta giorni. Apprezzabile è la previsione di consentire all’interessato di non essere vincolato, in sede di proposizione di ricorso (pena, del resto, la violazione dell’art. 113 Cost.), ai motivi di cui al preavviso. 3. Il regime processuale L’attuale disciplina processuale del rito accelerato modifica in minima parte e semplifica la disciplina di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 53/2010, che ha in gran parte sostituito l’art. 245 del d.lgs. n. 163/2006. Quest’ultima disposizione, in virtù dell’art. 3, c. 19, lett. d) oggi recita: “la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo”. Il c. 1 conferma l’esclusione della proponibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato per tutti gli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi quelli relativi agli incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse, e dei correlati provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Rispetto all’art. 8 del d.lgs. n. 53/2010, il dies a quo per la proposizione del ricorso è quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione -nel caso in cui la gara sia stata esperita senza previa pubblicazione del bando- e non più lo stesso giorno della pubblicazione; il termine è di trenta giorni, a condizione che l’avviso sia corredato della motivazione circa la scelta della mancata pubblicità. In caso di omissione anche di tale avviso, il termine di decadenza è di sei mesi, decorrente dal giorno successivo a quello di stipula del contratto. È inoltre riprodotta la previsione per cui, ove la stazione appaltante fruisca del patrocinio -è da ritenere, anche facoltativo- dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso deve essere notificato -non prima della notificazione all’Avvocatura- anche presso la sede della medesima stazione appaltante, affinché si produca l’effetto automatico di sospensione del termine per la stipulazione del contratto. L’art. 120 non contiene più la previsione secondo cui la competenza territoriale del T.A.R. è inderogabile ed il relativo difetto è rilevato, anche d’ufficio, prima di ogni altra questione, con il correlato regime processuale di pronuncia del difetto di competenza territoriale e della impugnabilità della relativa ordinanza. Tale regola trova infatti compiuta disciplina agli artt. 13, 14, 15 e 16 del Codice, applicabili anche al rito accelerato in materia di affidamento di contratti pubblici. Il termine per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti è stato razionalmente unificato in quello di trenta giorni, decorrente dalla ricezione delle comunicazioni dell’aggiudicazione o, in ogni altro caso, dalla piena conoscenza dell’atto lesivo; non è stata riprodotta la previsione ai sensi della quale, in caso di domanda cautelare, le parti a cui fosse stato notificato il ricorso potevano presentare istanze e memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione. Ove la controversia non sia definita con sentenza in forma semplificata in occasione della trattazione dell’istanza cautelare, ed ove il collegio non abbia fissato l’udienza di merito “a breve” ai sensi dell’art. 119, c. 3, è previsto che l’udienza pubblica sia comunque fissata “con assoluta priorità”. Come previsto anche dal lgs. n. 53/2010, si impone l’impugnazione di “nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara” con motivi aggiunti. Diversamente da quanto previsto dall’art. 119, e così come stabiliva l’abrogato art. 23-bis, legge Tar, il processo deve sempre essere definito con pubblicazione del dispositivo, da emettersi, però, non entro sette giorni dalla data dell’udienza pubblica, ma da quello “della sua deliberazione”. Il dispositivo è impugnabile, ma al solo fine di chiederne la sospensione dell’esecutività prima della pubblicazione della sentenza. Il rito accelerato, infine, trova applicazione in tutti i giudizi di impugnazione, comprese la revocazione e l’opposizione di terzo. 4. L’inefficacia del contratto stipulato in esito all’annullamento dell’aggiudicazione Gli artt. 121 ss. del Codice hanno attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sulla sorte del contratto in esito all’annullamento dell’aggiudicazione. In coerenza con la scelta compiuta nella legge di delega n. 88/2009, la c.d. “privazione di effetti del contratto” è resa possibile in relazione ad ogni tipo di vizio dell’aggiudicazione, e non solo per i vizi più gravi, per i quali l’art. 2-quinquies, c. 1, della direttiva 2007/66/CE impone agli Stati membri in via obbligatoria di introdurre la privazione di effetti, seppur temperata da alcune deroghe. Gli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sono, pertanto, rimessi alla scelta del giudice ed i suoi presupposti variano in funzione della tipologia e della gravità del vizio dell’aggiudicazione. Al giudice amministrativo non è stata anche attribuita una giurisdizione di merito, benché la delega consentisse tale possibilità. La previsione di una ipotesi di giurisdizione di merito avrebbe presupposto che la legge autorizzasse il giudice amministrativo a “sostituirsi” all’amministrazione, effettuando in luogo di questa scelte discrezionali conformi a regole non giuridiche di buona amministrazione, che attengono ai profili di opportunità e di convenienza del provvedimento amministrativo, che può essere adottato dal giudice o da un suo ausiliare in sostituzione, appunto, dell’amministrazione. Tale carattere della giurisdizione indubbiamente mal si attaglia a controversie aventi ad oggetto aspetti, di natura civilistica, inerenti l’effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto già stipulato. La traduzione italiana della direttiva 2007/66/CE e la legge delega hanno utilizzato il termine “privazione di effetti”. Tuttavia, si osserva che non si è trattato di una scelta obbligata, sia perché le direttive comunitarie spesso volutamente usano termini generici idonei ad essere adattati ai singoli ordinamenti degli Stati membri, sia perché la traduzione in altre lingue della stessa direttiva 2077/66/CE non è esattamente coincidente con il termine “privazione di effetti”. I testi della direttiva tradotti in altre lingue fanno riferimento all’inefficacia. Si è preferito recepire la direttiva utilizzando termini e istituti che il nostro ordinamento ha già approfondito e sperimentato con riguardo alla questione della sorte del contratto all’esito dell’annullamento dell’aggiudicazione. Va ricordato che la tradizionale tesi dell’annullabilità del contratto in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione è stata superata da orientamenti tendenti ad una caducazione automatica del contratto, che hanno sviluppato in vario modo le tesi della nullità e soprattutto della inefficacia. Tale ultimo sviluppo giurisprudenziale appare maggiormente coerente con la ratio della direttiva comunitaria, che mira a colpire, soprattutto in caso di violazioni gravi, il contratto stipulato in base ad una aggiudicazione viziata. In particolare, l’inefficacia meglio si presta a correggere il difetto di una locuzione atecnica e generica, quale è la “privazione di effetti”, ed a comprendere le diverse possibilità di incidere sul contratto con effetti ex tune o ex nunc. La categoria dell’inefficacia non è disciplinata dal codice civile, che però se ne occupa con riferimento ad istituti di carattere sia generale, che particolare. Spetta al legislatore disciplinare i presupposti e le condizioni perché possa essere dichiarata l’inefficacia e, con riferimento alla materia qui in esame, la declaratoria di inefficacia presuppone l’accertamento del vizio dell’aggiudicazione e dell’assenza degli elementi, che sotto diversi profili -nei limiti di quanto previsto dalla direttiva- possono determinare che il contratto resti efficace. I casi contemplati dall’art. 121 del Codice, corrispondono alle violazioni considerate più gravi dal diritto comunitario: a) l’affidamento diretto di un appalto senza previa pubblicazione del bando; b) la violazione dei termini sospensivi per la stipula del contratto che abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto, ed abbia influito sulle opportunità del ricorrente di ottenere l’affidamento. In tali casi, la regola è l’inefficacia del contratto con decorrenza ex tune o ex nunc. La decorrenza di tale inefficacia è decisa dal giudice, sulla base di una valutazione di opportunità. L’eccezione a tale regola è contemplata dal c. 2 dell’art. 121: il contratto resta efficace, anche in presenza delle gravi violazioni, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, ecc. Dall’art. 121 del Codice, quindi, si desume, in primo luogo, che la declaratoria di inefficacia del contratto presuppone l’annullamento dell’aggiudicazione: si introduce, quindi, un rapporto di pregiudizialità necessaria. Il giudice amministrativo può rigettare la domanda di inefficacia del contratto, in presenza delle gravi violazioni ivi elencate, solo in presenza di esigenze imperative connesse ad un interesse generale, di cui peraltro la norma non dettaglia, se non genericamente, i contenuti: il che aumenta in misura considerevole la discrezionalità del giudice, che pertanto è onerato di motivare rigorosamente la decisione circa la sussistenza di circostanze tali da “rendere evidente” che le obbligazioni contrattuali possano essere rispettate solo dall’esecutore originariamente (ed illegittimamente) dichiarato aggiudicatario. Discrezionalità assai ampia è inoltre attribuita al giudice nella valutazione sulla decorrenza della privazione di effetti. Tra le “esigenze imperative” gli interessi economici non possono assumere, di regola, rilevanza: di essi il giudice può tenere conto solo allorché ravvisi che la declaratoria di inefficacia possa condurre a conseguenze sproporzionate, an che in considerazione dell’eventuale mancata proposizione della domanda del ricorrente di subentrare nell’esecuzione del contratto. La mancata proposizione della domanda non solo impedisce di conseguire una pronuncia del giudice che disponga detto subentro in favore del ricorrente, ma costituisce condotta rilevante, valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c., ai sensi del successivo art. 124, c. 2, del Codice. Nei casi di annullamento dell’aggiudicazione per violazioni non gravi, di cui all’art. 122 del Codice, la discrezionalità del giudice è ancor maggiore, e va esercitata tenendo conto “degli interessi delle parti”, il che potrebbe condurre a pronunce che escludano l’inefficacia del contratto ove la considerazione dell’interesse dell’amministrazione assuma il sopravvento, nella valutazione del giudice medesimo, sull’interesse del privato; occorre quindi condurre tale valutazione nel pieno rispetto dei principi del giusto processo e della parità delle parti; anche in questo caso si rende necessaria la domanda di subentro, domanda da esaminare alla stregua della rappresentazione giudiziale dello stato di esecuzione e della possibilità di subentro nel contratto. 5. Le sanzioni alternative alla dichiarazione di inefficacia del contratto L’art. 123 del Codice dispone che il giudice applica le sanzioni alternative in guisa da assicurare il contraddittorio. All’uopo, richiama l’art. 73, c. 3, secondo cui esso giudice, se ritiene di porre a fondamento della propria decisione una questione rilevata d’ufficio, la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie. Deve quindi ritenersi che il potere di applicazione delle sanzioni alternative sia del tutto officioso, prescindendo, quindi, da una domanda di parte in tal senso; conclusione coerente con il dettato della direttiva 2007/66/CE e con la previsione secondo cui le sanzioni non hanno natura risarcitoria -tant’è che l’eventuale condanna si cumula alle stesse- ma afflittiva. Le sanzioni alternative sono di due tipi: - di natura pecuniaria, di importo dallo 0,5 % al 5 % del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione; - di natura reale, consistente nella riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. Trattandosi di sanzioni amministrative, l’art. 123, c. 2, individua i criteri alla stregua dei quali graduare dette sanzioni: il giudice amministrativo deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e determinare la misura delle sanzioni in modo che esse siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante ed all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione (ravvedimento operoso). L’art. 123, c. 3, del Codice, prevede che il giudice applica le sanzioni di cui al c. 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto (c.d. stand stili sostanziale), ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva (c.d. stand stili processuale), quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento. La scelta è coerente con l’art. 2-sexies, c. 1, della direttiva 2007/66/CE, che disciplina la sola violazione del termine dilatorio, anche in assenza di altri vizi e del concreto effetto della violazione sulle possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto. L’art. 2-sexies, c. 1, della direttiva rimette in questi casi agli stati la scelta tra la possibile privazione di effetti o l’alternativa delle sanzioni per il solo fatto della violazione di uno dei termini dilatori, con la conseguente possibilità -poi attuata nel nostro ordinamento- di individuare quale unica conseguenza l’applicazione da parte del giudice delle sanzioni alternative. 6. Tutela in forma specifica e per equivalente Ai sensi dell’art. 124 del Codice, la tutela reintegratoria è subordinata a due esplicite domande di parte: quella volta a conseguire l’aggiudicazione e quella, ovviamente consequenziale, volta ad ottenere la stipula del contratto. Si tratta di una azione di condanna ad un facere specifico dell’amministrazione, la cui peculiarità si ravvisa nella circostanza che il giudice dispone del potere non solo di ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo (quale appunto l’aggiudicazione), ma anche di imporre alla stazione appaltante di stipulare il contratto, previa declaratoria di inefficacia del negozio già stipulato. La struttura delle domande che il ricorrente è onerato di proporre esclude che il contratto già stipulato, e del quale si chiede di dichiarare l’inefficacia, vada impugnato, alla stessa stregua di quanto accade per la tradizionale impugnazione del provvedimento conclusivo della procedura di gara. In caso di rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia, il risarcimento per equivalente è subordinato alla prova del danno subito; prova che, ovviamente, il ricorrente è tenuto a fornire anche al fine di conseguire la reintegrazione in forma specifica. L’omissione della domanda di risarcimento del danno, in una alla dichiarazione di disponibilità a subentrare nella titolarità del rapporto negoziale, costituiscono, in assenza di giustificato motivo, elementi di valutazione della condotta del ricorrente, al fine di valutare il concorso colposo del ricorrente nella causazione del danno. In realtà, non è alla mancata proposizione della domanda (principale o alternativa) di risarcimento per equivalente che dovrebbe farsi riferimento ma, più probabilmente, a quella di declaratoria di inefficacia del contratto: il che, però, appare irrazionale; se il ricorrente avente titolo all’aggiudicazione non intende ottenere l’inefficacia del contratto non ha senso che questi sia comunque onerato a proporre detta domanda, ove egli ambisca esclusivamente al ristoro in forma pecuniaria. Tale domanda, tuttavia, appare necessaria proprio perché il c. 1 dell’alt. 124 prevede che il giudice possa accordare il risarcimento per equivalente se ritiene di non dichiarare il contratto inefficace, il che induce a ritenere che la domanda diretta ad ottenere l’inefficacia del contratto vada proposta anche nell’ipotesi in cui il ricorrente non sia ab origine interessato a subentrare nel rapporto, ma intenda solo conseguire la tutela per equivalente. PARTE VI Capitolo l: Il giudicato l. Efficacia ed effetti delle sentenze Avuto riguardo alle questioni con esse decise, le sentenze si distinguono in sentenze: interlocutorie: provvedono solo sul processo ordinando per es. l’integrazione del contraddittorio o disponendo mezzi istruttori; non definitive: decidono nel merito, accogliendola o respingendola, una di più domande cumulate in un unico processo, che prosegue per la decisione sulle domande non decise, o decidono, respingendola, un’eccezione sollevata dalle parti resistenti idonea, ove fondata, a comportare la definizione della controversia in senso sfavorevole alla parte che l’ha instaurata; definitive: pongono fine alla controversia radicata innanzi al giudice che le pronuncia e definiscono, quindi, con riferimento al giudice da cui promanano, la lite, vuoi nel rito, vuoi nel merito. Avuto riguardo all’efficacia propria delle sentenze, si distingue comunemente in efficacia: endoprocessuale: è l’effetto o l’insieme di effetti che si esauriscono nell’ambito del processo nel quale una sentenza viene pronunciata; è propria delle sentenze di rito, che accertano una volontà di legge meramente processuale; extraprocessuale: è l’effetto o l’insieme di effetti che si producono al di fuori del processo, e specificamente nella realtà materiale; è propria delle sentenze di merito, che accertano una volontà di legge sostanziale, e che per tale ragione esplicano la loro efficacia sul terreno del diritto sostanziale. Quindi l’efficacia dipende dall’oggetto dell'accertamento trasfuso in sentenza. Le pronunce interlocutorie, in quanto provvedono solo sul processo, hanno efficacia endoprocessuale, risultando ontologicamente non idonee a produrre effetti al di fuori del processo nel quale sono state pronunciate. Le sentenze non definitive possono o no produrre effetti al di fuori del processo nel quale sono state pronunciate: ciò dipende dall'oggetto dell’accertamento in esse trasfuso, e quindi dalla loro natura di sentenze di merito oppure meramente di rito. Una sentenza non definitiva che decide nel merito una di più domande cumulate, o che decide parzialmente, sempre nel merito, la domanda, non si differenzia in nulla dalla sentenza che definisca nel merito il processo del quale quella domanda costituisca l’unico oggetto, ed è perciò senz’altro idonea alla cosa giudicata sostanziale. Ove venga in considerazione una sentenza non definitiva che decide, respingendola, un’eccezione della parte resistente, occorre aver riguardo alla natura dell’eccezione e così all’oggetto dell’accertamento giudiziale espresso dalla sentenza che la respinge: la sentenza non definitiva di rigetto di un’eccezione potrà produrre effetti extraprocessuali ove importi la risoluzione di questioni che attengono al diritto sostanziale, ove rechi cioè un accertamento della disciplina sostanziale concretamente applicabile al caso controverso; se invece a essere decisa è un'eccezione meramente processuale l’accertamento della sua infondatezza non produce che effetti endoprocessuali senza conformare la realtà materiale, in quanto si risolve nell'accertamento del mancato rispetto, da parte del ricorrente, della norma processuale che dispone, affinché il giudice possa decidere nel merito il ricorso, che il quest’ultimo sia proposto entro il termine di decadenza. Circa le sentenze definitive, è diffusa l’opinione che di un’efficacia extraprocessuale possa parlarsi solo per quelle di merito: ed è da condividere, ove ci si attenga al criterio discretivo tra le due rappresentato dall’oggetto dell’accertamento che esprimono. Una parte della dottrina individua anche l’efficacia panprocessuale, riconosciuta propria delle pronunce rese dalla Corte di cassazione sulle questioni di giurisdizione. Queste, hanno efficacia vincolante nei successivi processi nei quali sia riproposta la medesima domanda e sopravvivono all’estinzione del processo nel quale sono state pronunciate. L’efficacia panprocessuale è più limitata di quella extraprocessuale, perché si ritiene che le sentenze della Corte di cassazione, tanto sulla competenza quanto sulla giurisdizione, non spieghino effetti nella realtà materiale, per limitarsi all'accertamento di una volontà di legge processuale. L'efficacia extraprocessuale, quanto alle sentenze che definiscono il giudizio, su domande costitutive, viene ripartita: costitutivo: eliminazione dell’atto impugnato; ripristinatorio: collegato all'efficacia normalmente retroattiva dell’annullamento giurisdizionale, dal quale deriva l'obbligo dell'amministrazione soccombente di ripristinare, in favore del ricorrente vittorioso, la situazione di fatto e di diritto nella quale questo si trovava prima dell’emanazione dell’atto illegittimo; conformativo, collegato alla persistenza, in capo all’amministrazione soccombente, del potere (o del dovere) di nuovamente intervenire sulla fattispecie dopo la sentenza di annullamento di un suo atto, e che si risolve nell’obbligo, per l’amministrazione medesima, di tener conto, nella sua azione, dei limiti che con riguardo a questa siano recati, perché oggetto di accertamento giudiziale, dalla sentenza costitutiva, ovvero che da questa siano comunque ricavabili. L’effetto costitutivo è presente in tutte le sentenze di annullamento, quello ripristinatorio e quello conformativo sono solo eventuali, potendosi produrre solo se ricorrano le situazioni che li inducono. Sotto questo profilo, e con riguardo alle sentenze alle quali non si connette né un effetto ripristinatorio né un effetto conformativo, si parla, di sentenze auto-esecutive. 2. Giudicato formale e giudicato sostanziale Tradizionalmente si distinguono due giudicati: formale: riferito alle pronunce giudiziali nei confronti delle quali non sono più esperibili i mezzi di impugnazione ordinari, e secondo l’opinione più diffusa è delineato dall'art. 324 c.p.c. sostanziale: è riferito alle pronunce che producono effetti nella realtà materiale, conformandola, e, sempre secondo l’opinione più diffusa, è delineato dall’art. 2909 c.c. Il giudicato formale indica l’intangibilità che la pronuncia giudiziale acquista in conseguenza della decadenza della parte nei cui confronti è pronunciata dal potere di proporre l’impugnazione ordinaria idonea a modificarla: intangibilità significa che a qualsiasi giudice è precluso di disapplicare una precedente sentenza passata in cosa giudicata formale, anche se illegale. Il giudicato formale pertanto è preclusivo a ulteriori contestazioni che cadano sul medesimo oggetto, e si risolve nel concetto di irripetibilità della controversia. Suscettibili di giudicato formale sono, nel sistema processuale amministrativo, tanto le sentenze, quanto i decreti o le ordinanze che definiscono il giudizio dando atto della sua estinzione o improcedibilità, quanto le ordinanze con le quali il giudice adito decide sulla propria competenza o sulla domanda cautelare. Il giudicato sostanziale presuppone il giudicato formale, ma con esso non si confonde: se tutte le pronunce giudiziali sono suscettibili di giudicato formale, invece il giudicato sostanziale è riferibile solo alle sentenze, passate in cosa giudicata formale, che producono effetti sul terreno del diritto sostanziale. La forza della sentenza sul terreno sostanziale viene spiegata con il ricorso al concetto di lex specialis, che secondo taluno darebbe luogo, ai fini della conformazione della realtà materiale, al concorso di fattispecie, mentre secondo altri la sentenza non si aggiungerebbe, ma si sostituirebbe tout court alla norma giuridica astratta. Il concetto di giudicato sostanziale esprime comunque la forza della sentenza sul terreno sostanziale, tale da rendere incontrovertibile l’accertamento in essa contenuto. Anche la sentenza di merito non coperta da giudicato formale produce effetti sul terreno del diritto sostanziale, e li produce fin dal momento in cui acquista -con il deposito- esistenza giuridica, vincolando le parti soccombenti a darvi esecuzione; ma l’accertamento in essa trasfuso non è connotato da incontrovertibilità, ed è perciò dotato di una qualitas inferiore a quella riconosciuta propria della sentenza che sia passata in cosa giudicata formale. Il giudicato formale è indifferente al contenuto della decisione, mentre tale indifferenza va esclusa per il giudicato sostanziale, proprio perché l’idoneità della sentenza alla produzione di effetti nella realtà materiale dipende dal suo contenuto. Si spiega così l’esclusione della riferibilità del giudicato sostanziale alle sentenze di rito: esse non hanno contenuto idoneo alla conformazione della realtà sostanziale perché non esprimono un accertamento di una concreta volontà della legge sostanziale, ma si limitano alla rilevazione di cause impeditive di un accertamento siffatto. E il discrimen tra sentenze di merito e di rito viene tracciato sulla base della natura, sostanziale o processuale, della norma di legge di cui il giudice fa applicazione. Se, con riferimento alle sentenze del giudice amministrativo che si pronunciano -nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva- su diritti soggettivi, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui la dottrina processualcivilistica perviene relativamente al giudicato materiale e al suo oggetto, invece una parte della dottrina dubita della stessa riferibilità del concetto di giudicato sostanziale alle sentenze costitutive pronunciate dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità. Ciò perché questa dottrina ritiene che il giudicato sostanziale sia proprio solo delle sentenze che definiscono rapporti tra parti che siano, sul terreno sostanziale, in posizione paritetica, dettando la disciplina del rapporto tra esse intercorrente. L'idoneità al giudicato sostanziale delle sentenze costitutive pronunciate in sede di giurisdizione generale di legittimità viene posta in dubbio anche da chi ritiene che esse non esprimano affatto un accertamento, e non lo esprimano proprio perché aventi natura costitutiva. Questi dubbi non hanno ragion d’essere. Non il primo, perché non vi è alcun argomento che valga a suffragare tanto la tesi che il giudicato sostanziale sia riferibile solo alle sentenze che risolvono contestazioni tra parti in posizione paritetica sul piano sostanziale. Ma neanche il secondo, perché sin da quando è stata elaborata la categoria delle sentenze costitutive (della specie di eliminazione di atti giuridici), si è sempre riconosciuto che in esse è presente un accertamento che la parte richiede. Per lungo tempo -e sulla scia dell’insegnamento di Chiovenda- si è ritenuto che il giudicato materiale cada solo su detto accertamento e che la modificazione giuridica si produca per virtù di legge. Successivamente, però, si è rilevato che, a definire in questo modo la natura della sentenza costitutiva, ci si pone in contrasto con il dato normativo che emerge dall’art. 2908 c.c. -secondo il quale è direttamente la sentenza che produce l’effetto giuridico di eliminazione giuridica- e si finisce in definitiva per escludere che la modificazione giuridica sia prodotta dalla sentenza: per negare quindi ciò che nondimeno si riconosce essere il proprium della sentenza costitutiva. Da questa constatazione, e nello sforzo di superare la distonia rispetto al dato normativo vigente propria della ricostruzione chiovendiana, ha preso avvio un orientamento dottrinale che attribuisce rilievo esclusivo, nella sentenza costitutiva, (soltanto) all’eliminazione giuridica, mentre l’accertamento delle condizioni volute dalla legge perché detta eliminazione sia giudizialmente disposta viene relegato a oggetto di mera cognizione, e non di accertamento, da parte del giudice. Scaturisce da qui l’idea che la sentenza costitutiva -di eliminazione giuridica- sia povera, e secondo taluno priva del tutto, di un accertamento sul quale possa cadere la forza del giudicato materiale. Così ritenendo tuttavia si attribuisce all’accertamento un ruolo meramente servente alla produzione dell’effetto giuridico giudizialmente disposto. Appare invece conforme alle indicazioni normative in materia di produzione di effetti sostanziali in virtù di pronuncia giudiziale ritenere che nelle sentenze costitutive vi sia accertamento (e non mera cognizione) sulle condizioni volute dalla legge per la produzione di effetti giuridici, e che a tale accertamento si affianchi la produzione di detti effetti giuridici. E che il giudicato materiale cada su entrambi gli elementi. Un accertamento che cada soltanto sulle condizioni volute dalla legge per la produzione degli effetti giuridici che la parte ricorrente vuole viene però ritenuto, da più parti, insufficiente a garantire un’efficace protezione della situazione giuridica soggettiva della parte medesima, perché un accertamento così circoscritto non comporta necessariamente l’accertamento in via definitiva della fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente vittorioso; e perché il ricorrente vittorioso risulta esposto -nei casi in cui l’amministrazione conservi, dopo la sentenza, il potere sostanziale di nuovamente provvedere- a un nuovo esercizio del potere amministrativo in senso per sé pregiudizievole, con effetti idonei a vanificare la tutela giurisdizionale già conseguita. Di qui il tentativo di parte della dottrina di piegare l’azione costitutiva, e il giudicato sostanziale cui essa può condurre, alla ritenuta necessità che il giudizio sia idoneo a raggiungere un accertamento pieno della fondatezza della pretesa materiale del ricorrente, da un lato, e dall’altro lato a escludere che a tale accertamento possa sopravvivere il potere dell’amministrazione di nuovamente incidere sulla fattispecie materiale con un nuovo provvedimento. Il che viene compendiato nella formula che il giudizio di impugnazione deve risolvere la questione della spettanza del bene della vita preteso dalla parte vittoriosa. Il tentativo di piegare il processo di impugnazione è stato compiuto sia dalla dottrina processualcivilistica, sia da quella amministrativistica, e ha condotto a costruire l’azione costitutiva come volta alla produzione di un assetto sostanziale stabile e definitivo del rapporto tra le parti. Si tratta però di tentativo che non resiste ai rilievi critici. Innanzitutto occorre osservare che non è connotazione essenziale di una protezione giurisdizionale efficace ed effettiva di situazioni giuridiche soggettive strumentali (quali sono gli interessi legittimi) l’attribuzione, a chi ne sia titolare, dell’utilità materiale finale cui la situazione soggettiva strumentale si correla. In secondo luogo, e quand’anche sia ben possibile immaginare che il giudicato su azione costitutiva possa cadere sul rapporto così come delineato in virtù della sentenza (e potrebbe essere questo il caso delle c.d. impugnazioni negoziali) ciò deve essere escluso, per le azioni costitutive esperibili innanzi al giudice amministrativo, perché in senso contrario depongono le disposizioni dell’art. 34 del Codice. Queste invero sanciscono che il giudice, che ritenga fondato il ricorso di impugnazione, può, oltre che annullare in tutto o in parte il provvedimento impugnato (c. 1, lett. a), altresì condannare l’amministrazione all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo anche misure di risarcimento in forma specifica (c. 1, lett. c), e può disporre inoltre, le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato (c. 1, lett. e): ma ciò il giudice può fare da un lato esclusivamente nei limiti della domanda giudiziale, e quindi in tanto in quanto una domanda giudiziale in tal senso sia stata articolata, e dall’altro lato senza poter “pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (c. 2). Ciò significa che la decisione su una domanda costitutiva è di per sé insufficiente a conformare il rapporto sostanziale tra le parti, la cui definitiva conformazione è anzi preclusa in via generale al giudice laddove essa postuli l’esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati. Tale essendo il limite che la legge processuale impone al giudice pur a fronte di domande cumulate che siano fondate, è da escludere che la decisione di accoglimento di una domanda puramente costitutiva possa di per sé importare l’attribuzione, al ricorrente vittorioso, dell’utilità sostanziale finale cui aspiri. Gli ostacoli alla compiuta definizione in sede giudiziale della questione della spettanza al ricorrente vittorioso dell’utilità finale cui aspiri derivano dal modo in cui la legge processuale disciplina i limiti e l'operatività delle sentenze costitutive del giudice amministrativo, e così, in via derivativa, il rapporto tra esse e il potere dell’amministrazione. L’approdo cui aspira la dottrina che fa leva sul principio di efficacia e di effettività della protezione giurisdizionale è suscettibile di essere raggiunto non forzando la latitudine dell’oggetto dell’accertamento giudiziale su domanda costitutiva fondata, bensì, invece, in forza dell'impiego dello strumentario processuale che il Codice pone a disposizione del ricorrente: il risultato sarà così attingibile da un lato in forza della formulazione di domande giudiziali ulteriori rispetto a quella puramente costitutiva, e dall’altro lato in forza dell’assolvimento dell’onere della prova che l’art. 63 del Codice delinea a carico di ciascuna delle parti del processo. Fermo l’insuperabile vincolo, per le parti che aspirino alla definizione giudiziale del rapporto sostanziale in sede di giudizio (ordinario) di cognizione, all’articolazione di idonee domande giudiziali, è possibile prospettare che le parti abbiano l’onere di allegare e di provare tutto ciò che valga a sostenere la posizione per così dire finale rispettivamente prospettata o sostenuta, e specificamente l'assetto rispettivamente propugnato del rapporto. Si potrebbe ipotizzare che il mancato assolvimento degli oneri di allegazione e di prova determini preclusione ad allegazioni future, dopo il giudicato: che diverrebbe così stabile in senso compiuto in forza della preclusione ad allegazioni future. Il tentativo di dare stabilità in questo senso al giudicato su azione costitutiva è stato compiuto dalla dottrina con l’elaborazione della teorica degli oneri procedimentali dell’amministrazione: l’amministrazione sarebbe gravata, nel corso del procedimento, dell’onere di allegare e addurre tutti gli elementi, in fatto e in diritto, idonei a dare risposta alla questione della spettanza, in capo a colui che ne abbia l’aspirazione, di un determinato bene della vita, e sarebbe in forza dell'assolvimento di un siffatto onere da parte dell’amministrazione che sarebbe possibile un compiuto accertamento giudiziale di spettanza: si tratta però di oneri di allegazione procedimentale a carico dell’amministrazione che non trovano riscontro nella legge sostanziale. Secondo una parte della dottrina, sarebbero delineabili oneri di allegazione e di prova riferiti a tutti gli elementi, di fatto e di diritto, idonei alla risoluzione della questione della spettanza dell'utilità finale cui il ricorrente aspiri: ove tali oneri non fossero adempiuti dall’amministrazione resistente, scatterebbe la preclusione all’allegazione futura, dopo il giudicato. Di oneri in tal senso potrebbe desumersi la configurabilità sia sulla base della regola sull’onere della prova di cui all’art. 63, sia e soprattutto sulla base del principio di non contestazione (dei fatti) introdotto dall’art. 64 per il quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione (oltre che le prove proposte dalle parti) i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”. Dal principio di non contestazione così come introdotto dall’art. 64 si può trarre soltanto la conclusione che l’amministrazione -in veste di parte resistente- è gravata dall’onere di contestare i fatti che il ricorrente affermi, e che non può quindi confidare sull'istruttoria compiuta nel corso del procedimento e così sul terreno del diritto sostanziale, ma non se ne può trarre la conclusione che essa sia gravata da un onere di allegazione e di prova che si estenda a fatti che il ricorrente non abbia affermato, né che l’onere di contestazione si estenda a valutazioni giuridiche. Un onere di siffatta consistenza potrebbe forse essere estrapolabile dall'art. 21della legge n. 241/1990: si potrebbe forse individuare un onere a carico dell’amministrazione di dimostrare in giudizio che quello impugnato con la deduzione di vizi formali o procedimentali è un atto vincolato, ovvero che il rispetto della norma che impone la comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe potuto condurre a un risultato provvedimentale di segno diverso: anche a così interpretare dette disposizioni, l'onere ravvisabile a carico dell'amministrazione avrebbe portata circoscritta alle fattispecie cui esse hanno riguardo, e sarebbe in ogni caso funzionale a escludere il potere del giudice investito di domanda costitutiva di pronunciare l’annullamento dell’atto impugnato. Rimane comunque fermo e insuperabile il dato normativo -racchiuso nell’art. 34- secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”: è così escluso che il giudice possa, pur in sede di accoglimento delle domande ulteriori rispetto a quella costitutiva, conformare compiutamente un rapporto di diritto sostanziale per la cui conformazione sia necessario l’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato. La conclusione è che il giudicato, su sentenza di annullamento di un provvedimento amministrativo, cade sull’accertamento di illegittimità dell’atto di esercizio del potere amministrativo, in funzione della tutela dell'interesse legittimo della parte che agisce in giudizio, e sempre nei limiti della domanda giudiziale: e dunque nei limiti segnati dai profili di illegittimità dell’esercizio del potere che siano stati dedotti con la domanda giudiziale. Rimane dunque la possibilità del riesercizio del potere amministrativo, in funzione di disciplina del rapporto tra le parti, pur dopo il giudicato di annullamento di un provvedimento. Tale possibilità è suscettibile di discendere da quanto dispone il diritto sostanziale, ma non è in alcun modo idonea a incidere sulla funzione del giudicato materiale, e specificamente sulla sua idoneità a garantire una protezione effettiva ed efficace alla situazione giuridica (di interesse legittimo) azionata dal ricorrente vittorioso: è nota la categoria delle sentenze rebus sic stantibus e l’enucleazione di un effetto c.d. di fattispecie. 3. Giudicato parziale, giudicato interno e giudicato implicito Nel caso in cui una sentenza definitiva rechi una pluralità di statuizioni trasfuse in una pluralità di capi (di rito o di merito), l’appello parziale, che investa cioè una soltanto delle statuizioni trasfuse in capi di sentenza, determina il passaggio in giudicato del capo non impugnato; si parla di giudicato parziale, avente a oggetto il capo non impugnato, fonte di preclusione per il giudice d’appello di esaminare la questione espressamente decisa dal giudice di primo grado ma non appellata tempestivamente dalla parte soccombente, e ciò quand'anche si tratti di questione rilevabile d’ufficio. Per spiegare questa preclusione, che è preclusione pro iudicato, una parte della giurisprudenza richiama la disposizione recata dall’art. 329 c.p.c., a tenore del quale “l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”. Fenomeno parzialmente diverso è quello al quale ci si riferisce con la locuzione di giudicato interno, che si verifica allorché, nell'ambito di un grado di giudizio, intervengano sentenze non definitive su questioni di rito o di merito: la sentenza non definitiva, ove non impugnata, preclude che sulla relativa questione si possa riaprire la discussione nell’ulteriore corso del processo. Il giudicato interno, dunque, individua una preclusione endoprocessuale, e si riferisce all’efficacia, preclusiva all’ulteriore disamina della questione decisa, che una sentenza esplica nell’ambito del processo nel quale viene pronunciata; la relativa figura è cristallizzata ora, anche per il processo amministrativo, dall’art. 103 del Codice, il quale raffigura, per la parte che vi abbia interesse, l’onere di immediato appello o di riserva facoltativa d’appello nei confronti delle sentenze non definitive. Il giudicato interno, in quanto preclusione endoprocessuale, si contrappone al giudicato esterno, che ha riguardo alla forza vincolante di una decisione al di fuori del processo nel quale è stata pronunciata. Poiché una tale forza sul terreno extraprocessuale è propria del giudicato materiale, la portata del giudicato interno è maggiore rispetto a quella del giudicato esterno, posto che la preclusione endoprocessuale identificata con la locuzione ‘giudicato interno’ è collegabile anche a sentenze che non sono suscettibili di produrre effetti nella realtà materiale extraprocessuale per limitarsi ad accertare una volontà di legge processuale. Rimane fermo che la sentenza non definitiva su questione potrà sopravvivere all’estinzione del processo se e in quanto si tratti di sentenza idonea alla cosa giudicata materiale, esprima cioè un accertamento di volontà di legge sostanziale. Una parte della dottrina ha da tempo individuato, accanto al giudicato espresso, il c.d. giudicato implicito: un giudicato cioè che cade, in assenza di tempestivo appello, su tutte le questioni, ivi comprese quelle sui presupposti processuali, che pur non essendo trasfuse in statuizioni espresse, si atteggiano però a questioni logicamente pregiudiziali rispetto a quelle espressamente decise e si reputano perciò implicitamente decise in forza della statuizione espressa sulla questione pregiudicata. Il riconoscimento della figura del giudicato implicito postula il riconoscimento della figura (presupposta) della decisione implicita, da lungo tempo riconosciuta: l’Adunanza Plenaria rilevava che mentre la preclusione da giudicato è configurabile solo sulle questioni che siano oggetto di espressa statuizione in primo grado non investita dall’appello, invece una questione che risulti decisa implicitamente, senza cioè integrare l'oggetto di una statuizione espressa, potrebbe, ove si tratti di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, essere sollevata d’ufficio dal giudice in appello, ovvero in appello essere proposta per la prima volta dalle parti resistenti in primo grado. Nondimeno, il riconoscimento della figura della decisione implicita non significa di per sé riconoscimento della figura del giudicato implicito, non significa, cioè, che sulle decisioni implicite debba necessariamente cadere il giudicato implicito: autorevoli giuristi hanno invero rilevano l’incompatibilità logica tra il concetto di giudicato e il ravvisarlo implicitamente in una pronuncia che esprima un accertamento su questioni diverse. Poiché il giudicato è predicabile con riferimento a un accertamento giudiziale, esso non può essere ravvisato implicitamente con riguardo a questioni diverse da quelle su cui l’accertamento cade. In definitiva, secondo questa dottrina, il giudicato non ha, non può avere ad oggetto le decisioni implicite. La figura del giudicato implicito è stata però di recente riconosciuta dalla Corte di cassazione: esso cade, in assenza di tempestivo appello, sulla questione di giurisdizione, che pur non costituisca oggetto di autonoma statuizione, a fronte di una decisione, e di correlata statuizione espressa, su questioni di merito o su altre questioni che presuppongano risolta la questione della spettanza della giurisdizione in capo al giudice che l'ha pronunciata. La soluzione si impone, secondo le Sezioni unite, alla luce della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo. La norma codicistica che consente di giungere al riconoscimento della figura del giudicato implicito viene individuata dalle Sezioni unite nell’art. 276 interpretata come norma che eleva l’ordine logico di trattazione e decisione delle questioni in ordine legale che il giudice ha l’obbligo di seguire: poiché il giudice è vincolato dalla legge processuale a seguire, nella trattazione e decisione delle questioni, l'ordine logico, la decisione di una questione che logicamente è pregiudicata da altra presuppone anteriormente, quand’anche implicitamente, decisa la questione pregiudiziale: anche sulla decisione della quale, quand’anche implicita, in assenza di tempestivo appello cade così il giudicato. Dal riconoscimento della possibile formazione del giudicato implicito sulla questione di giurisdizione consegue, nella giurisprudenza delle Sezioni unite, la riduzione dell'ambito di operatività dell’art. 37 c.p.c., a tenore del quale la questione di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo: una volta che si riconosca che sulla questione, in assenza di appello, cade il giudicato implicito, è necessario concludere che la questione non è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello per preclusione da giudicato implicito, ovvero in applicazione della regola di cui all’art. 329, c. 2, c.p.c. Si deve quindi concludere che l’ordine di trattazione delle questioni, quale indicato dall’art. 276, c. 2, c.p.c., si impone anche al giudice amministrativo integrando un suo “preciso obbligo di legge”, perché le Sezioni unite hanno precisato -nell’esercizio della loro funzione di nomofilachia- che “la regola della decisione per gradi appartiene alla natura stessa del processo” ed è perciò espressione dì un principio generale. La figura del giudicato implicito, così come riconosciuta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, imporrebbe la conclusione che tutte le questioni non trattate e non decise espressamente nel giudizio di primo grado, ma logicamente pregiudiziali a quelle espressamente decise, sono suscettibili di essere coperte dal giudicato implicito, che andrebbe pertanto a coprire tutte le decisioni implicite: con l'importante conseguenza che, onde evitare che su di esse il giudicato implicito cada, la parte sarebbe tenuta a proporre appello; e con l’ulteriore conseguenza che, in assenza di tempestivo appello sulla decisione implicita, rimarrebbe precluso al giudice del secondo grado di rilevare d’ufficio la questione, in quanto appunto coperta dal giudicato implicito. Sennonché le stesse Sezioni unite hanno ridotto i contorni della figura del giudicato implicito, escludendo che esso possa coprire le decisioni implicite di questioni che attengono alle nullità dei provvedimenti giudiziali discendenti dal difetto dei presupposti o delle condizioni del giudizio, e specificamente dalla mancanza di legitimatio ad causam, dalla decadenza sostanziale dall’azione, dalla mancanza della eventualmente previa formulazione di domanda in sede amministrativa dalla litispendenza. Sarebbe quindi profilabile un discrimine, e un diverso regime processuale, tra la questione di giurisdizione e le questioni che concernono la sussistenza dei presupposti processuali necessari affinché la pronuncia non sia inutiliter, comprensive della questione di difetto assoluto di giurisdizione: soltanto la questione di difetto relativo di giurisdizione potrebbe costituire oggetto di giudicato implicito, mentre le questioni attinenti alla sussistenza dei presupposti processuali necessari affinché la pronuncia di merito non sia inutiliter data sarebbero sempre rilevabili, anche d’ufficio, in ogni grado del processo. Una siffatta diversità di regime processuale potrebbe giustificarsi per il fatto che il giudizio radicato dinanzi al giudice privo di giurisdizione può trasmigrare dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente, mentre il giudizio radicato in difetto dei presupposti processuali necessari non può in nessun caso sfociare in una pronuncia di merito. A così ritenere, la portata del giudicato implicito, esso può cadere non su tutte le decisioni implicite su questioni di giurisdizione, bensì solo su quelle di difetto relativo di giurisdizione, posto che quelle di difetto assoluto altro non sono che questioni attinenti alla sussistenza di un presupposto necessario affinché la pronuncia di merito sia utiliter data. La figura del giudicato implicito trova formale riconoscimento, nella disciplina del processo amministrativo, quanto alla decisione implicita su questione di giurisdizione e quanto alla decisione implicita su questione di competenza: l’art. 9 del Codice dispone che “il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio” e che “nel giudizio d’appello è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo esplicito o implicito, ha statuito sulla giurisdizione”. L’art. 92 esclude però che integrino decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie, nonché quelle che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La limitazione del giudicato implicito alle sole decisioni implicite su questioni di giurisdizione e di competenza, quale operata dal Codice, è compatibile con la natura e con la funzione che sembra di dover riconoscere alla figura medesima, diretta a escludere che il terreno sul quale si svolge il processo possa essere posto in discussione in qualsiasi momento del suo svolgimento: di qui la necessità che le decisioni implicite su giurisdizione e su competenza integrino oggetto di giudicato implicito, e di limitarne la rilevabilità d’ufficio solo nel primo grado del giudizio. Stando alla lettera dell’art. 9, il giudicato implicito si formerebbe anche laddove sia prospettabile il difetto assoluto di giurisdizione, che rimarrebbe perciò escluso dalla rilevabilità officiosa oltre il primo grado. È da segnalare infine che l’art. 101 del Codice, ha introdotto una nuova figura di preclusione, non riconducibile alla figura del giudicato implicito pur se a questa equiparabile quanto all’effetto di paralizzare la trattabilità in appello di questioni vuoi di rito, vuoi di merito. Stabilisce la norma che si intendono rinunciare le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado che non siano espressamente riproposte in appello con il ricorso o, per le parti diverse dall’appellante, con la prima memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione nel secondo grado. Mentre, infatti, la figura del giudicato implicito presuppone un rapporto di pregiudizialità logica tra la questione che ne costituisce oggetto e la questione espressamente decisa, ed è così riconoscibile in forza di quel precetto-principio portante del processo che scandisce, e impone al giudice, l’ordine logico nella soluzione delle questioni, invece la disposizione recata dall’art. 101, del Codice, è applicabile in ogni ipotesi di assorbimento o di mancata pronuncia in primo grado su domanda o su eccezione. Ne consegue che, nella norma, non è affatto ravvisabile il riconoscimento dell’estensione del giudicato implicito alle questioni assorbite o non decise, posto che di giudicato implicito può parlarsi solo a fronte di una decisione implicita su questione logicamente pregiudicata: la norma introduce, propriamente, una preclusione alla trattazione in appello di tutte le questioni, sollevate ma non decise neppure implicitamente in primo grado, che in appello non siano state espressamente riproposte. 4. Limiti oggettivi e soggettivi del giudicato nel processo amministrativo Problematica è la demarcazione dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato. Quanto all’ambito oggettivo, e con riferimento al processo di impugnazione, la dottrina amministrativistica ritiene che esso sia segnato dalle pronunce sulla fondatezza della domanda di annullamento: solo queste integrerebbero la species delle sentenze di merito, idonee al giudicato sostanziale. Ma è prospettiva della cui esaustività si può discutere, perché un accertamento idoneo a conformare i rapporti tra le parti può discendere anche da pronunce diverse da quelle sulla fondatezza della domanda di annullamento alla stregua dei motivi di illegittimità dedotti, e in particolare da pronunce che accertino che il ricorrente non è titolare della situazione giuridica per la cui protezione agisce in giudizio, ovvero che accertino l’insussistenza di qualsiasi situazione giuridica in capo al ricorrente medesimo. Quanto all'ambito soggettivo, esso appare delineato dall'art. 2909 c.c. Con riferimento al processo amministrativo di impugnazione per motivo di legittimità, tuttavia, è diffusa l’opinione che la sfera di efficacia soggettiva della sentenza si estenda ultra partes allorché si tratti di sentenza che annulla un atto a contenuto generale o comunque produttivo di effetti nei confronti di una pluralità di soggetti: opinione che si fonda sul rilievo che un atto amministrativo inesistente –annullamento- non può produrre effetti nei confronti di nessuno. Si tratta di opinione che poggia dunque sull’attribuzione di rilievo decisivo, ai fini della determinazione della sfera di efficacia soggettiva della sentenza di annullamento, al contenuto costitutivo di questa, tralasciando però di considerare da un lato che l’eliminazione giuridica dell’atto impugnato, se richiesta da taluno soltanto dei soggetti legittimati e interessati alla sua impugnazione, dovrebbe produrre effetti nei confronti soltanto di chi quella modificazione giudiziale abbia richiesto, e dall’altro lato che la giurisprudenza amministrativa è decisamente orientata nel senso di escludere che possano agire per l’ottemperanza a una sentenza di annullamento i soggetti che, pur legittimati all’impugnazione dell’atto, non se ne siano però gravati e siano quindi rimasti estranei al giudizio definito con quella sentenza. Distinto problema è quello di individuare in quale accezione il concetto di parti del giudizio sia assunto dall’art. 2909 c.c. La dottrina processualcivilistica ha sottolineato che la locuzione “parti del processo” è polisensa, perché la legge si riferisce talora alle parti in senso sostanziale -soggetti del rapporto sostanziale che è l'oggetto del giudizio- e talaltra alle parti in senso formale -soggetti del rapporto processuale preso in considerazione dalla singola disposizione-. Una tale polisemia vi è anche nella legge processuale amministrativa e se l'art. 71 che individua l’onere delle parti di presentare l'istanza di fissazione dell’udienza di discussione, si riferisce alle parti in senso formale, invece l'art. 28, che ammette tutte le parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata all’intervento nel giudizio nel quale non sono parti formali, riconoscendo loro l’utilizzabilità dello strumentario previsto per l’esercizio del diritto di difesa, si riferisce alle parti in senso sostanziale. Poiché l’art. 2909 c.c. si riferisce alle parti senza specificare in quale accezione la locuzione ‘parti’ deve essere assunta, sarebbe necessario indagare la possibilità di assumerla come riferita alle parti in senso sostanziale: ove l'indagine sortisse effetto positivo, ne deriverebbe la conseguenza che anche le parti in senso sostanziale, anche non assumendo la qualità di parti in senso formale, sarebbero toccate dal giudicato materiale. Capitolo 2: Il giudizio di ottemperanza 1. Profili evolutivi del giudizio di ottemperanza Il giudice amministrativo, a seguito dell’annullamento del provvedimento amministrativo, era tenuto a rimettere gli atti all’autorità competente quale soggetto abilitato a stabilire, unilateralmente ed in via discrezionale, il modo di adeguarsi alla decisione. Diversa era la disciplina inerente alle sentenze del giudice ordinario, rispetto alla cui inesecuzione si attribuiva la cognizione di merito alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Questa scelta rispondeva ad uno scopo preciso: poiché la p.a. aveva l’obbligo di adeguarsi al giudicato ordinario, ma non quello di eliminare l’atto, e conservava viceversa un margine di apprezzamento discrezionale, si volle consentire ad un organismo in qualche modo prossimo all’apparato amministrativo, dotato all’uopo di giurisdizione di merito, di valutare se e come l’adeguamento al dictum giudiziale dovesse avere luogo. Tale assetto venne confermato affidando alla cognizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale i “ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico”; ricorsi che, per la ricchezza dei poteri “anche in merito” attribuiti al giudice, vennero inquadrati nella figura del giudizio di ottemperanza. Si evidenziò ben presto nella prassi che l’amministrazione difficilmente garantiva sua sponte l’esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo. La giurisprudenza dovette dunque supplire a tale carenza: la IV Sezione del Consiglio di Stato, a partire dalla decisione 181/1928, ampliò l’ambito operativo del giudizio di ottemperanza ricomprendendovi l’ipotesi della mancata esecuzione delle sentenze amministrative. Il rimedio venne poi esplicitamente previsto dall’art. 37, c. 3, della legge Tar come azionabile (oltre che nei riguardi delle sentenze del giudice ordinario anche) a fronte delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. Il processo amministrativo iniziò così a divenire uno strumento con il quale il giudice prendeva portava a soddisfazione le aspettative tutelate del privato. Rimanevano prive di rimedio esecutivo pronunce pur sempre (immediatamente) esecutive, per quanto ancora sovvertibili a seguito dell’esperimento dei mezzi di impugnazione. La legge 205/2000, segnò in tal senso una successiva e rilevante tappa evolutiva, prevedendo la sostanziale estensione delle regole proprie del giudizio di ottemperanza anche alle sentenze di primo grado, esecutive anche se soggette ad impugnazione, nonché alle ordinanze pronunciate dal giudice amministrativo in sede cautelare. 2. Le scelte del Codice del processo amministrativo II Codice del processo amministrativo, malgrado l’approccio ‘omissivo’ della legge delega sulla materia dell’ottemperanza, non si è limitato ad una riedizione dell’esistente: i suoi redattori hanno, invece, operato un significativo sforzo di armonizzazione delle disposizioni previgenti nel Libro IV (“Ottemperanza e riti speciali’’), Titolo I (“Giudizio di ottemperanza”), introducendo un’organica disciplina del giudizio di ottemperanza. Non solo: l’art. 34, c. 1, lett. e), del Codice, nell’elencare i contenuti delle sentenze di merito, prevede che il giudice amministrativo “dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza”. La previsione è di estremo interesse in funzione dell’ampliamento della tutela del ricorrente, in quanto consente l’enunciazione delle misure attuative, e persino l’investitura commissariale, anche all’esito del giudizio di cognizione. La norma, che potrebbe essere letta quasi come un’anticipazione dei poteri tipicamente esercitabili in sede di ottemperanza, vale comunque ad attrarre nel giudizio di cognizione il vaglio di fondatezza della pretesa sostanziale, quantomeno in presenza di un’attività amministrativa vincolata. Va da sé che la sentenza resa ai sensi dell’art. 114, c. 3-6, dovrà porsi in coerenza con le statuizioni già pronunciate. Al Codice va inoltre riconosciuto il merito, sempre in nome ed in funzione della effettività della tutela, di aver eliminato la necessità della diffida dapprima prevista quale passaggio procedurale necessario e preventivo rispetto al ricorso in ottemperanza; nonché di aver innovativamente esteso il rimedio del ricorso di ottemperanza, nella sistematica dei rapporti tra giurisdizioni, ben oltre l’ambito originario, elevandolo a strumento ad un tempo residuale e generale, ossia azionabile nei confronti della p.a. anche rispetto ai pronunciamenti dei collegi arbitrali e dei giudici speciali, in mancanza di rimedi specifici. Di ciò è riprova l’art. 112 del Codice, che nel ribadire l’obbligo della p.a. (e delle altre parti) di eseguire i provvedimenti del giudice amministrativo dilata l’operatività di siffatto obbligo anche rispetto ad altre decisioni, sanzionandolo con lo strumento dell’ottemperanza. Va da sé che, a fronte di sentenze del giudice ordinario o di giudici speciali, ovvero a fronte di lodi arbitrali, condizione per la proponibilità del ricorso in ottemperanza è che del giudizio (anche arbitrale) sia stata parte una p.a. o un soggetto ad essa equiparato, secondo il criterio interpretativo offerto dall’art. 7, c. 2, del Codice. Occorre poi rimarcare che, a differenza delle sentenze del giudice amministrativo, quelle del giudice ordinario e dei giudici speciali non consentono il rimedio dell’ottemperanza se non dopo il loro passaggio in giudicato. Una particolare sottolineatura merita la prevista esperibilità del giudizio di ottemperanza finalizzato a far eseguire un lodo arbitrale: il Codice, facendo leva sulla perfetta equiparabilità tra sentenza esecutiva e lodo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825 c.p.c. e, quindi, confortando la ricostruzione che colloca l’istituto dell’arbitrato in un quadro giurisdizionale piuttosto che negoziale, ricompone, in senso permissivo, il contrasto giurisprudenziale in precedenza insorto sulla praticabilità dell’accennata soluzione. Resta inteso che il ricorso in ottemperanza sarà inammissibile in assenza del decreto di esecutività ovvero in pendenza dei termini per proporre i rimedi di cui all’art. 827 c.p.c. (impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo). 3. Funzione e presupposti dei giudizio di ottemperanza Il giudizio di ottemperanza è uno strumento idoneo a rendere concrete le statuizioni contenute nel provvedimento giurisdizionale esecutivo e, in definitiva, a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale (effettività “esecutiva”). Si può affermare che tale effettività è oggi realizzabile, attraverso il giudizio di ottemperanza: a) nei riguardi delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) nei riguardi delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (sentenze non passate in giudicato ma esecutive; ordinanze cautelari); c) nei riguardi delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario (ad esempio i decreti ingiuntivi non opposti nell’ambito del procedimento monitorio), al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della p.a. di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) nei riguardi delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, di quei giudici (speciali) davanti ai quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della p.a. di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; e) nei riguardi dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della p.a. di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; trattasi dei lodi arbitrali pronunciati all’esito di procedimenti arbitrali rituali di diritto, vertenti su diritti soggettivi (art. 12 del Codice). Nell’attuale strutturazione dell’istituto, l’unico presupposto processuale del giudizio di ottemperanza è l’esistenza di un provvedimento esecutivo del giudice amministrativo (o di altro giudice o del collegio arbitrale); mentre la previa proposizione di una diffida a provvedere inoltrata all’amministrazione inadempiente non costituisce più presupposto processuale, come era invece nella normativa antecedente al Codice. Si deve ritenere che non costituisca presupposto processuale l’inadempimento dell’amministrazione di fronte al provvedimento giurisdizionale o, per dirla altrimenti, l’inesecuzione di questo: tale elemento è più propriamente da inquadrare quale parte dell’oggetto del giudizio, poiché su di esso si appunta una specifica attività di accertamento demandata al giudice. 4. Il petitum, la causa petendi e l’oggetto del processo di ottemperanza La causa petendi del giudizio di ottemperanza s’identifica con quella medesima situazione giuridica soggettiva che risulta azionata nel processo esitato nel provvedimento ineseguito: solitamente trattasi dell’interesse legittimo, ma in ambito di giurisdizione esclusiva possono venire in rilievo anche diritti soggettivi. Non sembra viceversa cogliere nel segno l’impostazione che individua la causa petendi, sempre e comunque, in un preteso diritto all’esecuzione (o all’ottemperanza), nascente dal pronunciamento giurisdizionale e speculare all’obbligo dell’amministrazione di conformarsi a questo. Se, sul piano normativo, tale conclusione potrebbe oggi ancorarsi alla previsione che ammette la proposizione del relativo ricorso in un termine decennale, in realtà il richiamo al trattamento processuale dell’istituto non sembra affatto probante. Non può infatti disconoscersi che il ricorrente punta, attraverso il giudizio di ottemperanza, a dare soddisfazione a quella medesima situazione che era stata originariamente azionata; e che, a causa della indisponibilità dell’amministrazione, è rimasta frustrata sul piano degli effetti giuridici, attesa l’assenza dì un provvedimento amministrativo conforme all’assetto degli interessi prefigurato nel comando giudiziale. Potrebbe anche sostenersi che il processo di ottemperanza costituisca una sorta di prosecuzione, a seconda dei casi, del giudizio di cognizione o del giudizio cautelare; ma ciò solo a condizione che l’espressione sia intesa in senso ideale e descrittivo, non in senso tecnico. Il rimedio esecutivo possiede una sua spiccata autonomia concettuale e strutturale, rispondendo esso a suoi propri presupposti ed essendo caratterizzato da un particolare iter procedurale, oltre che da una notevole ampiezza dei poteri di “merito” esercitabili dal giudice. In relazione alla causa petendi, l’individuazione del petitum del giudizio appare invece più complessa e richiede un preliminare chiarimento in ordine alla differenza intercorrente tra il giudizio di ottemperanza ed il giudizio di esecuzione di matrice civile. Questo secondo risponde all’esigenza di operare una trasformazione della realtà di fatto in corrispondenza al comando concreto di legge siccome individuato nella statuizione già contenuta in sentenza: l’esecuzione semplice adeguamento del fatto al diritto. Invece il giudizio di ottemperanza disciplinato dal c.p.a. si prefigge, nella gran parte dei casi e preliminarmente, proprio ed esattamente l’identificazione di una volontà di legge non ancora nitidamente emersa; ovvero il completamento di tale opera di identificazione, ove dal provvedimento ineseguito del giudice amministrativo permangano, come normalmente accade, ampi spazi di discrezionalità in capo all’amministrazione. Al giudice amministrativo (che si trovi di fronte ad un provvedimento giurisdizionale amministrativo ineseguito) viene perciò demandata un’attività complessa, intesa: - alla verifica della congruità della risposta operativa (ove vi sia stata) fornita dalla parte pubblica al provvedimento giurisdizionale, sì da acclarare l’inadempimento della p.a.; - alla determinazione del comportamento da realizzarsi nel caso concreto, ricavando dalle motivazioni poste alla base della pronuncia giudiziale, arricchite da un’ineliminabile opera interpretativa, chiarificatrice, specificativa ed integrativa, la regola dell’azione amministrativa di adeguamento alla pronuncia; all’adozione, anche in via sostitutiva rispetto all’autorità pubblica, dei provvedimenti necessari per realizzare un assetto di interessi conforme al provvedimento giurisdizionale (integrato, specificato e interpretato); - all’aspirazione del ricorrente al bene della vita oggetto della contesa processuale. L’enucleazione, nell’attività del giudice, di un essenziale contenuto cognitivo rende preferibile riferire al processo di ottemperanza uno scopo di “attuazione” del provvedimento giurisdizionale amministrativo, anziché di sua semplice “esecuzione”. Non si impedisce tuttavia che la pronuncia del giudice amministrativo sia anche suscettibile di esecuzione in senso stretto. Inerenti all’esecuzione sono infatti l’effetto demolitorio e quello ripristinatorio del provvedimento, che potrebbero in ipotesi essere gli unici risultati perseguibili in sede esecutiva (si pensi alla restituzione di un terreno espropriato in base a provvedimento annullato dal giudice amministrativo); mentre certamente esulano dall’esecuzione in senso stretto, per rientrare nel concetto di attuazione, gli effetti ulteriori, quelli cioè legati allo sviluppo successivo dell’azione amministrativa. Il quadro ricostruttivo si presenta sensibilmente differente quando l’esecuzione verta sulle sentenze, o pronunciamenti equiparati, del collegio arbitrale, del giudice ordinario o di giudici speciali. In tali casi il giudice amministrativo investito dell’esecuzione deve limitarsi ad esercitare i poteri di “stretta esecuzione”, in quanto eventuali statuizioni che esorbitassero dalla mera esecuzione sarebbero viziate per difetto di giurisdizione, non potendo il giudice amministrativo incidere su situazioni giuridiche soggettive sottratte alla sua cognizione (pensiamo ai diritti soggettivi non ricadenti nelle materie di giurisdizione esclusiva). - 5. Le sentenze del giudice amministrativo suscettibili di ottemperanza Il giudizio di ottemperanza sembra esperibile per far valere le sentenze che accolgano: il ricorso per annullamento, in quanto alla statuizione demolitoria della sentenza si accompagna un effetto conformativo, volto cioè ad indirizzare il successivo sviluppo dell’azione amministrativa; il ricorso per nullità per analoghe ragioni; il ricorso avverso il silenzio, poiché la relativa sentenza reca l’ordine all’amministrazione rimasta inerte di adottare entro un certo termine il provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento; il ricorso per condanna, in quanto possono essere richiesti il pagamento di somme di denaro dovute dall’amministrazione, l’adozione di misure idonee a tutelare la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio o l’ordine di risarcire il danno ingiusto derivante dalla lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi anche mediante misure di risarcimento in forma specifica. Deve essere ricordata, a quest’ultimo proposito, l’espressa disposizione recata dall’art. 34, c. 4, del Codice, per il caso di condanna pecuniaria: il giudice, in mancanza di opposizione delle parti, può limitarsi a stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, o non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, l’interessato può, proprio con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, chiedere la determinazione della somma dovuta o l’adempimento degli obblighi ineseguiti. Nella fattispecie esaminata, al giudice dell’ottemperanza viene affidato il compito di liquidare l’importo dovuto e di sostituirsi, se del caso, all’amministrazione inadempiente. Le peculiarità di questo giudizio rispetto al modello generale sono però evidenti: il giudice non è chiamato a determinare un assetto di interessi in un contesto che contrappone propriamente interesse/i pubblico/i ad interesse/i privato/i, ma unicamente a regolare i rapporti economici tra le parti, definendo la stessa domanda che era stata originariamente proposta in sede cognitoria. Dunque, nella fattispecie in esame tra il giudizio di ottemperanza e la sentenza (che stabilisce i soli criteri di liquidazione) il legislatore ha frapposto un tentativo di composizione consensuale degli interessi economici. A fronte di una sentenza di accertamento nulla osta ad ammettere un’azione di ottemperanza delucidativa ai sensi dell’art. 112, c. 5, del Codice, dal momento che l’esigenza di chiarimenti potrebbe sorgere anche in un contesto meramente dichiarativo. Altra questione attiene alla proponibilità del giudizio di ottemperanza a fronte della violazione, da parte della p.a., della sentenza applicativa dell’art. 21-octies, c. 2, della l. 241/1990, che fissa il principio di conservazione dei provvedimenti amministrativi. Nelle fattispecie contemplate dal c. 2 (provvedimento emanato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, o in carenza di previa comunicazione di avvio del procedimento) il giudice accerta che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; sembrano dunque non sussistere difficoltà ad ammettere che tale accertamento passi in giudicato sostanziale. Ne consegue che, ove l’amministrazione agisse in via di autotutela rimuovendo l’atto, violerebbe il giudicato (o comunque la sentenza esecutiva) abilitando i soggetti aventi interesse ad esperire l’ottemperanza. Tuttavia, se tale violazione si realizza senz’altro nel caso in cui la p.a. adotti un provvedimento di annullamento d’ufficio, maggiori perplessità sorgono nel caso di revoca, specie quando questa investa profili sopravvenuti di interesse pubblico che il giudice non aveva potuto conoscere; in tale contesto, la p.a. non sembra vincolata all’accertamento giudiziale. Lo strumento da attivare per contestare l’atto di autotutela parrebbe quello del ricorso di annullamento in sede ordinaria di cognizione. 6. Le sentenze dei giudice amministrativo insuscettibili di ottemperanza Il giudizio di ottemperanza non è esperibile in ordine alle sentenze autoesecutive (anche definite autoapplicative o autosatisfattive), la cui capacità esecutiva si esaurisce nell’effetto demolitorio. Tra di esse possono ricordarsi le pronunce che annullano i provvedimenti negativi di controllo, restituendo così piena efficacia all’atto controllato, senza che occorra da parte dell’amministrazione una specifica attività di adeguamento. Ma del pari possono ascriversi a tale novero le sentenze che annullano taluni atti sanzionatoti (come la sanzione disciplinare dell’ammonimento), quando essi non abbiano prodotto ulteriori conseguenze; nonché le sentenze che annullano provvedimenti postulanti una successiva attività materiale (come i decreti espropriativi), qualora tale attività non sia stata principiata. Alla stessa categoria appartengono le sentenze che, annullando provvedimenti amministrativi di autotutela demolitoria (revoche, annullamenti d’ufficio), ripristinano gli effetti dell’atto che aveva formato oggetto del procedimento di secondo grado. In tutti questi casi il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto inammissibile, non ravvisandosi una necessità di ulteriore attività esecutiva da parte dell’amministrazione. In tutte queste ipotesi la sentenza resa dal giudice amministrativo è idonea di per sé a soddisfare compiutamente l’interesse del ricorrente. L’inammissibilità del giudizio di ottemperanza è sempre stata riconosciuta relativamente ai ricorsi in ottemperanza proposti in esito a decisioni aventi carattere meramente processuale e prive, come tali, di statuizioni di merito. Qualche riflessione peculiare deve essere dedicata alla sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere. Tradizionalmente qualificata come sentenza “in rito”, l’art. 34, c. 5, del Codice la colloca oggi tra le “sentenze di merito”, stabilendo che il giudice la pronunci “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta”. La formulazione normativa rende esplicito che la sentenza in questione ingloba un accertamento giurisdizionale sul rapporto tra amministrazione e ricorrente che non può non fare stato tra le parti. Laddove, a seguito della sentenza, l’amministrazione agisse come se quell’accertamento non esistesse determinerebbe una violazione della sentenza resa inter partes, frustrata nella sua efficacia preclusiva. In questo quadro, sembra ragionevole elevare il giudizio di ottemperanza a sede idonea per appurare la violazione intervenuta ed assicurare la conformità dell’azione amministrativa alla statuizione già resa in sede cognitoria. In passato, si è ritenuta inammissibile l’ottemperanza promossa avverso le sentenze di rigetto, destinate a lasciare immutato il preesistente assetto giuridico dei rapporti così come delineato dagli atti e dai provvedimenti anteriori . Quest’ultima concezione non è però apparsa pacifica in dottrina, essendosi ritenuto che anche nella sentenza di rigetto possa identificarsi un contenuto ordinativo e preclusivo sufficiente per la proposizione del giudizio di ottemperanza, ovviamente da parte dei controinteressati. Ne consegue che il corrispondente ricorso introduttivo dovrebbe rimanere precluso, ed inficiato da inammissibilità, nel solo caso in cui la sentenza o la misura cautelare ineseguita, siano esse di accoglimento o di rigetto, risultino prive di prescrizioni sostanziali. 7. Il presupposto dell’inesecuzione L’obbligo di esecuzione dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo è posto non solo a carico dell'amministrazione, ma anche delle altre parti del giudizio. Per quanto la statuizione si presti ad una lettura riduttiva, incentrata sulla sottolineatura dell’obbligo della parte soccombente (anche privata) di prestare esecuzione alla sentenza, non può escludersi un’interpretazione più avanzata, tesa a sostenere l’esperibilità del giudizio di ottemperanza anche nei confronti delle parti private, in connessione all’ampliamento della giurisdizione amministrativa; si può pensare, ad es., alla inesecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno. In tale direzione sovviene peraltro un argumentum a contrario: l’art. 112 del Codice, relativo alla proponibilità del giudizio di ottemperanza, fa espresso richiamo alla finalità di ottenere l’adempimento dell’obbligo della p.a. di conformarsi al giudicato solo nelle lett. c), d) ed e), concernenti le pronunce dei giudici diversi da quello amministrativo e degli arbitri; dunque solo in tali ipotesi la legittimazione passiva del giudizio viene espressamente circoscritta all’amministrazione pubblica. Viceversa, tale precisazione non compare nelle lett. a) e b) inerenti ai vari tipi di provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, lasciando così supporre una possibile legittimazione anche di soggetti privati. L’evenienza più rilevante resta comunque quella tradizionale, nella quale cioè il provvedimento giurisdizionale esecutivo debba essere eseguito dalla p.a. In tale situazione, essa potrebbe scegliere l’ipotesi dell'inerzia, ossia della mancata osservanza del comando impartito dal giudice amministrativo; o potrebbe persino dichiarare esplicitamente di non voler dare esecuzione al dictum giudiziale. Entrambe trasgrediscono dell’obbligo sancito dall’art. 112, c. 1, del Codice e quindi integrano il presupposto della insecuzione, o inottemperanza, al provvedimento giurisdizionale esecutivo. Parimenti, quando l’esecuzione del giudicato risulti solo parziale, tale azione sarà sempre esperibile per conseguire l’attuazione delle statuizioni rimaste inosservate. Dai casi di inesecuzione vera e propria vanno tenute distinte le fattispecie di inesecuzione giustificata; infatti sia l’amministrazione che il giudice (dell’ottemperanza) devono tener conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto (ius superveniens) intervenute durante l’esplicarsi del ricorso originario e fino alla notifica della sentenza da eseguire. Il ricorrente non potrà, in tale eventualità, pretendere una piena esecuzione del provvedimento giurisdizionale la cui attuazione sia impedita dalle sopravvenienze, ma avrà titolo a vedersi ristorati gli eventuali danni subiti per effetto dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione. Infine, il principio generale del “ne bis in idem” impedisce la riproposizione di un ricorso di ottemperanza già esperito ed esitato in una sentenza non rivelatrice di alcun profilo di inottemperanza. 8. La nullità dell’atto violativo o elusivo del giudicato Il presupposto dell’inesecuzione può ravvisarsi anche nel caso in cui l’amministrazione adotti un provvedimento in diretto contrasto con le statuizioni contenute nel pronunciamento giudicato (violazione del giudicato), o incorporante un adempimento solo apparente e fittizio al giudicato stesso, ma in realtà finalizzato a rinviare la definizione dell’assetto degli interessi (atto soprassessorio o dilatorio) o comunque ad aggirare la portata precettiva del pronunciamento (elusione del giudicato). Il c. 1 dell’art. 21-septies l. 241/1990, ricomprende tra le diverse ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo anche quelle dell’atto adottato in violazione o elusione del giudicato. Allo stato l’art. 114, c. 4, lett. b) del Codice dispone che il giudice dell’ottemperanza, nel caso di accoglimento del ricorso, “dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato”. La controversia attinente alla nullità in questione, non solo ricade nella giurisdizione amministrativa esclusiva, ma segue le regole dell’ottemperanza a partire dal relativo termine di proponibilità, che è quello decennale proprio dell’actio iudicati. Tali previsioni determinano una divaricazione tra il regime processuale della nullità per violazione o elusione del giudicato e quello concernente le altre ipotesi di nullità di cui all’art. 21-septies l. 241/1990 (mancanza degli elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, sussistenza di altri casi di nullità previsti dalla legge), che possono essere fatte valere entro il termine fissato. Circa i poteri del giudice dell’esecuzione di fronte all’atto nullo per violazione o elusione del giudicato, l’art. 114, c. 4, lett. b), del Codice riconosce alla pronuncia di accoglimento del ricorso un contenuto meramente dichiarativo della nullità. È però possibile che il contrasto o l’elusione insorga rispetto ad un altro e diverso provvedimento giurisdizionale esecutivo, quale una sentenza non passata in giudicato o un’ordinanza cautelare: in tal caso si ravvisa non una nullità, bensì un’inefficacia dell’atto. Infatti, secondo quanto dispone l’art. 114, c. 4, lett. c), del Codice, il giudice, nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione; egli, inoltre, “provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”. La previsione sembra sottendere un potere di disapplicazione del giudice amministrativo non dissimile da quello assegnato al giudice ordinario. Resta fermo, esaminando l’ambito della cognizione del giudice, che nei casi di elusione o violazione del provvedimento giurisdizionale pregresso il giudizio di ottemperanza è destinato ad arricchirsi nella sua parte “di cognizione”: la pronuncia avrà un contenuto di accertamento della ricorrenza delle cause di nullità (o d’inefficacia) onde pervenire alla relativa declaratoria; essa poi, prendendo le mosse dal provvedimento giurisdizionale originario (eluso o violato) disporrà quanto necessario per fissare i parametri dell’azione amministrativa al fine di perseguire l’effettiva attuazione del comando in esso contenuto. 9. La competenza In ordine al regime della competenza per il giudizio di ottemperanza, dall’art. 113 del Codice si ricava il seguente quadro: A) nei casi di cui all’art. 112, c. 2, lett. a) (esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato) e lett. b) (esecuzione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo), il ricorso va proposto al giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta; in tali evenienze la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche quando l’esecuzione investa suoi provvedimenti confermati in sede di appello con motivazione avente lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado; B) nei casi di cui all’art. 123, c. 2, lett. c) (esecuzione delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario), lett. d) (esecuzione delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, dei giudici davanti ai quali non sia previsto il rimedio dell’esecuzione) e lett. e) (esecuzione del lodo arbitrale inoppugnabile), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice (ovvero il collegio arbitrale) che ha emesso il provvedimento di cui è chiesta l'esecuzione. Il principio che ha orientato il legislatore nel porre la disciplina sub A): il miglior interprete ed esecutore della decisione non può che essere lo stesso giudice che l’ha adottata, a lui spettando specificare ulteriormente e progressivamente le regulae juris e le normae agendi cui l’amministrazione è chiamata ad attenersi nella riedizione del provvedimento amministrativo. Ciò spiega perché, in virtù delle disposizioni richiamate, il tribunale amministrativo regionale è competente per l’esecuzione delle proprie pronunce confermate in grado d’appello solo a condizione che esse siano state “ratificate” nella loro portata sostanziale, ossia sul piano motivazionale e conformativo, dal Consiglio di Stato; mentre quest’ultimo rimane competente, per analoghe ragioni, ogniqualvolta, indipendentemente dalla formale conferma del dispositivo del primo giudice, il decisum sostanziale si rinvenga integralmente nella pronuncia di secondo grado; nonché nelle ipotesi in cui quest’ultima sia anche solo parzialmente modificatrice, innovatrice o integratrice della sostanza della motivazione contenuta nella decisione del TAR. Qualora il ricorso venga proposto innanzi a giudice incompetente, in violazione delle regole appena esposte, trova applicazione il regime della competenza inderogabile di cui all’art. 16 del Codice. 10. La procedura L’interesse concreto a ricorrere in sede di ottemperanza va riconosciuto in capo ai soggetti sui quali il provvedimento giurisdizionale esecutivo spiega i suoi effetti immediati; essi sono normalmente individuabili in coloro che hanno partecipato al giudizio all’esito del quale il provvedimento e stato pronunciato. Se, però, la pronuncia è efficace ultra partes, la legittimazione a chiederne l’attuazione può ricondursi a ciascuno dei soggetti interessati, anche se rimasti estranei al processo. Riguardo al termine per proporre il giudizio, opera la prescrizione di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza tradizionalmente valevole per l’actio iudicati. Nella disciplina antecedente al c.p.a. era pacifico che prima della proposizione del ricorso in ottemperanza l’interessato avesse l’obbligo di notificare all’organo dell’amministrazione tenuto all’adempimento, e quindi a pena di inammissibilità del ricorso stesso, un atto stragiudiziale di diffida ad adempiere al giudicato, entro un termine non inferiore a 30 giorni. Oggi l’art. 114, c. 1, del Codice depone per la facoltatività della diffida, che non può più qualificarsi alla stregua di presupposto processuale dell’azione esecutiva. Per quanto concerne la garanzia del contraddittorio nel processo di ottemperanza, il Codice del processo amministrativo supera provvidenzialmente le perplessità sorte in passato. Va infatti ricordato che il regolamento n. 642/1907, all’art. 91, prevedeva che il ricorso di ottemperanza fosse soggetto non a notifica, ma direttamente a deposito presso l’organo giurisdizionale competente; di tale deposito il segretario era tenuto a dare immediata comunicazione alla (sola) p.a. interessata, la quale, entro i 20 giorni successivi, poteva trasmettere le proprie osservazioni alla Segreteria del giudice. In parallelo con il progressivo riconoscimento al giudizio di ottemperanza del carattere della controvertibilità (discendente dal compimento dell’attività cognitoria indispensabile a determinare la portata sostanziale del giudicato e gli appropriati atti di esecuzione e di ottemperanza), la giurisprudenza iniziò ad imporre al ricorrente l’obbligo della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio sia all’amministrazione inottemperante che ai controinteressati, in precedenza pretermessi ed opportunamente individuati nei soggetti che in dipendenza dell’attuazione del giudicato potessero ricevere pregiudizio nella propria sfera giuridica. Per quanto la Consulta, con una lettura correttiva, avesse avallato il regime previgente della comunicazione, il Codice, nell’art. 114, c. 1, ha scelto di allineare la disciplina dell’ottemperanza alle regole generali, prevedendo che il ricorso debba essere notificato alla p.a. ed alle altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo “della cui ottemperanza si tratta”. La formulazione normativa lascia intendere che la notificazione sia da ritenere correttamente effettuata alle parti a prescindere dalla rispettiva legittimazione. Permane il dubbio se la notifica debba avvenire presso il domicilio reale dell’amministrazione, o presso quello eletto o ex lege. L’autonomia dell’azione rispetto a quella di cognizione porta a prediligere, in linea di principio, la prima soluzione, rinforzata anche dal rinvio esterno alle norme del c.p.c. di cui all’art. 39 del c.p.a. Basti in proposito rammentare l’art. 479 c.p.c., secondo il quale la notificazione del titolo esecutivo e del precetto deve essere fatta alla parte personalmente, nonché il successivo art. 489, che designa quale luogo delle notificazioni e delle comunicazioni ai creditori pignoranti, in sede espropriativa, la residenza dichiarata o il domicilio eletto nell’atto di precetto. La seconda soluzione potrebbe accreditarsi, invece, nei casi di azione di ottemperanza delucidativa su ricorso delle parti (art. 112, c. 5) o del commissario (art. 114, c. 6 e7). Nonostante la formulazione dell’art. 114 che fa espresso riferimento, al c. 1, all’amministrazione e “a tutte le parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta”, si potrebbe ritenere che, secondo le regole generali, il ricorso potrà essere notificato anche a solo uno dei controinteressati, salva l’eventuale successiva integrazione del contraddittorio disposta dal giudice. Il regime dell’incardinamento del ricorso viene così “normalizzato” è reso armonico con il modello delineato dal Codice. Permane tuttavia qualche dubbio circa la possibilità di evocare in sede di ottemperanza un’amministrazione diversa da quella rimasta soccombente nel pregresso giudizio di cognizione in quanto comunque serve a dare esecuzione al decisum. Al ricorso va allegato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. La prassi giurisprudenziale ha sempre ammesso, nell’ambito del processo di ottemperanza, la proposizione di istanze cautelari. Devono ritenersi esperibili tutte le forme di tutela cautelare oggi contemplate del Codice, collegiali e monocratiche, ante causam e post causam. Per quanto sia in concreto difficile che una simile ipotesi possa verificarsi, in sede di ottemperanza sembra anche proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, cui consegue la sospensione del processo esecutivo. Il processo di ottemperanza sfocia nella celebrazione non di un’udienza pubblica, bensì di una camera di consiglio. Valgono perciò per il giudizio di ottemperanza le regole caratterizzanti i riti camerali. Nel rito si ammette il deposito del ricorso, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante. Tuttavia, il compiuto adeguamento del rito al principio del contraddittorio dovrebbe escludere la possibilità di celebrare l’udienza camerale prima che il ricorrente abbia fornito la prova dell’effettiva ricezione della notificazione da parte dei legittimi contraddittori’4. Nel precedente regime normativo era consentita, a domanda, la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Oggi tale facoltà non è più prevista; tuttavia, vale il principio secondo cui l’assunzione della decisione a seguito di pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione stessa. L’art. 112 del Codice individua, nel c. 3, alcuni casi di cumulo dell’azione di ottemperanza con l’azione di condanna. Detto comma prevede infatti che contestualmente al ricorso in ottemperanza possano essere proposte, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza: a) l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza; b) l’azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione. Il caso sub a), pur sfociando in una pronuncia di condanna, presenta una teleologia perfettamente armonica con lo schema generale dell’azione esecutiva, in quanto le domande rivolte al giudice hanno ad oggetto statuizioni che derivano proprio ed esattamente dalla mancata esecuzione della precedente sentenza, laddove impositiva di obblighi pecuniari in capo alla p.a. nel contesto di un rapporto di tipo obbligatorio (si pensi alle controversie in tema di pubblico impiego non contrattualizzato). In relazione all’ipotesi sub b), il Codice consente senz’altro una domanda risarcitoria connessa ad un’esigenza strettamente esecutiva, afferente ai capi della sentenza rimasta ineseguita (ad esempio, reintegrazione del pubblico dipendente in un certo incarico o qualifica, in relazione ai quali siano rivendicati i compensi non percepiti). Ma la previsione ammette anche, nella prospettiva della concentrazione delle azioni, che il ricorrente rivendichi i danni originati dalla difformità dell’operato della p.a. rispetto al giudicato medesimo; ciò con potenziale rinuncia ad un grado di giudizio, nel caso di competenza del Consiglio di Stato. Del tutto opportuna è anche la prevista finalizzazione dell’ottemperanza al ristoro dei danni derivanti dalla preclusione (impossibilità) a realizzare il giudicato, in ragione di fattori emersi de iure o de facto. Anche in questa ipotesi il Consiglio di Stato, se competente per l’ottemperanza, conoscerà altresì della pretesa risarcitoria in unico grado. Non è chiaro, invece, se l’ottemperanza sia da ammettere qualora la situazione di fatto sia tale per cui l’esecuzione risulterebbe eccessivamente onerosa (per l’interesse pubblico o anche per l’interesse erariale della p.a. inottemperante). L’art. 112, c. 3 del Codice, fa espresso riferimento alla sola azione di danni in qualche modo collegata al precedente giudicato, sicché il cumulo parrebbe prima facie escluso in relazione ad un’azione risarcitoria che si radichi sulla mancata esecuzione, violazione o elusione di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza non passata in giudicato o ordinanza cautelare), o sulla circostanza che l’esecuzione di siffatto provvedimento risulti impossibile. Non v’è dubbio che sarebbe irragionevole far dipendere il cumulo dalla circostanza estrinseca che la pronuncia giurisdizionale abbia o meno il carattere del giudicato. Il d.lgs. 195/2011 ha soppresso il c. 4 dell’art. 112 che ammetteva la proposizione, in sede di ottemperanza, dell’azione di condanna al risarcimento ai sensi dell’art. 30, c. 5, diretta cioè al risarcimento del danno derivante dall’emanazione o esecuzione del provvedimento amministrativo illegittimo: non è quindi più esperibile l’azione risarcitoria ‘autonoma’ correlata ai danni patiti in conseguenza del provvedimento originario. 11. L’estinzione del giudizio di ottemperanza e la sentenza L’estinzione del giudizio di ottemperanza ha luogo, di regola, solo a seguito di sopravvenuta integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale che ne costituisce presupposto. Secondo l’orientamento prevalente, la proposizione del giudizio, e persino l’intervenuta nomina del commissario ad acta, non spogliano l’amministrazione del potere di porre in essere atti che costituiscano effettivo adempimento dell’obbligo di conformarsi al comando giudiziale. Questa tesi ha trovato conferma in quanto si prevedeva -sia pure in relazione al diverso ambito dell'esecuzione delle sentenze “sul silenzio”che all’atto dell’insediamento “il commissario, preliminarmente all’emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l’amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo”. Detta norma è stata abrogata, senza sostituzione con previsione analoga, dal Codice, ma la solidità teorica e dogmatica su cui si fonda la tesi della inesauribilità del potere amministrativo consente di riconoscerne l’attualità anche prescindendo dalla carenza di un appiglio letterale. Si ha invece improcedibilità per cessazione della materia del contendere (art. 34, c. 5, del Codice) quando gli atti adempitivi producano la piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente. Se, infatti, lo scopo del giudizio di ottemperanza è quello di consentire alla parte vittoriosa di ottenere la soddisfazione concreta e completa del suo interesse, una volta intervenuto un provvedimento effettivamente favorevole dell’amministrazione tale giudizio avrà esaurito la sua funzione. L'art. 114, c. 3, del Codice, dispone che il giudice dell’esecuzione decide con sentenza in forma semplificata. Pertanto, la decisione dovrà essere motivata e tale motivazione potrà eventualmente consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero ad un precedente conforme. Queste indicazioni appaiono di non agevole trasponibilità alla sentenza di ottemperanza; il relativo giudice, essendo vocato ad integrare e precisare i precetti che serviranno per la corretta riedizione del potere, o a chiarire le precedenti statuizioni, non potrà indulgere ad un'eccessiva compressione della parte motiva. Se è chiesta l’esecuzione di un’ordinanza cautelare, l'art. 114, c. 5, dispone che il giudice provveda con ordinanza. Non è dubbio, in ogni caso, che nel momento in cui definisce il giudizio di ottemperanza il giudice debba anche provvedere sulle spese di lite; tale obbligo è infatti riconnesso all’emanazione di una qualunque “decisione”, non escluse pertanto quelle rese ai sensi dell’art. 114, c. 3 e 5, del Codice. Nulla osta peraltro ad ammettere che, in sede di ottemperanza, il giudice amministrativo, nel pronunciare sulle spese, possa condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente stabilita. L’art. 115, c. 1, del Codice prevede che le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite in forma esecutiva se una o più delle parti ne facciano richiesta. A norma del successivo c. 2 i provvedimenti del giudice amministrativo che dispongano il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del c.p.c. e per l’iscrizione di ipoteca. Il c. 3 chiarisce poi che ai fini del giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. La vigente disciplina autorizza l’esecuzione a norma del c.p.c. in via alternativa rispetto al giudizio di ottemperanza, ma solo per i provvedimenti che dispongano il pagamento di somme di denaro. Per ottenere l'adempimento degli obblighi di facere la strada dell’ottemperanza rimane obbligata. Da notare il netto superamento della disciplina in precedenza dettata dal regolamento di procedura, che ammetteva la spedizione in forma esecutiva unicamente per il capo di sentenza inerente alle spese. Rimangono ferme tutte le disposizioni che prevedono limiti, sostanziali o procedurali, all’esecuzione forzata civile. Pensiamo alla necessità di attendere i centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo che si assegna alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare “le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro”. Per quanto attiene ai contenuti della sentenza, questi corrispondono alla natura mista del giudizio di ottemperanza, che tende all’attuazione (non semplice esecuzione) del comando giudiziale. Nella sentenza possono coesistere elementi di cognizione (riferite all’accertamento dell’inadempimento imputabile all’amministrazione ed all’attività determinativa del giudice) e dell’esecuzione (riferite all’attività di realizzazione del precedente comando giudiziale sotto l’aspetto strettamente esecutivo). Ad essi si aggiungono i caratteri propri della giurisdizione di merito, essendo il giudice autorizzato alla produzione di nuovi effetti giuridici anche in via sostituiva rispetto alla p.a. inadempiente. L’ampiezza dei poteri del giudice dell’ottemperanza, è scolpita nella disposizione che ricomprende il giudizio stesso tra i casi della giurisdizione “estesa al merito” (art. 134, c. 1, lett. a) del Codice). Il Codice è preciso in ordine i poteri del giudice, poiché prevede che questi, in caso di accoglimento del ricorso in ottemperanza: - ordini l’ottemperanza del provvedimento giurisdizionale originario, prescrivendo le relative modalità; - nomini, ove occorra, un commissario ad acta; - salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e non sussistano altre ragioni ostative, fissi, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. L’aspetto saliente dello strumento (dell’ottemperanza) risiede nel potere di sostituzione del giudice; il quale, per rendere effettiva la tutela del ricorrente, può giungere fino all’adozione di atti amministrativi che comportino uso di discrezionalità amministrativa. I modi di esercizio dei poteri sostitutivi sono liberamente stabiliti dal giudice dell’ottemperanza. Questi potrebbe anche spingersi ad adottare direttamente i provvedimenti necessari al fine dell’integrale attuazione del provvedimento giurisdizionale ineseguito; potrebbe cioè, dopo aver eventualmente assegnato all’amministrazione un termine per adottare il provvedimento, sostituire de plano la propria decisione sull’assetto degli interessi a quella dell’amministrazione. Va tuttavia ricordato che in base all’art. 112, c. 5, del Codice il ricorso può essere proposto anche al solo fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza. In questo ambito, quindi, la componente cognitoria appare decisamente assorbente, mentre scompaiono le componenti dell’esecuzione e dell’ottemperanza. È da riconoscere quale legittimata all’azione, accanto al ricorrente ed al commissario ad acta, anche la stessa amministrazione, privilegiandosi ad un tempo la duplice esigenza di evitare errori in fase esecutiva e di prevenire nuove contestazioni ed impugnazioni ad opera del ricorrente vittorioso. A fronte della mera richiesta di chiarimenti da parte del ricorrente, il giudice non potrà spingersi sino al punto di esercitare i poteri sostituivi nei riguardi della parte pubblica, direttamente o tramite la nomina di un commissario ad acta (ove non ancora nominato). Tale approccio sarebbe contrario al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che, in quanto principio generale, è certamente applicabile al processo amministrativo in generale, ed al processo esecutivo in particolare, in virtù del “rinvio esterno”. 12. Le impugnazioni Fatti salvi i termini di ciascuno specifico mezzo di impugnazione, le regole del processo esecutivo si estendono in toto al giudizio di impugnazione; e in caso di assorbimento del rito esecutivo nel rito ordinario il relativo regime processuale opera anche nel giudizio di impugnazione. Il Codice non prevede limiti all’appellabilità delle sentenze emesse dai T.A.R. in sede di ottemperanza. Dato che il Codice implicitamente -ma senza deroghe- ammette l’impugnazione dei “provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza”, pare difficile negare il rimedio impugnatorio anche relativamente alle statuizioni meramente attuative della precedente sentenza, poiché esse partecipano pur sempre della natura giurisdizionale. Né può disconoscersi l'utilità di proporre un appello che ad es., pur a fronte di un contenuto “certo” della sentenza ineseguita, valga a consentire una rimeditazione del percorso esecutivo rimesso all’amministrazione, anche solo per motivi di opportunità, convenienza, economicità ed efficacia della sua azione. Avverso la sentenza pronunciata in sede di esecuzione si deve comunque ritenere ammissibile senza limiti l’opposizione di terzo. La relativa legittimazione dovrà riconoscersi in conformità delle previsioni dettate dall’art. 108, c. 1 e 2, del Codice. Le sentenze rese dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza sono soggette a ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. I soggetti legittimati a proporre ricorso per Cassazione sono, comunque, il privato e l’amministrazione soccombente, anche se diversa da quella competente ad emettere l’atto dovuto in esecuzione del giudicato. 13. Il commissario ad acta e la c.d. penalità di mora Prima dell’emanazione del Codice, e particolarmente nei casi in cui l’attuazione del giudicato avesse comportato esercizio di potere discrezionale, si è riscontrata una certa propensione dei giudici amministrativi a rifuggire dall’ipotesi della sostituzione diretta per fare invece luogo alla nomina di un commissario ad acta, figura di stretta costruzione giurisprudenziale abilitata a provvedere in luogo dell’amministrazione dopo i1 decorso del termine. Il commissario viene nominato solo “ove occorra” (art. 114, c. 4, lett. d). Ciò conferma che la nomina commissariale è una semplice facoltà del giudice, cui attingere in vicende complesse ed involgenti atti ampiamente discrezionali. Verso lo stesso obiettivo sembrerebbe convergere la previsione inerente alla determinazione giudiziale della somma di denaro dovuta dall’amministrazione per successive violazioni o ulteriori ritardi, ossia la penalità di mora di cui all’art. 114, c. 4, lett. e), del Codice. Questo rimedio, punta ad incrementare il livello di effettività della tutela e ad indurre l’amministrazione a prestare osservanza ‘spontanea’ al provvedimento esecutivo. Caratteri fondamentali del rimedio: a) è una misura sanzionatoria, estranea alla logica risarcitoria, non prefiggendosi la riparazione del pregiudizio cagionato dalla mancata o non corretta esecuzione della sentenza, bensì lo stimolo del debitore all’adempimento con l’irrogazione di una “pena”; b) ha, nel processo amministrativo, un ambito applicativo più esteso che nel processo civile, in quanto la lett. e) “non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile. La scelta appare coerente con il rilievo che il rimedio dell’ottemperanza, grazie al potere sostitutivo esercitabile, nell’alveo di una giurisdizione di merito, dal giudice in via diretta o mediante la nomina di un commissario ad acta, non conosce, in linea di principio, l’ostacolo della non surrogabilità degli atti necessari al fine di assicurare l’esecuzione in re del precetto giudiziario”. Questa norma non intende porre rimedio alla non diretta coercibilità degli obblighi di condotta sanciti dal giudice, come nel sistema processualcivilistico, ma punta a far cessare il comportamento inottemperante del debitore. La scelta della persona del commissario non è ancorata a vincoli precisi. Il legislatore rimette al giudice dell’ottemperanza un ampio spazio valutativo nell’individuare la persona più idonea a ricoprire l’incarico commissariale. Frequente è stata, in passato, anche la nomina a commissario di un soggetto facente parte della stessa amministrazione inadempiente. Esigenze di imparzialità suggerirebbero tuttavia, ove la nomina investisse la dirigenza pubblica, di affidare l’incarico a soggetto appartenente ad un’amministrazione diversa da quella inottemperante. La giurisprudenza ammette che il commissario ad acta possa avvalersi di collaboratori per lo svolgimento dei propri incombenti, riconoscendogli una certa autonomia di scelta. Il compito del commissario ad acta consiste nell’adozione di quei provvedimenti amministrativi che si rendano necessari o per riempire il vuoto conseguente all’inerzia dell’amministrazione o per sostituire l’attività posta in essere da quest’ultima, quando non corrispondente alla piena ed esatta realizzazione del dictum sostanziale contenuto nel provvedimento giurisdizionale ineseguito, così come eventualmente precisato e specificato nella pronuncia di ottemperanza. A tale fine il commissario segue le direttive del giudice dell’ottemperanza, potendo ricavare le prescrizioni operative sia dal provvedimento giurisdizionale rimasto ineseguito sia dal provvedimento (sentenza o ordinanza) del giudice dell’ottemperanza. Quindi, all’attività del commissario si riconosce la funzione strumentale di adeguamento della realtà materiale e giuridica alle statuizioni contenute nel provvedimento esecutivo; trattasi, infatti, di quella stessa attività che il giudice dell’ottemperanza, in via di sostituzione dell’amministrazione, avrebbe avuto il potere di porre in essere direttamente. Il costante orientamento qualifica il termine assegnato dal giudice al commissario ad acta per dare concreta attuazione al giudicato come non perentorio, sicché il suo eventuale spirare non provoca decadenza del nominato dai poteri commissariali. Il commissario è organo ausiliario del giudice. Il ricorrente, laddove intenda contestare gli atti commissariali, dovrà farlo dinanzi allo stesso giudice dell’ottemperanza, per il principio generale secondo il quale l’organo legittimato ad avere cognizione sugli incidenti verificatisi in sede di esecuzione è lo stesso che la dirige. Le decisioni commissariali, possono essere contestate dalle parti mediante reclamo, che va notificato ai controinteressati e depositato nella Segreteria del giudice dell’ottemperanza nel termine di 60 giorni. Il Codice ha privilegiato la soluzione del ricorso in sede di cognizione ordinaria da parte del terzo pregiudicato dagli atti commissariali. È lo stesso art. 114, c. 6, così come riformulato dal d.lgs. 195/2011, a stabilire che “gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato con il rito ordinario”. Tale impostazione non pare invero perfettamente coincidente con le esigenze di concentrazione pur contemplate dal Codice. Tanto più che essa, spezzando l’originario nesso di ausiliarietà, potrebbe giustificare una dispersione tra i vari T.A.R. delle impugnative dei diversi atti commissariali, ove aventi efficacia territoriale distinta. Il finalismo precipuo del rimedio esecutivo, posto a presidio del supremo valore dell’effettività esecutiva della tutela giurisdizionale, merita di essere perseguito anche al cospetto di un’eventuale inerzia serbata dal Commissario ad acta. Ne consegue l’attivabilità del reclamo al collegio anche in tale eventualità, se del caso su iniziativa della stessa amministrazione, alla quale la situazione di stallo potrebbe nuocere non meno che al ricorrente. Inoltre una simile condotta del commissario potrà essere anche valutata ai fini di una sua sostituzione; potere rispetto al quale il giudice dell’ottemperanza, anche se non sollecitato dalle parti, non sembra incontrare specifici limiti normativi. Non può escludersi che gli atti del commissario siano ra