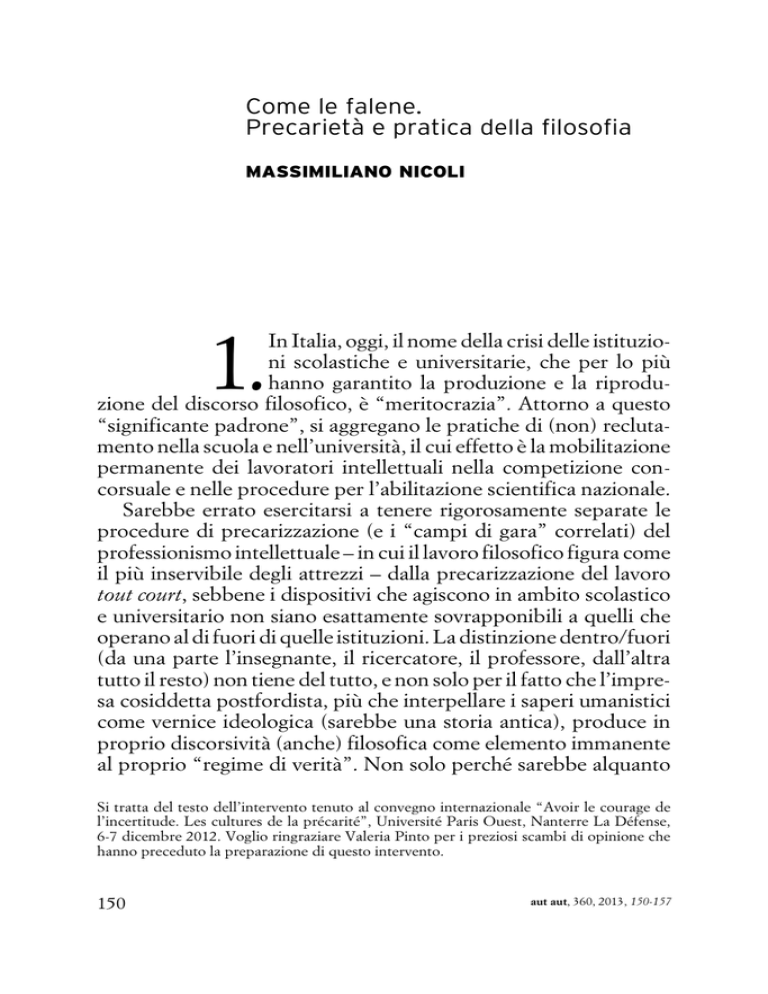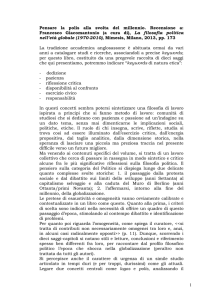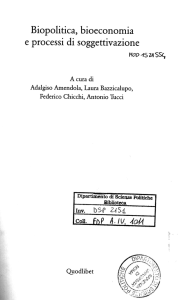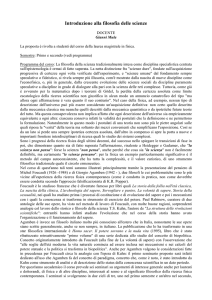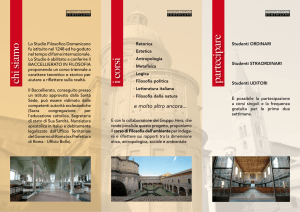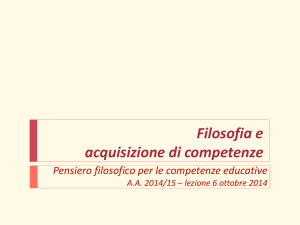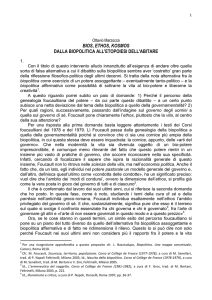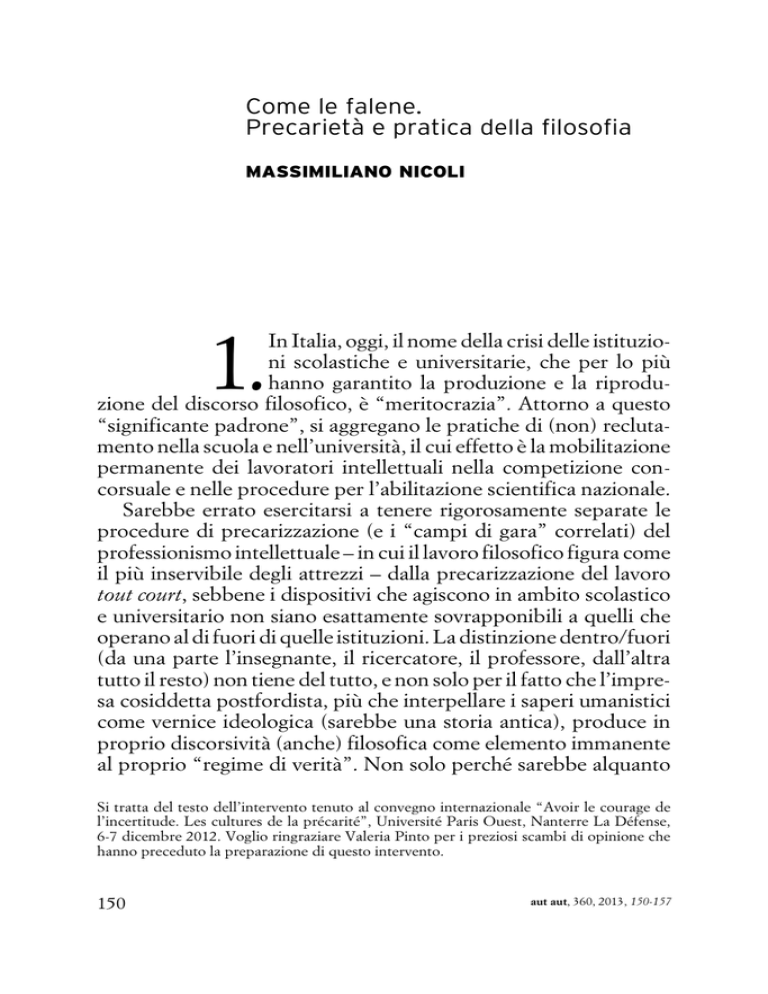
Come le falene.
Precarietà e pratica della filosofia
MASSIMILIANO NICOLI
1.
In Italia, oggi, il nome della crisi delle istituzioni scolastiche e universitarie, che per lo più
hanno garantito la produzione e la riproduzione del discorso filosofico, è “meritocrazia”. Attorno a questo
“significante padrone”, si aggregano le pratiche di (non) reclutamento nella scuola e nell’università, il cui effetto è la mobilitazione
permanente dei lavoratori intellettuali nella competizione concorsuale e nelle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale.
Sarebbe errato esercitarsi a tenere rigorosamente separate le
procedure di precarizzazione (e i “campi di gara” correlati) del
professionismo intellettuale – in cui il lavoro filosofico figura come
il più inservibile degli attrezzi – dalla precarizzazione del lavoro
tout court, sebbene i dispositivi che agiscono in ambito scolastico
e universitario non siano esattamente sovrapponibili a quelli che
operano al di fuori di quelle istituzioni. La distinzione dentro/fuori
(da una parte l’insegnante, il ricercatore, il professore, dall’altra
tutto il resto) non tiene del tutto, e non solo per il fatto che l’impresa cosiddetta postfordista, più che interpellare i saperi umanistici
come vernice ideologica (sarebbe una storia antica), produce in
proprio discorsività (anche) filosofica come elemento immanente
al proprio “regime di verità”. Non solo perché sarebbe alquanto
Si tratta del testo dell’intervento tenuto al convegno internazionale “Avoir le courage de
l’incertitude. Les cultures de la précarité”, Université Paris Ouest, Nanterre La Défense,
6-7 dicembre 2012. Voglio ringraziare Valeria Pinto per i preziosi scambi di opinione che
hanno preceduto la preparazione di questo intervento.
150
aut aut, 360, 2013, 150-157
discutibile identificare nel campo degli studi critici e filosofici un
fortino di resistenza aggredito, nelle sue fondamenta materiali,
dalla precarietà; essendo, forse, la figura dell’intellettuale come
free-rider narcisista e competitivo che abita in quel fortino una delle
ipostatizzazioni antropologiche verso cui tende la precarizzazione
del lavoro in generale. Il punto è, piuttosto, l’affinità degli effetti
di soggetto che le tecniche di precarizzazione producono – o
rinforzano – in termini di gestione imprenditoriale della propria
esistenza all’interno di ogni figura concreta del lavoro, come cascame – tutt’altro che secondario – delle procedure di oggettivazione
e soggettivazione degli individui attraverso pratiche professionali,
o per lo meno intenzionate alla produzione di reddito via lavoro.
Il campo di analisi della biopolitica aperto da Foucault ci offre
un’abbondanza di strumenti critici per leggere il testo delle tecnologie governamentali neoliberali nel senso della costituzione,
da parte di queste tecnologie, di “realtà di transazione”1 (come la
nozione di “società civile”, e prima ancora di “follia” e “sessualità”)
su cui agire per governare le condotte degli individui, arretrando
rispetto alla “tecnologia umana” dei sistemi normativi e disciplinari.2 In questo senso, l’allestimento di un “mondo del lavoro”
(ecco un’altra realtà di transazione) iper-flessibile appare come
l’episodio postfordista di una “tecnologia ambientale” che lavora
attorno all’individuo per organizzare il campo delle sue condotte
possibili. Il lavoro precarizzato come gigantesca palestra in cui
allenarsi alla flessibilità, in cui esercitarsi senza sosta lungo una
verticalità ascetica che punta a quel business della soggettività che
Sloterdijk chiama – icasticamente – “Io S.p.A.”.3 L’individuo imprenditore di se stesso che impiega ogni goccia del proprio tempo
di vita per valorizzare il proprio “capitale umano” non è solo un
attore che si rassegna al ricatto che la sua epoca gli impone, non
è solo un cinico opportunista, non è uno spietato individualista
1. M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France 1978-1979 (2004),
trad. di M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2007, p. 242.
2. Ivi, pp. 215-216.
3. P. Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica (2009), trad. di S. Franchini,
Raffaello Cortina, Milano 2010, p. 404.
151
impregnato di ideologia aziendalista e manageriale, è piuttosto
un trainee (un soggetto in allenamento) che produce attivamente
il proprio supplemento d’anima attraverso i veritativi pacchetti
di fitness auto-imprenditoriale che l’organizzazione flessibile del
mondo (del lavoro) gli pone a generosa disposizione. Mi pare evidente che questa cornice biopolitica inquadra oggi il lavoro prima
e oltre ogni concrezione determinata, essendo l’esercizio alla precarietà il lavoro che ciascuno è sollecitato a svolgere sulla propria
soggettività: una nuova specie di lavoro astratto che funziona come
causa immanente di ogni lavoro concreto, più che come astrazione
di quest’ultimo, e che, come tale, sfugge a ogni misura.4 Mi pare
altrettanto evidente che chi si occupa di filosofia professionalmente – o vorrebbe farlo – non può certo chiamarsi fuori da questo
quadro, sia che batta e ribatta sulle pareti di istituzioni marcescenti
ma geometriche nel loro agire precarizzante, sia che pratichi un
difficile – per esprimersi eufemisticamente – dentro/fuori fra quelle
istituzioni (precarizzanti ma piene di Gattungswesen) e lavoro en
général (precario e basta).
Ora, pure in questa scena biopolitica che produce effetti soggettivi di gestione manageriale della propria esistenza (il “divenire
impresa del soggetto” per fare il verso a Deleuze) per il tramite di realtà ambientali opportunamente costituite e governate, è possibile
– credo – identificare tecnologie di individualizzazione – forse, persino, a connotazione disciplinare, seppure in un senso esteso e da
approfondire –, che consentono al potere di transitare a doppio
senso di marcia fra il piano biopolitico di regolazione del mondo
del lavoro e il piano anatomo-politico dei corpi individuali. Qui, a
livello di queste tecnologie, la proceduralità della precarizzazione
che investe la pratica professionale della filosofia si fa specifica e
chiama in causa la questione dell’accesso al campo della visibilità intellettuale. Se i dispositivi di precarizzazione del professionismo
intellettuale non sono perfettamente sovrapponibili a quelli che
4. Infatti, non è retribuito. Ecco un’altra ottima ragione – se ce ne fosse ancora bisogno –
per rivendicare il reddito di esistenza, anche se, posta in questi termini, la questione assomiglia
più a una retribuzione per il proprio assoggettamento. “Reddito di assoggettamento”: non è
un gran titolo per un programma di rivendicazione politica.
152
organizzano il lavoro nell’impresa postfordista – fermi restando i medesimi effetti di soggetto – è perché, almeno per ora e
quanto meno in Italia, le pratiche confessionali di produzione di
soggettività auto-imprenditoriale tipiche dello Human Resource
Management, per fare un esempio,5 attualmente temporeggiano
di fronte ai bastioni della ricerca filosofica. A questo esitare, del
resto, corrispondono altre tattiche, a cui ora tenterò di fare cenno.
2. Torniamo alla questione della meritocrazia che infarcisce il discorso pubblico inerente alle riforme della scuola e dell’università
italiane. Data la scarsissima probabilità di ottenere un posto di
lavoro attraverso le “meritocratiche” procedure di reclutamento
stabilite dalle recenti riforme (l’oggettiva rareté di posti rende
la roulette francese un azzardo più remunerativo), l’effetto più
significativo di queste procedure va cercato sul piano delle trasformazioni soggettive che esse implicano. Sia che partecipi alle
prove di selezione per la scuola secondaria, sia che aspiri a conseguire l’abilitazione scientifica che consentirebbe l’esercizio della
professione universitaria, ogni “filosofo precario” partecipa oggi
a quella enorme “volontà di valutare” che anima il discorso e le
pratiche della meritocrazia.6
Da un lato, la situazione di esame e competizione permanenti
in cui si colloca chi si immette all’interno degli attuali dispositivi
di valutazione/selezione produce un’oggettivazione espropriante
del sapere di ciascuno in prodotti scientifici valutabili e misurabili
che oblitera tutto ciò che eccede quella oggettivazione, secondo
l’antica tradizione taylorfordista di cattura e privatizzazione del
general intellect generato nelle fucine della produzione. Dall’altro
– questa la novità –, la volontà di valutare fornisce in cambio una
soggettivazione ipertrofica degli individui esaminati in termini di
riconoscimento e visibilità del proprio lavoro, a patto che esso corrisponda alla norma della valutazione. Il postfordismo applicato
5. Cfr. M. Nicoli, Io sono un’impresa. Biopolitica e capitale umano, “aut aut”, 356, 2012.
6. Per una critica della cultura della valutazione rimando a V. Pinto, Valutare e punire,
Cronopio, Napoli 2012.
153
alla scena degli operatori intellettuali gioca all’interno di questo
proficuo paradosso: l’esame che normalizza porta in dono la luce,
e all’omologazione dei saperi corrisponde un campo di differenziazione degli individui lungo le polarità del visibile (per chi vince
la competizione) e dell’invisibile (per chi soccombe).
Ci si potrebbe applicare a riconoscere i tratti disciplinari e normalizzanti7 – la tecnologia umana – che caratterizzano queste (bio)
politiche della valutazione: una ripartizione degli individui nello
spazio che, attraverso il fantasma di una job position, li distribuisce
nel territorio nazionale o nello spazio sovranazionale della ricerca
globalizzata, secondo un preciso quadrillage scolastico o accademico; la costituzione di un tempo (di lavoro e di vita) frenetico,
pieno, compatto, di cui è obbligatorio capitalizzare ogni istante
(nulla dies sine linea) per esercitarsi alla propria competitività
intellettuale; l’allestimento di un campo di sorveglianza disseminata e di esame ininterrotto che lavora sulla pulsione scopica di
ciascuno esaltando le dimensioni dell’essere-guardati come oggetti
accademicamente seducenti e del guardare l’altro come competitor
le cui mosse vanno costantemente monitorate. Infine, si potrebbe
considerare l’insieme delle pratiche di valutazione come una sorta
di “macchina ottica”8 che, oltre a influire in maniera decisiva sulla
costituzione dei soggetti della ricerca, stabilisce le soglie minime
di visibilità degli oggetti di cui è possibile parlare nell’ambito del
discorso filosofico, oltre che il tipo di linguaggio che è opportuno
maneggiare. Ecco, forse, un altro episodio storico in cui delle
pratiche di potere – in questo caso la volontà di valutare – definiscono l’articolazione possibile fra visibile e dicibile e i processi di
oggettivazione e soggettivazione nel campo del sapere.
L’alternativa più remunerativa a questo rimbalzare, come le
falene, contro il faro panottico della valutazione meritocratica
7. Attualità di Sorvegliare e punire: potrebbe essere il titolo di un programma di ricerca
che si proponga di analizzare le trasformazioni – le avventure – del potere disciplinare in
una società in cui forse solo apparentemente ne rimangono poche tracce. Cfr. M. Foucault,
Sorvegliare e punire. Nascita della prigione (1975), trad. di A. Tarchetti, Einaudi, Torino 1993.
8. Cfr. G. Deleuze, Foucault (1986), trad. di P.A. Rovatti e F. Sossi, Cronopio, Napoli
20022, pp. 69-95.
154
sembra essere il tentativo di capitalizzare la riflessione critica
all’interno dei sistemi comunicativi dell’industria culturale e di
quel populismo filosofico a tonalità televisiva e spettacolare che
in questa sede non è possibile trattare, ma di cui da più parti si
colgono i segnali: il proliferare delle kermesse filosofiche; i nuovi
realismi pronti a conferire un ulteriore supplemento di potere alla
governamentalità tecnica che proprio alla realtà inemendabile della
crisi fa appello per conservare intatto l’esistente; oppure, per fare
un esempio interno al campo delle mie ricerche, l’uso delle analisi
foucaultiane sulla biopolitica come strumento di fluidificazione
delle tecnologie di potere nelle organizzazioni aziendali o, più
in grande, come belletto ideologico della razionalità di governo
neoliberale.
In ogni caso, laddove la precarizzazione del lavoro dentro e
fuori il professionismo intellettuale costituisce il campo di gara
in cui gli individui competono esercitandosi alla propria autovalorizzazione, il regime di visibilità istituito dalle pratiche di esame
e valutazione offre il correlato individualizzante che istruisce, a
livello microfisico, la cura di sé come impresa di vita a gestione
manageriale, il cui business plan prevede, oltre al fantasma di un
reddito stabile o di una corona da intellettuale, un assoggettamento
senza fine né pause.
3. Nel 1970, in un’intervista, Foucault ha detto:
Non sono sicuro, sapete, che la filosofia esista. Ciò che esiste
sono dei “filosofi”, vale a dire una certa categoria di persone
le cui attività e i cui discorsi sono molto cambiati di epoca in
epoca. Ciò che li distingue, come i loro vicini, i poeti e i folli, è
la partizione che li isola, e non l’unità di un genere o la costanza
di una malattia.
È da ben poco tempo che sono diventati tutti professori. Forse
non è che un episodio, forse ne avremo ancora per molto.9
9. M. Foucault, Le piège de Vincennes, intervista a “Le Nouvel Observateur” (1970),
in Dits et écrits, Gallimard, Paris 2001, vol. I, p. 938.
155
Dopo aver detto addio, per precisi motivi teorici e politici, all’intellettuale universale di sartriana memoria, oggi anche la figura
di intellettuale specifico proposta da Foucault vacilla sul piano
dell’agibilità materiale, in virtù dei processi di precarizzazione e
omologazione del lavoro critico che ho tentato di segnalare. Forse
dobbiamo iniziare a congedarci anche dalla figura del professore,
laddove coincidere con quella figura significa partecipare alla
meccanica di dispositivi che riproducono precarietà e cattura
imprenditoriale della propria vita.
Il terreno della scuola e dell’università mi pare un campo in
cui l’esito della battaglia che si può combattere è pregiudicato.
Lungi dal proporre scelte di purezza intellettuale, il punto è che –
generalmente – ci si rapporta ai dispositivi scolastici e accademici
come oggetti di mera conoscenza rispetto ai quali sarebbe facile e
immediato mantenere l’esteriorità e la distanza della critica, pur
partecipando direttamente al loro funzionamento, e dando contemporaneamente per scontata la costituzione del soggetto conoscente. Ci si immagina, cioè, come puro sguardo senza corpo, che,
in quanto tale, non può essere guardato né tanto meno, in quanto
soggetti incorporei, si può essere investiti dalle stesse pratiche che
si vorrebbero conoscere e criticare. Questa, piuttosto, mi sembra
una posizione di purezza e innocenza intellettuali.
La postura critica di cui abbiamo bisogno si colloca forse lungo
il bordo delle istituzioni, in uno spazio mobile e di oscillazione che
ci consenta di suscitare un nuovo gioco di verità: alterare l’oggetto
del discorso filosofico, spostandone il fuoco verso le sue stesse
condizioni di (im)possibilità (per esempio: precarizzazione e valutazione meritocratica) e sperimentare i modi di soggettivazione
che si rendono possibili attraverso quel gesto di oggettivazione.
Che tipo di soggetto può generarsi – che tipo di pratica della
filosofia può cominciare – quando l’oggetto della riflessione
critica diventa una diagnosi spietata delle pratiche di vita autoimprenditoriali che ci fanno essere ciò che siamo? Poco o nulla
ne potrà venire, se questo esercizio critico dovesse rimanere
inchiodato sul piano del sapere senza coinvolgere la dimensione
etica del saperci fare con quel sapere, senza accompagnarsi a un
156
atteggiamento teorico e pratico di radicale messa in discussione
della necessità intrinseca di ogni potere,10 che conduca, nel nostro
caso, alla “scoperta” della non-necessità e della fragilità storica
delle pratiche di valutazione meritocratica. Nulla di nuovo sotto il cielo della filosofia, se questo lavoro diagnostico dovesse
puntare – immer wieder – alla sua oggettivazione in un prodotto
scientifico ad alto coefficiente di visibilità. Diversamente, se quel
“coraggio della verità”, che secondo Foucault percorre come un
fiume carsico la storia della filosofia e delle sue pratiche,11 dovesse
riuscire ad affiorare nella tenebra della nostra impasse, mandando
in cortocircuito discorso critico e stile di vita, allora, forse, i nostri
discorsi, le nostre attività, quella partizione che ci isola rendendoci
simili ai folli e ai poeti, potrebbero iniziare a cambiare un’altra
volta. Mi sembra la condizione preliminare, la cui realizzazione
compete a ognuno di noi, per cominciare ad auto-organizzare
altrimenti il nostro lavoro, a costruire istituzioni in comune dal
basso del nostro suolo precario, a inventare quello che ancora non
c’è, o forse e più modestamente, a intravedere ciò di cui ancora
non riusciamo a parlare.
10. Cfr. Id., Du gouvernement des vivants. Cours au Collège de France 1979-1980, SeuilGallimard, Paris 2012, pp. 75-77.
11. Cfr. Id., Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de
France 1984 (2009), trad. a cura di M. Galzigna, Feltrinelli, Milano 2011.
157