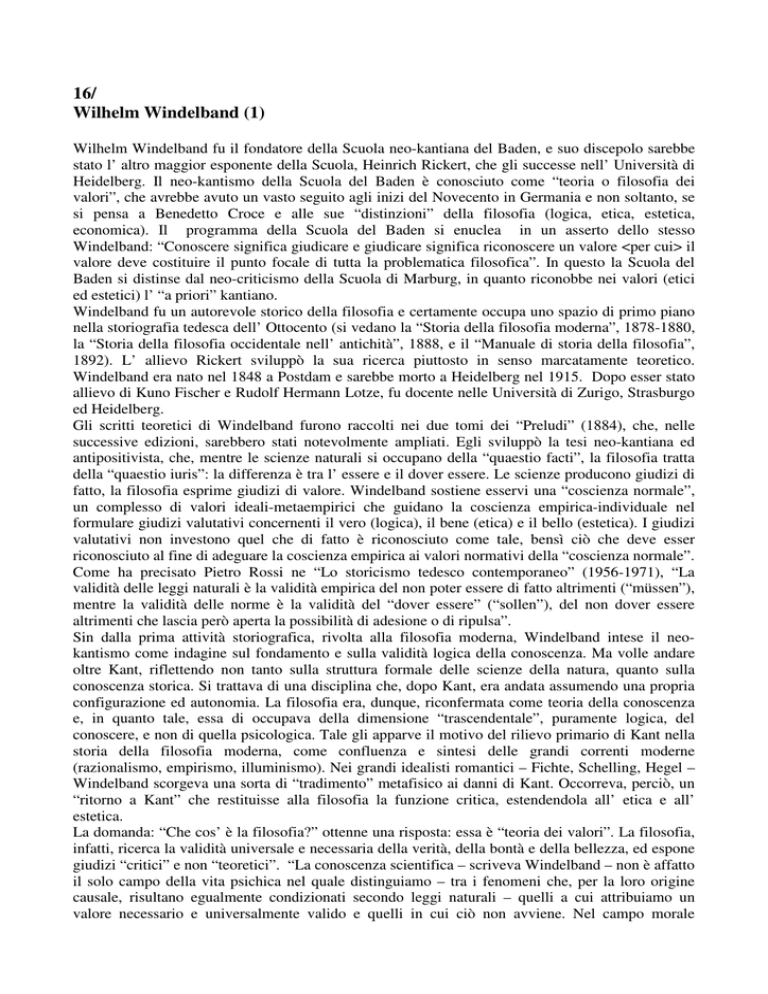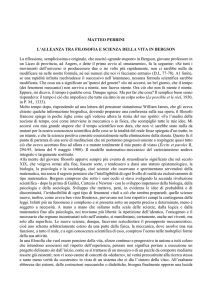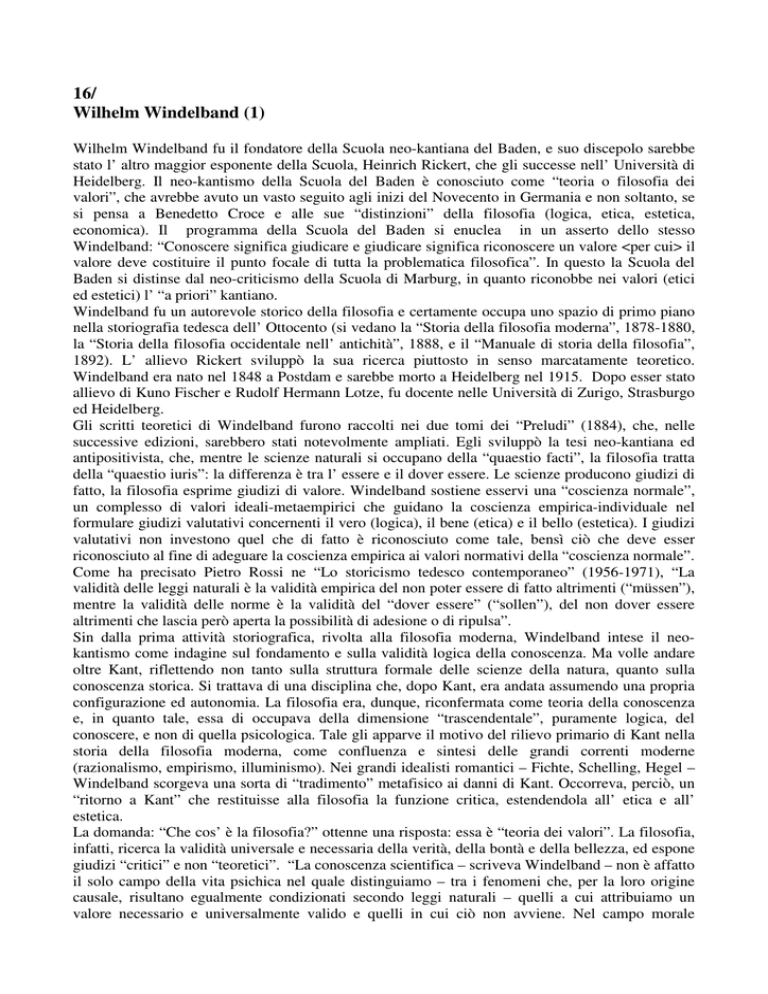
16/
Wilhelm Windelband (1)
Wilhelm Windelband fu il fondatore della Scuola neo-kantiana del Baden, e suo discepolo sarebbe
stato l’ altro maggior esponente della Scuola, Heinrich Rickert, che gli successe nell’ Università di
Heidelberg. Il neo-kantismo della Scuola del Baden è conosciuto come “teoria o filosofia dei
valori”, che avrebbe avuto un vasto seguito agli inizi del Novecento in Germania e non soltanto, se
si pensa a Benedetto Croce e alle sue “distinzioni” della filosofia (logica, etica, estetica,
economica). Il programma della Scuola del Baden si enuclea in un asserto dello stesso
Windelband: “Conoscere significa giudicare e giudicare significa riconoscere un valore <per cui> il
valore deve costituire il punto focale di tutta la problematica filosofica”. In questo la Scuola del
Baden si distinse dal neo-criticismo della Scuola di Marburg, in quanto riconobbe nei valori (etici
ed estetici) l’ “a priori” kantiano.
Windelband fu un autorevole storico della filosofia e certamente occupa uno spazio di primo piano
nella storiografia tedesca dell’ Ottocento (si vedano la “Storia della filosofia moderna”, 1878-1880,
la “Storia della filosofia occidentale nell’ antichità”, 1888, e il “Manuale di storia della filosofia”,
1892). L’ allievo Rickert sviluppò la sua ricerca piuttosto in senso marcatamente teoretico.
Windelband era nato nel 1848 a Postdam e sarebbe morto a Heidelberg nel 1915. Dopo esser stato
allievo di Kuno Fischer e Rudolf Hermann Lotze, fu docente nelle Università di Zurigo, Strasburgo
ed Heidelberg.
Gli scritti teoretici di Windelband furono raccolti nei due tomi dei “Preludi” (1884), che, nelle
successive edizioni, sarebbero stati notevolmente ampliati. Egli sviluppò la tesi neo-kantiana ed
antipositivista, che, mentre le scienze naturali si occupano della “quaestio facti”, la filosofia tratta
della “quaestio iuris”: la differenza è tra l’ essere e il dover essere. Le scienze producono giudizi di
fatto, la filosofia esprime giudizi di valore. Windelband sostiene esservi una “coscienza normale”,
un complesso di valori ideali-metaempirici che guidano la coscienza empirica-individuale nel
formulare giudizi valutativi concernenti il vero (logica), il bene (etica) e il bello (estetica). I giudizi
valutativi non investono quel che di fatto è riconosciuto come tale, bensì ciò che deve esser
riconosciuto al fine di adeguare la coscienza empirica ai valori normativi della “coscienza normale”.
Come ha precisato Pietro Rossi ne “Lo storicismo tedesco contemporaneo” (1956-1971), “La
validità delle leggi naturali è la validità empirica del non poter essere di fatto altrimenti (“müssen”),
mentre la validità delle norme è la validità del “dover essere” (“sollen”), del non dover essere
altrimenti che lascia però aperta la possibilità di adesione o di ripulsa”.
Sin dalla prima attività storiografica, rivolta alla filosofia moderna, Windelband intese il neokantismo come indagine sul fondamento e sulla validità logica della conoscenza. Ma volle andare
oltre Kant, riflettendo non tanto sulla struttura formale delle scienze della natura, quanto sulla
conoscenza storica. Si trattava di una disciplina che, dopo Kant, era andata assumendo una propria
configurazione ed autonomia. La filosofia era, dunque, riconfermata come teoria della conoscenza
e, in quanto tale, essa di occupava della dimensione “trascendentale”, puramente logica, del
conoscere, e non di quella psicologica. Tale gli apparve il motivo del rilievo primario di Kant nella
storia della filosofia moderna, come confluenza e sintesi delle grandi correnti moderne
(razionalismo, empirismo, illuminismo). Nei grandi idealisti romantici – Fichte, Schelling, Hegel –
Windelband scorgeva una sorta di “tradimento” metafisico ai danni di Kant. Occorreva, perciò, un
“ritorno a Kant” che restituisse alla filosofia la funzione critica, estendendola all’ etica e all’
estetica.
La domanda: “Che cos’ è la filosofia?” ottenne una risposta: essa è “teoria dei valori”. La filosofia,
infatti, ricerca la validità universale e necessaria della verità, della bontà e della bellezza, ed espone
giudizi “critici” e non “teoretici”. “La conoscenza scientifica – scriveva Windelband – non è affatto
il solo campo della vita psichica nel quale distinguiamo – tra i fenomeni che, per la loro origine
causale, risultano egualmente condizionati secondo leggi naturali – quelli a cui attribuiamo un
valore necessario e universalmente valido e quelli in cui ciò non avviene. Nel campo morale
ricorriamo al medesimo valore, del tutto indipendente dal modo di origine psicologica, per valutare
le azioni, le intenzioni e i caratteri come buoni o cattivi; e nel campo estetico ricorriamo ad esso per
quei particolari sentimenti che, senza alcun riferimento a uno scopo o a un interesse consapevole,
caratterizzano il loro oggetto come gradevole o sgradevole. In entrambi i campi spetterà dunque alla
filosofia un compito del tutto parallelo a quello della teoria della conoscenza, cioè il compito di
indagare con quale diritto queste pretese siano avanzate. Anche qui si tratta non già di una “questio
facti”, bensì di una “quaestio iuris”. In virtù di questa generalizzazione la filosofia “critica” appare
come la scienza delle determinazioni necessarie e universali di valore. Essa indaga se vi sia una
scienza, cioè un pensiero che possegga con validità universale e necessaria il valore della verità;
indaga se vi sia una morale, cioè un volere e un agire che posseggano con validità universale e
necessaria il valore del bene; indaga se vi sia un’ arte, cioè un intuire e un sentire che posseggano
con validità universale e necessaria il valore della bellezza. In tutti questi tre settori la filosofia non
si pone di fronte al suo oggetto (e perciò nel primo campo, ossia in quello teoretico, anche dinnanzi
alla scienza) come le altre scienze di fronte ai loro oggetti particolari, bensì si pone criticamente,
cioè in maniera da mettere alla prova il materiale del pensiero, della volontà, del sentimento rispetto
allo scopo della validità universale e necessaria, e da separare e da rifiutare ciò che non regge
dinanzi a questa prova”.
La filosofia è, dunque, “scienza critica dei valori universalmente validi” : “Ovunque – scrive
Windelband – la coscienza empirica scopre in sé questa necessità ideale di ciò che deve valere
universalmente, essa si incontra con una “coscienza normale”, la cui essenza “per noi” consiste nel
fatto che siamo convinti che essa deve essere reale indipendentemente dalla realtà che riveste nello
svolgimento della coscienza empirica, sottoposto alla necessità naturale. Per quanto piccoli siano il
grado e la misura in cui tale coscienza normale penetra la coscienza empirica e si fa valere all’
interno di questa, ciononostante tutte le valutazioni logiche, etiche ed estetiche sono formulate in
base alla convinzione che vi sia una coscienza normale, alla quale dobbiamo elevarci se le nostre
valutazioni debbono pretendere una validità universale necessaria: una coscienza normale che non
vale nel senso di un riconoscimento di fatto, ma che deve valere – e che perciò costituisce non già
una realtà empirica, bensì un ideale in base al quale dev’ essere misurato il valore di ogni realtà
empirica. Le leggi di questa “coscienza in generale” – secondo l’ espressione kantiana – non sono
più leggi naturali, che valgono in tutte le circostanze e a cui i singoli fatti debbono necessariamente
conformarsi, ma sono invece norme che debbono appunto valere, e la cui realizzazione determina il
valore della realtà empirica” (“Präludien”).
La filosofia si definisce come l’ indagine della “coscienza normale”, di quel presupposto che sta
“alla base di tutta la vita scientifica, etica ed estetica”, e che “gli individui debbono riconoscere al di
sopra di sé come norma valida”. Penetrando nella coscienza empirica e individuale, la filosofia vi
cerca ciò che sfugge alla necessità naturale: un “sistema di norme” oggettivamente valide.
Insomma, “La filosofia è la scienza dei principî della valutazione assoluta”. Al fondamento dell’
agire e dell’ operare dei singoli esseri umani, vi è un “sostrato” normativo, costituito da valori la cui
validità è incondizionata. L’ insieme, il complesso di tali valori è la “coscienza normale”.
La filosofia diventa “teoria dei valori”. Ed a questo punto, come ha scritto Pietro Rossi, dal punto
di vista di Windelband, è chiaro che “Le leggi naturali appartengono alla ragione giudicante, le
norme alla ragione valutante”. I valori, che confluiscono in sistema nella “coscienza normale”,
posseggono una validità ideale, universale e necessaria, che stabilisce il valore di quel che è
empirico. Essi sono prescrizioni e pertanto sono estranei alla necessità causale propria delle scienze
della natura.
Se la filosofia è “teoria dei valori”, essa rivela un’ estensione più ampia della teoria della
conoscenza. O meglio: la teoria della conoscenza non è che un’ area parziale della teoria dei valori.
Ora, è evidente che “la teoria della conoscenza diventa un settore specifico della teoria dei valori. E
la sua funzione sarà quindi quella di stabilire quali siano i valori che stanno a fondamento del
conoscere, come la funzione di una teoria della moralità o dell’ arte sarà quella di porre in luce i
valori che presiedono a questi altri settori dell’ attività umana. Tuttavia ciò non conduce a una
trasformazione del tipo di indagine critica a cui il neocriticismo si era attenuto; si ha soltanto un’
estensione dell’ ambito di tale indagine. Permane cioè, in Windelband, l’ isolamento di un piano di
pura validità logica – il piano trascendentale – al quale la teoria della conoscenza si riferisce,
prescindendo dalla considerazione dell’ aspetto psicologico dell’ attività umana. Solo che il piano
della validità logica viene inteso ora come un settore particolare di una sfera più ampia, la sfera
della validità normativa che costituisce la “coscienza normale”, e viene qualificato di conseguenza
come il piano di sussistenza dei valori” (Pietro Rossi). E se anche i valori non trovano traduzione e
realizzazione empirica nell’ agire individuale, essi conservano comunque la loro validità
incondizionata.
Definendo la filosofia come “Teoria dei valori”, Windelband trascurò per un certo tempo la
questione iniziale: lo statuto della conoscenza storica. La storia della filosofia gli appariva
strettamente empirica, legata ai fatti, e la conoscenza storica sembrava, comunque, nient’ altro che
constatazione. Ma distinse, poi, tra l’ aspetto empirico della storia della filosofia – che concerne le
tesi e le argomentazioni dei singoli filosofi, quel che essi hanno detto – e la sua dimensione
“razionale”, che verte invece sui problemi e sulle direttrici delle risposte date loro. Andavano
emergendo, di fronte a Windelband, questioni e problemi teoretici e pratici che acquisivano una loro
“storicità”, un loro forte legame con il progresso culturale-politico-sociale. Certo, in questo modo,
avvertiva una corrente sotterranea e strutturale che innervava la storia del pensiero dei singoli
filosofi, ma non approdò ancora all’ analisi della conoscenza storica. Come ha scritto Pietro Rossi,
“La distinzione tra un aspetto empirico e un aspetto razionale della storia della filosofia rappresenta
non già una rivalutazione del corso storico, da indagare nella complessità del suo divenire, ma
piuttosto una maniera di isolare un certo aspetto dello sviluppo della filosofia e di determinare in
esso – al di sopra della contingenza del succedersi temporale dei filosofi – l’ oggetto autentico della
storiografia filosofica. E la stessa affermazione dell’ indispensabilità della storia della filosofia per
la filosofia non diventa coscienza dell’ intrinseco carattere storico della filosofia – e quindi
acquisizione di una nuova dimensione della ricerca; essa indica soltanto il bisogno di una reciproca
cooperazione”.
Fu il confronto con la “critica della ragione storica” di Wilhelm Dilthey e con la sua distinzione tra
“scienze della natura” e “scienze dello spirito”, a provocarlo, inducendolo ad una analisi della
conoscenza storica per definirne la validità e lo specifico metodo. Interpretando in modo unilaterale
la distinzione diltheyana come una “antitesi oggettiva”, che nascondeva una “dualità metafisica”,
(Spirito e Natura), Windelband volle calcare l’ accento sul metodo. Non vi sono due “regni” della
realtà, su cui convergano altrettante scienze, ma vi sono due possibili approcci alla realtà, nella sua
unità: uno che bada alle “regolarità” di connessione tra i fenomeni; l’ altro che mira a intendere i
fatti singoli nella loro individualità. Le “scienze nomotetiche” cercano leggi, regolarità (così è per il
procedimento generalizzante dalla scienza). Le “scienze idiografiche” sondano, invece, singoli
avvenimenti e il loro è un “procedimento individualizzante”. La conoscenza storica diventava
scienza idiografica. Avviare un’ indagine metodologica che stabilisse la reciproca autonomia tra i
due ordine di scienze e fondasse la loro rispettiva validità logica, sarebbe stato il compito del
discepolo Heinrich Rickert.
17/
Wilhelm Windelband (2)
Wilhelm Windelband impresse al neo-criticismo tedesco del secondo Ottocento una forte
attenzione per la specificità, la possibilità e il fondamento della validità oggettiva di quelle che Max
Weber avrebbe chiamato le “scienze storico-sociali”. Pietro Rossi ha ricondotto la riflessione di
Windelband e dell’ allievo Heinrich Rickert a quello “storicismo tedesco contemporaneo” che volle
fondare criticamente la conoscenza storica e le altre scienze storico-sociale, evitando di appiattirle e
ridurle al metodo delle scienze della natura. Quel composito movimento faceva propria l’ istanza
positivista di una aderenza della scienza alla dimensione empirica, ma non credeva che il mondo
storico ed umano fosse comprensibile naturalisticamente.
La fondazione epistemologica delle scienze umane fu la questione centrale dello “storicismo
tedesco contemporaneo”, ma Pietro Rossi ha sottolineato con attenzione che se il soggetto
conoscente di Windelband e di Rickert è ancora quello kantiano (dotato di funzioni “a priori”, di
forme della sensibilità e dell’ intelletto), per gli altri storicisti “il soggetto della conoscenza è l’
uomo come essere storico concreto, i cui poteri conoscitivi sono condizionati dall’ orizzonte storico
nel quale è inserito”. Cosicché l’ attenzione metodologica rivolta alle scienze storico-sociali, per
intenderci la “Critica della ragione storica” di Wilhelm Dilthey, finiva col diventare “critica storica
della ragione”, analisi della storicità e della struttura del mondo umano, dei sistemi di cultura e dell’
organizzazione della società.
Pietro Rossi è nato nel 1930 a Torino, dove si è laureato in Filosofia nel 1952. Ha compiuto studi
di perfezionamento presso l’ Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, a Milano e a
Heidelberg. Libero docente dal 1956, è stato “yellow” della Rockfeller Foundation a Parigi dal 1959
al 1961. Ordinario a Cagliari da 1963 e poi a Torino, qui è titolare tuttora della cattedra di Filosofia
della Storia. Nel 1985 è stato “Max-Weber-Gastprofessor” ad Heidelberg. Della sua vasta e solida
produzione sono da ricordare, almeno, oltre a “Lo storicismo tedesco contemporaneo”, saggi come
“Storia e storicismo nella filosofia contemporanea” (1960), “La teoria della storiografia oggi”
(1983), “Vom Historismus zur historischen Sozialwissenschten” (1987), “La storiografia
contemporanea. Indirizzi e problemi” (1987), “La memoria del sapere” (1988), “La storia
comparata. Approcci e prospettive” (1990) e, in collaborazione con Carlo Augusto Viano,
“Filosofia italiana e filosofie straniere nel dopoguerra” (1991). Ha promosso in Italia la conoscenza
di Wilhelm Dilthey e Max Weber con le traduzioni delle loro opere di maggior rilievo, ma si è
occupato anche delle questioni epistemologiche, metodologiche e teoriche dell’ indagine storica e
delle scienze sociali.
Pietro Rossi ha invitato a non intendere lo “storicismo tedesco contemporaneo” come quella
degenerazione e “dissoluzione della visione romantica della storia” che condurrebbe univocamente
alla sociologia, secondo la lettura operatane da Ernst Troeltsch. La “visione romantica della storia”,
nata con Johann Gottfried Herder, finiva con la crisi della filosofia della storia di Georg Wilhelm
Friedrich Hegel: la storia non era più identificata con l’ Assoluto, e ogni suo momento individuale
non veniva più ricondotto all’ universale. Con lo storicismo tedesco contemporaneo, la storia
diveniva “prodotto dell’ opera finita degli uomini” e la storicità avrebbe costituito “l’ orizzonte
temporale entro cui l’ uomo vive e procede alla costruzione del proprio mondo di rapporti”.
Sembra di poter sostenere, nello stesso tempo, che la grande Scuola storica tedesca sollecitasse
fortemente i filosofi a riflettere metodologicamente sulle discipline storico-sociali. L’ Ottocento fu,
per la Germania, il “secolo della storia”. Da Theodor Mommsen a Jakob Burckhardt, da Karl Julius
Beloch a Gustav Droysen, da Eduard Zeller a Berthold Niebuhr, la Scuola storica diede contributi
fondamentali alla comprensione storica dell’ Occidente nella filosofia e nella politica, nell’ arte e
nella religione. La Riforma e il Rinascimento, la Grecia e Roma, ebbero una poderosa attenzione,
cui dev’ essere affiancata l’ acribia filologica di Hermann Diels, Hermann Usener ed altri, che
sondarono e recuperarono testi e fonti della filosofia antica.
Lo “storicismo tedesco contemporaneo” non fu certo il sottoprodotto o l’ esito tardivo e ottuso di
una simile ed eccezionale produzione. Esso fu ripensamento “critico” (nel senso kantiano) e
metodologico di quell’ immane opera storico-filologica, proprio per ritrovarne i fondamenti e la
validità dopo la crisi dello storicismo romantico e del suo apogeo hegeliano. Nessuno avrebbe osato
mettere in discussione il lavoro della Scuola storica, ma, mentre la filosofia della storia di Hegel si
avviava al tramonto ed emergeva il “ritorno a Kant”, lo “storicismo tedesco contemporaneo” intese
estendere la critica kantiana (che s’ era rivolta alla sola scienza della natura) alle scienze storiche. E
rinunciava, nello stesso tempo, alla concezione di una storia dialettica e razionale (fondata sull’
asserto di Hegel che tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è reale è razionale) per riscoprire
i limiti dell’ essere umano, senza ignorare quell’ aspetto irrazionale che sempre contraddistingue la
storia concreta, sulla quale pur si fonda il mondo umano.
“L’ analisi metodologica del “Grundriss der Historik” (1858) di Droysen e la considerazione
storico-filosofica delle “Weltgeschichtliche Betrachtungen” (1868-71) di Burckhardt – ha scritto
Pietro Rossi – riflettono già motivi ed esigenze di un mondo culturale che, per quanto legato a
quello romantico, ha abbandonato i suoi presupposti filosofici e mira a realizzare una diversa
comprensione della conoscenza storica e della struttura della storia”. L’ emancipazione dalla
filosofia romantica della storia costituì sin dall’ inizio l’ obiettivo dello “storicismo tedesco
contemporaneo”, cui seguì poi, con gradualità, il distacco dalla Scuola storica.
Windelband diede, comunque, un fondamentale contributo ad una analisi metodologica delle
scienze storico-sociali, che ne rifiutasse la riduzione naturalistica imposta dal positivismo, ma che
travalicasse anche i confini del neo-criticismo (la filosofia come teoria della conoscenza) per
approdare ad una comprensione strutturale della storicità costitutiva del mondo umano. Aveva
esordito con l’ esigenza di chiarire i termini della validità logica della “conoscenza storica”, ed era
pervenuto ad una “teoria dei valori”. In sintonia con Kant, ed ampliandone la visuale, egli intendeva
cogliere quei valori normativi che guidano l’ attività umana non soltanto nella dimensione del
conoscere, ma anche in quella dell’ agire morale e della valutazione estetica.
Condivise con Wilhelm Dilthey la convinzione che la filosofia non dovesse scostarsi dai progressi
e dalle conquiste della scienza. Essa doveva perciò procedere ad una ridiscussione delle discipline
storiche e dei loro fondamenti. Windelband rifiutava, però, la distinzione che Dilthey aveva operato
tra scienze della natura e scienze dello spirito. Una tale distinzione l’ avrebbe radicata – secondo
Windelband – nell’ oggetto (Natura e Spirito), e vi era, quindi, il rischio di riproporre una sorta di
dualismo metafisico, dal quale nessuno dei grandi filosofi moderni poteva dirsi esente (da Cartesio
a Spinoza sino ad Hegel).
In realtà, la distinzione tra “scienze della natura” e “scienze dello spirito” non era affatto
radicalmente oggettiva. Dilthey non voleva la riduzione delle scienze dello spirito a quelle della
natura, operata da August Comte, nemmeno nella sola dimensione metodica, come aveva stabilito
John Stuart Mill.
Non può non esservi, da parte del ricercatore, un diverso “atteggiamento”, quando si occupi delle
scienze dello spirito, giacchè egli è parte di quello stesso “mondo umano” che pone a proprio
oggetto. E se l’ uomo è tanto colui che ricerca quanto l’ “indagato”, calato comunque nel mondo
storico-sociale, non può esser ridotto a mero soggetto conoscente come voleva Kant. Egli deve
riappropriarsi, su entrambi i versanti della ricerca, della concretezza esistenziale del mondo umano
nella sua complessità e nelle sue multiformi espressioni. Contro il positivismo, Dilthey
salvaguardava l’ unità-totalità psicofisica dell’ essere umano e ribadiva che la dimensione spirituale
non ne è separabile se non per astrazione. Distingueva tra l’ esperienza “interna” e quella “esterna”:
la prima riguarda la natura, estranea e “straniera”; la seconda coinvolge quel “mondo umano” di
relazioni, affetti, stati d’ animo, di cui l’ uomo ha esperienza immediata (“Erlebnis”).
I due tipi di esperienza impediscono di concepire una distinzione meramente oggettiva (natura e
spirito) tra i due ordini di scienze. Ma Windelband ignorò tutto questo al fine di rimarcare la sua
distinzione – fortemente metodologica – tra “scienze nomotetiche” e “scienze idiografiche”. Scrisse
che “Quella tra natura e spirito è un’ antitesi oggettiva che è pervenuta a una posizione
predominante al tramonto del pensiero antico e agli inizi di quello medioevale, e che nella
metafisica moderna è stata fatta valere, con la massima decisione, da Cartesio e da Spinosa fino a
Schelling e a Hegel”. Attribuiva a Dilthey un vincolo cui egli in realtà intendeva sottrarsi. E
chiedendosi quali affinità di metodo possano esservi tra la psicologia e le scienze naturali,
rispondeva che entrambe raccolgono ed elaborano i fatti … Ma il metodo di accertamento dei fatti è
diverso, perché diversi sono gli oggetti. La psicologia, come le altre “scienze dello spirito”, pur esse
empiriche, “è diretta a rappresentare nel modo più compiuto ed esauriente il divenire particolare,
più o meno esteso, di una realtà singolare e limitata nel tempo”. L’ oggetto può essere il più vario:
“Si può trattare di un singolo avvenimento o di una serie complessiva di azioni e di vicende, della
natura e della vita di un uomo o di un intero popolo, del carattere specifico e dello sviluppo di una
lingua, di una religione, di un ordinamento giuridico, oppure di un prodotto letterario, artistico,
scientifico … Ma sempre lo scopo conoscitivo rimane quello di riprodurre e di intendere nella sua
realtà di fatto una formazione della vita umana, che si è presentata nella sua configurazione
singolare. E’ chiaro che con ciò si designa l’ intero ambito delle discipline storiche”.
In sostanza, la linea di demarcazione tra le scienze della natura e quelle del mondo umano è nel
metodo: “Le une cercano leggi generali, le altre fatti storici particolari … Le prime sono scienze di
leggi e le seconde sono scienze di avvenimenti; quelle insegnano ciò che è sempre, e queste ciò che
è stato una volta. Il pensiero scientifico è nel primo caso “nomotetico” e nel secondo “idiografico””.
Se però la differenza non riguarda l’ oggetto, resta inteso che per ogni fatto si danno due possibili
punti di vista: esso può esser considerato sia come particolare riconducibile ad una uniformità
legale, sia come individualità unica. “La distinzione tra la ricerca naturale e la storia comincia
soltanto là dove si tratta di utilizzare i fatti a scopo conoscitivo. Qui noi vediamo che l’ una cerca
leggi e l’ altra cerca invece forme. Nell’ una il pensiero conduce all’ accertamento del particolare
all’ apprendimento di relazioni generali, nell’ altra esso si sofferma alla caratterizzazione accurata
del particolare. Per lo scienziato naturale il singolo oggetto dato alla sua osservazione non possiede
mai, in quanto tale, valore scientifico; esso gli serve solo in quanto si ritiene giustificato a
considerarlo come un tipo, come un caso specifico di un concetto di genere … Allo storico si pone
invece il compito di far rivivere una formazione del passato nella sua intera configurazione
individuale, rendendola idealmente presente”.
18/
Heinrich Rickert (1)
Heinrich Rickert fu più sistematico e teoretico del maestro Wilhelm Windelband, dal quale riprese
la distinzione tra scienze nomotetiche e scienze idiografiche, oltre all’ esigenza prioritaria di
definire la scientificità e la metodologia della conoscenza storica. Ma, soprattutto, egli volle
riflettere sulla filosofia come “teoria dei valori”. La “südwestdeutsche Schule”, la Scuola del Sudovest o Scuola del Baden (Università di Heidelberg e Friburgo) era stata fondata da Windelband
ma ebbe certamente in Rickert il suo maggior esponente. Era la seconda scuola neo-kantiana
tedesca, dopo quella di Marburgo, e costituì un momento cruciale di elaborazione dell’
epistemologia delle scienze umane o storico-sociali.
La netta tendenza sistematica che lo contraddistingueva, indirizzò Rickert alla formulazione di una
teoria della conoscenza che stabilisse il fondamento e la validità della conoscenza storica. La
costante attenzione logica per la “teoria della conoscenza” lo condusse a definire lo statuto
epistemologico delle “scienze della cultura”. Affrontò la questione, superando il neo-kantismo,
anche se rimase vincolato al piano trascendentale e del soggetto conoscente, e ricondusse l’
indagine metodologica sulla scienza ai “fini ultimi” della ricerca scientifica: chi si occupa della
scienza deve porsi la questione di una “generale concezione della vita e del mondo”
(“Weltanschauung”). Dopo un secolo di frammentazione e specializzazione delle scienze,
Windelband riteneva fosse giunto il tempo di ritrovare il senso della “totalità” e affidò alla filosofia
(che nel frattempo aveva dovuto rinunciare alle problematiche tradizionali, affidandole alle scienze
settoriali) il compito di chiarire l’ apertura e l’ attenzione delle scienze nei confronti del “mondo”.
Il “mondo” delle scienze della natura gli appariva “freddo e tremendo”, un “macchinario” senza
vita, un “habitat” estraniante e privo di senso. Andando oltre l’ esigenza strettamente metodologica,
Rickert avvertiva la necessità di ricollocare l’ agire umano in un mondo che pulsasse di sensi e
significati. Egli non aveva una sua determinata “concezione del mondo” da imporre alle scienze
naturali, ma, di fronte alla loro inadeguatezza a conseguirne una, accentuò il ruolo delle scienze
della cultura. Mario Signore ha ben evidenziato che Rickert rifiutò la tesi che “le scienze culturali
debbono costruirsi sul modello delle scienze naturali, che colgono soltanto le regolarità calcolabili e
immutabili”. Signore intravvede da lontano Max Weber, quando ritiene che, sulla scia di
Windelband, Rickert giudicasse che “anche le scienze naturali, entrando in gioco nel nostro
comportamento individuale, non possono non subire una trasformazione dovuta al fatto” che l’
uomo è un essere culturale il quale può assumere, di fronte al mondo, una posizione consapevole,
conferendogli un senso.
Rickert andava definendo una logica delle scienze della cultura. E non volle estendere ad esse quel
fondamento naturalistico che, per le stesse scienze della natura, si mostrava ambiguo. Ritenne,
dunque, di poter ancorare le scienze della cultura ad un sistema di valori e affidò alla filosofia il
compito di “Weltanschauungslehre”, di scienza dei valori e dottrina di una “Weltanschauung”
(concezione del mondo).
Heinrich Rickert nacque a Danzig nel 1863. Il padre era parlamentare. Crebbe nei decenni di
Bismarck e fu un adolescente attento all’ arte e al teatro. Conseguì la laurea a Straβburg con
Wilhelm Windelband, a venticinque anni, e a ventotto si abilitò a Freiburg. Si ritrasse dalla storia
della letteratura per le inclinazioni filologiche che essa aveva assunto con Wilhelm Scherer, e
preferì le questioni storiche del Windelband di “Lehrbuch der Geschichte der Philosophie”, anche
se i suoi preminenti interessi non sarebbero stati certamente storico-filosofici. Professore
straordinario a Freiburg nel 1894, poi ordinario due anni dopo, avrebbe assunto la guida della
“Badische Schule”, per succedere, ad Heidelberg, a Windelband, nel 1915. Ad Heidelberg, Rickert
sarebbe morto nel 1936.
Tra le sue opere, si possono ricordare: “L’ oggetto della conoscenza: introduzione alla filosofia
trascendentale” (1892), “I limiti della formazione dei concetti nella scienza della natura:
introduzione logica alle scienze storiche” (1896-1902), “Scienza della cultura e scienza della
natura” (1899), e il saggio postumo “Immediatezza e significato” (1939).
Né la storia della letteratura né il giornalismo riuscirono ad appagare e ad assorbire un intellettuale
acuto e versatile, che volle essere attento a tutte le problematiche dell’ essere umano, dall’ esistenza
alla politica, dall’ economia all’ arte, sino alla tecnica. Riconoscerlo come il maggior esponente del
neo-criticismo tedesco sud-occidentale, dopo il fondatore Windelband, considerando anche l’
impegno che egli profuse nel “Logos. Internazionale Zeitschrift für Philosophie der Kultur”, è cosa
già più adeguata ad intenderne l’ ingegno. Il suo vero cruccio e l’ autentico oggetto della sua
riflessione furono, comunque, le „Geisteswissenchaften”, le “scienze della cultura”. E non si
accontentò della loro distinzione dalle “scienze naturali” come il Maestro Windelband. Volle
approfondire e definire il loro statuto epistemologico.
Rickert ripartiva dalla distinzione, operata dal predecessore, tra conoscenza storica e scienza
naturale, ma intese condurre sino in fondo l’ indagine logico-metodologica sulla conoscenza storica,
al fine di definirne appieno l’ autonomia e l’ identità. Come ha scritto Pietro Rossi, “l’ ideale della
scienza naturale <gli appariva> costituito da un’ integrale spiegazione meccanica della realtà,
conseguita mediante la determinazione di leggi incondizionatamente valide che esprimono, in
maniera universale e necessaria, i rapporti tra i suoi innumerevoli elementi”. L’ “orientamento
generalizzante” è dominante sia nelle scienze fisiche che in quelle psicologiche: esse producono, in
ogni caso, concetti generali ed ignorano l’ individualità nella sua unicità, singolarità, irripetibilità.
E’ questa la concezione della scienza che hanno tanto i positivisti quanto i neo-criticisti.
“Se vogliamo sapere qualcosa in merito alla singolarità, alla particolarità e all’ individualità del
reale, - scriveva Rickert – non possiamo rivolgerci a una scienza ai cui concetti viene posto un
limite dal divenire reale nella sua configurazione singolare e individuale, e al tempo stesso intuitiva;
ma, se dev’ esserci in generale una rappresentazione della realtà con riguardo al sua singolarità e
individualità, è necessaria a tale scopo una scienza la quale, nella sua elaborazione concettuale, si
discosti logicamente dalla scienza naturale nei punti essenziali. Conoscere la struttura logica di
questa scienza, delimitare la sua elaborazione concettuale nei confronti di ogni scienza naturale e
pervenire in tal modo al principio su cui si deve fondare la divisione logica delle scienze empiriche,
costituisce d’ ora innanzi il nostro compito, che si collega immediatamente all’ indicazione dei
limiti dell’ elaborazione concettuale della scienza naturale”. E Rickert continua: “Se dev’ esserci
una scienza del divenire singolare e individuale, questa dovrà chiamarsi scienza storica. Noi ci
rivolgiamo alla storia ogni volta che il nostro interesse non è soddisfatto dalla scienza naturale …
La storia considera la realtà da un punto di vista del tutto diverso, e si serve quindi necessariamente
anche di un metodo completamente differente di rappresentazione e di elaborazione concettuale …
La storia non può mai cercare di rappresentare la realtà in riferimento al generale, ma può
rappresentarla soltanto in riferimento al particolare e all’ individuale. Solamente ciò che è
individuale e singolare è realmente accaduto; e solamente una scienza che tratti del divenire
singolare può essere chiamata scienza storica ... “.
La conoscenza storica vuol porsi, nei confronti della stessa realtà di cui tratta la scienza, con una
diversa prospettiva, attenta alla particolarità. Natura e storia non sono che due aspetti di una sola
realtà, colta da due diversi punti di vista, generalizzante il primo, individualizzante il secondo.
Pietro Rossi, d’ altra parte, nota che neppure alla conoscenza storica è consentito cogliere “il dato
empirico nella sua immediatezza”, giacchè la semplice restituzione dei dati empirici non sarebbe
“conoscenza oggettivamente valida”. Anche la conoscenza storica necessità di un criterio per
ordinare la molteplicità dei dati empirici, conferendo loro unitarietà nell’ oggetto individuale. Tale
criterio è indicato da Windelband nella “relazione ai valori”, che consente di salvaguardare, tanto l’
unità della molteplicità di elementi che compongono l’ oggetto individuale quanto la sua
singolarità-unicità. La storia, sostiene Rickert, “si interessa soltanto di ciò che possiede, come si
suol dire, un significato universale. Ma ciò non può voler dire nient’ altro se non che il valore, in
riferimento al quale gli oggetti diventano per essa individui storici, dev’ essere un valore universale,
ossia valido per tutti … Il valore universale non deve abbracciare vari valori individuali come
propri casi specifici, ma dev’ essere soltanto un valore riconosciuto da tutti o valido per tutti; … ciò
che possiede significato universale in quanto è riferito a un valore universale non è, per tale motivo,
qualcosa di generale. Al contrario, il significato universale di un oggetto può crescere nella misura
in cui aumentano le differenze tra di esso e gli altri oggetti; e la storia avrà per oggetto l’ individuale
e il particolare proprio perché essa si occupa soltanto di ciò che è in relazione con un valore
universale. L’ individuo storico acquista pertanto un significato per tutti in quanto è diverso da ogni
altro”.
E ancora: “La validità della rappresentazione storica deve dipendere dalla validità dei valori cui
viene riferita la realtà storica; e perciò la pretesa di validità incondizionata dei concetti storici
presuppone il riconoscimento di valori incondizionatamente universali. Questo riconoscimento non
comporta affatto … la possibilità di una valutazione concordante degli oggetti storici; ma è
necessario che vengano riconosciuti in generale valori rispetto ai quali ognuno deve prendere
posizione anche come uomo di scienza, e a cui egli deve riferire la realtà; poiché soltanto allora il
suo corso individuale non può mai essergli completamente indifferente, e quindi anche una
rappresentazione della sua individualità non potrà mai sembrargli puramente arbitraria e superflua.
Non basta perciò escludere i valori puramente individuali e designare come principî direttivi di una
rappresentazione storica soltanto quei valori che sono comuni a tutti i membri di una determinata
comunità. Se la storia deve competere con il tipo di validità universale a cui la scienza universale
pretende con la formulazione di leggi generali, dobbiamo invece ammettere che certi valori non
siano soltanto riconosciuti di fatto da tutti i membri di determinate comunità, ma che il
riconoscimento di valori in generale può essere imposto a ogni uomo di scienza come inevitabile, e
che quindi è necessaria la relazione della realtà singolare e individuale con certi valori forniti di
una validità universale più che empirica. Soltanto a questa condizione una rappresentazione storica
può valere di per sé come una necessità scientifica”
Dai valori scaturisce una valutazione morale? I valori non conferiscono alcuna dignità morale ai
dati empirici, cui attribuiscono un’ identità e che collocano in una connessione evolutiva e continua
(il processo storico). La relazione ai valori non produce giudizi di valore etico-pratici. Essa
stabilisce, soltanto, attraverso una scelta ed una selezione, come debbano configurarsi e strutturarsi i
dati empirici. La relazione ai valori non consente altro che una “elaborazione concettuale” dei dati.
La soggettività nella conoscenza storica è pur sempre quella kantiana: si tratta di una soggettività
“trascendentale” che non può esser confusa con il singolo soggetto e che garantisce “validità
universale e necessaria” alla stessa conoscenza storica, scegliendo e ordinando i dati empirici,
secondo valori dalla “validità incondizionata”.
Del resto, Pietro Rossi ha colto acutamente l’ istanza metatifisica sottesa dalla rivendicazione di una
“validità assoluta dei valori”. I valori debbono avere un’ originaria “inseità” ed un’ appartenenza ad
una “sfera ideale”. La “coscienza normale” (normativa, garante di norme) è indipendente dall’
attuazione empirica effettiva dei valori nel concreto agire umano. Essa ha una consistenzasussistenza “platonica”. La trascendenza e la metafisica si affacciavano prepotentemente nell’
orizzonte di Rickert, inducendolo a superare l’ “a priori” kantiano, come era accaduto allo stesso
Windelband.
19/
Heinrich Rickert (2)
Heinrich Rickert rifiutò, per le scienze della cultura, il modello delle scienze naturali, fondato
esclusivamente sulle regolarità calcolabili, e, sviluppando il progetto del maestro Windelband,
sostenne che le stesse scienze della natura non possono ignorare che l’ uomo è un essere culturale, il
quale conferisce un senso al mondo in cui vive. L’ uomo valuta, e costituisce “beni culturali”
secondo valori Questi ultimi gli indicano una direzione ed un orientamento nella vita e nell’
esistenza storica concreta. I valori non discendono dalla valutazione: tra validità dei valori e
valutazione secondo i valori vi è incommensurabilità, cosicché una “filosofia dei valori” dovrà
interrogarsi sulla relazione tra uomo e valori. Rickert distingue tra “beni culturali puramente storici
e valori culturali formali o validi, astratti e soprastorici”. I “beni culturali” sono il veicolo con il
quale l’ uomo traduce i valori, in vista di una loro realizzazione sempre più alta e adeguata. Il
crescente conseguimento dei valori nella storia mira ad un progressivo perfezionamento.
L’ approssimazione al pieno conseguimento dei valori ha un’ inevitabile limite nella storicità dell’
operare umano. In ogni caso la “relazione al valore” consente alla scienza storica di distinguere ciò
che è essenziale da ciò che è inessenziale. Dato un sistema di valori trascendenti, lo storico può
orientarsi nel fluire molteplice della realtà ed istituirvi connessioni di senso. Il tendere al valore non
può mai venir meno ma non si può pretendere che il senso si realizzi pienamente e compiutamente
nella storia. I valori, comunque, si realizzano concretamente nella storia, sia pur in modo parziale.
Partecipano al suo mutamento. E’ lecito, dunque, chiedersi come si connettano i beni culturali al
sistema trascendente dei valori. Nota, al riguardo Mario Signore, che “di fronte a un sistema di
valori valido oggettivamente, inteso come “compito”, come orizzonte regolativo irreale, bisogna
chiedersi quale concreto rapporto esso riesca effettivamente a instaurare con il decorso degli eventi
storici, e quali siano le inevitabili conseguenze di una definitiva ir-relazione tra valori irreali e
storia, per la comprensibilità stessa della storia – Se una filosofia come dottrina dei valori irreali
non può mai diventare storica, giacchè in quanto irreali i valori non sono riducibili al divenire della
vita storica, “l’ “Historismus” è da contestare. Non esiste filosofia storica”. In quanto al filosofo
“solo se gli riesce di articolare la sua pienezza non storicamente, bensì sistematicamente, e così di
eliminare tutto ciò che è meramente storico, egli può sperare di pervenire alla filosofia””. Sembra
che l’ ultimo Rickert abbia deciso per un sistema dei valori del tutto indifferente al divenire e al
mutare della storia concreta. La fattività riduce i fatti storici ad una dimensione meramente empirica
ed i “beni culturali puramente storici” traggono il loro senso dal fatto che in essi si calano i “valori
culturali formali”. E’ difficile cogliere nei valori così intesi un dinamismo storico che ne faccia il
motore e l’ energia del fluire storico, nei suoi momenti individuali.
Quando Rickert si occupava della “validità logica della conoscenza storica” non pensava affatto ad
una “filosofia della storia”. Ci sono due modi di costruire l’ oggetto del sapere, ed entrambi sono
unilaterali. L’ uno è quello delle scienze della natura, vincolato al dato empirico-fenomenico, l’
altro è quello della metafisica, che subordina la storia ad una realtà metafisica che la trascende, la
guida e la preordina. Tra l’ immediatezza empirica e la trascendenza di una realtà che antecede la
storia, Rickert coglieva un “dover essere intrinseco alla conoscenza, capace di esplicare una
funzione normativa” (Pietro Rossi). All’ origine sia della scienza della natura che della conoscenza
storica, egli intravvedeva un soggetto sovra-individuale kantiano che conferisce ad entrambe
validità universale e necessaria. Quanto poi al fondamento di ciascuna delle due, Rickert scorgeva
nella “relazione ai valori” la specificità della conoscenza storica. Ma i valori avrebbero potuto
conferire alla conoscenza storica una “validità incondizionata” soltanto se essi avessero avuto
“validità assoluta”.
La “teoria dei valori” di Windelband aveva affidato ai valori, in un primo tempo, una funzione
semplicemente normativa, intendendoli come “i principi a priori che garantiscono in ogni settore la
validità dell’ attività umana” (Pietro Rossi). Ma se i valori debbono avere una validità universale e
necessaria in sé e per sé, occorre inevitabilmente assegnare loro una consistenza ideale e metafisica.
Quindi, se, da un canto, la conoscenza storica si istituisce nella “relazione ai valori” (i valori sono
criteri che la orientano nella selezione del dato empirico); dall’ altro, i valori si definiscono come
oggetto della conoscenza storica. L’ oggetto della quale diventa il processo storico, nel quale si
realizzano i valori. E il processo storico diventa il “mondo della cultura”.
Da una dimensione logica, che spetta all’ analisi critica del neo-kantismo, Rickert, come del resto
Windelband, approda alla trascendenza dei valori ed avvia l’ indagine della “struttura oggettiva
della cultura”. “La svolta verso la metafisica – nota Pietro Rossi –, che la teoria dei valori implica,
trova così la sua manifestazione nel rinvio dal problema della conoscenza storica alla
considerazione del modo in cui i valori possono trovare, mediante l’ attività umana, una
realizzazione storica – cioè a una considerazione che non trova più posto entro la teoria della
conoscenza e che conduce al di fuori del terreno logico”.
In una fase della sua riflessione, dunque, Rickert, come Windelband, non si sarebbe più interrogato
sulla cultura come area disciplinare nella quale debbono cogliersi fatti individuali; la cultura
diventava un “mondo” nel quale l’ agire umano dev’ essere chiarito e compreso nella sua concreta
dimensione storica e nella sua concreta traduzione dei valori. Dalla validità universale e necessaria
dei valori discende il senso della storia, e una filosofia della storia che voglia cogliere il processo
storico complessivo (universale) deve riferirsi, comunque, ai valori.
Che cosa significa il termine “storia”? Esso rimanda tanto alla “realtà storica” quanto alla
“conoscenza storica”. Ma la storia è, in sostanza, quel processo empirico, reale, cui la relazione ai
valori trascendenti conferisce senso. Certo, poi Rickert ha voluto distinguere le sfere di valori ai
quali corrispondono altrettanti contesti dell’ operare umano (dalla scienza all’ arte alla religiosità
… ) ma quel che importa qui è che la filosofia deve sondare la cultura nel suo concreto sviluppo
storico per comprendervi e rivelarvi la non meno concreta traduzione storica dei valori.
Rickert, del resto, individua in un intermedio “mondo del senso” l’ anello di congiunzione tra la
storia concreta e i valori, e se è vero che la cultura ha il suo senso proprio nella relazione con i
valori, è evidente che essa esiste in virtù della connessione della storia ai valori. Del “mondo del
senso” fanno parte quelle “forme spirituali” che costituiscono la “cultura come senso a sé
sussistente della realtà storica”, distinta dalla “cultura come realtà storica fornita di una connessione
e di uno sviluppo, la quale riposa sul riferimento al mondo dei valori” (Pietro Rossi). Con quale
processo, poi, si possa cogliere il senso di un oggetto storico, la soluzione sta nell’ “intendere”
(“Verstehen”), che Rickert mutua da Wilhelm Dilthey. L’ intendere consiste nella comprensione
dell’ oggetto storico, e un tale senso non è altro che la relazione di quell’ oggetto ad un valore.
Se il Rickert della maturità poneva “un sistema di valori assolutamente validi a fondamento dell’
oggettività e del nesso sistematico della scienza culturale” (Mario Signore), da giovane aveva
decretato, invece, la relatività storica di ogni “sistema di valori” in quanto vincolato, comunque, ad
un “sistema culturale”. In ogni caso, in un sistema trascendente hanno la loro realtà sovrastorica i
“valori culturali”, che si realizzano concretamente nella storia e che sono vincolati alla sua
temporalità, e che si traducono nei “beni culturali”. “Vi sono oggetti – scriveva Rickert – che, come
si suol dire, hanno un valore insito in loro, e che poi vengono chiamati essi stessi valori. Per
esempio un’ opera d’ arte è una siffatta realtà oggettiva. Ma è facile vedere come il valore insito
non è identico alla sua realtà. Tutto ciò che è reale in un quadro, la tela, i colori, la vernice, non fa
parte dei valori legati a esso. Perciò chiameremo tali realtà-oggettive, legate ai valori, “beni”, per
distinguerle dai valori insiti in esse. Anche i “valori economici”, di cui parla l’ economia nazionale,
sono, dunque, non dei valori, ma dei “beni”, e anche in altri casi non sarà difficile distinguere tra
beni e valori. Il valore è, tuttavia, legato a un soggetto, che valuta degli oggetti, e si potrebbe ora
credere che una realtà diventi un bene, un quadro un’ opera d’ arte, soltanto per il fatto che dei
soggetti attribuiscono loro un valore. L’ atto di valutazione coincide, dunque, forse con il valore
stesso? A volte si tende a rispondere positivamente a tale domanda oppure si distingue tra valore e
valutazione come tra “sentimento”, la gioia e il dolore, e atto della sensazione. Come la gioia esiste
soltanto in quanto sentita, così esisterebbero i valori soltanto in quanto valutazione di un soggetto. Il
valore stesso sarebbe quindi una realtà, più precisamente un’ esistenza psichica, e una scienza dei
valori farebbe quindi parte della psicologia”.
Rickert distingueva nettamente la valutazione e il valore: “la psicologia, come scienza dell’
esistenza psichica, non sa che farsene della problematica dei valori”. I valori non vanno confusi né
con “l’ atto psichico della valutazione”, né con i beni. “La domanda se il valore teorico di un
teorema è valido, se, come si suol dire, è vero, non sarà identica alla domanda se tale validità è
riconosciuta e se il valore teorico viene effettivamente valutato”. La conclusione di Rickert è che
“un valore può avere validità senza un atto di valutazione, che prenda posizione nei suoi riguardi. In
tal modo sono per esempio valide tutte le verità non ancora scoperte dalla scienza”. Lungi dal poter
essere confusi con i valori, i beni e le valutazioni sono “connessioni tra realtà e valori”. I valori
“formano un mondo a se stante al di là del soggetto e dell’ oggetto”.
In fin dei conti, secondo Rickert, “il compito della filosofia è di offrire una “Weltanschauung””,
una concezione del mondo che intenda essere “interpretazione del proprio significato esistenziale”.
Spetta alla filosofia dare un “unico centro” alla molteplicità della vita e ordinare “il materiale
reperibile nei beni culturali in un sistema ultrastorico”. “Una volta che abbiamo acquisito dei nessi
di valore sovrastorici possiamo metterli nuovamente in collegamento con la vita storica piena di
contenuto e se siamo riusciti a creare per i beni culturali in essa effettivamente esistenti un ordine,
con l’ aiuto di una classificazione completa, dev’ essere infine possibile costruire … un sistema in
cui, da una parte i vari tipi di valore … si trovano nell’ uniforme collegamento a un livello
gerarchico, e in cui, d’ altra parte, resta ancora spazio per il tutto non determinato dei beni culturali
storici”. Rickert pensava ad un “sistema aperto” quando escludeva che la filosofia potesse
appropriarsi immediatamente del mondo dei valori, e le affidava, pertanto, il compito di cogliere i
valori nella loro traduzione storica, che è opera dell’ uomo. I valori possono esser individuati nella
cultura. E la cultura non è altro che l’ impegno degli esseri umani nella realizzazione dei valori.
Secondo Rickert, “la storicità dell’ uomo non è altro che la sua appartenenza alla cultura”, precisa
Pietro Rossi, e si può comprendere quale sia il “posto dell’ uomo nel mondo” soltanto se si
considera la sua libertà nel realizzare certi valori nel corso dello sviluppo storico.
20/
Georg Simmel (1)
Georg Simmel ha lasciato – come rileva Pietro Rossi – un’ impronta epistemologica marcata nella
“sociologia formale”, una delle più importanti correnti della sociologia tedesca, di cui esponenti
sarebbero stati, tra gli altri, von Wieser e Vierkandt. La sua riflessione metodologica sulle scienze
sociali si è mossa partendo dalle loro concrete procedure, dalle categorie forgiate nel corso della
ricerca, dai loro ambiti di indagine. Certo, poi, trascinato e condotto, dalle premesse della sua
epistemologia, al relativismo assoluto dei valori, il “secondo” Simmel approdò ad una “filosofia
della vita” che, paradossalmente, gli restituiva proprio la relatività come assoluto. Influenzato da
Arthur Schopenhauer e da Friedrich Nietzsche, capovolse la sua attenzione per la storicità del
mondo moderno, di cui fu acuto interprete, in una metafisica della stessa civiltà moderna. Con la
riprovazione di György Lukàcs, che lo redarguì per aver voluto “fare dell’ estremo relativismo …
una “Weltanschauung”” e “di volgere in senso positivo l’ agnosticismo moderno in una forma
mistica”.
L’ anatema di Lukàcs era diretto alla “Visione della vita” dell’ ultimo Simmel, laddove costui
sosteneva che “Di fronte all’ affermazione del sempre più vasto e illimitato progresso del nostro
sapere non si dovrebbe … tralasciar di notare che, per così dire, all’ estremo opposto, tante cose che
noi possedevamo come “sicuro” sapere si degradano a incertezza o a errore riconosciuto”. Ed
esclamava Simmel : “Quante cose “sapeva l’ uomo del Medioevo, come pure il pensatore
illuminista del secolo XVIII o lo scienziato naturalista del XIX, che sono per noi o del tutto superate
o almeno assai dubbie! Quanta parte di quella che per noi oggi è “conoscenza” indiscussa, presto o
tardi subirà lo stesso destino!”. Lukàcs vedeva una netta “svalutazione della scientificità” nell’
affermazione di Simmel secondo cui “Una volta che si sia rinunciato all’ idea del “vero assoluto”,
che è del pari soltanto una formazione storica, si può giungere alla tesi paradossale che, nel
continuo procedere della conoscenza, la misura delle verità adottate viene pareggiata soltanto dalla
misura degli errori eliminati, e che, come in un corteo che mai si arresta, tante sono le conoscenze
“vere” che salgono per la scala principale quante sono le “illusioni” che vengono fatte discendere
per la scala di servizio”. Parole che preannunciano talune riflessioni di Max Weber e di Raimund
Karl Popper sull’ interminabile via della verificazione-validazione delle teorie scientifiche.
Georg Simmel nacque a Berlino nel 1858 da una famiglia ebrea che s’ era convertita al
cristianesimo. Frequentò il Gymnasium “Werder”. Si iscrisse poi alla “Humboldt” di Berlino, ove
ebbe come docente Theodor Mommsen. Seguì con forte interesse e notevole profitto corsi di
specializzazione: in psicologia con M. Lazarus e H. Steinthal (i quali avrebbero elaborato una
“Völkerpsychologie”, la psicologia dei popoli ripresa da Wilhelm Wundt, che ritenne di doverla
applicare ai processi psichici “superiori”, riservando i semplici processi psichici alla psicologia
sperimentale); di filosofia, sotto la guida di Edward Zeller; di storia dell’ arte, con la docenza di
Herman Grimm. Si laureò in filosofia nel 1881, discutendo una tesi dal titolo: “Das Wesen der
Materie nach Kants psysischer Monadologie”. “Privatdozent” nel 1885, a Berlino, interloquì
autorevolmente con Edmund Husserl ed Heinrich Rickert e contribuì a promuovere la riflessione di
filosofi come Antonio Banfi, Ernst Bloch, György Lukàcs. I due ultimi, con Karl Mannheim e
Martin Buber, ne furono allievi. Le origini ebraiche rendono conto degli ostacoli che egli incontrò
nella carriera universitaria, anche se non si possono sottovalutare la poliedricità e la versatilità dei
suoi molteplici interessi, che gli impedirono di qualificarsi come docente in una sola e determinata
disciplina accademica. Divenne, comunque, ordinario di filosofia a Strasburgo, soltanto nel 1914.
Sarebbe morto nella stessa Strasburgo nel 1918.
Di un autore enormemente fecondo e prolifico come Simmel , numerosi manoscritti sono andati
perduti in via del tutto definitiva negli anni della Grande Guerra, e, dei numerosi saggi pubblicati in
varie riviste e delle altrettanto copiose opere, vanno ricordati almeno: “I problemi della filosofia
della storia” (1882-1905), “Sulla differenziazione sociale” (1890), “Introduzione alla scienza
morale” (1892), “Filosofia del denaro” (1900), “La metropoli e la vita dello spirito” (1903), “Kant”
(1904), “Kant e Goethe” (1906), “La religione” (1906), “Schopenhauer e Nietzsche” (1907),
“Filosofia della moda” (1905), “Schopenhauer e Nietzsche” (1907), “Sociologia. Ricerca sulle
forme di associazione” (1908), “I problemi fondamentali della filosofia” (1910), “Goethe” (1913),
“Rembrandt. Un saggio di filosofia dell’ arte” (1916), “I problemi fondamentali della sociologia”
(1917), “Intuizione della vita” (1918), “Il conflitto della cultura moderna” (1918).
Simmel fu acuto e lungimirante “sociologo della modernità”, agli albori del Novecento, un secolo
nel quale altri avevano già intravvisto il dominio della società di massa e della massificazione dell’
individuo. Le sue sottili e innovative indagini avrebbero fornito uno dei contributi più qualificanti
alla sociologia come scienza. La socializzazione spersonalizzante nella grande metropoli, l’
impersonale razionalizzazione imposta dal danaro alle relazioni sociali, l’ indifferenza nei confronti
di ogni novità, suscitata dalla monetizzazione delle cose (l’ “atteggiamento blasè”), le figure sociali
del povero e dello straniero, la moda, il senso del pudore e la civetteria, tutto ciò costituiva un
inconsueto complesso di tematiche per la nuova scienza in gestazione: la sociologia.
Proprio il concreto interesse per i fatti sociali lo indusse ad accogliere, nelle scienze che si occupano
della società, il metodo empirico del positivismo, salvaguardando l’ esigenza del rigore descrittivo.
Come ha scritto Pietro Rossi ne “Lo storicismo tedesco contemporaneo”, “… solo il positivismo
poteva offrirgli un modello di indagine empiricamente controllata sui fenomeni sociali, che si
proponesse di evitare l’ assunzione di presupposti metafisici e che aspirasse a non diventare una
mera conferma sperimentale di una concezione filosofica della società”. La convergenza di Simmel
sul programma metodologico positivistico “si esprime nell’ affermazione del compito
rigorosamente descrittivo delle scienze sociali, e nel rifiuto della pretesa normativa che ne deriva”
puntualizza Rossi, poiché le scienze sociali non si prefiggono l’ obiettivo di “prescrivere agli
individui e ai gruppi sociali un determinato comportamento da seguire per giungere a una certa
forma di organizzazione politica piuttosto che a un’ altra”. Alle scienze sociali non compete né l’
elaborazione di regole di condotta né la formulazione di imperativi e comandi incondizionati. Esse
debbono piuttosto “studiare le diverse forme di associazione nella loro molteplicità: e ciò diventa
possibile soltanto se esse procedono a un’ opera di descrizione a base empirica, condotta attraverso
la constatazione di ciò che risulta mediante l’ esperienza. Le scienze sociali possono acquistare una
validità conoscitiva solo se, al pari delle scienze naturali, si limitano alla descrizione dei fenomeni
empiricamente osservabili”.
Qui, però, la prospettiva di Simmel divergeva dal positivismo, poiché egli negava alle scienze
sociali l’ obiettivo di conseguire leggi universali, necessarie e determinanti. Tuttalpiù, le
“uniformità” hanno valore euristico, nel senso che orientano concretamente la ricerca e si pongono
come ipotesi da confermare o smentire. Se le scienze sociali non mirano a leggi universali e
necessarie, in che cosa consiste la loro specifica funzione descrittiva? Per rispondere Simmel
ritrovò, con i neo-kantiani del Baden, la funzione critica della filosofia nei confronti della
conoscenza, per stabilirne la possibilità, i fondamenti e le condizioni di validità. Ma Windelband e
Rickert non avevano fatto altro che spostare l’ indagine di Kant dalla scienza della natura alla
conoscenza storica, e del criticismo kantiano avevano conservato la concezione di una teoria della
scienza che vuole interrogarsi sui principi a priori e che intende stabilire in termini puramente
trascendentali la validità logica del conoscere, a prescindere dal contenuto. Quel che importava era
la forma, mentre il contenuto veniva rinviato alla dimensione psicologica.
Al contrario di Windelband e di Rickert, Simmel rinunciò ad aprioristiche categorie universali e
necessarie, ed a principi a priori della ricerca. Rifiutava la prospettiva dei positivisti di cercar leggi
universali e necessarie, ma ne salvaguardava l’ aderenza all’ esperienza, contro i neo-kantiani. Di
questi ultimi condivideva la funzione critica della filosofia nei confronti della scienza, riformulando
però, in modo originale, una simile funzione. Liberandosi di un “a priori” che si impone all’
esperienza, la filosofia diventava metodologia critica che si interroga sui concreti procedimenti di
ricerca delle singole scienze sociali . Pietro Rossi coglie bene l’ originalità della posizione di
Simmel tra positivismo e neo-kantismo, quando sottolinea che “La distinzione tra forma e contenuto
della conoscenza non presuppone più < per Simmel > l’ eterogeneità dei due termini, in quanto
appartenenti a due piani diversi e contrapposti; essa diventa una distinzione funzionale fondata sul
posto che, in un determinato momento, un certo elemento occupa nel processo di ricerca. Ciò vuol
dire che l’ aspetto formale della conoscenza non è più costituito da categorie fornite di una validità
universale e necessaria; esse mutano a seconda dell’ ambito e dello scopo dell’ indagine”. Nello
stesso tempo, l’ “a priori” non può più esser imposto dall’ esperienza, ma ad essa dev’ essere
ricondotto: “… non è possibile isolare un complesso costante di principî a priori dell’ indagine
scientifica, poiché tali principi vengono assunti ed elaborati nel corso dell’ indagine stessa: l’
apriorità è il segno di una funzione esercitata in un particolare indirizzo di ricerca, non è un attributo
che poggia su un’ origine diversa dall’ esperienza. In tale maniera entra in crisi anche il presupposto
della validità universale e necessaria che il neocriticismo attribuiva alle categorie; la loro validità è
ora una validità euristica, che deve venire alla prova nel corso dell’ indagine”.
Simmel riconosceva che “Kant ha dimostrato che ogni conoscenza … è una funzione dell’
intelletto, il quale elabora quindi l’ intero contenuto del sapere mediante le sue forme “a priori”.
Ma, con Windelband e Rickert, notava polemicamente, da una parte, che “le funzioni spirituali,
descritte da Kant come l’ elemento “a priori” del conoscere, devono valere esclusivamente per la
conoscenza acquisita dalle scienze naturali”, e quindi si chiedeva che ne fosse della possibilità dell’
esperienza psichica. Dall’ altra, con maggior attenzione, rilevava che “l’ “a priori” kantiano – il
quale “rende possibile l’ esperienza in generale” – è soltanto il grado estremo di una serie, i cui
gradi inferiori sono profondamente radicati nei singoli settori dell’ esperienza”. Tali “principi”
svolgerebbero la funzione di “forme di connessione” nei confronti dei contenuti dati. Ma, avendo
Kant separato l’ “a priori” da ogni elemento empirico, non è chiaro “Fin dove … si estenda questo
dominio … delle forme di connessione sul materiale dei fatti”. L’ esperienza e l’ “a priori”, dopo
Kant, hanno accresciuto enormemente la loro estensione e Simmel evidenzia la differenza tra “le
forme più generali, che possono essere applicate a qualsiasi materiale e che si elevano al di sopra di
ogni singola esperienza, e le forme particolari, ottenute empiricamente e applicabili come “a priori”
soltanto a certi contenuti”. E aggiunge che il significato dell’ “a priori” non si risolve “nel contenuto
logico dei concetti in cui può in seguito venir espresso, ma si realizza nella sua efficacia per i
sorgere del nostro mondo conoscitivo”. “Ogni conoscenza è una traduzione di ciò che è
immediatamente dato in un nuovo linguaggio, con forme, categorie ed esigenze proprie soltanto di
essa. In quanto i fatti – quelli interni non meno di quelli esterni – diventano oggetto di scienza, essi
devono rispondere a domande che non vengono mai poste loro nella realtà e nella loro esistenza
originaria; per soddisfare i bisogni del sapere essi ricevono … un ordinamento secondo motivi
apparenti e motivi profondi, un’ accentuazione di punti singolari, di relazioni interne in base a
valori e a idee, che creano mediante essi una nuova formazione di specie particolare e con una
propria legge”.
Il neo-kantismo e lo stesso criticismo di Kant erano capovolti, in nome dell’ istanza positivistica del
primato dell’ esperienza e della concretezza delle scienze sociali nei loro metodi e nelle loro
procedure. Ma, nello stesso tempo, Simmel si contrapponeva alla tesi positivista che la descrizione
dei fatti (sociali) equivalga alla loro fedele riproduzione-constatazione. Le scienze sociali non
registrano fatti oggettivamente dati e preesistenti; ciascuna di esse rielabora, piuttosto, i fatti,
secondo proprie categorie, che non vanno intese come “forme universali dell’ intelletto” , tali per
tutti gli ambiti di ricerca. L’ esigenza metodologica imponeva, così, una sorta di mappa delle
scienze sociali, che ne cogliesse le specifiche e settoriali categorie, circoscrivendone anche il
“campo di ricerca”, ma non ignorandone le convergenze e le interazioni. Simmel si interrogò sulle
peculiarità del metodo, dei presupposti, delle categorie della psicologia, della sociologia, della
scienza morale, della scienza economica, riservando una particolare attenzione a quest’ ultima,
poiché si trattava di una disciplina già ben articolata e sviluppata.
21/
Georg Simmel (2)
Georg Simmel maturò una concezione relativistica della storia, attraverso l’ analisi metodologica
della scienza-conoscenza storica, che lo separò nettamente dal neo-criticismo. Il positivismo lo
aveva indotto a ribadire il primato dell’ esperienza nei confronti dell’ “intellettualismo” kantiano,
che vuol imporre “norme puramente logiche” a “tutti gli ambiti vitali”. Le molteplici
manifestazioni della vita, la stessa morale, si ribellano al predominio logico-formale. I neo-kantiani
Windelband e Rickert non hanno fatto altro che estendere le condizioni “a priori” della conoscenza
naturale alle scienze storico-sociali.
“Tutta l’ incertezza dell’ intellettualità moderna, - scriveva Simmel – anzi della stessa esistenza
moderna, la sua aspirazione che non è mai soggettivamente priva di scopo, ma ne rimane sempre
lontana, non poteva esprimersi con più forza, anzi – se Kant permette questo concetto – con più
passione, di quanto traspaia nel fatto che egli, il cui cuore batteva tutto dal lato delle verità compiute
della matematica e delle proposizioni a priori, negava tuttavia a queste ultime un valore autonomo
per il coglimento spirituale della piena realtà effettuale. Questo valore egli piuttosto lo affidò alle
nozze tra quella apriorità e l’ immagine sensoriale soggettivo-casuale, il cui diritto, quasi
morganatico, ha ereditato, invece della perfezione, la capacità di evoluzione”. Ma, ricorda Simmel,
“Era stata proprio la percezione, che procura innanzi tutto contenuto e significato alla conoscenza, a
impedire che quest’ ultima acquisisse validità e obiettività incondizionate; e d’ altro lato: proprio le
categorie e i principi fondamentali dell’ intelletto, ossia quell’ elemento della conoscenza che
conferisce a ogni percezione obiettività e validità più che momentanea, si riducevano di per se
stesse a una vuota formula, capace di rendere possibile la conoscenza soltanto quando scende dalla
sua altezza e si riempie della casualità dei contenuti sensoriali”. Eppure, “i fenomeni psichici carichi
di destino, pieni di valori, ci vengono incontro come delle unità con le quali, a tutta prima, la nostra
coscienza non sa, per così dire, cosa fare; per immedesimarci, per lasciare che il loro senso si
riproduca dentro di noi, traiamo fuori da ciascuno una dualità di elementi che, rappresentati nella
loro unilaterale assolutezza, danno, attraverso modificazioni reciproche, il fenomeno concreto, che
appare quindi come una mescolanza o un medio di questi estremi … così infine portiamo queste
formazioni unitarie dell’ arte, della educazione e del linguaggio, a una tale prossimità, da far
sorgere, accanto all’ interesse per il loro puro contenuto, l’ interesse per la loro pura forma, e
cogliendo soltanto nella sintesi di entrambe la significatività del tutto”.
In nome del positivismo, Simmel, intese superare l’ irriducibilità kantiana di forma e contenuto,
giacchè, come scrive Mario Signore, “Nelle operazioni del conoscere, l’ aspetto formale non è
costituito esclusivamente da categorie necessarie e valide universalmente, esso dipende da una serie
di fattori che non può certo definirsi universalmente valida, essendo legata all’ ambito particolare
della ricerca e allo scopo di questa, che è come dire che ogni ambito di indagine scientifica si
elabora i propri principi apriori, e se li elabora nel corso stesso dell’ indagine, finalizzandoli agli
scopi che l’ indagine si propone di raggiungere, cioè nel corso dell’ esperienza. E qui la lezione di
Kant si confronta, passando attraverso l’ eredità del neocriticismo, con l’ istanza positivistica della
critica all’ apriori e all’ autonomia di un piano trascendentale riservato alla teoria della conoscenza,
e consente a Simmel di riaprire il discorso sul compito della filosofia e sulla possibilità di
rielaborare un modo nuovo di interpretare il rapporto tra filosofia e scienza: problema nodale per il
positivismo, risolto da questo attraverso la riduzione della filosofia alla scienza, e da Simmel
attraverso la rivalutazione del compito critico svolto dalla filosofia anche nei confronti della
scienza”.
Le istanze opposte del positivismo e del neo-kantismo si intersecavano in Simmel, attutendo
reciprocamente le unilateralità e trovando una originale sintesi. Come ha sostenuto Pietro Rossi ne
“Lo storicismo tedesco contemporaneo”, “… se l’ interpretazione del rapporto tra filosofia e
conoscenza scientifica accettata da Simmel è quella neocriticistica e non già quella positivistica, ciò
non toglie che l’ insegnamento del positivismo abbia contribuito in maniera decisiva a sbloccarlo
dai limiti di tale interpretazione, e a dare a essa un significato più concreto. La filosofia non trovava
più nella conoscenza scientifica soltanto il proprio oggetto; essa diventava qualcosa di
indispensabile all’ opera stessa delle varie discipline”.
Aprendosi con un approccio nuovo al mondo umano ed alla sua dimensione storica, Simmel
avviava un’ attenta e circostanziata indagine metodologica delle varie scienze sociali, nelle
categorie e nel campo di indagine di ciascuna, proprio mentre si occupava della civiltà moderna,
della struttura economica come di quella sociale, dei comportamenti morali come delle
“Weltanschauungen”. Egli praticava, insomma, tanto la riflessione epistemologica quanto la
concreta ricerca, connettendo le due attività in una reciproca relazione circolare. Volle però
riservare una particolare attenzione alla conoscenza storica, che intese, per dirla con Pietro Rossi,
come “una specie di penetrazione psicologica impiegata per comprendere non se stessi, ma altri
individui, vissuti in un tempo diverso”. Oltre le strutture e le connessioni, i veri protagonisti della
storia gli apparivano, dunque, uomini concreti e determinati, personalità, anime, individualità, nella
loro unicità e irripetibilità.
La dimensione temporale dei fatti sociali indusse Simmel a interrogarsi sul loro sviluppo e sulla
loro processualità storica, definendo i termini della loro conoscibilità. La conoscenza storica si
qualificava come “intendere” (“Verstehen”) e “riprodurre” (“Nachbilden”) l’ origine e il
fondamento psicologico dei fatti storici. Essa gli appariva come comprensione, da parte dello
storico, delle motivazioni interiori dei concreti attori-protagonisti dei fatti storici. L’ operazione
compiuta dallo storico consisteva, sostanzialmente, in quell’ “empatia” (“Einfühlung”) che ha, del
resto, conosciuto una grande fortuna nei contesti filosofici contemporanei più vari, dall’ estetica
(Maurice Merleau-Ponty) alla fenomenologia (Max Scheler), dalla psichiatria fenomenologica
(Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, Carl Ramson Rogers) alla psicologia umanistica di Abraham
Harold Maslow.
L’ empatia è quell’ atteggiamento di partecipazione-condivisione emotiva nei riguardi dello stato
affettivo di un altro soggetto, che può esser caratterizzato, ma non necessariamente, da un’
immediata intuizione. L’ assunto centrale è quello di una fusione o corrispondenza o
compartecipazione o condivisione, da parte del soggetto, verso gli stati d’ animo, i sentimenti, i
vissuti, di altri soggetti. Simmel non credeva nell’ immediatezza intuitiva della comprensione
storica. Egli condivideva la distinzione di Wilhelm Dilthey tra scienze della natura e scienze dello
spirito: le prime si occupano di un oggetto – la natura – sostanzialmente estraneo all’ uomo; le
seconde vedono la convergenza di soggetto ed oggetto, poiché tanto lo storico quanto l’ individuo
produttore della storia, appartengono ad un comune “mondo”. Ma Simmel non intendeva la
conoscenza storica come un’ atto di intuizione immediata, una sorta di subitanea fusione tra il
soggetto e l’ oggetto. Egli intendeva l’ empatia, piuttosto, come “proiezione”, una trasmissione, un
conferimento dei propri sentimenti all’ altro, una partecipazione che non è identificazione e
dissolvimento nell’ altro. La corrispondenza tra soggetto ed oggetto non veniva assunta
immediatamente e assolutamente; essa costituiva, piuttosto, una “condizione di validità” da porsi e
ricercarsi in ogni concreta indagine storica, che non avrebbe dunque potuto trarne una
incondizionata validità. Scriveva Simmel che “ … le situazioni e i movimenti sociali – l’ equilibrio
della vita civile garantito dal diritto, i rapporti di subordinazione all’ interno del gruppo, l’
unificazione per fini comuni, la forma conferita alla vita comune dalle motivazioni ideali o materiali
– sono giudicabili, anzi constatabili solo in virtù di una immedesimazione empatetica personale.
Anche quel che in tali movimenti crediamo di poter toccare con mano, possiamo invece toccarlo
solo con l’ anima”.
Le categorie della storia sono, comunque, psicologiche (“la psicologia è l’ a priori della scienza
storica”, secondo Simmel, ricorda Pietro Rossi), ma non costituiscono forme assolute a priori nel
senso kantiano: esse esigono di essere assunte di volta in volta, nel procedere concreto della ricerca.
Non sono eterogenee al contenuto che viene dall’ esperienza. Hanno nei confronti di quest’ ultimo
soltanto una differente funzione, che non è altro che quella di organizzarlo e strutturarlo
concettualmente. Una volta assunte, esse valgono, ma valgono in quanto sono state assunte partendo
proprio dallo stesso dato empirico, cui intendono conferire un relativo senso di validità, senza
pretendere esiti indiscutibili e incondizionati.
Proprio qui si scava un incolmabile solco tra il neo-criticismo e la metodologia simmeliana della
storia: la conoscenza storica è relativa. La “linea di fuga” che conduce Simmel all’ assoluto
relativismo dei valori è ormai tracciata. Ma si tratta di una traiettoria la cui direzione scaturisce da
un serrato confronto metodologico con Kant sulla possibilità della conoscenza storica. Kant aveva
svincolato la teoria della conoscenza della natura, da un naturalismo che intendeva piegare il
soggetto alla semplice adeguazione all’ oggetto. La “rivoluzione copernicana” di Kant, che pone al
centro dell’ attività conoscitiva il soggetto, deve valere però anche per la storia. E allora, anche
Simmel ha una sua “rivoluzione copernicana” da compiere, ed è quella rivolta allo “storicismo”,
termine con il quale egli designa il “realismo” di un Leopold von Ranke, il quale, proseguendo
sulla scia filologico-storica di Barthold Georg Niebuhr, aveva ritenuto di potersi riappropriare del
fatto storico nella sua oggettività, in nome della neutralità della storiografia.
L’ esito dell’ attività storiografica non ha alcuna validità assoluta. Le categorie di cui si avvale lo
storico non hanno altra funzione che quella di “connettere” i dati empirici, riconducendoli all’ atto
della comprensione psicologica. Esse hanno un valore euristico, promuovono e guidano la ricerca, e
la validità della conoscenza storica è, dunque, relativa e condizionata. Essa si sostiene e risiede nelle
ipotesi assunte. Come ha scritto Pietro Rossi, secondo Simmel, in sostanza, “Il significato di un
oggetto per la conoscenza storica non è qualcosa che gli appartenga in sé, non è qualcosa di dato,
ma è qualcosa che gli viene attribuito in virtù di un certo interesse; e questo interesse definisce la
conoscenza storica nella sua relatività, cioè in un tipo di validità che è coinvolto nel mutare del
punto di vista e dei presupposti psicologici in cui questo si esprime. Lungi dal rappresentare una
garanzia assoluta di validità, la relazione con categorie che condizionano il processo di ricerca
diventa il “modo stesso mediante cui si fa valere la relatività della conoscenza storica”: e ciò in
quanto tali categorie non costituiscono forme a priori universali e necessarie, ma sono presupposti
psicologici di valore ipotetico che possono mutare a seconda della diversa direzione dell’ interesse
sul quale l’ indagine poggia”.
Simmel non si discostava da Windelband e Rickert, quando opponeva l’ individualità dell’ oggetto
storico-sociale alla legalità-uniformità cui i fenomeni vengono ricondotti dalle scienze della natura.
I fatti storico-sociali sono acquisiti nella loro irripetibile e unica individualità, anche se la
storiografia si orienta nel dato empirico con leggi e uniformità provvisorie e ipotetiche, che le
fornisce la filosofia. Si tratta di indicazioni che non presumono di restituire una struttura legale reale
della storia e della società. Esse costituiscono soltanto strumenti euristici che offrono una
preliminare prospettiva sulla “totalità storica” e che offrono direzioni d’ indagine alla concreta
ricerca.
Ma la totalità dei fatti storici indagati ha un senso? Vi è un senso della storia? La risposta di Simmel
è del tutto negativa, giacchè la questione è semplicemente improponibile. Tanto una prospettiva
della trascendenza quanto una lettura immanentistica della storia sono metafisiche, e la metodologia
critica della conoscenza storica non può dichiararsi né per l’ una né per l’ altra. Simmel rifiuta una
filosofia della storia che prescinda dalla concreta ricerca storiografica o che ad essa intenda
gratuitamente imporsi. Tanto un intervento provvidenziale divino quanto una forza progressiva
continua e irreversibile, costituiscono senza dubbio aspettative che si radicano nell’ animo umano.
Ma su di esse la concreta indagine storiografica non può pronunciarsi.
22/
Émile Durkheim (1)
Émile Durkheim, con Wilfredo Pareto, Max Weber, Georg Simmel e alcuni altri, ha dato un
contributo determinante alla definizione dello statuto epistemologico della sociologia come scienza
autonoma. Non è indifferente – per comprendere il suo intenso e proficuo lavoro – che egli si
interrogasse sull’ influenza e sul rilievo del condizionamento sociale nei confronti dei
comportamenti
individuali, proprio mentre, nella seconda metà dell’ Ottocento, andava
strutturandosi quella “società di massa” che sarebbe stato l’ emblema dell’ intero Novecento. Essa
avrebbe provocato e interpellato una schiera di sociologi e filosofi nei contesti più vari, dal tema
delle motivazioni inconsce delle masse e della loro manipolazione (Gustav Le Bon, con la
“Psychologie des foules”) alla suggestione che domina la mentalità di massa (Sigmund Freud, con i
tardivi saggi dedicati alla “Massenpsychologie und Ich Analyse”), dalla comprensione del fascismo
come risposta alla società di massa (Wilhelm Reich, con “Psicologia di massa del fascismo”), alla
denuncia dei pericoli insiti nella massificazione della società odierna (Ortega y Gasset, con “La
ribellione delle masse”). La sociologia, nella riflessione metodologica e nella concreta ricerca di
Émile Durkheim, si proponeva come la specifica scienza che indaga, con rigore razionale non
meno che con aderenza empirica, il multiforme condizionamento sociale nei confronti dell’
individuo. Durkheim volle compiere un’ operazione di chiarificazione epistemologica, sul piano del
metodo e dell’ oggetto, distinguendo la sociologia dagli approcci tradizionali alla società, come le
filosofie della storia (che oscillavano tra la psicologia come comprensione degli interni moventi dei
comportamenti individuali e il positivismo individualistico e contrattualistico, che intende le
relazioni sociali come composizione contrattualistica di interessi individuali e privati). Durkheim
conferiva una inedita dignità/autonomia alla dimensione sociale, e introduceva categorie
disciplinari come quelle di “coscienza collettiva” e “rappresentazione collettiva”. Egli intendeva
attribuire unità, identità e distinzione al “fatto sociale” come fatto naturale. Ma, pur rimarcando la
prospettiva del positivismo di August Comte, dal quale non si distaccò mai, e, ribadendo – nello
stesso tempo – il valore insopprimibile dell’ osservazione empirica per la sociologia, volle
verificare l’ effettiva incidenza empirica degli ideali e delle norme sociali sull’ azione del singolo.
Le norme sociali hanno una valenza oggettiva soltanto soggettiva, individuale. Solo in questo senso
sono “cose”, in quanto pesano, come imprescindibili fini, nell’ operare individuale. I “fatti sociali”
sono “entità psichiche” e non materiali. Le “rappresentazioni collettive” sono “elementi soggettivi
comuni” agli individui ed esercitano, nei loro confronti, un’ azione coercitiva. Durkheim, attraverso
le sue concrete indagini, teorizzò una “struttura normativa di controllo sociale”, un complesso di
norme morali cui gli individui si sottomettono, pena lo scadimento in una condizione di “anomia”,
di disorganizzazione e “chaos”. L’ ininfluenza delle norme sociali nella condotta individuale
potrebbe giungere all’ individualismo radicale, in cui, come già aveva ipotizzato Thomas Hobbes,
dominerebbe la guerra di tutti contro tutti, tutti sarebbero pronti ad azzannare ed aggredire
chiunque, e si imporrebbe una sola legge: quella del più forte. Durkheim sosteneva che, all’
estremo opposto, vi sarebbe una perfetta integrazione, nella quale il sistema pienamente coerente
delle norme eserciterebbe un effettivo controllo sui singoli. E ritenne che l’ obbligo sociale fosse,
comunque, morale e non fisico, rifiutando di considerare l’ adesione dell’ individuo alla norma
come meramente opportunistico-utilitaristico o dettato dal timore della minaccia e della punizione.
Émile Durkheim nacque nel 1858 ad Epinal, in Lorena, da una famiglia ebraica. Un anno prima era
morto August Comte. Per rispetto di una lunga tradizione familiare, decise di divenire rabbino e si
dedicò con particolare attenzione al Talmud e al Vecchio Testamento. Ma frequentò anche una
scuola laica. Ancora adolescente, rimase orfano di padre, e compì gli studi secondari nel Collegio di
Epinal, per poi soggiornare a Parigi. L’ influenza di un docente lo aveva avvicinato al cattolicesimo.
Nel 1871 ebbe la consueta confermazione ebraica. Ma nel corso della sua vita, pur non restando
certamente indifferente alle forme della vita religiosa, assunse un atteggiamento sostanzialmente
agnostico. Nel 1879, al terzo tentativo, entrava finalmente nell’ Ecole normale supérieure, in cui
ebbe come docenti, tra gli altri, Fustel De Coulanges ed Émile Boutroux. Ottenne l’ “agrégation” in
filosofia nel 1882 ed occupò una cattedra a Sens e a Saint-Quintine, poi, per un biennio andò a
Parigi e in Germania, ove frequentò con grande interesse il laboratorio sperimentale di psicologia
scientifica di Wilhelm Wundt. Docente di pedagogia e scienze sociali alla Facoltà di lettere di
Bordeaux dal 1887, fu il primo, in Francia, a condurre un corso di Sociologia. Nel 1891 diresse un
corso per i candidati all’ “agrégation” di filosofia, sui padri della sociologia. Già aveva pubblicato
sulla “Revue philosophique” un saggio su “Suicide et natalité” e nel 1893 avrebbe discusso la sua
tesi “De la division du travail sociale” (“La divisione del lavoro sociale”). Del 1895 è la prima
edizione de «Les règles de la méthode sociologique » («Le regole del metodo sociologico »).
Quando ottenne, l’ anno seguente, la cattedra di sociologia, una novità assoluta, promosse la
Rivista: “L’ année sociologique”, ove pubblicò le “Rappresentazioni individuali e rappresentazioni
collettive”. Nel 1897 avrebbe dato alle stampe “Le suicide” (“Il suicidio”). Del 1900 è un articolo
su “L’ annèe socilogique”, dal titolo: “Sur le totemisme” e l’ anno successivo ottenne la cattedra di
Pedagogia alla Sorbona. Nel 1906 sarebbe stato chiamato alla cattedra di Pedagogia a Parigi, ove
insegnò nello stesso tempo Sociologia e Pedagogia. Nel 1912 diede alle stampe “Les formes
élémentaires de la vie religieuse” (“Le forme elementari della vita religiosa”). Perse nel 1915 il
figlio Andrea a Salonicco e prese posizione sulla guerra con due saggi: “L’ Allemagne au-dessus de
tout. La mentalité allemande et la guerre” (“La Germania soprattutto. La mentalità tedesca e la
guerra”) e “Qui ha volu la guerre? Les origines de la guerre d’ après les documents diplomatiques”
(“Chi ha voluto la guerra? Le origini della guerra dai documenti diplomatici »). Il dolore lo stroncò
nel 1916, e l’ anno successivo morì.
Durkheim parteggiò per i “dreyfusardi”, i sostenitori dell’ innocenza del giovane ufficiale di
famiglia ebraica che era stato accusato ingiustamente di alto tradimento ai danni dello Stato
francese. L’ “affare Dreyfus” spaccò in due la Francia alla fine dell’ Ottocento. La revisione del
processo fu avversata dagli alti comandi in nome dell’ onorabilità dell’ esercito e la questione
diventò politica. “J’ accuse” (“io accuso”) tuonò Émile Zola contro lo stato maggiore dell’ esercito
ed i giudici militari, dal foglio di Georges Clemenceau, “L’ Aurore”, nel 1898. L’ “affare Dreyfus”
confermava la radicalizzazione della vita politica francese e, mentre i repubblicani moderati
andavano declinando, l’ opinione pubblica ottenne una parziale revisione della condanna di
Dreyfus, che peraltro sarebbe stato giudicato pienamente innocente soltanto nel 1906. Il “blocco
repubblicano” che aveva sostenuto Dreyfus, sarebbe stato alla guida della Terza Repubblica dal
1899 al 1906, scivolando però verso un certo moderatismo e immobilismo. Durkheim condivideva,
per dirla con Talcott Parsons (“The Structure of Social Action”, “La struttura dell’ azione sociale”,
1937), l’ ideologia democratica, progressista, umanitarista, radicale e anticlericale della media
borghesia francese, che Wilfredo Pareto, al contrario, dileggiava con acuta ironia. E del resto, tra i
due “padri fondatori” della sociologia vi sono altre e sostanziali diversità, dalla dimensione teoretica
della sociologia al rilievo di una formazione scientifico-matematica. Se, infatti, Pareto mirava a
risultati “distaccati”, privi di applicazioni pratiche, Durkheim credeva, con August Comte, nella
sociologia come strumento della programmazione e dell’ attività politica. E, del resto, Pareto veniva
dalla matematica e dalla scienze fisiche e quando approdò alle scienze sociali diede priorità all’
economia, la “scienza umana” che meglio s’ accorda con le scienze della natura. Durkheim era
cresciuto nell’ ambito storico-filosofico, non era esperto d’ economia e le sue conoscenze
scientifico-matematiche non andavano oltre quelle di una media e “buona” cultura”. Ma quel che
rimarca Talcott Parsons nella differenza tra i due è, propriamente, il modo di intendere la relazione
metodologica tra piano teorico e piano sperimentale. Giacchè Pareto possedeva un forte “senso
della complessità dei problemi empirici” che affrontava, e la loro predominanza nella sua opera non
consentì che uno spazio modesto ai suoi “schemi teoretici”. I quali, pertanto, non sono agevolmente
e facilmente evidenziabili ed esplicabili. Al contrario, Durkheim si mosse da “pochi postulati
fondamentali”, e per quanto i problemi che si pose non fossero così copiosi come quelli di Pareto,
egli sviluppò “una linea di pensiero elaborando le implicazioni di pochi postulati fondamentali”
sostiene Parsons, e scrive che “Il suo pensiero presenta forse minore ricchezza di problemi rispetto
< a Pareto > ma a ciò corrisponde una non comune arditezza nelle linee generali d’ impostazione
del sistema teoretico. Durkheim non si lasciò mai distogliere dallo studio dei problemi
fondamentali. La sua osservazione empirica ha il carattere di un “experimentum crucis” piuttosto
che di una analisi descrittiva d’ un dato campo. Lo spazio riservato ai fatti non è, nella sua opera,
molto ampio (in senso relativo); invece, i postulati di fondamentale rilevanza metodologica possono
essere analizzati con … precisione …”. Parsons non condivideva la diffusa opinione per cui
Durkheim fosse un filosofo piuttosto che uno “scienziato empirico” e volle dimostrare come, in
tutta la sua opera, vi fosse “uno stretto rapporto tra le sue posizioni teoretiche e i problemi d’
interpretazione del materiale empirico che egli stava analizzando”. Ed è certo che, nel suo percorso
sociologico, la teorizzazione vuol essere la costante risposta a concreti “problemi empirici” di
primario rilievo. Di questa circolarità fra questioni empiriche e fattuali, da una parte, e soluzioni
teoretiche loro, dall’ altra, restano monografie che costituiscono altrettante pietre miliari nella
storia della sociologia come scienza che indaga questioni empiriche con riflessioni teoretiche: “La
divisione del lavoro sociale”, le “Forme elementari della vita religiosa” e “Il suicidio”. Pur
oscillando tra dati empirici desunti da altri e informazioni “di prima mano”, Durkheim muoveva da
questioni circoscritte per approdare a contributi determinanti e di valore generale per il metodo
sociologico. Proprio dall’ esigenza di intelligere problemi empirici, egli giungeva a risposte
originali sul piano della metodologia della scienza sociologica. “Il significato di ciò che Durkheim
fece nel campo metodologico – sostiene Talcott Parsons - < è comprensibile > soltanto conoscendo
i problemi che gli si presentavano” nella ricerca empirica, specifica e circostanziata. Solo il serrato
confronto con la ricerca empirica può dar conto dell’ evoluzione dinamica del pensiero teoretico di
Durkheim, che Talcott Parsons ordina secondo quattro fasi, da quella “formativa” (in cui si
confronta con le questioni fondamentali) della “Divisione del lavoro sociale”, alla sintesi iniziale
delle “Regole del metodo sociologico” e de “Il suicidio”, in cui vi è una prima soluzione teorica
esplicativa dei problemi empirici; dal ripensamento teoretico de “L’ Éducation morale” e “La
détermination du fait moral” al tentativo di “una nuova sintesi generale” avviato ne “Les formes
élémentaires de la vie religieuse” e stroncato dalla morte causata dalla perdita dell’ unico figlio.
Il confronto continuo e ininterrotto con i temi della ricerca – nell’ orientamento e nella scelta dei
quali era, nel contempo, guidato da alcune irrevocabili consapevolezze teoriche – lo condusse
gradualmente ad elaborare una metodologia sociologica che restava sostanzialmente positivistica
ma che, avverso l’ individualismo e l’ utilitarismo, conseguiva il primato dei fatti sociali nei
confronti dell’ individuo. I fatti sociali debbono essere considerati “comme des choses”, ma questo
non significa che essi siano cose materiali. La loro realtà è psichica. Con questo, Durkheim non
intendeva ridurre la sociologia alla psicologia. Intendeva, anzi, uscire dal paradigma della
sociologia positivistica e individualistica: le finalità che guidano l’ individuo hanno una realtà
soggettiva, ma nel contempo lo sovrastano ed acquistano una dimensione sociale-comunesovraindividuale. E’ vero, come ha scritto Angelo Scivoletto (“Il metodo sociologico di Émile
Durkheim”), che “La virtù e insieme il limite del positivismo fu l’ ancoramento di ogni possibilità
conoscitiva alla constatazione e all’ analisi dei “fatti”, quali elementi costitutivi di una realtà esterna
al soggetto, da lui indipendente e che a questi, semmai, si impone in tutta la sua oggettività: la
cosiddetta realtà che parla da sé. La “virtù” di una simile impostazione epistemologica è consistita,
come è ben noto, nel determinare l’ abbattimento della barriera solipsistica dell’ “idealismo” o di un
certo materialismo che vorrebbe fare del conoscere umano una pura emanazione del concreto”. E
non si può negare che, anche in Durkheim, il postulato gnoseologico fosse “l’ “alterità” di soggetto
conoscente e di oggetto conosciuto” e che, soltanto “con gli studi sulla religione”, egli si distaccasse
dalla “fattualità” e riconoscesse “nella fenomenologia religiosa anche una funzione
simboleggiatrice”. Ma la “cosa” sociale doveva esser da lui pensata in modo del tutto nuovo.
Scivoletto appunta come Durkheim non intendesse “deificare, a livello materiale, l’ ordine sociale,
ma reificarlo al livello suo proprio, vederlo come “cosa”, cioè semplicemente come oggetto da
conoscere”. L’ “oggetto sociale” doveva essere altro dal soggetto, ma non nel senso metafisico.
Chiarire la natura dell’ “a priori” del fatto sociale sarebbe stato l’ impegno perpetuo di Durkheim.
23 /
Émile Durkheim (2)
Émile Durkheim definì lo statuto epistemologico della sociologia come scienza, attraverso l’
istituzione di un costante rapporto di circolarità/reciprocità tra elaborazione teorica e ricerca
empirica. Nel percorso da lui compiuto per affrontare cruciali questioni (“De la division du Travail
Social”, “Le Suicide”, “Les Formes Élémentaires de la vie religieuse – Le systéme totémique en
Australie”), Durkheim ha elaborato progressivamente le categorie della comprensione sociologica.
E per quanto un titolo come: “Règles de la méthode sociologique” lasci intendere che nel saggio vi
sia una spiccata e centrale attenzione per le tematiche metodologiche ed epistemologiche, Talcott
Parsons, uno dei più autorevoli interpreti dell’ opera di Dukheim, nota la gradualità delle sue
acquisizioni teoriche attraverso l’ opera “empirica”, ed il solido legame che proprio nell’ ultimo
Durkheim assumono religione ed epistemologia: “ … lo studio della religione venne a costituire il
principale elemento empirico in base al quale egli maturò l’ ultima fase di sviluppo della sua
struttura teoretica generale”. “Sociologia religiosa e teoria della conoscenza” è il significato titolo
dell’ introduzione alle “Forme”. Del resto, l’ intima relazione tra religione e società fu un tema
condiviso da Wilfredo Pareto e Max Weber. La prima consapevolezza ed esigenza da cui si mosse
Durkheim – “De la division du Travail Social” era la sua tesi per il “doctorat” e la diede alle stampe
a trentacinque anni – fu il fondamento scientifico che deve essere dato all’ ordine morale e sociale.
Durkheim s’ era alimentato del “milieu” positivistico nell’ “École Normale” di Parigi e, anche se
Charles Renouvier lo aveva indirizzato al rigore etico del kantismo, sviluppò la centralità del suo
interesse per le scienze sociali attraverso August Comte, Jean-Jacques Rousseau, Charles-Loius de
Secondat barone di La Bréde e di Montesquieu, al quale ultimo avrebbe dedicato la tesi in latino del
1892 (“Quid Secundatus politicae scientiae instituendae contulerit”, nella cui introduzione annotava
di aver preferito l’ espressione “scientia politica” a sociologia, perché quest’ ultimo era allora
termine ancor poco definito e inadeguato al livello accademico). Controverso è il ruolo che ebbe,
nella sua formazione, il periodo trascorso in Germania, ove studiò numerosi autori e in particolare il
Ferdinand Tönnies di “Gemeinschaft und Gesellschaft”, ma è certo che - come ha sottolineato
Alessandro Pizzorno – altre sono le matrici della sua riflessione e le problematiche con le quali essa
si confrontò. “Da una parte stava un groviglio di problemi che erano tipici della situazione culturale
e politica francese degli ultimi decenni del secolo. C’ era la tradizione positivistica comtiana, e l’
esigenza di confermare che l’ ordine politico e morale devono venir fondati sulla scienza; a questo
si aggiungeva il bisogno di sollevarsi dal pessimismo della seconda generazione positivista, quella
di <Hippolyte-Adolphe> Taine e di <Joseph-Ernest> Renan, perché si identificava con un
momento di crisi della nazione francese. C’ era il ricordo del crollo del secondo impero come crollo
non tanto di un regime politico quanto di un ordine sociale”. Con Comte, Durkheim scorgeva nella
scienza della società lo strumento con cui la politica avrebbe potuto ritrovare l’ ordine, superare i
conflitti, ristabilire l’ equilibrio e l’ armonia. Comte aveva destinato il suo “Corso di filosofia
positiva” alla formazione della classe dirigente che avrebbe dovuto guidare la transizione all’ età
positiva e alla società positiva, che sarebbero state dominate dalll’ industria e dal sapere positivo. A
nulla valgono le riforme politiche volte ad instaurare una società positiva-industriale (Claude-Henri
de Rouvroy conte di Saint-Simon) se esse non sono sostenute e precedute da una “rivoluzione
filosofica”, da un “mutamento di sistema nelle idee”. Il mutamento politico-istituzionale deve
seguire, e non precedere, la “rivoluzione filosofica”. “La filosofia positiva – enunciava Comte –
merita la maggior attenzione, perché ai nostri giorni per la sua praticità è la più importante … essa
sola può essere considerata l’ unica base solida della riorganizzazione sociale, destinata a por fine
allo stato di crisi nel quale si dibattono da molto tempo anche le nazioni più civili”. E la crisi
intellettuale porta con sé, ineluttabilmente, l’ anarchia sociale e politica. Ma Comte sosteneva anche
l’ efficacia della filosofia positiva contro il pericolo opposto all’ anarchia: la repessione,
conservatrice e immobilistica, della Restaurazione. E qui si deve riandare alla restaurazione
borbonica in Francia, e poi all’ alleanza orleanista tra la grande borghesia imprenditoriale, agraria e
capitalistica, da una parte, e Luigi Filippo, il “re borghese”, dall’ altra. E non si dimentichino la
prima rivoluzione industriale vissuta dalla Francia negli Anni Trenta e la vicenda del Secondo
Impero di Napoleone III. Se l’ “ordine” al quale pensava Comte, non era certo da confondersi con
l’ “ordine” politico d’ antico regime, legittimista e tradizionalista, restaurato nel Congresso di
Vienna del 1715, occorre precisare anche che egli distinse la sociologia in due grandi parti: la
statica sociale e la dinamica sociale. Scriveva Comte nel “Corso di filosofia positiva” che la civiltà
moderna esige tanto l’ ordine quanto il progresso: “Nessun ordine reale può più esser stabilito, né
soprattutto durare se non è pienamente compatibile con il progresso; nessun grande progresso
potrebbe effettivamente compiersi, se non tendesse infine all’ evidente consolidamento dell’
ordine”. La sociologia statica si sarebbe occupata delle leggi dell’ organizzazione sociale; quella
dinamica, invece, dello sviluppo sociale. La statica sociale intendeva essere una anatomia dell’
organizzazione degli elementi del corpo sociale e, quindi, una analisi delle strutture di ogni società
umana. “Dapprima è necessario studiare … con un’ astrazione provvisoria, l’ ordine umano come
se fosse immobile. Ne apprezzeremo così le diverse leggi fondamentali, necessariamente comuni a
tutti i tempi e a tutti i luoghi. Questa base sistematica ci permetterà, in un secondo tempo, di
spiegare in modo generale un’ evoluzione graduale, che ha avuto il suo fondamento sempre nella
crescente realizzazione del regime proprio della vera natura umana, e i cui germi essenziali
dovettero esistere sempre …”. La statica studia, in sostanza, il consenso sociale. Una società è come
un organismo vivente. Come comprendere il funzionamento di un organo se non collocandolo al
giusto posto nell’ organismo? E come comprendere la politica e lo Strato se non situandoli nella più
ampia e complessiva struttura sociale, in un suo certo “stato”, in una “data situazione” e in un “certo
momento” ? La statica sociale è, insomma, l’ anatomia della struttura sociale in un suo “stato”, ed
analisi del “consenso”, e perciò vuol spiegare semplicemente come un insieme di individui o
famiglie costituiscano una comunità. La dinamica sociale, invece, secondo Comte, mostra
storicamente il rilievo della legge dei tre stati nello sviluppo progressivo dell’ umanità. L’ elemento
propulsore del progresso dell’ umanità è l’ evoluzione intellettuale. I suoi tre stadi sono “lo stato
teologico, o fittizio; lo stato metafisico, o astratto; lo stato scientifico, o positivo”, e in essi si
succedono tre “tipi di filosofia”, tre “sistemi concettuali generali”.
Non è casuale che Durkheim si occupasse soprattutto dell’ ordine sociale e trascurasse – Talcott
Parsons l’ ha acutamente notato – l’ aspetto del dinamismo e del mutamento sociale. E, del resto,
Alessandro Pizzorno rileva come “il pensiero politico e sociale dei positivisti” francesi fosse
rimasto coinvolto nel “processo di disgregazione, o di crisi” generale socio-politica francese, per cui
essi finissero “per rivolgersi ad ideali di ricostruzione pre-rivoluzionaria della società”, così da
scalzare “il potenziale costruttivo contenuto nei valori di eguaglianza fratellanza e libertà”. La
società francese, negli anni della Terza Repubblica, mirava, soprattutto, all’ ordine, ma non
intendeva “rinnegare la tradizione borghese repubblicana, che utilmente poteva servire a stimolare e
giustificare un allargamento della partecipazione popolare – o almeno piccolo-borghese – a quest’
ordine”. Era un’ esigenza che sarebbe emersa poi nei radical-socialisti. E, aggiunge Pizzorno,
“Durkheim sentirà con fervore il compito di offrire basi scientifiche e morali a questo nuovo
ordine”. Angelo Scivoletto (“Il metodo sociologico di Émile Durkheim”) ha individuato, nelle
ragioni che indussero Durkheim a “far sociologia”, “Non solo il desiderio di dar spazio ad una
scienza della società, in opposizione alle astrattezze della sociologia”, che lo spinse “a continuare il
lavoro edificatorio di Comte” e a dar il proprio apporto al “consolidamento morale della Terza
Repubblica”. Si tratta di un’ istanza di morale civile per la società francese in un’ epoca ben
determinata storicamente: ma se questo è il “milieu” culturale di Durkheim, il suo lavoro scientifico
procede a dar soluzione ad un quesito che Pizzorno ha individuato molto bene, esprimendolo in una
domanda: “è possibile fondare l’ ordine sociale e la convivenza civile sul semplice riconoscimento
degli interessi individuali?”. In altri termini: “E’ possibile che i rapporti tra gli individui siano
regolati puramente dall’ accordo, contrattuale o no, tra i loro interessi, e non affondino invece le
loro radici in un elemento che è comune a tutta la collettività?”. Il conseguimento dei fini egoistici e
della felicità individuale è sufficiente a spiegare la divisione del lavoro nelle società complesse e
differenziate? Durkheim insistette sull’ inadeguatezza dell’ individualismo e del contrattualismo a
dar conto della solidarietà collettiva sociale. La tesi centrale sostenuta ne “La divisione del lavoro
sociale”, in fondo, rivendica la moralità della divisione-specializzazione del lavoro, ma, nello stesso
tempo, attribuisce alla scienza sociologica il compito di indagare i valori morali, giacchè essi
sfuggono ad una comprensione scientifica meramente biologica o psicologica. La divisione del
lavoro scaturisce certamente dalle dimensioni demografiche, che producono eterogeneità, come
voleva Herbert Spencer, ma essa cresce soprattutto con la differenziazione e la quantità dei rapporti
sociali. “Densità dinamica o morale” e “competizione tra gli individui” sono direttamente
proporzionali, ed è proprio per evitare il conflitto della competitività che i singoli differenziano le
loro attività. La divisione del lavoro è il fondamento normativo-morale della solidarietà sociale.
Ciascuno sviluppa soltanto quelle facoltà che gli consentono di produrre un determinato apporto
alla società, sacrificando le altre. Già qui Durkheim stabilisce il peso e il rilievo delle regole moralisociali sulla vita individuale, e scopre, come puntualizza Pizzorno, “un insieme di fatti extraindividuali, nei quali le regole morali hanno radice. Sono le varie maniere di fare, di pensare, di
sentire che esistono prima e al di fuori delle coscienze individuali, e che hanno il potere di imporsi
in qualche modo ad esse”. Le “regole morali” costituiscono “l’ insieme di pratiche e di credenze
costituite, i sistemi religiosi e quelli giuridici, i sistemi di segni, come i vari linguaggi, i sistemi di
scambio, come quello monetario, o, per certe società, quello dei doni, e poi il costume, le pressioni
e le obbligazioni delle opinioni; le norme professionali; le pressioni delle emozioni e delle
manifestazioni collettive”. Di tutti questi fatti avrebbe dovuto occuparsi la scienza sociologica.
Certo, per ora, il metodo della sociologia era allo “stato nascente”, e Durkheim avrebbe ripresa la
questione ne “Les règles de la methode sociologique”, ma gli era già chiaro che il fondamento dell’
“ordine morale” è sociale e non individuale-individualistico-contrattualistico. Prende corpo l’ idea
di “coscienza collettiva” che è autonoma e sovraindividuale. La specializzazione delle funzioni
promuove lo sviluppo di una solidarietà organica ed evita la disgregazione sociale. Laddove vi
siano ruoli sociali ben differenziati, non esiste quella “solidarietà meccanica” che contraddistingue
le società uniformi nelle loro parti. In tali società le coscienze individuali sono sottomesse ad una
coscienza comune. Essa annulla quel che ostacola sentimenti, credenze, pratiche che la collettività
condivide in modo intenso. In una società in cui domini la “solidarietà meccanica”, il diritto impone
sanzioni repressive e punitive. La “solidarietà organica” si afferma in una società caratterizzata da
“un sistema di organi differenti, ognuno dei quali ha un compito specifico, e in cui l’ emergere delle
coscienze individuali testimonia il progredire della divisione del lavoro”. Grazie alla divisione del
lavoro, “l’ individuo ridiventa consapevole del suo stato di dipendenza nei confronti della società e
del fatto che da questa provengono le forze che lo trattengono e lo frenano … diventando la fonte
eminente della solidarietà sociale, la divisione del lavoro diventa anche la base dell’ ordine morale”.
Durkheim rilevava che la divisione del lavoro si afferma sulla struttura segmentarla della società, e
che “La vita sociale, invece di concentrarsi in una molteplicità di piccoli focolari distinti e simili, si
generalizza. I rapporti sociali … diventano di conseguenza più numerosi, poiché da ogni lato si
estendono al di là dei loro limiti primitivi. La divisione del lavoro progredisce quindi quanto più
numerosi sono gli individui sufficientemente a contatto da poter agire e reagire gli uni sugli altri”.
D’ altra parte, “se il lavoro si divide sempre più a misura che le società diventano voluminose e più
dense ciò … accade … perché la lotta per la vita è più ardente … La divisione del lavoro è quindi
un risultato della lotta per la vita; ma è uno scioglimento mitigato di essa. Grazie ad essa, infatti, i
rivali non sono obbligati ad eliminarsi a vicenda, ma possono coesistere fianco a fianco”. E se l’
ereditarietà non “attitudini particolari per questa o quella scienza” bensì “facoltà molto generali”,
ciascuna di esser “può convenire a numerosissime specialità differenti” in virtù della “varietà degli
ambienti <sociali> nei quali gli individui sono situati”: i vari ambienti “determinano le loro
specializzazioni in sensi divergenti”.
24 /
Émile Durkheim (3)
Émile Durkheim si interrogò, nel corso di tutta la sua produzione, sullo statuto epistemologico della
sociologia come scienza autonoma, definendone progressivamente le categorie ed il metodo. Talcott
Parsons ha notato come, soltanto dopo aver condotto a temine “La divisione del lavoro sociale” ed
essersi scontrato con le questioni empiriche che da quella ricerca scaturivano, Durkheim potè
operare un confronto serrato con gli “schemi concettuali” che il suo tempo gli proponeva. “La sua
produzione scientifica, oltre che metodologica, – ha scritto Angelo Scivoletto – è almeno
relativamente comunicabile e utilizzabile in contesti sociali e in tempi diversi, proprio perché,
nonostante la sua opposizione al “generale” quale astrazione dal particolare, Durkheim stesso nel
concreto farsi della sua ricerca adottò o pervenne a concetti e a teorie generalizzate: così è per l’
anomia, per le correlazioni del suicidio, per alcune regole del metodo” e “la sua propensione
teorico-empirica, accentuata in una direzione spesso genuinamente scientifica nel senso attuale, gli
permise, forse inconsapevolmente, di pervenire ad una sociologia ancor oggi “leggibile”, ossia
cumulabile con gli sforzi e le opere di altri scienziati sociali”. Già mentre si interrogava sulla
“coscienza collettiva” (che scaturisce dalla specializzazione), ma anche sull’ anomìa prodotta dalle
forme patologiche di divisione del lavoro, egli rifiutava le teorie individualistiche ed utilitaristiche
sulla società industriale moderna. Ed era andato elaborando, sia pur temporaneamente, una nuova
prospettiva, che muoveva dalla concezione positivistica della società, riformandola però nei suoi
punti cardinali. Talcott Parsons ricorda ne “La struttura dell’ azione sociale” come l’ utilitarismo
pretendesse di dar conto della condotta umana avvalendosi del principio del “perseguimento
razionale dei bisogni o dei desideri degli individui”. I rapporti sociali sarebbero perciò possibili
nella misura in cui offrono a ciascuno i mezzi per conseguire i fini individuali. Era una prospettiva
finalistica che una sociologia positivistica non poteva accettare. I positivisti non avrebbero mai
avallato dei bisogni “soggettivi”, in quanto volubili, incontrollabili, gratuiti, e sfuggenti ad un
osservatore esterno. Parsone nota anche come – nella “Divisione del lavoro sociale” – vi sia “l’
intuizione empirica fondamentale dalla quale si diparte l’ elaborazione teoretica di Durkheim e che
egli tenne sempre presente” : l’ insieme complesso delle azioni miranti al “perseguimento degli
interessi individuali, avviene nell’ ambito d’ un corpo di norme indipendenti dalle ragioni
individuali immediate delle parti contraenti”. L’ individualismo utilitaristico (Durkheim pensava, in
particolare ad Herbert Spencer) non riesce a dar ragione dell’ ordine sociale, dell’ “ordine
normativo della società”. Gli “economisti” ignorano che “anche … le transazioni di mero
“interesse” del mercato … vengono in realtà effettuate in conformità a un corpo di leggi che non
fanno parte dell’ accordo “specifico” fra le parti”. Tali norme preesistono a qualsiasi accordo e lo
rendono possibile. E un accordo contrattuale vincola gli esseri umani solo per un fine e un periodo
di tempo limitati. Il perseguimento di interessi individualistici non è la condizione bensì l’ effetto di
un ordine normativo. Durkheim rifiutava la tesi di Herbert Spencer secondo la quale lo Stato e l’
ordine sociale si ridimensionerebbero progressivamente di fronte all’ incedere della
“differenziazione” e dei rapporti contrattuali individuali. Era convinto proprio del contrario. Senza
uno “schema d’ ordine”, senza un “sistema di norme regolamentatrici”, l’ “ordine individualistico”,
che consente “il perseguimento di interessi individualistici” e la “cooperazione pacifica” e
laboriosa, si tradurrebbe in “ostilità e distruzione”, nella “guerra di tutti contro tutti” da cui era
partito Thomas Hobbes per giustificare lo Stato assoluto. Costui, in “Elementorum philosophiae
sectio tertia de cive” (1640), aveva dato una giustificazione teorica del potere monarchico, non per
fare della mera apologia, bensì per fondare la necessità dello Stato assoluto in un’ età travagliata da
conflitti sociali, politici e religiosi. Pessimista circa la natura umana che, abbandonata a se stessa
sarebbe rivolta al male, Hobbes intese fondare con rigore geometrico (euclideo) una scienza dell’
uomo e dello Stato, che prendesse atto del lucreziano “homo homini lupus” e accettasse una natura
umana egoistica, priva di socievolezza e comunitarietà. Contro la tesi aristotelica dell’ uomo
“animale politico” per sua natura, egli congetturò, come un’ ipotesi euristica e confrontando le
popolazioni primitive con quelle “civili”, lo stato “puramente naturale” dell’ uomo. E intravvide
che, laddove la ragione non trionfi e si affermi invece l’ originaria costituzione umana, domina una
condizione caratterizzata dal “bellum omnium contra omnes”, ove ciascuno provvede soltanto alla
propria sopravvivenza ed a manifestare, per quanto possibile, la propria potenza. In una tale
situazione di perenne insicurezza per ciascuno, nasce l’ esigenza di salvaguardare la vita
individuale, che il diritto soggettivo di tutti a tutto mette continuamente a rischio. Hobbes ritiene,
quindi, che, soltanto per salvaguardare la propria esistenza, tutti gli individui abbiano concordato un
contratto sociale (patto d’ unione), rinunciando a tutti i propri arbitrari diritti e attribuendoli al
principe (patto di soggezione). Tutti i singoli, portatori di “ius in omnia”, convengono nel “pactum
societatis” e nel “pactum subiectionis” e il potere sovrano consegue, in modo esclusivo,
irrevocabile, assoluto e indivisibile, lo “ius in omnia”, così da assicurare a ciascuno la vita ed i beni.
Durkheim non ignorò l’ importanza dello Stato ma non adottò la soluzione di Hobbes. Non credeva
nella “disciplina come coercizione”. Le imposizioni ed i divieti imposti con la forza non fanno felici
gli uomini: l’ equità deve contraddistinguere le limitazioni e non vi è disciplina senza “autorità
morale”. Durkheim non era certamente indifferente all’ esigenza dell’ ordine sociale di Hobbes, ma
si chiedeva anche in che misura fosse valida l’ importanza della divisione del lavoro e della
specializzazione per una società come quella teorizzata dagli individualisti. Certo, come notava
Talcott Parsons, “Senza specializzazione non ci sarebbe società, poiché sono i vantaggi reciproci di
scambio che costituiscono la ragione principale dell’ abbandono dello stato naturale e dell’ adesione
al sistema dei rapporti sociali”. Ma fino a che punto e da quando? Durkheim non accettava l’
edonismo psicologico! Non sempre e comunque la specializzazione dà felicità. La “soddisfazione
quantitativa dei bisogni” ha comunque un limite intrinseco, al contrario del miglioramento
qualitativo. Egli volle concepire una “solidarietà organica” che si distinguesse nettamente dall’
insieme degli interessi individuali. Gli utilitaristi concepivano i bisogni individuali come soggettivi,
interni, interiori, “spontanei”: egli avvertì l’ esigenza di cogliere l’ “esteriorità” e quindi la capacità
costrittiva dei moventi dell’ azione umana. E giungeva alla conclusione che, nella metodologia della
scienza positiva, “i fatti sociali devono essere trattati “comme des choses””, come “oggetti del
mondo esterno”, come “fatti osservabili”. Così esigeva l’ epistemologia a fondamento della scienza
positiva, “con la sua accentuazione dell’ elemento empirico, osservabile”. Il fatto empirico è
contraddistinto dall’ esteriorità, dall’ oggettività. E’ svincolato dagli stati d’ animo dell’ osservatore
e si impone all’ individuo. Articolando le sue indagini su “De la Division du Travail Social” e su
“Le Suicide”, questioni sociali molto concrete, egli insisteva sopra fatti dall’ indubbia
“verificabilità oggettiva”, privi della aleatoria soggettività dei sentimenti . D’ altra parte, egli
riservava, nelle “Règles de la méthode sociologique”, l’ oggettività e l’ esteriorità del fatto sociale
non tanto allo scienziato-osservatore quanto all’ individuo-attore, proprio perché separava il fatto
sociale dai bisogni utilitaristici ed individualistici: “ … il comportamento umano – notava Parsons –
deve essere interpretato in termini di fattori, di forze che per l’ individuo che agisce possono anche
essere considerate “cose”, fatti che non possono essere alterati in conformità ai suoi desideri o
sentimenti personali. Questa è, in ultima analisi, l’ antitesi dei bisogni degli utilitaristi, che sono
spontanei e soggettivi, mentre le “cose” non sono spontanee ma date, non soggettive ma esterne. Se
i bisogni non sono sufficienti a spiegare il comportamento, l’ unica alternativa sta nei fattori che
rientrano nella categoria delle “cose” in questo senso”. I fatti sociali sono “cose”. Ma non cose
materiali. Non sono, però, neppure fatti puramente psichici, nel senso che siano conoscibili soltanto
attraverso una introspezione mentale. Essi si pongono di fronte all’ osservatore e sono suscettibili di
verifica sperimentale. “La proposizione secondo la quale i fatti sociali devono essere trattati come
cose – scriveva Durkheim ne “Le regole del metodo sociologico” – è una di quelle che han
provocato la maggior parte di contraddizioni”. E notava lo scalpore suscitato dal fatto che
“assimiliamo alle realtà del mondo esteriore quelle del mondo sociale”. Questo atteggiamento di
ripulsa per il fondamento del suo metodo “Significava ingannarsi singolarmente sul senso e la
portata di questa assimilazione, il cui scopo non è quello di abbassare le forme superiori dell’ essere
a quelle inferiori, ma, al contrario, quello di rivendicare per le prime un grado di realtà almeno
uguale a quello che tutti riconoscono alle seconde”. E precisava che “Non diciamo che i fatti sociali
sono cose materiali, ma che sono cose allo stesso titolo delle cose materiali, sebbene d’ un’ altra
maniera”. E chiedendosi: “Che è infatti una cosa?” rispondeva: “La cosa si oppone all’ idea come
ciò che si conosce dal di fuori si oppone a ciò che si conosce dal di dentro. E’ cosa ogni oggetto di
conoscenza che non è naturalmente compenetrabile all’ intelligenza; tutto ciò di cui non possiamo
farci una nozione adeguata attraverso un semplice processo d’ analisi mentale, tutto ciò che lo
spirito non può giungere a comprendere se non a condizione di uscir fuori di se stesso, per via di
osservazioni e di esperimenti, passando progressivamente dai caratteri più esteriori e
immediatamente accessibili a quelli meno visibili e profondi”. Insomma, concludeva a questo
riguardo Durkheim, “Trattare i fatti di un certo ordine come cose non è, dunque, classificarli in
questa o quella categoria del reale; è osservare di fronte ad essi un certo atteggiamento mentale”. La
riflessione metodologica condusse Durkheim, a questo punto, a distinguere tra “cose individuali” e
“cose sociali”. Si trattava, in entrambi i casi, di cose naturali, ma gli era ormai chiaro che “I fatti
sociali erano “cose” caratterizzate, sia per l’ osservatore che per l’ attore, dall’ esteriorità e dalla
costrizione rispetto all’ attore”. Parsons ha schematicamente ben raffigurato l’ epistemologia che
Durkheim andava definendo, rappresentando la sovrapposizione di tre termini: “soggettivo”,
“oggettivo” e “individuale”, ove “Quello soggettivo diventa la categoria residua, quell’ elemento
dell’ oggettivo che non è individuale. A questo punto non c’ è un campo soggettivo che non sia pure
individuale”. Attenendosi ad una metodologia scientifica positivista, e rifiutando le “finalità” nell’
agire umano, tipiche dell’ utilitarismo, egli cercava “cose”, fatti esterni e costrittivi rispetto all’
individuo, che non andassero però riferiti all’ ereditarietà ed all’ambiente (non sociale). E tali fatti,
di natura sociale, li concepì come “entità psichiche”, “fatti – dice Parsons – aventi carattere di realtà
e di oggettività allo stesso modo di quelli che si riferiscono a cose materiali”. Certo la società non
è una realtà materiale; è forse una entità metafisica? Non esiste una “mentalità di gruppo” in
quanto tale; esistono, in quanto sono osservabili, le “menti individuali”. La società, come entità
concreta, è costituita da individui concreti. Durkheim, però, teneva ben distinto il piano sociale da
quello psicologico, giacchè, mentre la psicologia si occupa delle facoltà umane, “il sociale è
presente nella misura in cui l’ azione umana è determinata dalla coscienza “collettiva” in contrasto
con la coscienza “individuale””. E dal momento che i contenuti della “coscienza collettiva” sono
“rappresentazioni collettive” (“représentations”), essa coscienza non dev’ essere più intesa in senso
strettamente “etico”. Le rappresentazioni sono “fatti oggettivi” tanto per l’ “attore” che le avverte e
ne è influenzato nell’ operare, quanto per il sociologo (credenze e sentimenti comuni). La società
non è, comunque, una semplice somma di individui e i fatti sociali non possono esser studiati in
una prospettiva psicologica. La società è una totalità organica, un “individuo collettivo”, che si
esprime in norme e rappresentazioni rivolte ai singoli. La sua azione nei confronti degli individui
che la costituiscono è di formazione e coercizione. I fatti sociali vanno intesi come cose, dotate di
specifiche relazioni e autonomi dagli individui. Il loro complesso costituisce una struttura nella
quale le istituzioni sono funzionali all’ equilibrio dell’ intero. E “istituzioni” sono quei sistemi
organizzati di norme e regole che vincolano l’ agire individuale in un determinato contesto sociale
(dalle pratiche religiose ai contratti giuridici, dai metodi formativi alla costituzione della famiglia
…). Angelo Scivoletto ha sottolineato attentamente il “razionalismo sociale” di Durkheim, anche
nei suoi rischi di una sociologia “immobilistica” e “statica”: “La coscienza collettiva quale insieme
di rappresentazioni collettive, di valori e di norme, ha in sé tutte le verità reali, ci contiene, per così
dire, nel suo orizzonte culturale, ci si impone e si insinua in noi stessi; lo scienziato sociale non ha
che da reinterpretare il senso comune, le verità possedute dalla collettività, per razionalizzarle”.
25 /
Émile Durkheim (4)
Émile Durkheim sviluppò, dopo aver steso “Le Suicide”, due grandi direttrici “teoretiche e
metodologiche” per la definizione della sociologia come scienza autonoma: quella che lo portò a
definire la “teoria del controllo sociale” e quella che volle cogliere la stretta relazione tra religione e
vita sociale. Riguardo alla prima delle due coordinate, è certo che egli trasse dalle indagini
empiriche della “Divisione del lavoro sociale” e del “Suicidio” – per dirla con Talcott Parsons –
importanti implicanze metodologiche ed epistemologiche. Angelo Scivoletto – ne “Il metodo
sociologico di Émile Durkheim” – non esita a riconoscere che egli fece “largo uso di concetti quali
gli “indici di mortalità” o di “coesione sociale”, che a ben vedere non sono che dimensioni formali,
strumenti metodologici, quali noi potremmo intendere la “domination”, la “subordination”, la
formazione delle “hièrarchies” di Simmel”, nei confronti dei quali proprio lui, Durkheim, si era
scagliato con vigore polemico. Scivoletto sottolinea che, proprio nell’ elaborazione e nel ricorso a
quegli “strumenti metodologici”, egli ha notevolmente anticipato “una metodologia moderna e anzi
attuale”, ma rimarca anche che tale metodologia, da lui adottata “con successo nelle opere di ricerca
empirica”, “gli vietò una sistemazione “aperta” in sede teoretica in quanto troppo ancorata alla
“attualità sociale” che, nella sua concezione era effettivamente unica, irripetibile e spaziotemporalmente determinata”. Resta perciò certo che “concetti e teorie generalizzate” da lui
costruiti “nel concreto farsi della ricerca”, sono soltanto “relativamente comunicabili e utilizzabili
in contesti sociali e in tempi diversi”. Non è però meno vero che Durkheim confrontò i suoi
“concetti” metodologici e interpretativi con le teorie sistematiche “classiche”, da Comte a Spencer.
Così, ne “La divisione del lavoro sociale”, aveva rifiutato la concezione utilitaristicaindividualistica dei rapporti contrattuali come fondamento delle relazioni sociali. Ad essi aveva
contrapposto un “sistema di norme” che precedono lo stesso contratto. Era una tesi generale che
Talcott Parsons scorse ben formulata teoreticamente nella “anomia” del suicidio, evenienza sociale
studiata con molta attenzione da Durkheim. Nel “Suicidio”, scrive Talcott Parsons, “emerge che
non soltanto i rapporti contrattuali ma in generale ogni stabile relazione sociale e l’ equilibrio
personale dei membri di un gruppo sociale dipendono dall’ esistenza di una struttura normativa
relativa al comportamento, generalmente accettata dai membri della comunità come fornita di
autorità morale e inoltre dalla loro effettiva sottomissione a tali norme”. Tali norme regolerebbero
la scelta individuale dei mezzi per conseguire i fini, i bisogni ed i desideri del singolo. E Talcott
Parsons aggiunge che, secondo Durkheim, “Quando questa struttura normativa di controllo viene
sconvolta e disorganizzata, la condotta individuale è ugualmente disorganizzata e caotica: l’
individuo si disperde in attività senza senso. L’ anomia è precisamente questo stato di
disorganizzazione, in cui viene meno l’ influenza delle norme sulla condotta individuale”. L’
estrema possibilità, in una tale condizione, è l’ hobbesiana legge del più forte, l’ anarchico arbitrio
per il quale tutti sono ostili nei confronti di tutti. All’ opposto vi è una “integrazione perfetta”,
fondata sulla piena coerenza della comunità, secondo saldi elementi normativi e il controllo
effettivo di tali elementi sull’ individuo. Durkheim avrebbe finito con il radicalizzare il conflitto tra
l’ “elemento individuale”, il caotico desiderio e impulso senza disciplina, e la regola. Del resto, con
Kant, notava che non vi sarebbe alcuna esigenza di una norma regolatrice se non pulsassero nell’
individuo desideri “centrifughi”.Per la verità, riguardo alla natura umana ed alle origini
contrattualistiche della società, Durkheim non era così pessimista come Rousseau. Certamente
“Durkheim – rileva Angelo Scivoletto – non pensa all’ individuo come ad un essere che “in
interiore” porta valori di giustizia e di purezza che la società così come è strutturata gli nega di
esprimere, ed anzi gli reprime dentro imponendo regole innaturali … Egli, al contrario, ravvisa
nella società, in questa società, la fonte di ogni sano ambito di libertà individuale: non è la società
malvagia che toglie alla persona la facoltà di esprimersi in tutta la sua “innata” bontà, ma semmai
esistono individui che, con la loro esuberante e illecita arbitrarietà, rischierebbero, se lasciati fare, di
procurare la rovina dell’ ordine sociale, unica condizione di genuina libertà”. Alla “repressiva”
società esistente, Rousseau contrapponeva una futura società garante di felicità. Durkheim vede
nella società, comunque, una fonte di felicità. Ma, ne “La dualità della natura umana e le sue
condizioni sociali” del 1914, avrebbe esposto esplicitamente l’ idea di una natura umana che è
lacerata tra la tendenza egoistica e istintiva e quella sociale. La prima precluderebbe all’ essere
umano l’ integrazione completa, e la socializzazione esigerebbe, comunque, un forte sacrificio ed
una conseguente infelicità. Tesi che anticipava, da vicino, quella di Sigmund Freud ne “Il disagio
della civiltà”: la civiltà comporta l’ infelicità dell’ individuo perché le sue norme esigono la
repressione delle sue pulsioni in nome di un sempre più forte principio di realtà e di convivenza
reciprocamente rispettosa. Circa la dualità tra impulsi egoistici e socialità, scriveva Durkheim che
“l’ uomo stesso <ne> ha avuto, in ogni tempo, vivo senso. Ovunque, infatti, egli si è concepito
come formato da due esseri eterogenei: da un lato il corpo, dall’ altro l’ anima … Per secoli si è
creduto che l’ anima potesse, fin da questa vita, sfuggire al corpo e condurre in lontananza una
esistenza autonoma … Una volta che il corpo si dissolve e si annienta, l’ anima sopravvive, e in
condizioni nuove prosegue, in un tempo più o meno lungo, il corso del suo destino”. E Durkheim
prendeva atto che in tutte le culture vi è una “credenza così universale e permanente” che non può
esser considerata illusoria. E’ innegabile che “La nostra intelligenza come la nostra attività
presentano due forme assai differenti: da una parte vi sono le sensazioni e le tendenze sensibili,
dall’ altra il pensiero concettuale e l’ attività morale. Ciascuna di queste due parti di noi stessi
gravita attorno a un polo che gli è proprio e questi due poli non sono solamente distinti, ma si
configurano come opposti”. E non vi è alcun dubbio che “I nostri appetiti sensibili sono
necessariamente egoisti; hanno per oggetto la nostra individualità e essa sola … Al contrario, l’
attività morale si riconosce dal fatto che le regole di condotta cui essa si conforma sono suscettibili
di essere rese universali … La moralità si genera solo nel disinteresse, nell’ attaccamento a qualcosa
di altro da noi stessi … Una sensazione di colore o di suono è strettamente dipendente dal mio
organismo individuale e io non posso staccarla da esso … Al contrario i concetti sono sempre
comuni a una pluralità di uomini”. Se, quindi, “Vi è in noi, un essere che si rappresenta tutto in
rapporto a sé, dal suo punto di vista, che, in quel che fa, non ha altro oggetto che se stesso … ve ne
è un altro anche che conosce le cose “sub specie aeternitatis”, come se partecipasse di un pensiero
diverso dal nostro e che, nello stesso tempo, nei suoi atti, tende a realizzare fini che lo superano”.
Durkheim è, così, certo che “La vecchia formula “Homo duplex” < sia > verificata nei fatti”, in
quanto “Non possiamo consacrarci ai fini morali senza dipendere da noi stessi, senza urtare gli
istinti e le propensioni più profondamente radicate nel nostro corpo. Non esiste atto morale che non
implichi sacrificio, in quanto, come ha dimostrato Kant, la legge del dovere non può farci obbedire
senza umiliare la nostra sensibilità individuale”. Mentre rifletteva sulle statistiche del suicidio e sui
loro legami con l’ anomia, Durkheim ripensò alla funzione delle norme sociali e alla loro capacità
di costrizione nei confronti dell’ individuo. Non credeva alla “fisicità” della forza di costrizione
delle norme e si interrogò sulla natura di una tale “costrizione”. E distinse tra la costrizione naturale
(come ad esempio la “trasgressione di una norma fisiologica”, che nel rifiuto del cibo conduce
inevitabilmente a morir di fame) e la costrizione morale, nella quale la sanzione che segue, ad
esempio, ad un reato, non è meccanica, ma scaturisce dalla “volontà umana generale”. “Il problema
di Durkheim – scrive al riguardo Talcott Parsons – era trovare un modo per inserire il concetto di
norma nella sua metodologia positivistica, introducendo il minimo di modificazioni: egli lo risolve
considerando la norma come un fenomeno della situazione esterna per l’ individuo che agisce. La
sanzione s’ inserisce soltanto indirettamente poiché, partendo dal presupposto dell’ atteggiamento
eticamente neutro dello scienziato, < per il primo Durkheim > non si ha nessun altro motivo d’
obbedienza alla legge se non il tentativo d’ evitare le sanzioni”. Ma ora Durkheim riformulava l’
idea della costrizione come una “adesione volontaria”, come dovere, come “obbligo morale” di
rispettare la norma. E la costrizione morale si presentava ben diversamente da quella fisica. La
nuova tesi che andava emergendo ne “L’ éducation morale” era che vi è, da parte, dell’ individuo,
un “atteggiamento di rispetto” nei confronti delle norme. Un tale atteggiamento non può essere
ridotto al mero calcolo utilitaristico per evitare la sanzione. Esso dev’ essere ricondotto, piuttosto,
all’ esigenza dell’ ordine sociale, e costringe a ripensare alla moralità, tanto nell’ esigenza della
obbligatorietà che accompagna la norma, quanto nella desiderabilità del bene che dal rispetto della
norma scaturisce. Durkheim sembra aver intravvisto il Super-io di Sigmund Freud – l’ istanza
morale introiettata e inconscia – quando, con la sua “teoria dell’ obbligo morale” ha concepito la
realtà della norma non più come meramente esteriore-estranea, ma interiore all’ individuo. A
ragione, Talcott Parsons nota che “il sistema delle norme di obbligo morale diventa l’ elemento
sociale come tale” e che “in questi termini l’ integrazione di un gruppo sociale consiste nel
riconoscimento comune, da parte dei suoi membri, di un singolo corpo integrato da norme dotate di
autorità morale”. Stabilità e ordine di una società sono vincolate al fatto che essa è, comunque, una
“comunità morale”. Per questo le “rappresentazioni collettive” non debbono più essere concepite
come “un sistema di idee “riguardanti” una realtà empirica esistente fuori dalla mente degli
individui”; esse vanno intese, piuttosto, come “corpo di idee che formano esse stesse il fattore
effettivo dell’ azione”. Non si pone più la questione se esista, in termini metafisici, una “mentalità
collettiva”: vi sono, a fondamento dell’ ordine sociale, delle “norme ideali” che vincolano
moralmente i membri della società. Quindi “la moralità è un fenomeno sociale” o, il che è lo stesso,
“la società è un fenomeno morale”. E le norme morali sono quei “fattori reali dell’ azione”, di cui
deve occuparsi la sociologia. Essa è scienza “esplicativa” e non “normativa” poiché non valuta le
norme morali-sociali, di per se stesse, ma si occupa della loro efficacia nel guidare l’ azione
individuale. Angelo Scivoletto ha evocato la salda convinzione del Durkheim delle “Règles”
secondo cui “per agire con conoscenza di causa non basta sapere ciò che dobbiamo volere, ma
occorre sapere anche perché lo dobbiamo”. Scivoletto, laureato in filosofia, è stato dapprima
ordinario nei licei, per poi conseguire la libera docenza in filosofia teoretica nel 1965. Dedicatosi
alla sociologia nell’ Università di Parma, ha dato un forte impulso all’ Istituto di Sociologia,
promuovendo tra l’ altro una serie di indagini teoriche e sperimentali. La sua originale riflessione
teoretica, di cui sono da ricordare almeno: “Il discorso analogico” (1958), “Dialogo sulla analogia”
(1958) e “Il segno della ragione” (1963) gli ha fornito robuste coordinate euristiche per la
successiva e feconda ricerca sperimentale che si è mossa nella dimensione urbana, universitaria e
politica. Riguardo alla collocazione della morale nella sociologia di Durkheim, Scivoletto ha scritto,
senza mezzi termini, che anch’ essa “non si costituisce se non come emanazione della società in
quanto tale e che quindi lo strumento con cui si può tendere a razionalizzarla è la sociologia”.
Insomma: “Durkheim pensa posivisticamente anche la morale, e conta di poterne dare, o che se ne
possa comunque dare, una sistemazione razionale dalla quale discendano i motivi che debbano
ispirare la condotta umana”. Talcott Parsons (1902-1979), da parte sua, è stato il primo ad
imprimere alla sociologia nord-americana, sino ad allora attestata su ricerche sostanzialmente
empiriche, una decisa svolta metodologica e teorica. Egli si è giovato di Max Weber per elaborare
la sua teoria dell’ azione sociale (oltre a “La struttura dell’ azione sociale”, 1937, sono da ricordare
“Il sistema sociale”, 1951, e “Teoria sociologica e società moderna”, 1967), ma certamente dovette
a Durkheim la sua eminente attenzione per apparati e dispositivi volti a consolidare la solidarietà, l’
integrazione e la coesione sociale. Egli fu particolarmente attento all’ interazione dei soggetti sociali
ed alle norme, alle motivazioni, ai fini, che la regolano. Alla sociologia, non soltanto nordamericana, egli ha lasciato categorie euristiche fondamentali come quelle di “funzione” e di
“sistema”, che avrebbero consentito di padroneggiare la complessità ed eterogeneità sociale e
connettere omogeneamente strutture altrimenti eterogenee.
26 /
Émile Durkheim (5)
L’ ultimo, ma non il definitivo, Émile Durkheim – stroncato da una morte prematura – fu quello
delle “Forme elementari della vita religiosa”. Talcott Parsons gli ha dedicato un capitolo della sua
“The structure of Social Action”, dal titolo significativo: “L’ ultima fase: religione ed
epistemologia”, giacchè vi convivono, distinti epperò correlati, l’ epistemologia, come esito il più
maturo di tutta la riflessione precedente, e la teoria della religione. Un argomento, quest’ ultimo
che, peraltro, aveva sollecitato l’ ancor giovane Durkheim, senza mai abbandonarlo. E “Les formes
élémentaires de la vie religieuse”, costituiscono tanto una « monografia tecnica sul totemismo
australiano » quanto un rigoroso « studio teorico » contraddistinto da “un ragionamento teoretico
estremamente acuto”. L’ idea di fondo era che “la religione è l’ insieme di leggi che regolano le
azioni e le relazioni sociali” e riteneva “la distinzione tra lo stato morale e lo stato religioso …
relativamente secondaria”. “Una religione – appuntava nelle “Questioni preliminari” de “Les
formes” – è un sistema solidale di credenze e di pratiche relative a cose sacre, cioè separate e
interdette, le quali uniscono in un’ unica comunità morale … tutti quelli che vi aderiscono”. Egli
volle, quindi, risalire alle espressioni-manifestazioni originarie, semplici, primigenie, elementari
della religione, ritenendo “più corretto dal punto di vista metodologico cercare di caratterizzare i
fenomeni elementari di cui è formata ogni religione, prima del sistema prodotto dalla loro unione”.
Nella “Conclusione” de “Les formes” dichiarava che “Per quanto semplice sia il sistema < totemico
> che abbiamo studiato, vi abbiamo ritrovato tutte le grandi idee e i principali atteggiamenti rituali
che sono alla base anche delle religioni più progredite: la distinzione delle cose tra sacre e profane,
la nozione di anima, di spirito, di personalità mitica, di divinità nazionale ed anche internazionale, il
culto negativo e le pratiche ascetiche che ne costituiscono la forma esasperata, i riti di oblazione e di
comunione, i riti imitativi, i riti commemorativi, i riti piaculari – nulla di essenziale è assente”. “Se
nelle umilissime società che abbiamo studiato – aggiungeva – siamo riusciti finalmente a scorgere
alcuni degli elementi da cui sono costituite le nozioni religiose fondamentali, non c’ è ragione per
non estendere alle altre religioni i risultati più generali della nostra ricerca”. L’ induzione che traeva
dall’ analisi del totemismo voleva esser valida per ogni religione e “Se presso alcuni popoli le idee
di sacro, di anima, di dèi, si spiegano su base sociologica, si deve scientificamente presumere che,
in linea di principio, la stessa spiegazione valga per tutti i popoli in cui si ritrovano le stesse idee
con gli stessi caratteri essenziali”. E coglieva tra religione e società una sorta di causalità reciproca,
per cui il fondamento della società è religioso e, nello stesso tempo, la religione è l’ originaria
espressione sociale. Tant’è che nell’ interazione delle coscienze individuali cresce un complesso di
immagini e sentimenti che si costituiscono poi secondo proprie leggi. Del resto, Durkheim, nella
stessa opera, sottolineava le radici religiose delle prime cosmologie, e riconduceva, quindi, anche la
scienza ad un originario sostrato religioso. Le “categorie” aristoteliche – che costituiscono l’
ossatura della conoscenza e della comunicazione – “sono di origine religiosa” e perciò “devono
essere anch’ esse cose sociali, cioè prodotti del pensiero collettivo”. Con la qual cosa egli tracciava
una sorta di triangolo equilatero ai cui vertici stanno società – scienza – religione, tra di loro
inscindibilmente connesse. E definiva l’ essenza della religione attraverso due antitesi, che
costituiscono i pilastri della teoria della religione prospettata ne “Les formes”: sacro / profano, da
una parte, e (riguardo ai fenomeni religiosi) credenze / riti, dall’ altra. Per la prima, scriveva
Durkheim che “Tutte le credenze religiose conosciute, siano esse semplici o complesse, hanno uno
stesso carattere comune: esse presuppongono una classificazione delle cose reali o ideali che si
rappresentano gli uomini, in due classi o in due generi opposti, definiti generalmente con due
termini distinti – tradotti abbastanza bene dalle designazioni di sacro e profano”. E continuava nella
convinzione che “La divisione del mondo in due domini che comprendono l’ uno tutto ciò che è
sacro, e l’ altro tutto ciò che è profano, è il carattere distintivo del pensiero religioso: le credenze, i
miti, gli gnomi, le leggende sono rappresentazioni, o sistemi di rappresentazioni che esprimono la
natura delle cose sacre, le virtù e i poteri loro attribuiti, la loro storia, i loro rapporti reciproci e con
le cose profane”. Durkheim avvertiva però che “… per cose sacre non bisogna intendere soltanto
quegli esseri personali che vengono chiamati dèi o spiriti; una roccia, un albero, una fonte, un
ciottolo, un pezzo di legno, una casa, insomma qualsiasi cosa può essere sacra. Un rito può avere
questo carattere; ed anzi non esistono riti che in qualche grado non lo posseggano. Esistono parole,
espressioni, formule che possono essere pronunciate soltanto dalla bocca di persone consacrate;
esistono gesti e movimenti che non possono essere eseguiti da chiunque”. Tra sacro e profano si
impone una eterogeneità assoluta e da sempre “lo spirito umano” li ha “concepiti come genri
separati … come due mondi tra cui non c’ è nulla di comune”. Le cose sacre – in quanto si
attribuiscono loro facoltà e virtù eccezionali – esigono un atteggiamento di “rispetto” e “cautela”.
La seconda distinzione fondamentale vuole che le espressioni religiose siano o credenze o riti, pur
non separabili, per cui l’ ignoranza delle credenze impedisce la comprensibilità del rituale di quella
religione. “Le credenze propriamente religiose – scrive Durkheim – sono sempre comuni a una
collettività determinata, che fa professione di aderirvi e di praticare i riti ad esse solidali”. Le
credenze “non sono soltanto ammesse a titolo individuale da tutti i membri di questa collettività, ma
sono cosa del gruppo e ne costituiscono l’ unità”. Ed è per lui importante sottolineare che “ovunque
osserviamo una vita religiosa, essa ha per substrato un gruppo definito” per cui “Anche i culti
privati, come quello domestico o corporativo, adempiono a questa condizione, essi sono sempre
celebrati da una collettività, cioè la famiglia o la corporazione”. In sostanza, mentre le credenze
sono espressioni del pensiero, i riti esigono l’ azione: “I riti sono azioni che vengono compiute in
relazione con le cose sacre”, e “Le credenze religiose – ha notato al riguardo Talcott Parsons – sono
credenze che riguardano le cose sacre, la loro origine, funzione e importanza per l’ uomo”. Del
resto, lo stesso Parsons rileva che, subito all’ inizio de “Les formes”, Durkheim “osserva che un
elemento così persistente e costante nella vita umana, come è la religione, è inconcepibile se le idee
a esso associate fossero semplici illusioni” e non riprendessero una qualche realtà. E questo lo
conduce a criticare quelle concezioni che colgono, nelle “idee religiose”, l’ “elemento principale
della religione” non meno di quelle che vorrebbero “far derivare queste idee dalle impressioni che
gli uomini hanno del mondo empirico”. Di qui la critica tanto all’ “animismo” quanto al
“naturismo”, perché suggeriscono la natura illusoria delle “idee religiose”, le quali avrebbero, nella
loro prospettiva, la funzione di spiegare, pre-scientificamente, fenomeni naturali (dai sogni alle
eclissi) suscettibili di una spiegazione scientifica. Né i fatti psicologici “interni” (i sogni) né i fatti
esteriori (le eclissi, gli uragani …) sono i riferimenti privilegiati delle “idee religiose”. Vi è, invece,
un terzo tipo di fatti che esse significano: “la realtà riflessa nelle idee religiose deve essere la realtà
sociale”. E ancora Parsons annota come, secondo Durkheim, “la società è … la realtà che sta alla
base dei simboli del rituale religioso perché è l’ unica realtà empirica che, avendo natura morale,
può essere ritenuta il fondamento dell’ atteggiamento rituale” e “il rituale è … un’ espressione dei
valori ultimi comuni che costituiscono l’ elemento normativo specificamente “sociale” nella società
concreta”. Tale era la conclusione cui era giunto attraverso una letteratura antropologicaetnologica-etnografica molto ampia e fortemente documentata, sul totemismo australiano e dei
“popoli indiani dell’ America settentrionale”, tra cui si dovrebbero ricordare, almeno, i nomi di C.
Strehlow, H. Klaatsch, K. L. Parker, E. Eylmann, J. Mathew, B. Spencer, F. J. Gillen, A. W.
Howitt, G. Taplin; molti altri etnologici andrebbero ricordati ancora, ma basti il nome di James
George Frazer, l’ autore del classico “The Golden Bough. A Study in Magie And Religion” (“Il
ramo d’ oro. Studio sulla magia e la religione”, 1922) che avrebbe ispirato “Totem und tabu” di
Sigmund Freud, e le “Bemerkungen” di Ludwig Wittgenstein. E’ solo da rilevare che Durkheim
coglieva nell’ etnologia intenti solamente descrittivi, senza trovarvi alcuna preoccupazione
sociologica. I copiosi dati empirici che l’ etnologia gli offriva dovevano, dunque, esser “filtrati” con
opportune categorie interpretative e indurre generalizzazioni metodologiche. Proprio ne “Les
formes”, ricorda Talcott Parsons, vi è “La principale esposizione della teoria epistemologica di
Durkheim” e, anche si ritiene, senz’altro, che “I problemi dell’ epistemologia sono, naturalmente,
problemi filosofici e non scientifici”, è certo che le sue “posizioni epistemologiche” siano
“intimamente legate al suo sistema di teoria scientifica”. Ora è certo che, pur senza mai aver
professato esplicitamente una rigorosa aderenza empirica della ricerca, Durkheim ne “Les régles”
pensò al fatto sociale come ad una “cosa”. Anche se la cosa in questione era una norma, un ideale.
E, comunque, un ideale esiste, è un fatto, tanto per colui che agisce in vista della sua realizzazione,
quanto per il sociologo che lo “osserva” come “esterno”. Ora, ne “Les formes” Durkheim pervenne
definitivamente alla convinzione, per dirla con Parsons, che “la società esiste soltanto nella mente
degli individui”, e che “Il fattore sociale non si doveva cercare “al di fuori” di questa entità
concreta” che è l’ individuo concreto “dal punto di vista soggettivo”. Durkheim, però, ritiene di
aver conseguito che “le categorie fondamentali del pensiero, e di conseguenza la scienza, hanno
origini religiose” e, se è vero che “fino a un momento relativamente avanzato dell’ evoluzione, le
regole della morale e del diritto non si distinguevano dalle prescrizioni rituali”, allora è ragionevole
credere che “quasi tutte le grandi istituzioni sociali sono sorte dalla religione”.
Ma egli è
consapevole che le “categorie” di cui parla e che sono essenziali alla conoscenza scientifica, non
possono avere un’ origine empirica: la prospettiva empirista, in questo senso, è errata. Ma sbagliano
anche i kantiani (aprioristi) nel ritenere impossibile che se ne possa dare una “spiegazione”
empirica. “Il caos delle impressioni sensoriali –chiarisce Parsons – è organizzato in un ordine di
conoscenza valida per mezzo delle categorie. Ma l’ uso strumentale della conoscenza, per il
perseguimento di fini immediati, crea un nuovo caos potenziale il quale è a sua volta ricondotto all’
ordine dalle norme istituzionali. Infine s’ instaura l’ ordine nel caos fortuito dei simboli concreti per
mezzo del comune riferimento alla realtà sociale”. Durkheim annota che “La materia del pensiero
logico è costituita di concetti: cercare come la società possa aver partecipato alla genesi del pensiero
logico conduce quindi a domandarsi come essa possa aver preso parte alla formazione dei concetti”.
Il concetto non può esser inteso, semplicemente, come un’ “idea generale”. L’ individuo
generalizza, comparando le sue percezioni in quel che hanno in comune, ma non si comprende
“perché mai la generalizzazione sarebbe possibile nella società e attraverso di essa”. Certamente,
ciò che contraddistingue il pensiero logico non è soltanto la “maggiore estensione delle
rappresentazioni che lo costituiscono”. E Durkheim si chiede: “Se le idee particolari non hanno
nulla di logico, perché sarebbe altrimenti per le idee generali?”. Semplicemente perché “Il generale
non esiste che nel particolare; esso è il particolare semplificato e impoverito … In ogni specie di
religione gli dèi sono individualità distinte le une dalle altre; ciononostante essi vengono concepiti,
non già percepiti … ciascuno di noi si forma una certa nozione degli individui con cui è in rapporto,
del loro carattere, della loro fisionomia, dei tratti distintivi del loro temperamento fisico e morale:
queste nozioni sono autentici concetti”. Ecco la risposta circa la natura dei concetti-categorie: “Le
rappresentazioni sensibili sono in un flusso perpetuto; esse si spingono come le onde di un fiume …
Il concetto invece è al di fuori del tempo e del divenire … Un concetto non è il mio concetto; mi è
comune con altri uomini o può in ogni caso essere loro comunicato … Il concetto è una
rappresentazione essenzialmente impersonale: è attraverso di esso che le intelligenze comunicano”.
La conseguenza di questo era che Durkheim, pur non rigettando del tutto il suo positivismo,
approdava ad un “idealismo” secondo il quale, pur continuando la società ad essere suscettibile di
osservazione, essa consisteva “Esclusivamente in idee e sentimenti”, anzi – notava Parsons –
neppure di “idee” ma dell’ “Idea”. Diventava chiaro a Durkheim “quale sia la parte della società
nella genesi del pensiero logico”. Esso sarebbe nato nel “momento in cui, al di sopra delle
rappresentazioni fugaci che deve all’ esperienza sensibile, l’ uomo è arrivato a concepire un mondo
di ideali stabili, luogo comune delle intelligenze. Pensare logicamente è infatti sempre, in qualche
misura, pensare in maniera impersonale; è anche pensare “sub specie aeternitatis”. L’ ultimo
Durkheim ritenne, non senza contraddizioni, che “lo scopo della sociologia sia studiare i sistemi
delle idee di valore “in se stessi””.
27 /
Franz Brentano
Franz Brentano mosse dall’ esigenza di una filosofia come scienza rigorosa. Avviò un confronto
fortemente polemico e reattivo con l’ idealismo, campione delle filosofie speculative. Hegel e gli
altri filosofi romantici avevano preteso di edificare “sistemi del mondo” che cogliessero la totalità e
l’ intero, ma lo fecero in modo del tutto arbitrario, assumendo come certe delle mere ipotesi. Così,
Hegel aveva creduto, illusoriamente e gratuitamente, di poter ricondurre la storia e la natura alle
manifestazioni dialettiche e necessarie di uno Spirito assoluto. La filosofia idealistica era priva di un
fondamento scientifico. Brentano rinveniva in Aristotele quel rigore metodologico e scientifico di
cui la filosofia avrebbe dovuto riappropriarsi. Intravvide, con un approccio “ciclico”, lo
svolgimento della storia della filosofia occidentale secondo quattro fasi: quella dell’ ascesa,
metodologicamente corretta e dominata dal problema teoretica; quella dello “scadimento” all’
esigenza pratico-scientifica; quella scettica; quella mistica e idealistica, che rimedia allo scetticismo
con il dogmatismo, privo di fondamenti rigorosi. Poiché giudicava la filosofia sua contemporanea
essere allo stadio mistico, ritenne di poter contribuire alla sua evoluzione teoretica con un
ripensamento empirico-psicologico del funzionamento della mente. E pose, alla lontana, le basi per
la fenomenologia di Edmund Husserl, riscoprendo l’ intenzionalità della coscienza in chiave
moderna. Propugnò uno “psicologismo” secondo il quale i concetti debbono essere ricondotti ad atti
intenzionali della coscienza. A tali atti egli riconobbe una natura del tutto psicologica. Brentano era
convinto che, mentre i fenomeni fisici possono essere conosciuti solo in via probabile, quelli
psichici sono immediatamente evidenti, certi e accompagnati da coscienza immediata. E
distingueva tra una “coscienza primaria”, che si ha quando il soggetto si riferisca ad un fenomeno
fisico, e una “coscienza secondaria”, se il riferimento è ad un fenomeno psichico. Solo in tal caso la
percezione è evidente. Collocava così, al centro della sua attenzione, non tanto le cose “esteriori”,
quanto le “strutture fenomeniche”, le cose come si mostrano-evidenziano-appaiono nell’ orizzonte
intenzionale del soggetto. Ed era certamente questa la via maestra che egli avrebbe indicato ad
Edmund Husserl, uno dei suoi maggiori e numerosi allievi, tra i quali sono da ricordare almeno
Anton Marty, Alexius Meinong, Kazimierz Twardowski e lo stesso Sigmund Freud. Lo
psicologismo di Brentano fu decisivo per l’ analisi dei fatti di coscienza avviata da Husserl con “La
filosofia dell’ aritmetica” (1891) e volta ad una conferma della validità oggettiva delle leggi
logiche, scientifiche e matematiche. Husserl, d’ altra parte, avrebbe contrapposto allo psicologismo
di Brentano, il “logicismo” di Gottlob Frege, Bertrand Russell e altri, cercando una mediazione che
assolvesse alle esigenze di entrambi, evitandone però, le rispettive aporie. Lo psicologismo non
giustificava, infatti, l’ universalità e la necessità di quelle leggi; ma il logicismo, da parte sua, non
spiegava come leggi universali e necessarie potessero essere alla portata della mente umana. In ogni
caso, la filosofia dell’ intenzionalità di Brentano costituì uno svincolo e uno snodo di primario
rilievo nella teoria della conoscenza, non solo tedesca, del tardo Ottocento, e rappresentò un banco
di prova per la fenomenologia di Husserl. Brentano poneva capo ad un travagliato dibattito attorno
alla rappresentazione come ”analogon”, sul piano psicologico, dell’ oggetto. Sino ad allora, la
rappresentazione era stata concepita come immagine mentale dell’ ‘oggetto-cosa reale. E si era
riproposta la questione neo-kantiana del rapporto tra i fenomeni rappresentati e le forme
trascendentali-soggettive che conferiscono loro struttura formale. Franz Brentano era nato nel 1836
a Marienberg, nella Prussia Renana. Studiò filosofia e teologia a Monaco, Würzburg e Berlino, e,
dopo aver fatto parte, per diversi anni, dell’ Ordine domenicano, lo avrebbe abbandonato,
rinunciando al cattolicesimo. Era stato allievo di Friedrich Adolf Trendelenburg e fu docente di
filosofia a Würzburg e a Vienna, sino al 1895, anno in cui lasciò l’ insegnamento. Visse, da allora,
a Firenze, per poi stabilirsi a Zurigo, all’ inizio della Grande Guerra, ove risiedette sino alla morte,
nel 1917, ad un anno dalla fine del primo conflitto mondiale. Attento studioso della Scolastica e
della filosofia di Aristotele (“Sui molteplici significati dell’ essere in Aristotele”, 1862; “La
psicologia di Aristotele”, 1867; “Il creazionismo di Aristotele”, 1882; “Aristotele e la sua visione
del mondo”, 1911; “La dottrina di Aristotele sull’ origine dello spirito umano”, 1911), vari suoi
saggi sono usciti postumi, come – a parte “Sull’ origine della conoscenza morale” (1889) e “Il
futuro della filosofia” (1893) – “ Sull’ esistenza di Dio” (1929) e “Verità ed evidenza” (1930).
Brentano, è però da ricordare, soprattutto, per i saggi di psicologia, primo fra di essi “La psicologia
dal punto di vista empirico” (1874) e le “Ricerche di psicologia della sensazione” (1907). . La via di
Brentano alla psicologia è marcatamente diversa da quella di Wilhelm Wundt. Il quale, con Theodor
Fechner e Hermann Ebbinghaus, aveva ripreso l’ esigenza sollevata da Johann Friedrich Herbart, di
isolare i fatti psicologici minimi, attraverso un’ analisi scientifica e sperimentale dell’ esperienza
psichica. Secondo una tale prospettiva, i fatti psichici si aggregherebbero secondo leggi che possono
essere colte tramite la sperimentazione e l’ impiego di strumenti matematici, ricorrendo all’
introspezione oggettiva per le rilevazioni di laboratorio. L’ associazionismo e la “chimica psichica”
di Wundt furono avversati, all’ interno della stessa fisiologia della percezione, da scienziati come
Hermann Helmholtz, il quale sostenne l’ irriducibilità della percezione alla semplice immediatezza.
La percezione non è riducibile ad una semplice ricezione passiva: essa è il frutto di funzioni
logiche. All indirizzo esplicativo-sperimentale degli psicologi associazionisti, Brentano oppose un
metodo descrittivo-empirico. Ridurre i fenomeni psichici a dati percettivi atomici, estremamente
semplici, è artificioso. Non si tratta di spiegarli, scomponendoli nei loro presunti elementi percettivi
primi, bensì di descriverli-evidenziarli per quel che sono e si mostrano, nel loro fluire. Sbagliava
Wundt quando scomponeva la psiche nei suoi presunti elementi costitutivi, per poi ricomporli in
unità secondo leggi in virtù delle quali si assocerebbero. Proprio quanto scomponeva i fenomeni
psichici nelle loro elementari componenti “atomiche”, Wundt ne perdeva il senso e la natura. L’
esperienza psichica si può descrivere, ma non spiegare. Ed una distaccata osservazione psicologica
mostra che gli atti mentali sono da ricondursi ai loro “oggetti”. I fenomeni psichici sono, tutti,
specificamente, sia pur diversamente, rivolti, in modo dinamico, ad un riferimento esterno, “altro”.
Così, ad esempio, la rappresentazione rimanda al rappresentato. Si tratta della loro “intenzionalità”.
Così come voleva la Scolastica medioevale,da Alberto Magno a Tommaso d’ Aquino, da Duns
Scoto a Guglielmo d’ Ockham. Destituite di fondamento le “species”, in quanto inadeguate ad esser
termini di mediazione tra il soggetto e le cose, il Trecento aveva scoperto l’ “intentio” come segno
che significa una classe di oggetti. “Ogni fenomeno psichico – scriveva Brentano – è caratterizzato
da ciò che gli scolastici del Medioevo hanno chiamato l’ esistenza intenzionale (o anche mentale) di
un oggetto, e che noi potremmo chiamare, sia pure con parole non del tutto prive di ambiguità, il
riferimento ad un contenuto, la direzione verso un oggetto, sotto il quale termine non va intesa una
realtà, ovvero l’ oggettualità immanente”. Brentano riteneva, insomma, che tutti i fenomeni
psichici sono contraddistinti dall’ “intenzionalità” in quanto rimandano ad un “oggetto immanente”.
E l’ “oggetto” è “immanente” in quanto è presente all’ atto intenzionale. Brentano volle classificare
i fenomeni psichici come: rappresentazioni, aspettazioni, volizioni, secondo un criterio gerarchico,
dal momento che non vi è “aspettazione”, ad esempio una credenza, che non presupponga una
rappresentazione di quello in cui si crede, e, del resto, un atto volitivo esige non soltanto una
rappresentazione del processo cui l’ atto mira, ma anche la credenza-fiducia attorno ai mezzi atti a
conseguire il fine voluto. Nella rappresentazione, l’ oggetto è semplicemente presente; nell’
aspettazione, l’ oggetto è affermato o negato; nella volizione, l’ oggetto è amato o negato. Brentano,
all’ inizio, credeva che l’ oggetto potesse essere tanto irreale quanto reale, ma, successivamente,
concluse che, comunque, l’ oggetto dell’ intenzionalità è reale. L’ intenzionalità costituiva una
nuova coordinata metodologica per la psicologia, che, pur non rinunciando all’ introspezione, era
indotta a considerare i diversi tipi di oggetti cui ineriscono i diversi atti psichici. Un determinato
atto psichico si riferisce ad un altrettanto determinato tipo di oggetto, che gli è correlato. “Intentio”,
“intentionalité”, « Intentionalität »: era la grande lezione che – attraverso Brentano – sarebbe giunta
dalla Scolastica medioevale ad Edmund Husserl, il fondatore della fenomenologia contemporanea.
Presso gli Scolastici, “intentio” era lo stesso che concetto e intenzionalmente (“intentionaliter”)
stava per “concettualmente”. Tommaso d’ Aquino intese il concetto mentale proprio come
“intentio”, in quanto esso si riferisce ad un oggetto (“in alium tendere”). Gli Scolastici intesero poi
l’ “intentio” come l’ atto stesso dell’ intelletto che si rivolge al suo oggetto (“intentio intellecta”) e
distinsero tra l’ “intentio recta”, rivolta alla cosa, e l’ “intentio obliqua”, diretta al soggetto dell’ atto
intellettivo. Ma distinsero anche tra i contenuti concreti dell’ atto intellettivo (“primae intentiones”)
in quanto oggetti d’ esperienza, e i contenuti astratti (“secundae intentiones”) come i concetti (le
“specie”). Brentano riformulò in chiave moderna la teoria dell’ intenzionalità. Proprio la
caratteristica dell’ intenzionalità distingue i fenomeni psichici da quelli fisici. Qualsiasi fenomeno
psichico è coscienza di un oggetto, è diretto verso un oggetto, rimanda ad un contenuto. E come si è
detto, l’ oggetto dell’ atto intenzionale è, almeno per il primo Brentano, immanente all’ atto
psichico. E del resto tutti gli atti psichici, proprio perché intenzionali, sono accompagnati da
autocoscienza. Husserl avrebbe fondato la sua fenomenologia sull’ intenzionalità degli atti psichici,
anche se si sarebbe scostato dal maestro Brentano su alcuni punti. Ad esempio, non ritenne che l’
intenzionalità costituisse il divario tra fenomeni psichici e fenomeni fisici, giacchè rifiutò di
attribuire, indiscriminatamente, a tutti i fenomeni psichici, l’ intenzionalità. Eppoi volle considerare
l’ oggetto dell’ atto intenzionale soltanto come significato o senso: l’ oggetto non è immanente all’
intenzionalità. La trascende. L’ oggetto dell’ atto intenzionale non è affatto una rappresentazione
mentale dell’ oggetto reale. La questione non era di semplice soluzione. E rimandava alle
oscillazioni di Brentano in merito. Vi sono o no gli “entia rationis”, gli enti di ragione, o soltanto gli
oggetti reali sono oggetti del pensiero? Anton Marty ricondusse la questione gnoseologica della
relazione tra atti mentali conoscitivi e loro oggetti alla dimensione linguistica, e distinse tra il
significato e la denotazione. La cosa concreta e individua che io percepisco, viene da me denotata
con un nome comune, ma nello stesso tempo la rappresento mentalmente e perciò le conferisco un
significato. L’ oggetto dell’ intenzionalità della coscienza non è né la cosa reale né l’ oggetto non
reale, bensì la loro correlazione con la coscienza. Kasimierz Twardowski – il fondatore di quella
Scuola logica polacca che avrebbe annoverato tra i suoi più significativi esponenti J Lukasievwicz e
A Tarski – volle collocare, tra l’ oggetto intenzionato e l’ atto psichico dell’ intenzionare, il
contenuto dell’ atto. Nella rappresentazione di un oggetto, è pensato il suo contenuto, e l’ oggetto
viene rappresentato mediante il contenuto della rappresentazione. Alexius Meinong anticipò
Friedrich Ludwig Gottlob Frege e Bertrand Russell, con la teoria degli oggetti e la teoria della
denotazione. Egli obiettò, semplicemente a Brentano, che, se l’ oggetto conosciuto fosse soltanto
quello reale, delle classi e delle relazioni matematiche non resterebbe nulla. E quindi
contraddistinse l’ oggetto, non tanto per la sua esistenza reale, quanto per la sua essenza, il suo
“Sosein”, per cui l’ ippogrifo, o la chimera di cartesiana memoria, sono oggetti della conoscenza, a
prescindere dalla loro reale esistenza. Secondo Twardowski, seppur non esista realmente l’
ippogrifo, io ho la rappresentazione del relativo contenuto. Secondo Meinong la correlazione con
la coscienza dell’ oggetto ippogrifo sussiste ma in via del tutto ipotetica, almeno fino a quando non
ne abbia verificata la reale esistenza.
28 /
Wilhelm Dilthey (1)
Wilhelm Dilthey operò una netta distinzione tra le “scienze della natura” e le “scienze dello spirito”,
riservando alle prime la comprensione dell’ essere umano nella sua realtà storico-sociale. I fatti di
cui trattano le scienze della natura sono considerati nella loro esteriorità, mentre l’ esperienza
umana può essere acquisita nei suoi moventi interiori. Ed in questo lo storico è certamente
avvantaggiato, poiché egli può condividere gli stati d’ animo di coloro che hanno operato nella
storia. Scriveva Dilthey nell’ “Introduzione alle scienze dello spirito” (1883) che “La costruzione
delle scienze della natura è determinata dal modo con cui è dato il loro oggetto, cioè la natura. Le
immagini si presentano in un continuo mutamento e sono riunite in oggetti, questi riempiono e
occupano la coscienza empirica, e formano l’ oggetto della scienza descrittiva della natura”. Ben
diversamente, “… il mondo storico dell’ uomo … quale ci si presenta nelle scienze dello spirito …
non è una copia … di una realtà sussistente al di fuori di quelle. Il conoscere non può configurarsi in
tal maniera, poiché esso è e resta legato ai mezzi dell’ intuizione, dell’ intendere e del pensiero
concettuale”. Contro il carattere estrinseco dei fenomeni naturali, si pone l’ interiorità degli
individui concreti che operano nella storia. Partecipare e condividere l’ esperienza interiore è la via
che lo storico deve prendere per entrare nella struttura delle singole età storiche e cogliere i nessi tra
le varie epoche. E Dilthey aggiungeva nelle “Idee su una psicologia descrittiva e analitica” (1894)
che “Le scienze dello spirito si distinguono dalle scienze della natura in quanto queste hanno per
oggetto dei fatti che si presentano nella coscienza dall’ esterno, cioè come fenomeni singoli, mentre
nelle scienze dello spirito i fatti si presentano originariamente dall’ interno, come realtà e come una
connessione vivente”. Dilthey è certamente un riferimento imprescindibile per comprendere lo
“storicismo tedesco contemporaneo” e le sue istanze epistemologiche. Ha ben osservato Mario
Signore che i maggiori studiosi dello “storicismo”, Pietro Rossi, Raymond Aron e Friedrich
Meinecke, hanno dovuto muoversi da lui per comprendere “quel processo di corrosione dello
storicismo assoluto che in Germania ebbe nel sistema hegeliano l’ espressione più comprensiva e
definitiva”. Lo storicismo assoluto, metafisico e dogmatico, cui poneva capo l’ idealismo di Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, fu, per la prima volta, messo in discussione, proprio nell’ ambito della
conoscenza storica e della comprensione della storicità del mondo umano, dal “pensiero critico” di
Dilthey. Il quale si mosse dalla consapevolezza, come ha in sostanza ricordato Aron, che nessuna
“formula” riuscirà mai a racchiudere il “divenire inesauribile della vita”, opponendosi al
razionalismo ottimistico hegeliano, secondo il quale, ogni momento della storia come della natura è
riferibile alla manifestazione dialettica e logica dello Spirito assoluto. Lo spirito umano fu indotto a
far i conti con i propri limiti, come voleva Kant, a non allontanarsi dal dato nell’ enunciare le sue
proposizioni e a non discortarsi mai dal “territorio” della storia e dal piano storico. Con Dilthey, ha
scritto Signore, la riflessione filosofica “ … si orienta sul passato umano, accoglie e giustifica l’
impegno di autocomprensione che l’ uomo compie, attraverso una nuova attenzione al suo passato e
alle sue opere”. In questo senso la filosofia coglie, comunque, “… un’ unità mai extrastorica, ma
sempre e solo nel suo stesso realizzarsi come storia, istante per istante, epoca per epoca, con la
conseguente riduzione della filosofia della storia alla scienza storica, alla quale viene riconosciuto il
compito di offrire all’ uomo il significato e il valore della sua “territorialità”, accompagnato alla
riscoperta della sua identità”. Dilthey fondava una “filosofia dell’ uomo, in quanto essere storico”,
ma, per questo, doveva porsi in modo critico di fronte alla storia ed elaborare una kantiana “critica
della ragione storica”. Wilhelm Dilthey nacque a Briebrich am Rhein (ducato di Nassau) , nel
1833, e morì a Bolzano nel 1911. Dopo il liceo a Wiesbaden, frequentò le Università di Heidelberg
e Berlino, con accentuati interessi per la storia, la teologia e la filosofia. A Berlino conobbe alcuni
dei maggiori esponenti della Scuola storica, da Boeckh a Ranke, e maturò quella forte attenzione
per la cultura romantica tedesca cui non avrebbe mai rinunciato. La sua “intensa partecipazione a
un mondo spirituale di cui … si sente erede”, come ha scritto Pietro Rossi, non esclude che egli, nei
confronti del Romanticismo assuma “un atteggiamento di distacco e di valutazione critica”
fortemente storico. Friedrich Adolf Trendelenburg indusse Dilthey ad accuparsi della biografia di
uno dei propri maestri, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (l’ altro era Hegel) di cui Dilthey
redasse una parziale biografia (“Leben Schleiermachers”, 1867-1870) che non avrebbe portato a
compimento. Non si trattò, comunque, di una scelta obbligata e neppur meramente storiografica: per
quanto formatosi in un ambiente religioso ed ecclesiastico, (peraltro aperto all’ “Aufklärung”, ai
Lumi) Dilthey avrebbe trovato in quel filosofo della religione una robusta vena antidogmatica (ma
non irreligiosa). All’ attenzione per Schleiermacher debbono essere aggiunti gli studi su Johann
Georg Hamann, Novalis (alias Friedrich von Hardenberg), Friedrich Hölderlin. Certamente però il
“ritorno a Kant” e il neo-criticismo, che caratterizzarono nel secondo Ottocento la filosofia tedesca,
diressero il forte interesse che Dilthey era andato maturando per la storicità del mondo umano, ad
una fondazione critica delle “scienze dello spirito” e ad una “critica della ragione storica”. E’
certamente rilevante per “la formazione speculativa di Dilthey”, come ha rilevato Pietro Rossi, “L’
urto tra la cultura romantica in declino e il movimento positivistico” : egli non poteva rinunciare all’
attenzione dei romantici per il “mondo spirituale dell’ uomo” e rifiutava la riduzione naturalistica
dello spirito, operata dai positivisti. Non condivideva neppure il loro scientismo. Proprio in nome di
una sensibilità romantica di cui sentiva d’ essere portatore, rifiutava di sottomettere la cultura
umana alla scienza e alla tecnica. Rossi ha sottolineato che non vi fu, in lui, alcun misconoscimento
dell’ importanza della scienza, e proprio dal positivismo apprese la lezione e l’ esigenza di un solido
legame tra la filosofia e l’ indagine scientifica, pur rivendicando l’ autonomia del mondo storico
dalla dimensione naturalistica in cui la scienza avrebbe voluto rinchiuderlo. Il naturalismo e le
varie forme di idealismo gli apparivano come altrentante “intuizioni del mondo”, “atteggiamenti
dinnanzi alla vita” , che ambiscono ad una validità assoluta, incondizionata, aprioristica, senza
alcuna radice nella ricerca particolare e scientificamente impostata. Dilthey successe nella cattedra
di Berlino a Rudolf Hermann Lotze nel 1882 e sino al 1906 avrebbe elaborato i fondamenti della
“critica della ragione storica”. Le opere di Dilthey sono state raccolte nelle “Gesammelte
Schriften”, in undici volumi, presso l’ Editore Teubner (Leipzig-Berlin). In italiano sono
disponibili, tra l’ altro, la “Critica della ragione storica”, a cura di Pietro Rossi, “Ermeneutica e
religione”, a cura di Gianfranco Morra, “L’ analisi dell’ uomo e l’ intuizione della natura dal
Rinascimento al secolo XVIII” e la “Psicologia”. La figlia Clara Misch Dilthey raccolse le lettere e
il diario giovanile del padre (“Der junge Dilthey. Ein Lebensbild und Tagebüchern“). Fra i titoli più
significativi della produzione di Dilthey sono da ricordare, almeno, per l’ attività storiografica, “Il
diciottesimo secolo e il mondo storico” (1901) e “La giovinezza di Hegel” (1907), rilevante per le
sollecitazioni a nuovi studi hegeliani. Dei saggi teoretici di Dilthey, vanno ricordati “Introduzione
alle scienze dello spirito” (1883), “Idee su una psicologia descrittiva e analitica” (1894), “Contributi
allo studio dell’ individualità” (1895-1896), “Studi per la fondazione delle scienze dello spirito”
(1905), “L’ essenza della filosofia” (1907), “La costruzione del mondo storico nelle scienze dello
spirito” (1910-1927), “I tipi dell’ intuizione del mondo” (1911). In un complesso e ricco „milieu“,
nutrito dall’ apertuta alla storicità del mondo umano da parte della „Scuola storica“(che si era
dispiegata nell’ attività storiografica di Leopold Ranke, Friedrich Adolf Trendelenburg, Theodor
Mommsen, Joachim Ritter), dalla multiforme cultura romantica, dal “ritorno a Kant”, Dilthey
eresse un “orientamento generale”, come scrive Signore, volto al “mondo spirituale dell’ uomo”, cui
“nulla appare estraneo, se lo si indaga con autentico atteggiamento storico, cioè umano, nemmeno
la scientificità dei positivisti, purchè sempre accolta accanto all’ arte, alla religione e alla filosofia,
che insieme alla scienza indicano al ricercatore la strada del chiarimento di aspetti della realtà
altrettanto essenziali quanto quello scientifico e tecnico”. Da Kant ai positivisti, la riflessione
epistemologica non si era mai concentrata sulla essenziale storicità dell’ essere umano e sulla
specificità-autonomia delle scienze dello spirito rispetto alle scienze della natura. La “critica (in
senso kantiano”) della ragione storica” non si sarebbe più occupata delle funzioni a priori della
conoscenza, bensì dell’ uomo nella sua storicità e fatticità concreta (anche se quest’ ultimo
sostantivo s’ attaglia piuttosto a Martin Heidegger). “Il problema fondamentale della filosofia –
scriveva Dilthey – è stato determinato in maniera definitiva da Kant … Non c’ è nessuna
conoscenza rigorosa se non di ciò che è dato nell’ esperienza. E infatti l’ oggetto di questa
conoscenza rigorosa è la connessione di tutti i fenomeni secondo leggi … Questa fondazione critica
è il compito universale della filosofia, in virtù del quale essa è scienza delle scienze, dottrina della
scienza …”. Notava però anche che da Kant veniva alla filosofia una sorta di “secondo compito”,
quello di “fondare una scienza empirica dei fenomeni spirituali”. Tale era il compito che si poneva a
Dilthey, e – retrocedendo rispetto ad Hegel - tale era il senso di un “ritorno a Kant”. “Il nostro
compito – asseriva – è ben segnato: proseguire la via critica di Kant e fondare una scienza empirica
dello spirito umano in cooperazione con gli studiosi di altri campi”, e il programma della filosofia
diventava quello di “conoscere le leggi che regolano i fenomeni sociali, intellettuali e morali”. Nel
definire l’ autonomia e lo specifico metodo delle scienze dello spirito, Dilthey dichiarò di voler
evitare l’ unilateralità tanto di August Comte quanto di John Stuart Mill nel definire lo statuto
epistemologico delle scienze dello spirito. Al primo rimproverava il riduzionismo: “Comte …
considera lo studio dello spirito umano come dipendente dalla scienza fisiologica, e l’ aspetto di
uniformità che può venir osservato nella successione degli stati spirituali come l’ effetto dell’
uniformità riscontrabile negli stati corporei, negando perciò che la regolarità presente negli stati
psichici possa essere studiata di per sé. A questo stato di cose corrisponde, secondo lui, la posizione
della scienza della società nella storia delle scienze”. Comte sbaglia nel subordinare “lo studio dei
fenomeni spirituali alla conoscenza naturale” e sbaglia nel giudicare sterile l’ “osservazione
interna”, l’ introspezione. Dilthey sottolinea che Stuart Mill ha riconosciuto “l’ autonomia delle basi
di spiegazione delle scienze dello spirito”,
salvo contestargli di aver subordinato “in modo
eccessivo i metodi < delle scienze dello spirito > allo schema che egli ha elaborato attraverso lo
studio delle scienze della natura” . La logica di Stuart Mill mirava a “trasporre nel campo delle
scienze dello spirito i metodi sviluppati in base alla tecnica delle scienze della natura …”. Dilthey
intendeva portare a compimento l’ opera avviata dalla Scuola storica. Nella quale, rileva Pietro
Rossi, “ … trovava uno sforzo di comprensione del mondo umano che, pur sorgendo nell’ ambito
della cultura romantica, si era orientato verso una ricerca specifica sulla vita storica dell’ uomo”.
Ne accoglieva l’ “impostazione metodologica della ricerca concreta” e ne riceveva la sollecitazione
a comprendere l’ “uomo come concreto essere storico”. E d’ altra parte si assumeva il compito di
“fondare filosoficamente il principio della scuola storica e il lavoro delle scienze particolari della
società” giacchè dichiarava che “la scuola storica non ha fino ad oggi spezzato i limiti interni, che
hanno ostacolato sia la sua elaborazione teorica sia la sua influenza sulla vita. Alla sua indagine e
alla sua utilizzazione dei fenomeni storici mancava la connessione con l’ analisi dei fatti di
coscienza, e con ciò il riferimento all’ unico sapere che risulta in ultima istanza certo, vale a dire
mancava una fondazione filosofica”.
29 /
Wilhelm Dilthey (2)
Wilhelm Dilthey volle conferire fondamento, validità ed autonomia oggettiva alla struttura
metodologica delle “scienze dello spirito”, attraverso una “critica della ragione storica” che
spostava l’ asse del criticismo kantiano dalle scienze della natura alla conoscenza storico-sociale.
Dilthey rigettava la riduzione positivistica del mondo storico-sociale alla dimensione deterministica
della natura. Ma intendeva superare anche lo storicismo assoluto di Hegel, secondo il quale la storia
non è altro, come la natura, che una successione dialettica di determinazioni dell’ unico Spirito
assoluto e infinito. Nel generale “ritorno a Kant”, Dilthey intese compiere, nei confronti della
conoscenza del mondo storico e umano, la stessa operazione che Kant aveva riservato alle scienze
naturali. Si imponeva con lui, per dirla con Pietro Rossi, “il problema critico della storia”, il quale si
articolava in due direzioni: la prima questione era quella “dell’ analisi metodologica delle scienze
storico-sociali”; la seconda verteva sulla “determinazione della struttura storica del mondo umano”.
Egli intendeva dare giustificazione, ragione e fondamento filosofici al tentativo della Scuola storica
tedesca “di dar vita a un edificio organico di discipline che hanno per oggetto la vita storica dell’
uomo”. Una indagine metodologica immersa nella loro effettiva ricerca e produzione, avrebbe
permesso di definire le operazioni, gli strumenti e le categorie concettuali delle scienze che si
occupano del mondo storico La via maestra per risolvere entrambe le questioni era quella di definire
l’ identità e la distinzione delle scienze dello spirito nei confronti delle scienze della natura.
Indagare e analizzare in modo critico i presupposti, il metodo e le operazioni delle discipline
applicate e messe a punto dalla concreta ricerca della Scuola storica: fu questa l’ esigenza di fondo
che indusse Dilthey a staccarsi da Kant, quando scoprì la radicale dimensione storica dell’ agire
morale e lo sottrasse all’ incondizionato e metastorico imperativo categorico, che Kant voleva
separato dalla concreta coscienza operante comunque in una concreta situazione storica. Dylthey
volle distinguersi dalla teoria della conoscenza di Kant, proprio perché essa era esclusivamente e
riduttivamente “gnoseologica”: la conoscenza non è che un’ aspetto della “totalità della vita
psichica”. E la storia è lo stesso “movimento storico”, il lavoro e l’ impegno concreti di concreti
individui e di concrete generazioni che operano all’ interno di concrete relazioni sociali, non
limitandosi a conoscere ma anche ad agire, sperare, volere … Sbagliava Kant quando concepiva l’
essere umano semplicemente come “pensante”. Di lui restava l’ esigenza di una teoria della
conoscenza critica che stabilisse le “condizioni di validità” delle scienze dello spirito,
riconducendole allo stesso essere umano, inteso però nel complesso delle sue molteplici
manifestazioni ed espressioni. Comprendere il mondo umano, nella sua storicità, e cogliere il
fondamento delle specifiche scienze che se ne occupano (emancipandole tanto dalla tradizionale
filosofia della storia quanto dalle scienze della natura): tale divenne l’ impegno di Dilthey.
Approdando alla radicale storicità della vita spirituale, Dilthey, come ha scritto Pietro Rossi,
concepiva la specificità epistemologica delle “scienze morali e politiche” nella loro caratteristica di
costituire “una totalità caratterizzata dall’ appartenenza del soggetto conoscente allo stesso mondo
umano che forma l’ oggetto dell’ indagine”. La relazione dell’ essere umano con le scienze dello
spirito è ben diversa da quella che egli intrattiene con le scienze della natura. L’ oggetto delle prime
è costituito dagli individui e dai “rapporti inter-umani” a partire da “un atteggiamento di ricerca”
del tutto differente da quello che le scienze della natura hanno nei confronti dei fatti naturali. Le
scienze dello spirito si occupano della volontà, dell’ intelligenza, dell’ azione cosciente di individui
che interagiscono con la società. Esse non cercano cause come quelle di cui si occupano le scienze
della natura, bensì si interrogano sul “gioco dei motivi e degli scopi”. Si tratta di una ben diversa
causalità. Di fronte a Dilthey si schiudevano due mondi, due differenti aree della realtà: l’ oggettivo
ed “esterno” mondo della natura e il mondo umano, quel “regno della storia” ove dominano la
responsabilità, la libertà, la volontà, la dimensione interiore dello spirito. Pietro Rossi ha avvertito
che una tale distinzione non dev’ essere assunta in senso metafisico, giacchè Dilthey non intende
“separare arbitrariamente i fenomeni spirituali dalla totalità psicofisica dell’ uomo”. L’ uomo
interagisce con la natura, ne è influenzato e nello stesso tempo agisce, nei suoi confronti, con
intenzione e proponendosi dei fini. E sbaglieremmo anche se credessimo che la distinzione tra i due
ordini di scienze sia segnata esclusivamente dai due corrispondenti oggetti: due mondi e due sfere
della realtà. La primaria distinzione è, in effetti, metodologica, poiché le scienze della natura
fruiscono di un’ esperienza esterna, mentre quelle dello spirito ricorrono all’ esperienza interna,
potendo far conto sulla “osservazione diretta che l’ uomo conduce su se stesso o sugli altri individui
o sui rapporti inter-umani”. La distinzione tra i due ordini di scienze si giocava soltanto in secondo
piano sull’ oggetto. Anzitutto, la specificità delle scienze dello spirito risiedeva nell’ approccio al
proprio oggetto: possedendo l’ uomo, del proprio mondo, una coscienza immediata, esse si
avvalgono dell’ esperienza interna (“Erlebnis”) con cui il singolo si rivolge a se stesso e, nello
stesso tempo, comprende gli altri. Significati, fini, valori … ecco le categorie delle scienze dello
spirito. “L’ uomo – scrive Pietro Rossi al riguardo – ha … un’ esperienza immediata della vita
spirituale nella propria interiorità, senza alcuna mediazione concettuale: tale esperienza è l’
“Erlebnis”, che costituisce il nucleo generatore delle scienze dello spirito … “. Deve esser però
chiaro che l’ “Erlebnis” “… non è mera rappresentazione ma è insieme rappresentazione,
sentimento, volontà” giacchè “l’ uomo ha coscienza immediata del suo vivere nel tempo”. Nell’
“Erlebnis” “sono presenti ogni concetto, ogni valore, ogni fine dell’ uomo”. Dilthey avrebbe poi
concepito l’ “Erleben” come un flusso e una successione di “Erlebnisse”: ogni “Erleben” è un
contenuto minimo della vita psichica, ed è immediato non meno dell’ “Erlebnis”. Scriveva Dilthey
che “… la nostra immagine dell’ intera natura risulta una mera ombra, gettata da una realtà a noi
nascosta, mentre noi possediamo la realtà qual essa è solamente nei fatti della coscienza, dati dall’
esperienza interna. L’ analisi di questi fatti costituisce il centro delle scienze dello spirito, cosicché
la conoscenza dei principi del mondo spirituale permane – in conformità con l’ ispirazione della
scuola storica – nell’ ambito di esso, e le scienze dello spirito formano un sistema indipendente”. E
ancora: “I fatti della società ci sono comprensibili dall’ interno, possiamo riprodurli fino a un certo
punto in noi, sulla base dell’ osservazione dei nostri propri stati, e accompagnamo intuitivamente la
rappresentazione del mondo storico con l’ amore e l’ odio, con tutto il gioco dei nostri affetti … La
società è il nostro mondo. Noi viviamo in essa il gioco delle azioni reciproche, con tutta la forza del
nostro intero essere, poiché percepiamo in noi stessi dall’ interno, in un vivente tumulto, gli stati e
le forze su cui si costruisce il suo sistema”. Le scienze dello spirito si occupano del “mondo umano”
nella dimensione storica e sociale, tanto passata quanto presente. Esse si articolano perciò lungo due
direttrici: l’ una attenta all’ individualità dei “fatti spirituali” (l’ attività storiografica), l’ altra diretta
alle uniformità che sono astratte dall’ individualità con un procedimento comparativo (psicologia,
antropologia). La biforcazione dell’ orientamento delle scienze dello spirito in un approccio
individualizzante ed in uno generalizzante, ne decreta il carattere particolaristico: ciascuna coglie
soltanto un determinato e particolare aspetto del mondo umano e – senza pretendere di attingerne,
da sola, la totalità – rinvia, dunque, alle altre. Del resto, se ogni individuo è un “mondo” (soltanto
parzialmente sondabile), non è meno vero che gli individui sono in relazione tra loro, coesistono e
convivono, producendo “sistemi di cultura”, istituzioni e associazioni (la struttura esterna della
società). Nei sistemi di cultura l’ individuo non è dissolto, ma resta il fatto che famiglia, stato,
chiesa … sopravvivono ai singoli e li indirizzano a fini comuni. Senza dimenticare, comunque, che
la vita sociale si snoda nel tempo. Certo se, come ha sottolineato Pietro Rossi, nella prospettiva di
Dilthey “le scienze dello spirito hanno a loro oggetto la vita individuale e sociale dell’ uomo nella
sua storicità”, e i fatti naturali vi hanno, comunque, soltanto il ruolo di ambiente e di condizione, il
metodo di tali scienze si avvale prevalentemente “della descrizione, dell’ analisi, della
comparazione, dell’ ermeneutica” di contro a quello delle scienze della natura, le quali ricorrono ad
induzione, esperimento, matematica . Rossi sottolinea anche che Dilthey deve essersi ben reso conto
che l’ “esperienza interna”, “l’ immediata coscienza che l’ individuo ha della propria totalità e dei
propri stati interiori, non è sufficiente come fonte della conoscenza del mondo umano e dei rapporti
inter-umani”. Occorre certo indagare la vita psichica dell’ individuo, che non può, però, esser
considerato nel suo isolamento e nella sua separatezza dagli altri, bensì nella complessità strutturale
della vita psichica che si articola in una molteplicità e in un flusso di stati coscienti che rimandano
all’ unità dell’ io ma anche al mondo esterno. Nella correlazione fra questi tre poli consiste la
“struttura permanente della vita psichica” e Dilthey ritiene che a studiarla debba essere una
“psicologia descrittiva” che eviti di scadere in una “meccanica psicologica” o in una psicologia
naturalistica, la quale pretenda di ridurre il mondo psichico ad elementi computabili, nello stesso
modo in cui fisica e chimica spiegano il mondo corporeo. La psicologia descrittiva e analitica,
scrive Dilthey, si avvale di “un procedimento analitico, non già costruttivo. Essa deve partire dalla
vita psichica nel suo sviluppo, non già derivarla da processi elementari” e aggiunge che “Il suo
oggetto dev’ essere l’ uomo sviluppato e la vita psichica nella sua compiutezza; è questa che dev’
essere colta, descritta e analizzata nella sua totalità”, in quanto “L’ io si trova in un mutare di stati,
che vengono riconosciuti come unitari mediante la coscienza dell’ identità della persona; e al tempo
stesso si trova condizionato da un mondo esterno e reagente su di esso, mentre lo coglie pure nella
sua coscienza e lo sa determinato dagli atti della sua percezione sensibile. In quanto l’ unità vivente
si trova condizionata dall’ ambiente in cui vive, e a sua volta reagente su di esso, ne deriva un’
organizzazione dei suoi stati interiori. Essa può venir designata cone struttura della vita psichica”.
Dalla traduzione concettuale dell’ “immediata esperienza interiore”, compiuta dalla psicologia
descrittiva e analitica, muovono le altre scienze dello spirito che si occupano delle relazioni sociali.
Ad esse non può, però, bastare l’ esperienza interna”, giacchè esse si rivolgono alle relazioni tra gli
individui. Cone costruiscono il mondo storico le scienze dello spirito? Quali operazioni compiono,
muovendosi dall’ “Erleben”, per costruire un sapere (oggettivo) sul mondo storico? Per chiarire l’
apertura della singola coscienza alle altrui coscienze, ai loro moventi e ai loro scopi, Dilthey ricorre
all’ “espressione” e all“intendere”. “Erlebnis” ed “Erleben” sono in relazione immediata con l’
espressione, nella quale la vita psichica si oggettiva e si offre all’ apprendimento oggettivo. L’
espressione trascende l’ esperienza vissuta e consente le operazioni dell’ apprendimento oggettivo,
dalla comparazione alla distinzione, dal giudizio al sillogismo. Alla relazione tra “Erleben” ed
“Erlebnis” e all’ espressione, si aggiunge l’ intendere. L’ intendere è comprensione dell’
espressione. Per dirla con Pietro Rossi, “L’ immediatezza della vita psichica si oggettiva nell’
espressione, e deve esser penetrata attraverso l’ espressione in cui si è oggettivata”. E Dilthey
enuncia che “Le scienze dello spirito cono così fondate su questa connessione di vita, espressione e
intendere”, aggiungendo che “Una scienza appartiene alle scienze dello spirito soltanto quando il
suo oggetto ci è accessibile mediante l’ atteggiamento fondato sulla connessione di vita, espressione
e intendere”. La vita psichica, nella sua immediatezza, ha oggettivazione nell’ espressione e può e
deve essere compresa tramite l’ espressione in cui si è oggettivata. “L’ intendere – annota Pietro
Rossi – attinge l’ interiorità altrui, che si manifesta nell’ espressione”, ma è sempre riferito all’
“Erleben” “che gli fornisce la possibilità di penetrare al di là dell’ espressione la vita psichica di
altri individui”. Cosicché “l’ “Erleben” costituisce il punto di partenza dell’ apprendimento del
mondo umano, e l’ intendere mira appunto a superare il piano dell’ immediatezza per cogliere l’
interiorità altrui”. La condizione umana è “vita”. La vita altro non è che “azione reciproca degli
individui” che costruiscono il “mondo umano”. Altro non è, la vita, che attività reciproca dei
singoli. Essa non vuol essere un principio assoluto. Essa non è altro che la traduzione nella
dimensione sensibile dell’ interiorità spirituale dell’ uomo. E, come tale, può esser compresa. In
quanto gli esseri umani, nelle “connessioni dinamiche” che essi istituiscono (i “sistemi di cultura”,
le “forme di organizzazione esterna”), sono, comunque, sempre se stessi e comprendono se stessi.
============
30/
Henri Bergson (1)
Henri Bergson fu assertore di un “evoluzionismo spiritualistico” che avrebbe dominato nella
filosofia francese a cavallo di Ottocento e Novecento. Ripensò in modo vitalistico l’ evoluzionismo
darwiniano; ma, pur acquisendo la tesi dell’ evoluzione delle specie, rifiutò la deterministica
selezione naturale. Volle superare la contrapposizione tradizionale tra meccanicismo e finalismo, e
concepì l’ evoluzione come il frutto di uno “slancio vitale” (“élan vital”) che muove sia verso l’
intelligenza che verso l’ istinto, tendenze distinte ma unite dall’ intuizione. L’ evoluzione vitale e
creatrice di Bergson, riecheggia il contingentismo di Boutroux, uno dei suoi maestri. Bergson seppe
congiungere la riflessione interiore di Sant’ Agostino e il moderno soggettivismo di Renè des
Cartes e Blaise Pascal con l’ evoluzionismo di Herbert Spencer. Ne scaturì una critica
epistemologica che muove da Maine de Biran e Félix Ravaisson-Mollien, e guarda alle scienze con
occhio distaccato ed emancipato, proseguendo nella traiettoria di Émile Boutroux. I suoi originali
contributi critici sulla scienza non meno che sull’ arte, sulla società e sulla religione, avrebbero
avuto un notevole rilievo nel pragmatismo di William James e, in generale, nell’ estetica, nella
sociologia e nella filosofia della scienza. Una robusta traccia di Bergson permane nell’
esistenzialismo francese, nella fenomenologia di Max Scheler, nella filosofia della matematica di
Alfred North Whitehead e nel comportamentismo sociale di George Herbert Mead. Il titolo di un
saggio di Gilles Deleuze è significativo: “Le bergsonisme” (1966). E, indubbiamente, Bergson fece
“moda”, com’ era accaduto a Renè des Cartes, sconfinando anche, con la sua influenza, nell’ area
artistica e letteraria (si pensi soltanto a Marcel Proust). Al positivismo ortodosso che conobbe da
giovane, Bergson oppose l’ irriducibilità della creatività della coscienza spirituale alla dimensione
naturalistica. Ma proprio perché intese comprendere la vita della coscienza, non rifiutò ed anzi
valorizzò le acquisizioni della scienza e la dimensione corporea e naturale. Allo spiritualismo che lo
precedeva, rimproverò quell’ isolamento della vita spirituale che l’ avrebbe ridotta ad un
“miraggio”. La vita spirituale deve essere intesa invece, secondo lui, come energia creatrice che si
scontra con condizionamenti e barriere che la mortificano e la svalutano. Quella di Bergson non fu
un’ arbitraria interpretazione della scienza alla luce di metafisiche irrazionalistiche, come avrebbero
inteso i positivisti ortodossi, bensì un originale ripensamento delle acquisizioni della scienza, che
non poteva prescindere dalla complessità della coscienza umana, nella sua autonomia dalla
dimensione naturalistica, deterministica e meccanicistica.
Può uno spiritualista – anzi il maggior spiritualista francese – esser annoverato tra gli epistemologi
contemporanei? I neopositivisti inorridirebbero. Ma se Bergson volle essere un realista che non
ignorava i “fatti” dei positivisti, pur non intendendo ridurre ad essi la dimensione spirituale dell’
essere umano, egli volle rivalutare il rapporto tra scienza e metafisica. E tuttora, se non si vuol
aderire ad una concezione rigidamente logico-strutturale della filosofia della scienza, tipica del
neopositivismo e del post-neopositivismo, è necessario ripensare al ruolo di una riflessione
metafisica nella definizione delle teorie scientifiche. Si potrebbe ricordare, al riguardo, quell’
“esame filosofico della scienza” che è stato ad esempio avviato, in Italia, da Evandro Agazzi,
Francesco Barone e altri, ma basterà citare il commento introduttivo di Mariano Bianca a “Le
filosofie della scienza” di Rom Harré (laureato in ingegneria e matematica presso l’ Università di
Auckland – Nuova Zelanda – e in filosofia presso l’ Università di Oxford). Scrive Bianca che “L’
epistemologia neopositivista considera la scienza scevra da ogni influenza filosofica ed in
particolare metafisica: le teorie e le proposizioni scientifiche sono costituite solo da concetti di
origine empirica”. Il compito degli epistemologi sarebbe, dunque, quello di purificare la scienza da
qualsiasi “interferenza filosofica”. Ma con Karl Raimund Popper, Thomas Kuhn e Paul Karl
Feyerabend, ci si è resi conto che la “scienza paradigmatica non è costituita da soli esperimenti,
osservazioni e teorie, bensì anche da elementi extrascientifici che hanno un ruolo fondamentale
nello sviluppo della ricerca” e che “gli elementi paradigmatici < delle teorie scientifiche > non sono
originati dalla scienza, bensì da un più vasto serbatoio culturale e in particolare filosofico”. Il
neopositivismo aveva completato il programma empiristico ed illuministico di espunzione della
metafisica dalla scienza. Ma la “seconda rivoluzione scientifica” s’ è dovuta confrontare con
“profondi problemi filosofici”, e del resto, se Harré ha sottolineato l’ importanza e la centralità di
categorie metafisiche nella scienza, non è meno importante tener conto delle categorie scientifiche
che innovano la filosofia. In ogni caso, è semplicemente lapalissiano quel che osserva Bianca: “tutti
i concetti “fondamentali” delle varie discipline scientifiche hanno un valore filosofico; sia nel caso
in cui sono stati prodotti originariamente dalla scienza, sia in quello in cui sono stati un risultato di
influenze molteplici e metafisiche”. Concetti come quello di tempo, di spazio, di forza, di energia,
di relatività, di evoluzione, di numero, di causa, di dimensione … hanno, senza alcun dubbio, una
“valenza metafisica”. Del resto, con Kuhn, è diventato chiaro che categorie concettuali, metodi e
teorie scientifiche sono saldamente connessi alle età storiche che li esprimono. Certo, poi, con
Ortega y Gasset, dovremmo citare il fisico austriaco Ludwig Boltzmann quando sostiene che “Né la
logica, né la filosofia, né la metafisica, decidono in ultima istanza se qualche cosa sia vero o falso,
perché a deciderlo è soltanto l’ azione. Per questo motivo non considero le conquiste della tecnica
come semplici precipitati secondari della scienza naturale, ma come prove logiche di questa. Se non
ci fossimo proposto quelle conquiste pratiche, non sapremmo come dobbiamo ragionare. Non ci
sono ragionamenti più corretti di quelli che raggiungono risultati pratici”. E Ortega y Gasset spezza
una lancia a favore dei pragmatisti. Ma quando poi si chiede se il “confort”, la comodità, il
confortevole, siano il motore della scienza, opera un ironico confronto tra i greci e i cinesi:
“Platone, mentre meditava i pensieri che hanno reso possibile la fisica moderna e con essa il
confort, conduceva, come tutti i Greci, una vita molto dura, e in quanto a strumenti, mezzi di
trasporto, riscaldamento e arredamento domestico si trovava in condizioni veramente barbare. Alla
stessa data, i Cinesi, che non hanno mai avuto un pensiero scientifico, che mai hanno organizzato
una teoria, tessevano tele deliziose e fabbricavano oggetti utili e costruivano artefatti di squisito
confort. Mentre ad Atene l’ Accademia platonica inventava la matematica pura, a Pechino si inventa
il fazzoletto da tasca” (“Scienza e filosofia”). Ma forse Ortega y Gasset dimenticava che l’
Occidente ha mutuato proprio dai cinesi l’ uso della bussola, la stampa a caratteri mobili, la stampa
su carta e, purtroppo, anche la polvere da sparo.
Henri Bergson era nato a Parigi nel 1859 da famiglia ebrea di origini polacche. Frequentò l’ École
Normale, ove fu allievo di Étienne-Émile-Marie Boutroux e Léon Ollé-Laprune, studiando
filosofia, matematica, chimica e biologia. Conseguì il dottorato in filosofia nel 1889. La seconda
delle due dissertazioni, quella in francese – l’ altra era in latino: “Quid Aristoteles de loco senserit”
– costituiva quel “Saggio sui dati immediati della coscienza” (“Essais sur le donnes immediates de
la coscience”) che, subito pubblicato, gli avrebbe recato grande notorietà. Nel 1896, Bergson
pubblicò “Matiére et Memoire” (“Materia e memoria”), che avrebbe ispirato William James. Dopo
l’ insegnamento nei licei di Anger e Clermont-Ferrand, ebbe l’ incarico di “Maitre de conferences”
all’ École normale, incontrando l’ ostilità dei più conservatori all’ interno dell’ Università. Fu
docente al Collége de France dal 1889 al 1907; diede alle stampe, in questi anni, “Le rire” (“Il
riso”, 1900), “Introduction a la métaphisique” (“Introduzione alla metafisica”, 1903), “L’ évolution
créatrice” (“L’ evoluzione creatrice”, 1907). Del 1922 è “Dureé et simultaneità” (“Durata e
simultaneità”), in cui l’ autore si confrontò con la teoria einsteiniana della relatività. Accademico di
Francia, vide consolidarsi la sua fama, sino ad ottenere il Premio Nobel per la letteratura, in virtù
della sua brillante e felice scrittura. Ancora nel 1934 pubblicò “Le deux sources de la morale et de
la religion” (“Le due fonti della morale e della religione”). Più volte nella sua vita, Bergson dovette
essere sul punto di convertirsi al cristianesimo. Ma negli anni dell’ occupazione nazista volle
ribadire la sua fede, per solidarietà con la comunità ebraica. Rifiutò il trattamento di favore che i
nazisti avrebbero voluto riservargli a causa della sua notorietà. Già nel 1939, all’ atto dell’
invasione, s’ era ufficialmente iscritto nelle liste degli ebrei. Sarebbe morto nella Parigi occupata,
nell’ ala ebraica di un ospedale, nel 1941.
La solida formazione scientifica del giovane Bergson gli provocava incertezze attorno alla scelta dei
suoi interessi: proseguire nella ricerca scientifica o aderire allo spiritualismo di Maine de Biran,
Ravaisson, Lachelier, Boutroux? Aveva coltivato con entusiasmo l’ evoluzionismo di Charles
Robert Darwin e apprezzava la maestosità della metafisica evoluzionistica di Herbert Spencer. E
mentre l’ evoluzionismo gli prospettava una natura biologica dominata da un dinamico
meccanicismo, che conferiva alle forme di vita funzioni sempre più adeguate all’ adattamento,
condivise inizialmente l’ ottimismo dei positivisti, secondo cui la scienza avrebbe chiarito con il
determinismo fisico-matematico tutta la realtà. Gli sembrò che il progresso dominasse ovunque
nella natura. Ma presto lo spiritualismo lo indusse a guardare con occhio critico alla scienza ed a
cercare nella filosofia risposte che quella non sembrava poter dare. Scelse di non dedicarsi alla
ricerca scientifica ma, lungi dall’ annientare il piano deterministico, che contraddistingue la fisica
positivistica, ritenne di poter cogliere, al di sotto di esso (come del resto aveva già fatto a modo suo
Gottfried Wilhelm Leibniz), la profonda dimensione della vita. Egli avvertì l’ esigenza di non
ridurre la filosofia ad una generalizzazione delle acquisizioni delle scienze positive, come avevano
inteso fare i positivisti. Il positivismo era stato, dopo il sensismo settecentesco, l’ avversario più
temibile di Maine de Biran, Felix Ravaisson e Jules Lequier, i quali si erano arroccati dietro un fiero
tradizionalismo spiritualistico in difesa del primato della coscienza. La giovanile matrice positivista,
invece, condusse Bergson a muoversi proprio dai “dati immediati della coscienza” per rilevare l’
inadeguatezza della spiegazione meccanicistica e muovere ad una teoria dell’ esperienza nella quale
avesse cittadinanza anche la vita della coscienza. Distaccandosi dunque dal tradizionalismo
spiritualistico, egli seguiva le tracce di Émile Boutroux: accoglieva la scienza, ma proprio per
scoprirvi il rinvio ad un piano diverso da quello meccanicistico. È significativo il fatto che i suoi
termini di confronto, nel “Saggio sui dati immediati della coscienza” (1889), fossero coloro che
lavorarono ad una psicologia sperimentale, associazionistica e scientifica: Theodor Gustav
Fechner, Wilhelm Max Wundt, Hermann Ludwig Ferdinand Helmoltz. Ma anche il positivismo
inglese e francese. Conseguita una nuova concezione dell’ esperienza (“Materia e memoria”,
1906), elaborò una originale “philosophie nouvelle”, emancipata tanto dallo spiritualismo quanto
dal positivismo (“L’ évolution créatrice”, 1907). Ricorrendo all’ intuizione per penetrare nella vita
della coscienza, compì una analisi del tempo, distinguendo fra il tempo spazializzato e il tempo
interiore (la “durata”), per poi estendere, nella sua “filosofia della vita”, la durata al cosmo intero.
Al culmine della sua riflessione colse nell’ universo due impulsi opposti: il primo mira alla
uniforme distribuzione dell’ energia (come pretende il secondo principio della termodinamica); il
secondo è l’ “élan vital”, lo slancio vitale, la volontà con cui ogni organismo vivente tende a
perpetuare se stesso, opponendosi al primo impulso.
31 /
Henri Bergson (2)
Nonostante sia stato detto che Henri Bergson, dopo gli iniziali, intensi e approfonditi studi e
interessi giovanili per la scienza, se ne sarebbe definitivamente allontanato, egli assunse sempre,
come sostrato e come punto di partenza della sua “filosofia della vita”, le scienze positive e i grandi
principi posti dalle scienze del suo tempo (in particolare, nell’ “Evoluzione creatrice”, i suoi
riferimenti sono il principio di conservazione dell’ energia e il secondo principio della
termodinamica), pur filosoficamente ripensati. Il confronto con la biologia e la neuropsicologia
contemporanee è costante nella sua riflessione (si pensi, ad esempio, alla circostanziata critica delle
teorie della conoscenza della psicologia atomistica-associazionistica, in “Materia e memoria”). E’
vero che, alla luce degli odierni sviluppi di tali discipline, molte delle sue deduzioni parrebbero
superate, ma è altrettanto certo che Bergson non mise mai in discussione la veridicità delle
acquisizioni delle scienze positive. Non vi è mai, in lui, alcun tentativo di destituire di fondamento
le scienze settoriali e specialistiche o di minarne i risultati. Anche se non esita a coglierne i limiti,
giacchè esse ritaglierebbero una sezione della intera dimensione dell’ universo, studiandola poi in
modo statico secondo il movimento delle parti componenti. Comunque, l’ immagine che di Bergson
si fecero molti contemporanei – in Francia e in Europa – come dell’ araldo che muoveva alla
riscossa spiritualistica contro lo scientismo positivista, ormai non regge più. La scelta di dedicarsi
alla filosofia, abbandonando la concreta ricerca scientifica, non volle esser per lui una rinuncia al
sapere scientifico, bensì la coniugazione della tradizione spiritualistica (che andava da Sant’
Agostino Vescovo di Ippona a René des Cartes, sino a Blaise Pascal, Maine de Biran ed Émile
Boutroux) con il positivismo e la scienza moderna. Non si trattava di un insostenibile
compromesso, bensì di una complessa operazione che richiamava la sintesi compiuta da Leibniz tra
la filosofia antica e scolastica, da una parte, e la scienza meccanicistica e deterministica dei
contemporanei, dall’ altra. Egli intese illuminare una dimensione, quella della coscienza e dello
spirito umano, nella quale le scienze positive, in realtà, affondano ed alla quale rinviano, anche se
presumono di annientarla. Cercò, dunque, dietro la superficie dei fatti e delle leggi scientifiche, l’
autentica dimensione della realtà interiore ed esteriore, che si rifiutava di rinchiudere nella gabbia
del meccanicismo e del determinismo. Ma proprio perché tentò efficacemente di districarsi dai
tradizionali dualismi di spiritualismo e positivismo, coscienza e corporeità, spirito e materia, finì
con l’ essere unilateralmente esaltato o disprezzato, e in ogni caso fu frainteso, complice anche la
celebrità che ebbe la sua filosofia, divenuta una vera e propria moda. Tant’ è che nel 1932 volle
riproporre, contro le interpretazioni deformanti del “bergsonismo”, la reale entità e l’ effettiva
portata della sua filosofia (“Il pensiero e il movente”, 1933). In ogni caso, una lettura critica e
approfondita gli tributò riscontri e apprezzamenti presso filosofi di diversa impostazione, come
William James e Alfred North Whitehead. Vladimir Jankélévitch lo apprezzò (“Henri Bergson”,
1959) come Vittorio Mathieu (“Bergson: il profondo e la sua espressione”, 1954). Fortemente critici
furono, nei suoi confronti, Lodovico Geymonat (“Storia della filosofia”, 1971) e Bertrand Arthur
William Russell (“Storia della filosofia occidentale”, 1967). J. Chevalier e il Padre A. D.
Sertillanges vollero cogliere la forte prossimità al cattolicesimo della sua “filosofia della vita”. Ma
Jacques Maritain non era d’ accordo. Nel 1914 il presunto panteismo di Bergson lo aveva costretto
a far parte dell’ Indice dei libri proibiti. György Lukàcs vide in Bergson una delle “forme altamente
sviluppate” dell’ irrazionalismo, accomunandolo ai pragmatisti, a Boutroux, a Croce. “L’ attacco
principale di Bergson – scrive Lukàcs in “Die Zerstörung der Vernunft”, “La distruzione della
ragione”) – è rivolto contro l’ obbiettività e la scientificità della conoscenza data dalle scienze della
natura. L’ astratta e brusca contrapposizione della razionalità e dell’ intuizione irrazionalistica
raggiunge in lui – sul terreno gnoseologico – il suo punto culminante …”. E prosegue: “Ciò che in
Mach era semplicemente un appello agnostico all’ immediatezza soggettiva della percezione dà
luogo in Bergson a una visione dell’ universo fondata sull’ intuizione radicalmente irrazionalistica”.
Lukàcs non esita a vedere in Bergson un nemico della razionalità, proprio nella Patria dell’
illuminismo e del materialismo. “Bergson, nella creazione di miti decisamente irrazionalistici …
rivolge i suoi attacchi da un punto di vista filosofico contro l’ obbiettività e la razionalità, contro il
predominio della ragione (che è del pari un’ antica tradizione francese) e si batte per una visione
irrazionalistica dell’ universo”. La filosofia irrazionalistica di Bergson avrebbe, al pari di quella di
Martin Heidegger, il suo punto di forza nella critica al tempo reale e oggettivo della scienza, cui
contrapporrebbe un “tempo soggettivamente vissuto”. “Entrambi – scrive Lukàcs –, Bergson e
Heidegger, contrappongono un tempo soggettivamente vissuto, considerato come il vero tempo, al
tempo reale e oggettivo”. Con la differenza che nella filosofia di Bergson, la quale “presenta molti
elementi di affinità con Simmel e con il pragmatismo”, il “tempo vissuto” costituirebbe “un organo
della conquista soggettivistico-individualistica del mondo”; “… mentre nella deprimente filosofia di
Heidegger il tempo “reale” si ritira dal mondo, si svuota di contenuto e acquista un carattere
teologico concentrandosi esclusivamente nel momento dell’ intima decisione”. Dietro l’ attacco di
Bergson al “tempo spazializzato” e ai “concetti delle scienze esatte”, vi sarebbe il suo vero
movente: colpire la “concezione materialistica promossa dalle scienza della natura nel periodo di
ascesa della borghesia”. Il “tempo volgare” corrisponderebbe, invece, in Heidegger, “all’ esistenza
che si degrada nel “si impersonale” e il tempo reale indica nel senso della morte”. E Heidegger
vorrebbe colpire “l’ influsso del materialismo storico che si fa ormai sentire dovunque”. Ma si
potrebbe replicare che la critica di Bergson alla scienza non era né estrinseca né estemporanea,
come quella di Nietzsche e Heidegger. Ammesso che le loro obiezioni non avessero motivi di
rilievo. D’ altra parte, la valutazione della tecnica che si ritrova in Bergson, al contrario di quella
che si ritrova negli altri due, è del tutto baconiana, illuministica, positivistica e ottimistica. Nella
tecnica egli vedeva una rivelazione dello Slancio vitale e creatore. La tecnica, certamente, secondo
lui, produce nuovi e confortevoli strumenti, ma l’ invenzione è, anzitutto, feconda di nuove idee ed
ispirazioni che promuovono il progresso. Le “invenzioni meccaniche” e gli “strumenti artificiali”
suscitavano la sua ammirazione ed egli le considerava come i suggelli di un’ epoca, le memorie
notevoli della storia, ben di più delle orribili guerre. Bergson non si opponeva alla scienza, ma allo
scientismo che nega l’ ansia metafisica – come voleva Kant – che è nell’ essere umano e che evoca
la retta via logica all’ essere di Parmenide, il quale trascende la falsa conoscenza di chi si ferma all’
apparenza e alla mera sensibilità. La tecnica crea il benessere e ci rende produttori e fabbricatori,
ma il suo prodotto può essere una cattiva metafisica, quella dell’ “homo faber”. La metafisica dei
greci era sottratta all’ azione. Essa mirava alla contemplazione della Verita che sta oltre i fenomeni.
E Bergson rifiutava di ridurre la realtà delle cose alla materia. Una cattiva metafisica produce una
cattiva scienza. Egli non voleva dissolvere la scienza nella filosofia. Il suo intento era quello di
volgere lo sguardo più lontano. Non pensava ad una emancipazione della filosofia dalla scienza o ad
un rinnovato scontro tra scienza e filosofia. In buona sostanza, comunque, se si valuta la critica di
Lukàcs a Bergson , pare ragionevolmente che essa si rivolga alla concezione del tempo e allo
strumento con cui elaborarla: l’ intuizione (anti-intellettualistica e irrazionalistica). Ma si consideri,
comunque, per aver un giusto metro, prima di considerare i caposaldi della filosofia di Bergson, che
l’ autorevole teorico delle strutture dissipative, il fisico Ilya Prigogine, dichiarò di aver tratto
profondi motivi di riflessione da Bergson. Ne “Le bergsonisme” di Gilles Deleuze (la traduzione
italiana del 2001, “Il bergsonismo e altri saggi”, è a cura di Pier Aldo Rovatti e Deborah Borca) c’
è un invito: rileggere Bergson, rimuovendo quel “bergsonismo” di maniera, cui le mode e la
manualistica (ma anche gli ideologismi) ci hanno costretto. Ci si può anche chiedere da quale
diversa prospettiva e secondo quale esigenza – rispetto a Bergson – Isaac Newton sia giunto al suo
tempo assoluto e al suo spazio assoluto. Numerosi altri filosofi si erano cimentati attorno alla natura
del tempo. Secondo Aristotele il tempo è “il numero del movimento secondo il prima e il poi” in
quanto è un “continuum”. Kant aveva ridotto tempo e spazio alle forme dell’ intuizione sensibile,
del tutto soggettive. Ma citarli per un confronto con Bergson non è molto utile. Vincenzo Fano e
Isabella Tassani hanno pubblicato, nel 2002 un ampio saggio su “L’ orologio di Einstein. La
riflessione filosofica sul tempo della fisica”, ove, accanto a nomi come quelli di Lawrence Sklar,
John Erman e Michael Friedman, evocano proprio classici come Hans Reichenbach o Bergson,
laddove costoro hanno evidenziato l’ importanza della relatività ristretta per la nozione di tempo.
Certo non si può non ricordare l’ operazionismo di Einstein: i concetti fisici debbono essere
sostenuti da un metodo che confermi empiricamente la verità o la falsità di quel che ne discende, se
non si vuole che essi si rivelino infecondi e che le affermazioni che da essi si traggono risultino
prive di senso. Del resto, il tempo e lo spazio assoluti di Newton erano del tutto funzionali e
strumentali a quella fisica, da lui portata a compimento, che noi definiamo classica e che la
relatività di Einstein non avrebbe destituito di fondamento, se non ridimensionandone la portata. “Il
mondo di Newton – scrive Paolo Rossi ne “La rivoluzione scientifica: da Copernico a Newton” –
risulta composto … di tre elementi” e cita gli “Studi newtoniani” di Alexandre Koyré: il primo
elemento è “la materia, vale a dire un infinito numero di particelle separate e distinte l’ una dall’
altra, impenetrabili e immodificabili, ma non identiche”; il secondo è il movimento, quello strano e
paradossale stato relativo che non modifica le particelle nel loro essere, ma si limita a trasportarle
qua e là per il vuoto infinito e omogeneo”; il terzo è “lo spazio, vale a dire il vuoto realmente
infinito e omogeneo in cui, senza incontrare opposizione, i corpuscoli (e i corpi da essi formati)
compiono i loro movimenti”. Ernst Mach notava la contraddizione di un Newton che, da una parte,
opponeva alla pretesa di chiarire la causa-natura metafisica della gravitazione il proprio stato di
“filosofo naturale” (ora diremmo, semplicemente, “scienziato”) ed enunciava il principio
“Hypotheses non fingo” (ipotesi metafisiche: beninteso!); ma poi, d’ altra parte, sosteneva essere lo
spazio e il tempo assoluti, la qual cosa non è sperimentabile ed ha piuttosto il carattere di un’
“ipotesi” metafisica, dogmatica e inverificabile. Ma, ed è questo il punto, Paolo Rossi sottolinea
che “Gli stati di quiete e di moto rettilineo uniforme, perfettamente equivalenti tra loro, possono
essere determinati solo in relazione ad altri corpi che siano in quiete o in moto. Poiché il rinvio a
ulteriori sistemi di riferimento si riproduce all’ infinito, il flusso eterno e uniforme del tempo
(tempo assoluto) e l’ estensione infinita dello spazio (spazio assoluto) costituiscono per Newton le
coordinate alle quali è necessario far ricorso per definire, al limite, lo stato di quiete o di moto dei
corpi: “Il tempo assoluto, vero e matematico, in sé e per sua natura privo di relazione con qualcosa
di esterno, fluisce in modo uniforme e, con altro nome, vien detto durata … Lo spazio assoluto, per
sua natura privo di ogni relazione con qualcosa di esterno, rimane sempre simile a se stesso ed
immobile …””. La conclusione è che “Nello spazio assoluto < la legge della gravitazione
universale > garantisce la unità e la coesione dell’ universo”. Bergson, da parte sua, si poneva,
semplicemente, la questione della vera natura del tempo, come numerosi altri filosofi prima (e dopo
di lui) e concludeva che la fisica – sulla quale lui si era formato – non era in grado di affrontarla. L’
esigenza di una funzionalità strumentale del tempo (o di una determinata nozione del tempo, ad
esempio assoluto o relativo) alla fisica, o ad una fisica (ad esempio quelle di Newton o di Einstein)
non può esser confusa con la questione della natura del tempo. In ogni caso, egli non intendeva
minare la validità della fisica positiva ma, al contrario, congetturò la propria concezione del tempo
attraverso una continua concertazione e un serrato confronto con le scienze del suo tempo. E non è
detto che la riflessione meta-fisica che, in una certa età può apparire “inutile” per la scienza, non
finisca col rivelarsi feconda e funzionale, in epoche successive, ad un ripensamento e a nuove
formulazioni della scienza. Sarebbe miope lo sguardo che ignorasse le provocazioni e le
sollecitazioni che all’ epistemologia e, in generale alla filosofia, sono venute dalla fisica sul tema
della temporalità. La relatività ristretta ne ha rilanciato la dimensione soggettiva. E per i filosofi, già
al tempo di Bergson, non era più tempo di dar alla domanda: “Che cos’è il tempo?”, una risposta
come quella di Sant’ Agostino: “Lo ignoro”. Bergson oppose al “tempo spazializzato e misurabile”
della scienza, la “durata”, propria della coscienza. Scriveva nel “Saggio sui dati immediati della
coscienza” che “Nella coscienza noi troviamo degli stati che si succedono senza distinguersi, nello
spazio delle simultaneità che si distinguono senza succedersi, nel senso che l’ una non esiste più
quando l’ altra appare. Fuori di noi, esteriorità reciproca senza successione, dentro, successione
senza esteriorità reciproca”.
32 /
Henri Bergson (3)
Se Kant con la sua “Critica della ragion pura” s’ era risvegliato dal sonno dogmatico in cui lo aveva
costretto la metafisica leibniziano-wolffiana, Henri Bergson emerse dal tradizionalismo spiritualista
e coscienzialista, che dominava nella filosofia francese, da Montaigne e Cartesio in poi. E
avvalendosi della sua solida formazione scientifica, avviò un confronto serrato con il meccanicismo
e il riduzionismo dei positivisti. Muovendosi con competenza tra l’ evoluzionismo positivista
anglosassone, l’ eredità epistemologica del positivismo francese e la psicologia sperimentale
associazionistico-esplicativa, Bergson elaborò una originale teoria dell’ esperienza. Essa lo svincolò
dalla gabbia del positivismo e gli dischiuse una nuova prospettiva sulla coscienza, che non negava
le acquisizioni scientifiche. Ma, al contrario, intendeva trovare, proprio in esse, nuove
consapevolezze e nuovi spazi. Per penetrare a fondo il fluire della coscienza, adottò l’ intuizione
come strumento privilegiato. Assumendo una prospettiva anti-intellettualistica, egli si opponeva all’
associazionismo atomistico di Wilhelm Wundt. Secondo il quale il flusso di coscienza sarebbe
snaturato nella sua mobilità continua ed unitaria e ridotto ad “atomi” numerabili, da trattare ed
organizzare secondo leggi meccaniche. L’ intuizione bersoniana intendeva assicurare alla filosofia
una piena e fedele adesione alla coscienza, così da evitarne la riduzione – compiuta dalla psicologia
associazionistica e sperimentale – alla sola attività analitico-intellettiva. L’ anti-intellettualismo di
Bergson non era il trionfo di un “irrazionalismo reazionario”, bensì la via per conferire precisione e
aderenza della filosofia al proprio oggetto, la coscienza. Una precisione ed una aderenza che non
potevano non aver condizioni e strumenti diversi da quelli che sostengono e suffragano, invece, le
scienze della natura. “Il determinismo psicologico, nella sua forma più precisa e più recente, scriveva Bergson nell’ “Essais sur le donnes immediates de la coscience” (“Saggio sui dati
immediati della coscienza”) del 1889 – implica una concezione associazionistica dello spirito. Ci si
rappresenta lo stato di coscienza attuale come necessitato dagli stati anteriori; e tuttavia si avverte
che non si tratta in tal caso d’ una necessità geometrica, come, ad esempio, quella che lega una
risultante ai movimenti componenti … Il determinismo associazionista si rappresenta l’ io come un
aggruppamento di stati psichici, il più forte dei quali esercita un’ influenza preponderante e trascina
i rimanenti con sé”. L’ io, la coscienza, dev’ essere inteso come un flusso ed uno svolgimento
continuo di stati, compenetrantisi vicendevolmente, senza che tra di loro vi sia giustapposizione e
discrezione. Erroneamente, l’ associazionismo psicologico disseziona i “dati immediati della
coscienza” in “atomi psichici” e li riduce ad una dimensione meramente quantitativa e sperimentale.
Un approccio qualitativo-intuitivo mostra, appunto, differenze qualitative tra gli stati psicologici,
che vanno dall’ attenzione alla tensione, dalle forti emozioni alle sensazioni affettive e
rappresentative, alle sensazioni acustiche, termiche, ponderali e luminose. Il metodo intuitivo lo
fece approdare ad una originale concezione del tempo. Giacchè l’ esperienza immediata dell’ io
rivela che la temporalità della coscienza è di natura diversa dal tempo della scienza fisica. Il
fraintendimento più grave del determinismo associazionista e psico-fisico è proprio quello di ridurre
il “tempo vissuto” della coscienza a quello “spazializzato” della scienza sperimentale. Bergson
arriva alla distinzione tra “durata” e “tempo spazializzato” attraverso un complesso itinerario, le cui
tappe sono conddistinte dai paradossi di Zenone aleatico (che dimostrava, per assurdo, le tesi del
maestro Parmenide contro il movimento e la molteplicità), dallo studio della psico-fisica di Theodor
Gustav Fechner e dalla riflessione sul criticismo di Kant. Herbert Spencer e tutta la scienza
positivista avevano una concezione univoca del tempo: quella spazializzata-matematizzata della
meccanica. Essa imponeva la temporalità come successione alla coscienza, che vive invece nella
“durata”, Ad esempio, scriveva Bergson nel “Saggio”, è vero che “… i suoni della campana mi
giungono in modo successivo. Ma delle due cose l’ una: o trattengo ciascuna di queste sensazioni
successive per organizzarla insieme alle altre in un gruppo che mi ricorda un’ aria o un ritmo noto, e
in questo caso non conto i suoni, ma mi limito a raccogliere l’ impressione per così dire qualitativa
che il loro numero produce in me; oppure mi propongo esplicitamente di contarli”. Ma “allora sarà
necessario che io li dissoci, e che questa dissociazione venga effettuata in un ambito omogeneo in
cui i suoni, svuotati della loro qualità, vuoti in un certo senso, lascino tracce sempre uguali del loro
passaggio”. Certo, resta da chiarire “se questo ambito appartenga al tempo o allo spazio”, ma,
comunque, “un momento del tempo non potrebbe conservarsi per aggiungersi agli altri. I suoni
possono dissociarsi purchè lascino degli intervalli vuoti tra loro. E noi possiamo contarli perché
permangono intervalli tra i suoni che passano: ma come potrebbero permanere se fossero pura
durata e non spazio?”. In sostanza, quindi, “è proprio nello spazio che viene effettuata l’
operazione”. “Contare” i singoli suoni di una campana vuol dire renderli discreti, distinguerli,
dissociarli, collocando tra l’ uno e l’ altro un intervallo, insomma inserirli in uno spazio. Riunire i
suoni in un ritmo equivale ad averne un’ impressione qualitativa. Similmente, “quando sentiamo
una serie di colpi di martello, i suoni, in quanto sensazioni pure, formano una melodia indivisibile,
dando ancora luogo a ciò che abbiamo chiamato un progresso dinamico: ma sapendo che agisce la
stessa causa oggettiva, dividiamo questo progresso in fasi che da questo momento consideriamo
identiche; e poiché questa molteplicità di termini identici non può essere concepita se non in base a
un dispiegamento nello spazio, perveniamo di nuovo e necessariamente all’ idea di un tempo
omogeneo, immagine simbolica della durata reale”. Ora, tanto l’ uomo comune quanto lo scienziato
“spazializzano” il tempo. Ma il tempo spazializzato della successione deriva dalla “durata reale”,
attraverso una “esteriorizzazione”. Bergson, sempre nel “Saggio” sostiene che “solo lo spazio è
omogeneo”. “Le cose situate in esso costituiscono una molteplicità indistinta … tutte le molteplicità
distinte sono ottenute grazie a un dispiegamento nello spazio”. La “molteplicità indistinta” degli
oggetti della meccanica, il loro movimento e la relativa durata, acquista un ordine spaziale quando i
suoi elementi vengano distesi nello spazio. D’ altra parte, “nello spazio non ci sono né durata né
successione, nel senso in cui la coscienza intende questi termini: ognuno dei cosiddetti stati
successivi del mondo esterno esiste da solo, e la loro molteplicità ha realtà solo per una coscienza in
grado prima di conservarli, e poi di giustapporli esteriorizzandoli gli uni rispetto agli altri”. Se la
coscienza conserva tali molteplici stati, la cosa è dovuta al fatto che essi producono “fatti di
coscienza”, i quali “si compenetrano, si organizzano insensibilmente insieme e, per l’ effetto di
questa stessa solidarietà, legano il passato al presente”. La coscienza possiede simultaneamente i
“fatti di coscienza”. Se la coscienza “esteriorizza gli uni rispetto agli altri, è perché, pensando poi
alla loro distinzione radicale (poiché uno cessa quando l’ altro appare), li pensa nella forma di una
molteplicità distinta: il che significa ritornare ad allinearli insieme nello spazio in cui ciascuno di
essi esisteva separatamente. Lo spazio di cui ci si serve per far ciò è proprio ciò che viene definito
tempo omogeneo”. Insomma “… parecchi stati di coscienza si organizzano fra loro, si
compenetrano, si arricchiscono sempre più … a un io che ignorasse lo spazio, essi potrebbero
fornire così il sentimento della durata pura: ma già per impiegare il termine “parecchi” avevamo
isolato questi stati gli uni dagli altri, li avevamo esteriorizzati, gli uni rispetto agli altri, li avevamo
insomma giustapposti, e così, la stessa espressione cui abbiamo dovuto far ricorso, tradiva la nostra
abitudine radicata di distinguere il tempo nello spazio”. Bergson coglie due modi separati con i
quali la coscienza si relaziona al mondo, l’ uno qualitativo, l’ altro quantitativo. Solo per abitudine
passiamo dall’ uno all’ altro. Ma, mentre nel secondo, cose e stati di coscienza sono percepiti
secondo una successione quantitativa di elementi, nel primo (la durata pura) si ha “una successione
di mutamenti qualitativi che si fondono, si penetrano, senza contorni precisi, senza alcuna tendenza
a esteriorizzarsi gli uni in rapporto agli altri, senza alcuna parentela con il numero, cioè con l’
eterogeneità pura”. In sostanza, il tempo, nell’ interiorità della coscienza, è “durata” continua, priva
di scansioni-differenziazioni numeriche e spazializzanti. Pensiamo alle oscillazioni del pendolo.
Ciascuna posizione del pendolo è distinta dalle precedenti. Seguendo la successione delle
oscillazioni è come se computassimo delle simultaneità. Se poi immaginiamo di distrarre la nostra
coscienza e di non dirigerla più alle oscillazioni, che cosa resta? Comunque una sola posizione del
pendolo, senza alcuna durata. Proviamo, invece, a cancellare le oscillazioni. Rimane òa “durata”
eterogenea della coscienza, priva di esteriorità. “Quando seguo con gli occhi sul quadrante di un
orologio il movimento della lancetta che corrisponde alle oscillazioni del pendolo, non misuro la
durata, come potrebbe sembrare; mi limito invece a contare delle simultaneità, cosa molto diversa.
Al di fuori di me, nello spazio, vi è un’ unica posizione della lancetta e del pendolo, in quanto non
resta nulla delle posizioni passate. Dentro di me, si svolge un processo d’ organizzazione o di mutua
compenetrazione dei fatti di coscienza, che costituisce la vera durata. Mi rappresento ciò che io
chiamo le oscillazioni passate del pendolo, nello stesso tempo in cui percepisco l’ oscillazione
attuale, proprio perché io duro in questo modo. Sopprimiamo ora, per un istante, l’ io che pensa
queste cosiddette oscillazioni successive; avremo sempre una sola oscillazione del pendolo, anzi
una sola posizione di questo pendolo, e quindi nessuna durata. Sopprimiamo, d’ altra parte, il
pendolo e le sue oscillazioni; avremo solo la durata eterogenea dell’ io, senza momenti esterni gli
uni agli altri, senza rapporti con il numero. Così, nel nostro io, vi è successione senza esteriorità
reciproca; al di fuori dell’ io, esteriorità reciproca senza successione: esteriorità reciproca, in quanto
l’ oscillazione presente è radicalmente distinta dalla oscillazione precedente che non è più; ma
assenza di successione, in quanto la successione esiste solo per uno spettatore cosciente che ricordi
il passato e giustapponga le due oscillazioni o i loro simboli in uno spazio ausiliario”. Tra “durata”
della coscienza e oscillazione del pendolo che le è simultanea vi è una relazione che si trasforma in
consuetudine-abitudine: la separazione- distinzione tra gli stati successivi della vita della coscienza.
Ne scaturisce la convinzione che la “durata” della coscienza sia “spazializzata”. E’ una
convinzione sbagliata, come quella che ci lascia credere che le oscillazioni del pendolo stiano in una
successione “spaziale” (il “tempo omogeneo”). Ma, scrive Bergson, “tra successione senza
esteriorità e … esteriorità senza successione si attua una specie di scambio … Siccome ognuna dele
fasi successive della nostra vita cosciente, che tuttavia si compenetrano fra loro, corrisponde a una
oscillazione del pendolo a essa simultanea, e siccome d’ altra parte queste oscillazioni sono
nettamente distinte, poiché quando una si produce l’ altra non c’ è più, contraiamo l’ abitudine di
stabilire la stessa distinzione tra i momenti successivi della nostra vita cosciente: le oscillazioni del
bilanciere la scompongono, per così dire, in parti esterne le une alle altre. Di qui l’ idea erronea di
una durata interna omogenea, analoga allo spazio, i cui momenti identici si susseguirebbero senza
compenetrarsi”. La coscienza esige il ricordo delle oscillazioni precedenti, per rappresentare le
oscillazioni del pendolo. L’ orgine della successione delle oscillazioni esige la loro esterioritàdiscrezione. Ecco la ragione della corrispondenza all’ esteriorità dello spazio dei momenti
successivi nell’ interno della coscienza. La coscienza si dota di un “tempo omogeneo” che ha una
funzione del tutto pratica. Ma la durata reale è interiore ed eterogenea.
33 /
Henri Bergson (4)
Henri Bergson criticò la concezione univoca che del tempo avevano l’ evoluzionismo filosofico di
Herbert Spencer e, in generale, le scienze positiviste. Per la scienza e la filosofia del suo tempo, non
vi era altro che un tempo spazializzato, omogeneo, matematizzato, quello della meccanica. E ciò
che più lo lasciava perplesso era che ad una tale mera successione si volesse ridurre il tempo dei
fatti biologici e psicologici. Bergson oppose così, al tempo “quantificato”, “computato” e
misurabile della scienza, l’ unità sintetica della “durata”, del tutto qualitativa, che è la temporalità
irreversibile della coscienza. Essa è costituita da momenti che non sono discreti ed esterni tra di
loro, ma che anzi si compenetrano. Bergson paragonava, nell’ “Introduzione alla metafisica”,
(“Introduction a la métaphisique”, 1903), la “durata” ad un “arrotolarsi continuo, come quello d’ un
filo su un gomitolo, perché il nostro passato ci segue, e s’ ingrossa senza sosta del presente che
raccoglie nel suo cammino”. Il tempo spazializzato della meccanica è costituito da una molteplicità
di elementi, ciascuno dei quali è autonomo e attuale per sé. Il tempo dell’ orologio è scandito in
minuti, e se anche un minuto vien diviso in due, ciascuna delle due metà è della stessa natura. Il
tempo della meccanica si distende nello spazio e con esso si confonde. Um momento della durata
interiore, invece, se vien separato dal flusso che lo ha generato, perde la propria natura qualitativa.
Così accadrebbe ad uno stato d’ animo, disancorato dalle sue ragioni. “Un sentimento complesso –
scriveva Bergson – conterrà un numero abbastanza grande di elementi più semplici, ma, finchè
questi elementi non si distingueranno con una perfetta chiarezza, non si potrà dire che erano
interamente realizzati, e, non appena la coscienza ne avrà la percezione distinta, lo stato psichico
che risulta dalla sintesi sarà per ciò stesso cambiato”. La “durata” interiore dischiude all’ uomo l’
autonoma dimensione della propria soggettività. Bergson scopre, come già Kant, un “libero regno
dei fini”, nel quale si muove la coscienza, libera e autocreatrice, svincolata dalla datità delle cose e
dalla causalità deterministica della quale queste ultime sono prigioniere. La coscienza, come durata
e come libertà, si sottrae al determinismo dell’ identità delle cause e degli effetti. Nell’ interiorità
non vi è nulla di identico o di prevedibile. La soggettività è in grado di porsi in forme sempre
nuove. “Siamo liberi – scrive Bergson – quando i nostri atti emanano dalla nostra personalità intera,
quando la esprimono”. Libertà e autocreatività contraddistinguono quella soggettività che si esprime
pienamente e compiutamente nella durata di cui è il frutto. La “querelle” interminabile tra i due
modi tradizionali di comprendere la coscienza – quello deterministico e quello indeterministico –
non può aver ricomposizione definitiva, semplicemente perché è mal posta. Essa riposa, in entrambi
i casi, su una riduzione dell’ interiorità a connessioni causali che appartengono al mondo della
natura e su una frammentazione atomistica della coscienza. L’ ottica deterministica ricerca specifici
e determinati moventi interiori che spiegherebbero l’ azione, così come un determinato fenomeno
naturale ne provoca un altro. Ma nella durata interiore non vi è distinzione- successione di elementi
e momenti. Tutta la coscienza, nella sua unità, è comunque all’ origine dell’ azione. La prospettiva
indeterministica riconduce l’ azione al libero arbitrio che sceglierebbe tra varie possibilità. Ma di
nuovo: l’ unità della coscienza non è in discussione. Gli stati e i momenti della coscienza non
soggiacciono ad alcuna identità-uniformità. Ciascuno di essi è irripetibile ed è parte di un flusso
continuo e intero che non può esser concepito come semplice successione-scansione causale e
lineare. L’ unicità e irripetibilità dei fatti psichici dev’ essere collocata nel dinamismo della durata.
Libertà è durata, flusso temporale in cui dominano passato e memoria. Tanto il determinismo
psichico (associazionismo) quanto l’ indeterminismo (idealismo kantiano) riducono gli stati della
coscienza ai fatti naturali, esterni e ripetibili. Il “Saggio sui dati immediati della coscienza” (“Essais
sur le donnes immediates de la coscience”, 1889) concludeva con un sostanziale dualismo tra
interiorità ed esteriorità, fra tempo spazializzato e durata interiore, fra tempo della scienza e tempo
della coscienza, tra libertà e determinismo. Si riaffacciava il dualismo cartesiano tra anima e corpo,
tra sostanza estesa e sostanza pensante, tra finalismo e determinismo, tra “res cogitans” e “res
extensa”, che aveva turbato la metafisica razionalistica moderna, dagli occasionalisti come Geulinx
e Malebranche a Spinoza e Leibniz. In “Materia e memoria” (“Matière et memoire”, 1896) Bergson
affrontò la questione dell’ autonomia della coscienza nei confronti della materia, un tema sul quale
già si era misurato Maine de Biran. Certo, la domanda: “perché ci sia la materia?”, è generica. Essa
si specifica così: “perché c’ è il corpo?”. La qual cosa rimanda alla coscienza e alla
contrapposizione cartesiana e spiritualistica tra anima e corpo. Bergson partì dagli esiti del “Saggio
sui dati immediati della coscienza”, che diede per acquisiti, e approfondì il discorso. Nelle
operazioni della coscienza si distinguono memoria, ricordo e percezione. La memoria non è altro
che la coscienza. In quanto è autocoscienza e presenza della coscienza a se stessa nel costruirsi e
nel dipanarsi del ricordo. Il ricordo, propriamente, è la traduzione attuale di un dato della coscienza.
La funzione del ricordare, d’ altra parte, non è sempre in grado di tradurre, nell’ attualità presente,
un ricordo. Il ricordo è, appunto, una funzione cerebrale. La percezione è la distinzione-selezione
fra stimoli, in vista dell’ azione. In queste tre facoltà-operazioni della coscienza, vi è la distinzione
tra anima e corpo, ma anche la loro continuità. Dalla pura dimensione spirituale, attraverso la
memoria, funzione del cervello, si scende alla percezione, che riguarda l’ azione, e, dunque, il
corpo. In tal modo la corporeità viene ricondotta alla spiritualità. Il corpo acquisisce una funzione
strumentale e operativa per l’ azione che muove dalla coscienza. La memoria è, comunque, la
facoltà centrale, in questo ripensamento dei rapporti tra coscienza e materia. Bergson intende la
percezione come un dinamico movimento e non come uno stato. Tanto l’ idealismo quanto il
realismo concepiscono la percezione come uno stato soggettivo. E così si precludono la
comprensione tanto della percezione quanto della memoria (il passato!). Percezione e ricordo si
compenetrano ma è sbagliato intenderli come “stati”. Non si comprende la vera natura del ricordo
se non si intende la percezione pura come un’ azione che si distende nel reale. “L’ errore capitale …
che, risalendo dalla psicologia alla metafisica – scrive Bergson – finisce per dissimularci tanto la
conoscenza del corpo quanto quella dello spirito, consiste nello scorgere, tra la percezione pura e il
ricordo, solo una differenza di intensità, e non di natura”. E’ vero che “le nostre rappresentazioni
sono impregnate di ricordi e … un ricordo non ridiventa presente se non prendendo a prestito il
corpo di qualche percezione in cui si inserisce”. “… Percezione e ricordo si compenetrano e
scambiano sempre qualcosa … Si pretende < dalla psicologia e dalla metafisica > che questi stati
misti, composti, in parti ineguali, di percezione pura e ricordo puro, siano stati semplici”. Ma,
sottolinea Bergson, tra la percezione e il ricordo non vi è soltanto una differenza di grado, bensì di
natura. Il ricordo non è “una percezione più debole”. E la percezione non è un ricordo più intenso.
“Per il realismo – riflette Bergson – l’ ordine invariabile dei fenomeni naturali risiede in una causa
distinta dalle nostre stesse percezioni, sia che questa causa debba rimanere in conoscibile sia che
attraverso uno sforzo … di costruzione metafisica, la si possa cogliere. Per l’ idealista, al contrario,
queste percezioni sono l’ insieme della realtà, e l’ ordine invariabile dei fenomeni naturali è solo il
simbolo attraverso il quale esprimiamo, accanto alle percezioni reali, le percezioni possibili. Ma
tanto per il realismo quanto per l’ idealismo le percezioni sono delle allucinazioni vere, stati del
soggetto proiettati al suo esterno; e le due dottrine differiscono semplicemente per il fatto che per l’
una questi stati costituiscono la realtà, mentre per l’ altra arrivano a coglierla”. In sostanza, tanto per
il realismo quanto per l’ idealismo, la percezione è uno stato soggettivo: per il primo, è la stessa,
fedele, realtà; per il secondo, è il mezzo tramite cui cogliere la realtà esteriore. Percezione e ricordo
non sono stati psichici che differiscano solo per intensità. Sia che si risolva il ricordo nella
percezione, sia che si approssimi la percezione al ricordo, si cade nell’ errore di considerare la
percezione come uno stato soggettivo, che per il realismo è mezzo per appropriarsi della realtà
esteriore, mentre per gli idealisti coincide con la realtà stessa. In entrambi i casi, è preclusa la
distinzione tra passato e presente, memoria e percezione. Il fatto è che la percezione è un’ attività e
non uno stato, un movimento attivo e dinamico. Tra percezione e ricordo vi è un abisso
qualitativamente incolmabile, giacchè, se la percezione agisce, il ricordo non agisce più.
“Ristabiliamo – scrive Bergson – il vero carattere della percezione; mostriamo, nella percezione
pura, un sistema di azioni nascenti che affonda nel reale le sue profonde radici: questa percezione si
distinguerà radicalmente dal ricordo; la realtà delle cose non sarà più costruita o ricostruita, ma
toccata, penetrata, vissuta; e invece di perpetuarsi in discussioni metafisiche, il problema rimasto
irrisolto tra il realismo e l’ idealismo, dovrà essere risolto una volta per tutte dall’ intuizione”. La
“percezione pura” è frutto del sistema nervoso. E il sistema nervoso è materiale come materiale è la
realtà esterna . Tra realtà materiale e realtà spirituale occorre operare una netta distinzione. Evitando
il materialismo ma anche l’ ingenuo spiritualismo. Materialisti e spiritualisti negano alla materia
quel che il senso comune le riconosce, ma “la materia è esattamente come appare”. Occorre
eliminare dalla materia “ogni virtualità, ogni potenza nascosta”. E’ questa la retta via per conferire
“realtà indipendente” ai “fenomeni dello spirito”. Ma la cosa è possibile solo se si lasciano “alla
materia quelle qualità che, in modo concorde, materialisti e spiritualisti staccano da essa, questi per
farne delle rappresentazioni dello spirito, quelli per scorgere in essa solo il rivestimento accidentale
dell’ estensione”. La filosofia deve far proprio l’ atteggiamento del senso comune quando si pone di
fronte alla materia, così da non svilirla e svuotarla come fanno tanto gli spiritualisti quanto i
materialisti. Ma deve, nello stesso tempo, ammettere l’ autonomia della memoria, che ci consente di
percepire “in noi” la materia. “La memoria, praticamente inseparabile dalla percezione, intercala il
passato nel presente, contrae inoltre i molteplici momenti della durata in un’ unica intuizione, e
così, con la sua duplice operazione, diviene la causa per la quale noi percepiamo la materia in noi,
mentre di diritto la percepiamo in sé”. Un’ adeguata attenzione alla memoria ci darà la certezza
empirica dell’ autonomia e della realtà “separata” dello spirito. “Se la memoria è ciò che comunica
alla percezione soprattutto il suo carattere soggettivo, la filosofia della materia … dovrà mirare
anzitutto a eliminarne l’ apporto … Poiché la percezione pura ci dà la totalità o per lo meno l’
essenziale della materia, e poiché il resto proviene dalla memoria e si aggiunge alla materia, è
necessario che, per principio, la memoria sia una capacità assolutamente indipendente dalla
materia”. E conclude Bergson: “E’ proprio qui, nel fenomeno della memoria, che dobbiamo
verificare sperimentalmente se lo spirito sia una realtà”. La memoria non si risolve nell’ atto
percettivo e dev’ essere compresa nella sua sostanziale immaterialità e spiritualità. Il dualismo
materia/spirito, scaturisce dall’ errata interpretazione che hanno dato tanto l’ idealismo quanto il
materialismo, della materia. “Ogni tentativo di far derivare il ricordo puro da un’ operazione del
cervello, dovrà rivelarsi all’ analisi come un’ illusione fondamentale”. Materia e memoria debbono
essere tenute ben distinte proprio per ritrovare la loro sintesi. La materia non è né pura estensione né
semplice rappresentazione spirituale: è la percezione che coglie l’ essenza qualitativa che le è
propria. La teoria della memoria di “Materia e memoria” pone capo all’ irriducibilità del ricordo
alle funzioni cerebrali e lo intende, piuttosto, come la confluenza e il “crocevia” di materia e
spirito, in una gerarchia di stati della coscienza che vanno dalla materialità dell’ azione alla
memoria come la più autentica espressione dell’ io. Ed è una concezione unitaria della mente che
scaturisce da una forte e robusta cultura psicologica che vede Bergson muoversi con padronanza e
aderenza sperimentale nella complessità di patologie come le varie forme di afasia e le lesioni dell’
encefalo.
34/
Henri Bergson (5)
Il giovane Henri Bergson aveva creduto di voler e poter dare sistematicità definitiva alla filosofia
evoluzionistica di Herbert Spencer, che intese come una grande metafisica. E ne trasse l’ immagine
nitida e potente della totalità dell’ universo nella sua progressività lineare ed univoca. Una
progressività in cui non vi sono ricorsi, interruzioni, arretramenti o soluzioni di continuità. Ma via
via che l’ ottimismo spenceriano gli si dispiegava con tutto il suo afflato “romantico”, crebbe in lui
un forte scetticismo nei confronti del positivismo e del suo riduzionismo naturalistico verso la
mente e la coscienza. E, al fine di salvaguardare l’ autonomia e la specificità dell’ io, volle
distinguerne la temporalità propria e interna da quella della meccanica. Il tempo della scienza è
spazializzato e reversibile; gli istanti collocati in una successione spaziale, sono discreti ed esterni l’
un l’ altro. Al contrario, la “durata” della coscienza, il tempo vissuto, è memoria del passato e
anticipazione del futuro, è integrazione e reciproca penetrazione di stati. Il tempo spazializzato è
senz’altro un irrinunciabile strumento per la scienza, ma il determinismo che esso trascina con sé è
inefficace nella comprensione della vita della coscienza. Solo se si guarda al flusso continuo e
ininterrotto della coscienza, si può accedere alla sua libertà; giacchè la libertà c’ è quando “i nostri
atti scaturiscono da tutta la nostra personalità, quando la esprimono …”. Come Kant – che la
credeva un inconoscibile “noumeno” – anche Bergson escludeva che la libertà possa essere
analizzata e definitita. Ma della nostra libertà noi siamo, comunque, immediatamente consapevoli e
certi, pur se sappiamo cogliere l’ io nella sua dimensione autentica e profonda. Le due temporalità
evocavano, però, il dualismo cartesiano delle sostanze (pensante ed estesa), l’ estraneità tra la
coscienza, regno del finalismo, e la corporeità estesa, regno del meccanicismo. Bergson si apprestò,
quindi, a definire con chiarezza “la distinzione del corpo e dello spirito” così da “penetrare più
intimamente nel meccanismo della loro unione”. Nonostante intendesse salvaguardare la
dimensione dello spirito e della coscienza, egli non voleva la scissione. Cercava la continuità, alla
maniera di Leibniz. “In una coscienza umana – scriveva – c’ è infinitamente di più che nel cervello
corrispondente”, e rifutava la psicologia sperimentale associazionistica e ogni prospettiva
psicologica che riduca gli stati mentali a mere funzioni cerebrali. La coscienza non è che memoria
ma la memoria, se deve far uso di funzioni cerebrali e corporee, è però autonoma dal corpo. Una
lesione cerebrale compromette il ricordo e la relazione tra la coscienza e le cose, ma non la
coscienza. La memoria spirituale non è altro che la “durata”, la temporalità propria della coscienza,
e se l’ encefalo seleziona e invia i ricordi relativi all’ azione da eseguire, il suo apporto al flusso e al
processo della coscienza è davvero parziale. La percezione non è una semplice conoscenza. Essa ha
una funzione pratica e operativa. Agisce sulla realtà materiale. Memoria, ricordo, percezione: sono
le tre funzioni principali di “Materia e memoria” (1896). Bergson s’ è chiesto come la memoria,
immersa nella durata reale, si connetta alla percezione e generi l’ esperienza soggettiva. Un’
esperienza, quella soggettiva, che non è certo riconducibile ad una aggregazione-successione di
“atomi psichici”, come vogliono gli psicologi sperimentali e associazionisti, ma nasce da un flusso
di ricordi originati sia dalla memoria che dalla percezione attuale. “Il nostro corpo – scrive Bergson
in “Materia e memoria” – non è altro che la parte della nostra rappresentazione che rinasce
invariabilmente, la parte sempre presente, o piuttosto quella che, ogni momento, è appena passata.
Immagine esso stesso, questo corpo non può immagazzinare le immagini, perché fa parte di esse”.
Insomma, il corpo, come la coscienza e gli oggetti, non è che un’ immagine. Ma quale relazione vi è
tra le percezioni e il cervello? “Le percezioni non si situano nel cervello; è il cervello che è in esse”.
Bergson rifiutava la neurofisiologia di Pierre-Paul Broca, secondo il quale la memoria si spiegava
attraverso un impulso nervoso che imprimerebbe i ricordi nell’ encefalo, quasi che le neurocellule
di una determinata area di quest’ ultimo fossero le portatrici della funzione del ricordo. Una tale
area avrebbe poi preso da lui il nome (“Brocasche Windung”, “Broca’s area”), ovvero la terza
circonvoluzione cerebro-frontale, quella più bassa. Sarebbe, in sostanza, la parte inferiore della
circonvoluzione frontale (“gyrus frontalis inferior”). Il terzo posteriore della circonvoluzione
temporale superiore dell’ emisfero sinistro era deputato a produrre le immagini verbali motorie.
Broca era uno di quei “localizzazionisti stretti” che, da F. J. Gall (fondatore della frenologia) in poi
erano convinti che settori precisi della corteccia cerebrale sono deputati ad altrettante specifiche
funzioni. Bergson obiettava a Broca che non mancano casi di lesioni cerebrali nell’ area interessata,
in cui si dia un recupero della memoria e scriveva che ”… in ogni istante, quest’ immagine tutta
particolare, che persiste in mezzo alle altre e che chiamo il mio corpo, costituisce … un taglio
trasversale nel divenire universale. E’ quindi il luogo di passaggio dei movimenti ricevuti o rinviati,
il “trait d’ union” tra le cose che agiscono su di me e le cose sulle quali io agisco, la sede, in una
parola, dei fenomeni sensorio-motori”. Il corpo è il luogo d’ incontro, il punto d’ intersecazione
della coscienza nel mondo oggettivo. La corporeità è la mediazione fra la dimensione della durata e
la dimensione delle immagini-oggetto. E. secondo Bergson, il mondo delle cose non è in sé,
esternamente alla coscienza. L’ immagine delle cose, quando si incontri con l’ immagine dell’ io,
origina la conoscenza, che è dunque un’ interazione. Il mondo è un complesso di immagini. Il
mondo delle cose è così come la coscienza lo percepisce. Il mondo delle cose e la stessa coscienza
non sono che immagini. “Se rappresento – diceva Bergson – con un cono SAB la totalità dei ricordi
accumulati nella mia memoria, la base AB, situata nel passato, rimane immobile, mentre il vertice
S, che raffigura in ogni momento il mio presente, avanza senza posa, e sempre senza posa, tocca il
piano mobile P della mia rappresentazione attuale dell’ universo. L’ immagine del corpo si
concentra in S; e, poiché fa parte del piano P, tale immagine si limita a ricevere e a restituire le
azioni che emanano da tutte le immagini che compongono il piano”. Per capire la vita della
coscienza, il suo fluire dinamico, si immagini, dunque, un cono capovolto, il cui vertice è anche un
punto del piano su cui esso giace perpendicolarmente. La percezione attuale che io ho del mondo, il
complesso delle immagini del mio campo percettivo, sono rappresentati dal piano P. La base AB
dello stesso cono (la più lontana dal piano P) sta a significare i ricordi, il passato, la memoria. Il
vertice S del cono è il punto di intersezione-intersecazione dell’ immagine-corpo (il mio corpo,
beninteso) nella percezione attuale delle immagini-mondo. Memoria e percezione (attuale),
percezione e materia non sono disgiunti o contrapposti da alcuna soluzione di continuità. Date le
immagini degli oggetti situati sul piano P, l’ immagine corporea sceglie tra di esse con una sorta di
“principio economico”, a seconda della loro convenienza e funzionalità pratica. In questa scelta l’
immagine corporea tiene conto dei ricordi giacenti nella memoria (rappresentata dalla base AB del
cono). Tali ricordi sono, del resto, l’ esito delle precedenti scelte compiute dall’ immagine corporea
tra le immagini-oggetto dello stesso piano P. La circolarità tra passato e presente rende evidente la
sintonia tra memoria e “durata” (il tempo della coscienza). La memoria conserva il passato nel
presente ed è biunivocamente connessa alla percezione. Orienta la percezione ma dalla percezione è
indotta a far riaffiorare i ricordi. “La memoria del corpo, costituita dall’ insieme dei sistemi
sensorio-motori che l’ abitudine ha organizzato – scrive Bergson – è … una memoria quasi
istantanea a cui la vera memoria del passato serve da base”. Vi sono dunque due memorie: quella
che accumula e quella che “distende” i ricordi sul fondo immediato delle percezioni. E aggiunge
Bergson: “Poiché esse non costituiscono due cose separate, poiché la prima è … solo la punta
mobile che la seconda inserisce nel piano mobile dell’ esperienza, è naturale che queste due
funzioni si prestino un mutuo appoggio”. La “vera memoria” (la memoria della coscienza come
durata) entra nel piano delle percezioni attuali e dell’ esperienza “esterna” grazie alla “memoria del
corpo”. “Da un lato, infatti, la memoria del passato presenta ai meccanismi sensorio-motori tutti i
ricordi in grado di guidarli nel loro compito e di dirigere la reazione motrice nel senso suggerito
dagli insegnamenti dell’ esperienza: le associazioni per contiguità e per somiglianza consistono
proprio in ciò. Ma, dall’ altro, gli apparati sensorio-motori forniscono ai ricordi impotenti, cioè
inconsci, il modo di prendere corpo, di materializzarsi, insomma di divenire presenti”.
L’ ultimo Bergson volle coniugare la sua teoria della conoscenza con la “teoria della vita”,
ponendo capo ad una “filosofia della vita” che attribuiva la durata reale (della coscienza) allo stesso
universo. “Se voglio prepararmi un bicchiere di acqua zuccherata – scriveva Bergson -, checchè
faccia, debbo pur aspettare che lo zucchero si sciolga. Questo piccolo fatto è ricco di insegnamenti:
giacchè il tempo dell’ attesa non è più quel tempo matematico che varrebbe, per tutto il corso della
storia del mondo materiale, anche se questa avesse a dispiegarsi in un sol tratto nello spazio: essa
coindice con la mia impazienza, cioè con una parte della mia durata, che non si può allungare o
abbreviare ad arbitrio. Non è più qualcosa di pensato, è qualcosa di vissuto …”. Pur senza
contestare le acquisizioni della scienza, Bergson ritenne di dover proporre una nuova prospettiva non più statica, settoriale e meccanica come quella scientifica – nei confronti di un’ universoorganismo che “dura” ed è continua creazione di nuove forme. La realtà biologica mostra tutta la
sua creatività, novità, imprevedibilità: è vita che sempre si rinnova ed inventa, portando con sé,
nelle sue nuove forme, tutto il passato. Bergson supera l’ antinomia meccanicismo/finalismo,
quando concepisce una universale “evoluzione creatrice”, che esclude tanto la causalità efficiente
del meccanicismo quanto la causa finale nel processo evolutivo. “Le spiegazioni meccanicistiche –
scrive – valgono per i sistemi che il nostro intelletto distacca artificiosamente dal tutto … L’
essenza delle spiegazioni meccanicistiche sta, infatti, nel considerare l’ avvenire ed il passato come
calcolabili in funzione del presente e di pretendere così che “tutto è dato”. Secondo tale ipotesi,
passato, presente e futuro, sarebbero visibili di colpo da parte di un’ intelligenza sovrumana capace
di effettuare il calcolo”. E, d’ altra parte, “Come nella ipotesi meccanicistica, anche < nella dottrina
della finalità (di Leibniz) > si parte dal presupposto che “tutto è dato”. Il finalismo così inteso non è
che meccanicismo rovesciato: si ispira allo stesso postulato, con questa sola differenza … esso pone
innanzi a noi, anziché dietro, la luce con cui pretende guidarci; all’ impulso del passato sostituisce l’
attrazione del divenire”. La teoria cosmologico-metafisica dell’ ultimo Bergson svincolava la
prospettiva evoluzionistica dal determinismo darwiniano come dal finalismo creeazionistico e
provvidenzialistico. Il suo evoluzionismo dinamico era di nuovo tipo e concepiva l’ evoluzione
come creatività e vitalità autonoma, da ricondursi ad una libertà creatrice originaria. Tale egli la
intese come forza immanente e primigenia, uno “slancio vitale” che paragonò allo scoppio di una
granata, “scissasi improvvisamente in frammenti che, essendo essi stessi granate, sono scoppiati a
loro volta, dando luogo a frammenti destinati a scoppiare ancora, e così di seguito, per moltissimo
tempo”. Ecco gli infiniti gradi della realtà: i frammenti che guizzano in ogni direzione senza alcuna
prevedibilità. E, di fronte ad un albero che ramifica come un “frattale” in direzioni imprevedibili,
non è possibile predeterminare e tracciare preliminarmente alcuna direttrice dell’ evoluzione.
Anche nel mondo naturale “L’ incessante progredire del passato … intacca l’ avvenire e …
progredendo, si accresce”. L’ universo può esser compreso solo se se ne intendono l’ evoluzione e il
progresso, privi di predeterminazioni e aperti perennemente al nuovo. Lo “slancio vitale” che urge
nell’ universo non è altro che la vita, la quale anima, internamente, tutto l’ universo e dà conto dell’
evoluzione creatrice che anima l’ intera natura.