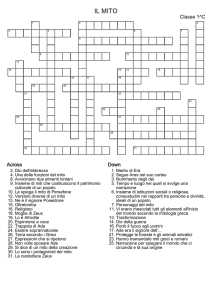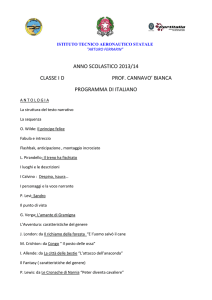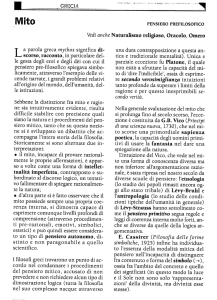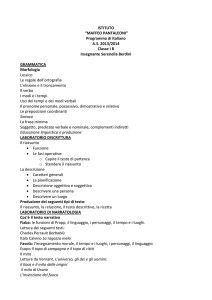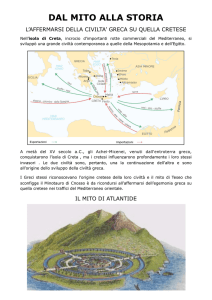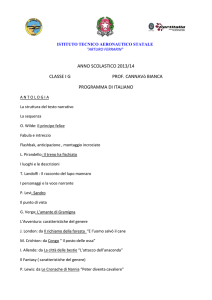La Cicuta On-line
Autore:
Sezione:
Ermeneutica
LORENZO CAPITANIO
La maschera di Proteo, l’immagine del Mito nello specchio dell’anima
occidentale
Darum denken wir auch dabei der himmlischen, die sonst
Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit
Per questo ci fanno pensare ai celesti, che qui
Sono già stati e che a tempo giusto ritorneranno
(Friedrich Hölderlin, Brot und Wein, Elegia, inverno 1800-1801)
Se si vuole assegnare al genio greco un volto che esprima efficacemente l’essenza del suo
carattere, questo è l’inesauribile creatività con cui esso seppe dare la propria forma al mondo, a
partire da una trama proteiforme e inesauribile di racconti, vicende di dèi e di eroi, che abbiamo
imparato a designare con il termine “mito”, quanto mai abusato e ambivalente.
È noto che un popolo conferisce gli ineffabili contorni del divino a ciò che ritiene degno
della massima venerazione, e nessun popolo seppe dare tanto valore all’umana facoltà del conoscere
come fecero gli Elleni. Vediamo per essi il divino, sin dai bagliori aurorali della filosofia, assumere
i caratteri dell’intellegibile, di ciò che massimamente dà una forma e un limite a ciò che all’uomo è
estraneo. Attraverso l’eterea coltre dei secoli, la civiltà greca ci appare come il trionfo del limite e
della proporzione sull’informe, ma che da quell’informe trae la linfa vitale e la gioia solenne del
proprio trionfo. Civiltà dell’Olimpo e dei Misteri, del mito e della filosofia, aurea coincidenza degli
opposti che dialetticamente impose sui millenni il proprio sigillo.
Uno dei massimi esponenti del rinnovato interesse per la grecità e il problema del mito che,
silenziosamente, attraversa i primi decenni del Novecento è il filologo Walter Friedrich Otto. Nel
suo capolavoro “Gli dèi della Grecia. L’immagine del divino nello specchio dello spirito greco”
mette in evidenza, come nessun altro in precedenza, l’unicità dell’orizzonte entro il quale l’uomo
greco trascorre la propria esistenza e organizza il proprio conoscere, orizzonte che, non senza
amarezza, colpisce noi moderni per la sua lontananza e incommensurabilità.
Difatti la nostra concezione del divino, accecata dall’assoluta trascendenza della divinità, ci
impedisce di cogliere appieno il significato di un orizzonte in cui la trascendenza assume i tratti
medesimi del reale, in totale e incessante coincidenza col mondo.
Alla religione ellenica è del tutto estraneo il concetto di miracolo, inteso in senso ebraicocristiano, miracolo è la realtà stessa, nel suo continuo trascendersi e assumere la forma del divino.
Questa “rivelazione” del divino non può che configurarsi come esperienza estatica e
assolutamente originaria. Si pensi al ruolo sacro che la poesia rivestiva presso i greci, si rammenti il
proemio dei poemi omerici o del poema filosofico di Parmenide, dove in versi perfetti è scolpita la
verità dell’essere rivelata dalla dea. Il poeta non è un creatore (poietés), ma attraverso di lui risuona
la parola della divinità, immagine solenne dell’ordine eterno del cosmo. Il poeta è strumento delle
Muse, da Zeus concepite per celebrare l’armonia del mondo, un tramite, un ponte fra l’umano e il
divino, tra l’eterno e il transeunte. Questa la forma e l’essenza stessa del Mito, che non
rappresenterebbe, come il senso comune o, disgraziatamente, anche certa filosofia vorrebbe
intenderlo, una disposizione mentale “primitiva” con cui l’uomo ancora non “civilizzato” si servì
per dare una pallida e fantasiosa spiegazione del mondo prima di affidarsi alla più solida ragione
discorsiva, ma è, nella visione di Otto, l’autorivelarsi della verità dell’essere nella sua originaria
manifestazione. Irriducibile dunque a qualsiasi “mentalità” o “approccio esistenziale” proprio in
virtù del suo precedere ogni sfera logico-razionale. Il mito autentico, originario, è contemplazione
primigenia, partecipazione estatica e canto silenzioso del mistero dell’essere nella sua vitale e
luminosa immediatezza, e il rito, che può essere inteso alla stregua di una perpetuare e vivere
autenticamente il contenuto del mito, coincide, presso i greci (così come per i romani), con le forme
della vita stessa e dell’agire quotidiano. Lasciando la parola ad Otto : “Il mondo si compie nella
nascita della forma, che ne rivela l’essere e con esso coincide. E questa forma sono la parola e il
canto, originariamente identici, prodotti non da facoltà umana ma rilucenti dell’essere stesso delle
cose; una manifestazione divina: la Musa. Essa è lo spirito e la forza del mito del mondo, nella sua
rivelazione come forma sonora".1
A differenza della cultura indiana, dove la parola è subordinata alla mente, che tutto
sovrasta, Prajapati, il progenitore e protettore della vita, mentre i Deva, le divinità, sono parola, per i
greci pensiero e parola formano una unità indissolubile che racchiude al suo interno qualsiasi
fenomeno e accadimento. Λόγος è pensiero e parola al contempo, che corrisponde all’essere (τὸ γὰρ
αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι)2 ma la lingua greca possiede un altro termine per indicare la parola:
“μύθος“.
Se λόγος indica il discorso razionale, premeditato, che serve a convincere (λέγειν avrebbe
fondamentalmente il significato dello “scegliere” e del “raccogliere”), “μύθος“, che solo in epoca
tarda ha assunto il significato di “favola”, “racconto fantastico”, indica originariamente la parola nel
suo valore reale e oggettivo, ciò che accade ed è accaduto conformemente all’essere. Per
comprendere il senso in cui vada intesa l’esperienza mitica, ci viene in soccorso un oscuro autore
neo-platonico amico e collaboratore dell’imperatore Giuliano, Salustio. Leggiamo nel suo De diis et
mundo che “anche il mondo infatti può esser detto un mito, perché in esso corpi e oggetti si
manifestano, mentre le anime e le intelligenze si nascondono”.3
È un luogo comune l’opinione secondo cui, attraverso un processo messo in atto dalla stessa
filosofia, i greci tentarono di sbarazzarsi del mito, scrutato ormai con diffidenza e ribrezzo.
L’orizzonte nel quale l’uomo greco è sempre vissuto è essenzialmente mitico, nel senso che
sopra indicammo, e cessò di esistere come tale solo al crollo definitivo della civiltà dell’Ellade; le
critiche mosse dai versi di Senofane non rappresentano che l’artificioso espediente di un poeta
comico.
1
W.F. Otto, Il Mito, a c. di G.Moretti, Il Melangolo, Genova 2000, pg. 61
2
Parmenide, frammenti, 28 B 3 DK
3
Salustio, Sugli dèi e il mondo, a c. di R. di Giuseppe, Adelphi, Milano 2000, pg.121
Attraverso il mito la Grecia ha concepito la vita in un eterno presente: Apollo che, ardente di
desiderio, insegue la bella Dafne, Edipo interrogato dalla sfinge, i titani cacciati nelle profondità
della terra dall’ascesa degli olimpi, le eroiche imprese di Bellerofonte, Eracle e Dioniso,
“Queste cose non avvennero mai, ma sono sempre: l’intelligenza le vede tutte assieme per un
istante, la parola le percorre e le espone in successione”.4
Il tempo è dai greci considerato qualcosa di sospetto e di cui è meglio non curarsi; quanto
appaiono diverse le città classiche, senza tempo, dalle nostre ove, riprendendo una brillante analogia
spengleriana, il fatale incombere del tempo è continuamente ricordato dai “rintocchi risonanti
giorno e notte da innumerevoli torri e campanili sull’Europa occidentale”!5 Prima di Aristotele non
esisteva nessuna divisione del giorno e le meridiane erano trattate come oggetti insignificanti.
Furono i tedeschi a inventare gli orologi meccanici, “simboli paurosi del tempo che passa”. Oswald
Spengler vede la maniera occidentale di intendere il tempo come il risultato dell’incontro di due
opposte concezioni: quella greco-romana e quella arabo-magica. Laddove quest’ultima concepiva il
tempo come un qualcosa di sospeso tra un inizio e una fine determinati dall’arbitrio di una divinità
trascendente, l’occidente cristiano riprese tale concezione stendendola lungo una linea temporale,
dominata dal disegno della provvidenza divina (si pensi ad Agostino o a Gioacchino da Fiore,
giganti del Medioevo cristiano).
Non appartiene alla civiltà greca un’idea della storia, ma solo quella di un puro presente,
tanto osannata e rimpianta da Goethe - “non conosce passato e futuro; il presente è la sua eternità”6
- in cui la storia stessa è vista come un mito (Erodoto e Tucidide venivano letti pubblicamente per le
strade così come l’Iliade e l’Odissea) e il mondo non come un qualcosa che diviene ma che è;
mentre l’Europa moderna ha visto nella storia un processo organico, di cui, almeno fino al XIX
secolo, si è sempre creduta il punto focale.
Questa contraddizione, questa malattia del tempo è la radice di quella brama di infinito, di
quella “anima faustiana” che fonda la cultura occidentale, la cui epopea è l’incessante tensione
verso l’infinito e l’indeterminato attraverso il veicolo della forma. Si pensi alle cattedrali gotiche,
opere che assurgono a immediata rappresentazione di questo spirito; in esse, infatti, la nuda roccia
è come smaterializzata in una ornatissima sublimazione verso l’assoluta trascendenza.
L’occidente scaturisce da un’insanabile frattura, quella fra il mondo degli antichi dèi
(possiamo dire del mito), e il nuovo orizzonte dischiuso dalla religione cristiana. Le divinità di un
tempo, in cui possiamo vedere, con Herder, la pura e genuina espressione dello spirito dei popoli,
sono state cacciate dai loro luoghi sacri, i templi abbattuti, le statue mutilate, la stessa natura è stata
svuotata e desacralizzata, per far posto a che cosa?
Scrive il giovane Hegel ne “La positività della religione cristiana”: “Il cristianesimo ha
spopolato il Walhalla, ha distrutto i boschi sacri, ha estirpato i miti del popolo come scandalosa
superstizione e veleno diabolico, dandoci in cambio i miti di un popolo il cui clima, legislazione,
cultura, interessi sono a noi estranei, la cui storia non ha assolutamente alcun legame con noi.”
Il cristianesimo, vestito l’abito della metafisica greca, impose nuovi valori e dogmi a una
civiltà esausta, ma che ad essi rimaneva estreanea, si pensi all’eroica quanto disperata impresa
4
Ivi. Pag. 127
5
O. Spengler, Il Tramonto dell’Occidente, trad. it. J. Evola, Longanesi, Milano 2008, pg. 30
6
Goethe, ancora giovanissimo, scrive questo breve passo nel frammento Die Natur.
dell’imperatore Giuliano di far risorgere il paganesimo in rinnovate vesti, o alla ostinata resistenza
dell’aristocrazia romana verso la nuova religione, incarnata da figure come Simmaco e Pretestato e
immortalata nei Saturnalia di Macrobio.
Ma mentre possiamo attingere alla mitologia classica grazie a quegli imperituri monumenti
sopravvissuti, non a caso, al trascorrer dei millenni, e ai quali l’occidente non ha mai smesso di
guardare con riverenza, quella dei popoli germanici è andata irrimediabilmente perduta. Questo
perché la “civilizzazione” di questi popoli e il loro avvicinarsi alla scrittura avvenne in
concomitanza con la loro cristianizzazione. La più antica e completa testimonianza di tale mitologia
è l’Edda di Snorri Sturluson, curioso erudito islandese vissuto nel secolo XIII dell’era volgare, il
che presuppone una pesante compenetrazione di temi cristiani. Come è noto, secondo una tradizione
che affonda in Origene, il cristianesimo, piuttosto che negare le divinità pagane, preferì
demonizzarle, cosicché, una volta dimenticate, le vediamo relegate nelle profondità dell’inconscio.
Nei quadri di Hyeronimus Bosch vediamo gli arcani geni dei popoli nordici prendere la forma di
oscuri e atroci demonii della coscienza. Lo stesso si può dire di quell’universo di gnomi e curiose
creature che affollano le campagne del nord Europa e delle isole britanniche. Questo fenomeno non
è affatto privo di importanza, dato il rilievo rivestito dalla Germania, e dal Romanticismo tedesco,
all’interno della cultura europea. È proprio nell’era romantica che il significato della frattura emerge
in tutta la sua tragicità e potenza creativa, lo schlegeliano Streben nach dem Unbedingten,
massimamente incarnato nelle forme dell’idealismo “etico” di Fichte e nella musica di Beethoven,
rappresenta il culmine della civiltà occidentale, l’eroica vetta dalla quale essa riesce ad osservare il
proprio dramma perpetuandolo in un eroismo che si fa puro atto e movimento, tensione
indeterminata verso l’ineffabile. Le sinfonie di Beethoven ci regalano, nell’estasi e nella
commozione, la concreta esperienza della cosa in sé, della sublimità di uno Streben senza fine.
Come potrebbe la musica non assurgere ad arte simbolo dell’anima occidentale, non è essa il
massimo tentativo di racchiudere l’infinito nel tempo, di risolvere l’infinito nel finito, di imprimere
il sigillo dello spirito sull’angosciosa fuga degl’istanti attingendo l’eternità, trascendendo ogni
determinazione?
È l’epoca in cui l’artista avverte dentro di sé il momento culminante della scissione, dove
l’assenza degli dèi testimonia la lontananza da un autentico rapporto col mondo, ma, nel cuore della
fredda notte dell’Esperia, egli rimane sveglio nella trepidante attesa di una nuova alba, di un
recupero del divino e dell’originario. Vediamo questa Sehnsucht attraversare, come un bagliore
inquieto, tutta la generazione romantica, dai fratelli Grimm, instancabili raccoglitori di fiabe e
antiche saghe, a Novalis, che interpretò questo slancio come un ritorno alla “notte lunare incantata
del Medioevo”, e a Hölderlin, figura che forse racchiude più di ogni altra l’unicità dell’era
romantica.
Risuona nei suoi versi il tenue chiarore della veglia notturna, il rimpianto per lo svanire del
meriggio incantato del dio Pan, quando “nessuno sopportava la vita da solo” perché ormai gli dèi
sembrano essersene andati, più non si curano delle vicende umane, non sono più natura ma spirito,
non vi è più gioiosa ed estatica immediatezza ma cade la notte e il silenzio su ogni cosa. Ecco allora
che questa frattura rivela il suo carattere fondativo, gli dèi, fuggiti, lasciaron delle tracce, si
presentano all’individuo nella forma dell’assenza, della traccia, del simbolo. La tensione
inappagabile verso una sintesi dorata e irraggiungibile è il vero parto dell’occidente, nell’elegia Brot
und Wein, la sublimità della notte preannuncia la luce del nuovo giorno; il pane ed il vino, “ci fanno
pensare ai celesti, che qui / Sono già stati e che a tempo giusto ritorneranno”. Essi sono le tracce
lasciate ai mortali da Demetra e Dioniso, il veniente dio, colui che “concilia la Notte col Giorno” ,
colui che “rimane e la traccia degli dèi fuggiti / Porta giù fra la tenebra ai senza dèi”. Della luce di
quel meriggio rimane solo l’occaso, solo un tenue baluginare tra i flutti delle tenebre, dove i
contorni del dio del vino si confondono con quelli del Cristo, è solo in forme diverse che essa può
esser rivissuta. Nel “Più antico programma sistematico dell’idealismo tedesco”, del 1797, leggiamo
la prammatica necessità di possedere una nuova “mitologia della ragione” (Mythologie der
Vernuft); attraverso di essa, che dovrebbe costituire “l’estrema, la più alta opera dell’uomo”,“la
mitologia deve divenire filosofica, così da rendere il popolo razionale, e la filosofia deve divenire
mitologica, così da rendere sensibili i filosofi”.7 Non è forse un tentativo di proiettare l’avvenire
dell’occidente in una dimensione originaria che era propria dei greci, estranea alla distinzione fra
credenza popolare e religione, fra religione e ragione, un tentativo di riappropriarsi di quella sfera
del mito grazie alla quale, come indica Otto, è possibile anche il pensare razionale?
Il λόγος assunto come guida dalla civiltà occidentale ha dimenticato questa sua
connotazione originaria e il primo riaffacciarsi dell’esperienza mitica in terra d’Esperia è avvenuto
non sotto il segno del pensiero, ma sotto quello delle arti figurative.
Consideriamo per un attimo quell’assoluto miracolo che è il Rinascimento italiano, in esso
vediamo, dagli studi filologici e antiquari degli umanisti, secondo una tradizione iniziata dal
Petrarca, erompere il mito originario, intimamente congiunto al veicolo suo proprio, che è la forma.
Il mito torna ad essere vissuto in maniera immediata, non più come fantasia o mera erudizione, lo
vediamo tralucere, davanti ai nostri occhi, dai capolavori del Botticelli, o dalle tavole aldine della
Hypnerotomachia Poliphilii, il libro più bello della stampa occidentale, superba sintesi
dell’umanesimo tardo-quattrocentesco, la cui paternità, tradizionalmente assegnata al domenicano
Francesco Colonna, è tuttavia contesa fra personaggi come Pico della Mirandola, Leon Battista
Alberti e Lorenzo de’ Medici. Questo brevissimo risveglio della coscienza mitica venne inghiottito
dall’avanzare della storia, ma assieme ad esso si fonda l’Europa moderna.
Venendo infine al Novecento, non può fare a meno di stupire l’interesse generalmente
suscitato dalla problematica del mito, il proliferare di studi e interpretazioni che vi si affollano
attorno. È forse il segnale di una cultura, e di una civiltà, che, cosciente del proprio intimo e
materiale disfacimento, cerca un ritorno all’origine, se non altro per dar ragion di essa, e, con essa,
del proprio declino?
L’interpretazione che abbiamo mostrato, quella di W. F. Otto, è senz’altro una delle più
profonde e suggestive, il cui valore coincide col tentativo di liberare il mito da qualsivoglia
sovrastruttura per contemplarlo nella sua purezza originaria, nell’accezione che fu propria dei Greci.
Essa interpretazione si muove comunque in un generale clima di rivalutazione e “riattualizzazione”
del mito, che attraversa studiosi come Cassirer, Blumenberg, Kerényi e Lévy-Strauss, solo per
citarne alcuni. Qual è il valore di questo sguardo al mito? È possibile per noi, uomini della civiltà
del “progresso” e della tecnica, afferrare il significato di questo essere multiforme, che, in maniera
del tutto disincantata, ci appare come un mediatore fra il nulla e l’orizzonte di senso (Lotito), tra il
niente del tempo e il nulla dell’eterno (Vitiello)? Abbiamo solo a che fare con un mito tecnicizzato,
come indica Kerényi, con un oggetto utilizzabile tecnicamente e svincolato da ogni radice
ontologica? Se così fosse, ogni nostro tentativo di “afferrare” il mito, compreso quello di Otto,
questo filologo innamorato dei Greci tanto da sentirsi uno di loro, si ridurrebbe a un distorcere la
sua verità originaria, alla quale possiamo tendere ogniqualvolta gettiamo lo sguardo sulla ferita da
7
Friedrich Hoelderlin, Scritti di estetica, SE 2004, pg. 157-158
cui è sorta la nostra civiltà, ma che non possiamo più vivere nella sua dimensione autentica. È il
mito un tentativo di riempire un vuoto, di colmare un’angoscia mediante l’evocazione della parola?
Vediamo piuttosto che ciò che caratterizza l'esperienza mitica è il suo stare attorno al silenzio che
precede la parola, il silenzio nel quale ogni ente è dato nella sua immediatezza. "La favola de'
Greci si disse anco mythos, onde vien a' Latini mutus", scrive Vico nella Scienza Nuova. Il tentativo
di ricondurlo ad un'allegoria, come, discostandosi dalla tradizione rinascimentale, fece Bacone, non
rende certo giustizia all'intima complessità del mito, che altro non dice se non se stesso, in una
tautegorica autotelicità, come fenomeno originario e fondativo della natura umana. Scrisse Walter
Benjamin che “Le allegorie sono nel mondo del pensiero ciò che le rovine sono nel mondo delle
cose”8 e l’uomo moderno, chiuso entro un orizzonte di rovine, non può che scorgere nel mito stesso,
oltre che in se medesimo, un rudere immerso nella polvere del tempo.
8
W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 1980