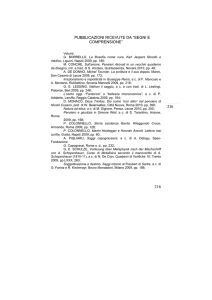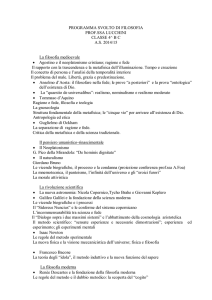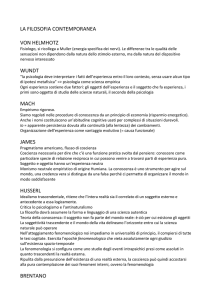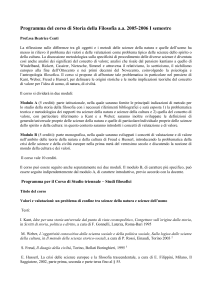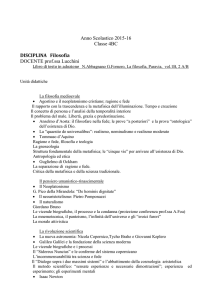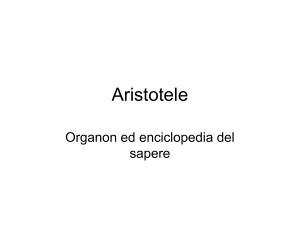RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XXI
NUOVA SERIE - N. 62 - MAGGIO-AGOSTO 2007
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università del Salento, con la collaborazione del “Centro Italiano
di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università del Salento, e dello
stesso Dipartimento.
Parte di questa pubblicazione rientra nel Progetto di Rilevante Interesse Nazionale su “Fenomenologia, narrazione, riflessione etico-politica: testi e temi
del pensiero francese del Novecento”, a cui partecipano le Università di Bari,
del Salento, Roma Tre, Sassari e Verona.
Questo volume di “Segni e comprensione” è finanziato parzialmente anche
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, con sede a Bari.
2
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce), Antonio
Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno), Antonio
Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Maria Lucia Colì, Daniela De Leo, Lucia
De Pascalis, Alessandra Lezzi, Giorgio Rizzo.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia e
Scienze sociali, Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel.
(0832) 294627/8; fax (0832) 294626. E-mail: [email protected]
sito: siba2.unile.it/ese
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Umberto I, 51
73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/205577 - 0832/200373. Iscritto al n.
389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento annuo:
Italia t 30,00, Estero t 45,00, c/c postale 16805731 intestato a Piero Manni
s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata.
Un fascicolo t 12,00, degli anni precedenti il doppio.
Stampato presso Tiemme - Manduria
nel giugno 2007 - per conto di Piero Manni s.r.l.
SOMMARIO
5
Teresia Margareta Drügemüller
Edith Stein nella vita del Carmelo
16
Frédéric Worms
L’idea di “momento 1900”. Un problema filosofico e storico
38
Augusto Ponzio
Filosofia del linguaggio come arte dell’ascolto
85
Luigi De Blasi
Il Kant di Heidegger e il problema della metafisica
102
Silvia Chiletti
Ai limiti di fenomenologia e strutturalismo.
Il concetto di struttura nella filosofia di Merleau-Ponty
119
Piero Venturelli
Montesquieu scienziato della politica e della società
124
Daniele Bertini
Posizione generale del problema del pensare
141
Irene Angelopulos
La realtà del cinema tra mito e psicoanalisi
149
Emanuele Fadda
Quanto è generale la semiotica generale?
156
Susan Petrilli
Senso, responsabilità e antropocentrismo relazionale
A proposito di un testo di Mario Signore
162
Aniello Montano
La fenomenologia e l’oltre-fenomenologia
3
165
Marcello Marino
Sartre e le emozioni. La trasformazione magica del mondo
179
Francesco Tarantino
La ripetizione e la nascita. Storia della filosofia e psicoterapia
187
Rosa Calcaterra
I rifiuti come emergenza filosofica
190
Recensione
194
Notiziario
205
Pubblicazioni ricevute
4
“Segni e comprensione” è disponibile in edizione telematica sul sito http://siba2.unile.it/ese,
alla pagina Pubblications. Ogni numero sarà scaricabile due mesi dopo la pubblicazione
cartacea della rivista.
EDITH STEIN NELLA VITA DEL CARMELO1
“Ho sempre percepito che il Signore mi riservava qualcosa che avrei potuto trovare soltanto nel Carmelo!”2 Queste le parole di Edith Stein, quando chiese di essere accolta nel Carmelo di Colonia.
Il 14.10.1933 passò “nella pace più completa l’uscio della Casa del Signore. Non potevo provare un’immensa gioia, perché ciò che avevo lasciato dietro di me era troppo doloroso.”3 La cosa tanto dolorosa era l’addio alla madre
e ai fratelli. Che le fosse costato molto, lo si notava dall’espressione seria,
stanca e triste del suo viso quando fu presentata alle abitanti del convento come postulante Edith Stein. La filosofa che nel mondo degli scienziati era nota
e stimata, entrò in convento con la più completa semplicità e umiltà.
Ben presto iniziò a prendere parte alla quotidianità del Carmelo. Edith Stein
era un’artista delle cose quotidiane. Nulla le è stato risparmiato, e nulla le è
piovuto dal cielo. Anche lei ha dovuto lottare duramente.
Quando Edith Stein giunse al Carmelo di Colonia, aveva già percorso una
lunga via. Da giovane si era allontanata completamente da Dio, tanto che si
era volutamente imposta di non pregare più. Poi però, l’incontro con cristiani
credenti riavvicinarono questa ebrea dalle molteplici doti alla fede ed a Dio e
quindi anche alla fede in Gesù Cristo, il Crocifisso4.
L’1 gennaio 1922 fu battezzata e il 2 febbraio dello stesso anno ricevette la
Cresima. Sperava di essere subito ammessa nel Carmelo, ma dovette piegarsi al fatto che, avendo causato tanto dispiacere a sua madre con il suo battesimo, ora non poteva recarle anche questo dolore. Le porte del Carmelo si
aprirono per lei soltanto dopo undici anni trascorsi svolgendo attività di insegnamento nelle scuole e di ricerche scientifiche, dando conferenze e occupando per un breve periodo fino alla primavera del 1933 un posto di docente presso l’Istituto Tedesco di Pedagogia Scientifica a Münster. “Finalmente aveva tutto ciò che fuori le mancava e non le mancava più nulla di ciò di cui, fuori disponeva.”5
Che idea ci eravamo fatta noi giovani novizie su chi fosse questa postulante Edith? Cosa sapevamo della sua carriera scientifica che dovette interrompere? Vedevamo soltanto una postulante Edith 42enne che sembrava inserirsi in maniera molto naturale nel nostro noviziato. La madre priora e la direttrice delle novizie erano dell’avviso che sarebbe stato meglio per tutti se noi novizie non sapessimo nulla. Solo a poco a poco e per caso venimmo a sapere
chi fosse veramente la postulante Edith. Già nelle prime ore di ricreazione ci
raccontò di sua madre, di suo padre deceduto, dei fratelli e delle sorelle. Noi
eravamo curiose e non avendo ricevuto alcuna notizia da parte della direttrice
SAGGI
di Teresia Margareta Drügemüller*
5
6
delle novizie, ponemmo a lei tante domande a cui rispose con tanta disponibilità.
Così avvenne che un giorno la postulante concluse i suoi racconti con la
frase seguente: “Come saprete i miei famigliari sono ebrei!” La direttrice delle
novizie non era molto contenta del fatto che la postulante svelasse così presto
la sua provenienza ebraica, e le fece l’appunto, ma questa rispose con la massima amabilità: “Se ora devo condividere con le mie consorelle piaceri e dolori, è giusto che anche le mie consorelle condividano con me piaceri e dolori e
sappiano che sono ebrea.” Questo me lo riferì la direttrice delle novizie quello
stesso giorno. Attraverso i miei conoscenti venni a sapere chi fosse la nostra
postulante Edith che nel frattempo si sforzava di assumersi gli impegni quotidiani nel Carmelo.
Intanto, la nuova postulante trovò nel Carmelo la sua nuova patria. Il suo viso serio, ancora marcato dalle tracce del difficile distacco da casa, col tempo
si rasserenò fino a cambiare completamente la sua persona e farla sembrare
20 anni più giovane. In un primo periodo, la postulante visse serenamente. Si
impegnava con noi a penetrare sempre più a fondo nello spirito dell’Ordine.
Trascorreva le giornate con la preghiera comune, la meditazione e il lavoro.
Amava moltissimo la preghiera corale. Dal suo battesimo aveva pregato ogni
giorno il breviario romano dopo le sue intense giornate di lavoro. Ora poteva
pregare e cantare nella comunità delle suore. Quanto amava i salmi, queste
preghiere millenarie del popolo di Dio a cui apparteneva anche lei.
Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Annunzia a Giacobbe la sua parola,
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo,
non ha manifestato ad altri i suoi precetti. (Salmo 147)
Possiamo partecipare anche noi alla gioia del popolo che sa di essere il popolo eletto tra i popoli della Terra. Sin da piccolo l’ebreo sa che la nuvola della
magnificenza divina lo accompagna. Ovunque egli si trovi in questo mondo, la
magnificenza divina sta sopra di lui. Egli porta sempre in cuor suo le parole delle Sacre Scritture: “Questo popolo è figlio di Dio!”6 Anche Sr. Benedicta, in
quanto figlia di Israele, era cosciente di essere eletta, anche se con la massima umiltà. Era meraviglioso vederla così tutta dedita a Dio e anche figlia del
Popolo Eletto di Dio. Era un’ebrea, ma sottolineava sempre anche “ebrea tedesca”7, così come anche sua madre e i suoi parenti si definivano sempre
“ebrei tedeschi”. Questa coscienza e certezza conferiva a Sr. Teresia Benedicta una grande forza interiore che traspariva.
Non solo durante la preghiera corale, ma anche durante la meditazione vedevamo una persona totalmente abbandonata in Dio. Dal canto suo era molto
restia a parlare della sua preghiera: “Quando mi immaginate al mio posto, non
vedetemi con il saio bianco…, ma nel vecchio abito marrone, piccola, per ter-
SAGGI
ra. Allo stesso modo anche le mie riflessioni non sono alti voli della mente, bensì quasi sempre umili e semplici. Sono però sempre permeati dalla gratitudine
per aver ricevuto questo posto come patria terrena e tappa verso la patria eterna.”8 Se sottolinea che le sue riflessioni erano quasi sempre umili e semplici,
significa che c’erano anche delle eccezioni. Ma ne riparleremo più avanti.
La vita quotidiana della postulante Edith prevedeva, oltre alle ore dedicate
alla preghiera, anche molto lavoro. Molte ore di lavoro nel Carmelo di Colonia
erano dedicate alla ricerca scientifica, in particolare alla rielaborazione di uno
scritto che sarebbe diventato l’opera “Essere finito ed essere eterno”9. Tuttavia
c’erano da svolgere anche i lavori di casa, come riordinare e pulire. Ogni suora è responsabile di un determinato ambito della casa. Anche alla nuova postulante fu conferito un ambito. Dovevate vedere con quale dedizione faceva
le pulizie, con quanto slancio e in che modo maldestro! Ma con il tempo la postulante Edith imparò come usare la scopa al meglio, come passare lo straccio e tanti altri lavori di questo genere.
Considerava il fatto di essere maldestra nei lavori di casa come “una scuola dell’umiltà, dove si devono fare cose che si riesce ad eseguire soltanto con
grande fatica e in maniera imperfetta.”10 Con le parole della moglie di suo cugino Richard avrebbe potuto dire: “Tutte queste cose sono tanto più difficili,
quanto più sono distanti dalla (Filosofia).”11
Svolgendo queste mansioni non perdeva mai il buon umore. Era buffissima
quando durante la ricreazione descriveva le sue avventure con scopa e strofinaccio. D’altra parte le dispiaceva non essere stata istruita, da giovane, almeno in alcune faccende di casa.
La vestizione della postulante fu una grande festa, proprio come, un anno
più tardi, la professione dei voti. La postulante era diventata una novizia, la novizia una suora professa. Come scrisse ad una amica religiosa, aveva “portato con sé” il nome di “Teresia Benedicta della Croce”, “poiché è sotto la croce
che compresi il destino del popolo di Dio che allora cominciava già a delinearsi. Pensai che coloro che comprendevano che si trattava della Croce di Cristo,
dovevano caricarsela sulle spalle nel nome di tutti. Oggi so molto meglio di
quanto non sapessi prima del mio ingresso in convento cosa significa essere
sposa di Dio nel segno della Croce.”12 La Croce di Cristo faceva parte imprescindibile della vita quotidiana della nostra consorella Teresia Benedicta. Pativa molto quando veniva a sapere del destino toccato ai suoi parenti, amici e
conoscenti. In quegli anni del Nazismo cresceva sempre più il disprezzo nei
confronti degli ebrei.
Sr. Teresia Benedicta lavorava con grande lena alla sua opera scientifica
“Essere finito ed essere eterno”, con la speranza di farla stampare al più presto. In un primo momento tutto sembrava filare liscio. Poi però subentrarono
grandi difficoltà. “Non so ancora cosa succederà riguardo alla pubblicazione di
quest’opera. Se si realizzasse, sarebbe il mio regalo d’addio alla Germania”13,
scrisse poche settimane prima della sua fuga.
Giunse la notte del 9 novembre 1938, la cosiddetta “Notte dei cristalli”, in
cui le orde con le camicie marroni importunarono, minacciarono e intimidirono
gli ebrei su tutto il territorio del Reich tedesco. Furono distrutte anche preziose
7
8
opere d’arte, furono incendiate le sinagoghe. I nazisti giravano sbraitando per
le strade e schernivano gli ebrei urlando brutte canzoni.
Sr. Teresia Benedicta ammutolì quando venne a sapere tutto questo. Per
non mettere in pericolo il nostro convento, chiese subito di essere trasferita nel
nostro convento associato di Echt nei Paesi Bassi. Poco dopo Natale, le formalità erano sbrigate. Questa festa di Natale nel Carmelo di Colonia fu adombrata da tutti gli avvenimenti recenti. In una lettera natalizia, Sr. Teresia Benedicta scrisse: “Più intenso si fa il buio attorno a noi, e più dobbiamo predisporre il nostro cuore a ricevere la Luce dall’alto.”14
Il 31 dicembre 1938 fu il giorno del difficile addio dal Carmelo di Colonia.
Tutte le suore si erano riunite nella sala di ricreazione. Lei pronunciò ancora
qualche parola di ringraziamento e poi abbracciò ogni suora, una dopo l’altra.
Quando fu il mio turno, fui capace soltanto di pronunciare il suo nome. Diede
un singhiozzo di pianto, ma si riprese subito e passò alla prossima suora per
abbracciarla e dirle addio.
“Non esiste consolazione umana, ma colui che impone la sua croce, sa come rendere dolce e leggero il fardello… Con la macchina che mi condusse qua
potei ancora andare nella Schnurgasse e ricevere la benedizione della Regina
della Pace. Non ho bisogno di descrivere quanto l’addio alla cara famiglia conventuale fosse difficile!”15 Queste le parole scritte ad una amica religiosa. Ad
un’altra amica invece confidò in una lettera: “Ho iniziato [l’anno] davanti al Santissimo assieme alla mia nuova famiglia conventuale. Lei può ben immaginare
quanto fosse doloroso l’addio a Colonia. Ma sono di nuovo nel Carmerlo e circondata da caloroso amore materno e fraterno. Questa casa fu fondata dalle
Carmelitane di Colonia che nel 1875 furono cacciate.”16
Come nel Carmelo di Colonia, anche a Echt Sr. Teresia Benedicta si dedicò ai suoi lavori di ricerca nella speranza di portare a termine finalmente la
stampa della sua opera “Essere finito ed essere eterno”. Si preoccupava dei
suoi fratelli e delle sue sorelle rimasti a Breslau. Alcuni fecero in tempo ad emigrare, altri non volevano andare via dalla loro patria tedesca. Essa pregava per
tutti i bisogni e tutte le pene di cui veniva a sapere e nelle sue lettere pregava
i suoi interlocutori di ricordare nelle loro preghiere lei e le sue preoccupazioni.
I giorni trascorsi nel Carmelo di Echt si facevano ogni giorno più cupi, anche
se l’immenso amore fraterno e la grande comprensione alleviavano un poco le
pene.
È su una via molto stretta che Sr. Teresia Benedicta saliva verso la cima del
Carmelo. La Guerra Mondiale si allargava sempre più. Anche i Paesi Bassi
erano minacciati. Il 29.10.1939 essa scrisse in una lettera: “…La grande opera [Essere finito ed essere eterno] si è arenata.” Era svanita ogni speranza di
poter ancora pubblicare l’opera. L’editore (Borgmeyer, Breslau)17 aveva perso
ogni possibilità. Essa ne parla in questi termini: “Ogni tentativo è fallito. Non so
più cos’altro fare se non mettere tutto nelle mani del Signore. Visto che il lavoro di correzione si è ormai interrotto, ho chiesto di poter lavorare in casa… Mi
è stato affidato il refettorio. Si aggiungono anche lavori in comune nella grande casa di campagna, molti panni da lavare, tante pulizie e così via.”18 A tempo perso produsse ancora qualche testo più breve, ma accanto ai lavori in ca-
SAGGI
sa non le rimaneva più molto tempo. Così descrisse in una lettera i suoi sentimenti: “Da quando sono qui, il sentimento fondamentale è quello di grande gratitudine perché posso stare qui e perché la casa è così com’è. Sono però continuamente cosciente del fatto che qui non sarà la nostra patria per sempre.
Non voglio altro se non che attraverso di me avvenga la volontà di Dio. A Lui
spetta decidere quanto mi vuole lasciare qui e cosa verrà dopo.”19
Forse presagiva già cosa le sarebbe successo? “È necessario pregare molto per rimanere fedele in ogni situazione”20, scrisse in un’altra lettera. Anche i
Santi sono uomini che soffrono amaramente del male inflitto loro, ma cercano
di sopportarlo seguendo il Signore crocifisso. “Non si può desiderare di essere liberati dalla croce se si porta il titolo della Croce” osservò in una lettera del
17.11.1940 indirizzata ad una carmelitana.21 Giorno per giorno Sr. Teresia Benedicta ha sentito il peso della sua croce e ha ridetto il suo “sì”.
A partire dal maggio del 1940 anche i Paesi Bassi furono coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale. Il futuro si profilava sempre più buio.
Nell’autunno di quell’anno ricevette l’incarico da parte dei suoi superiori di
scrivere un lavoro su San Giovanni della Croce in occasione dell’imminente
400° compleanno del Santo (1542-1942). Sr. Teresia Benedicta raccolse il materiale e si mise subito al lavoro.
Per la nuova opera che stava redigendo scelse il titolo di “La scienza della
Croce“. Sicuramente questo incarico ridiede un po’ di slancio a Sr. Teresia Benedicta. Sin da giovane era abituata a lavorare di mente. Che le fosse mancato si evince anche dalla lettera succitata in cui scrive: “Sono grata di poter ancora fare qualcosa prima che il cervello mi si arrugginisca completamente.”22
Come lavoro propedeutico scrisse il breve articolo “Le vie verso la conoscenza di Dio – La teologia simbolica dell’Aeropagita e i suoi presupposti oggettivi.”
Ricominciò a dedicare ogni minuto libero alla scrittura.
Nel frattempo – il 12.10.1941 – si festeggiò nel convento il suo 50° compleanno. Fu rallegrata da una piccola rappresentazione teatrale che descrisse in
una lettera: “Ho visto non soltanto Abramo, ma anche Enoch e Noè, Isacco e
Giacobbe, Mosé ed Aronne, Davide, Elia ed Eliseo. Abramo era una figura rispettabile. In Mosé spiccava soltanto il naso e per il resto era piccolo e gracilino; sul retro delle sue tavole della legge c’era la lista della spesa della settimana scorsa. Questa notevole rappresentazione è stata possibile perché al
momento abbiamo un noviziato eccezionalmente numeroso in confronto alla
norma nel Carmelo.”23
Qualche settimana più tardi raccontò che sua sorella Frieda era stata evacuata dalla casa materna dai Nazisti e portata in una “comunità abitativa di
ebrei” con l’obbligo di prestare servizio. Lì viveva con undici signore nobili di
Breslau in un vano sotto il tetto. Il fratello maggiore era in attesa di subire una
sorte simile. Sua sorella Rosa invece era riuscita a rifugiarsi in tempo nel Carmelo di Echt. Il peso di queste notizie gravavano come un macigno su Sr. Teresia Benedicta, poiché amava moltissimo i suoi fratelli e le sue sorelle.
Dovette sperimentare ancora altre delusioni dolorose. Ma accolse ogni
amarezza per seguire sempre la Croce di Cristo. Verso la fine dell’anno 1941
(non è nota la data precisa) scrisse: “Si può ricavare una Scientia Crucis
9
10
[scienza della Croce] soltanto se si prova sulla propria pelle tutta la pesantezza della croce. Di questo ero convinta sin dal primo momento e ho quindi pronunciato ‘Ave Crux, spes unica’ [‘Ave, Croce, nostra unica speranza!’]”.24
Da anni sentiva gravare su di sé la croce con tutto il suo duro peso. Si sentiva profondamente addolorata dall’ideologia del nazionalsocialismo, dall’amarissimo destino del suo popolo ebreo con tutti gli aspetti collaterali, dalla dura
guerra che portava il popolo all’estrema povertà. Aveva presentito già da diversi anni che si stava avvicinando una catastrofe ed aveva offerto a Dio la sua
vita per impedire il disastro. Si aspettava aiuto soltanto da Dio, perché aveva
capito che l’aiuto umano in questa immensa miseria non bastava. “Ho fiducia
che Dio ha accettato la mia vita. Mi viene spesso di pensare alla regina Ester
che è stata allontanata dal suo popolo proprio per poterlo rappresentare davanti al re. Sono soltanto la sua poverissima, impotente, piccola Ester. Ma il Re
che mi ha prescelta è immensamente grande e potente. Questa è la mia consolazione!”25 Queste le sue parole rivolte ad un’amica religiosa.
Era consapevole della sua situazione precaria e di quella di sua sorella Rosa. Una notizia funesta dopo l’altra giungeva anche nella solitudine del Carmelo di Echt. Sr. Teresia Benedicta chiese di poter emigrare in Svizzera. Le trattative si trascinavano. In fondo, però, essa sperava, “che la situazione non si
modificasse prima della fine della guerra“26.
Cercarono di intervenire delle persone per aiutare. La mettevano in guardia, la supplicavano di poterla nascondere. Ma Sr. Teresia Benedicta rifiutava.
Nel frattempo lavorava senza sosta alla “Scienza della Croce”, forse perché inconsciamente sentiva che le sarebbe rimasto pochissimo tempo27.
Non c’è dubbio che le ore di preghiera e il lavoro dedicato alla “Scienza della Croce” alleviarono le pene di Edith Stein in quel periodo. Scrivendo con rigore scientifico della vita e della dottrina di San Giovanni della Croce, essa
svelava, senza volerlo, la sua propria vita mistica nella grazia. Sapeva di aver
ricevuto una grazia straordinaria. Sapeva che nella sua vita Dio l’aveva condotta e guidata. Sapeva che Dio l’aveva raccolta e l’aveva chiamata vicino a
sé dopo che ella si era allontanata da Lui. Sapeva che Dio le aveva regalato
tanta conoscenza piena della Sua luce.
Nella “Scienza della Croce” descrisse sicuramente la via del santo padre
del suo ordine, San Giovanni della Croce, ma non si può non notare come contemporaneamente riferì anche delle sue esperienze. Sapeva per esperienza
personale di cosa scriveva nel passo seguente: “Se un non credente venisse
sorpreso dalla grazia, la dottrina della fede che egli fin’ora non ha ancora accettato, dovrebbe venirgli necessariamente in aiuto per portarlo a raggiungere
la conoscenza del fenomeno del quale viene ora afferrato… Non è una condizione necessaria che la grazia sia insita nell’anima di una persona per poter
essere toccata nell’intimo. Questo contatto può condurre un non credente incallito ad avvicinarsi alla fede e può essere donato come preparazione all’accoglienza della grazia che santifica. Può anche fungere da mezzo per rendere
utile un non credente a determinati fini… Se il contatto avviene in un’anima che
non è in grado di accogliere la grazia, con esso dovrebbe essere donata anche la grazia che santifica e presupporrebbe necessariamente un pentimento
SAGGI
completo.”28 In questo passo Sr. Teresia Benedicta rivela senza dubbio la sua
esperienza riguardante il grande dono della grazia di Dio.
Partendo da queste parole non è difficile trovare il collegamento con la confessione che proprio la lettura della “Vita” della nostra santa Madre Teresa del
Bambin Gesù pose fine alla sua lunga ed ostinata ricerca della verità.29 Infatti
negli anni passati aveva ricercato incessantemente la verità. Nelle esperienza
mistiche di Santa Teresa essa vide le sue proprie esperienze interiori e le riconobbe come “verità”. Ora sapeva con certezza da “Chi” il suo intimo era stato
toccato. Dio stesso le rivelò il Suo segreto. Riconobbe Dio come non lo aveva
mai conosciuto in passato, e riconobbe le proprie profondità che in passato le
erano rimaste celate. Avendo ricevuto la grazia di Dio, fece l’esperienza dentro di sé del “fuoco di Sion”, e il suo amore per Cristo assomigliò al “braciere di
Gerusalemme”, come possiamo leggere nella sua opera “Scienza della Croce”. Era certa di questo: Tutto è grazia. Così proseguì nella sua preghiera: “Tu
mi dai una conoscenza divina che riempie tutta l’abilità e la capacità del mio intelletto! Tu mi infondi l’amore sino al limite di capienza della mia volontà, sommergendo la sostanza dell’anima mia con il torrente del piacere provocato dal
tuo contatto e dal tuo congiungimento sostanziale.”30
Mentre il suo spirito si innalzava fino alla più alta unione mistica, Sr. Teresa
Benedicta sperimentò l’estrema minaccia alla sua esistenza e soprattutto alla
vita di sua sorella Rosa che aveva molta paura e che si aspettava tutto l’aiuto
da lei. Le trattative per emigrare in Svizzera avevano preso una piega che lasciava sperare ben poco. Nell’ultima lettera che scrisse ancora dal Carmelo –
o che comunque è conservata – leggiamo: “C’è molto dubbio sul fatto se riceveremo il permesso di emigrare. Sembra in ogni caso che ci sarà molto da attendere. Non sarei però triste, se non arrivasse per niente. Perché non è facile lasciare per la seconda volta una cara famiglia conventuale. Ma accetto tutto quello che Dio mi manda!”31 Quando Sr. Teresia Benedicta scrisse queste righe il 29.7.1942, i nazisti avevano già stabilito la sua sorte e quella di tutti gli
ebrei cattolici.
La domenica del 26.7.1942 in tutte le chiese cattoliche si lesse una lettera
pastorale dei vescovi olandesi: si trattava di una protesta contro la persecuzione degli ebrei. Per vendetta la domenica successiva – il 2.8.1942 – i nazisti arrestarono tutti gli ebrei cattolici, anche Sr. Benedetta e sua sorella Rosa Stein.
Più di 900 ebrei furono internati nel campo di concentramento di Drente-Westerbork.
Iniziò così un periodo molto doloroso. Dal campo giunsero ancora tre brevi
lettere indirizzate al Carmelo di Echt. Nella lettera del 5.8.1942 si legge: “Abbiamo fiducia nella vostra preghiera. Qui ci sono così tante persone bisognose del conforto, ed esse sperano di riceverlo dalle suore.”32 Nelle sue ultime righe scritte il 6.8.1942 dal campo pregò di mandarle il breviario aggiungendo:
“Fin’ora sono riuscita a pregare benissimo.”33
Tutto ciò che era umanamente possibile fare in una tale situazione, Sr. Teresia Benedicta tentò di farlo per dare conforto e forza alle persone impaurite.
Si occupò dei bambini le cui madri, stravolte dal dolore, non avevano la forza
di prendersi cura di loro.
11
12
La mattina del venerdì – il 7.8.1942 – prestissimo gli ebrei cattolici internati furono trasportati verso Est. Quindi venerdì e sabato furono gli ultimi giorni
della vita di Sr. Teresia Benedicta e di così tante altre persone arrestate con lei.
La domenica – il 9.8.1942 – il trasporto giunse alla meta: il campo di lavoro di
Auschwitz. Lì furono separati i giovani capaci di lavorare dagli altri che furono
subito caricati sui camion e portati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. La stessa domenica – il 9.8.1942 – furono uccisi tutti, probabilmente con
gas velenoso.
Si racconta che molti ebrei andarono ad incontrare la morte cantando i Salmi, tanto che le loro voci si udivano per tutto l’ampio piazzale del campo.
Anche Sr. Teresia Benedicta non può che aver confermato anche in questa
ora difficile la sua completa dedizione a Dio e l’offerta della sua vita per le pene dell’epoca. Era divenuta tutt’uno con il suo Signore in Croce. Così come Dio
l’aveva innalzata fino alle cime della vita mistica, così l’aveva anche accolta
nell’ultima ed estrema imitazione di Suo Figlio in Croce. Egli l’ha portata a compimento e l’ha donata alla Sua Chiesa come colei che è benedetta dalla Croce.
Edith Stein, figlia del popolo di Israele ed ebrea tedesca, era nata il giorno
della Riconciliazione del Popolo di Dio. “Mia madre dava molta importanza a
questo fatto, e credo che questo, più di ogni altra cosa, abbia contribuito a renderle tanto cara questa sua figlia più giovane.”34
Questa grande donna potrebbe essere presa ad esempio come anello di
conciliazione tra Ebrei e Cristiani affinché entrambi riconoscano che sono figli
e figlie dello stesso Padre in Cielo grazie al cui amore e alla cui benedizione
essi vivono. – Edith Stein è la prima donna santificata che svolgeva un’attività
lavorativa in senso moderno. Papa Giovanni Paolo II la vede in particolare come una cristiana che ha saputo armonizzare la fede viva con il sapere in vari
ambiti. Che interceda per noi presso il Dio meravigliosamente espresso nei
Suoi Santi.
(Traduzione e cura di Fr. Francesco M. Alfieri, O. F. M., Università Lateranense)
* Sr. Teresa Margareta vom Herzen Jesu (Drügemüller) O.C.D., nata il 20.VIII.1910 a Vorhelm
vicino a Ahlen, in Westfalia, l’ultima delle religiose del Carmelo di Colonia, è stata con-novizia di
Edith Stein e ha convissuto tutto il tempo che Edith ha trascorso in questo monastero (14.X.1933
- 31.XII.1938). Da piccola è vissuta in fattoria ed è la più grande di quattordici figli: quattro maschi
e dieci femmine. Dopo gli studi frequentò un corso di economia domestica presso un Istituto di
suore, ma ben presto entrò nel Carmelo di Colonia. Da giovane era spesso ammalata e la Stein
ne parlerà spesso nelle sue lettere(Cfr. Lettera 322, 332, 334, 338, 446, 597, 684, 751, in E. STEIN.,
Selbstbildnis in Briefen: Zweiter Teil: 1933-1942, Bd. 3, Herder, Freiburg-Basel-Wien 2000). Per tre
anni è stata Priora del Carmelo di Colonia e attualmente ha novantasei anni. È stata lei che ha iniziato, già negli anni cinquanta, a raccogliere i documenti, lettere e fotografie, mettendo così le basi dell’attuale archivio di Edith Stein di Colonia. [N.d.T.].
1 Il manoscritto originale – Edith Stein im Alltag des Karmel – non esiste più, come mi informa
in una lettera, del 2.XII.2006, Sr. Amata Neyer O.C.D., responsabile dell’Archivio Stein di Colonia.
SAGGI
Il testo in questione è stato stampato, dalle Carmelitane di Colonia, ad uso interno, nel 1989 e ristampato successivamente nel 1998. Nel mio lavoro ho utilizzato quest’ultima ristampa. Il testo
consta di 9 pagine. Ringrazio Sr. A. Neyer per avermi inviato preziose informazioni a riguardo. Traduzione italiana e apparato critico a cura di Fr. Francesco M. Alfieri O.F.M. In questo piccolo scritto l’autrice racconta, in modo sobrio e profondo, l’esperienza che ha avuto stando accanto ad Edith
nel Carmelo di Colonia. La testimonianza oculare dell’autrice permetterà al lettore di avvicinarsi alla soglia del mistero di questa grande donna per ammirarne la sua scelta di vita unitamente ad una
profonda onestà intellettuale. [N.d.T.].
2 Come giunsi al Carmelo di Colonia, pubblicato in: Edith Stein di Sr. Teresia Renate dello Spirito Santo [T. R. POSSELT, Edith Stein. Das Lebensbild einer Karmelitin und Philosophin, Glock und
Lutz, Nürnberg 1948; tr. it. Edith Stein, a cura delle Carmelitane Scalze di Arezzo, Morcelliana,
Brescia, 1952, p. 174; (Sr. Teresa Benedetta consegnò la presente relazione, come dono di Natale, alla sua M. Priora del Carmelo di Colonia, nella notte santa del 1938). Sr. T.R. der Spiritu Sancto (Posselt), è nata il 28.4.1981 a Neu, ed è stata dal 1936 per otto volte priora del Carmelo di
Colonia. Morirà il (26).I.1961. Ella, già nei primi anni del dopoguerra, compilò una biografia su
Edith Stein/Schwester Teresia Benedica a Cruce.Questo scritto ha conosciuto nel tempo molte edizioni ed è stato tradotto in diverse lingue. N.d.T.].
3 Ivi, p. 184.
4 Edith aveva conosciuto, nel suo soggiorno a Gottinga, Adolf Reinach, assistente di E. Husserl,
e la sua consorte. I Reinach si erano convertiti alla fede evangelica. A. Reinach muore in Fiandra
nel novembre del 1917. Edith andò a trovare la giovane vedova, in quanto era stata invitata a Gottinga per ordinare le opere postume del marito, ma aveva una certa ritrosia pensando di trovare una
donna distrutta dal dolore. Quando si rese conto della serenità con la quale aveva accettato la
scomparsa del marito, fece lei stessa esperienza di quello che può operare la fede. È suggestivo
rievocare quell’incontro con le stesse parole di Edith: “Fu il mio primo incontro con la Croce, la mia
prima esperienza della forza divina che dalla Croce emana e si e si comunica a quelli che l’abbracciano […]. Fu quello il momento in cui la mia incredulità crollò, impallidì l’ebraismo e Cristo si levò
raggiante davanti al mio sguardo: Cristo nel mistero della sua Croce”; ivi, pp. 103-104 [N.d.T.].
5 Autoritratto nelle lettere, Lettera 194 [E. STEIN., Selbstbildnis in Briefen: Zweiter Teil: 19331942, cit., Lettera 370 (Köln-Lindenthal, 11.II.1935), p. 108; tr. it. Lettere per un autoritratto, vol. I,
di T. Galiani, Città Nuova, Roma, in corso di stampa. La lettera è indirizzata a Konrad Schwind, nipote del deceduto Vicario Generale Josef Schwind di Speyer. Era nato il 14.X.1898 a Schifferstadt
ed è deceduto il 21.IX.1976. Nel periodo in cui è stata scritta la lettera era parroco a FrankenthalMörsch/Palatinato. (Nell’edizione tedesca che ho utilizzato viene cambiata la numerazione delle
lettere, in quanto sono state aggiunte alcune lettere nuove e tolte le lettere a Roman Ingarden, che
sono state pubblicate a parte. Di volta in volta segnalerò le nuove numerazioni corrispondenti a
quelle utilizzate dall’autrice). N.d.T.].
6 Libro della Sapienza 18, 13 b.
7 Le sue radici ebraiche fanno sì che Edith condivida, fino all’ultimo istante della sua vita, non
solo le sorti del suo popolo ma anche quelle dell’intera Germania. Ella si è vista rifiutata e perseguitata per questa sua doppia appartenenza; (Cf. A. ALES BELLO – PH. CHENAUX, Edith Stein e il Nazismo, Città Nuova, Roma 2005). Anche la mentalità dominante del suo ambiente familiare verrà
espressa – a distanza di tempo – da una nipote di Edith, Susanne Batzdorff-Biberstein (nata il
25.IX.1921, vive attualmente con la sua famiglia in USA): “Diventando cattolica nostra zia aveva
abbandonato il suo popolo; il suo ingresso in convento manifesta di fronte al mondo esterno una
volontà di separarsi dal popolo ebreo”; in E. STEIN, Vita e pensiero, a cura di Waltraud Herbstrith,
Città Nuova, Roma 1987, p. 71 [N.d.T].
8 Lettera 182 [E. STEIN., Selbstbildnis in Briefen: Zweiter Teil: 1933-1942, cit., Lettera 342
(Köln-Lindenthal, 17.X.1934), pp. 78-79. La lettera è indirizzata a Petra (Agnes) Brüning, badessa
del Convento delle Orsoline a Dorten, nata il 15.VIII.1879 a Osterwick/Coesfeld e deceduta il
15.II.1955 a Dorten. Ella aveva invitato Edith a trascorre con lei il Natale a Dorten e, da allora inizio tra le due un intenso scambio epistolare durato per molti anni. Petra andò a farle visita non soltanto a Colonia, ma anche nel Carmelo di Echt.]
9 E. STEIN, Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins, Werke,
II, Herder, Louvain-Freiburg i. Br. 1950; tr. it. Essere finito e Essere eterno, di L. Vigone, revisione
e presentazione di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 1999. L’opera è stata iniziata nella primave-
13
14
ra del 1935, poco dopo la fine dell’anno di noviziato – emise i voti il 21.IV.1935 – e la Stein aggiungerà alla firma della Prefazione: Köln-Lindenthal, 1.9.1936 [N.d.T].
10 Lettera 254 [E. STEIN, Selbstbildnis in Briefen: Zweiter Teil: 1933-1942, cit., Lettera 535
(Köln-Lindenthal, 12.XII.1937), p. 292. La lettera è indirizzata a Petra Brüning.].
11 Dalla vita di una famiglia ebrea, p. (321). [E. STEIN., Aus dem Leben einer jüdischen Familie. Das leben Edith Stein: Kindheit und Jugend, Werke VII, hrsg.von Dr. Gelber und P. Fr. Romaeus Leuven OCD, Druten und Freiburg-Basel-Wien 1985, p. 231. tr. it. di B. VENTURI, Storia di una
famiglia ebrea. Lineamenti autobiografici: l’infanzia e gli anni giovanili, Città Nuova, Roma 1999?,
p. 239. (A fine lavoro sono venuto a conoscenza che sta per essere inaugurata la nuova edizione
italiana di tutti gli scritti di Edith Stein con l’uscita del suo prime volume: Dalla vita di una famiglia
ebrea e altri scritti autobiografici, tr. it. a cura di B. Venturi, F. Iodice e M. D’Ambra che ha curato
anche le revisioni e le integrazioni sulla base del testo della Edith Stein Gesamtausgabe(ESGA),
Città Nuova – OCD, 2007). Il riferimento testuale dell’autrice (“All diese Dinge sind um so Komplizierter, je weiter sie fon der (Philosophie) entfernt sind”) non corrisponde esattamente a quello dell’edizione del 1985 né alla nuova edizione Edith Stein Gesamtausgabe (Bd.I, 2002, p. 212). Ripropongo per intero la citazione: “Die Dinge sind um so Komplizierter, je weiter sie sich von der (Mathematik) entfernen”. N.d.T].
12 Lettera 287 [E. STEIN., Selbstbildnis in Briefen: Zweiter Teil: 1933-1942, cit., Lettera 580
(Köln-Lindenthal, 9.XII.1938), p. 338. La lettera è indirizzata a Petra Brüning.].
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Lettera 290 [Ivi, Lettera 586 (Echt, 3.I.1939), p. 343. La lettera è indirizzata a Petra Brüning.].
16 Lettera 292 [Ivi, Lettera 595 (Echt, 22.I.1939), p. 353. La lettera è indirizzata a Uta von Bodman – nata il 16.XI.1896 a Lahr/Baden è deceduta il 14.VIII.1988 a Oberkirch – collega di lavoro
di Edith nella scuola di S. Magdalena come insegnante di Arte.].
17 Cfr. E. STEIN, Essere finito e Essere eterno, cit., p. 539: “L’opera sarebbe dovuta uscire a
Breslavia presso Borgmeyer, il medesimo editore che aveva pubblicato la traduzione del De Veritate di san Tommaso curato da E. Stein. La composizione del testo iniziò nell’autunno del 1936,
ma – dopo numerose interruzioni durate interi mesi – dovette essere definitivamente sospesa nel
1939. Le misure coercitive nazionalsocialiste non permettevano che fosse stampata nessun’opera di autore non ariano A quell’epoca era impaginata la prima parte dell’opera, erano composte le
prime bozze della seconda parte, comprese le due appendici e le note” [N.d.T].
18 Lettera 306 [E. STEIN, Selbstbildnis in Briefen: Zweiter Teil: 1933-1942, cit., Lettera 645, pp.
416-417. La lettera è indirizzata ad Agnella(Maria) Stadtmüller – nata il 9.VI.1898 a Landstuhl e
deceduta il 9.II.1965 a Speyer – suora domenica dell’Istituto di S. Magdalena in Speyer. Ella, per
prepararsi allo studio universitario, aveva preso lezioni private da Edith.].
19 Ibidem [L’autrice riporta questa citazione come proseguo della Lettera 306. Tale passo appartiene invece alla Lettera 300: Ivi, Lettera 614 (Karmel Echt, 16.IV.1939), pp. 382-383. La Lettera è indirizzata a Petra Brüning.].
20 Lettera 300 [Ibidem].
21 Lettera 316 [Ivi, Lettera 678, p. 465. La lettera è indirizzata a Johanna(Ida) van Weersth –
nata il 20.III.1901 a Hauset è deceduta il 22.V.1971 a Echt – allora badessa del Carmelo di Beeker. Finita la guerra, nel maggio del 1946, tornò nel Carmelo di Echt ed ebbe il grande merito di
raccogliere e mettere al sicuro tutti i documenti lasciati da Edith.].
22 Ibidem.
23 Lettera 324 [Ivi, Lettera 707(Echt, 13.X.1941), p. 509. La lettera è indirizzata a Johanna van
Weersth.]
24 Lettera 330 [Ivi, Lettera 710, p. 511. La lettera è indirizzata ad Antonia Ambrosia(Theresia)
Engelmann, suora carmelitana, nata il 31.III.1875 a Eltville sul Reno e deceduta il 30.IV.1972 ad
Echt. Questo lettera è stata scritta sul retro di una letterina di un carmelitano di Waspik e porta la
data del 29.IX.1941. Non è possibile determinare il nome di questo carmelitano in quanto la parte
inferiore del foglietto è strappata.].
25 Lettera 281 [Ivi, Lettera 573 (Köln-Lindenthal, 31.X.38), p. 333. La lettera è indirizzata a Petra Brüning.].
26 Lettera 335 [Ivi, Lettera 731 (Echt, 8.IV.1942), p. 540. La lettera è indirizzata a Agnella Stadtmüller.].
SAGGI
27 Stava lavorando a quest’opera quando venne tratta in arresto il 2.VIII.1942. La terza parte
del manoscritto, intitolata Sulla via della Croce, non poté essere portata a termine. Di essa rimane solo un frammento [N.d.T.].
28 Scienza della Croce, p. 163 [E. STEIN, Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes a Cruce, Werke I, hrsg.von Dr. Gelber und P. Fr. Romaeus Leuven OCD, Druten und Freiburg-BaselWien 1983, p. 163; tr. it. di P. Edoardo di Santa Teresa, Scienza Crucis. Studio su S. Giovanni della Croce, Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 1982, p. 205. N.d.T.].
29 Come giunsi al Carmelo di Colonia [Stein Edith, Wie ich in den Kölner Karmel Kam, mit Erläuterungen und Ergänzungen von Schw. Maria Amata Neyer, Echter-Vellag-Würzburg 1994, p.
20; tr. it. Come giunsi al Carmelo di Colonia, di Fabrizio Iodice, Edizioni OCD, Milano 1998, p. 20].
30 Scienza della Croce, p. 170 [Stein E., Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes a Cruce,
cit., p. 170; tr. it. Come giunsi al Carmelo di Colonia, cit., p. 212].
31 Lettera 339 [E. STEIN, Selbstbildnis in Briefen: Zweiter Teil: 1933-1942,cit., Lettera 760, p.
577. La lettera è indirizzata a Auguste Pérignon, cugina di Agnella Stadtmüller, nata il 2.II.1886 a
Landstuhl e deceduta il 24.II.1971 a Speyer. Era insegnante nel Palatinato.].
32 Lettera 341 [Ivi, Lettera 767(Drenke-Westerbork, Baracca 36), pp. 583-584. La lettera è indirizzata ad Antonia Engelmann (Cfr. nota 25). Riporto per intero la traduzione di questa lettera:
“Oggi una crocerossina di Amsterdam vuole parlare con il console. Qui da ieri, tutto è vietato agli
ebrei cattolici. Forse qualcuno da fuori può ancora tentare qualcosa, ma con pochissime speranze. C’è in progetto di far partire un trasporto venerdì prossimo. Potreste scrivere a Mère Clare a
Venlo, Kaldenkerkenweg 185, e richiedere il nostro Ms., nel caso non l’abbia spedito. Abbiamo fiducia nella vostra preghiera. Qui ci sono così tante persone bisognose del conforto, ed esse sperano di riceverlo dalle suore. In Corde Jesu, vostra sempre grata B.” ].
33 Lettera 342 [Ivi, Lettera 768, p. 584. Questa lettera, indirizzata a A. Engelmann, porta la data del 6.IV.1942, ma è evidentemente un errore di Sr. Teresia Benedicta. La vera data è il
6.VIII.1942].
34 Dalla vita di una famiglia ebrea, p. 47 [E. Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie. Das
leben Edith Stein: Kindheit und Jugend, cit., p. 47; tr. it. di B. Venturi, cit., p. 67. N.d.T.]
15
L’IDEA DI “MOMENTO 1900”.
UN PROBLEMA FILOSOFICO E STORICO
di Frédéric Worms
16
Nel 1889 Henri Bergson pubblica l’Essai sur les données immédiates de la
conscience, il suo primo libro. Ora, può darsi che oggi si debba vedere in ciò
un duplice inizio. Probabilmente, Bergson non inaugura in tal modo soltanto la
sua opera, ma un nuovo momento filosofico, che si può chiamare il “momento
1900”; e ciò perché, al di là della sua tesi propria, questo libro formula una questione più ampia, suscettibile di differenti soluzioni, in cui si incontrano i principali nodi problematici dell’epoca.
Può anche darsi, nondimeno, che non siamo più in grado di vederlo o di
comprenderlo. È possibile, in altre parole, che oggi si faccia fatica a percepire
la specificità e la diversità di questo momento filosofico attraverso le quali tale
momento si congiunge alle altre dimensioni del suo tempo – dalla scienza, alla politica, all’arte – e inaugura realmente il XX secolo, almeno in Francia, conducendo fino a noi. Lo scopo del presente articolo, del resto, non è se non
quello di tentare di porre rimedio a questa incapacità, di mostrare non soltanto che un libro come quello di Bergson inaugura, assieme ad altri libri, un momento siffatto; ma, anche, di mostrare che solo la nozione di momento, correttamente intesa, permette di rendere giustizia a questa singolare opera nella
sua relazione con altre opere e con la loro epoca; e che essa fornisce uno strumento o addirittura un principio per una storia del pensiero filosofico.
Ciò che rende questo compito ancor più difficile ed importante per la filosofia dell’inizio del XX secolo in Francia è precisamente il fatto che essa sembra
avere costituito un “momento”, non nel senso forte che si cercherà di difendere in questa sede – definito da un problema preciso e condiviso, intorno al quale si raggruppano e si oppongono opere filosofiche singolari, che si relaziona
allo stesso tempo con i principali saperi e le principali questioni del loro tempo
–, ma in un senso molto più debole e vago. Che la si intenda in senso ideologico, sociologico o aneddotico, l’unità di questo “momento” sembra in effetti
depotenziata. Si tratterà di uno “spiritualismo francese” superato e condannato nello stesso momento in cui si nominava, con il quale i filosofi della generazione successiva, per esempio Sartre o Nizan, dovranno rompere senza mediazione, rimproverandogli di disconoscere e persino di tradire i problemi concreti emersi allora, per esempio in Husserl, Freud o Marx. Probabilmente, si
cercherà in ciò una novità sociologica o politica che si inserisca nella “Repubblica dei Professori”, un riconoscimento istituzionale senz’altro inedito, segnatamente per la filosofia, che sarà messo in opera innanzitutto per l’Affaire Dreyfus, ma anche per la Prima Guerra Mondiale, nel quale, tuttavia, esso si perderà. Si ricadrà di conseguenza nell’aneddoto, ad esempio nella notorietà
SAGGI
mondiale, fatta di onori e di polemiche, di Bergson tra il 1900 e il 1914, o ai legami che lo uniscono, tra molti altri, a Jaurès (la loro rivalità all’Ecole Normale
e à l’agrégation), a Péguy o a Proust (suo cugino per intesa, paggetto di sua
moglie in occasione del suo matrimonio). Certo, tali tratti manifesterebbero almeno un aspetto essenziale dell’idea di momento, tanto in filosofia quanto in
altre discipline, e cioè la discontinuità che essa presuppone nella storia, come
anche, del resto, le relazioni sulle quali essa riposa. Ma se la rottura che apre
il momento “1900” sembra netta e, addirittura, violenta, tanto durante la guerra quanto durante le polemiche degli anni 30, può darsi anche che essa nasconda per ciò stesso la sua consistenza, la sua diversità interna e la rottura
inaugurata quando esso venne a costituirsi intorno agli anno 1890. In sintesi,
non si può scartare la possibilità che, almeno tra il 1889 e il 1914, si sia costituito un momento filosofico in un senso più forte, senza il quale non si potrebbe comprendere il seguito del secolo nelle rotture e nelle riprese che l’hanno
scandito. Qui, dunque, sul caso “1900”, si tratterà allo stesso tempo di comprendere ciò che può definire un momento filosofico in generale – la sua unità, ma anche le sue tensioni, il legame tra la filosofia e gli altri saperi o le altre
pratiche – e di comprendere anche (o innanzitutto) se ci è stato e quale è stato lo stesso “momento 1900”, quale la sua estensione e quali i suoi limiti, quali la sua fecondità e quali i suoi rischi. Sul piano del metodo, dunque, come anche sul piano del contenuto, si dovrà introdurre infine ciò che potrebbe essere
una storia della filosofia francese del XX secolo.
Il movimento delle osservazioni che seguono s’impone.
Bisognerà innanzitutto tentare di vedere se un’unica questione unisca o no
l’opera di Bergson e quella, probabilmente meno conosciuta, di altri; una questione che permetta di comprendere al tempo stesso la loro unità condivisa e
la loro rispettiva specificità. Diciamolo sin d’ora (ma impegnandoci a dimostrarlo nel seguito): può darsi che, dietro l’immagine generalmente condivisa dello
“spiritualismo francese”, vedremo prendere forma una precisa questione che
potrebbe essere formulata in termini di “spirito”, ma tale da esprimere le divisioni e i differenziazioni del secolo che inizia più di qualunque altra dottrina fissamente costituita.
Nel seguito, sarà ancor più essenziale esplorare le relazioni tra tali questioni filosofiche e quelle che nascono negli altri ambiti del sapere. Diciamo sin
d’ora, anche questa volta, a quale ipotesi giungeremo. Si sosterrà in effetti che
la relazione della filosofia con le altre pratiche o gli altri saperi umani non è diretta in un senso o nell’altro, come se la filosofia dovesse o esprimere la verità di ciò che si verifica altrove, in una specie di sapere assoluto, o essere attraversata da sommovimenti sotterranei sui quali non ha alcuna presa. È piuttosto attraverso questioni precise e condivise che le opere filosofiche si congiungono ai saperi del proprio tempo; ma, a loro volta, questi stessi saperi si
congiungono alla filosofia attraverso la formulazione esplicita delle loro questioni in opere particolari che sono come dei crocevia. Tali ci paiono qui, esemplari ciascuna nel proprio ambito, e lungi da ogni aneddoto, le opere di Jaurès,
Poincaré o Proust. Così, in uno stesso “momento”, ci sarebbero una questione comune e delle differenze profonde, non solo tra le singole opere filosofi-
17
che, ma anche tra esse, prese nel loro complesso, e le opere politiche, scientifiche o estetiche. La storia della filosofia (lungi dal prendere le distanze da esse e dall’assorbirle), deve cogliere tanto la filosofia quanto la storia.
Pertanto, alla fine si potrà, a titolo di semplice prospettiva, indicare anche
ciò che potrebbe condurre da un “momento”, definito in questi termini, ad un
altro momento, abbozzando in tal modo il percorso che condurrebbe, lungo il
secolo, fino al nostro presente.
Una problematica comune ad opere singolari?
La questione dello spirito in Bergson, Brunschvicg e Alain
18
Si può ripartire, senza artificio, dall’Essai sur les données immédiates de la
conscience.
In realtà, la forza del primo libro di Bergson sta nel fatto che, dietro una distinzione apparentemente classica tra lo spazio e il tempo (o, meglio, durata),
esso combina senza mostrarlo i due elementi di qualunque momento filosofico determinato, e cioè una potenza di rottura o rifiuto legata a un certo stato
del sapere del proprio tempo, e una potenza di dislocamento o di rinnovamento, o anche di affermazione, non soltanto di una tesi singolare, ma pure di una
problematica generale che è anch’essa legata da un nuovo stato del sapere.
Si può brevemente dire in cosa consistano questo rifiuto e questo rinnovamento prima di vedere in che cosa essi conducano al problema che anima l’opera
di Bergson, ma che egli condivide con i suoi contemporanei (non solo in Francia, benché sia in Francia che si formula a poco a poco in maniera tale da determinare un quadro specifico).
Distingueremo due tappe o due questioni nella stessa distinzione tra lo spazio e il tempo ripresa da Bergson.
In effetti, prima di venire all’originalità profonda della nozione di durata, all’asimmetria tra essa e la nozione di spazio, alla rivendicazione metafisica che
senza dubbio essa contiene (come la contiene, in maniera audace e prudente, il titolo del libro), bisogna innanzitutto insistere sulla questione che rappresenta, nel 1889, il ritorno alla stessa questione dello spazio e del tempo. Non
si tratta semplicemente di un ritorno convenzionale ad una questione o ad una
dottrina di scuola, per esempio a quella di Kant (che Bergson non manca di criticare, almeno nel caso del tempo). La posta in gioco di ciò che all’epoca è, forse giustamente, un “ritorno a Kant”, è, se così si può dire, più critica e decisiva. Si tratta di opporsi all’idea, implicitamente dominante alla fine del XIX secolo, del primato di una scienza che tratterebbe direttamente dei fatti oggettivi
e che sarebbe essa stessa un fatto, se non un fatto principale, anche a proposito della psicologia o della sociologia (il caso di Comte in Francia, di Spencer
in Inghilterra, di Wundt in Germania). Si tratta più precisamente di affermare
nuovamente il ruolo (o un primo ruolo) dello spirito nell’esperienza. Tornare allo spazio e al tempo, che Kant chiamava le “forme a priori della sensibilità” significa chiedersi nuovamente se percepiamo le cose o i fatti direttamente, o,
piuttosto, attraverso il prisma del nostro spirito; significa tornare alla questione
critica o alla questione del soggetto. La prima frase dell’Avant-propos di Bergson, in maniera inapparente, è a questo proposito carica di senso:
Sappiamo infatti che, almeno nel caso dello spazio, Bergson spingerà il relativismo critico un po’ più lontano di Kant. Se la nostra conoscenza passa a
suo parere attraverso i prismi dello spazio e del linguaggio, ciò non dipende
soltanto dalla nostra sensibilità in generale, ma anche alla nostra azione, più
precisamente alla nostra condizione di esseri viventi e umani. È una via percorsa da Darwin. Comunque stiano le cose a tal proposito, una prima cosa, essenziale, deve essere sottolineata. Se, alla fine del XIX secolo, si vuole tornare dalla scienza alla politica passando per l’arte, ciò non si verifica soltanto in
ragione delle crisi che possono colpire dall’interno questo o quel discorso (per
esempio, nel caso della scienza, le geometrie non euclidee o, ben presto, la
teoria della relatività); ma anche in ragione di una crisi più estesa e che concerne il ruolo dello spirito umano nell’esperienza: esso è soggetto o oggetto,
costituente o deformante? Coglie la verità o soltanto i fenomeni? Delle verità o
soltanto delle ipotesi? Proprio come, per esempio, la tesi di Jaurès (De la réalité du monde sensible, 1893) o l’opera di Proust, che del resto gli risponderanno a livelli differenti, il libro di Bergson è innanzitutto, e nella maniera più decisa, un ritorno a queste questioni di principio. Di fronte ai progressi della scienza e, soprattutto, delle dottrine che la considerano come acquisita, si può, senza fare ricorso al discorso metafisico tradizionale, ridare un ruolo allo “spirito”:
sarà questa, forse, una delle direttrici non soltanto del “momento 1900”, ma di
tutto il secolo.
Ma è precisamente su questo punto che Bergson si spinge oltre. Se egli è
considerato, in virtù della sua giovinezza esaltata (e spesso confusa) come
l’eroe di una rivoluzione filosofica, non è senz’altro soltanto perché ha criticato
(ma anche fondato) la scienza a partire dallo spazio, riprendendo (ciò, purtroppo, non è abbastanza noto), almeno su questo punto, il gesto di Kant! Ciò è
possibile anche perché egli ha operato un secondo rifiuto, perché si è opposto
a Kant anche su un altro punto riconoscendo per così dire un secondo ruolo
allo “spirito”, attraverso la questione del tempo o la distinzione tra il tempo e la
durata. La realtà che prima di tutte sfugge alla nostra conoscenza spaziale è
innanzitutto, secondo Bergson, il tempo, non soltanto nello scorrere continuo
che la nostra rappresentazione cerca di mascherare e governare, ma soprattutto nell’atto interno che lo fissa e che la nostra memoria e la nostra libertà
manifestano: sono questo atto e, anche, questo scorrere, che Bergson designa
con il nome di durata. Quest’ultima – e Bergson lo sottolineerà sempre più nettamente2 – è quindi “innanzitutto” spirito. In ogni caso è questo atto che fa sì
che le “données immédiates de la conscience” non saranno mai nel suo pensiero (come nella “fenomenologia”, contemporanea, di Husserl) dei fenomeni
dati “a” una coscienza, ma piuttosto i dati reali di “una” coscienza individuale
che le fissa e le prolunga, che ricorda e agisce. Così, la critica della scienza in
SAGGI
“nous nous exprimons nécessairement par des mots, et nous pensons le
plus souvent dans l’espace” (Essai.., p. VII)1.
19
20
nome dello spazio rivela come rovescio della medaglia un’altra dimensione irriducibile dello spirito, vera porta d’ingresso o “via regale” (per applicare a Bergson l’espressione di Freud a proposito del sogno) in una nuova “metafisica”.
Sarebbe questa la singolarità irriducibile di Bergson.
Tuttavia, è evidente che, se vi è nel gesto di Bergson una novità, essa non
risiede, come si crede sovente, nella sola affermazione della durata o dello spirito. Essa risiede anche, e forse soprattutto, nella distinzione tra due dimensioni dello spirito, o tra due interventi dello spirito nell’esperienza. Ci sembra possibile formulare il “problema dello spirito” nella filosofia “francese” del momento “1900” precisamente nella seguente maniera: si può risalire dalla nostra
esperienza allo spirito, non soltanto come a un fondamento soggettivo e relativo, ma come ad un atto assoluto sul quale si possano fondare non soltanto la
nostra scienza, ma anche la nostra condotta e, in fondo, la nostra vita? Ma, come si percepisce sin d’ora, non bisognerebbe vedere in questo problema come una parola d’ordine, quella del ritorno a un “soggetto” di cui ciascun autore presenti una figura tranquilla e pacifica sotto il nome metafisico di spirito e il
cui quadro d’insieme, nello stile “terza Repubblica”, abbia un aria desueta di distribuzione dei premi! Al contrario, ciò che esprime la nozione di spirito in una
filosofia che vuol essere empirista e rifiuta le metafisiche tradizionali, è qualcosa come una profonda lacerazione ove, nelle crisi dell’arte, della scienza, della politica (e innanzitutto contro l’ignoranza di queste crisi) non si potrebbe trovare il soggetto senza che venga posta la questione della sua portata metafisica, morale e persino religiosa. È una tale lacerazione che si deve cercare nella filosofia di Bergson come anche nelle altre grandi dottrine filosofiche dell’epoca, le quali, sullo sfondo dello stesso problema, propongono soluzioni radicalmente differenti, soprattutto in Francia.
Conviene infatti insistere e comprendere in che senso si dà una questione
che permette di comprendere un’opera come quella di Bergson e quella dei
suoi contemporanei. Allora si vedrà se l’idea di “momento”, applicata a questi
problemi, sia in grado di svolgere una duplice funzione: l’individuazione di sistemi di pensiero che sono particolari per principio; la relazione attraverso poste in gioco storiche condivise per principio.
La tensione tra un’opera e un momento: il caso Bergson
È l’opera di Bergson, innanzitutto, che non può essere ridotta una semplicistica parola d’ordine.
Certo, la “questione” dello spirito porta, in Bergson, ad una critica della
scienza e ad una rivendicazione metafisica che, da sole, potrebbero disegnare un “programma”: ciò spiegherebbe come l’intero momento possa apparire
“bergsoniano”. In ciò si nasconde un rischio incontestabile, un rischio che non
mancherà di essere aggravato dall’impegno politico di Bergson durante la Prima Guerra Mondiale e sul quale si baserà la generazione degli anni 30 (Georges Politzer in primis 3, seguito da Sartre) per rompere con il suo pensiero.
Ma ci importa andare più in là: in breve, si può dire che, lungi dall’essere
SAGGI
stabilita di primo acchito, la distinzione tra lo spazio e il tempo non cessa di intensificarsi lungo tutta l’opera di Bergson, il quale non si accontenta di un dualismo scontato, ma traspone all’interno dello spirito una tensione il cui equilibrio è di libro in libro più difficile da trovare. È proprio questa tensione interna
che spiegherebbe così il contrasto costante di Bergson con il suo tempo, i suoi
avversari, ma anche, come aveva immediatamente capito Péguy, con i suoi discepoli, con gli onori e, come aveva ben capito ancora una volta Péguy, a ridosso questa volta della guerra, con la sua solitudine4. In filosofia, in politica,
in religione, egli sarà diviso tra attese contraddittorie o, come egli stesso dice
nel suo ultimo grande libro, “tra l’albero e la corteccia”5. È questo che costituisce anche la sua grandezza non soltanto filosofica ma anche storica, ciò che
gli conferisce il suo ruolo centrale nella storia della Francia, in cui si deve distinguere tra il bergsonismo chiuso e il bergsonismo aperto, tra lettori come per
esempio Chevalier e Jankélévitch e lettori come Pétain e De Gaulle.
La questione sembra tuttavia assai ampia. A partire dall’Essai sur les données immédiates de la conscience, di cui si deve qui dire un’ultima cosa, sembra che Bergson salti da un polo dello spirito all’altro. Ciò che, nel 1889, fece
la forza dell’Essai non è il passaggio da una critica della “psicofisica”, che pretendeva di misurare scientificamente lo spirito (primo capitolo), alla dimostrazione della libertà (terzo capitolo), alla distinzione tra lo spazio e la durata (capitolo centrale, che è come una mediazione fra questi due grandi gesti)? Non
è stato questo salto ad aver infiammato la querelle sul bergsonismo, sulla
“nuova filosofia”? La successiva evoluzione del suo pensiero non è una semplice applicazione? Matière et mémoire, sottotitolato “essai sur la relation du
corps à l’esprit”, del 1896; L’Evolution créatrice, del 1907; Les deux sources de
la morale e de la religion: per numerosi lettori o non-lettori frettolosi è sufficiente citare i titoli di queste tre altre grandi opere per non aver più bisogno di leggerle! E che dire delle raccolte di articoli: La pensée et le mouvant, del 1934,
con il celebre manifesto del 1903 (“Introduction à la métaphysique”), e L’énergie spirituelle, il cui titolo, nel 1919, subito dopo la guerra e i suoi discorsi, non
è anodina, con anche un articolo sui “fantôme de vivants et la recherche psychique” (che sembra giustificare lo “spiritismo” più che lo spiritualismo)? Bergson sarebbe colui che ha ridotto la scienza ad una funzione pratica e ha preteso di attingere una realtà spirituale tanto in noi quanto nell’universo e nella
storia.
Tuttavia, se si guardassero le cose da più vicino, cosa si vedrebbe esattamente? Tutto il contrario di un dualismo già compiuto che è sufficiente lasciar
dipanare. Certo, dal suo primo libro al secondo, Bergson passa dalla “vie intérieure” alla materia. Ma si tratta giustappunto di una sorpresa: il lettore di Matière et mémoire si trova immediatamente immerso, ad opera della sua percezione pura, nell’esteriorità radicale della materia, anche se in seguito questa
percezione si mescola alla memoria nella vita dello spirito e la stessa materia
è definita facendo ricorso alla durata, che è analoga alla nostra benché irriducibile ad essa. La stessa vita, ne L’évolution créatrice, è duplice: lo “slancio vitale” che è obbligatorio supporre per spiegare la sua imprevedibile evoluzione
ricade in specie determinate di cui l’umanità, con la sua intelligenza logica e
21
22
tecnica adattata alla spazialità, è il successo più alto! L’opposizione fra due
morali e due religioni, infine, sarà tutto fuorché una semplice applicazione del
dualismo iniziale. Se il grande uomo dabbene o il grande mistico ci affascina
non è solo perché egli recupera lo slancio vitale e la durata; ma anche perché
rompe con la morale chiusa che oppone le società fino all’omicidio e allo sterminio e perché difende una morale aperta, senza distinzione tra gli uomini, e
ciò facendo rivela la differenza fra queste due morali. È perché egli non si richiama verbalmente a un presunto principio divino, al fine di rinforzare un legame sociale contro gli altri, ma prova con i suoi atti che ha superato l’umanità rivolgendosi ad essa, rompendo ogni chiusura. Così, lungi dal fornire a un
“io” una ricetta già compiuta e così falsamente vicina al suo “culto” barresiano,
lungi dall’immergersi nel flusso dello slancio vitale o nell’esaltazione di uno spirito “nazionale” che non aveva esitato a rendere operativo durante la guerra,
Bergson scopre una divisione più profonda che passa in ciascuno di noi e rinnova interamente il suo pensiero. I due termini del dualismo di Bergson non sono il corpo e lo spirito, ma delle direzioni e del corpo e dello spirito, che ancora oggi custodiscono se non il fondamento assoluto che egli ha tentato di dar
loro, almeno il loro potere di orientamento.
Tutte le relazioni di Bergson con il suo “momento” saranno marcate da questa tensione profonda. Da un lato, c’è questa “querelle del bergsonismo”, che
percorre l’Europa prima di infiammarsi e spegnersi nella guerra. Dall’altro, ci
sono delle relazioni profonde, che spesso sono rimaste virtuali, con altre dottrine, e ciò problema per problema: dal numero alla storia, con Husserl; dall’incosciente al riso e alla civiltà, con Freud; dall’azione all’esperienza religiosa,
con James; e molti altri ancora. La ricezione di Bergson, anche in Francia, si
muove in questa alternativa: intensità e probabile maggior confusione nei dibattiti di ogni ordine (è il primo filosofo “mediatico” dell’epoca moderna), somiglianze e divergenze profonde con le altre dottrine filosofiche. Proprio tornando a queste ultime si potrà comprendere la specificità dell’opera di Bergson,
non solo in se stessa, ma in riferimento ad un “momento” che è in effetti determinante per tutto il secolo a venire. Definiremo questo aspetto innanzitutto attraverso una prima relazione, che è anche uno dei filoni principali della filosofia francese del XX secolo.
Un’altra via dello spiritualismo in Francia?
Il posto di Léon Brunschvicg nel momento 1900 e successivamente
Se si dovesse effettivamente citare il nome di un filosofo la cui dottrina sia
stata associata a quella di Bergson – fino alla comune opposizione, in nome
dello “spiritualismo”, all’inizio degli anni 30 – e che tuttavia gli si è opposto successivamente al punto da apparire oggi6 come l’origine dell’altra grande tradizione della filosofia francese del XX secolo, da Bachelard a Foucault passando per Cavaillès e Canguilhem, sarebbe senza esitazione quello, oggi quasi dimenticato, di Léon Brunschvicg.
Ciò richiede tuttavia un messa a fuoco.
SAGGI
Più precisamente, ciò richiede, prima di rileggere la sua opera e vedere perché essa comporta questa prossimità e questa originalità, che si torni sull’immagine di un professore della Sorbona tra le due guerre, duramente maltrattato dalla storia.
In effetti, conviene innanzitutto non accontentarsi dell’immagine che è stata consegnata per esempio da Nizan, che faceva di Brunschvicg il più importante dei Chiens de Garde 7 che hanno tradito non soltanto l’uomo concreto in
nome dello spirito, ma anche (e con lo stesso gesto) la filosofia per gli interessi della borghesia; o anche da Sartre, secondo il quale era una priorità assoluta8 uscire da questa “filosofia alimentare” fondata sull’“interiorità umidiccia” di
cui Brunschvicg era il principale rappresentante. È vero che, in questo articolo
celebre e folgorante, Brunschvicg non era il solo dal quale Sartre voleva emanciparsi: vi si trova anche questa frase meno nota ma profondamente rivelatrice: “eccoci liberati da Proust”! Ma ciò non basta per rivedere la questione.
Brunschvicg era soltanto questo universitario che dominava le istituzioni accademiche e dettava il neokantismo vago e benpensante della Sorbona e i programmi dei concorsi finché il disastro del 1940 lo costringe a rifugiarsi a Aixen-Provence, ove, adeguatamente accolto da Blondel, morì esiliato nell’intimo? Diversi indizi permettono di dubitarne sin d’ora. Si resterà stupiti del modo in cui, prima di dedicargli alcune lezioni del suo corso sulla Natura, Merleau-Ponty, nella sua Phénoménologie de la perception del 1945, diresse costantemente l’una accanto all’altra, senz’altro per prenderne le istanze, la “filosofia dell’intuizione” di Bergson e la filosofia “della riflessione” di Brunschvicg9.
La stessa relazione è abbozzata da Ricoeur, nella sua importante prefazione
a L’Expérience intérieure de la liberté de Jean Nabert10, che fu suo maestro (ed
uno dei discepoli più importanti di Brunschvicg). Non è certo per la sua influenza accademica che Brunschvicg si trova collocato nell’ambito di tali relazioni.
È in virtù della specificità di un’opera. Si deve dunque andare oltre e passare
dal vegliardo apparentemente ben collocato al giovane che si lancia, al principio degli anni 1890, in una battaglia che non ha nulla da invidiare alle altre.
In effetti, nel 1893, quando Brunschvicg lancia, con i suoi migliori amici, Elie
Halévy et Xavier Léon, la Revue de métaphysique et de morale, non è solo con
l’entusiasmo di alcuni giovani filosofi provenienti dallo stesso milieu parigino,
più diversificato di quanto non si creda. Pur avendo giocato negli Champs-Elysées con il giovane Marcel Proust (e forse con una certa Gilberte), pur invitato nei saloni della famiglia Halévy, Brunschvicg condivide con essi più gli interessi intellettuali di una generazione che il milieu sociale in senso stretto. Essi
sono stati innanzitutto gli allievi degli stessi maestri presso il Liceo Condorcet;
poi, con Halévy (e Emile Charter, il futuro Alain, anch’egli partecipe sin dal principio di questa avventura) all’Ecole Normale e all’Università. Sono queste preoccupazioni che la nuova Revue vuole esprimere e incarnare pubblicamente.
Una delle differenze, del resto, tra Brunschvicg e Bergson riguarderà sempre
questo aspetto. Se egli condivide precisamente le prese di distanza di Bergson, Brunschvicg li inscrive in un quadro collettivo e pubblico: dopo la Revue,
gli stessi amici fondano nel 1900 la Societé française de Philosophie, ispiratrice del Vocabulaire critique de philosophie coordinato da Lalande, e i Congres-
23
24
si internazionali, che conosceranno una prima pausa durante la guerra, prima
di un ultimo momento simbolico nel 1937. Se Bergson vi partecipa, è perché
Brunschvicg e Xavier Léon tengono ad associarlo, quasi ad arruolarlo: lo hanno messo immediatamente, suo malgrado, alla loro testa, pur consapevoli delle divergenze che li separano. Brunschvicg non conobbe la stessa influenza
politica di Bergson; ma partecipò alle Commissioni dell’Académie des sciences
morales et politiques, ai dibattiti dell’“Union pour la vérité” de Desjardins, come
anche alle sue decadi di Pontigny. Quanto a sua moglie, fu una delle prime
quattro donne ministro di Francia, nel governo del Front populaire. L’amicizia
con Halévy, infine, e soprattutto essa, resta un crogiolo in cui si uniscono preoccupazioni filosofiche e pubbliche, come mostrerà la pubblicazione postuma,
a cura di Jean Wahl, dell’Agenda retrouvé 11, in cui Brunschvicg, cinquant’anni
dopo, annota i pensieri quotidiani dedicati all’autore de L’ère des tyrannies (deceduto immediatamente prima della guerra) in occasione di una separazione,
durata un anno, all’epoca della loro giovinezza12.
Il contributo di Brunschvicg al primo numeri della Revue de métaphysique
et de morale, nel 1893, deve del resto recuperare tutta la sua importanza. In
questo breve studio su Renan13, uno dei maestri del momento precedente, si
esprime appunto il rifiuto condiviso con Bergson: il rifiuto di una relazione non
critica con la scienza, che vede nel suo progresso fattuale una garanzia del
suo fondamento e del suo valore. L’accumulazione “sintetica” dei risultati non
basta né basterà mai; ciò che conta, prima di tutto, è l’approfondimento “analitico” delle condizioni di questi successi e degli ostacoli che incontra. Sin da
ora si esprime il ritorno ad una filosofia “critica”, se non ad una filosofia “dello
spirito”. Tutto si svolge, ancora una volta, secondo le modalità di questo passaggio. In effetti, Brunschvicg non va dalla critica della scienza (o di una certa
filosofia della scienza) ad una metafisica che pretenda di superarla. Per lui non
si tratta mai di passare dal “soggetto” della scienza, cioè dalle attività che l’analisi riflessiva scopre in noi come sue condizioni, ad uno “spirito” esterno, uno
spirito inteso come un oggetto o una cosa. Tutta la filosofia di Brunschvicg può
precisamente essere definita come un passaggio interno da un soggetto della
scienza ad uno “spirito” pienamente certo della validità dei suoi atti, che si
esaurisce ma che si riconquista senza sosta in essi. Il solo errore di Kant è
quello di aver creduto che gli atti del nostro spirito valessero soltanto per noi,
soltanto per l’uomo, in maniera relativa. Nel suo pensiero, il criticismo restava
un relativismo, quasi uno scetticismo. L’ombra della cosa in sé e della trascendenza aleggiava ancora. Non è così per Brunschvicg, che segue a questo proposito un successore di Kant (sul quale Xavier Léon scriverà la sua opera principale), Fichte, che recupera anche la filosofia di Spinoza, sul quale, come
Alain, egli scrive, prima della sua tesi, un libro capitale14. A suo parere, gli atti
che la riflessione scopre a fondamento della scienza non hanno nulla di umano in un senso ristretto e relativo; essi ci scoprono al contrario un io assoluto
e un orientamento per la stessa umanità, nell’insieme delle sue determinazioni. Così, come è già evidente in base a queste prime osservazioni, se è vero
che la finalità di Brunschvicg può essere assimilata a quella di Bergson in virtù della comune opposizione agli stessi avversari, è vero anche che non c’è
SAGGI
nulla di più differente, in ciascuno di essi, dei mezzi e dei rimedi ricercati. La
stessa confusione minaccia d’altronde le loro specificità. Anche per Brunschvicg l’assimilazione ad uno “spiritualismo” è cosa fatta! Anche per lui, infatti, la filosofia non risiede ultimamente in un salto dagli atti della conoscenza (innanzitutto il “giudizio”) all’affermazione – anche quella religiosa – dello spirito
(anche se si dà una unità di principio fra questi due gesti), ma nella difficoltà
crescenti di questo passaggio, anch’esse attestate dallo stesso sviluppo della
sua opera.
Al fine di scandirla, distinguiamo in essa solo tre tappe.
È innanzitutto il tempo dell’affermazione. Nella tesi intitolata De la modalité
du jugement, completata (come in Bergson, ma in senso opposto!) da una tesi latina e critica su Aristotele, nel libro su Spinoza, ma anche, intorno al 1900,
dai saggi da titoli significativi (Introduction à la vie de l’esprit, 1900; L’idéalisme
contemporain, 1905), Brunschvicg rivendica questa filosofia dello spirito interiore. Essa si fonda su degli atti semplici e puri, il giudizio che unisce e coordina i dati dell’esperienza, senza il quale non c’è esperienza; l’affermazione di
esistenza, il “ciò è” senza il quale nulla è dato. Essa rivendica una necessità,
non fattuale ma intellettuale, non fatale ma affermata o prodotta. Così, lo Spinoza di Brunschvicg, come quello di Alain, è uno Spinoza dell’interiorità. Non
è, come negli idealisti tedeschi un secolo prima, anche se pure ad essi serve
a superare Kant, il filosofo della natura o del panteismo. Non è il Deus sive natura, così determinante da Goethe a Hegel, ma il Dio interiore, “l’amore intellettuale di Dio”, quello che serve da modello!
Ma tutto ciò resta programmatico se non si cercano le prove dello spirito là
dove esse si trovano, in una storia dell’umanità orientata da quella della scienza. I tre libri che ne sono testimonianza15 sono caratterizzati da una tensione
fondamentale. Da un lato, essi inaugurano una filosofia delle scienze “alla francese”, che consiste meno nel vedere nella scienza un atto dello spirito che nel
cercare l’esperienza intellettuale stessa nella concettualità scientifica, conquistata sul suo “ostacolo” interno, sia che esso sia definito, come in Bachelard,
dall’immaginario, sia che esso sia, come in Canguilhem o Althusser, definito
dall’ideologia. Da un altro lato, le opere di Brunschvicg non si allontanano mai
dalla sua finalità speculativa, se non apologetica; e non per questo, nelle loro
stesse tensioni, non restano significative. Esse indicano, come in Bergson, che
una segreta tensione lacera, nella sua immanenza, l’esperienza umana. I due
autori rifiutano tanto il fatalismo dell’aldilà quanto quello del quaggiù, il ritorno
alla trascendenza o la rassegnazione ad una immanenza uniforme o relativa.
La loro opposizione disegna come i due bordi di una differenza assoluta nella
nostra stessa esperienza, dalla parte della vita o del concetto, che attraverserà senza dubbio tutto il secolo.
Gli anni 30 vedranno, nell’opera di Brunschvicg, un ritorno all’attività pubblica; non più però nella rivendicazione entusiastica, ma in una sorta di inquietudine non finalizzata a sé, ma alla propria epoca – una inquietudine di cui Emmanuel Lévinas è stato testimone commosso in occasione di una sua visita in
rue Scheffer nel 1932, lo stesso anno dei Chiens de Garde 16. La questione
“dello spirito”, nel momento in cui deve attingere la storia, rischia di non esse-
25
re più intesa. Sullo “spirito europeo”, sulla crisi delle scienze, il tono si fa cupo,
partecipa di questo discorso generale che, da Bergson a Paul Valery, da Husserl à Freud, ha agitato gli anni fra le guerre mondiali, come ha mostrato Jacques Derrida in testo capitale17. Nel suo ultimo libro, Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne, pubblicato postumo a Ginevra, si potrà vedere un significato molteplice. Se ne indicherà qui solo uno: proprio come Bergson in un testo della guerra precedente18, Brunschvicg vede finalmente nella diversità tra
Descartes e Pascal una dualità che fonda la “filosofia francese” e che sarà ripresa a partire da Rousseau e Voltaire fino a Maine de Biran e Auguste Comte. Si può essere tentati di vedere nella stessa relazione tra Bergson e Brunschvicg una nuova figura di questa dualità (stranamente colorata dalla stessa
storia della Francia) nel nuovo momento che essa a sua volta colora e contribuisce a definire.
Lo spirito del momento 1900: unità e diversità, aperture e resistenze.
L’esempio di Alain
26
Non potrebbe essere questione di ridurre il “momento 1900 in filosofia”, anche in Francia, alla tensione tra le figure, le opere, i discepoli di Bergson e di
Brunschvicg. Certo, tra il Collège de France (ove Bergson ottiene un posto nel
1900) e la Sorbonne, con gli scritti polemici in un senso o nell’altro, come quelli di Le Roy o di Julien Benda, essa comincia a disegnare un quadro, determinante anche per l’accettazione o il rifiuto filosofico di altre dottrine contemporanee provenienti precisamente dall’estero. Il silenzio filosofico francese su
Nietzsche (che muore nel 1900) o su Freud (la cui Traumdeutung appare nello stesso anno) si spiega parzialmente a partire da questa circostanza. Che
Russell sia stato rapidamente pubblicato dalla Revue de métaphysique et de
morale, o Husserl invitato da Brunschvicg per le celebri conferenze che daranno origine alle Meditazioni Cartesiane, non impedirà il fraintendimento, per difetto o per eccesso, delle loro dottrine, del quale è vero che essi saranno in
parte responsabili (vedi la celebre esclamazione di Husserl: “siamo noi i veri
bergsoniani”). Queste resistenze saranno, come sempre, una delle fonti del
prossimo momento filosofico, anche in Francia; e i momenti si alimentano di dislocazioni non soltanto nel tempo, ma anche nello spazio. Su ciò non potremo
insistere in questa sede. Non si potrà neppure evocare tutta la varietà del momento 1900 in Francia; sia in metafisica, per esempio con la tesi di Maurice
Blondel su L’azione, la cui prima versione, nel 1893, è una delle parti principali del dibattito sullo spirito; sia in filosofia della scienza, in cui Couturat si oppone tanto ai bergsoniani quanto a Brunschvicg e in cui il dibattito è molteplice e
contrastato, con delle figure come quelle di Duhem o Meyerson. Ma si dirà
qualcosa sulla figura e la dottrina di Alain, prima di venire alle opere che, a partire dagli altri ambiti della teoria o della pratica, pervengono infine alla filosofia.
In realtà, non è solo un effetto di prospettiva se questa opera ci sembra in
un certo senso chiude il cerchio del “momento 1900” in filosofia.
In un certo senso, è innanzitutto il caso di un semplice punto di vista crono-
SAGGI
logico. In effetti, nato nello stesso anno di Brunschvicg (1869), amico intimo
anch’egli di Elie Halévy, protagonista come si è detto degli inizi della Revue de
métaphysique et de morale19, ove suoi articoli compaiono sotto un primo pseudonimo, di origine platonica (Critone), Emile Chartier pubblicherà tuttavia le
sue prime opere importanti solo dopo la Prima Guerra Mondiale, servendosi
per esse di un nuovo pseudonimo, Alain, utilizzato per i Propos della Gazette
de Rouen, che cominciavano a garantirgli una grande notorietà. È come se
l’esperienza della guerra, alla quale partecipa volontariamente quando ormai
la sua età lo dispensava dal farlo, che lo spinge a entrare davvero nell’arena e
a pubblicare i libri che, pur condividendo indiscutibilmente le il rifiuto e le problematiche che muovevano i suoi contemporanei, si oppongono già ad essi;
dei libri che, pur riguardando questioni di principio e pur costruendo una dottrina, sono innanzitutto orientate da un progetto etico e politico. Tre libri in un lasso di tempo molto breve sembrano così formare un triangolo, che chiude esso
stesso la figura formata con Bergson e Brunschvicg. Sono le Quatre-vingt-un
chapitres sur l’esprit et les passions par l’auteur des propos d’Alain (1917), titolo originale di ciò che diverranno poi gli Eléments de philosophie, seguiti da
Mars ou la guerre jugée, et du Système des beaux-arts. Certo, numerose opere seguiranno, compresa le raccolte di Propos (tra i quali il celebre Le citoyen
contre les pouvoirs). Ma queste tre opere assicurano ai nostri occhi la singolarità filosofica di Alain nel suo momento proprio, al di là dell’influenza del professore de Khâgne presso il Liceo Henri IV, maestro riconosciuto di una generazione che si distinguerà in ogni ambito della filosofia (si legano a lui più spesso una Simone Weil, per esempio, che Calguilhem o Aron). Al proposito bisogna dire qui qualcosa.
Lo scopo di Alain, in virtù del quale si inscrive nella questione comune che
abbiamo evocato, ma anche la sua singolarità, appaiono evidenti già nei titoli
di questi libri.
Come per Brunschvicg, anche per lui si tratta innanzitutto di provare l’irriducibilità dello “spirito” e il suo ruolo indispensabile nella più semplice come nella più complessa delle nostre esperienze. L’esempio classico della percezione
di un dado cubico presa a prestito dal suo maestro Jules Lagneau, lo prova a
sufficienza; di fatto gli occhi, da soli, non bastano a “vederlo”; ci vuole l’atto di
un soggetto, il lavoro o, più precisamente ancora, il giudizio del nostro spirito,
che lega e completa i dati dei sensi. Ma per Alain, come per Brunschvicg, l’irriducibilità di questo atto va molto oltre: “Il est clair que mon esprit n’est pas un
des rouages de mon corps, ni une partie de l’Univers. Il est le tout de tout”
(Quatre-vingt-un chapitres…, 2a ed. 1921, p. 162 nota sul contesto).
Ma da questo punto di vista lo finalità di Alain non è la deduzione di una metafisica, né la formulazione di una scienza. Esso consiste innanzitutto nella fondazione di un’etica, cioè nel confronto tra il giudizio indipendente dello spirito,
considerato come una forza o un potere, e ciò che gli si oppone nella nostra
esperienza e nella nostra pratica, che Alain determina con il termine generico
di passioni. La finalità dei Quatre-vingt-un chapitres sur l’esprit et les passions
è in tal modo chiaramente delimitato, nell’Introduzione, tra due estremi. È la finalità più semplice e essenziale della filosofia:
27
Toute la force “du philosophe” est dans un ferme jugement, contre la
mort, contre la maladie, contre un rêve, contre une déception. Cette notion de la philosophie est familière à tous et elle suffit20.
28
Ma questa idea semplice ed essenziale ne comprende immediatamente
un’altra. Impossibile infatti attingere questo “giudizio fermo” senza la “conoscenza delle passioni e delle loro “cause”, che implica “une connaissance plus
exacte des choses et du corps humain lui-même, qui réagit continuellement
contre les choses, et presque toujours sans notre permission, par exemple
quand mon cœur bat et que mes mains tremblent”21.
Così stanno le cose in Alain come in Platone, negli stoici o soprattutto (e di
nuovo) Spinoza. La mira etica implica un svolta teorica e per di più sistematica. L’etica non conduce alla felicità se non attraverso la conoscenza del tutto
e del sé. C’è un duplice rischio: credere che siano sufficienti delle massime
pratiche (mentre, al contrario, il loro stesso strumento, il giudizio, implica la conoscenza); e, inversamente, credere che la conoscenza possa valere di per se
stessa senza essere messa in opera dalla pratica. La vera filosofia è nel mezzo; e il suo scopo è chiaramente definito: “Toute connaissance est bonne au
philosophe, autant qu’elle conduit à la sagesse; mais l’objet véritable est toujours une bonne police de l’esprit” (ibid, p. 10).
La finalità non è dunque un approfondimento dello spirito di per sé, né come realtà metafisica né come atto puro o assoluto. Pertanto, il termine “police
de l’esprit”, poi precisato come “police des opinions “ e come “police des moeurs”, può sorprendere. Che vi si veda un tratto rivelatore di colui che sarà il
pensatore del “radicalismo” in Francia o una ripresa della metafora politica dell’anima nella Repubblica (Politeia) di Platone (il che è almeno in parte) l’immagine della “police de l’esprit” non sembra in ogni caso meno ambiziosa o ambigua dei progetti intuitivi o riflessivi di Bergson o Brunschvicg.
Si deve tuttavia andare oltre. Non è sufficiente infatti porre l’esistenza dello
spirito e di ciò che gli si oppone. Né basta cercare di restare sul solo piano pratico criticando sia le tesi metafisiche di Bergson, dietro le quali Alain sospetta
nascondersi un ritorno del religioso22, sia gli sforzi epistemologici di Brunschvicg. Se così stanno le cose, ci si trova di fronte ad un discorso laico su
principi generali di morale.
Ora, ciò che costituisce la specificità di Alain è in realtà la precisione dell’analisi e della classificazione delle “passioni”, che porta metodicamente e persino sistematicamente dalla tesi originaria al suo dispiegamento etico. Questo
è il caso dei Quatre-vingt et un chapitres. Alain vi prospetta in realtà i principi
e la struttura del suo studio delle passioni, che sarà sviluppato dal complesso
delle sue opere successive. Esse hanno tre principi essenziali: il corpo, l’immaginazione, la società o “le cerimonie” – che bisogna conoscere nel dettaglio e
nel loro carattere necessario se si vuole, se non opporvisi, almeno “governarle”. Ciò faranno precisamente i due altri grandi libri che appaiono quasi contemporaneamente, in una sorta di relazione incrociata. In effetti, Mars ou la
guerre jugée non si accontenta di criticare la guerra: si tratta di uno studio sistematico e in un certo senso insuperato delle passioni della guerra, e segna-
Fecondità e limiti del “momento 1900”. Conclusioni e prospettive
Non si può in effetti pretendere che le relazioni appena abbozzate siano
sufficienti, da sole, a costituire interamente un “momento” filosofico. A tal fine
occorrono altre conferme, che costituiranno altrettanti prolungamenti. Evocheremo qui le due conferme principali.
SAGGI
tamente del “potere” come passione. In tale contesto, dunque, non soltanto il
giudizio è giudizio di uno spettatore, ma in qualche modo è anche e soprattutto, nella guerra, l’apice delle passioni, uno sforzo per resistervi. Ma il Système
des beaux-arts, da parte sua, non è un ritorno alla contemplazione e neppure,
alla maniera di Kant, una critica del “giudizio” di gusto, che completerebbe le
ricerche teorica e pratica degli altri libri. In realtà, Alain vede nelle belle arti una
disciplina del corpo, dell’immaginazione o della società, che non ha nulla di
astratto o di esclusivamente “spirituale”. I primi capitoli, sulle fanfare o le parate militari, costituiscono così un legame inatteso ed essenziale tra i libri e sono in ogni punto ammirevoli, mentre, dall’altra parte, la riflessione sull’opera e
sulla necessità di fare, che giungono ad essere delle analisi del lavoro (che
hanno influito decisivamente su Simone Weil) mostrano che l’attestazione del
ruolo dello spirito nell’esperienza non può che essere pratica e concreta. I libri
successivi sugli dei e la natura andranno nello stesso senso.
Così Alain chiude, in un certo senso, ciò che abbiamo chiamato “il momento 1900 in filosofia”, al quale è legato il suo destino. Egli non riuscirà ad evitare, in effetti, le critiche degli anni 30. Ma il suo atteggiamento durante la Prima
Guerra Mondiale, come anche il carattere concreto, descrittivo e sistematico
della sua analisi delle passioni gli varranno un’influenza lungo tutti gli anni 30,
almeno finché il suo “pacifismo” radicale lo condurrà a posizioni controverse
(compresa quella su Munich, nel 1938), senza escludere il fatto che ha finito
per soccombere ad alcune delle “passioni” che aveva saputo criticare23.
Come si può vedere, non si tratta minimamente, sotto il nome di “momento
1900”, dell’unità astratta di un solo e medesimo “spiritualismo”. C’è senz’altro
una unità, ma è l’unità di una questione; ed essa non vale se non attraverso una
diversità costituita da opere specifiche, con la loro quantità di novità e di rischio.
Si intuisce tuttavia in che modo, nella sua stessa costituzione, un tale “momento” includa il rischio di ridursi ad un’immagine precostituita di se stesso,
che porterà ad ulteriori rotture ancora imprevedibili. Esse si annunceranno tanto in maniera negativa che in maniera positiva, attraverso delle polemiche o attraverso delle scoperte, attraverso dei rifiuti o attraverso delle affermazioni. Ma
ciò che in tal modo rischia di restare nascosto è proprio la varietà di cui fin qui
si è passata in rassegna solo una parte, o, anche, la diversità tra filosofi. Per
comprendere in tutta la sua profondità un tale momento filosofico, conviene andare oltre. Bisogna comprendere in che mode esso sia costituito da un lato da
un incontro tra le questioni e le opere filosofiche e, dall’altro lato, dai saperi pratici ad esso contemporanei. Su questo punto, a titolo di semplice prospettiva,
faremo nel seguito del testo delle osservazioni indicative.
29
30
Nessuna delle due, del resto, sarà un’applicazione di risultati acquisiti.
In effetti, la ricerca degli esiti possibili dei dibattiti filosofici finora incontrati
sul terreno della scienza, dell’arte o della politica, non è minimamente scontata. Non può trattarsi di applicare dall’esterno discussioni filosofiche su problemi che trascendono per principio la filosofia. Al contrario, ciò può avere un senso soltanto se la formulazione incontra i dibattiti filosofici dal loro interno, all’interno di opere la cui singolarità dipende proprio da questo. In effetti, come le
grandi opere filosofiche incontrano necessariamente i nuovi problemi scientifici, politici o estetici del loro tempo, così certe grandi opere politiche, scientifiche o estetiche (tutte e per principio? È un altro problema!) incontrano esplicitamente i problemi filosofici del loro tempo. Ciò, del resto, può porre ancora un
altro problema, di lettura o di interpretazione. In effetti, non si può neppure ridurre queste opere a delle tesi filosofiche, come se Proust, quando ha scritto
ciò che innanzitutto è un opera letteraria ed ha in un certo senso scelto la letteratura a detrimento della filosofia, non facesse altro che rispondere a Bergson! Né si può dimenticare la loro dimensione filosofica, come se la critica
dell’intelligenza o la questione metafisica del tempo non entrassero assolutamente nello stesso progetto di Proust! Questa sarebbe allora precisamente
uno dei progressi della stessa idea di “momento”: permettere di comprendere
la specificità di queste opere attraverso una lacerazione determinata in un contesto determinato della teoria e della pratica e, al tempo stesso, attraverso una
precisa posizione nel contesto di un dibattito filosofico determinato che unisce
ed oppone molteplici opere intorno a problemi comuni. A questo proposito, il
momento “1900” appare del resto esemplare in virtù della moltitudine di opere
che testimoniano questo incontro creativo in tutti i campi. Pertanto, anche questa verifica richiederebbe una ricerca nuova e approfondita, della quale potremo dire poco in questa sede.
Un incontro politico, scientifico, estetico: Jaurès, Poincaré, Proust
L’elemento comune che caratterizza, pur nei loro rispettivi campi, Jaurès,
Poincaré o Proust non consiste senz’altro nella fuga, davanti ai cambiamenti
che lacerano i loro ambiti, nella filosofia e segnatamente in un discorso “spiritualista” in un certo senso vago (come spesso è stato rimproverato a Jaurès,
ma anche, come s’è visto, a Proust).
Sorprendentemente, si tratta al contrario di prendere le misure di queste lacerazioni interne e persino di spingerle fino al punto in cui esse riguardano le
cadres e gli atti fondamentali dello spirito, segnatamente a proposito dello spazio e del tempo. Si tratta precisamente di ciò che li costringe a prendere posizione nel dibattito filosofico dei loro contemporanei, ma anche ciò che permette loro, attraverso gli stessi termini di questo dibattito, di rinnovare in profondità la loro pratica, tanto in politica quanto in scienza o letteratura. Potremo qui
dire solo una parola a proposito di questi tre autori che ai nostri occhi sono
esemplari e persino decisivi sotto ogni rispetto.
Si potrebbe in principio essere sorpresi, in effetti, nel constatare che Jaurès
SAGGI
torni alla filosofia quando già aveva portato a compimento un mandato come
deputato e che lo faccia per dedicare la sua tesi alla “realtà del mondo sensibile” e per rifiutare, in essa, la tesi recentemente sostenuta dal suo vecchio collega Bergson. Perché voler assolutamente mostrare che lo spirito non si trova
nella durata interiore dell’io, ma, al contrario, nel rapporto con lo spazio e il
mondo esterno e persino in questo mondo esterno, al punto da difendere una
sorta di panteismo cosmico, al quale si avvicinerà a sua volta lo stesso Bergson? Qual è il rapporto con le crisi sociali e politiche della fine del XIX secolo? Per comprenderlo, bisogna rivolgersi alla seconda tesi di Jaurès (in latino,
beninteso) sulla “origine del socialismo tedesco in Lutero, Kant, Fiche, Hegel”24. La finalità di Jaurès è in effetti quella di mostrare che il socialismo, contrariamente alle apparenze, non soltanto affonda le proprie radici nell’idealismo
tedesco, ma trova addirittura il suo fondamento in un certo determinato idealismo. Ciò non significa che Jaurès neghi il contributo di Marx. Al contrario, la
profonda lacerazione che attraversa la politica del secolo concerne il riconoscimento della priorità di principio delle relazioni materiali ed economiche, della
produzione e del lavoro, tra gli uomini. In tal senso ciò che è lacerato è la stessa idea di un “soggetto” autonomo, lo stesso che è appena nato dalla modernità e dal diritto. Ciò che però Jaurès respinge, anticipando sorprendentemente il Sartre della Critica della ragione dialettica!, è l’idea che queste condizioni
materiali della storia obbediscano a leggi che sono esse stesse materiali o, se
si vuole, naturali, cioè necessarie. Secondo un’espressione scritta su una lavagna nera in occasione di un congresso socialista, “la storia non si fa da sola”. Il socialismo non consiste soltanto (o consiste non soltanto) in una spiegazione scientifica dei rapporti sociali, ma nella prospettiva di un ideale di giustizia che, nei rapporti sociali, è l’equivalente della prospettiva unitaria che opera nella natura e che attesta l’irriducibilità dello spirito. Il legame tra le due facce di questo pensiero appare chiaramente attraverso una sorta di chiasmo: se
nell’ambito della politica bisogna mostrare l’irriducibilità dello spirito e della libertà, allora, nell’ambito della metafisica, bisogna mostrare che questa libertà,
questo spirito, non si realizza se non nel mondo e nella storia e quindi bisogna
respingere l’io bergsoniano, questo “eremita della libertà”, poiché la libertà non
può essere pensata senza la giustizia.
Jaurès è tutto qui: colui che dovrà conciliare i principi formali violati nell’affaire Dreyfus e le rivendicazioni sociali, colui che dovrà pensare la rivoluzione
la giustizia, colui che dovrà pensare L’armée nouvelle e criticare la guerra al
punto di essere assassinato alle soglie del disastro!
Si potrebbe ugualmente essere sorpresi del fatto che Poincaré, che allora
era già al vertice di tutti gli ambiti della scienza del suo tempo, dedicasse del
tempo a scrivere numerosi e capitali contributi e a partecipare a dibattiti polemici sulla Revue de métaphysique et de morale, di cui abbiamo in precedenza
evocato la nascita. Ciò non troverà spiegazione né facendo ricorso all’aneddoto (aveva sposato la sorella di Boutroux, uno dei maestri dell’epoca, al quale
peraltro Jaurès dedica la sua tesi latina), né facendo ricorso ad un’aspirazione
altamente divulgativa. Se Poincaré deve in qualche modo trarre una lezione filosofica da tutti i mutamenti della scienza del suo tempo (per esempio attraver-
31
32
so le geometrie non-euclidee e, presto, le premesse della relatività), al punto
da elaborare le tesi sulla “convenzione” che renderanno possibile la celebrità
talora ambigua de La science et l’hypothèse e delle sue altre raccolte, ciò non
accade per un qualche piacere, foss’anche solo quello del paradosso e della
discussione. Se occorre dimostrare che la scelta di una geometria, che la misura dello spazio e persino del tempo, e addirittura lo spazio e il tempo come
tali, possono risultare da una “convenzione”, essere fondati sulla “comodità” e
non su un accordo a priori con le cose, non è soltanto per lacerare le nostre
certezze ingenue e la scienza costituita, anticipando sul celebre “Newton, scusami” di Einstein. È anche per ricercare quale ruolo preciso che resta allo spirito nella scienza per farla avanzare dall’interno. Così, ciò che scopre Poincaré è che il lavoro dello spirito consiste meno in un accordo con il reale che nella ricerca di una armonia fondata su invarianze che autorizzano delle analogie
apparentemente lontane dal reale. Così, il “convenzionalismo” non è soltanto
una teoria aggiuntiva, e fondamentale, nel dibattito filosofico del momento
1900, accanto, ancora una volta, a quelle di Bergson o di Brunschvicg. Essa è
altresì una tappa decisiva nella stessa ricerca scientifica di Poincaré, come se,
per far avanzare la scienza, occorresse lacerare radicalmente e esplicitamente (per così dire attraverso una riflessione filosofica interna) il ruolo fino ad allora riconosciuto al “soggetto” nella scienza, a rischio di perderlo e poi ritrovarlo, all’interno della scienza stessa, dislocato e trasformato.
La sorpresa più grande, nel caso di Proust, non sta nel fatto che egli difende delle teorie filosofiche nella sua stessa opera letteraria. Ai nostri occhi, essa dipende da tutt’altro. Essa sta nel fatto che l’autore del Contre Sainte-Beuve – questa demolizione radicale di una critica letteraria fondata sulla “psicologia” e sulla biografia dell’“autore”, questa difesa radicale di un’autonomia della
letteratura e dell’arte in generale – sia anche l’autore della Recherche du
temps perdu – che è innanzitutto romanzo della scrittura e libro sul Libro, ma
anche, come indica il suo sottotitolo, ricerca di una verità psicologica ed anche
vitale pura: ricerca, in un certo senso, di sé. Quando Proust scrive che “l’arte
è la vera vita”, bisogna intenderlo in duplice senso: l’arte è la “vera vita”, per
opposizione alla vita, e nella sua stessa perfezione formale; ma l’arte è anche
la vera vita, per eccesso o per intensità vitale e nel suo rapporto alla stessa acme delle nostre esistenze! Ci saranno sempre, nella critica di Proust, queste
due tendenze principali: quella formalista e quella metafisica, quella che insiste sull’autonomia dell’opera (e Proust è in tal senso contemporaneo di Mallarmé) e quella che insiste sull’autonomia dell’opera come esperienza (ed in tal
senso Proust è un contemporaneo di James), senza dimenticare la critica intermedia e filosofica che “paragona” Proust a Bergson o Freud. Ora, ecco cosa ci sembra possibile sostenere: Proust prende in effetti le misure, anticipando in tal modo Foucault (e, inoltre, le critiche di Sartre) della lacerazione prodotta dall’emancipazione del linguaggio. Il “soggetto” non lo controlla né si ritrova in esso come in uno specchio traslucido e manipolabile. Ma ciò che egli
perde con questo falso rapporto al linguaggio è un falso rapporto a se stesso.
Bisogna spingere fino in fondo il rapporto con l’arte e con il linguaggio per ritrovarvi ciò che maggiormente ci sfugge nell’esperienza e nella vita: il “tempo”
Da un momento all’altro: verso una storia
della filosofia francese del XX secolo
Non soltanto ci è stato un “momento 1900” in filosofia, ma questo è stato un
momento determinante per tutta la filosofia francese del XX secolo. La sua costituzione, la sua rottura ed anche le sue riprese lasceranno la loro impronta
su tutto il secolo. Le brevi osservazioni conclusive che seguono devono quindi anche abbozzare delle prospettive per andare oltre.
La questione dello spirito, innanzitutto, lungi dal costituire una parola d’ordine semplicistica, inaugura piuttosto, come si è visto, uno spazio di estreme
tensioni. Non si tratta di rifugiarsi in una metafisica costituita, anche laica o laicizzata, ma al contrario di accentuare ancora il movimento di crisi dell’epoca.
Si deve dunque rimettersi alla libertà imprevedibile, all’evoluzione della vita, al
misticismo? Alla storia della scienza con tutte le sue difficoltà, i suoi ostacoli, le
sue conquiste? Ad una critica “radicale” in tutti gli ambiti? Non si tratta di risvolti facili, non più facili di quanto non siano le posizioni tese di Jaurès, Poincaré
o Proust, evocate in precedenza a titolo di esempio; per non parlare delle
scienze umane, della sociologia di Tarde o Durkheim, per i quali il problema
dello \spirito è centrale da ogni punto di vista. Insomma, se c’è un tale problema dello “spirito”, non si tratta di un rifugio “spiritualista” già precostituito di
SAGGI
stesso. In tal modo, le posizioni filosofiche di Proust sulla memoria o il tempo
non saranno soltanto controversie con Bergson o altri. Esse saranno innanzitutto lo strumento per questa congiunzione inattesa e ultimativa tra le nostre
sensazioni più intime, la madeleine, i pavés, il lutto e “gli annali del bello stile”,
la metafora, la frase, l’opera. Ma inversamente, senza questa questione filosofica o metafisica del “momento 1900”, probabilmente Proust non avrebbe potuto mettere in connessione in maniera così decisiva questi due poli inseparabili, la cui separazione è una mutilazione: l’arte e la vita.
Così, è proprio in opere irriducibilmente specifiche che il “momento” filosofico raggiunge le lacerazioni più profonde e più generali che caratterizzano il
suo tempo. Gli sconvolgimenti appena evocati non mancano in effetti di confermare almeno in parte la diagnosi di un Foucault ne Le parole e le cose: un
accordo apparentemente originario tra l’uomo e il mondo, tra l’uomo e se stesso, si disfa nel corso del XIX secolo. Impossibile accordare facilmente nella figura dell’“uomo” queste due funzioni: un “soggetto” della conoscenza e un oggetto unificato da nuovi saperi; questi ultimi lo disfano dall’interno e fanno
emergere piuttosto nuove forze, vita, lavoro o linguaggio. Ma, a spiegare questi sconvolgimenti, non è una semplice successione tra un accordo che si suppone acquisito e una rottura che si suppone definitiva. Sono piuttosto delle tensioni tra questi poli opposti della esperienza, la ricerca di un accordo, l’esperienza della rottura. È di queste tensioni che testimoniano, intorno al 1900, tanto il “ritorno” del problema generale dello “spirito” quanto le opere particolari (filosofiche e non) che abbiamo evocato in precedenza. Sarebbe questa la nostra prima conclusione, prima di un’ultima serie di osservazioni.
33
34
fronte a dei saperi o delle pratiche che minaccerebbero il “soggetto”. Al contrario, si tratta una intensificazione di questa crisi o di questa stessa divisione di
fronte alla presa di coscienza critica che questi saperi o queste pratiche non
sono più effettivamente scontati, di fronte alla divisione che rischiano di introdurre nell’uomo. Lo “spirito” non sarà qui un fondamento stabile e certo, ma al
contrario una lacerazione profonda nella nostra esperienza che richiama dei
sussulti e delle conversioni inseparabili dalle lacerazioni del secolo!
Ma si vede anche in che modo, in controluce, una piega o un deposito abbia anche potuto prodursi, completando la costituzione del “momento” come
tale. È qui, beninteso, che si dovrebbero reintrodurre le considerazioni, lasciate in sospeso al principio, di ordine ideologico, sociologico ed anche aneddotico. Innanzitutto di ordine ideologico, nella misura in cui il discorso sullo spirito
è in effetti sollecitato da usi politici del resto differenti per una Repubblica ancora fragile, di fronte alle falle rivelate dall’affaire Dreyfus o nei rischi della
guerra. Derrida (precisamente nell’opera sopra citata) ha mostrato che queste
tensioni non erano esterne ma costitutive di qualunque discorso sullo spirito.
Poi, forse soprattutto, di ordine sociologico: tutto si svolge come se il triangolo
Bergson, Brunschvicg, Alain non fosse soltanto teorico ma anche geografico e
istituzionale, con degli aspetti particolarmente stretti e addirittura opprimenti tra
il Collège de France, la Sorbonne et l’Ecole Normale Supérieure, il liceo Henri IV. Tutta una generazione vedrà in questo non un riconoscimento liberatore
della filosofia, ma una ufficializzazione che chiamerà la critica, se non la rivolta (e una dislocazione verso Saint-Germain des prés, ma anche Billancourt).
Non si deve infine dimenticare l’aneddoto nel senso più ampio: lo sfondo, reso
brutalmente desueto dalla guerra, dalle società e dai congressi eruditi, di una
Repubblica degli spiriti che rischia di ripiegare su quella dei banchetti anche
quando i problemi e le opere non cessano tuttavia di circolare. È in tal modo
che un “momento” si irrigidisce; e cessa di essere soltanto quello della filosofia del tournant del secolo in Francia, ma quello molto “1900” della filosofia
“francese”. È così che si rinforzano le figure “nazionali” della filosofia, con tutti
i rischi che ciò comporta.
Tutto ciò contribuisce a spiegare senz’altro la rottura che sopravverrà negli
anni 30, che tuttavia non si può ridurre solo a questi aspetti. Certo, non si comprenderanno i pamphlets di Politzer contro Bergson, di Nizan contro i Chiens
de Garde ed anche di Benda contro La Trahison des clercs, senza questo contesto istituzionale e politico aggravato dalla crisi. Il termine stesso o l’accusa di
“tradimento” costituisce un legame sorprendente tra questi tre autori. Dà il titolo al libro di Benda, impegnato da lungo tempo in una polemica furiosa contro
Bergson; è soprattutto l’ultima parola dei due scritti di Politzer e Nizan! Ma anche in questi testi una critica filosofica appoggia la critica politica. Essa ha per
parola d’ordine il concreto; e sarà rinforzata dalla mirabile raccolta, anch’essa
del 1932, di Jean Wahl: Vers le concret, riedito recentemente25, di cui Sartre dirà l’importanza che ha avuto per lui. Se c’è “tradimento” non è solo perché la
filosofia si è messa al servizio della borghesia o, più in generale, dell’ideologia;
è perché essa ha sbagliato questione: ha trattato dello spirito astratto invece
che della vita concreta degli uomini in tutti i suoi aspetti. Politzer, contro Ber-
SAGGI
gson, si appoggia a Freud di cui offre un’analisi che è capitale tanto in se stessa quanto in virtù della sua influenza; Nizan non fa che rivendicare il marxismo,
lo conosce e lo utilizza con profondità. Sartre aggiungerà a queste novità teoriche sia la sua scoperta, in Germania, della fenomenologia di Husserl e di Heidegger, sia la sua intuizione propria, che trasformerà presto la parola d’ordine
“concreto”, ancora vaga, in un problema preciso: quello dell’esistenza.
Insomma, un momento si chiude, si irrigidisce e inoltre si indebolisce in virtù del suo deposito istituzionale; ma esso arretra davanti al momento successivo solo se la rottura si accompagna anche ad una rottura profonda nei problemi e nei saperi. È questo il caso degli anni 30, la cui portata critica è quindi
decisiva, anche se i grandi libri che annunciano saranno scritti o pubblicati, almeno in Francia, in maniera sorprendentemente concentrata, durante la seconda guerra mondiale.
Tale sarebbe il passaggio da un “momento” all’altro. Si dirà in altra sede come si costituisca il momento dell’“esistenza” (se non dell’esistenzialismo), e
come sarà sostituito a sua volta da quello della struttura, o dello strutturalismo,
intorno al 1960.
È proprio una storia della filosofia francese del XX secolo che, a partire da
ciò che precede, ci sembra possibile e necessaria.
Ma essa non si costituisce che di rotture, benché sia poi costituita, in diversi modi, anche di riprese.
Probabilmente, si tratta innanzitutto di quella delle tensioni iniziali: l’opposizione tra Bergson e Bruschvicg inaugura bene, come indicato, una duplice serie di filiazioni o, meglio, di metamorfosi. Certo, essa non coincide perfettamente con l’opposizione tra “filosofie della coscienza” e “filosofie del concetto”, enigmaticamente formulata da Cavaillès nelle ultime righe del suo scritto principale26, poi ripreso da Canguilhem e Foucault. Ma in un modo o nell’altro, essa attraversa il secolo, sino alla prossimità e alla differenza tra Foucault e Deleuze,
in quel momento, quello degli “anni 60”, che viene a sua volta a rompersi.
Si tratta anche della continuità da un’opera all’altra, pur attraverso le loro
differenze. Merleau-Ponty, ma anche Sartre, non possono più essere compresi senza Bergson; e Bachelard o Cavaillès senza Bruschvicg. L’assenza del
momento 1900 e delle sue grandi figure nella storia del secolo ha costituito, finora o quasi, una grave e incomprensibile lacuna che non mutila solo la storia,
ma anche la filosofia.
C’è infine la ripresa dei problemi. Si deve senz’altro evitare ogni fraintendimento, soprattutto su questo punto. Per esempio, oggi il problema dello “spirito”, nel solco delle scienze cognitive, non ha nulla a che vedere con quello che
abbiamo sopra evocato. Sotto molti riguardi, gli è addirittura opposto: la cognizione inscrive la conoscenza nel vivente e nel cervello, non rimanda ad uno
“spirito” come soggetto e, ancor più, come atto assoluto. È possibile che il problema del momento attuale sia quindi piuttosto quello della vita nei suoi rapporti (relazione e rottura) con la conoscenza, ma anche con l’etica e la politica. L’idea di momento, in ogni caso, sarebbe anche una maniera di pensare,
nella sua differenza e nella sua consistenza, il presente. Ma può anche darsi
che la ripresa del problema dello spirito quale è stato posto, in tutte le sue di-
35
mensioni, nel 1900, permetta, senza confondersi con esso, senza alcun rimando e senza alcuna nostalgia, di non restringere e anzi di dare tutta la sua portata al problema odierno. Cos’è una filosofia che non volesse più comprendere, a partire dalla vita, tanto la particolarità della vita individuale, quanto la posizione di concetti o di norme universali, che non si porrebbe più e che farebbe di tutto per evitare la questione di questo duplice assoluto? Chi prenderebbe le distanze in questo modo dalle esigenze esistenziali e storiche del suo
tempo come anche dal legame con saperi, le arti e la politica?
Ciò è tanto più vero che, se è possibile pensare la filosofia attraverso i suoi
momenti, è probabilmente impossibile pensare qualunque momento, nella storia passata come nel presente, senza la filosofia.
(traduzione dal francese di Francesco Marrone)
36
1 Rinviamo alla paginazione dell’edizione di Bergson nell’edizione tascabile Quadrige (PUF),
riportata a margine dei volumi della Collection du Centenarie (Oeuvres, ed. Robinet, PUF, 1959,
Mélanges, ed. Robinet, PUF, 1972).
2 Al proposito, vedi l’Introduzione alla sua ultima raccolta La pensée et le mouvant (1934), segnatamente la seconda parte.
3 Ne Le Bergsonisme ou la fin d’une parade philosophique (1929), di cui l’intero quarto capitolo “la vraie figure du sage” si scaglia per la prima volta contro questi discorsi. Ciò non toglie nulla
nondimeno all’importanza ed all’influenza del libro.
4 In una magnifica lettera scritta in occasione della messa all’Indice dei libri di Bergson ad opera della Chiesa: “dans la solitude où vous êtes au milieu de tant de bruit” (in BERGSON, Mélanges,
PUF, Paris 1972, pp. 57).
5 “Telle est la méthode que nous préconisons. Encore une fois, elle ne plaira ni aux uns ni aux
autres. On risque à l’appliquer d’être pris entre l’arbre et l’écorce…” (Les deux sources de la morale et de la religion, p. 1201).
6 Abbiamo già sottolineato questo punto in due contributi. Uno edito in Les philosophes et la
science, ed. P. Wagner, Gallimard, coll. Folio essais, 2° ed. 2005; l’altro in Le moment 1900 en philosophie, ed. F. Worms, Presses du Septentrion 2004. Accordiamo quanto sostenuto al proposito
da Alain Badiou nell’ultimo capitolo del suo Deleuze, la clameur de l’être, Hachette, coll. “coup double”, 1997, p. 144: “posons que l’histoire de cette période <à l’échelle du siècle> est commandée
par deux noms propres: Bergson et Brunschvicg”.
7 Rieder 1932, ristampato da Maspero, 1968.
8 Si tratta senz’altro del celebre testo pubblicato nella NRF nel 1939: “Une idée fondamentale
de la phénoménologie de Husserl, l’intériorité” che V. De Coorebyter ha recentemente mostrato
(Vrin, 2003) essere stato scritto nel 1934.
9 Al di là di questi due testi, si faccia riferimento anche a “Partout au nulle part”, la sua introduzione ai Philosophes célèbres edito da Mazenod nel 1955. Testo capitale sotto ogni riguardo, è stato ripreso in Signes del 1961, che noi commentiamo nella nostra riedizione del libro di Mazenod
che uscirà nella collana Livre de poche.
10 Vedi Nabert, L’expérience intérieure de la liberté et autres essais de philosophie morale,
PUF, coll. “philosophie morale”, 1994, che contiene eccellenti saggi su Bergson et Brunschvicg; e
la cosiddetta prefazione di Paul Ricoeur intitolata L’arbre de la philosophie réflexive.
11 Editions de Minuit, 1945: mirabile documento.
12 Non si può non rimandare qui alla Correspondance de Elie Halévy, curata da François Furet per Fayard; la corrispondenza tra Elie e Florence Halévy e Alain era invece stata pubblicata a
parte per Gallimard.
SAGGI
13 “Revue de métaphysique et de morale”, n. 1, études critiques, pp. 86-97, ma vedi soprattutto p. 96.
14 Vi si riscontrerà l’influenza delle Pensées di Pascal, delle quali resta il primo grande editore
moderno (il riferimento è all’edizione Brunschvicg).
15 Les Etapes de la philosophie mathématique (1912), L’Expérience humaine et la causalité
physique (1922), Le Progrès de la conscience dans la philosophie occidentale (1927).
16 La racconta con emozione in Difficile liberté, “une visite chez Léon Bruschvicg”. Un omaggio così intenso anche da parte di Vladimir Jankélévitch, ripreso in Sources, Seuil, 1984.
17 Vedi De l’esprit, Heidegger et la question, ristampato da Flammarion, coll. Champs.
18 Vedi la brochure del 1915: “la philosophie française”, ripresa nei Mélanges, cit.
19 A questo proposito vedi il volume di Renzo Ragghianti, Alain et les débuts de la Revue de
métaphysique et de morale, ed. L’Harmattan, 2004.
20 Op. cit. Paris, 1921, 2° ed., p. 9.
21 Ibid., pp. 9-10.
22 Per una messa a punto recente sulla questione si veda il dossier “Alain e Bergson”, del Bulletin n. 98 dell’Assocoation des amis d’Alain, dicembre 2004. Vedi, in particolare, l’articolo di Thierry Laterre; in cui non sono raccolti tuttavia tutti i testi di Alain su Bergson.
23 Se si vuol capire perché Sartre e Merleau-Ponty parlano dell’antisemitismo, anche nazista,
come di una “passione”, lo si può anche fare senza Alain. La loro relazione con Alain meriterebbe
comunque una ricerca approfondita.
24 Inizialmente riedita nel “Bulletin Jean Jaurès” e, assieme alla tesi principale, in Philosopher
à trente ans, vol. delle Oeuvres complètes, Fayard, 2000.
25 Vrin, 2005, ed. M. Girel.
26 Sulla logica e la teoria della scienza, scritto in prigione durante la guerra e edito postumo da
Canguilhem e Ehresmann. Cavaillé era stato fucilato ad Arras.
37
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
COME ARTE DELL’ASCOLTO*
di Augusto Ponzio
1. Filosofia del linguaggio, semiotica e linguistica
38
La filosofia del linguaggio non può prescindere dal rapporto con le scienze
dei segni e del linguaggio, in particolare dalla due discipline che se ne occupano “in generale”, la semiotica, “scienza”, o “teoria”, “dottrina” generale dei segni, e la linguistica generale.
Un punto di svolta nella storia della semiotica fu segnato nella prima metà
degli anni Sessanta quando Thomas A. Sebeok (1920-2001) estese i confini
della scienza dei segni quale risultava fino ad allora con il nome di “semiologia”. Quest’ultima si basava sul paradigma verbale ed era viziata dall’errore di
scambiare la parte per il tutto. Sebeok chiama questa tendenza nello studio dei
segni la “tradizione minore” contrapponendovi quella “maggiore” per ampiezza
temporale ed estensione tematica, rappresentata da John Locke (1632-1704)
e Charles S. Peirce (1838-1914) e che risale ai primi studi sui segni e sui sintomi (l’antica semeiotica medica) di Ippocrate di Cos (ca 460-377 a C.) e Galeno (129-200 ca. Attraverso numerose pubblicazioni, Sebeok ha fatto valere
una nuova visione della semiotica il cui campo coincide con quello delle scienze della vita, in base all’assunto che tutto ciò che è vita è segno. In seguito all’opera di Sebeok – ampiamente inspirata a Peirce, ma anche a Charles Morris (1901-1979) e a Roman Jakobson (1896-1982), questi ultimi due diretti
maestri di Sebeok – sia la concezione del campo semiotico, sia la concezione
della storia della semiotica sono mutate notevolmente. La semiotica odierna
deve a Sebeok la sua configurazione come “semiotica globale” (Sebeok 2001a
e b). Il virtù di questo approccio “globale” o “olistico” la ricerca semiotica sulla
“vita dei segni” è direttamente interessata anche ai “segni della vita”. Nella prospettiva della semiotica globale, semiosi (cioè la relazione, o processo o situazione in cui qualcosa è segno), e vita coincidono, dato che la semiosi è l’attributo criteriale della vita. Conseguentemente la semiotica globale si presenta
anche come critica delle teoria e delle pratiche semiotiche di tipo antropocentrico e glottocentrico. Estendendosi ben al di là dei segni che gli uomini adoperano per comunicare, oggetto della semiologia di Ferdinand de Saussure
(1857-1913), la semiotica globale include non solo la zoosemiotica (termine introdotto da Sebeok nel 1963) – comprensiva dell’antroposemiotica – e lo studio dei segni degli altri grandi regni (fitosemiotica e micosemiotica) ma anche
la microsemiotica e l’endosemiotica fino a coincidere con la biosemiotica
L’oggetto della semiotica globale, o semiotica della vita (v. Ponzio, Petrilli
2002), è la semiosfera che è fatta coincidere con la biosfera. Il termine “semio-
SAGGI
sfera” è preso da Lotman (1975) ma è inteso da Sebeok in un senso molto più
ampio. Infatti, Jurij M.Lotman (1922-1993) limita il campo di riferimento del termine “semiosfera” alla cultura umana e afferma che fuori della semiosfera così intesa non ci sarebbe comunicazione. Al contrario, nella prospettiva della semiotica globale per la quale la semiosi coincide con la vita, la semiosfera è
identificata con la biosfera, termine coniato dal russo Vladimir Vernadskij
(1863-1945) nel 1926, e intesa quindi come “semiobiosera”. La semiosfera nel
senso di Lotman, limitata alla cultura umana e quindi ai segni verbali e non verbali dei suoi linguaggi, cioè all’antroposemiosi, è solo una porzione limitata della semiobiosfera che invece si estende per tutta la rete dei segni del mondo vivente.
Considerata nell’ambito della semiotica globale, la linguistica generale fa
parte dell’antroposemiotica. Essa ha come oggetto di studio il linguaggio verbale, orale e scritto, esaminato non relativamente ad una lingua particolare e
neppure in qualche particolare genere di discorso o genere letterario, ma negli aspetti essenziali che caratterizzano il modo in cui generalmente si presenta nella lingua. La collocazione della linguistica nella semiotica globale non soltanto è funzionale nella classificazione delle scienze, ma permette anche che
il concetto di segno in generale che la linguistica impiega traendolo da una semiotica generale non sia il risultato di una visione parziale del mondo dei segni. La linguistica descrive tramite il verbale il verbale. Essa usa la lingua per
descrivere la lingua. La lingua si presta a questo doppio ruolo, perché essa
coincide con il descrivibile. Non solo non si sottrae alla descrizione ma la impone. La sua pretesa è che ciò che ha significato coincida con ciò che essa descrive o può descrivere. La sua capacità di descrizione è agevolata dalla sua
possibilità di essere scritta. Ma anche la sua descrivibilità ne è agevolata. Anzi la scrittura (la trascrizione) è già descrizione della lingua.
La linguistica certamente deve impiegare il segno verbale per descrivere il
segno verbale, deve impiegare la lingua per descrivere la lingua. Ma ciò non la
obbliga a restare confinata nel verbale come orizzonte della descrizione. Finché il suo modello di segno resta confinato in tale orizzonte, la linguistica si
presenta come doppiamente descrittiva, perché impiega la lingua anche come
modello oltre che come mezzo. Risulta completamente (idolatricamente) subalterna al suo oggetto. La sua descrizione è l’aderenza della rappresentazione, anziché il distanziamento della raffigurazione. Essa infatti non solo inevitabilmente interpreta il verbale tramite il verbale ma fa del verbale il criterio dell’interpretabilità, riduce ogni significato al significato verbale ogni segno al segno verbale.
La portata interpretativa del segno verbale da parte della linguistica tanto
più aumenta quanto meno è subalterna al segno verbale. Una linguistica basata su una teoria esplicativa e critica del linguaggio non può restare confinata nell’orizzonte della lingua, il suo modello di segno non può coincidere con
quello verbale. La linguistica deve guardare alla lingua da un punto di vista semiotico, che non può essere a sua volta linguistico, come in fin dei conti avviene nella semiologia preconizzata da Saussure, malgrado il suo sforzo di guardare alla linguistica dal punto di vista di una scienza che non si occupa dei se-
39
40
gni e valori verbali, cioè l’economia. Solo una descrizione effettivamente semiotica della lingua permette una descrizione della lingua non glottocentrica,
cioè la sua comprensione a partire da un orizzonte esterno a quello della sua
stessa descrizione, a partire dalla messa in discussione della sua pretesa che
ciò che ha significato e dunque è segno coincida con ciò che essa descrive o
può descrivere, e che il segnico sia assimilabile al verbale.
Anche i linguaggi, siano essi verbali o non verbali si lasciano scrivere (trascrivere) e per lo più si lasciano anche descrivere. La descrizione è agevolata
quando essi siano scritti (trascritti). La descrizione di Roland Barthes (19151980) del linguaggio della moda, per esempio, si avvale del fatto che la moda
è già scritta (trascritta). La possibilità di estendere la linguistica, cioè la descrizione della lingua, dalla lingua ai linguaggi sta alla base della semiologia. Malgrado il suo presentarsi come scienza generale dei segni, la semiologia occupandosi soltanto di linguaggi, cioè di sistemi segnici umani, non solo è in effetti antroposemiotica, ma applica ai segni e ai linguaggi che descrive le categorie elaborate nella descrizione del linguaggio verbale, e quando non vi riesce,
nega il carattere di linguaggio e di segno a ciò che si sottrae alla descrizione.
Sicché già limitata ai linguaggi e non estesa ai sistemi di comunicazione che
non lo sono, la semiologia in quanto estensione della linguistica, delimita ulteriormente la sua ampiezza alla scrivibilità e descrivibilità linguistica dei linguaggi. I linguaggi siano essi verbali o non verbali, si lasciano scrivere (per esempio, la moda è scritta, le musica è scritta, il fumetto è scritto, la fotografia è scritta) ma, a differenza delle lingue, la loro descrizione è difficile, e in certi casi la
loro resistenza è tale che, poiché è la lingua che li descrive, il loro sottrarsi costringe la lingua rivedere i termini e le categorie con le quail descrive se stessa, e ridefinire il modello di segno, secondo il quale individua e descrive il “segno verbale”.
Il linguaggio musicale è forse quello maggiormente refrattario alla descrizione e dunque più capace di evidenziare il limiti del segno verbale e le concezioni dei segno che lo assumono a modello secondo una prospettiva glottocentrica. La musica ha rappresentato fin ora un territorio a sé stante, resistente fino
all’irriducibilità all’inglobamento nella visione generale di ciò che è segno e linguaggio. Il linguaggio della musica si è prestato ben poco ad essere trattato alla stregua di ciò che le scienze dei segni hanno definito come linguaggio. Al
punto che la semiotica della musica non può più prescindere dalla questione
“quale semiotica per la musica?”, disponendosi alla messa in discussione di se
stessa di fronte a questo “linguaggio” refrattario alle proprie categorie.
Una decostruzione e ricostruzione dei modelli semiotici (semiologici) si impone. Al punto che una semiotica della musica non può essere la semiotica applicata alla musica, ma una semiotica che sia della musica, nel senso che le
appartenga, che verifichi la sua possibilità di ricostruzione a partire dalla sua
prospettiva. Si tratta dunque di riconsiderare i concetti stessi di “linguaggio”, di
“significato”, di “segno”, di “interpretazione”, di “comprensione”, di “comunicazione”. Ciò può rendere possibile una riflessione semiotica sulla musica che
consenta il parlarne senza sottometterla al potere del segno verbale e alla semiotica (semiologia) costruita in funzione di esso.
2. Semiotica come metasemiosi e linguaggio come congegno di modellazione
Possiamo aggiungere però un altro significato di semiotica a quello di scienza generale dei segni. Il termine “semiotica” può anche essere usato per indicare la specificità della semiosi umana, dell’impiego dei segni da parte della
specie umana. Sebeok ha precisato questo significato in un testo del 1989 “Semiosis and semiotics: what lies in their future?” (ora cap. 9 del suo libro A Sign
is Just a Sign (1991: 97-99, trad. it. 181-185).
La semiotica è un modo esclusivamente umano di ricercare, che consiste nel riflettere – in maniera informale o sistematica – sulla semiosi. Possiamo predire con sicurezza che tale modalità di ricerca esisterà fino a
quando continuerà ad esistere il genere umano, così come esso si è andato evolvendo per circa tre milioni di anni nelle successive espressioni
di Homo, che – in considerazione, fra gli altri aspetti, della crescente ampiezza del cervello e delle relative capacità cognitive – sono state indicate con i termini habilis, erectus, sapiens, neanderthalensis e, per la fase
attuale, sapiens sapiens. La semiotica, in altre parole, indica semplicemente la tendenza universale della mente umana al fantasticare focalizzato specularmente verso l’interno della propria strategia cognitiva a lungo termine e sui propri comportamenti quotidiani. Locke indicò questo
modo di indagare come ricerca di “conoscenza umana”; Peirce, come
“gioco del fantasticare” (Sebeok 1991: 97, trad. it. 181).
Questo significato di “semiotica” comporta che tale termine indichi una certa tappa dell’evoluzione della semiosi, precisamente quella in cui essa si presenta come specifica semiosi umana. La semiotica così intesa, vale a dire co-
SAGGI
Non stiamo parlando di una questione di semiotica settoriale, speciale. Se
nella musica abbiamo a che fare con linguaggi e segni, si tratta sicuramente
dei segni più refrattari, più resistenti al “parlare dei segni”, più “altri”, e proprio
per questo la semiotica deve, già nel momento della sua costituzione come semiotica generale, tenere conto del problema della possibilità di una semiotica
della musica, anzi partire proprio da esso, perché così può costruire un modello di segno non rigido, non limitato, che non diventi una sorta di letto di Procuste quando venga “applicato” alla musica. Bisogna interrogarsi sulla possibilità di una semiotica della musica, fin dal momento della costituzione di una semiotica generale (v. A. Ponzio e M. Lomuto, Semiotica della musica, 1998). È
necessario verificare, fin dall’inizio, la possibilità di una semiotica della musica,
in cui “della musica” sia un “genitivo soggettivo” e non un “genitivo oggettivo”:
non una semiotica che abbia come oggetto su cui si applica la musica, ma una
semiotica che abbia la musica come suo punto di vista. Una semiotica che al
voler sentire (pratica dell’interrogatorio poliziesco, della commissione d’esame,
del confessionale e della seduta psicoanalitica) sostituisca l’atteggiamento dell’ascolto. Non l’“ascolto applicato” (Barthes, Havas), il voler sentire, il costringere a dire, ma l’ascolto rispondente.
41
42
me semiosi specificamente umana, ci interessa qui particolarmente perché in
questo salto qualitativo nella storia evolutiva della semiosi entra in gioco il linguaggio, inteso però non come capacità di comunicazione ma come capacità
di modellazione specifica della specie umana. Nell’articolo The evolution of semiosis, in Posner et alii (vol. 1, art. 19), Sebeok esamina la corrispondenza tra
le diverse branche della semiotica e i differenti tipi di semiosi, dal mondo dei
microrganismi ai grandi regni e al mondo umano. La caratteristica della semiosi umana o antroposemiosi è la semiotica intesa come riflessione sulla semiosi. È grazie al congegno di modellazione chiamato da Sebeok “linguaggio”, che
è specifico della specie umana fin dall’inizio della sua evoluzione e che è il fattore interno che l’ha resa possibile, l’antroposemiosi si caratterizza come semiotica. Il linguaggio, così inteso, va distinto dal “parlare”, dalla lingua, la cui
funzione originaria era la comunicazione e che non apparve nell’evoluzione
della specie umana se non molto tardi. A quanto pare, l’Homo habilis era dotato di linguaggio ma era privo di parola. Ma si deve presumere che del linguaggio, cioè del congegno di modellazione muto, era già dotato il primo ominide
apparso sulla Terra, in quanto occupante una nicchia specifica nell’evoluzione
delle specie. È il linguaggio che ne ha permesso l’evoluzione fino all’attuale
Homo sapien sapiens Il parlare e quindi la formazione delle lingue segnano il
passaggio all’Homo sapiens.
Nel mondo della vita, che, abbiamo detto, coincide con il mondo della semiosi (v. ivi: 436-37), la semiosi umana specifica si presenta come metasemiosi, cioè come possibilità si riflettere sui segni. Ciò significa che i segni sono impiegati non soltanto in un processo interpretativo che coincide con una determinata risposta diretta, ma anche in una interpretazione che si presenta come
riflessione sui segni, come sospensione della risposta e come possibilità di deliberazione. Con Sebeok, stiamo chiamando questa specifica capacità di metasemiosi, resa possibile dal “linguaggio”, cioè dal congegno di modellazione
proprio della specie umana, “semiotica”. Richiamandoci alla giusta osservazione di Aristotele, che si trova all’inizio della Metafisica, secondo cui l’uomo tende per sua natura alla conoscenza, possiamo dire, e ciò può anche spiegare
meglio che cosa si intende per “conoscenza”, che l’uomo tende per sua natura alla semiotica che (v. Petrilli 1998a). L’uomo è un animale semiotico (v. Deely, Petrilli, Ponzio, Semiotic Animal 2005): il che può anche chiarire il senso di
“animale razionale”.
Dunque, la semiosi umana o antroposemiosi è caratterizzata dal fatto che
essa si presenta come antroposemiotica. Sicché, tornando alle due tendenze
della semiotica intesa come scienza, possiamo dire che la semiotica come antroposemiosi specifica, come semiosi speficamente umana, può: a) avventurarsi per l’intero universo considerandolo dal punto di vista segnico e ricercando in esso significati e sensi; b) assolutizzare l’antroposemiosi identificandola
con l’intera semiosi, cioè considerandola erroneamente l’unica semiosi possibile.
La semiotica come scienza generale dei segni seguendo il primo orientamento costruisce i suoi modelli sulla base di una “semiotica globale” estensibile all’intero universo in quanto perfuso di segni (Peirce); seguendo il secondo,
3. Modellazione, comunicazione e dialogo
Dobbiamo chiarire qui due nozioni, secondo noi fondamentali in semiotica
e tra loro collegate: modellazione e dialogismo. Senza di esse non si può comprendere una terza nozione, generalmente privilegiata nello studio dei segni a
scapito delle altre due, quella di comunicazione.
Il concetto di modellazione è ripreso dalla cosiddetta scuola di Mosca-Tartu v. Lucid 1977 and Rudy 1986) che lo usano per riferirsi alla lingua, considerata “sistema primario di modellazione”, e agli altri sistemi culturali umani considerati “sistemi secondari di modellazione”. Però noi impieghiamo “modellazione” secondo l’uso che ne fa Sebeok, il quale estende tale concetto oltre
l’ambito dell’antroposemiosi collegando a quello di Umwelt (mondo circostante) del biologo Jakob von Uexküll (1864-1944). Nell’interpretazione di Sebeok,
Umwelt significa “modello del mondo esterno”. Sulla base delle ricerche in biosemiotica, sappiamo che la capacità di modellazione può essere osservata in
tutte le forme di vita. La “teoria dei sistemi di modellazione” (Modeling systems
theory) recentemente riformulata da Sebeok in collaborazione con Marcel Danesi (Sebeok, Danesi 2000) studia appunto i fenomeni semiotici come processi di modellazione. Alla luce della semiotica orientata nel senso della teoria dei
sistemi di modellazione, la semiosi – capacità caratterizzante tutte le forme di
vita – può essere definita come “la capacità delle specie di produrre e comprendere gli specifici tipi di modelli di cui dispongono per organizzare e codificare l’imput percettivo nel modo proprio di ciascuna di essi ” (ivi: 5).
Lo studio applicato della teoria dei sistemi di modellazione è l’“analisi dei sistemi” (systems analysis), che distingue i sistemi di modellazione in primario,
secondario e terziario. sistema di modellazione primario è la capacità innata di
modellazione simulativa, cioè un sistema che permette a tutti gli organismi di
simulare un mondo secondo modalità specie-specifice.(cfr. ivi: 44-45). Come
abbiamo detto, Sebeok introduce il termine “linguaggio” per indicare il sistema
specie specifico della modellazione primaria della specie Homo. Non la lingua,
come sostiene la scuola di Mosca-Tartu, ma il linguaggio è il sistema primario
di modellazione. La lingua, che comparirà abbastanza tardi nell’evoluzione
umana, è invece sistema secondario di modellazione. Sicché, conseguentemente, i sistemi segnici culturali che presuppongono la lingua sono terziari. La
modellazione secondaria sottende processi di modellazione sia indicazionali,
sia estensionali. La forma di modellazione indicazionale è stata registrata in
varie specie viventi: mentre quella estensionale è una capacità unicamente
umana poiché presuppone il linguaggio (sistema primario di modellazione proprio soltanto dell’uomo), che, come abbiamo visto, Sebeok distingue dal parlare, dalla lingua; che è un sistema di modellazione secondario (v. ivi: cf. 82-95).
Il sistema terziario di modellazione è quello che sta alla base di processi alta-
SAGGI
invece, li costruisce sulla base della riduzione dei segni a quelli della vita sociale umana (semiologia), parteggiando così per una visione chiaramente antropocentrica.
43
44
mente astratti di modellazione di tipo simbolico (cf. ivi: 120-129) che presuppongono, oltre al linguaggio, anche la lingua.
La comunicazione presuppone la modellazione, poiché si realizza all’interno del mondo che essa produce. Certamente i sistemi di modellazione sono a
loro volta il risultato della comunicazione della specie, nella sua evoluzione, e
l’ambiente entro cui la modellazione si produce per adattamento. Ma tale comunicazione avviene pur sempre sulla base della modellazione di cui la specie, in quanto appartenente a una nicchia particolare, è già dotata. Per esempio, il linguaggio come sistema specie specifico della specie Homo, e quindi
già in dotazione dell’ominide, presiede alla comunicazione con l’ambiente in
rapporto alla quale, per adattamento, ma necessariamente secondo il suo specifico sistema di modellazione (che gli assegna, fin dal suo primo apparire, una
nicchia particolare rispetto alle altre specie, per quanta vicinanza per omologia
possa presentare con esse), si evolverà fino all’Homo sapiens sapiens.
Per “dialogo” si intende il modo secondo cui un organismo nella sua Umwelt specifica è in relazione con l’organico intraspecifico e extraspecifico e con
l’inorganico. La semiosi ha in generale un carattere dialogico. La nozione di
“dialogicità” non contraddice, ma anzi affianca e conferma quelle che insistono
sull’autonomia dell’organismo vivente, quali il “ciclo funzionale” di Th. Uexküll
e l’“autopoiesi” di Maturana e Varela (1980). Inoltre il dialogo va distinto dalla
comunicazione. La comunicazione è solo un aspetto della semiosi. Gli altri due
sono la modellazione e il dialogità. Il carattere dialogico della semiosi verbale,
la sua funzione modellizante e comunicativa, sono caratterizzazioni umane
specie-specifiche che si ritrovano nella semiosi in generale di qualsiasi essere
vivente. La dialogità non riguarda soltanto il ragionamento e non è circoscritta
all’antroposemiosi. La relazione tra interpretato e interpretante in cui consiste
ogni semiosi è dialogica. Peirce stesso ha insistito su questo aspetto. Ma chi
soprattutto ha evidenziato la natura dialogica del segno e della semiosi è Michail Bachtin (1895-1975). Alla dialogità della parola, espressa nel romanzo
polifonico di Dostoevskij (Bachtin 1929), corrisponde la dialogicità, l’intercorporeità, del corpo grottesco quale si rivela nel “realismo grottesco” descritto da
Bachtin (1965) nella sua analisi di Gargantua e Pantaguel di François Rabelais. Dialogicità e intercorporeità sono le facce di una stessa medaglia, fanno
parte della reale, materiale, interconnessione biosemiotica dei corpi viventi. “La
vita per sua natura è dialogica. Vivere significa partecipare a un dialogo” (Bachtin, “Piano per il rifacimento del libro su Dostoevskij”, 1961, in Bachtin 1979,
trad. it.: 331). Possiamo parlare di una dia-logica bachtiniana, che più volte, fin
dal Dostoevskij del 1929, viene esplicitamente o implicitamente contrapposta
alla dialettica hegeliana e al materialismo dialettico del socialismo reale. C’è alla base della concezione bachtiniana una dialogica della natura, una dialogica
della vita, che oggi verrebbe espressa in termini di “biosemiotica” e che spiega l’interessamento di Bachtin per gli studi di biologia della sua epoca.
Nella visione di Bachtin non ci sono limiti definiti della dialogità verbale e di
quella intercorporea. La prima si estende, travalicando divisioni anche nazionali e linguistiche, a quell’intero ambito Lotman chiamava “semiosfera”; la seconda si estende per tutta la “biosfera” (Vernadskij). Per Bachtin il dialogo e il
4. L’origine del linguaggio
La questione dell’origine del linguaggio verbale è stata generalmente sottovalutata dalla comunità scientifica come non degna di discussione a causa delle soluzioni gratuite e infondate a cui essa ha dato luogo (una delle eccezioni
sotto questo riguardo è costituita dal libro di Giorgio Fano (1885-1963), Origini e natura del linguaggio (1972), ormai noto anche in traduzione inglese.
Sulla base degli studi più recenti, il problema dell’origine del linguaggio verbale può essere ripreso ed esaminato in tutta la sua complessità. Una delle
proposte più sistematiche di utilizzazione di tali studi proviene da Sebeok, che
ha attribuito il carattere specie-specifico del linguaggio verbale, del parlare
(speech), al fatto di essere basato sul sistema primario di modellazione dell’uomo, che egli ha chiamato “linguaggio” (language), e quindi ne ha spiegato la
comparsa, a un certo punto dell’evoluzione della specie umana, sulla base di
un processo di adattamento regolato dal linguaggio come modellazione. Conseguentemente, a più riprese, Sebeok è intervenuto polemicamente e ironicamente a raffreddare l’entusiasmo nei confronti delle teorie e delle pratiche di
addestramento, in voga particolarmente negli Stati Uniti, fondate sulla possibilità di “animali parlanti”.
Secondo la teoria della modellazione di Sebeok, il sistema primario di modellazione della specie Homo, “il linguaggio”, da non confondere con il linguaggio verbale, con il parlare, è apparso e si evoluto per adattamento molto prima
di quest’ultimo, che non appare, nel corso dell’evoluzione della specie umana,
SAGGI
corpo sono strettamente interconnessi, e l’adeguata immagine del corpo dialogico è il corpo grottesco. È per questo che il grottesco compare anche nel genere romanzo, genere letterario maggiormente dialogico, e particolarmente nel
“romanzo polifonico” di Dostoevskij. Ed è per questo che Bachtin, nella seconda edizione del 1963 (la prima è del 1929) della sua monografia su Dostoevskij, include un capitolo (il IV) sul rapporto tra il genere romanzo e il realismo
grottesco del folclore carnevalesco, mostrando come tale genere affondi nella
visione del realismo grottesco le proprie radici. Dunque, il dialogo non esiste
soltanto nella semiosi della comunicazione dove l’interpretato è già esso stesso una risposta interpretante rivolta ad essere interpretata come segno prima
ancora di esserlo effettivamente da parte di un interpretante esterno, Ma il dialogo sussiste anche nella semiosi della sintomatizzazione, dove l’interpretato è
una risposta interpretante (sintomo) non rivolta ad essere interpretata; così come sussiste nella semiosi dell’informazione, dove qualcosa di inanimato agisce come segno solo perché riceve un’interpretazione da parte di un essere vivente: tale interpretazione, la risposta dell’interprete, ha pur sempre un carattere dialogico. Il dialogo non inizia con il comportamento segnalizzante di un
emittente che intende comunicare qualcosa a un ricevente a proposito di un
oggetto. L’intera semiosi è un processo dialogico. La logica della semiosi nel
suo insieme, come tutto unitario, è una dia-logica. L’interpretante come tale è
“una disposizione a rispondere”.
45
46
se non con l’apparizione dell’Homo sapiens e con una funzione specificamente comunicativa. Il linguaggio nel senso di Sebeok, non nacque, invece, come
congegno comunicativo, ma come congegno di modellazione. Anche Noam
Chomsky ha sostenuto il carattere non essenzialmente comunicativo del linguaggio, ma dicendo “linguaggio” Chomsky vuol dire “linguaggio verbale”,
“parlare”, ciò che Sebeok chiama “speechi. Per Sebeok invece il linguaggio
verbale ha, fin dalla sua apparizione per adattamento, una specifica funzione
comunicativa. La teoria del linguaggio verbale di Chomsky non conosce la differenza stabilita da Sebeok tra “linguaggio” e “linguaggio verbale”, e senza
questa differenza non è possibile spiegare adeguatamente né l’origine, né il
funzionamento del linguaggio verbale.
Come abbiamo detto, il linguaggio, come qui viene inteso, è un congegno
di modellazione (modeling device) di cui era già dotato, anche se certamente
in maniera non sviluppata, il primo ominide ed è questa originaria “dotazione”
della specie umana a spiegarne lo sviluppo fino all’Homo sapiens sapiens (v.
Sebeok, Language as a Primary Modeling System?”, in Sebeok 1994: 117128). Anche gli altri animali hanno un sistema di modellazione che produce il
loro mondo; il linguaggio è quello dell’uomo. Ma il congegno di modellazione
dell’uomo è completamente differente dagli altri sistemi primari di modellazione. La sua caratteristica specifica è ciò che Peirce chiamava “il gioco del fantasticare” (quest’espressione è utilizzata da Sebeok come titolo di uno dei suoi
libri) e che Giambattista Vico (1668-1744) chiamava “logica poetica” (v. Danesi 2000), cioè la possibilità di produrre più modelli e dunque, per usare l’espressione di G. W. Leibniz (1646-1716), di inventare, di simulare, un numero infinito di “mondi possibili”, diversamente dagli altri animali altre specie animali.
Il parlare, come il linguaggio, è apparso anch’esso per adattamento, ma con
funzione comunicativa, e molto tempo dopo rispetto al linguaggio, precisamente con la comparsa dell’Homo sapiens. Nel corso dell’evoluzione della specie
umana, per un processo di “ex-attamento” (exaptation: questa espressione è
di S. J. Gould e E. S. Vrba 1982), come il linguaggio potenziò le funzioni comunicative tramite l’invenzione del parlare, così quest’ultimo potenziò quelle
del linguaggio svolgendo anche una funzione modellizzante in ciascuna delle
molteplici lingue in cui si andò realizzando. Il linguaggio è il primario adattamento evolutivo che caratterizzò l’ominide. Il linguaggio verbale, il parlare, si
sviluppò con funzioni comunicative dal linguaggio come dispositivo modellizzante, in seguito all’evoluzione delle capacità fisiche e neurologiche che resero possibile l’impiego del linguaggio per la comunicazione vocale. Exattato per
la comunicazione verbale, prima nella forma di linguaggio verbale orale e poi
di linguaggio verbale scritto, il linguaggio come congegno di modellazione primaria permise anche il rafforzamento delle capacità umane di comunicazione
non-verbale dando luogo a un ampio e complesso sviluppo dei linguaggi nonverbali (v. Nonverbal bodily sign categories, di Fernando Poyatos, in P. Bouissac 1998: 451-453). Il parlare, a sua volta, exattato per la modellazione, poté
funzionare, in quanto lingua, come sistema secondario di modellazione. In tal
modo, il parlare, oltre a incrementare la capacità di comunicazione e potenziare quelle dei linguaggi non-verbali favorendone anche la specializzazione e
SAGGI
proliferazione, sviluppò la capacità semiotica dell’uomo sul piano conoscitivo,
organizzativo, inventivo, ecc.
Circa la relazione tra linguaggio e parlare, Sebeok fa notare che essa ha richiesto un reciproco adeguamento della capacità di codificazione e decodificazione. Fra il linguaggio “exattato” per la comunicazione, prima in funzione del
parlare orale, “for ear and mouth work” e poi nello scritto e in altre forme di comunicazione, e il verbale exattato per la modellazione (secondaria), “for mind
work”, resta un risultato ancora distante un’assoluta reciproca adeguazione, e
la collaborazione tra i due sistemi è ancora in corso di perfezionamento (cfr.
Sebeok 1991a: 56). Osserva Sebeok:
Per quanto concerne il motivo per cui questo processo di exattamento
impiegò diversi milioni di anni per realizzarsi, la risposta sembra essere
che l’adeguamento di un meccanismo specie-specifico per codificare il
linguaggio in parlare, cioè producendo segni vocalmente, con un complementare meccanismo per decodificarlo, cioè ricevere e interpretare un
flusso di segni verbali/vocali (frasi), deve aver impiegato tanto tempo per
poter realizzare un processo di sintonizzazione, che è lungi dall’essere
completo (dato che gli individui umani hanno molte difficoltà nel comprendere messaggi verbali che si trasmettono l’un l’altro) (in Posner et alii, vol.
1: 443-444; in Sebeok 1991, trad. it.: 178).
Bisogna a questo punto segnalare un altro processo di exattazione nell’evoluzione dell’altroposemiosi. Ci riferiamo alla separazione tra “lavoro manuale”
e “lavoro intellettuale”, che si presenta – per usare la terminologia di Ferruccio
Rossi-Landi (1921-1985) – come separazione tra “lavoro non linguistico (verbale)” e “lavoro linguistico (verbale)”. Soltanto molto recentemente, come risultato dello sviluppo tecnologico, in cui la comunicazione è diventata produttiva
(nella fase attuale della produzione capitalistica che può essere indicata come
fase della comunicazione-produzione: v. Ponzio 1997d, 1999b, 2003a) questi
due tipi di lavoro si sono incontrati e unificati. Il computer come unità dell’hardware e del software è l’espressione più evidente di questo adeguamento che
tende all’unificazione.
5. Il linguaggio come lavoro
Abbiamo visto che Sebeok pone il linguaggio come congegno di modellazione alla base dell’“ear and mouth work” e del “mind work”.
Una teoria del linguaggio come lavoro fu elaborata da Ferruccio Rossi-Landi (1921-1985) a partire dai suoi scritti degli anni Sessanta. Questa teoria è lo
sviluppo della sua precedente concezione del linguaggio come “parlare comune” (v. Rossi-Landi 1998 [1961], cioè come insieme di operazioni comuni che
stanno alla base delle diverse lingue. In entrambi i casi si tratta di passare da
un livello superficiale di osservazione, – sia esso quello della descrizione del
comportamento linguistico (comportamentismo), o dell’uso linguistico (Wittgenstein), o del linguaggio ordinario (filosofia oxoniense), o dello “stato di una
47
48
lingua determinata” (Saussure), o dell’analisi tassonomica (Martinet), o della
“visione del mondo” di una lingua determinata (secondo la cosiddetta “teoria
della relatività linguistica” (Sapir e Whorf) – al livello della esplicitazione delle
strutture e dei processi di cui il parlare e le lingue sono il prodotto.
Si tratta della questione del superamento delle teorie del linguaggio di tipo
descrittivistico, ma anche della teoria chomskiana, che, pur orientata in senso
esplicativo e generativo, ritiene di dover descrivere una grammatica universale innata, che è in effetti il risultato dell’ipostatizzazione della stessa lingua che
dovrebbe spiegare (a causa del carattere unigraduale di tale teoria, che confonde, secondo la terminologia di Sebastian K. Faumian (1965) “genotipico” e
“fenotipico”).
Usando la terminologia ripresa dalla critica di Karl Marx all’economia politica, Rossi-Landi imposta il problema come necessità di uno spostamento dello
studio del linguaggio verbale dal livello del mercato linguistico a quello del lavoro linguistico. Tali espressioni sono evidentemente metaforiche. Ma lo sono
non come effetto di superficiali analogie bensì sulla base di omologie individuate, attraverso un metodo omologico rivolto a studiare somiglianze di ordine
strutturale e genetico tra produzione linguistica verbale e produzione materiale in quanto facenti parte di uno stesso processo semiotico, quello della riproduzione sociale, della riproduzione della vita sociale umana. Possiamo dire
che il passagio dal suo libro del 1961, Significato comunicazione e parlare comune, a quello del 1985, Metodica filosofica e scienza dei segni(nuova ed.
2006).è il passaggio da una metodica del parlare comune a una metodica della semiosi comune che sta alla base dei sistemi segnici e dei messaggi verbali e non-verbali di cui è fatta un’intera organizzazione economico-culturale. Una
teoria generale della società, che riesca a cogliere i nessi strutturali e generici
al di là delle separazioni e settorializzazioni di ordine storico-sociale, ideologico, o relative allo specialismo scientifico, viene a coincidere con una semiotica
generale, dato che “l’uomo comunica con tutta la sua organizzazione sociale”
(Rossi-Landi 2003a [1968]: 196).
Non esistono divisioni “naturali” che ci costringano ad allocare in regioni separate il lavoro verbale e il lavoro non-verbale, la produzione di messaggi verbali e la produzione di merci, in quanto, in entrambi i casi, si tratta di uno stesso tipo di semiosi, si tratta – potremmo dire stabilendo un collegamento tra il
concetto di “lavoro” di Rossi-Landi e quello di “modellazione” di Sebeok – del
risultato dello stesso lavoro linguistico di modellazione Perciò lo studio di uno
dei sistemi segnici della complessiva cultura umana, della complessiva riproduzione sociale, si può rivelare utile per lo studio di un altro: “perché studiando l’uno o l’altro sistema, si studia fondamentalmente la stessa cosa (ivi: 111).
Sia che si tratti di merci, sia che si tratti di messaggi verbali, sia che si tratti della produzione e dello scambio di oggetti, sia che si tratti della produzione e dello scambio di segni, la semiotica ha a che fare con la stessa problematica,
quella del lavoro che li produce e che rende possibile lo scambio. Ciò trova piena conferma nella fase attuale dello sviluppo del capitalismo (prevista ma non
direttamente vissuta da Rossi-Landi) che possiamo indicare come fase della
globalizzazione o della comunicazione-produzione, in cui la comunicazione è
Si può salire lungo quello che io ho chiamato “schema omologico della
produzione”, fino a un certo punto, dove accade una cosa impressionante, e cioè che le due produzioni confluiscono. Questa è una cosa degli ultimi pochi decenni: perché nella produzione di computer confluiscono un
hardware, nel linguaggio dei tecnici, cioè un corpo materiale, la materia
elaborata di cui è costituito il computer, e un software, cioè un programma, un insieme di rapporti logici esprimibili verbalmente. Quindi il non-linguistico, l’oggettuale, e il linguistico ad altissimo livello di elaborazione sono confluiti l’uno nell’altro quasi sotto i nostri occhi, ma anche quasi soltanto sotto gli occhi delle persone più giovani (Rossi-Landi 1985b: 171).
Un esempio dell’applicazione degli schemi concettuali elaborati nello studio
del segnico-verbale al segnico non-verbale è offerto da Claude Lévi-Strauss
(1949, 1958), il quale si serve delle categorie della linguistica, in particolare
della fonologia, nello studio delle regole di matrimonio e dei sistemi di parentela. Rossi-Landi tenta il procedimento opposto: cioè far valere nello studio del
linguaggio verbale, strumenti concettuali elaborati nello studio del segnico nonverbale, quello della produzione e dello scambio economico, servendosi delle
categorie della scienza economica.
Lo stesso Saussurre aveva assunto a modello l’economia nello studio del
valore linguistico, ma si era avvalso dell’“economia pura”, di tipo marginalistico, della scuola di Losanna (L. Walras, V. Pareto), che limitava il proprio studio
al livello del mercato. Per Rossi-Landi si tratta invece di passare dal livello del
mercato linguistico a quello della produzione linguistica; e a tal fine riprende le
categorie dell’economia politica nella sua fase classica, ricardiano-marxiana.
Il concetto di lavoro linguistico è il terzo elemento, quello fondante, di cui la
dicotomia saussuriana di “langue” e parole” non tiene conto. In Saussure “langage” è un concetto non sufficientemente approfondito, perché esso è inteso
sia come il “materiale concreto etorogeneo” su cui la linguistica ritaglia il suo
“oggetto astratto” di langue, sia l’unità di langue e parole, sia la “facoltà” del
parlare. Per Rossi-Landi il “linguaggio”, inteso come “lavoro”, è ciò di cui le lingue sono il prodotto ed è ciò che le riattiva e rivalorizza nella “parole”, che è individuale solo perché è individuale la singola lavorazione, ma il “modello della
lavorazione è sociale”(2003 [1968]: 68). Ciò rende accostabile, secondo noi, il
SAGGI
divenuta pervasiva e non solo risulta che le merci sono messaggi, ma che i
messaggi sono stessi sono a loro volta merci, e in cui la comunicazione occupa, nel ciclo produttivo, non solo il posto intermedio, quello dello scambio o circolazione o mercato, ma è presente ed essenziale dei due estremi, quello iniziale e quello finale, della produzione e del consumo (v. Ponzio 1999b, 2002a,
3003a).
Rossi-Landi, negli ultimi anni della sua vita, si rese conto della sempre maggiore convergenza di produzione materiale e produzione linguistica, da lui studiate nei loro rapporti omologici quando erano ben distinte nella organizzazione sociale capitalistica, caratterizzata ancora dalla netta separazione netta tra
lavoro materiale e lavoro intellettuale. In un seminario svoltosi a Bari nell’aprile del 1985, a un mese dalla sua morte, Rossi-Landi faceva notare che
49
concetto di “linguaggio come lavoro” a quello, proposto da Sebeok, di linguaggio come “modellazione primaria”. Scrive infatti Rossi-Landi:
[…] il lavoro linguistico sta dalla parte del langage in quanto si oppone sia
alla parole perché collettivo anziché individuale, sia alla langue perché lavoro anziché prodotto. Facendo del langage la mera unità di langue e parole, ci si preclude lo studio delle tecniche collettive e comunitarie del linguaggio. Alla bipartizione tra lingua e parlare si deve sostituire una tripartizione: il lavoro linguistico (collettivo) produce la lingua (collettiva) su cui
e con cui si esercita il parlare dei singoli, i cui prodotti rifluiscono nello
stesso serbatoio da cui ne sono stati attinti materiali e strumenti (ivi: 69).
50
Rossi-Landi parla di “lavoro linguistico” per caratterizzare il linguaggio verbale come semiosi specifica dell’uomo, che consiste nell’uso mediato dei segni, dove ciò che media, come in qualsiasi produzione umana di artefatti, è “lavoro”, come Hegel prima di Marx aveva già notato. Rossi-Landi contrappone
lavoro ad attività. Possiamo dire che, rispetto all’attività dell’interpretazione semiosica riscontrabile in qualsiasi essere vivente ed anche nell’uomo soprattutto a livello endosemiosico, il lavoro linguistico è interpretazione semiotica. È
produzione di segni attraverso l’elaborazione di segni impiegati come materiali, tramite segni impiegati come strumenti, in base a modelli essi stessi risultato di precedenti produzione segniche.
L’espressione “lavoro linguistico” fa pensare a un processo che si realizza
in base alla consapevolezza di chi lo effettua. In realtà, anche in considerazione della nozione “lavoro alienato” impiegata da Marx (anche questa sulla scorta di Hegel) e alla nozione di “lavoro onirico” impiegata da Sigmund Freud, non
c’è nessun rapporto di connessione necessaria tra “lavoro” e “consapevolezza” (v. Rossi-Landi 1985a: 7). Lo sviluppo della capacità di interpretazione semiotica dell’uomo consiste anche nel promuovere lo sviluppo della consapevolezza riguardo al lavoro linguistico e a quello non linguistico attraverso la conoscenza e il controllo dei programmi, delle programmazioni e delle progettazioni della loro erogazione.
A causa del lavoro mercificato e alienato della nostra forma sociale “lavoro”
nell’espressione “lavoro linguistico” fa pensare a qualcosa di contrapposto rispetto all’“attività ludica” e dunque può far apparire come in contrasto il “lavoro linguistico” con “il gioco del fantasticare” di cui parla Peirce e a cui Sebeok
si richiama per caratterizzare l’uomo come animale semiotico e per riferirsi alla sua modellazione primaria specifica, quella del “linguaggio”. In realtà “lavoro” non è contrapposto ad “attività ludica”, perché anche le “attività ludiche” richiedono un preliminare lavoro di preparazione e un lavoro di esecuzione, e
perché esistono lavori particolarmente piacevoli e addirittura ludici. “Non esistono distinzioni a taglio netto”, afferma Rossi-Landi, e se è possibile individuare due zone estreme e in cui situare ciò che è “lavoro” e ciò che non lo è, c’è
anche un’ampia zona intermedia “in cui le determinanti delle due zone estreme si sovrappongono o intrecciano” (Rossi-Landi 1985: 11).
Ciò che la teoria linguistica di Chomsky non riesce a spiegare è la molteplicità delle lingue, che, per giunta, contrasta con l’ipotesi dell’unicità della grammatica universale innata.
Il plurilinguismo non consiste soltanto nella molteplicità delle lingue ma anche nella molteplicità dei linguaggi all’interno di una stessa lingua. Anche di
quest’altra molteplicità si disinteressa la linguistica chomskiana che considera
la lingua come un unico e unitario codice. La pluralità delle lingue e il prurilinguismo interno a ogni lingua non possono essere spiegate dalla linguistica di
Chomsky, perché, se da una parte essa insiste sul “carattere creativo del linguaggio”, con “linguaggio” intende unicamente il linguaggio verbale, e, d’altra,
resta ancorata al presupposto che il linguaggio verbale, a qualsiasi lingua appartenga e a qualsiasi grammatica particolare ubbidisca, abbia una sua grammatica universale, concepita con le stesse caratteristiche e componenti (fonologico, sintattico, semantico) delle grammatiche particolari, alle cui leggi possono essere ricondotte tutte quelle delle grammatiche particolari delle diverse
lingue. Dati i suoi presupposti, la linguistica chomskiana non riesce ad affrontare l’“enigma di Babele”.
Il plurilinguismo non consiste soltanto nel fatto che i linguaggi verbali e le
lingue umane sono molteplici e non riconducibili ad un unico sistema univoco
ed onnicomprensivo che possa soppiantarli tutti, oppure che possa fungere da
modello per lo studio, comprensione e caratterizzazioe teorica degli altri. Il plurilinguismo è anche dato dal fatto che ogni lingua e ogni linguaggio vive di rapporti diretti o indiretti, impliciti o espliciti con altre lingue e altri linguaggi, ai cui
segni rinvia, non fosse altro che come possibili interpretanti tramite i quali si costituisce, si determina, si approfondisce, si trasforma il significato dei suoi termini. Ha insomma con essi rapporti di traduzione ma anche di derivazione, di
reciproco completamento, di comune inserimento nel linguaggio complessivo
di una determinata cultura, ecc.
Le lingue si formano e si sviluppano attraverso reciproco rapporti di interazione, di scambio; ciascuna di esse ha origine nella vita di un’altra lingua, nelle sue suddivisioni interne e stratificazioni, nella dialettica interna dei suoi linguaggi e in quella esterna dei rapporti con altre lingue, ecc. Quanto più complessa diventa una lingua, per capacità espressive, per specificazione e specializzazione terminologica, per estensione semantico-ideologica, per arricchimento dei suoi linguaggi e generi discorsuali, tanto più ciò è indicativo della
sua partecipazione alla vita linguistica di altri sistemi verbali.
Fra coloro che maggiormente hanno contribuito alla considerazione dell’importanza del plurilinguismo nella vita di una lingua e in generale di ogni sistema
segnico culturale – ma più attraverso la loro “riscoperta” assai recente, che attraverso la diretta diffusione delle loro idee nello stesso periodo in cui le produssero e scrissero – si possono ricordare Bachtin (che direttamente si è occupato di questo problema facendosi sostenitore di una concezione polilogica e plurilinguistica in un periodo e in un ambiente politico culturale dominato dall’imposizione di una visione meccanicistica e monolinguistica, quale quella stalinista)
SAGGI
6. L’enigma di Babele
51
52
e Peirce. Quest’ultimo indirettamente ha contribuito con la sua teoria della “fuga illimitata degli interpretanti” a far comprendere il carattere vitale, per la lingua, del plurilinguismo interno ed esterno ad essa, indicando la necessità del
rapporto del segno, perché esso sia tale, con altri segni che lo interpretano e ne
determinano volta per volta il significato in relazioni dinamiche e aperte, di tipo
tanto endolinguistico quanto interlinguistico. In Italia un’anticipazione della concezione della essenzialità del plurilinguismo può essere trovata in Giacomo
Leopardi (1798-1837), caso forse unico, e non solo italiano, rispetto al periodo
in cui visse (v. Ponzio 2001: 67-80). Troviamo in Leopardi, più volte ripresa ed
esplicitamente esposta, ma presente anche come posizione di fondo delle sue
riflessioni sulla lingua, la concezione secondo la quale il plurilinguismo, sia
esterno sia interno a una lingua, è un fattore necessario e costitutivo di essa.
Leopardi si distacca da quelle tendenze filosofico-linguistiche che, come si
esprime Bachtin (1975), conoscono soltanto due poli della vita linguistica e in
essi dispongono forzatamente tutti i fenomeni linguistici: il sistema della lingua
unitaria e la realizzazione individuale di questa lingua da parte del parlante.
Se il plurilinguismo è già per così dire dato naturalmente – anche se è certamente più forte o più debole a seconda delle situazioni storico-culturali –, è,
cioè, un movimento irrefrenabile della vita linguistica, ciò su cui attivamente si
può invece intervenire per favorirne il processo riguarda la trasformazione del
plurilinguismo in pluridiscorsività dialogizzata (Bachtin).
Con “pluridiscorsività dialogica” si intende il superamento della situazione di
mera convivenza, non solo in una stessa cultura e in una stessa lingua, ma anche in una stessa persona, di più linguaggi e in certi casi di più lingue, nella direzione di un rapporto di comunicazione, di confronto, di reciproca interpretazione, che è poi la condizione della possibilità di distanziamento del parlare da
un certo linguaggio e da una certa lingua, per poter realizzare nei loro confronti una coscienza metalinguistica e critica.
Fra gli ideali che il senso comume a torto indica per una vita umana ottimale, vi sono anche il monolinguismo e l’univocità (ma ciò è ritrovabile pure in
orientamenti filosofici che hanno assunto a criterio di valutazione delle lingue
naturali – storico-sociali – le caratteristiche dei linguaggi logico-formali): un’unica lingua, un unico significato per ogni significante, un sistema verbale immutabile e privo di linguaggi interni che provochino scarti semantici da un linguaggio ad un altro. Ciò garantirebbe una comunicazione completa e una precisa
espressione della realtà e dei propri vissuti. La “New Speech” ipotizzata e descritta nel romanzo di Orwell 1984 è la pesante satira del mito della “lingua perfetta”.
Il mito biblico della torre babelica descrive il passaggio da una situazione
originaria di felice monolinguismo alla “confusione delle lingue”, al “caos del
plurilinguismo”. Nel mondo felice originario, che l’uomo sarebbe andato via via
perdendo, il mito babelico colloca anche 1’unicità e l’univocità linguistica. E tuttavia nella punizione, Dio gioca, per così dire, al rialzo (se no, che dio sarebbe?). Dio umilia donando. Il plurilinguismo è un dono. Anche se spesso, misconosciuto. A differenza della situazione della Pentecoste – in cui l’intendere la
lingua altrui consiste nel sentirla risuonare nella propria stessa lingua, sicché
7. Due condizioni dell’interpretabilità del verbale: il silenzio e il tacere
La distinzione fra “silenzio” e “tacere”, indicata nel titolo è presa da un breve passo degli Appunti del 1970-71 di Michail Bachtin:
SAGGI
non avviene nessun effettivo incontro fra lingue diverse e ciascuna non conosce che se stessa e rimane chiusa e soddisfatta nella propria identità – nella
babele delle lingue c’è un effettivo incontro fra le diverse lingue e la sperimentazione di tutta la loro irriducibile alterità
La nostalgia del “monolinguismo originario” è facilmente ritrovabile anche
fuori dal mito e dal senso cornune, in certe concezioni filosofiche e linguistiche.
La molteplicità delle lingue sarebbe riconducibile ad un’unica lingua originaria,
a una Ursprache, o alle strutture linguistiche universali che sottenderebbero
tutte le lingue, le cui divergenze riguarderebbero solo la struttura superficiale.
Quest’ultima concezione è quella di Chomsky.
Considerando, come fa Chomsky, lo studio del linguaggio verbale in termini di innatismo biologistico e ritenendo marginali le forze socio-culturali, storiche nello sviluppo linguistico, non si spiega come mai le strutture biologiche
universali del linguaggio verbale non riescano a produrre un’unica lingua, né
come i condizionamenti e le differenze sociali abbiano la meglio producendo
un plurilinguismo interno a una stessa lingua.
Ciò che la teoria chomskiana non riesce a spiegare non è soltanto l’esistenza della molteplicità delle lingue. Il vincolo della grammatica universale innata
impedisce anche che si possa comprendere fino in fondo e spiegare il carattere creativo del linguaggio.
Il plurilinguismo e il plurilogismo – come pure la plurivocità, l’ambiguità, la
vaghezza –, anziché una punizione, una maledizione, una caduta a partire da
una condizione di felicità originaria, sono condizioni fondamentali e imprescindibili della comunicazione, della espressione e della comprensione. Si è sulla
via della comprensione dell’enigma di Babele quando si considerano l’ambiguità, la duttilità semantica, la polisemia, l’ermetismo, la simulazione, la finzione,
l’allusione, la reticenza, il sottinteso, il malinteso, l’alterità come aspetti essenziali del linguaggio verbale anziché assumerli come secondari, c il malinteso.
ome suoi punti deboli, come tratti superficiali. Invece di dire la stessa realtà, il
linguaggio verbale tende continuamente a prenderne le distanze, con altri significati, con un altro dire, dicendo un’altra realtà.
Una spiegazione del plurilinguismo e della creatività linguistica può essere
trovata attribuendo al linguaggio, quale procedura modellizzante specie-specifica dell’uomo, distinta dal verbale, proprio la caratteristica di poter produrre più
mondi e di poter impiegare la stessa “materia”, nel senso di Louis Hjelmslev
(1899-1965), per realizzare più universi linguistici: la pluralità delle lingue e la
loro diversa modalità di espressione (sul piano fonologico, sintattico, semantico e pragmatico) della “realtà”, dipenderebbe in tal caso proprio dalla propensione del linguaggio, come dispositivo modellizzante, al plurilinguismo e al plurilogismo, all’inventiva, all’innovazione, alla creatività.
53
Il silenzio e il suono. La percezione del suono (sullo sfondo del silenzio).
Il silenzio (assenza di suono) e il tacere (assenza di parole). La pausa e
l’inizio della parola. La violazione del silenzio da parte di un suono è meccanica e fisiologica (come condizione della percezione); la violazione del
tacere invece da parte di una parola è personalistica e dotata di senso: è
un tutt’altro mondo. Nel silenzio nulla risuona (o qualcosa non risuona),
nel tacere nessuno parla (o qualcuno non parla). Il tacere è possibile soltanto nel mondo umano (e soltanto per l’uomo). Naturalmente, sia il silenzio sia il tacere sono sempre relativi. Le condizioni della percezione
del suono, le condizioni dell’intendimento-riconoscimento del segno, le
condizioni dell’intendimento produttore di senso della parola. Il tacere / il
suono dotato di senso (parola) / la pausa costituiscono una particolare logosfera, una struttura unitaria e ininterrotta, una totalità aperta (incompibile). L’intendimento riconoscimento degli elementi iterabili del discorso
(cioè della lingua) e l’intendimento produttore di senso dell’enunciazione
non iterabile. Ogni elemento del discorso è percepito su due piani: sul
piano dell’iterabilità della lingua e sul piano dell’enunciazione non iterabile. Attraverso l’enunciazione la lingua partecipa alla non iterabilità storica
e alla totalità incompiuta della logosfera
54
Abbiamo citato il testo di Bachtin dalla traduzione apparsa nella rivista “Intersezioni” nel 1981 (I, 1, pp. 115-124), perché è preferibile a quella successiva (1988, trad. it., di Bachtin 1979), in cui, nello stesso passo, che per il resto
rimane immutato, “tacere” è sostituito con “mutismo”.
Bachtin, nel passo sopra citato, distingue le condizioni della percezione del
suono, le condizioni dell’identificazione del segno verbale e le condizioni della
comprensione del senso dell’enunciazione. Delle prime due, quelle della percezione del suono e dell’identificazione del segno, fa parte il silenzio; mentre il
tacere è fra le condizioni della comprensione del senso.
Il silenzio permette la percezione dei suoni e dei tratti distintivi della lingua
(i fonemi) e quindi il riconoscimento, l’identificazione degli elementi reiterabili
del discorso, cioè degli elementi che fanno parte della lingua, al livello fonologico, sintattico e semantico. Il tacere è invece condizione della comprensione
del senso della singola enunciazione nella sua irripetibilità e quindi la condizione della risposta ad essa quale essa è in questa sua singolarità e irripetibilità.
Il silenzio permette l’individuazione dei suoni e l’identificazione delle parti ripetibili dell’enunciazione che fanno parte del sistema della lingua. Il tacere, invece, permette di cogliere l’enunciazione quale evento irripetibile, nel suo senso
particolare e di rispondere adeguatamente ad essa. Il silenzio ha a che fare
con la lingua e con il suo sostrato fisico, di ordine acustico e fisiologico. Il tacere, invece, ha a che fare con l’enunciazione e col senso e con il suo sostrato propriamente umano, storico-sociale. Il silenzio è collegato con entità fisiche, i suoni, e con le unità astratte della lingua come sistema: i fonemi, i morfemi, le proposizioni, le frasi. Il tacere, invece, riguarda l’unità concreta della
comunicazione verbale, l’enunciazione nella sua parte non iterabile.
Finché si occupa unicamente degli elementi della lingua e della frase, si riconosce, come unica condizione del segno verbale, il silenzio. Non si è in grado di inoltrarsi nello spazio del tacere, che è quello dell’enunciazione nella sua
irripetibilità e dell’interpretante di comprensione rispondente: lo spazio dell’intertestualità e della dialogica delle enunciazioni. La filosofia del linguaggio si
differenzia dalla linguistica che assume come suoi oggetti la lingua e la frase.
Gli oggetti della linguistica si stagliano sul silenzio, che permette di percepire
suoni e di identificare segni verbali, Il silenzio non è solo l’unica condizione degli oggetti di cui tale linguistica si occupa, ma anche il loro limite, oltre il quale
c’è che negazione o azzeramento.
Sia la linguistica tassonomica, sia quella generativo-trasformazionale – la
quale sposta l’attenzione dagli elementi della lingua e della frase ai rapporti di
generazione delle frasi – rientrano in uno stesso orientamento che prescinde
dal rapporto di comprensione rispondente delle enunciazioni e dal loro senso,
che, a differenza delle frasi e del loro significato, non hanno il silenzio come loro limite ma richiedono, invece, il tacere come condizione del loro stesso prodursi. Di conseguenza la linguistica tassonomica e quella generativa nulla possono dire dell’enunciazione come cellula viva del parlare, del suo carattere dialogico, della sua essenziale destinazione verso la comprensione rispondente.
E nulla possono dire delle diverse forme del tacere, del parlare indiretto, differito, allusivo, parodico, ironico, della sua ambiguità e polisemia, del suo senso
implicito, del sottinteso, dello slittamento del dire, della sua possibilità di disimpegno, della sua capacità di “spostamento” (Barthes 1978). Nulla sanno dire
quindi della scrittura letteraria che è fatta delle “forme del tacere”: “scrittore” dice Bachtin (1979), negli appunti del 1970-71, è colui che non usa la lingua direttamente, ma “ha il dono del parlare indiretto”, “indossa la veste del tacere”.
Fondandosi sulla nozione di sistema di regole o codice, e potendo dunque
muoversi soltanto nello spazio che va dal suono al segno verbale fonologicamente, sintatticamente, semanticamente identificato, cioè lo spazio del silenzio, questo tipo di linguistica, la linguistica del codice, può essere appunto soprannominata “linguistica del silenzio”.
Non è casuale l’incontro e il reciproco scambio metodologico e terminologico fra la linguistica della frase e la teoria matematica dell’informazione (v. C. E.
Shannon e W. Weaver 1949). La stessa denominazione “linguistica del codice”
richiama questo scambio. Come la teoria dell’informazione, questo tipo di linguistica non conosce altra forma di ostacolo, di disturbo, nell’interpretazione
dei segni verbali ridotta alla de-codificazione, cioè al riconoscimento e all’identificazione, che il “rumore”. Una volta che si è ridotta l’enunciazione al rapporto, proprio del segnale, fra codice e messaggio, l’unico disturbo può essere il
“rumore”, dovuto a un’imperfezione del canale, o a un’interferenza del contesto esterno, o a una carenza di regole restrittive fra codice e messaggio che
permette l’insorgere di ambiguità. Fondamentalmente si tratta di un’interruzione del silenzio, il quale è la condizione di percezione del segnale.
SAGGI
8. La frase come cellula morta della lingua
e l’enunciazione cellula viva del parlare
55
56
Il problema del senso fuoriesce dai limiti della linguistica del codice, della
linguistica del silenzio e riguarda la riflessione linguistica che non si limita alla
lingua in quanto codice, né alle relazioni linguistiche tra gli elementi del sistema della lingua o fra gli elementi di una singola enunciazione o al rapporto fra
le frasi e ai processi di trasformazione (dalle “strutture profonde” alle “strutture
superficiali”), ma si occupa delle relazioni dialogiche fra segni verbali, in quanto enunciati, e interpretanti di comprensione rispondente. Lo sfondo su cui si
stagliano questi rapporti dialogici è il tacere. Il silenzio, l’assenza di rumore costituiscono, invece, la condizione fisica dell’enunciazione, la condizione minimale che la riguarda nella dimensione della segnalità vale a dire in quella del
riconoscimento e dell’identificazione, ma non bastano perché l’enunciazione
sussista come segno e abbia senso. Il tacere è sia la situazione, la posizione
da cui ha inizio l’enunciazione, sia la situazione, la posizione in cui è ricevuta.
La libertà di parola ha come condizione la possibilità di tacere, quale scelta del
parlante, ed è violazione del tacere e non semplice violazione del silenzio; al
tempo stesso presuppone il tacere come posizione di ascolto.
Possiamo a questo punto ritornare sull’opportunità di una connessione, dal
punto di vista della filosofia del linguaggio, tra linguistica generale e semiotica
della musica risulta da due motivi. Il primo l’abbiamo detto: è che le procedure
di accostamento al verbale devono essere non solo stabilite sulla base di un
modello di segno in generale, cioè un modello semiotico, e quindi, come tale,
non coincidente con quello di segno verbale, ma capace anche di rendere conto dei segni più refrattari rispetto a categorie semiotiche fonocentriche (come
tali, pseudosemiotiche). La cartina di tornasole di un modello semiotico del genere è offerta dal linguaggio musicale che è tanto refrattario alle categorie fonocentriche che, di fronte alla difficoltà di omologarlo linguaggio verbale, nasce
la tentazione di non consideralo un linguaggio. Il secondo motivo è dato dal fatto che le procedure di accostamento al verbale da parte di una linguistica generale, non ridotta a linguistica del silenzio, devono essere stabilite anche in
considerazione di ciò che nella musica è essenziale: l’ascolto.
Dal tacere, da cui l’enunciazione ha avvio come libera scelta, al tacere che
essa richiede, cui si rivolge, cui si consegna e che l’accoglie nell’ascolto: questo il movimento dell’enunciazione. Fra l’uno e l’altro tacere non vi è differenza
sostanziale: il tacere da cui ha avvio l’enunciazione è stato, a sua volta posizione, di ascolto; e l’enunciazione è, in effetti, una risposta, un’interpretante di
comprensione rispondente. Viceversa, il tacere che è posizione di ascolto, è, a
sua volta, proprio perché l’ascolto si realizzi effettivamente, avvio di un interpretante di comprensione rispondente, che se è di tipo verbale, è una risposta
sotto forma di enunciazione. Scrive Bachtin (1979, trad. it.: 254-255):
Nella linguistica trovano tuttora cittadinanza finzioni come l’“ascoltante” e
il “comprendente” (partner del “parlante”), “flusso verbale continuo”, ecc.
Queste finzioni danno un’idea del tutto svisata del complesso, multilaterale e attivo processo di comunicazione verbale. Nei corsi di linguistica
generale, anche nei più seri (come quello di Saussure) spesso si raffigurano con uno schema didattico i due partner della comunicazione verba-
Proprio al tacere dell’ascolto rispondente è rivolta l’enunciazione. Tolto il tacere dell’ascolto rispondente resta il silenzio a cui l’enunciazione evidentemente non si rivolge. E a cui si sottrae. Il silenzio appartiene alla sfera della lingua
in quanto sistema e al linguaggio come iterazione, come riproduzione di ciò
che Michel Foucault (1926-1984) “ordine del discorso” (Foucault 1970). Invece il tacere appartiene alla sfera dell’enunciazione non iterabile, partecipa della “totalità incompiuta della logosfera” (Bachtin 1979). Il tacere permette all’enunciazione di sottrasi al silenzio indagatorio, coercitivo, del sistema linguistico, il cui carattere “fascista”, come dice Roland Barthes (1978) non sta nel
fatto che impedisce di dire, ma, al contrario nel fatto che obbliga a dire, a reiterare i significati fissati, sanciti dall’ordine del discorso. Il silenzio impone di
parlare, ma non è ascolto. Il tacere è ascolto e, in quanto ascolto rispondente,
è pausa dell’enunciazione non iterabile.
Il silenzio del sistema della lingua, divenuto “universo chiuso di discorso”
SAGGI
le: il parlante e l’ascoltante (colui che percepisce il discorso), si schematizzano cioè i processi attivi del discorso nel parlante e i corrispondenti
processi attivi di percezione e comprensione del discorso dell’ascoltante.
Non si può dire che questi schemi siano erronei e non corrispondano a
determinati momenti della realtà, ma, quando vengono fatti passare per
la reale totalità della comunicazione verbale, essi diventano una finzione
scientifica. In effetti, l’ascoltante, percependo e comprendendo il significato (linguistico) d’un discorso, contemporaneamente assume nei riguardi di esso una posizione responsiva attiva: è in accordo o in disaccordo
(del tutto o in parte), lo integra, lo applica, si prepara ad eseguirlo, ecc.;
e questa posizione responsiva dell’ascoltante si forma nel corso di tutto
il processo dell’ascolto e della comprensione, fin dal suo inizio, a volte letteralmente fin dalla prima parola del parlante. Ogni comprensione d’un
discorso vivo, d’una viva enunciazione ha un carattere attivamente responsivo (anche se il grado di questa attività può variare assai); ogni
comprensione è pregna di una risposta e, sotto una forma o sotto un’altra, la genera immancabilmente: l’ascoltante diventa parlante. La comprensione passiva dei significati del discorso sentito è soltanto il momento astratto della reale e globale comprensione attivamente responsiva,
che si materializza nella successiva risposta reale ad alta voce. Naturalmente, non sempre si ha una risposta ad alta voce immediatamente successiva all’enunciazione: la comprensione attivamente responsiva di ciò
che si è sentito (ad esempio, di un comando) può immediatamente realizzarsi in azione (l’esecuzione dell’ordine o del comando compreso e accettato), può restare per il momento una comprensione responsiva tacita
(alcuni generi di discorso hanno appunto come fine soltanto questa comprensione, come, ad esempio, i generi lirici), ma si tratta, per così dire di
una comprensione responsiva ad azione ritardata: prima o poi ciò che è
stato sentito e attivamente compreso riecheggia nei discorsi successivi o
nel comportamento dell’uditore. I generi della comunicazione culturalmente complessa, per lo più, hanno come fine proprio questa comprensione attivamente responsiva ad azione ritardata. Tutto ciò che noi stiamo ora dicendo vale anche, con le debite proporzioni e integrazioni, per
il discorso scritto e letto.
57
(Herbert Marcuse 1967) abolisce l’ascolto appartenente alla non iterabilità storica e alla totalità aperta, incompibile della logosfera. Altro è l’ascolto, altro è il
voler sentire: l’ascolto lascia parlare e lascia scegliere ciò che si vuol dire, lascia manifestare ed è rivolto ai segni nella loro costitutiva plurivocità e contraddittorietà. Il voler sentire, invece, obbliga a dire, impone l’univocità, la pertinenza alle domande, la coerenza, la non-contraddizione. Scrive Barthes (con Roland Havas 1977: 989):
nel campo dell’ascolto è incluso non solo l’inconscio, nel senso topico del
termine, ma anche se così si può dire, le sue forme laiche: l’implicito, l’indiretto, il supplementare, il differito. L’ascolto si apre a tutte le forme di polisemia, di sovradeterminazione, di sovrapposizione disgregando la Legge che prescrive l’ascolto diretto, univoco.
58
L’ascolto diretto e univoco è quello “applicato” (ibidem) del “voler sentire”,
che è collegato con il silenzio e con l’esclusione del tacere, esclusione sia come mancanza di ascolto sia come imposizione a parlare e dunque a dire univocamente. Inoltre, come abbiamo visto, il tacere è collegato con l’ascolto attivo; l’“ascolto parla”, dice Barthes, come Bachtin. Perciò sullo sfondo del tacere non si stabiliscono gerarchie fra chi è obbligato a rispondere e chi ha il potere di interrogare e di giudicare. Il silenzio dell’universo chiuso di discorso,
escludendo il tacere dell’ascolto rispondente e affermando il voler sentire, “applicando” l’ascolto, fissa i ruoli del domandare e del rispondere, separa l’ascoltare dal parlare. Sicché, come dice Barthes, mentre
si crede che per liberare l’ascolto basti prendere la parola, invece un
ascolto libero è essenzialmente un ascolto che circola e scambia, che disgrega, con la sua mobilità, la rete rigida dei ruoli di parola. Non è possibile immaginare una società libera se si accetta che in essa siano mantenuti gli antichi luoghi d’ascolto [diretto e univoco]: quelli del credente,
del discepolo, del paziente (ivi: 990),
cioè, aggiungiamo noi, i luoghi del silenzio.
La “linguistica del silenzio” corrisponde ad un sistema di comunicazione dominato dal silenzio. La linguistica del codice è l’espressione di reali forze centripete del sociale. Il monologismo, la tendenza verso l’univocità e l’abbassamento del segno al livello della segnalità secondo un rapporto di scambio
eguale fra significante e significato, appartengono solo secondariamente alla
linguistica del silenzio: esse appartengono in primo luogo alla forma sociale
che ha scelto il silenzio come sfondo del parlare e di cui la linguistica del silenzio è solo un’espressione.L’omologazione dell’universo comunicativo riduce
l’ascolto al voler sentire, assottiglia gli spazi del tacere in cui la libertà di ascolto è necessaria quanto la libertà di parola; e di conseguenza l’omologazione
dell’universo comunicativo attribuisce concretamente al segno verbale unicamente le caratteristiche convenzionali del segnale oppure le caratteristiche naturali del suono.
Dalla necessità del naturale alla ripetizione del convenzionale, o per dirla
9. Scrittura letteraria e traduzione
Come guarda le cose la scrittura letteraria? Le guarda in maniera indiretta,
con la coda dell’occhio. E ciò le permette di usare la lingua per uscire dai limiti del mondo con cui esso coincide, di uscire dalla sfera dell’essere-così, dall’ordine del discorso, dalla rappresentazione, dall’ontologia. Quest’uso della
lingua standone fuori, quest’“impresa antigrammaticale” (Artaud) nei confonti
della lingua e della sua ontologia, attraverso lo sguardo indiretto della letteratura, conferisce alla scrittura letteraria un carattere sovversivo: “una sovversione non sospetta” (Jabès 1984). La visione indiretta della scrittura letteraria permette di scorgere e di raffigurare ciò che sfugge allo sguardo diretto, troppo
scoperto e vulberabile. Edgar Allan Poe (1809-1949) lo dice attarverso Auguste Dupin. Guardare l’oggetto direttamente pregiudica le proprie capacità visi-
SAGGI
con Charles S. Peirce dalla indicalità alla simbolicità: questo è l’ambito riservato al segno che perde così la sua ambivalenza, la sua duttilità, la sua possibilità di avere un interpretante che abbia una sua originarietà, autonomia, alterità assoluta (nel senso di Lévinas) – caratteri che Peirce attribuisce all’iconicità. Rinchiuso nell’universo del silenzio e della costrizione a parlare secondo le
leggi, le convenzioni, le abitudini, il segno perde il suo carattere di sfida, di provocazione, rispetto all’identità, alla totalità chiusa; perde la sua possibilità di rimettere in discussione, ciò che sembra saldo e definitivo, quasi avesse i caratteri della naturalità. Cosa che invece il segno può fare col suo stesso tacere,
con la sua stessa non collaborazione con l’universo chiuso di discorso, con il
suo stesso sottrarsi al monologismo, col suo fuoriuscire dalla logica dello
scambio eguale fra significante e significato, fra interpretato e interpretante.
“La violazione del silenzio da parte del suono è meccanica e fisiologica […].
Il tacere è possibile soltanto nel mondo umano” (corsivo nostro), dice Bachtin
nel passo citato sopra, all’inizio del paragrafo 6. Ebbene la costrizione del segno nello spazio del silenzio, la sua separazione dal tacere e dalla libertà di
ascolto, dall’ascolto aperto alla polisemia, toglie al segno il suo carattere umano e lo rende qualcosa di meccanico e di pseudonaturale, facendolo oscillare
fra la convenzionalità del segnale e la naturalità del suono, la naturalità di ciò
che non rivendica un senso.
La filosofia del linguaggio, come è concepita in questo libro, recupera, per
quanto riguarda il verbale, quelli aspetti che la “linguistica del silenzio” espunge con la conseguente espunzione (Lévinas) del rapporto con l’altro, del rapporto di alterità, che è costitutivo della vita della parola. Così intesa, la filosofia
del linguaggio guarda al linguaggio verbale in cui maggiormente risalta il dialogo, l’ascolto, l’ospitalità e l’accoglienza della parola altrui. Sotto questo punto di vista particolarmente interessanti risultano la scrittura letteraria e la pratica della traduzione. La scrittura letteraria, questa forma del tacere (Bachtin
1979), allusiva, parodica, ironica, questa forma di riso, è forse la scrittura che
oggi maggiormente afferma i diritti dell’alterità contro l’omologazione all’identità della comunicazione dominante.
59
60
ve. Guardare una stella di lato, con la coda dell’occhio, più sensibile per una
maggiore concentrazione di bastoncelli, alle deboli impressioni della luce, consente di contemplarla distintamente, di apprezzarne al massimo la luminosità,
di averne una percezione più raffinata.
Italo Calvino (1923-1985) considera lo sguado indiretto della letteratura come “possibilità di salute” contro l’“epidemia pestilenziale” che ha colpito l’umanità nella facoltà che più la caratterizza, “una peste del linguaggio” che si manifesta come omologazione, automatismo, appiattimento non solo dell’espressione verbale, ma della vita stessa e anche dell’immaginazione, del desiderio.
La letteratura, e, aggiunge Calvino, “forse solo la letteratura”, può produrre gli
anticorpi della “peste del linguaggio essa può difenderci dalla pietrificazione
della realtà, perché come l’“eroe leggero” Perseo, che nel mito vince la Medusa, guarda anch’essa in maniera indiretta. Nel romanzo di Orwell 1984 la scrittura letteraria è presentata come l’ultimo baluardo alla “New Speech” e all’ipotesi di una realtà omologata in cui tutto è in funzione della produttività della comunicazione e in cui, di conseguenza, l’infunzionale e il superfluo siano stati
cancellati.
Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente (§ 8), L’imprecisione, la
vaghezza del segno verbale, la sua plurivocità e duttilità semantica non sono
suoi difetti come invece appaiono a chi assuma come modello i linguaggi artificiali, formalizzati. Sono invece le condizioni della possibilità di adeguazione a
una realtà che è sempre mutevole e varia e della possibilità della comunicazione in contesti situazionali sempre nuovi e diversi e in cui gli interlocutori sono
in un rapporto di reciproca alterità (v. Volosinov 1929, Schaff 1977, De Mauro
1994). Proprio perché vive nel punto di incrocio di parole diverse – la parola
propria e la parola altrui – di linguaggi diversi, il significato non è mai fissato
una volta per tutte: il punto di partenza della comunicazione non è l’univocità;
al contrario, è sulla base di una plurivocità di partenza che la comunicazione
può tendere a una convergenza semantica, a una relativa univocità.
Come Bachtin (1975, it.: 93-103), Steiner (1975) sottolinea la presenza di
tendenze centrifughe nella “stessa” lingua che fanno sì che essa non sia mai
unitaria. Una lingua è una realtà pluridiscorsiva, è fatta di linguaggi diversi e vive di questa diversità: diversità linguistiche di registro, di gruppo sociale, professionale, di sesso, di generazione, ecc. In una lingua vi sono altre lingue, come matrici, come sopravvivenze, come alternative scartate, come possibilità
latenti, altre lingue con cui essa si trova in rapporti di “compromesso”, di “scontro, di “assorbimento”, di “scambio”, ecc.
Se si parte dal riconoscimento del plurilinguismo come elemento costitutivo
di ogni lingua, si perviene, con George Steiner, ma anche, molto prima di lui,
con Victoria Welby (1837-1912), a considerare la traduzione non come pratica
accessoria, ma come coincidente con qualsiasi processo di espressione verbale, anzi con qualsiasi pratica umana, verbale e non-verbale, di interpretazione e significazione. Tradurre non è solo passare da un lingua ad un’altra: dato
il plurilinguismo interno a una stessa lingua, dato il carattere di alterità che ogni
linguaggio, ogni discorso presentano e dato il continuo trasformarsi della lingua, che produce un distanziamento linguistico fra una generazione e un’altra,
SAGGI
non solo qualsiasi forma di interpretazione ma anche qualsiasi forma di
espressione verbale è una traduzione. Sia da parte di chi comunica, sia da parte di chi interpreta è necessario un processo di riformulazione, di traduzione.
Il limite dell’estensione del concetto di traduzione in Steiner (a differenza di
Welby e di Peirce) è che essa non è giustificata semioticamente. Manca, cioè,
una riflessione sul concetto stesso di segno che mostri che come in esso, in
quanto consiste nel rapporto segno-interpretante, la traduzione abbia un ruolo
fondamentale. Non c’è segno senza interpretante, cioè senza un altro segno
che ne possa esprimere il significato. Il significato quindi sussiste soltanto nei
rapporti di reciproca traduzione fra i segni, e non vi è dato autonomamente e
antecedentemente rispetto a tali rapporti (v. Petrilli 1999-2000, 2001, 2003a e
2003b. Utilizzando e precisando la terminologia di Jakobson possiamo distinguere tre forme di traduzione (v. Petrilli 1998a): a) traduzione endolinguale (interna a una stessa lingua) o riformulazione, che consiste nell’interpretazione
dei segni verbali per mezzo della stessa lingua. Endolinguistica è, invece, la
traduzione interna a uno stesso linguaggio, verbale o non-verbale. b) traduzione interlinguale (tra due lingue diverse) o traduzione propriamente detta, che
consiste nell’interpretazione dei segni verbali di una lingua per mezzo dei segni verbali di un’altra lingua. Interlinguistica è, invece, la traduzione tra linguaggi diversi, che, nel caso in cui si tratti di traduzione tra linguaggi non-verbali o
tra linguaggi verbali e non-verbali, sarà specificabile come c) traduzione intersemiotica o trasmutazionee consiste nell’interpretare segni verbali per mezzo
di sistemi segnici non-verbali e viceversa.
Non c’è semiosi, cioè non c’è situazione segnica o processo segnico, in cui
non intervenga almeno una di queste forme di traduzione. Soprattutto la prima
e la terza intervengono continuamente. Fra significato e traduzione intercorre
un rapporto di indissolubile interdipendenza. È erroneo credere che il significato sia definito fuori dai processi di traduzione e che la traduzione consista semplicemente nell’esprimere uno “stesso significato” – autonomamente e precedentemente determinato – con un significante diverso da quello cui esso sarebbe originariamente legato, nel sostituire un materiale segnico per esprimere lo stesso significato. Il significato, al contrario, in quanto “percorso interpretativo” si realizza entro processi di traduzione, anzi la semiosi stessa è un processo di traduzione.
Qualsiasi richiesta di chiarimento, di spiegazione, di definizione semantica
è una richiesta di traduzione nel proprio linguaggio del linguaggio altrui, tale da
permettere l’assunzione nella propria produzione testuale di modalità espressive estranee; e ciò può essere efficacemente realizzato solo tramite un riadattamento, una riformulazione che tenga conto, volta per volta, del linguaggio, o
dei linguaggi, di cui dispone e di cui in fin dei conti è fatto il soggetto a cui la
spiegazione è rivolta. Il rapporto fra linguaggi diversi è necessario non solo alla semplice appropriazione di un determinato lessico. La comprensione del significato di un certo testo si realizza nell’incontro di linguaggi diversi, anche
quando si intenda per “significato” il senso, la funzione del testo e del campo
linguistico cui appartiene.
È con il passaggio da un linguaggio all’altro e da una lingua all’altra che i si-
61
62
gnificati si chiariscono, con il conseguente approfondimento della coscienza linguistica, che non è nulla di diverso dalla complessiva presa di coscienza e padronanza situazionale. Nel rapporto interlinguistico, interno o esterno a una determinata lingua, la catena degli interpretanti verbali non termina là dove finisce
il campo semantico-ideologico di un determinato linguaggio o di una determinata lingua, ma ne travalica i confini entrando nei domini di altri linguaggi o lingue.
Per il distanziamento dalla propria lingua in modo da averne una visione critica, sono necessari, come dice Bachtin, gli occhi di un’altra lingua. Gli studi di
psicologia del bilinguismo e dell’educazione bilingue condotti in Italia da R. Titone nell’ambito della psicopedagogia del linguaggio e le ricerche in questi settori svolte da psicolingusti americani (Diebold e altri), canadesi (Bain e Danesi),
svizzeri (Grosjean (v. Titone, a cura di, 1995) confermano la distinzione fra una
semplice situazione di bilinguismo funzionale, inerente ad ambienti multiculturali, e una “competenza bilingue”, come padronanza di due lingue nel senso della comprensione linguistica adeguata del loro funzionamento e delle loro differenze. Titone insiste sull’importanza dell’acquisizione linguistica della seconda
lingua non semplicemente come strumento comunicativo, ma soprattutto come
fattore formativo rivolto allo sviluppo dell’intera personalità del discente.
Anche se in certi passaggi Titone sembra includere quest’ultimo aspetto
nella sfera della “competenza comunicativa” quale momento pragmatico di integrazione e completamento della competenza comunicativa (v. ivi: 180), tuttavia dalle sue analisi risulta, nel complesso, che l’acquisizione linguistica della seconda lingua come fattore formativo è qualcosa di diverso e di più dell’insegnamento della seconda lingua come strumento comunicativo (v. ivi: 195).
Titone distingue fra “consapevolezza linguistica” e “coscienza metalinguistica”.
La prima è caratterizzata dal suo carattere implicito, in quanto causata dalla
maturazione cognitiva anche antecedentemente alla scolarizzazione formale.
La seconda consiste in una conoscenza formale, intenzionale, dichiarativa dei
sistemi semiotici comuni alle lingue, ed emerge intorno ai dodici anni in seguito a una adeguata esposizione alla scolarizzazione formale (v. ivi: 190). La conoscenza di una seconda lingua è particolarmente importante nello sviluppo
della conoscenza metalinguistica.
Il punto interessante da sottolineare qui è che la bilingualità, come stato
psicologico implicante fattori intellettivi e atteggiamenti motivazionali,
sembra essere un fattore particolarmente forte nell’influenzare lo sviluppo della coscienza metalinguistica perfino in bambini molto piccoli cresciuti in uno stato di bilinguismo simultaneo (ivi: 190-191).
Il riconoscimento dell’importanza dell’apprendimento linguistico allargato a
una seconda o terza lingua in funzione dello sviluppo complessivo della personalità, ovvero in funzione della presa di coscienza linguistica, è connesso
con una concezione del parlare che non lo riduca a strumento comunicativo,
ma che lo consideri come abilità cognitiva complessa (v. ivi: 18), o, secondo
la nostra terminologia (v. sopra), come procedura modellizzante secondaria rispetto al linguaggio inteso come procedura modellizzante primaria, caratterizzata dalla “sintassi” o “scrittura”, e quindi come capacità, specificamente uma-
10. Falsi amici di ordine semantico-ideologico. Un esempio: “Wesen”
È abbastanza noto il carattere fuorviante che nella traduzione svolgono
quelle parole che vengono indicate come “falsi amici”. Si tratta delle parole che
possono ingannare il traduttore perché eguali o simili a quelle che bisogna tradurre sotto l’aspetto del signans, la forma significante, ma diverse per quanto
SAGGI
na, di costruzione e decostruzione infinite tramite un numero finito di elementi. Il linguaggio, così inteso, è la modellazione specie-specifica dell’uomo. Essa sul piano filogenetico era già propria dell’ominide e ne spiega lo sviluppo
fino all’homo abilis e poi fino all’homo sapiens che impiega il parlare per comunicare. Sul piano ontogenetico, è già “in dotazione” dell’infante, benché infans, non parlante. Sul piano patologico, è in possesso del sordomuto, per
quanto questi sia incapace di utilizzare il mezzo comunicativo del parlare. Si
potrebbe dire che al cane più bravo a farsi capire non manca solo la parola,
come spesso si dice; manca in primo luogo il linguaggio inteso come modellazione primaria. È al sordumuto, il quale non per questo è privo della capacità di linguaggio, che manca solo la parola. Se, come avviene nella divertente scenetta immaginata da De Mauro (1994: 130), due nostri antenati preistorici potevano lamentarsi per la nuova invenzione del parlare e dei suoi “inconvenienti” (De Mauro non si chiede con che mezzo lo avrebbero fatto) è perché dotati di linguaggio e di altri mezzi comunicativi rispetto al parlare. Il linguaggio, quale capacità di costruzione di più mondi possibili, trova una sua
delimitazione costruttiva nel realizzarsi mediante una lingua determinata. “Il
gioco del fantasticare” (Sebeok), fondato sul linguaggio, trova nella lingua tanto più incremento quanto più è in grado di avvantaggiarsi di tutti gli strumenti
che la lingua fornisce e di sfruttare in pieno tutte quante le sue potenzialità,
anche perché le lingue stesse sono il risultato storico di “questo gioco del fantasticare”, sono fondate sulla capacità di linguaggio e testimoniano ciascuna
della sua capacità di costruzione di più mondi.
Ma la capacità di linguaggio e il gioco del fantasticare trovano anche nella
lingua così come storicamente si è costruita una delimitazione delle proprie
possibilità. Questa restrizione del linguaggio da parte di una lingua può essere superata con l’impiego di un’altra lingua, la cui conoscenza pertanto non
serve soltanto per superare barriere di ordine comunicativo, ma anche di ordine cognitivo, critico, assiologico, ideologico, inventivo, ecc. con l’evidente vantaggio – proprio di un plurilinguismo dialogico – sul piano della capacità decostruttiva e ricostruttiva, quale condizione del pieno sviluppo, non delimitato e
non pregiudicato unilinearmente, della personalità.
La presa di coscienza nei confronti della propria lingua, che è resa possibile dall’assunzione della visione del mondo di un’altra lingua, permette una visione non coincidente con quella offerta dalla propria lingua e capace di arricchire dunque, sul piano dialogico, non solo la coscienza linguistica del parlante, ma anche la coscienza linguistica della lingua stessa quale si esprime nelle sue regole di ordine sintattico e semantico.
63
64
concerne invece il signatum, il significato. Dicendo così, risulta chiaro che falsi amici, al contrario di quanto generalmente si pensa usando questa espressione non sono le parole della lingua da cui si traduce, ma quelle della lingua
d’arrivo, soprattutto quando si tratta della propria lingua. L’inganno è determinato dalle parole che ci sono familiari e che ci inducono a scambiare per lo
stesso ciò che invece è completamente altro.
Meno considerata è la questione di quelli che possiamo chiamere “falsi amici di ordine semantico-ideologico”: si tratta dei casi in cui si incorre in una traduzione errata scambiando l’effettivo significato di un termine per un’altro con
cui si simpatizza sul piano ideologico (o, più genericamente assiologico, o, in
altri termini, connotativo), e che si crede perciò di poter ravvisare nel primo. Un
esempio del genere è costituito dalla parola tedesca Wesen. Chi per esempio
traduce un autore come Meister Eckart (1260-1327) lo sa molto bene. Ma il rischio di fallacia nella traduzione di questa parola aumenta quando interviene
qualche tendenza di ordine semantico-ideologico.
Negli anni 1971-72 si svolse sulla rivista francese “L’Homme et la Société”
una discussione, sul problema della traduzione delle Tesi su Feuerbach di Karl
Marx, fra il filosofo francese Lucien Séve e il filosofo polacco Adam Schaff (gli
articoli di questo dibattito sono raccolti in Schaff e Séve 1975). La tesi di Sève
consisteva nel sostenere che Schaff (1913-2006) avesse tradotto erroneamente il testo della VI tesi di Marx su Feuerbach, discostandosi dalle traduzioni ufficiali. Ciò che a Sève interessava mostrare, al di là di una questione puramente filologica, è che questo errore di lettura da parte di Schaff della VI tesi era
connesso con un’erronea, secondo Sève, intepretazione del marxismo in chiave umanistica. La questione di fondo del dibattito fra Schaff e Sève è appunto
quella del rapporto fra marxismo e umanesimo (connessa evidentemente con
la questione dell’interpretazione degli stessi termini “marxismo” e “umanesimo”. La traduzione della VI tesi di Marx su Feuerbach occupa un ruolo centrale nell’antropologia marxiana. E Sève non esagera quando dice che l’interpretazione di questa tesi ne rappresenta “la pietra angolare”. Benché dunque incentrata sulla traduzione e l’interpretazione di alcune espressioni delle Tesi, la
discussione fra Schaff e Sève non è una controversia concernente soltanto
“parole”, né un puro problema di “marxologia”. Si tratta, al contrario, di una
questione che, come osserva Schaff, può essere pienamente compresa soltanto quando se ne cerchino i retroscena e le implicazioni in rapporto alla “controversia sui contenuti del socialismo, la controversia sui mezzi per superare
gli effetti e le conseguenze dello stalinismo nel movimento comunista, ecc.”
(Schaff e Séve 1975: 114).
A noi interessa questa discussione per mostrare come una questione di traduzione, sia collegata non soltanto con interpretazioni di ordine linguistico interne alla semantica e alla sintassi delle lingue in questione, ma sia invece anche connessa con simpatie di ordine ideologico che fanno travisare il significato dei termini e conseguentemente del testo in cui sono impiegati. Oggetto immediato e diretto della discussione è in particolare la traduzione dell’espressione das menschliche Wesen della VI tesi. In tedesco il testo di Marx in questione è il seguente:
Se si traduce, come fa Sève, Wesen con “essenza”, il testo in italiano è il
seguente (questa è anche la traduzione italiana della VI tesi nelle Opere complete di Marx e Engels (vol. V, 1972):
Feuerbach risolve l’essenza religiosa nell’essenza umana. Ma l’essenza
umana non è qualcosa di astratto che sia immanente all’individuo singolo. Nella sua realtà essa è l’insieme dei rapporti sociali.
Schaff sostiene che tale traduzione è errata. Questa traduzione che non è
accettata soltanto da Sève, ma anzi è quella generalmente ricorrente e convalidata dalla tradizione. Questa traduzione risale a Georggij V. Plechanov (18571918) ed è riscontrabile sia in tutte le successive traduzioni russe delle Tesi,
sia in quelle francesi, italiane, polacche che si conformano all’edizione russa.
Nelle traduzioni italiane delle Tesi, “das menschliche Wesen” è tradotto con
“l’essenza umana”, tranne in quella delle Edizioni Rinascita, 1950: 77, dove è
tradotta con “l’essere umano”. Secondo Schaff, l’espressione suddetta deve
essere intesa nel senso di “l’uomo reale”, “l’essere umano”, “l’individuo umano”, per cui si ottiene:
l’individuo umano è nella sua realtà l’insieme dei rapporti sociali.
Schaff mostra come la traduzione di das menschliche Wesen con “l’essenza umana”, che sul piano ideologico comporta il mantenimento di una concezione astratta e idealistica dell’uomo, indichi, del resto, una cattiva conoscenza della lingua tedesca. Schaff si appella alle regole sintattiche del tedesco e
fa notare, che, nella lingua tedesca, l’espressione das Wesen, se è seguita da
un sostantivo al genitivo, significa “essenza”: per esempio, das Wesen des Cristentums significa “l’essenza del cristianesimo”; se invece il sostantivo Wesen
è preceduto da un aggettivo qualificativo, significa “essere”: così, das christliche Wesen significa “l’essere cristiano”; das religiöse Wesen significa “l’essere religioso”. Di conseguenza, das Wesen des Menschen e das menschliche
Wesen hanno due significati diversi e non possono essere tradotti indifferentemente con “l’essenza umana”. Più precisamente: secondo Schaff, das menschliche Wesen significa “l’essere umano in concreto” in contrapposizione
all’“uomo in generale”, all’“uomo in astratto”: significa dunque “l’individuo umano”. Cosi, nella lingua tedesca, das Wesen des Himmels significa “l’essenza
del cielo”, mentre das himmlische Wesen significa “un essere celeste”, e analogamente das Wesen der Ausdehnung (l’essenza dell’estensione) e das ausgedehnte Wesen (ciò che è esteso, res extensa) hanno due significati del tutto diversi.
Oltre che sulla base della sintassi della lingua tedesca, Schaff dimostra che
das menschliche Wesen significa “l’essere umano”, “l’individuo umano concre-
SAGGI
Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Aber
das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.
65
to” analizzando anche l’uso della parola Wesen in Feuerbach e nell’Ideologia
tedesca di Marx e Engels. Particolarmente indicativa in questo senso è l’uso di
questa espressione nel passo di un’opera di Ludwig Feuerbach del 1845 in cui
questi difende le sue idee contenute in Das Wesen des Christentums (L’essenza del Cristianesimo, 1841) contro le critiche mossegli da Max Stirner in Der
Einzigen und sein Eigentum (L’unico e la sua proprietà, 1845) Si tratta dell’espressione
das wirkliche, sinnliche, individuelle menschliche Wesen das religiöse,
d.i. höchste Wesen ist.
Qui la presenza degli aggettivi che precedono Wesen (wirkliche, sinnlicbe,
individuelle) provano chiaramente che tale terrnine, così come qui è impiegato, conformenemente alle suddette regole sintattiche, significa non “essenza”,
ma “essere”, “essere particolare, concreto”. La traduzione dell’espressione riportata è perciò inequivocabilmente:
l’essere religioso e supremo è l’essere umano reale, sensibile e individuale.
66
Questa espressione di Feuerbach, secondo Schaff, è importante anche per
un altro motivo, connesso al precedente: si può supporre che Marx avesse in
mente proprio questo passo, quando, nella VI tesi, procedendo oltre Feuerbach che riconduceva l’essere religioso all’essere umano (reale, sensibile, individuale) affermava che questo essere umano è l’insieme dei rapporti sociali.
La discussione sulla traduzione della VI tesi sta ad indicare quanto sia importante, nella traduzione, rendersi conto dell’inganno dovuto ai “falsi amici di
ordine semantico-ideologico”.
11. Ipertesto e lettura-traduzione
In considerazione di quanto abbiamo detto a proposito del testo e della sua
interpretazione-lettura, impiegheremo qui l’ipertesto come paradigma dell’interpretazione-traduzione interlinguistica. Nell’accezione del linguaggio dell’informatica l’“ipertesto” è scrittura tramite calcolatore, che si organizza in maniera non lineare e che non fa ricorso a un unico tipo né ad un unico sistema di
segni. L’ipertesto è il sistema o il metodo, per il potenziamento, tramite computer, di una scrittura-lettura non lineare. Ciò significa la possibilità di “cucire”
componenti dell’opera in una “rete” e di spostarsi liberamente, di “navigare”,
scegliendo fra le alternative offerte dall’ipertesto, un percorso nella rete. Per
ipertesto si può intendere, metonimicamente, il tipo di testo ripondente a un
metodo o sistema del genere. Ci interessa qui considerare i vantaggi che può
trarre una teoria della traduzione interlinguistica che assuma questo tipo di testo come paradigma.
L’ipertesto è un testo-lettura in senso eminente, perché qui è privilegiato il
SAGGI
lettore, in quanto questo testo è fatto per permettergli di scegliere fra più percorsi di lettura. Qui la lettura non si svolge in senso lineare, in senso unico, il
“giusto senso”, in base al quale, con la sua autorità, l’autore costringe il lettore a muoversi secondo l’ordine dell’esposizione e in funzione di ciò che l’autore ha voluto dire, impedendogli di avere uno spazio suo e di muoversi liberamente in funzione di ciò che, invece, la lettura gli provoca volta per volta come
ininterrotto affluire di idee, stimoli e associazioni. Nell’ipertesto il dialogo tra segno interpretatnte e segno interpretato in cui si costituiscono il significato e il
senso riguarda direttamente il testo. L’autore passa in secondo piano. Si tratta
di comprendere ciò che il testo dice, piuttosto che ciò che l’autore ha voluto dire. Qui la materialità del testo si evidenzia non solo nei riguardi dell’interpretelettore, ma anche nei confronti dell’interprete-autore.
Al di là dei contenuti, e anche delle modalità tecniche di utilizzazione dell’ipertesto ciò che a noi qui interessa è l’apporto epistemologico e metodologico che questa particolare mezzo intermediale, in quanto tale, comporta nei
confronti della concezione del testo e di conseguenza dell’approccio ad esso
nel processo traduttivo. L’ipertesto incrementa il carattere associativo e personale della lettura, stabilisce con il testo una modalità di movimento secondo più
sensi, svincola lettura da un unico tipo e da un unico sistema di segni, abitua
a un rapporto dialogico col testo, che può avere effetti anche nell’atteggiamento della lettura-traduzione, come lettura capace di crearsi percorsi differenziati, di “leggere alzando la testa”, di “scrivere la lettura”, come dice Roland Barthes. La pratica dell’ipertesto informatico blocca finalmente l’interesse smisurato che da secoli si ha nei confronti dell’autore, abolisce il privilegio conferito
alla fonte dell’opera (persona o contesto storico), interesse smisurato e privilegio generalmente sancito e incrementato dalla critica letteraria – l’unica che
fornisce nella scuola e nell’università una metodologia di accostamento al testo, sopperendo all’assenza ricorrente di discipline come la linguistica testuale o la semiotica del testo.
Nell’ipertesto ciò che interessa è il testo e la molteplicità di itinerari secondo cui può essere letto. La censura nei confronti una lettura non lineare, “disordinata”, a salti, che si disperde e va alla deriva, cade in conseguenza del modo stesso in cui questo testo, caratterizzato dall’ipertestualità e multimedialità,
è stato prodotto. Con tale tipo di censura viene a cadere anche il rispetto dell’autorità, quella dell’autore, con cui di solito un testo è letto. Il testo-lettura qui
prende il sopravvento sul testo pre-scritto. Anche perché l’ipertesto multimediale non è la parola di un autore, ma il risultato di una molteplicità di contributi, di
competenze, di mezzi espressivi.
L’ipertesto multimediale affranca il testo-lettura in quanto tale, qualsiasi sia
la funzione del testo. In questo senso, l’ipertesto multimediale realizza, se non
nel senso che la compie per la prima volta, certamente nel senso che la istituzionalizza, la rivoluzione copernicana che sposta il centro dall’autore al lettore
sollecitandolo per giunta non ad una lettura-fruizione ma ad una lettura-scrittura. Scrivere la lettura (indipendentemente, sia ben chiaro, dal ricorso al segno
scritto, alla trascrizione). Questa possibilità che l’ipertesto multimediale visibilizza dovrebbe essere additata, in una teoria della traduzione, quale obiettivo
67
68
di qualsiasi lettura-traduzione intesa come comprensione rispondente, sopratrtutto quando si tratta del testo letterario. Inoltre, l’ipertesto si sottrae al modello deduttivo, secondo cui c’è un percorso da certe premesse a una determinata conclusione. Alla logica deduttiva subentra una logica associativa, che è la
logica stessa della traduzione in quanto lettura-scrittura come partecipazione
massimamente attiva, come comprensione massimamente rispondente. Come
nell’ipertesto, il rapporto si stabilisce per associazioni basate sulla memoria
personale del traduttore e sulla deriva del suo ricordare, sul suo interesse, sulla sua curiosità, sulle sue esperienze, sulla sua abilità di “distrazione”, sicché
il rinvio dal segno interpretato al segno interpretante non è deciso in maniera
costrittiva, deduttiva appunto, come nel rapporto indicale. Qui il rapporto fra interpretato e interpretante procede per ipotesi, si basa sull’iniziativa e sull’inventiva del lettore, richiede inferenze di tipo prevalentemente abduttivo e in certi
casi particolarmente rischiose.
L’ipertesto risulta così ciò a cui una traduzione dovrebbe tendere. La comprensione rispondente della lettura-traduzione dovrebbe assumere come modello un testo-lettura che è un ipertesto. Ma questo tipo di lettura ci è ancora
poco familiare, perché da secoli ci interessiamo nella lettura soprattutto di seguire l’autore, di “pedinarlo senza mai perderlo di vista”, con lo scopo di vedere da dove viene e dove si dirige, al punto che le sue stesse digressioni, divagazioni e soste ci spazientiscono.
La contrattazione, la negoziazione, in cui la traduzione necessariamente si
realizza riguarda il rapporto tra traduttore e testo e non il rapporto tra traduttore e autore. Negoziazione e ascolto, negoziazione e comprensione rispondente sono qui inseparabili, ed il loro carattere dialogico dipende dall’alterità, dall’autonomia, dalla resistenza, dall’oggettività, in una parola, dalla materialità
del testo da tradurre.
Ci sono testi, scritti dallo stesso autore, per depistare il lettore e per lasciarlo libero di scegliere il suo percorso di lettura. “Certi autori”, dice Barthes (1984,
it.: 24) “ci hanno avvertiti che eravamo liberi di leggere i loro testi a nostro piacimento e che tutto sommato si disinteressavano della nostra scelta (Valéry)”.
Barthes si riferisce in particolare a testi di scrittura letteraria, la cui lettura richiede una sorta di ri-scrittura. Qui l’ipertestualità è una conseguenza del carattere eminentemente dialogico del testo letterario, della sua inesauribile intertestualità, dalla sua capacità di spostamento del significante, che apre la significazione nella direzione della significanza. Ma, affinché questi testi possano realizzare nella lettura la loro natura di ipertesti, si richiede un’educazione
alla lettura che la stessa critica letteraria ostacola, interessata com’è, generalmente, a quel che l’autore ha detto e ai motivi autobiografici, psicologici, ideologici, storico-sociali, per cui l’ha detto.
L’ipertesto è un metodo di ampliamento delle possibilità di realizzazione
della scrittura come procedura modellizzante che caratterizza il linguaggio in
quanto capacità specie-specifica dell’uomo. L’ipertesto, come il linguaggio,
procede non in maniera lineare. Organizza connessioni fra parti distanti del
suo “tessuto”, collegamenti fra punti distanti della rete di interpretati-interpretanti di cui è fatto. La linearità è superata da una struttura reticolare. In questo
12. Stranieri alla propria lingua: ciò che accomuna il traduttore e lo scrittore
Bachtin (1929) criticando la concezione saussuriana della lingua come un
sistema che si impone al parlante fa notare che tiene presente il modello della lingua straniera e soprattutto morta quando si imposta il rapporto della lingua con il parlante in termini di imposizione, di accettazione passiva. Lo studio
delle lingue straniere e soprattutto delle lingue morte, il filologismo, sta alla base della linguistica saussuriana. Non è esatto dire che il parlante subisce, accetta passivamente la propria lingua. Non c’è da una parte il soggetto parlante, l’individuo, e dall’altra la lingua, la quale, fatto sociale, non sarebbe “una
funzione del soggetto parlante, ma un prodotto che l’individuo registra passivamente” (Saussure). Non si “accetta” la propria lingua materna, osserva Bachtin; è dentro la propria lingua che si giunge per la prima volta alla consapevolezza. La lingua non si impone alla persona che la parla: essa è il luogo dove essa si sveglia per la prima volta.
Solo la lingua straniera si stabilisce un rapporto di contrapposizione fra parlante e lingua, la quale si impone come sistema di norme e deve essere accettata. Ma proprio questo rapporto con la lingua straniera permette quella distanza, quell’exotopia, nei confronti della propria stessa lingua, della lingua materna, della lingua dove la coscienza si è originariamente formata, che è la posizione stessa che lo scrittore deve assumere nei confronti della lingua per essere tale. Questo avvertire l’estraneità della propria lingua come se fosse stra-
S AGGI
senso è meno restrittivo, meno vincolante del testo scritto tradizionale, o meglio, del modo tradizionale di scrivere e di leggere. L’ipertesto mostra che scrivere e leggere non è necessariamente scrivere e leggere in sequenza, incanalare il pensiero in una riga dopo l’altra, e secondo un ordine privilegiato, come
ci hanno insegnano fin da piccoli.
L’ipertesto non è soltanto un metodo. A partire da esso, è possibile delineare una metodica, con importanti implicazioni sulla teoria e sulla pratica della lettura e di quel particolare modo di lettura che è traduzione (v. Ponzio 2004c).
La “decentralizzazione” dell’ipertesto, il fatto che esso non abbia un centro fisso, ma sia un sistema infinitamente decentrabile e ricentrabile, può avere implicazioni sulla de-centralizzazione delle stesse attività cognitive come loro
condizione per orientamenti aperti e non pregiudizialmente orientati. Ciò è
massimamente richiesto nel rapporto con una lingua straniera e nella pratica
della traduzione in quanto dialogo interlinguistico. La capacità di decentralizzazione e ricentrazione diviene condizione formativa di un’identità aperta all’alterità, capace di messa in discussione di automatismi e percorsi pragmatico-interpretativi abituali. Da questo punto di vista, la pratica dell’ipertesto abitua allo spostamento del segno e dunque alla capacità di messa in discussione dell’universo organizzato secondo determinati sistemi segnici, quelli della lingua
di appartenenza in primo luogo, rendendo possibile, nella traduzione, l’accoglienza, l’ospitalità, in questa lingua, di un testo modellato in tutt’altro universo
linguistico-culturale.
69
70
niera, o meglio questo riconoscerla come altrui, come altra, la presa di coscienza del fatto che non se ne è proprietari, pone lo scrittore nella posizione di traduttore. L’Autobiographical Essays di Jorge L. Borges (1899-1986) attesta
questo rapporto strettissimo fra scrittore e traduttore, più precisamente fra lettura, traduzione e riscrittura: Borges lettore-traduttore-scrittore. Ciò che accomuna traduttore e scrittore è il fatto che entrambi non usano la lingua direttamente, non parlano a nome proprio. Lo scrittore, a differenza del giornalista,
del critico letterario, dell’esperto di una certa disciplina, ecc., non scrive in maniera diretta, non assume la parola come propria, usa la lingua standone fuori. Come autore-uomo, lo scrittore non dice nulla. Nell’opera letteraria, l’autorescrittore parla nelle forme diverse del tacere quali la parodia, l’ironia, l’allegoria, ecc. Il tacere elude l’ordine del discorso (Foucault), ha le caratteristiche che
Maurice Blanchot (1907-2004) attribuisce all’altra notte, quella che non serve
alla produttività del giorno.
Il traduttore, come lo scrittore, si trova a dover “lottare”, dice Borges, con la
propria lingua, sentendone tutta la materialità, l’oggettività, l’estraneità. Per lo
scrittore-traduttore il linguaggio e la lingua si presentano come Roland Barthes
li descrive in Leçon: il linguaggio una legislazione e la lingua il suo codice. Lo
scrittore-traduttore è colui che direttamente sperimenta il potere insito nella lingua, è colui che chiaramente avverte che una lingua è caratterizzata non è tanto da ciò che essa permette di dire, quanto da ciò essa obbliga a dire. Nella lingua, servilità e potere si fondono indissolubilmente. Dal linguaggio non si può
uscire. Si può uscire tuttavia dalla propria lingua, la si può usare standone fuori, la si può “truffare”, come dice Barthes, esercitando su di essa un’azione di
“slittamento”; e la scrittura letteraria è tale “truffa salutare”, questa sfida alla lingua, questa possibilità di sottrarsi alla servilità e al potere di chi la usa standone dentro. Ma è la lingua straniera ad a permettere la salda posizione esterna
da cui lo scrittore – in qualche modo per questo pur sempre scrittore-traduttore – può sia rendersi conto della predeterminazione insita nell’impiego della lingua, sia esercitare l’azione di slittamento su di essa, in cui appunto consite il
mestiere di scrittore.
Si comprende come dal punto di vista dello scrittore e del traduttore, data
la loro exotopia rispetto alla propria stessa lingua che dunque è avvertita come in tutta la sua alterità, come lingua dell’altro, non risultino contraddittorie le
due proposizioni che troviamo nel libro di Jacques Derrida (1930-2005) Il monolinguismo dell’altro (2004: 11):
– Non si parla che una solo lingua.
– Non si parla mai una sola lingua.
Questa doppia postulazione […] non infatti è soltanto la legge stessa di
ciò che chiamiamo traduzione. sarebbe la legge stessa come traduzione
(ivi14).
Lo scrittore e il traduttore vivono la verità del rapporto con la lingua, perché
“chiunque deve poter dire: ‘non ho che una sol lingua e (ora, ormai, permanentemente) non è la mia’. E anziché chiusura questo riconoscimento è “è la condizione del rivolgersi all’altro”, è “la possibilità di dare la propria parola all’altro”
13. Traduzione e linguaggio come modellazione primaria
A chi è rivolta la traduzione? È la domanda posta all’inizio del saggio di Walter Benjamin (1892-1940, “Il compito del traduttore” in Benjamin 1962: 39-52).
La risposta ingenua è: “A coloro che non comprendono la lingua dell’originale”.
La traduzione dice la “stessa cosa” dell’originale, ma nella lingua che essi non
comprendono. Questa “stessa cosa” è ciò che l’originale vorrebbe “comunicare”. La traduzione media, trasmette, la comunicazione.
Il problema è se il testo sia fatto appositamente per comunicare. Un’opera
poetica ha ben poco da dire e da comunicare. “L’essenziale in essa non è comunicazione, non è testimonianza” (ivi: 39). La traduzione interessata a comunicare medierebbe qualcosa di inessenziale, trasmetterebbe l’inessenziale.
Inoltre, il testo, se è rivolto al lettore, è rivolto al lettore della lingua in cui è scritto. Il traduttore sarebbe allora a servizio di un lettore a cui il testo non era destinato. Ci sarebbe in questo caso una resistenza del testo alla traduzione non
per la difficoltà di essere tradotto in una data lingua ma perché non è fatto per
essere tradotto, non intendeva rivolgersi ai parlanti di quella lingua. D’altra parte il testo non è rivolto neppure genericamente ai parlanti della lingua in cui è
scritto; esso è rivolto a un destinatario, dal quale non vuol essere semplicemente inteso, ma essere compreso in maniera rispondente (comprensione rispondente). Il problema della traducibilità diventa il problema della destinazione del testo e dunque dell’intenzione del testo di essere tradotto. Tale intenzione non va identificata con quella dell’autore. Nei testi letterari l’autore non ha
su di essi nessuna autorità (ciò a causa dell’indipendenza dell’opera rispetto al
S AGGI
(ivi: 28). Il guardare le cose dal di fuori, da una posizione extralocalizzata, non
significa affatto uno sguardo indifferente e oggettivo. L’exotopia della scrittura
letteraria rafforza, proprio a causa della distanza, la prossimmità, la non indifferenza (Lévinas): lo scrittore non solo partecipa alla vita ma l’ama anche dal
di fuori, di quell’amore che tutti riconosciamo come quello vero perché è rivolto ad essa nella sua infunzionalita. Questo amare ciò che è lontano accomuna
scrittura e traduzione.
Scrittura letteraria e traduzione si somigliano anche perché entrambe comportano l’oblio di sé e un grande senso dell’ospitalità richiesta alla lingua, “propria” o altrui, non per sé ma per altri, l’altro-autore nel caso del traduttore, l’altro-eroe nel caso dello scrittore. La traduzione svolge nei confronti della scrittura letteraria un ruolo di non poca importanza, quello di rendere visibile lo
scrittore che, in quanto scrittore, ha scelto, con il proprio tacere, di rendersi invisibile; e, paradossalmente, lo fa mediante un altro che ha scelto pure lui l’invisibilità, non parlando più a nome suo, il traduttore. Questo carattere di icona
della traduzione letteraria, che, come le sacre immagini, rende visibile ciò che
è invisibile, proprio perché il suo autore, a differenza dell’autore di un testo di
critica letteraria, si è messo da parte, è un aspetto da cui non si può prescindere per comprendere il non semplice rapporto fra traduzione-icona e originale-archetipo.
71
72
suo autore, per “la solitudine essenziale dell’opera”, come si esprime Maurice
Blanchot). Tale intenzione non è neppure quella della lingua in cui è scritto. Se
la lingua consenta la traduzione del testo: è questo generalmente il problema
della traducibilità, che è il problema della comunicazione tra le lingue. La lingua non è interessata a tale problema. Essa richiede soltanto che si dica, e si
dica in essa. Essa costringe a dire (Barthes: “la lingua è fascista”) e a dire in
essa stessa.
Ma c’è anche il problema dei generi letterari: se il genere letterario consenta la traduzione. È la questione della traducibilità dei generi poetici. Siamo così ricondotti al rapporto tra traduzione e comunicazione: se la traduzione deve
trasmettere la comunicazione del testo, l’abbiamo detto, un’opera poetica ha
ben poco da comunicare. Mediando la comunicazione, la traduzione media
qualcosa di inessenziale, e se il traduttore si mette a sua volta a poetare quello che si ottiene “è la trasmissione imprecisa di un contenuto inessenziale”
(Benjamin 1962: 39). Il genere letterario non c’entra con l’intenzione del testo
di essere tradotto. L’intenzione del testo di essere tradotto non riguarda né il
lettore, né l’autore, né la lingua, né i generi letterari. Abbiamo detto che è una
faccenda di destinazione: a chi o a che cosa è destinato? Esso è certamente
destinato a chi è in grado di leggerlo, a chi conosce la sua stessa lingua. Ma
dicendo così non stiamo di nuovo parlando delle intenzioni dell’autore? E di
nuovo dei limiti a lui imposti dalla lingua e dal genere?
Passiamo attraverso un esperienza traduttiva come quella di Antonin Artaud (1896-1948), in cui l’intenzione del testo di essere tradotto, che il traduttore Artaud prende a cuore, elude appunto qualsiasi presunta sua intenzione
che abbia a che fare l’appartenenza, come se l’intenzione del testo di essere
tradotto consistesse proprio nella sua emancipazione da ogni appartenenza, in
primo luogo quella della lingua in cui è scritto e quella dell’autore. Questa
emancipazione non è facile e non può essere realizzata semplicemente ignorando l’autore e la lingua. La traduzione deve realizzarsi in contrasto precisamente con le loro intenzioni, se vuole assecondare le intenzioni del testo. La
traduzione di Artaud si presenta così come un’operazione deliberatamente
contro la lingua e contro l’autore. Antonin Artaud intitola L’arve et l’aume la sua
traduzione in francese di Humpty Dumpty, sesto capitolo di Through the Looking-Glass, di Lewis Carroll (1832-98), fatta durante il suo internamento nell’ospedale psichiatrico di Rodez (settembre 1943) e poi rivista nel 1947. Vi aggiunge il sottotitolo “Impresa anti-grammaticale su Lewis Carroll e contro di lui”.
Ben presto (giugno 1944) Artaud aveva espresso la convinzione che la sua traduzione si era realizzata “come se si trattasse di una mia opera originale e personale con commento”.
Come osserva Gilles Deleuze (1925-95), i giochi di parole di Carroll, comprese le sue parole valigia che all’inizio Artaud aveva trovato di una “attualità
stupefacente”, non vanno al di là di una messa in caricatura dello scambio
eguale fra significato e significante, senza però denunciare le finzioni, le ipocrisie, i sacrifici, le rimozioni, le soppressioni su cui esso si basa; senza intaccare le strutture sociali, i meccanismi produttivi, i presupposti ideologici cui esso
è funzionale. In fin dei conti una scrittura rappresentativa delle “superfluità del-
Gli animali del profondo diventano figure di carta prive di spessore. A
maggior ragione Attraverso lo specchio investe la superficie di uno specchio e istituisce quella di un gioco di scacchi. […] Non è che la superficie
abbia meno nonsenso del profondo. Ma non è lo stesso nonsenso. […]
Gli eventi puri e senza mescolanze brillano al di sopra dei corpi misti, al
di sopra delle loro azioni e delle loro passioni intricate. Come un vapore
della terra, sprigionano in superficie un incorporeo, un puro ‘espresso’ del
profondo: non la spada, ma il lampo della spada; il lampo senza spada
come il sorriso senza gatto (Deleuze 1993, it.: 37-38).
L’attraversamento del testo di Lewis Carroll da parte di Artaud (leggere è
“leggere attraverso”) diviene una crudele impresa antigrammaticale contro lo
stesso Carroll. La “sommossa contro l’io e contro le condizioni ordinarie dell’io” che il testo di Carroll tradisce, nel doppio senso della parola “tradire” –
cioè perde (“fino alla perdita di tutto il corpo”) e rivela suo malgrado –, diventa obiettivo del testo lettura-traduzione-scrittura di Artaud. E vuole che nella
pubblicazione di L’arve et l’aume venga aggiunto il post-scriptum seguente:
“Ho avuto la sensazione, leggendo la poesia di Lewis Carroll sui pesci, l’essere, l’obbedienza, il ‘principio’ del mare, e dio, rivelazione di una verità accecante, la sensazione che quella poesia sono io ad averla pensata e scritta in
altri secoli e ritrovavo la mia propria opera fra le mani di Lewis Carroll” (lettera a M. Barbezat del 23 marzo 1947, ora in prefazione a L’arve e l’aume
1989). Il testo di Carroll, in fin dei conti, non è che trascrizione; la traduzione
è la scrittura.
L’arve e l’aume: da una parte la “materia” (purport) nel senso di Louis Hjelmslev, dall’altra il “linguaggio” umano come procedura modellizzante, come
scrittura, che produce interpretati e interpretanti sul piano del contenuto e sul
piano dell’espressione. Simile alla nuvola di Amleto, che cambia aspetto da
momento all’altro, è la materia nel senso di Hjelmslev (v. sopra), a cui il lavoro
segnico conferisce forme diverse e su cui ogni lingua traccia le sue particolari
suddivisioni; materia che è fisica, acustica nel caso linguaggio verbale, per ciò
che concerne la forma dell’espressione, ma è anche la “massa del pensiero”
amorfa, per ciò che concerne la forma del contenuto. Sicché, per il lavoro linguistico depositato nelle diverse lingue, come la stessa sabbia si può mettere
in stampi diversi, e la stessa nuvola può assumere sempre nuove forme, così
la stessa materia risulta formata o ristrutturata diversamente in lingue diverse
(cfr. Hjelmslev 1968: 56-57). Malgrado la sua alterità rispetto a una configura-
S AGGI
l’essere” (cfr. Deleuze 1993). Carroll sbircia nello specchio, ma sa ben tenere
lontano da sé il doppio intravisto, l’ombra. Un’infinità di “astuzie psichiche”
“senz’anima”. Un “linguaggio affettato”. La sommossa che tutta la sua opera invoca è da lui stesso sedata. La battaglia del profondo, i suoi mostri, la mescolanza dei corpi, il sotto-sopra, il sovvertimento dell’ordine, l’incontro di infimo e
elevato, di cibo ed escremento, il mangiarsi delle parole, le avventure sotterranee di Alice (titolo originario di Alice nel paese delle meraviglie), tutto questo è
soppiantato, come osserva Deleuze, da un gioco in superficie: anziché lo sprofondamento, movimenti laterali di scivolamento.
73
74
zione, malgrado le sue possibilità altre, la materia si dà sempre come significata, essa obbedisce a una forma e si presenta come sostanza. “Obbedire”,
un verbo centrale in L’arve e l’aume. L’irrigidirsi, l’ossificarsi delle parole, che
codificano, bloccano e paralizzano il pensiero, non è che un aspetto della sclerotizzazione generale dei segni umani a cui bisogna restituire le risorse dimenticate del linguaggio come processo di modellazione infinita, di scrittura. La
conseguenza di questo indurimento, di questa pietrificazione, dice Artaud in Il
teatro e il suo doppio, è che la cultura nel suo insieme prevarica sulla vita, detta legge alla vita anziché essere mezzo per comprendere ed esercitare la vita.
“Quando pronunciamo la parola ‘vita’”, precisa Artaud, “dobbiamo renderci
conto che non si tratta della vita quale la conosciamo attraverso l’aspetto esteriore dei fatti, ma del suo nucleo fragile e irrequieto, inafferrabile dalle forme”
(Artaud 1961:133). Da una parte la vita così intesa, l’arbre; la “materia matrice”, larva, embrione, uovo; dall’altra “le forme suscettibili di pietrificazione”,
l’aume, l’essere che la vita umana è diventata.
A una cultura pietrificata, che persevera nella riproduzione di se stessa, corrisponde un concetto pietrificato di teatro, il teatro della rappresentazione, un
teatro pietrificato. Ma il teatro ha la sua ombra, che costituisce il suo doppio: “il
vero teatro, in quanto si muove e in quanto si avvale di strumenti vivi, continua
ad agitare ombre in cui la vita non ha cessato di sussultare” (Artaud 1961:
132). L’inaridimento del linguaggio verbale e non-verbale, la sua limitazione,
ha comportato la perdita di rapporto con l’ombra, con la vita, con il corpo. Bisogna spezzare il linguaggio ufficiale per raggiungere la vita, rifiutare i consueti limiti dell’uomo allargare infinitamente i confini della cosiddetta realtà, cominciando col rifare il teatro, luogo specializzato della rappresentazione. Ciò richiede preparazione, calcolo. Non ci si può accontentare di “essere semplici
organi di registrazione” (ivi: 133).
L’essere è ripetizione, la vittoria sul vivere, sull’alterità del corpo. L’essere è
la vita che ostinandosi ad essere, a ripetersi, anche nelle parole, a riconfermarsi, si sottrae alla vita; conatus essendi, che si economicizza, che non si espone, che non vuole rischi, che si preserva. L’essere è il presente che riservandosi, tenendosi in serbo, per l’identità perde se stesso. Una morte per ostinazione
della presenza, una morte come ripetizione. Nella traduzione di Humpty Dumpty, il testo che traduce sorpassa il testo che si pretende “originale” ricongiungendosi alla materia matrice, l’arve, con un atto di crudeltà – già da tempo calcolato e praticato, ancor prima di incontrarsi con esso, sulla scena del teatro
della crudeltà – contro di esso, contro la lingua inglese, che Artaud non conosce bene, e contro la lingua francese. Ne risulta una metamorfosi-rinascita in un
testo che si pretende più originale del testo originale tradotto, perché si porta e
si espone alla sua stessa origine più di quanto esso abbia mai rischiato di fare.
La traducibilità riguarda il rapporto tra il testo e il linguaggio e tanto più un
testo ha operato l’attraversamento della lingua nella direzione del linguaggio (è
l’attraversamento per il quale il testo diventa letterario) tanto più non solo è traducibile, ma esige (Benjamin 1962: 40) la traduzione. La traduzione è “esigibile”: “poiché si può affermare che se la traduzione è una forma, la traducibilità
deve essere essenziale a certe opere” (ibidem). È per il rapporto col linguag-
Se nella traduzione si esprime l’affinità delle lingue, ciò non ha luogo per
una vaga somiglianza della riproduzione dell’originale. Come è evidente,
in generale, che all’affinità non deve corrispondere necessariamente una
somiglianza. E il concetto di affinità concorda in questo contesto, col suo
uso più stretto [e cioè col significato di “parentela”, esplicito nella parola tedesca Verwandtschaft], anche nel senso che esso non può essere sufficientemente definito (in entrambi i casi) da identità di discendenza, anche
se – per la determinazione di quell’uso più stretto – il concetto di discendenza rimanga indispensabile. – In che cosa si può cercare l’affinità di due
lingue – a prescidere da una parentela storica? Certo altrettanto poco nella somiglianza di opere poetiche che in quella delle loro parole. Piuttosto
ogni affinità metastorica delle lingue consiste in ciò che ciascuna di esse,
presa come un tutto, è intesa una sola e medesima cosa, che tuttavia non
è accessibile a nessuna di esse singolarmente, ma solo alla totalità delle
loro intenzioni, reciprocamente complementari: la pura lingua (ivi: 44).
Noi interpretiamo tale “pura lingua” in termini di “parlare comune” o di “lavoro linguistico” nel senso di Rossi-Landi (1998 e 2003) o, se dal verbale passiamo al semiotico, in termini di “linguaggio” nel senso di Sebeok. Spostandosi
dalla lingua al linguaggio attraverso l’apertura e la messa in dialogo delle lingue, sicché “una lingua si vede con gli occhi di un’altra lingua” (Bachtin), la “traduzione è più che mera comunicazione” (Benjamin 1962:45); e ciò risulta nella traduzione delle opere letterarie in cui la comunicazione è l’inessenziale.
Scrive Benjamin:
[…] La vera traduzione è trasparente, non copre l’orginale, non gli fa ombra, ma lascia cadere tanto più interamente sull’originale, come rafforzata dal suo proprio mezzo, la luce della pura lingua.
[…] Redimere nella propria quella pura lingua che è racchiusa in un’altra;
o, prigioniera nell’opera, liberarla nella traduzione – è questo il compito
del traduttore (ivi: 49-50).
La traduzione non rappresenta il testo orginale ma lo raffigura, vale a dire
fa sì che di esso si dia come ri-velazione e non come svelamento, come icona
e non come idolo (cfr. Luciano Ponzio 2000, 2002, 2004) rinviando dal detto al
dire, dal dicibile all’indicibile. “La versione interlineare del testo sacro è l’archetipo o l’ideale della traduzione” (Benjamin 1962:52).
S AGGI
gio che il testo non solo è traducibile, ma è destinato ad essere tradotto, e
“benché”, come dice Benjamin, “per quanto buona, una traduzione non possa
mai significare qualcosa per l’originale […], tuttavia essa è in rapporto all’orginale in forza della sua traducibilità” (ivi:41). La traduzione dipende (nel duplice
senso di “essere resa possibile” e di essere causata”) dall’affinità delle lingue
dovuta alla loro comune partecipazione al linguaggio. Scrive Benjamin:
75
14. Filosofia del linguaggio e semioetica
76
La filosofia del linguaggio, per quanto riguarda il linguaggio verbale e dunque la scienza che se ne occupa la linguistica, fa propria la vocazione al tacere e all’ascolto della scrittura letteraria e della pratica della traduzione: una concezione del linguaggio che sia quella che la scrittura letteraria e la pratica della traduzione permettono di cogliere sottraendosi al “voler sentire” imposto dalla lingua e mostrando l’insonsenibilità della “linguistica del silenzio”, della linguistica, cioè, che riduce l’enunciazione alla frase, la sua interpretazione all’identificazione, il suo valore segnico alla segnalità. Per quanto riguarda il segno in generale, la sua caratterizzazione, la sua tipologia, ecc. e dunque la prospettiva della semiotica generale, la filosofia del linguaggio si orienta verso una
semiotica della musica, nel duplice senso che abbiamo detto: cioè assumendo
il segno musicale, il linguaggio della musica, particolarmente refrattario a una
semiotica glottocentrica, come termine di verifica del proprio effettivo carattere
generale, e facendo, anche in questo caso, dell’ascolto, essenziale nella musica, la condizione metodologica di una teoria generale del segno.
Ma la filosofia del linguaggio tiene conto anche della semiotica come capacità specie-specifica, come metasemiosi e, come tale, connessa con la responsabilità: l’essere umano, unico animale semiotico, è l’unico animale capace di rispondere dei segni e del suo compo segnico, ed è quindi soggetto alla
e della responsabilità. Sotto questo riguardo, l’istanza critica della filosofia del
linguaggio nei confronti della scienza dei segni, che, nella sua attuale configurazione di semiotica globale, data la coincidenza di semiosi e vita si occupa
dell’intera vita sul pianeta, consiste concretamente nel far sì che se ne occupi
non soltanto nel senso conoscitivo, ma anche nel senso pragmatico di fare stare bene la vita, di prendersene cura. Sotto questo aspetto la semiotica recupera il suo rapporto con la semeiotica medica, che non riguarda soltanto la conoscenza storica delle proprie origini, ma anche il suo orientamento, la sua piega, nei confronti della reltà storica attuale dove la globalizzazione rende inseparabile dal destino di ciascuno quello dell’intera vita sul pianeta. Abbiamo
chiamato quest’orientamento, questa piega dello studio dei segni in un primo
tempo “etosemiotica” e successivamente “semioetica” (v. Ponzio-Petrilli
2003a). Anche in questo caso si tratta di una questione di ascolto, ma, a differenza di quanto concerne il suo aspetto specificamente teoretico, non in senso musicale, ma appunto nel senso della semeiotica medica. Si tratta di mettersi in ascolto dei sintomi dell’attuale mondo della globalizzazione, per individuarne i diversi aspetti di malessere (nei rapporti sociali, internazionali, nella
vita degli individui, nell’abiente, nella vita complessiva del pianeta). Ciò con lo
scopo di una diagnosi, di una prognosi, di cura e di una profilassi, al fine di un
futuro della globalizzazione e in contrasto con una globalizzazione votata alla
sua autodistruzione.
È il nostro presente il “futuro anteriore della semiotica” (v. Caputo, Petrilli
Ponzio 2005) perché riteniamo che si decide oggi il futuro della semiotica, non
solo come scienza, ma anche come capacità umana specie specifica di usare
i segni per riflettere sui segni e decidere di conseguenza. Il problema non è di
S AGGI
ordine semplicemente teorico poiché si tratta della semiotica anche come semeiotica, come sintomatologia, ai fini di prevenire e curare. Perché è oggi –
mai un presente è stato, come il nostro, così carico di responsabilità nei confronti del futuro e così capace di mettere a rischio la possibilità stessa del futuro –, che si decide della vita dei segni e dei segni della vita, del perdurare,
sul pianeta Terra, della semiosi. Della semiosi, della vita, in quanto animale semiotico l’essere umano è l’unico animale responsabile. E, più di ogni altro essere umano, lo è chi per professione si occupa dello studio dei segni. Parafrasando Terenzio: sono uno che si occupa di segni, e niente della vita dei segni
mi è indifferente.
* Introduzione all’edizione brasiliana di A. PONZIO, P. CALEFATO, S. PETRILLI, Fondamenti di Filosofia del linguaggio, Laterza, Roma-Bari 1999, Fundamentos de Filosofia da Linguagem, Vozes,
Petrópolis, RJ (Brasile) 2007.
Riferimenti bibliografici
ARTAUD, ANTONIN
1961 Il teatro e il suo doppio, pref. di J. Derrida, Einaudi, Torino.
1989 L’arve e l’aume, con 24 lettere a M. Baberzat, L’Arbalète, Parigi; trad. it. di L. Feroldi, in Artaud, Il sistema della crudeltà, Millepiani, 11, Mimesis, Milano, pp. 11-19.
“Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura”, serie annuale diretta da Augusto Ponzio.
1990 Il senso e l’opera, 1, Longo, Ravenna.
1991 Arte e sacrificio, 2, Longo, Ravenna.
1992 Il valore, 3, Longo, Ravenna.
1993 Migrazioni, 4, Longo, Ravenna.
1994 Materia, 5, Longo, Ravenna.
1995 Mondo, 6, Longo, Ravenna.
1996 Il mondo/Il mare, 7, Longo, Ravenna.
1997 Luce, 8, Longo, Ravenna.
1998 Nero, n. s. (= nuova serie) 1, a cura di S. Petrilli, Manni, Lecce.
1999-2000 La traduzione, n.s., 2, a cura di S. Petrilli, Meltemi, Roma.
2000 Tra segni, n.s., 3, a cura di S.Petrilli, Meltemi, Roma.
2001 Lo stesso altro, n.s., 4, a cura di S.Petrilli, Meltemi, Roma.
2002 Vita, n.s., 5, a cura di A. Ponzio, Meltemi, Roma.
2003 Nero, n.s., 6, nuova ediz., a cura di S.Petrilli, Meltemi, Roma.
2003-04 Lavoro immateriale, n.s., 7, a cura di S. Petrilli, Meltemi, Roma.
2004 The Gifth, n.s., 8, a cura di G. Vaughan, Meltemi, Roma.
2005 Mondo di guerra, n.s., 9, a cura di A. Catone e A. Ponzio, Meltemi, Roma.
BACHTIN, MICHAIL M. (v. anche Medvedev, P. N e Volosinov, V. N.)
1920-24 Per una filosofia dell’azione responsabile, trad. it. di M. De Michiel, introd. di A.
Ponzio, Manni, Lecce 1998.
77
78
1929 Problemi dell’opera di Dostoevskij, ed. critica a cura di M. De Michiel, introd. di
A. Ponzio, Dedalo, Bari 1997.
1965 L’opera di Rabelais e la cultura popolare, trad. it. di M. Romano, Einaudi, Torino
1979, nuova ed. 2001.
1975 Estetica e romanzo, trad. it. C. Janovi∫, Einaudi,Torino 1979, nuova ed. 2001.
1979 L’autore e l’eroe. Teoria letteraria e scienze umane, trad. it. di C. Janovi?,
Einaudi, Torino 1988, nuova ed. 2000.
2003 Linguaggio e scrittura, scritti in collab. con V. N. Volosinov, introd. di A.
Ponzio, trad. di L. Ponzio, Meltemi, Roma.
BACHTIN, M.M.; KANAEV I.I.; MEDVEDEV, P., VOLOSINOV, V. N.
1995 Il percorso bachtiniano fino ai “problemi dell’opera di Dostoevskij”(1919-29), a
cura di A. Ponzio, P. Jachia e M. De Michiel, Dedalo, Bari.
BACHTIN, MICHAIL (con Volosinov, Valentin, N.)
1927 Freud e il freudismo. Studio critico, trad. it. di L. Ponzio, a cura di A. Ponzio, Mimesis, Milano 2005.
1929 Marxismo e filosofia del linguaggio, a cura di A. Ponzio, trad. di M. De Michiel,
Manni, Lecce, 1998.
BACHTIN, NIKOLAJ M.
1998 La scrittura e l’umano, presentazione di A. Ponzio, trad. di M. De Michiel, Edizioni dal Sud, Bari
BARTHES, ROLAND
1978 Leçon, trad. it. di R. Guidieri, Lezione, Einaudi, Torino1981, nuova ed. insieme a
Sade, Fourier, Loyola (1971), 2001.
1982 L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, trad. it. di C. Benincasa, G.Bottiroli, G.P.
Caprettini, D. De Agostini, L. Lonzi, G. Mariotti, L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III,
Einaudi, Torino1985, nuova ed. 2003.
1984 Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, trad. it. di B. Bellotto, Il brusio
della lingua, Einaudi, Torino 1998.
2002a Comment vivre ensemble, Cours et séminaires au College de France (1976-77),
a cura di C. Coste, Seuil, Parigi.
2002b Le Neutre, Cours et séminaires au College de France (1977-78), a cura di T.
Clerc, Seuil, Parigi.
2003 La préparation du roman, I et II, Cours et séminaires au College de France
(1979-80), a cura di N. Léger, Seuil, Parigi.
BARTHES, ROLAND; HAVAS, ROLAND
1977 Ascolto, in Enciclopedia, vol. I, Einaudi, Torino.
BENE, CARMELO,
1995 Opere, Bompiani, Milano.
BENJAMIN, WALTER
1962 Angelus Novus, Einaudi, Torino.
1971 Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 1980.
BENJAMIN, WALTER ET ALII
1995 Il carattere distruttivo, “Millepiani”, 4, Mimesi, Milano.
BLOCK DE BEHAR, LISA
1997 Al margine di Borges, pres. di A. Ponzio, Edizioni dal Sud, Bari.
BONFANTINI, MASSIMO
1987 La semiosi e l’abduzione, Bompiani, Milano, nuova ed. 2003.
2000 Breve corso di semiotica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
BONFANTINI, MASSIMO; CAPUTO, COSIMO; PETRILLI, SUSAN; PONZIO, AUGUSTO; SEBEOK, T A.
1998 (a cura) Basi. Significare, inventare, dialogare, Manni, Lecce
BONFANTINI, MASSIMO A., PETRILLI, SUSAN, PONZIO, AUGUSTO
S AGGI
1996 I tre dialoghi della menzogna e della verità, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
2006 I dialoghi semiotici, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli.
BORGES, JORGE LUIS
1984-85 Tutte le opere, 2 voll.a cura di D. Porzio, Mondadori, Milano.
BOUISSAC, PAUL
1998 (a cura di) Enciclopedia of Semiotics, Oxford University Press, New York.
CALVINO, ITALO
1988 Lezioni americane, Feltrinelli, Milano; nuova ed. Mondadori, Milano 2006.
CAPUTO, COSIMO
1996 Materia signata. Sulle tracce di Hjelmeslev, Humboldt e Rossi-Landi, Edizioni
Levante, Bari.
2000 Semiologia e semiotica o la forma e la materia del segno, Graphis, Bari.
2003 Semiotica del linguaggio e delle lingue, Graphis, Bari.
2004 Semiotica e comunicazione, Edizioni dal Sud, Bari.
2006 Semiotica e linguistica, Carocci, Roma.
CAPUTO, COSIMO; PETRILLI, SUSAN, PONZIO, AUGUSTO
2006 Tesi per il futuro anteriore della semiotica. Il programma di ricerca della scuola
di Bari-Lecce, Mimesis, Milano.
COBLEY, PAUL (ed.)
2001 (a cura)The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. Routledge,
London and New York.
DANESI, MARCEL
1998 The Body in the Sign: Thomas A. Sebeok and Semiotics, Legas, Toronto; trad it.
di S. Petrilli in Marcel Danesi, Susan Petrilli, Augusto Ponzio, Il corpo nelsegno.
Introduzione alla semiotica globale, Graphis, Bari.
2000 Lingua, metafora, concetto. Vico e la linguistica cognitiva, Bari, Edizioni dal Sud.
DELEUZE, GILLES
1996 Critica e clinica, Cortina, Milano.
DE MAURO, TULLIO
1994 Capire le parole, Laterza, Roma-Bari.
DE MAURO, TULLIO; SUGETA, SHIGEAKI
1995 (eds.) Saussure and Linguistics Today, Bulzoni, Roma.
DEPRETTO, CATHERINE
1997 (a cura di) L’héritage de Mikhaïl Bakhtine, Presses Universitaires de Bordeaux,
Bordeaux.
DEELY, JOHN; PETRILLI, SUSAN; PONZIO, AUGUSTO
2005 The Semiotic Animal, Legas, New York, Ottawa, Toronto.
DERRIDA, JACQUES
2000 Che cos’è una traduzione “relevante”, in S. Petrilli 1999-2000, pp. 25-45.
2004 Il monologismo dell’altro, Milano, Cortina.
ECO, UMBERTO
1997 Kant e l’ornitorinco, Bompiani, Milano.
2003 Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani
FOUCAULT, MICHEL
1994 Poteri e strategie, a. di P. Dalla Vigna, Mimesis, Milano.
1996a Follia, scrittura, discorso, a cura di J. Revel, trad. it. di G. Costa, Feltrinelli, Milano.
1996b Scritti letterari, a cura di C. Milanes, Feltrinelli, Milano.
Il secondo rinascimento nel pianeta, Congresso mondiale di cifrematica, Milano, 28-30
maggio 2004, Spirali, Milano 2005.
IPPOCRATE DI COS
79
80
1965 Opere, a cura di M. Veggetti, Torino, UTET.
JABÈS, EDMOND
1982 Il libro della sovversione non sospetta, trad. it. di A. Prete, Feltrinelli, Milano 1984.
LÉVINAS, EMMANUEL
1996 Dio, la morte e il tempo (1993), Jaca Book, Milano.
1999 Filosofia del linguaggio, a cura di Julia Ponzio, Graphis, Bari.
2002 Dall’altro all’io, a cura di A. Ponzio, trad. di J. Ponzio, Meltemi, Roma.
LOTMAN, JURIJ
1975 La semiosfera, a cura di S. Salvestroni, Marsilio, Venezia.
LUCID, DANIEL P.
1988 (a cura di), Soviet Semiotics, John Opkins University Press, Baltimore.
MARX, KARL; ENGELS, FRIEDRICH
1845-46a Die deutsche Ideologie, in Werke, Dietz, Berlin, 1963-1968, trad. it. in MarxEngels, Opere complete, V, Editori Riuniti, Roma 1972.
2005 Manoscritti matematici, edizione critica a cura di A. Ponzio, çilano: Spirali.
MATURANA, HUMBERTO R. AND VARELA, FRANCISCO J.
1980 Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, Dordrecht: D. Reidel.
Medicina e umanità. Atti del congresso internazionale, Milano, 28-30 novembre 2003,
Spirali, Milano, 2004.
MERRELL, FLOYD
1992 Sign, Textuality, World, Indiana University Press, Bloomington.
Modernitas, Festival della modernità, Milano 22-25 giugno 2006, Spirali, Milano, 2006.
MORRIS, CHARLES
1938 Lineamenti di una teoria dei segni, a cura di F. Rossi-Landi, ried. a cura di S. Petrilli, Manni, Lecce 1999.
1949 The Open Self, Prentice-Hall, Nedw York; trad. it. e introd. di S. Petrilli, Graphis,
Bari 2002.
1964 Signification and Significance. A Study of the Relations of Signs and Values,
trad. it. di S. Petrilli, Significazione e significatività, Graphis, Bari 2000.
NÖTH, WINFRIED
1990 Handbook of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington.
ORWELL, GEORGES
1949 Nineteen Eigthty-Four. A Novel, Penguin, New York 1982; trad. di G. Baldini,
1984, Mondadori, Milano 1982.
PASOLINI, PIER PAOLO
1976 Lettere luterane, Einaudi, Torino.
1990 Scritti corsari, Garzanti, Milano.
PEIRCE, CHARLES S.
2003 Opere, a cura di M. A. Bonfantini, Bompiani, Milano.
PESSOA, FERNANDO
1994 Una sola moltitudine, 2 voll. a cura di A. Tabucchi, Adelphi, Milano.
PETRILLI, SUSAN (v. anche Ponzio A.)
1995a Materia segnica e interpretazione, Milella, Lecce.
1995b Che cosa significa significare?, Edizioni dal Sud, Bari.
1996 Bachtin Read in Italy (1980-1994), “Le Bulletin Bachtin The Bakhtin Newsletter”,
5, 1996, pp. 55-66.
1998a Teoria dei segni e del linguaggio, Graphis, Bari, nuova ed. 2001.
1998b Su Victoria Welby. Significs e filosofia del linguaggio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
1999-2000 (a cura) La traduzione, “Athanor”, 2, Meltemi, Roma.
2000 (a cura) Tra segni, “Athanor”, 3, Meltemi, Roma.
(a cura) Lo stesso altro, “Athanor, 4”, Meltemi, Roma.
(a cura) Linguaggi, Giuseppe Laterza, Bari.
(a cura) Translation Translation, Rodopi, Amsterdam.
(a cura) Lavoro immateriale, dedicato al pensiero di Ferruccio Rossi-Landi,
“Athanor”, 6, Meltemi, Roma.
2004 (a cura) Ideology, Logic, and Dialogue in Semioethic Perspective. Special Issue,
Semiotica. Journal of the International Association for Semiotic Studies, 148-1/4.
2005 Percorsi della semiotica, Graphis, Bari.
2007 (a cura) La filosofia del linguaggio come arte dell’ascolto, Edizioni dal sud, Bari.
PETRILLI, SUSAN; PONZIO, AUGUSTO
1998 Signs of Research on Signs, fascicolo monografico di Semiotische Berichte, della Österreichschen Gesellschaft für Semiotik, Jg. 22, 3/4.
1999 Fuori campo. I segni del corpo tra rappresentazione ed eccedenza, Mimesis, Milano.
2000 Philosophy of Language, Art and Answerability in Mikhail Bakhtin, Legas, Toronto.
2005 Semiotics Unbounded. Interpretative Routes in the Open Network of Signs, Toronto, University Press, Toronto.
PETRILLI, SUSAN; CALEFATO, PATRIZIA
2003 (a cura) Logica, dialogica, ideologica, Mimesis, Milano
PIETRO ISPANO (Petrus Hispanus Portugalensis)
1230 Trattato di logica. Summule logicales, cura e trad. it. di A. Ponzio con testo a
fronte, Bompiani, Milano 2004.
POE, EDGAR ALLAN
1970 Great Tales and Poems, Washinton Square Press, New York.
1987 Auguste Dupin, investigatore, Passigli, Firenze.
PONZIO, AUGUSTO (v. anche Petrilli S.)
1994 Scrittura, linguaggio e alterità tra Bachtin e Lévinas, Firenze, La nuova Italia.
1995a La differenza non indifferente. Comunicazione, migrazione, guerra, Mimesis, Milano. Nuova ed. 2002.
1995b Responsabilità e alterità in Emmanuel Lévinas, Jaca Book, Milano.
1995c El juego del comunicar. Entre literatura y filosofia, trad. spagn. di M. Arringa Flórez, Episteme, Valencia.
1995d Segni per parlare dei segni. Signs to talk about signs (testo bilingue), Adriatica,
Bari.
1996a Subjet alterité dans la philosophie de Emmanuel Lévinas, L’Harmattan, Parigi.
1996b (a cura) Comunicazione, comunità, informazione. Nuove tecnologie e mondializzazione della comunicazione, Manni, Lecce.
1997a La rivoluzione bachtiniana. Il pensiero di Bachtin e l’ideologia contemporanea,
Levante Editori, Bari; trad. spagn. La revolucion bajtiniana. El pensamiento de
Bajtin y la ideologia contemporanea, Catedra, Madrid 1998.
1997b Che cos’è la letteratura? Otto questioni dialogando con Carlo A. Augieri, Milella,
Lecce.
1997c Metodologia della formazione linguistica, Laterza, Roma-Bari.
1997d Elogio dell’infunzionale. Critica dell’ideologia della produttività, Castelvecchi, Roma. Nuova ed. ampliata, Mimesis, Milano 2004.
1999a La coda dell’occhio. Letture del linguaggio letterario, Graphis, Bari.
1999b La comunicazione, Graphis, Bari.
2001 Enunciazione e testo letterario nell’insegnamento dell’italiano come LS, Guerra,
Perugia.
2002a Individuo umano, Linguaggio e globalizzazione nella filosofia di Adam Schaff,
Mimesis, Meltemi.
S AGGI
2001
2003a
2003b
2003c
81
82
2002b (a cura di) Vita, “Athanor”, 5, Meltemi, Roma.
2002c Il linguaggio e le lingue. Introduzione alla linguistica generale, Graphis, Bari.
2003a I segni tra globalità e infinità. Per la critica della comunicazione globale, Cacucci, Bari.
2003b Modeling, dialogue, and globalization: Biosemiotics and semiotics of self, “Semiotiké? Sign Sistems Studies”, University of Tartu, 31.1, pp. 25-63.
2004a Semiotica e dialettica, Edizioni dal Sud, Bari.
2004b Linguistica generale, scritura letteraria e traduzione, Guerra, Perugia:.
2004c Testo come ipertesto e traduzione letteraria, Guaraldi, Rimini.
2004d ‘Dialogism and biosemiotics’, “Semiotica”, 150-1/4 (2004), pp. 39-60.
2005 (a cura di), Mondo di guerra, in collab, con A. Catone, fascicolo monografico della serie Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura, XIII, 5, Meltemi, Roma
2006a The Dialogic Nature of Sign, Legas, Ottawa, 2006.
2006b Linguaggio e relazioni sociali (1970) Bari, Graphis.
2006c Produzione linguistica e ideologia sociale (1970), Bari, Graphis.
2006d La cifrematica e l’ascolto, Bari, Graphis.
2006e Political ideology and the language of the European constitution, “Semiotica”.
Special issue Political Semiotics, ed. Bernard Lamizet, 159 – 1/ 4 2006.
2006f Methaphor and poetic logic in Vico, “Semiotica”, Special issue Perspective on
Metaphor. Ed. Fank Neussel, 161 - 1/4, 2006.
2006g The I questioned:Emmanuel Levinas and the critique of occidental reason, special
issue of “Subjet matter A Journal of Communications and the Self”, vol. 3, n. 3.
PONZIO, AUGUSTO; LOMUTO, MICHELE
1997 Semiotica della musica, Graphis, Bari.
PONZIO, AUGUSTO; PETRILLI, SUSAN
2000a Il sentire della comunicazione globale, Meltemi, Roma.
2000b Philosphy of Language, Art and Answerability in Mikhail Bachtin, Legas, New
York/Ottawa/Toronto.
2001 Thomas A. Sebeok and the Signs of Life., Icon Books, London.
2002a I segni e la vita. La semiotica globale di Thomas A. Sebeok, Spirali, Milano.
2002b Sign Vehicles for Semiotic Travels: Two New Handbooks, “Semiotica. Journal of
the International Association for Semiotc Studies”, 141-1/4, pp. 203-350.
2003a Semioetica, Meltemi, Roma.
2003b View in Literary Semiotics, Legas, Toronto.
2005 La raffigurazione letteraria, Mimesis, Milano.
PONZIO, AUGUSTO; PETRILLI, SUSAN, CALAFATO, PATRIZIA
2006 Con Roland Barthes alle sorgenti del senso, Mimesis, Roma.
PONZIO, AUGUSTO; PETRILLI, SUSAN; PONZIO, JULIA
2005 Reasoning with Emmanuel Lévinas, Legas, New York/Ottawa/Toronto.
PONZIO, JULIA
1999 L’oggettività del tempo. La questione della temporalità in Husserl e Heidegger.
Prefazione di Aldo Masullo, Bari, Edizioni dal Sud.
2000 Il presente sospeso. Alterità e appropriazione in Heidegger e Lévinas, Edizioni
dal Sud, Bari
2005 Il ritmo della scrittura. Tempo, alterità e comunicazione, Schena, Fasano-Brindisi.
PONZIO, LUCIANO
2000 Icona e raffigurazione. Bachtin, Malevič, Chagall, Adriatica, Bari.
2002 Visioni del testo, Graphis, Bari.
2004 Lo squarcio di Malevič, Spirali, Milano. 2005
Differimenti. Annotazioni per un nuovo spostamento artistico, Mimesis, Milano.
POSNER, ROLAND; ROBERING, KLAUS; SEBEOK, THOMS A.
S AGGI
1997-2004 (a cura) Semiotik/Semiotics: A Handbook on the Sign-Theoretic Foundations of Nature and Culture, W. De Gruyter, Berlin, 4 voll.
PRETE, ANTONIO
1996 L’ospitalità della lingua, Manni, Lecce.
PRODI, GIORGIO
1977 Le basi materiali della significazione, Bompiani, Milano.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO
1982 Ideologia (1a ed. 1978), Mondadori, Milano, nuova ed. a cura e con introd. di A.
Ponzio, Meltemi, Roma 2005.
1985a Metodica filosofica e scienza dei segni (2005), Bompiani, Milano, nuova ed. a
cura di A. Ponzio, con introd. 2005.
1985b Il corpo del testo tra riproduzione sociale ed eccedenza. Dialogo, a cura di S. Petrilli, “Corposcritto”, 2, 2, Bari, Edizioni dal Sud, 2002.
1992 Between Signs and Non-Signs, a cura di Susan Petrilli, John Benjamin, Amsterdam.
1994 Semiotica e ideologia (1a ed. 1972), a cura di A. Ponzio, Bompiani, Milano.
1998 Significato, comunicazione e parlare comune (1a ed. 1961) a cura di A. Ponzio,
Marsilio, Venezia
2003a Il linguaggio come lavoro e come mercato (1a ed. 1968), introd. e cura di A. Ponzio, Bompiani, Milano.
2003b Sritti su Gilbert Ryle e la filosofia analitica, a cura di Cristina Zorzella, present. di
Enrico Berti, Padova: Il Poligrafo.
RUDY, STEPHEN
1986 Semiotics in the USSR, in The Semiotic Sphere, a cura di T. A. Sebeok e J. Umiker-Sebeok (eds.), Plenum, New York, pp. 34-67.
SAUSSURE, FERDINAND DE
2005 Scritti inediti di linguistica generale, trad. it. di T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari.
SCHAFF, ADAM
1995 Il mio ventesimo secolo, a cura di A. Ponzio, Adriatica, Bari.
2000 Meditazioni, a cura di A. Ponzio, Edizioni dal Sud, Bari.
2003 (a cura) Sociolinguistica, trad. di A. De Luca, present. di P. Calefato, Graphis,
Bari.
SCHAFF, ADAM; SÈVE, LUCIEN
1975 Marxismo e umanesimo, a cura di A. Ponzio, Dedalo, Bari.
SEBEOK, THOMAS A.
1991 A Sign Is Just A Sign, Bloomington, Indiana University Press; trad. it., introd. e
cura di S. Petrilli, A Sign is just a sign. La semiotica globale, Milano, Spirali,
1998.
1998 Come comunicano gli animali che non parlano, introd. trad. e cura di S. Petrilli,
Edizioni dal Sud, Bari.
2000 Some Reflections of Vico in Semiotics”, in D. G. Lockwood, P.H. Fries, J.E. Copeland (a cura di), Fuctional Approaches to Language, Culture and Cognition,
John Benjamins Amsterdam, pp. 555-568.
2001a Signs: An introduxction to Semiotics, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-Londra; trad. it. di S. Petrilli, Segni. Una introduzione alla semiotica, Carocci,
Roma, 2003.
2001b Global Semiotics, Indiana University Press, Bloomington.
SEBEOK THOMAS A. AND DANESI, MARCEL
2000 The Forms of Meanings. Modeling Systems Theory and Semiotic Analysis, Mouton de Gruyer, Berlin 2000.
SEBEOK, THOMAS A., SUSAN PETRILLI, AUGUSTO PONZIO
83
84
2001 Semiotica dell’io, Meltemi, Roma,.
SEMERARI, GIUSEPPE
2005 Insecuritas. Tecniche e paradigmi della salvezza (1982), Spirali, Milano.
SHANNON, CLAUDE E.; WEAER, WARREN
1949 The mathematic theory of communication, University of Illinois Press, Urbana.
SOLIMINI, MARIA
2000 Itinerari di antropologia culturale, Edizioni dal Sud, Bari.
Stress. La clinica della vita, “Il secondo rinascimento”, 95, 2003, pp. 46-294.
TITONE, RENZO
1995 (a cura) La pesonalità bilingue, Bompiani, Milano.
UEXKÜLL, JACOB VON,
1967 Ambiente e comportamento, introd. di F. Mondella, Il Saggiatore, Milano.
1973 Theoretische Biologie [1928], Frankfurt am Main, Suhrkamp.
2002 I mondi invisibili della vita. in Ponzio A. (a cura), 2002b, pp. 53-64
VAILATI, GIOVANNI
2000 Il metodo della filosofia. Saggi di critica del linguaggio, a cura di F. Rossi-Landi,
nuova ed. a cura di A. Ponzio, Graphis, Bari.
VAUGAN, GENEVIEVE
2005 Per-donare. Una critica femminista dello scambio, Meltemi, Milano.
2004a Il Manifesto cifrematico, Spirali, Milano.
2004b La rivoluzione cifrematica, Spirali, Milano.
VERNADSKIJ, VLADIMIR I.
1926 Biosfera, Nauka, Leningrado; trad. franc. La biosphère, Seuil, Parigi, 2002.
VICO, GIAMABATTISTA
1976 Principj di Scienza nuova, tre tomi, a cura di F. Nicolini, Torino, Einaudi.
WELBY, VICTORIA
2006 Senso, significato, significatività, introd e cura di S. Petrilli, Graphis, Bari.
KANT-HEIDEGGER
IL KANT DI HEIDEGGER
E IL PROBLEMA DELLA METAFISICA
Se per Gadamer l’ermeneutica risulta fondante nel processo conoscitivo e
reinterpretativo, per Heidegger l’ermeneutica deve risolversi in metafisica, nel
senso che ogni interpretazione viene ad informarsi all’interno di una condizione temporale, intenzionale della coscienza e di un fondamento. Lo svolgimento interpretativo si sviluppa secondo un progetto, il cui obiettivo deve definire il
senso del non detto: possibilità intenzionale attorno a tutto ciò che un autore
avrebbe potuto o voluto dichiarare. L’inattualità del testo è paradossalmente il
non-dato, il non esplicitato e tuttavia percepito o sentito, nonostante il limite
temporale, lo spirito del tempo nel quale l’autore ha ideato un pensiero. Il non
detto deve esplicare, originalmente l’autentico fondamento che dispiegandosi
nei meandri di un pensiero sottile, in modo disorganico a volte celato, si svolge nelle diverse strutture concettuali. Pertanto, Kant viene reinterpretato in rapporto non solo a ciò che ha detto, ma anche a ciò che avrebbe potuto dire.
Kant, per il Primo Heidegger, e Nietzsche, per il Secondo Heidegger, pur nella differenza delle premesse e dei risultati, possono indicare la stessa cosa.
Anche se il primo rientra in un piano progettuale volto a garantire il rapporto tra
filosofia dell’esistenza e metafisica generale e il secondo,dopo la cosiddetta
Svolta, a convalidare, attraverso la figura del filosofo-destino, il rapporto tra
metafisica e oblio dell’essere, queste due fasi vanno interpretate per tutto ciò
che nella filosofia di Kant e di Nietzsche si presenta come implicito, non esplicitamente espresso.
L’interpretazione, almeno per il primo Heidegger, non comporta soltanto
una semplice conoscenza della tecnica filologica, ma soprattutto una rielaborazione filosofica improntata sulla valenza ontologica e su un’analisi esistenzialistica che per l’Heidegger della soggettività del soggetto è un riferimento
portante, originario e condizione fondamentale per intendere l’altro, il passato,
il testo e la soggettività che non devono implicare un’analisi d’ordine psicologico o antropologico.
La comprensione procede conformemente ad un circolo continuo di domande (l’interpretante) e risposte (l’interpretato), giammai risolutive, infinitamente
limitate per cogliere il senso filosofico non solo dell’autore, ma anche della verità dell’essere. Tale metodica si riscontra soprattutto in Essere e tempo e in
Kant e il problema della metafisica e comunque nelle opere prodotte prima della Svolta. Il piano di lavoro del Primo Heidegger procede attraverso una linea
guida in grado di esplorare l’apertura di comprensioni inedite, originali, e scorgere, all’interno di un impianto di pensiero, quei concetti potenzialmente capaci di dischiudersi per una rivisitazione, scomposizione e ricomposizione al fine
S AGGI
di Luigi De Blasi
85
86
di arricchirle di scenari inconsueti. La posizione di Heidegger può riallacciarsi
a quella di Gadamer, per il quale l’interpretazione definitiva sarebbe in sé una
contraddizione. L’interpretazione è sempre in cammino. La ricerca procede insistentemente ad individuare, specie in Essere e tempo, il filo conduttore per
ricostruire un nuovo sapere, una nuova filosofia antitetica alla metafisica tradizionale. Una valutazione originale diretta a rivedere l’uomo, il mondo e il concetto di Dio, attraverso il correttivo ontologico della metafisica generale, anziché speciale, valevole ad invalidare, teologicamente, l’ente Sommo che anche
se di sommo grado è una rappresentazione entizzata di Dio e come tale oggetto di un’impropria analisi scientifica.
Alla base della teoresi – il riferimento vale a questo punto anche per il Primo Heidegger – c’è la metafisica, il cui sviluppo, sciolto da residui universalistici, a-temporali, logici, ha il compito di palesare, sotto una nuova ottica, tutti
quegli aspetti legati alla cultura occidentale, tra i quali: il problema dell’essere,
del tempo, del “soggetto”. Questioni, non facilmente risolvibili, che riguardano
il problema del nulla e il suo rapporto con l’essere; il rapporto tra il tempo e l’essere, la relazione tra l’essere e l’esistenza e in ultimo l’individuazione del fondamento, da cui dipende il problema stesso della metafisica come l’accadimento fondamentale nell’essere esistenziale. Essa è l’essere esistenziale
stesso. Pertanto Heidegger pensa ad una stretta relazione di coappartenenza
tra la metafisica e l’uomo; la metafisica è il principio d’essere, principio essendi, e, kantianamente, può essere intesa come una disposizione naturale dello
spirito.
Successivamente (dopo il 1930, anno della cosiddetta Svolta) la metafisica
viene intesa come nascondimento dell’essere, oblio dell’essere e non più accadimento fondamentale nell’essere esistenziale. Essa va rivisitata e all’occorrenza rielaborata riguardo alle origini, all’essenzialità e soprattutto al fondamento oscuro.Questa questione potrebbe raccordare il Primo con il Secondo
Heidegger, giacché in entrambi si fa esplicito riferimento alle origini della metafisica di cui si ignora qualunque esplicitazione rispetto a princìpi costitutivi e
fondanti.
Secondo Gianni Vattimo, Heidegger non avrebbe superato la ripetitività dialogica, domanda e risposta, in quanto la sua metafisica risulterebbe caratterizzata da questa eterna riproduzione1. Secondo tale punto di vista, il filosofare
heideggeriano non riesce a porsi oltre la metafisica stessa e non rappresenta
nemmeno una critica serrata al pensiero filosofico da Platone a Nietzsche, a
causa di una metafisicità astratta e priva di un’adeguata tematizzazione dell’essere. Tutto ciò comporta lo scacco dell’analitica esistenziale che, basandosi sul non-senso e sul nulla, si ridurrebbe ad un circolo dialogico chiuso, ripetitivo non certo aperto ma, fondamentalmente, ritornante e legato alla soggettività dell’interpretante senza alcun riscontro oggettivo. A questa teoria si può
rispondere facendo riferimento non solo a Heidegger, ma anche a Gadamer, il
maestro dell’ermeneutica; entrambi gli autori sostengono un uso rigoroso e
giustificabile dell’interpretazione da intendere come una pre-apertura 2. La filosofia esistenziale pertanto esige un nuovo rapporto con l’altro, con il mondo,
con la “cosa” e l’infinita possibilità dell’esserci da intendere come soggetto er-
1. Rivisitazione dei concetti kantiani di autocoscienza,
immaginazione trascendentale, Io penso
Heidegger si serve della Prima edizione della Critica della Ragion pura in
quanto più rispondente all’esigenza di svelare il fondamento e più incline ad
un’inedita analisi esistenziale. Il 31° paragrafo di Kant e il problema della metafisica chiarisce la preferenza verso la Prima edizione che si presenta più
adatta a determinare l’essenza della trascendenza del conoscere e soprattutto la conversione della ragion pura in ragione pura finita 3. Sotto questo aspetto Kant era riuscito a scorgere l’originarietà del fondamento, che gli avrebbe
consentito di esplorare una ragione pura di tipo fenomenologico ma, inspiegabilmente, “Kant ha indietreggiato di fronte (alla) radice”. La puntualizzazione
della radice oscura e originaria avrebbe permesso un’elaborazione genuinamente trascendentale e pura ma Kant vide l’ignoto e dovette indietreggiare.
Nella I edizione, che risale al 1781, le sezioni II e III possono essere considerate un passaggio essenziale per la filosofia di Kant. Per quanto riguarda la
sezione II (“Deduzione dei concetti puri dell’intelletto”), Kant identifica il fondamento trascendentale (appercezione trascendentale) con il concetto di unità
coscienziale giacché “niente può venire a conoscenza se non mediante questa appercezione originaria” (Appendice p. 661). Inoltre si viene a delineare anche il rapporto esistente tra l’unità trascendentale dell’appercezione e la pura
S AGGI
rante, al quale spetta il compito di attribuire significato alle cose o dare voce all’ente, compreso il passato. Dare un senso comporta una revisione della genesi e dell’evoluzione dei valori; significa rivalutare la funzione della metafisica
che, se pur oltrepassata, non può sottrarsi all’esistenza e all’uomo.
L’opera Kant e il problema della metafisica, prodotta con l’intenzione di presentarsi come prima sezione del secondo volume (di fatto mai pubblicato) di
Essere e tempo, con il titolo La dottrina kantiana dello schematismo e del tempo come avviamento alla problematica della “temporalità”, si presentò, invece,
come testo unico nel 1929. Il riferimento a Kant risulta costante lungo il corso
di tutte le sue indagini, anche successivamente al testo in questione con Il problema della cosa. A proposito della dottrina kantiana dei princìpi trascendentali del 1962 e in seguito la Tesi di Kant sull’essere. Esiste, tuttavia, una sostanziale differenza tra il Kant concepito in Kant e il problema della metafisica e in
Essere e tempo e il Kant reinterpretato in seguito. Se nelle opere anteriori al
1929 risulta dominante il problema dell’ontologia in rapporto all’esistenza autentica e originaria, in quelle successive si cerca di assegnare al kantismo un
valore storico-epocale, nel senso, come afferma H. Hoppe (Wandlungen in der
Kant- Auffassung Heideggers), che la metafisica kantiana, lungi dal riferimento al fondamento originario, si prospetterebbe come realizzazione storica della scienza e della tecnica. Tale impostazione contrassegnò la filosofia di F.
Nietzsche, cui Heidegger assegna il valore di Destino, giacché in Nietzsche si
verrebbe ad attuare il compimento della metafisica come dispiegamento della
scienza e della tecnica.
87
88
immaginazione; è interessante notare come l’intelletto si viene a qualificare come “l’unità dell’appercezione in relazione alla sintesi dell’immaginazione” (Appendice, p. 664). Nella stessa sezione emerge il ruolo fondamentale svolto dall’immaginazione quale unità sintetica senza la quale non si può avere “nessun
concetto di oggetti”. Nella II edizione del 1787, l’immaginazione (sintesi delle
intuizioni) si viene a conformare alle categorie (cit. vol. I, p. 145), mentre nella
Prima Edizione “l’Io (è) stabile e permanente […] costituisce il correlato di tutte le nostre rappresentazioni […] è quest’appercezione, che deve aggiungersi
all’immaginazione pura per rendere intellettuale la sua funzione” (Appendice p. 667). Se confrontiamo la suddetta citazione con tutto ciò che Kant “corregge” nell’edizione del 1787, in cui si può leggere che “L’Io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni; ché altrimenti verrebbe rappresentato in me qualcosa che non potrebbe essere per nulla pensato”4, ci si accorge della sostanziale diversità d’intenti, nel senso che l’immaginazione, secondo quest’ultima visione, abbisogna del dato dell’intuizione e della sintesi rappresentativa. L’io Penso acquisisce una posizione autonoma rispetto all’immaginazione, pertanto l’Io (come l’immaginazione) perde stabilità e permanenza
e ciò comporta la rinuncia alla sua più vera trascendentalità. Tutto ciò comporta una certa dipendenza dell’immaginazione dall’intelletto e quindi dai concetti. Nella Prima edizione il concetto di causa si accosta all’appercezione trascendentale (autocoscienza) determinantesi come fondamento originario che
regola l’unità delle categorie.
Nella prima edizione la sintesi è affidata all’immaginazione pura, viceversa
nella Seconda le categorie o i concetti puri assumono il valore di funzioni unificatrici dell’intelletto; nella edizione del 1787 la sintesi è stabilita dall’Io penso
attraverso le sue rappresentazioni, e comunque assoggettato all’attività unificatrice a priori dell’intelletto.
Per il primo Kant le radici della conoscenza (“la possibilità di una esperienza in generale”) sono “senso, immaginazione e appercezione” (Appendice, vol.
II, p. 662); l’intelletto si presenta come facoltà secondaria in ordine d’importanza; nella Seconda edizione, le facoltà principali della conoscenza sono la sensibilità e l’intelletto.
Il problema del fondamento, nell’elaborazione critica compiuta da Heidegger, viene ad identificarsi con l’immaginazione trascendentale, che assume il
ruolo di funzione necessaria e non può certo essere considerata una funzione
cieca; a meno che con tale espressione non si voglia designare la parte oscura, cioè poco conosciuta. Lo svuotamento dell’immaginazione trascendentale
attuato nell’edizione del 1787 determina la decisione di attribuire una funzione
fondamentale solo alla sensibilità e all’intelletto fino a considerarli gli unici fattori capaci di generare una reale conoscenza. La seconda edizione, quindi, denota il passaggio da un’immaginazione intesa come funzione fondamentale
dell’anima ad una semplice funzione categoriale dell’intelletto. L’immaginazione e di conseguenza l’uomo si vengono a trovare in una posizione depauperata del suo privilegio fino al punto da costituirsi passivamente alla norma e al logicismo schematico5. Tra i passi filosofici più indicativi della prima edizione,
scartati successivamente dalla seconda, appaiono importantissimi il capitolo la
Noi dunque abbiamo un’immaginazione pura come facoltà fondamentale
dell’anima umana, la quale sta a base di ogni conoscenza a priori […]
senso e intelletto devono, mediante tale funzione trascendentale della
immaginazione, necessariamente coerire; ché altrimenti essi darebbero
sì fenomeni, ma non oggetti di una conoscenza empirica, né quindi una
esperienza6.
La ricerca indirizzata al primato dell’immaginazione e non certo all’intelletto
non rappresenta una questione meramente formale ed estrinseca, in quanto
con l’immaginazione viene ad attuarsi la stessa possibilità della filosofia trascendentale. Siccome l’immaginazione è parte della Deduzione trascendentale, Heidegger oltretutto insiste non solo sulla oggettività della deduzione ma
anche sulla sua soggettività. Si tratta a questo punto di seguire il percorso heideggeriano secondo gli snodi più importanti, che possono essere sintetizzati in
due assunti fondamentali:
(1) Heidegger privilegia l’immaginazione trascendentale ché potrebbe essere concepita come formatrice di una veduta (orizzonte) entro cui collocare l’ente e la sua stessa possibilità di essere conosciuto. In questa fase della ricerca,
l’immaginazione trascendentale è il fondamento, su cui si stabilisce sia la possibilità della conoscenza ontologica sia l’altra possibilità della metaphysica generalis. Si evince, quindi, la fondamentalità dell’immaginazione che risulta l’elemento fondante della trascendentalità (conoscenza ontologica) e la base della
stessa metafisica generale “La fondazione kantiana della metafisica fa capo all’immaginazione trascendentale”7.
(2) Heidegger concepisce l’io penso come parte essenziale di tutta la filosofia trascendentale e la prova di ciò segue un percorso, il cui punto di partenza indica un’identità tra il tempo e l’io nel senso che non devono essere intesi
come giustapposti, l’uno di fronte all’altro, come elementi diversi e irriducibili
giacché indicano fondamentalmente la stessa cosa 8. Come se non bastasse
l’analisi tende addirittura a considerare lo stesso io come parte integrante della metafisica.
Nel pensiero kantiano l’immaginazione, spesso, viene riferita non solo all’appercezione trascendentale, ma anche al tempo. Nel prosieguo della ricerca Heidegger avanza l’ipotesi che l’immaginazione derivi direttamente dal tempo e addirittura che immaginazione e tempo siano la stessa cosa. Severino insiste sulla problematica riguardante l’unità-identità tra tempo e immaginazione trascendentale. Per questa visione afferma in modo inequivocabile che l’unità va ad
estendersi fino a comprendere la pura intuizione (tempo), la pura immaginazione ed anche il puro intelletto. Nello sviluppo della sua analisi si può constatare
come la deduzione trascendentale ha comportato la possibilità di interpretare
l’immaginazione trascendentale come la radice di sensibilità e intelletto 9.
S AGGI
Deduzione dei concetti puri dell’intelletto e, più in particolare, la Sezione Terza
con il titolo “Del rapporto dell’intelletto con gli oggetti in generale e della possibilità di conoscere questi a priori”. L’interpretazione di Heidegger dipende dall’assunto kantiano
89
Oltre alla conclusione avanzata, Heidegger è spinto da una motivazione
fondamentale, non solo individuare il fondamento al di là del rapsodistico e
frammentario filosofare kantiano, ma anche semplificare la filosofia di Kant che
avrebbe giustapposto diverse facoltà senza intravedere il filo conduttore che
legherebbe differenti (solo apparentemente) funzioni dello spirito. Tuttavia, nella Critica della Ragion pura se da una parte vige la giustapposizione di io penso, immaginazione trascendentale, schematismo trascendentale, dall’altra è
possibile individuare l’essenziale convergenza del tempo con l’io penso e con
l’immaginazione trascendentale. Interpretando in forma trascendentale l’immaginazione, il tempo e l’io penso, Kant avrebbe scorto una concreta unità
Kant, proprio per la sua radicalità con la quale, nella sua fondazione della metafisica, ha per la prima volta interpretato trascendentalmente sia il
tempo per sé, sia l’io penso per sé li ha ricondotti entrambi alla loro identità originaria, senza tuttavia riconoscere quest’identità come tale10.
90
Heidegger pensa di aver individuato la fonte della pura trascendentalità nell’identità immaginazione-tempo-appercezione, anzi a titolo puramente introduttivo possiamo sostenere che il trascendentale coincide con la più pura possibilità. Per tale motivo l’immaginazione non può essere assoggettata a qualsiasi principio d’ordine analitico e sintetico.
Nell’analisi successiva si cerca di chiarire il rifiuto di Kant di porsi in maniera più originale rispetto alle conclusioni ottenute dalla tradizionale impostazione filosofica del passato. Il rifiuto ad andare fino in fondo denota un indietreggiamento rispetto al fondamento che avrebbe avuto lo scopo di unificare la filosofia kantiana e rifondare la metafisica fin dalla sua struttura.
La critica è tutta tesa a dimostrare che il kantismo ricalca, nelle conclusioni
e nel metodo, l’errore a suo tempo compiuto da Aristotele: entrambi i filosofi
(Kant e Aristotele) non avrebbero riportato i concetti puri e le altre attività dell’anima ad una funzione che giustificasse la pura trascendentalità e soprattutto un “qualcosa” di più originario che rendesse fattibile l’unità di tutte le facoltà
dell’uomo e superasse la giustapposizione. Un’essenza in grado di garantire la
fonte (la radice) della ragion pura, della ragion pratica all’interno di un essere
nel mondo. Si viene a delineare quella radice oscura, cui Heidegger fa continuamente riferimento e che Kant aveva pensato, ma da cui, inspiegabilmente,
era indietreggiato. L’intuizione è pura come è pura la morale autonoma come
è puro l’intelletto: la loro intima purezza deve provenire da un’unica radice fondante. Anche l’intelletto deve essere inteso “il finito in sommo grado”, e ancora l’intuizione pura è di “natura finita”. Alla base del pensiero kantiano ci sarebbero alcuni indizi su un “qualcosa” fondante, in grado di far richiamare l’idea di
una metafisica della metafisica, fondamento del fondamento: un abisso senza
fondo; che si mostra esteriormente nel dovere morale, nell’eticità. Riguardo all’edizione del 1781, Kant fa presente all’amico Markus Herz che un’indagine di
questo tipo sarà sempre gravosa. Essa contiene infatti la metafisica della metafisica; l’eventualità di un’indagine considerata gravosa avrebbe comportato
un’indagine del tutto inattuale al di là dello stesso limite temporale in cui Kant
visse e operò. La successiva elaborazione della Critica concepita come una
2. Alla ricerca del fondamento
È importante osservare che lo schema critico di Heidegger nei riguardi di
Kant, circa l’inefficace deducibilità delle categorie dell’intelletto, ricalchi in una
certa misura l’osservazione critica di Kant nei confronti di Aristotele. Kant redarguisce Aristotele per la frammentarietà con cui ha fronteggiato il problema
delle categorie e per l’assenza del filo conduttore in grado di rendere logicamente efficace e ragionevole la strutturazione categoriale. Kant si cimenta a dimostrare il legame delle categorie con la tipologia dei giudizi, contro l’impianto
di taluni che non hanno saputo servirsi di un filo conduttore. Tuttavia, solo parzialmente può essere legittimata l’affermazione: “la filosofia trascendentale ha
il vantaggio, ma anche l’obbligo, di ricercare i suoi concetti colla guida d’un
principio”11, in quanto il richiamo al presupposto, secondo cui le categorie si
mostrano come concetti primitivi e originari dell’intelletto, ostacola qualsivoglia
analisi e la derivazione dei concetti attraverso un principio fondante. La critica
di Heidegger è volta a indicare che l’impostazione di Kant riguardo alla questione dei concetti e dei giudizi, persegue, nelle conclusioni, l’equivoco aristotelico perché tutti e due i filosofi (Kant e Aristotele) non avrebbero riportato i concetti puri ad un fondamento valevole a giustificare la trascendentalità, in quanto se il principio è assimilabile alla tavola dei giudizi
il carattere della […] tavola dei giudizi… è del tutto incerto. Anche Kant
esita nel definirla; la chiama ora tavola trascendentale, ora tavola logica
dei giudizi. Così, sulla tavola kantiana dei giudizi sembra ricadere l’accusa mossa dallo stesso Kant alla tavola aristotelica delle categorie. Perché le categorie non solo non sono dedotte di fatto, ma non si possono
assolutamente dedurre dalla tavola dei giudizi12.
A mano a mano che l’esame critico nei confronti del kantismo procede vengono focalizzati i possibili princìpi trascendentali, deputati a unificare tutto il filosofare kantiano. Lo scopo di Essere e tempo, in fondo, perseguiva l’obiettivo
di puntare sul tempo originario con l’esplicito proposito di rifondare una nuova
metafisica tematizzando l’essere, comunque dipendente dalla speculazione
sulla temporalità.
Bisogna, tuttavia, tener presente che il problema ricorrente è dato non solo
dal primato della logica, dell’intelletto, dell’intuizione o dell’immaginazione, ma
anche dal problema sull’Unità essenziale. La ricerca deve oltrepassare la frammentazione che contrassegna la ragione teoretica, che per svolgersi abbisogna di ricorrenti mediazioni, senza riconoscersi in una costituzione sintetica:
l’unità essenziale o meglio il problema dell’unità essenziale della conoscenza
per porre fine all’isolamento tra le funzioni. Per tale motivo la sintesi pura non
S AGGI
“teoria della conoscenza” avrebbe eluso una ricerca faticosa? Metafisica della
metafisica rievoca un qualcosa che Kant non avrebbe reso esplicito, cui meditava ininterrottamente e, forse, per paura d’imbattersi nell’errore della vecchia
metafisica si guardò bene dal renderlo evidente.
91
92
appartiene né all’intuizione né al pensiero; la natura della sintesi pura, pertanto, non può essere né estetico-trascendentale né logico-trascendentale 13.
Un notevole contributo diretto a specificare tale prospettiva è stato apportato diffusamente soprattutto in Che cos’è la metafisica?, il cui esame si rivolge
alla speculazione sull’essenza dell’uomo al fine di delucidare il concetto di unità essenziale. Il proposito consiste nel convertire il pensiero da un ordine per
il quale pensare è conoscere per concetti ad un livello per il quale il pensiero
si stabilizza “su una via, per mezzo della quale esso pervenga alla relazione
della verità dell’essere all’essenza dell’uomo”14. Risulta tale prospettazione reiterata nell’opera più significativa per tale studio, Kant e il problema della metafisica, in cui si viene a palesare l’intento centrato su un’attenta e rigorosa analisi per specificare il primato non tanto della logica e né dell’estetica, ma dell’unità essenziale e originaria. L’unificazione originaria dell’unità essenziale
della conoscenza o l’individuazione del fondamento coincide, solo provvisoriamente, con l’immaginazione trascendentale, in quanto si arriva ad una conclusione che paradossalmente sembra non prediligere alcuna abilità o funzione.
Prende forma il principio semplificatore della pura ragione in grado di collegare i tasselli della ragione teoretica e pratica. Kant avrebbe ricalcato il vecchio
errore di proporre un uomo come un essere parcellizzato e frazionato in distinte facoltà.
La rielaborazione successiva si determina in un’unità sintetica non dipendente dalla immaginazione, dal tempo o dall’intelletto come se ognuno di essi,
a seconda della specifica visualizzazione, si costituisse in una sua unità, ma
da un qualcosa (definiamo con qualcosa una realtà che deve essere ancora
scoperta) deputato a sintetizzare le rappresentazioni, il mondo esterno e quello interno. Pertanto l’unità sintetica non appartiene esclusivamente né all’Io
penso né all’immaginazione trascendentale né al tempo.
L’elaborazione conclusiva di Severino, tuttavia, avrebbe condotto, citando
l’Heidegger del Kant e il problema della metafisica, all’esito per il quale: La pura autoaffezione – il tempo – fornisce la struttura trascendentale originaria del
“soggetto” […] finito come tale (Heidegger e la metafisica, p. 101). Sebbene il
tempo rappresenti l’idea-guida, l’interesse di Heidegger non si rivolge all’unità
di qualche particolare funzione, ma sembrerebbe dirigersi verso “qualcosa” capace di oltrepassarli. Risulterebbero evidenti differenti progettazioni: una speculazione mira a far dipendere tutte le funzioni dall’immaginazione trascendentale; una seconda tende alla fondatività del tempo; una terza prospettazione
tende ad individuare nell’intrinseca identità il livello fondante attraverso il concetto di trascendentalità; in ultimo è il soggetto in cui si viene a realizzare l’effettiva sintesi. Tempo e immaginazione trascendentale, (definita l’ignoto inquietante), in ultima analisi, conserverebbero una certa importanza ma perderebbero la valenza fondativa.
Risulta evidente l’intenzione di Heidegger ad impegnare qualsivoglia ricerca sull’io soggettivo all’interno della metafisica. Solo che bisogna chiedersi: chi
è quell’uomo che si espone alla domanda “Che cos’è l’uomo?”. Per Heidegger
non basta rispondere alla domanda “Che cos’è …?” senza considerare la possibilità di anticipare un campo di indagine non inquadrabile più nell’ambito
3. Dal “che cosa posso…” a che cosa non posso
Secondo Heidegger, Kant si posizionerebbe in una via di mezzo tra un pensiero ancorato agli schemi classici e metafisici ed un pensare il fondamento,
ossia l’essere che in Kant non traspare in modo esplicito. Pertanto l’autentica
filosofia trascendentale non si basa sull’ente (anche l’uomo è un ente) ma nella possibilità della comprensione preliminare dell’essere18. Kant giunge al primato della ragione pura, pratica; individua la possibilità di oltrepassare la sensibilità e l’intelletto con le sue idee trascendentali, ma non si avvia oltre il problema della conoscenza e della morale, perché indietreggia.
Oltretutto non è l’uomo a sorreggere le tre domande in quanto la quarta domanda Che cos’è l’uomo? sembrerebbe spogliarsi nei confronti dell’assunto:
Che cosa mi è lecito sperare?19. Nel momento in cui Kant si decide con il che
cosa, di fatto il suo che cosa posso…? approda ad una forma d’impotenza, in
S AGGI
scientifico come l’antropologia, la teologia, l’eticità ecc… La soggettività, quindi, è parte integrante di un’eventuale rifondazione che possa avere a che fare
con l’originarietà del tempo, dell’immaginazione trascendentale in quanto “il ricorso all’antropologia di Kant non è forse fallito? Senza dubbio”15. Altamente
significativo è il passaggio successivo, in cui si ravvisa un altro aspetto fondamentale che consiste nell’assegnare l’uomo interamente alla metafisica, ritenuta l’unica in grado di rispondere in modo più genuino e inedito non solo alla domanda Che cos’è l’uomo?, ma anche alla prima (Che cosa posso sapere?); alla seconda (Che cosa devo fare?) e alla terza (Che cosa posso sperare?).
Mentre per Kant alla prima domanda deve rispondere la metafisica (di tipo speciale), alla seconda la morale, alla terza la religione e alla quarta (Che cos’è
l’uomo?) l’antropologia. Se per Heidegger tutto ha inizio e fine con la metafisica che va comunque reimpostata e rifondata, per Kant tutto deve ascriversi all’antropologia, dal momento che le prime tre domande e le rispettive scienze si
riferiscono alla quarta domanda16.
Il problema circa la possibilità dell’autentica trascendentalità dipende, per
una comprensione corretta, dalla Soggettività del soggetto umano 17. Il concetto di soggettività del soggetto non deve far pensare all’idea di un’identità soggettiva (coscienziale) come un’unità permanente e stabile. La definizione soggettività viene utilizzata da Heidegger in via essenzialmente provvisoria e non
inquadrabile all’unità del soggetto, in quanto l’essenza della soggettività deve
riferirsi ad un suo uso problematico, possibilitante ed esplicantesi in una metodica quale quella di cercare.
Probabilmente, già nel cosiddetto primo Heidegger, l’indagine esistenziale
non soddisferebbe completamente la tematizzazione della metafisica nei confronti della quale, Heidegger pensava con eventualità ad un effettivo superamento attraverso uno strumentario critico più efficace e soprattutto più incline
all’approfondimento filosofico, maggiormente attrezzato per fronteggiare l’essenza della metafisica e il suo ruolo nella cultura dell’Occidente, aspetto che
sarà ampiamente ridiscusso nel cosiddetto secondo Heidegger.
93
94
quanto quell’uomo può concretamente fare ben poco nel senso che l’uomo alla fine rischia di non poter fare, di non poter sapere, di non poter sperare. A
questo punto comincia la tragedia! E la tragicità dell’uomo forse sta proprio nel
suo essersi pre-disposto all’incondizionato? Alla sua legge morale assoluta?
Per tutto ciò Heidegger pensa che sia più ragionevole collocare l’esser-ci nel
regno del condizionato ossia nel suo essere-nel-mondo.
Il punto di vista del poter… kantiano è un potere che di fatto non può per
due motivi principali: il potere dell’uomo non giunge a soddisfare le pretese se
non in un Regno dei fini; un essere infinito e onnipotente non si porrebbe nemmeno la domanda di poter o non poter. Il poter sostenere una morale pura, una
conoscenza ecc., sta a dimostrare l’insufficienza dell’uomo di affermarsi come
essere-morale; il suo poter esser fa vedere solo la sua collocazione nella temporalità, ma che non legittima l’uomo come essere morale. Non è la morale a
stabilire le regole dell’essere condizionato, al contrario è l’essenza dell’uomo
e, quindi, la limitatezza, a convalidare la legge morale. L’uomo è un essere morale perché è un essere in-finito: finito perché limitato e collocato in un essernel-mondo, infinito (e quindi illimitato) per la possibilità di oltrepassarsi nella direzione dell’essere, solo che questo essere non può essere definito. L’uomo è
un progetto gettato: progetto in quanto riesce a comprendere se stesso e il
mondo nella condizione possibilitante ed esistenziale; gettato per la semplice
ragione di trovarsi in un mondo. La limitatezza, che in ambito morale si esplica nella “condizionatezza” permette all’uomo di ricorrere al dovere, all’appello
morale.
La prospettazione delle quattro domande sottende un’essenza mancante,
priva di fondamento; di conseguenza: bisogna chiedersi per quale motivo la ragione dell’uomo pone domande circa che cosa. La quarta domanda (Che cos’è l’uomo?) deve essere posta sott’inchiesta per la semplice ragione che essa come è stata formulata e concepita rischia di compromettere l’esito per una
autentica fondazione dell’esserci e della stessa metafisica:
Questa questione non viene posta nei suoi giusti termini, sia che noi ci
domandiamo che cosa è l’uomo, e sia che ci domandiamo chi è, poiché,
con questo che cosa e con questo chi, noi già ci siam posti dal punto di
vista di ciò che è personale o oggetto. Ma ciò ch’è personale, non meno
di ciò ch’è oggettivo, trascura e insieme impedisce di vedere quel che si
essenzia nell’ex-sistenza storica dell’essere20.
Questo tipo di analisi invalida l’impostazione del chi e\o del che cosa, implicitamente configurabile nell’ottica antropologia (personale); viceversa un intendimento oggettivo ci rimanda di nuovo non al fondamento della metafisica (metafisica generale), ma a quella speciale. L’attenzione deve rivolgersi alla natura o se vogliamo al carattere problematico delle domande: chi domanda si autorivela nella sua intima essenza. Antecedentemente l’essenza della metafisica era determinata dall’originarietà del tempo, ora è la formulazione della domanda che cosa posso… a produrre l’essenza stessa della metafisica giacché
– a detta di Heidegger – un essere perfetto e infinito non avrebbe il bisogno di
S AGGI
porsi questo interrogativo in ragione della sua stessa natura. Il non-potere dell’uomo non deve essere inteso come una deficienza, ma nel senso preciso di
una immunità da qualsiasi deficienza o negazione 21. La stessa ragione morale che si esprime nel dovere è consapevole di cogliersi nella condizione di chi
non ha ancora adempiuto, per cui abbisogna di chiedersi che cosa debba. Il
“non ancora” di un adempimento manifesta un’essenziale indeterminatezza: il
segno di un essere che, annettendo il suo intimo interesse a un dovere, ammette nella sua più intima essenza la precarietà, il non-essere ancora. La tragedia di un uomo che è consapevole di non poter sapere, l’impossibilità del fare o di adottare la legge morale come morale pura; un che cosa posso sperare che rischia di concludersi nella disperazione e una quarta domanda cui è
estremamente problematico rispondere. Per tale prospettiva potrebbe venir
meno anche un caposaldo, il comandamento della filosofia kantiana: l’idea dell’Incondizionato. Pertanto l’attività pratica incorre nel rischio di risolversi, purtroppo, nell’impossibilità di poter mettere in atto tutto ciò che attiene al mondo
intelligibile, e “dal momento che l’uomo non può tendere, assolutamente verso
la santa volontà, (il regno di Dio) […] senza mai poter raggiungerli, la sua esistenza è tragica”22. Il filosofare kantiano sembrerebbe per L. Goldmann concretarsi nella tragedia nel non poter fare, un non poter sapere e, soprattutto,
nel non poter sperare. Bisogna, tuttavia stabilire una differenza tra un non può
tendere e un non poter raggiungere. L’uomo non può rinunciare al suo tendere verso…, anche se di fatto può essere conscio di non potere mai raggiungere la perfezione e la purezza della moralità. Kant non vuole rispondere in modo esplicito e dichiarativo; fa riferimento ad un fondamento solo rapsodicamente; non risponde per esempio alle domande fondamentali Che cosa …, in
quanto alla prima domanda non risponde la metafisica, alla seconda non risponde la morale, alla terza la religione non risponde se non con il suo stesso
domandare. Così per la quarta l’uomo non può rispondere senza interrogare
nuovamente se stesso. Sarebbe legittimo domandarsi se la radice della Metafisica non si basi, innanzitutto, sul continuo domandar-si. È come se Kant avesse ancora una volta rifiutato (anzi indietreggiato per usare la citazione di Heidegger) di rispondere in modo definitivo, tuttavia – e tutto ciò deve valere anche per l’uomo – Kant non rinuncia ad interrogarsi. È come se Kant, alla base
delle tre domande, avesse compreso l’uomo (Cos’è l’uomo?), ma a fondamento dell’uomo è come se avesse anteposto la stessa domanda. All’origine delle
tre domande non c’è la risposta delle tre discipline ma la condizione dell’uomo
destinato a riproporre la stessa domanda (?). Può risultare ragionevole supporre che il domandarsi (le quattro domande – ? –) della ragione possa sottendere non solo un’inquietudine fondamentale ma anche il senso di una metafisica
che si viene a cogliere in quella che Kant definisce come una disposizione dello spirito? Il fondamento che non si dà né come oggetto né come soggetto né
nella direttiva dell’ente ma di un essere, la cui radice può possibilmente rilevarsi nell’interrogante.
In contrasto con la metafisica classica che, alla domanda su Dio e la sua
esistenza, procedeva con uno strumentario logico strutturato su costrutti logico-teologici, la metafisica kantiana (fondamento originario), adeguatamente ri-
95
96
visitata, deve far riferimento al pro-porre semplicemente la domanda in base
ad un preciso criterio trascendentale (da Kant individuato nell’idea trascendentale, in seguito nella supposizione e in ultimo nel postulato) senza che l’uomo
possa, in nessun caso, “promettersi” in modo esaustivo e definitivo, e nell’incessante postulare, cioè “domandar-si” si viene a cogliere l’essenza morale,
teologica e il destino stesso dell’uomo. In base a ciò la postulazione non deve
riferirsi, come era avvenuto per Kant, ad un’asserzione postulativa matematica o di natura prettamente logica; deve invece richiamare l’idea di una richiesta, di una domanda e tale prospettazione non contraddirebbe, certamente, il
costrutto criticistico anzi lo renderebbe più rispondente ad una formulazione
autenticamente autonoma e originaria, antitetica a quella tradizione filosofica
che per lungo tempo aveva utilizzato e sfruttato le asserzioni dei postulati per
convalidare una determinata filosofia politica o del diritto.
La metafisica classica concepiva la possibilità della trascendenza nella domanda cui faceva seguito una risposta sull’uomo, su Dio e sul mondo. Per la
metafisica rinnovata (kantiana) la domanda continua e tormentosa potrebbe
essere l’autentica legge della coscienza anche se la teologia, ragionevolmente, trasforma la domanda in speranza che, cristianamente, comporta la disperazione dell’uomo giacché l’esistenzialismo ha indicato lo stretto rapporto esistente tra speranza e disperazione che informa la stessa fede da non intendere come un “porto di quiete” ma un porto aperto.
5. Il noumeno: perché Heidegger rifiuta la cosa in sé?
Anche rispetto alla questione del noumeno, Heidegger preferisce rivalutare
la Prima edizione della Critica della ragion pura, ché gli sembra maggiormente strutturata sulla trascendentalità23.
Con la Seconda edizione si passa dalla determinazione secondo cui non
varrebbe più la funzione logica nei giudizi come condizione della possibilità
delle cose stesse alla precisa indicazione per la quale
Il concetto di noumeno, cioè di una cosa che deve essere pensata […]
come cosa in sé […] giacché non si può della sensibilità asserire che sia
l’unico modo possibile di intuizione […]. Il concetto di noumeno è dunque
solo un concetto limite (Grenzhegriff), per circoscrivere le pretese della
sensibilità, e di uso, perciò, puramente negativo24.
Il noumeno rappresenta il limite all’uso dei concetti puri dell’intelletto che
non possono essere mai di uso trascendentale, ma solo sempre di uso empirico (cit. I. Kant, Critica della ragion pura, Vol. I, p. 250); nella prima edizione e
più specificamente nel paragrafo 3, titolato Della sintesi della ricognizione nel
concetto, appare evidente il ruolo portante della coscienza, in virtù della osservazione secondo la quale
questo oggetto non deve essere pensato se non come qualcosa in generale = x, perché fuori della nostra conoscenza noi non abbiamo più nulla,
Per Kant la critica della metafisica classica si compie con la ragione che pone il limite alla pretesa di estendere gli a priori nei confronti dell’in sé; per Heidegger, paradossalmente, la cosa in sé, nella sua accezione negativa o positiva, si qualifica già metafisicamente, in quanto essa implicherebbe la preclusione di tutte le possibilità più autentiche. Innanzitutto, bisogna tener presente
che per Heidegger, non è la cosa in sé a contrassegnare la natura finita della
ragione pura e dell’intelletto e quindi della conoscenza, dal momento che un
essere infinito non potrebbe anticipare una cosa posta fuori di sé; al contrario
è l’esser-ci a fissare i limiti e perciò la stessa possibilità della cosa in sé (noumeno) o per dirla con Kant il concetto stesso di un qualcosa posto fuori di me.
Pertanto non è la cosa in sé a fondare e stabilire la finitezza, ma è la “gettazione” (vero limite per l’uomo) che permette l’affermazione o la negazione dell’in
sé. Oltretutto, Heidegger non pensa al rapporto uomo-mondo secondo l’ottica
di soggetto-oggetto, mediazione questa già superata dal “maestro” Husserl;
non c’è per Heidegger un in me e un fuor di me come se si trattassero di realtà già date per se stesse.
Kant, quindi, avrebbe presupposto “la distinzione e la connessione dell’in
me e del fuori di me”26. Ha accolto da un lato “l’oggetto in un duplice significato, cioè come fenomeno o come cosa in sé”, dall’altro, la stessa volontà, l’ha
concepita come fenomeno e come appartenente ad una cosa in sé. Riconosce
valido il fuor di me che non appartiene all’immaginazione: “il senso e non l’immaginazione, che lega inseparabilmente l’esterno al mio senso interno” (Critica della ragion pura, p. 35). Non considera la possibilità di un io, che si viene
a determinare o come fuori di se stesso e in se stesso, in quanto pensa alla
cosa in sé nel modo di datità, nella presenza costante senza presupporre la
cosa come condizione della volontà nel suo essere nella limitatezza (come nella seconda edizione del 1787) e per questo la cosa in sé è già data.
Kant, considerando la volontà nel duplice significato noumenico (nella sua
accezione pura) e sintetico, non si sarebbe spinto a determinare la possibilità
di una volontà che fa di un qual-cosa un oggetto (fenomeno) da una parte e
una cosa noumenica dall’altra; pertanto la cosa viene visualizzata o come noumeno (l’in sé) e come fenomeno (il per sé).
Se qualcosa viene posta come oggetto, ciò dipende dal fissarsi nell’ordine
costante del tempo, così come la permanenza nel tempo di un vissuto esistenziale può determinare la stabilità di un io che si definisce come soggetto. Ciò
che viene definito come dato di esperienza possibile è sempre riferibile ad una
configurazione relazionale di soggetto-oggetto che rende fattibile una certa conoscenza. La filosofia di Kant si collocherebbe all’interno di una veduta per la
quale si presentano (presenza) una soggettività e una oggettualità; in questo
senso apparterrebbe alla filosofia tradizionale; tuttavia l’originalità può dipendere dall’aver indicato la possibilità di andare “oltre”. Quando Kant definisce
trascendentale “una conoscenza che si occupa non degli oggetti, ma del no-
S AGGI
che si possa porre a riscontro di questa cognizione come corrispondente […] noi troviamo che il nostro pensiero del rapporto di ogni cognizione
col suo oggetto25.
97
98
stro modo di conoscerli” vuole affermare che il modo concernerebbe l’andaroltre gli oggetti stessi; Heidegger non a caso insiste sul fatto che la conoscenza trascendentale non esamina l’ente stesso, ma la comprensione preliminare
dell’essere27. Quel modo deve riferirsi all’a priori, ma Kant non avrebbe colto la
vera essenza di quegli a priori, senz’altro basilari per l’intelletto, ma non solo.
Il nostro modo di… non riguarderebbe l’oggetto, ma il suo essere non esclusivamente configurabile come oggetto di conoscenza. Alla domanda: qual è l’essenza degli a priori? Kant non ha risposto. Stabilendo il concetto di conoscenza trascendentale come una forma di conoscenza “che si occupa non di oggetti, ma del nostro modo di conoscenza degli oggetti in quanto questa deve esser possibile a priori”28, aveva già intuito la possibilità dell’oltrepassamento dell’oggetto stesso, ossia come afferma Heidegger l’andar oltre (la trascendenza).
Forse, alla domanda di cui sopra, Kant non poteva rispondere, in quanto sarebbe andato incontro ad un tipo di ricerca azzardata con la conseguenza di
invalidare l’idea di scienza così come era intesa nel suo tempo (“vide l’ignoto
e indietreggiò”). Kant aveva pensato di rispondere riguardo al problema della
metafisica con la domanda “che cosa posso sapere?”, ma in questo “cosa posso” non poteva cogliere la verità, il fondamento, poiché nel che cosa … si attua lo sbarramento nei confronti dell’essere. Analogamente, partendo dall’assunto che cos’è l’uomo? o chi è l’uomo, Kant lo avrebbe di fatto concepito, preliminarmente, in senso personale 29. Il che cosa preclude, pregiudizialmente,
qualsivoglia tematizzazione dell’essere. Per Heidegger questo “che cos’è l’uomo? ” non rivela, in modo autentico, l’interrogazione sull’esserci dell’uomo.
6. La metafisica come possibilità fondativa dell’etica
A questo punto, bisogna chiedersi: in che modo si caratterizza la questione
ontologica per Kant? L’ontologia si caratterizza con la tematizzazione del fondamento, esplicantesi in un “al di là” (anche a livello morale); una trascendenza o un andare oltre, però comprendente la sensibilità.
Il distacco tra la vecchia metafisica e quella nuova dipende dall’aver, Kant,
pre-disposto con l’appercezione trascendentale (teoresi) e con la persona e il
suo “rispetto” (ragion pratica) i requisiti fondanti l’oltrepassamento e quindi il
problema dell’essere. Secondo Heidegger la sintesi a priori si compie nel rapporto tra l’esistenza e l’essere; esisterebbe un rapporto di coappartenenza tra
esistenza ed essere: questo è l’unico modo per convalidare, esistenzialmente,
il significato di sintetico a priori da interpretare quindi come unità di un vissuto
e tematizzazione dell’essere.
Anche se risultasse vera l’affermazione di coloro i quali sostengono l’eclissamento della metafisica, di cui nella Critica della ragion pratica non sembra
esserci una pur minima traccia, è ragionevole chiederci: perché Kant lascia cadere l’idea della metafisica per sostenere l’intelletto, la sua logicità, che, nella
prima edizione, era stato sovrastato da altri spunti teoretici come l’immaginazione trascendentale e intuizione pura? Cosa potrebbe significare metafisica
della metafisica? Metafisica della metafisica potrebbe avere a che fare con l’in-
1 Vattimo è dell’avviso che “l’infinità dell’interpretazione, il perpetuo riprodursi della dialetticadialogica di domanda e risposta […] ha qualcosa dell’erramento dell’uomo e dell’esilio […] l’insistere dell’ermeneutica, […] e sull’infinità dell’interpretazione appare anch’esso un momento interno dell’epoca della metafisica, che non può presentarsi come suo oltrepassamento” (Le avventure della differenza. Che cosa significa pensare dopo Nietzsche e Heidegger, Garzanti, Milano
1980, p. 39).
2 L’assunto di Heidegger, sotto certi aspetti, somiglia a quello di Gadamer secondo il quale il
testo porta ad espressione un certo contenuto, ma che ciò accada dipende in definitiva dall’inter-
S AGGI
tento di mettere a punto un fondamento tale da legittimare un primato della metafisica. Un rimando, quindi, ad un qualcosa di originario e fondante; che Kant,
disgraziatamente, non avrebbe voluto chiarire, cui egli meditava ininterrottamente e che, forse, per paura di imbattersi in un errore così usuale nel sistema della tradizionale metafisica ben si guardò dal esporlo manifestamente (?).
Un’altra domanda, seguendo l’impostazione heideggeriana, potrebbe essere così disposta: è possibile, riguardo al tema morale, individuare un aspetto
che solo esteriormente si presenti come “questione morale”, quando, invece,
ciò che risulta “morale” non faccia riferimento ad una tematizzazione ontologica, fino al punto di identificare il problema morale con il problema generale della metafisica? Ancora, Kant denomina il suo metodo (alludendo anche alla metafisica) critico, ma seguendo l’impostazione di Heidegger – Kant ha realmente sottoposto all’esame (al tribunale della ragione) critico la metafisica e soprattutto i suoi eventuali sviluppi? Esisterebbero spunti tali da indurci a pensare al
modo in cui Kant abbia potuto rappresentare e mascherare nelle sue tre Critiche la metafisica? È ragionevole considerare, nelle opere posteriori all’edizione del 1787, un’effettiva continuità intenzionale, riguardante una radice, velatamente attiva negli scritti kantiani, anche se, solitamente e comunemente,
configurata come legge morale? Basterebbe, a questo punto, chiamare in causa la Fondazione della metafisica dei costumi in cui, contrariamente alla Critica della ragion pratica, Kant fa esplicito riferimento alla metafisica e ad un suo
totale primato anche nei confronti della morale, e non a caso fa dipendere la
morale dalla fondazione, cioè da un fondamento; tale impianto darebbe ragione all’assunto di Heidegger: “se manca [la] metafisica […] diventa addirittura
impossibile […] fondare i costumi [la morale] sui loro veri principi”30. Ad un certo punto, con la Critica della ragion pratica l’impostazione così come emerge
dalla Fondazione viene messa da parte per convalidare la “supremazia” dell’etica che non risulta deducibile da altri princìpi non assolutamente dipendenti dalla legge morale. È proprio la Fondazione che, più e meglio di ogni altra
opera kantiana, giustifica il proposito di Heidegger, giacché in quest’opera Kant
afferma in modo esplicito l’idea di una “legge morale nella sua purezza e genuinità […] è da cercarsi nella filosofia pura; bisogna dunque che questa [la
metafisica] preceda, altrimenti non può darsi alcuna filosofia morale”31. Per tutto ciò, non più una metafisica come etica, ma un’etica come metafisica; e ancora non più una metafisica come estetica, ma un’estetica come metafisica.
99
100
prete […]. Il significato di un testo non va perciò paragonato a un immobile e unico punto di vista
fissato una volta per tutte […]. Ciò significa che nella riattualizzazione del senso del testo sono
sempre coinvolte anche le opinioni proprie dell’interprete. Così l’orizzonte proprio dell’interprete si
rivela determinante (H. GADAMER, Verità e Metodo, Paravia, Torino 1992, p. 73).
3 M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, Laterza, Roma-Bari 1985, p. 140.
4 Critica della ragion pura, trad. di G. Gentile e G. Lombardo Radice, vol. I, Laterza, Bari 1977,
p. 132.
5 “Persino il brano con il quale Kant introduceva per la prima volta nella Critica della ragion
pura l’immaginazione trascendentale, definendola come una “indispensabile funzione dell’anima”,
subisce in seguito, benché soltanto nella sua copia personale, una variazione assai sintomatica.
Anziché “funzione dell’anima”, Kant preferisce scrivere “funzione dell’intelletto”. E così la sintesi
pura risulta assegnata all’intelletto puro” (M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, cit. p.
141).
6 Critica della ragion pura, Appendice (prima ed.), vol. II, p. 668.
7 Kant e il problema della metafisica, cit. pp. 169, 173.
8 Ivi, p. 165.
9 E. SEVERINO, Heidegger e la metafisica, Adelphi, Milano 1994, p. 94.
10 Kant e il problema della metafisica, cit., p. 165.
11 Critica della ragion pura, cit., vol. I, p. 105.
12 Kant e il problema della metafisica, cit., p. 56. Nell’impianto kantiano, il funzionamento delle
categorie non ha un’effettiva dimostrazione in sede teoretica, in quanto le attività trascendentali dell’intelletto necessitano di una mediazione sintetica, perché possa convalidarsi ogni conoscenza possibile. Pertanto l’esercizio delle categorie per Heidegger manifesta una certa giustapposizione, si
tratta, allora, di sviluppare una ricerca volta ad individuare un filo conduttore in grado di favorire il
transito non solo categoriale, ma anche di svolgere la funzione mediativa tra l’attività teoretica e pratica, senza che quest’ultima si arroghi il diritto o addirittura la pretesa di un primato. Le categorie risultano essere fissate secondo un ordine universale e necessario, senza che la ragione critica sia
in condizione di chiarirne l’effettiva origine. Per Heidegger non è sufficiente appurare la genesi delle categorie senza individuare un fondamento diretto, principalmente, a invalidare le molteplici giustapposizioni teoretiche. Heidegger, nel capitolo titolato Stadi di svolgimento del progetto dell’intrinseca possibilità dell’ontologia, affronta tale questione, prospettando l’idea di riconsiderare il difetto
genetico della tavola categoriale l’“Origine delle categorie è stata molte volte messa in dubbio, e lo
è tuttora. Il principale motivo di perplessità deriva dal carattere discutibile e dall’insufficiente fondatezza della stessa fonte originaria, la tavola dei giudizi in quanto tale. In realtà, Kant non sviluppa la
molteplicità delle funzioni che si esplicano nel giudizio […]. Egli presenta, invece, una tavola già
compiuta, articolata secondo i quattro momenti capitali: Quantità, Qualità, Relazione, Modalità. Ma
non mostra in pari tempo se e in qual misura questi quattro elementi trovino fondamento nell’essenza dell’intelletto. Ed è lecito porre in dubbio che essi possano, in genere, essere suscettibili di una
fondazione puramente logico-formale” (p. 56).
13 Ivi, p. 64.
14 M. HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, trad. di A. Carlini, La Nuova Italia, Firenze 1964, p.
72.
15 Kant e il problema della metafisicai, cit., pp. 178, 179.
16 Se Kant nella Dottrina trascendentale del metodo, nel paragrafo Dell’ideale del Sommo bene come principio determinante del fine ultimo della ragion pura, allo scopo di accostare la conoscenza teoretica alla morale pura pratica, riassume con tre domande l’interesse della ragione
(“Ogni interesse della mia ragione (così speculativo, come pratico) si concentra nelle tre domande seguenti” 1° Che cosa posso sapere? 2° Che cosa devo fare? 3° Che cosa posso sperare?” –
Heidegger, solo in parte in accordo con l’impianto kantiano, inserendo le domande nell’ambito della Metaphysica specialis, specifica meglio una quarta domanda, a dire il vero già contemplata da
Kant: Che cos’è l’uomo?; Alla prima domanda risponde la metafisica, alla seconda la morale, alla
terza la religione e alla quarta l’antropologia. In fondo, potrebbe ascriversi tutto all’antropologia, dal
momento che i primi tre problemi si riferiscono al quarto). Heidegger condivide l’interesse di Kant
a comprovare come l’origine della conoscenza e della scienza (compreso il problema Dio) abbiano principio e fine nell’uomo, anche se Kant non avrebbe tenuto conto dell’autentica natura dell’uomo, un concetto di natura legato alla scienza antropologica e alla filosofia tradizionale. La com-
S AGGI
prensione dell’uomo viene a chiarirsi non nel suo essere già dato come ente biologico, psicologico, storico-dialettico ecc., ma nel suo porsi come esser-ci, nell’accezione dell’ermeneutica della finitudine. Il Criticismo come filosofia del limite della ragione viene per Heidegger inteso come metafisica del finito “giacché la comprensione dell’essere “è” essa stessa la più intima essenza della
finitezza. Con ciò, abbiamo ottenuto proprio quel concetto della finitezza che sta alla base di una
problematica della fondazione della metafisica. […] il problema della fondazione della metafisica
trova la sua radice nell’interrogazione sull’esserci nell’uomo, o meglio sul suo più intimo fondamento, la comprensione dell’essere come finitezza essenzialmente esistente”, Kant e il problema della metafisica, cit., pp. 197, 198.
17Ivi, p. 178.
18 “Una conoscenza trascendentale, dunque, non prende in esame l’ente stesso, ma la possibilità della comprensione preliminare dell’essere”; Ivi, p. 23.
19 “Il comandamento (afferma Kant è quello) di realizzare il Sommo bene (che è) fondato oggettivamente – nella Ragion pratica”. Il destino dell’uomo si realizza attraverso le sue azioni pratiche al fine di costituire una perfetta comunità, il sommo bene, la pace perpetua. Ma l’incapacità,
ossia l’impossibilità dell’uomo di poter realmente attuare quei modelli o quei valori, segna la tragedia “e dal momento che l’uomo non può tendere, assolutamente verso la santa volontà, (il regno
di Dio) […] senza mai poter raggiungerli, la sua esistenza è tragica”; L. GOLDMANN, Introduzione a
Kant, trad. di S. Mantovani e V. Messana, Mondadori, Milano 1975, p. 180.
20 Che cos’è metafisica?, cit., pp. 101, 102.
21 Kant e il problema della metafisica, cit., p. 186.
22 L. GOLDMANN, Introduzione a Kant, cit., p. 180.
23 “Se si lasciano da parte tutte le condizioni della sensibilità, che mostrano le categorie come
concetti di un uso empirico possibile, e si considerano come concetti delle cose in generale (quindi di uso trascendentale), non resta altro che considerare la funzione logica nei giudizi come condizione della possibilità delle cose stesse, senza tuttavia poter menomamente indicare dove mai
possano avere la loro applicazione e il loro oggetto, e cioè come possano nel puro intelletto, senza sensibilità, acquistare qualche significato e valore oggettivo” (Critica della ragion pura, vol. I,
cit., p. 247, nota 3).
24 Ivi, vol. I, p. 257.
25 Ivi, vol. II, Appendice, p. 655.
26 M. HEIDEGGER, Essere e tempo, trad. di P. Chiodi, Longanesi, Milano 1970, p. 254.
27 Kant e il problema della metafisica, cit., p. 23. “Una conoscenza trascendentale, dunque,
non prende in esame l’ente stesso, ma la possibilità della comprensione preliminare dell’essere
dell’ente. Essa riguarda “l’andar oltre” (trascendenza) della ragion pura verso l’ente, grazie al quale l’esperienza può finalmente conformarsi all’ente come al suo possibile oggetto”.
28 Critica della ragion pura, vol. I, Introduzione), cit. p. 58.
29 Che cos’è metafisica?, cit., p. 101.
30 Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, Bari 1980, p. 37.
31 Ivi, p. 7. Più avanti, Kant rende più esplicito il concetto non di una metafisica come etica, ma
di un’etica come metafisica: “se manca questa metafisica, non solo diventa vano determinare esattamente per il giudizio speculativo l’elemento morale del dovere in tutto ciò che è conforme al dovere, ma diventa addirittura impossibile […] fondare i costumi sui loro veri princìpi” (p. 37).
101
AI LIMITI DI FENOMENOLOGIA
E STRUTTURALISMO. IL CONCETTO
DI STRUTTURA NELLA FILOSOFIA
DI MAURICE MERLEAU-PONTY
di Silvia Chiletti
Non ci sono da cercare delle cose spirituali,
ci sono solo delle strutture del vuoto – Semplicemente,
io voglio conficcare questo vuoto nell’Essere visibile,
mostrare che esso ne è il rovescio
Il visibile e l’invisibile
102
“Merleau-Ponty […] is neither a pure phenomenologist nor a pure structuralist […] but something else, a Merleau-Pontean”1. Questa affermazione con
cui James. M. Edie tenta di definire la filosofia di Maurice Merleau-Ponty può
dare l’impressione di una banale tautologia, ciononostante essa riassume efficacemente le risposte degli studiosi che si sono confrontati con la sua filosofia: non è possibile annoverare Merleau-Ponty all’interno della corrente strutturalista, così come non sarebbe esauriente definire questo pensatore come
l’erede francese della fenomenologia husserliana. Se si continua la ricerca sull’argomento, infatti, ci si troverà davanti ad una manciata di articoli non troppo
recenti, provenienti per lo più dal mondo filosofico anglo-sassone, alcuni dei
quali, già dal titolo, annunciano più o meno tutti la stessa tesi: il pensiero di
Merleau-Ponty si colloca fra, between, la fenomenologia e lo strutturalismo, è
una sorta di punto a metà strada2.
Il titolo del presente saggio vuole riprendere e, allo stesso tempo, precisare questa posizione: da un lato è innegabile che le due correnti si avvicinino significativamente e lascino tracce importanti nel pensiero merleau-pontyano,
dall’altro lato, usando la locuzione ai limiti, invece di un semplice fra, intendo
dichiarare fin da subito che la posizione di Merleau-Ponty non è una via di
mezzo, o una commistione, un “imbroglio phénoménologico-structuraliste”3,
ma una prospettiva che va oltre, una sorta di terza dimensione generata dal
mantenimento e, allo stesso tempo, dallo sconvolgimento delle due prospettive accennate.
Merleau-Ponty stesso, inoltre, ha sempre voluto precisare che il suo pensiero non si fonda su compromessi. La filosofia merleau-pontyana ha come
scopo sin dall’inizio dichiarato quello di “comprendere i rapporti di coscienza e
natura – organica, psicologica o anche sociale”4 superando le opposizioni della filosofia tradizionale; parlare di compromesso, di un semplice fra, non significa altro che inserire un punto a metà strada tra due estremi che restano così
immobili. La riflessione sui rapporti tra coscienza e natura, al contrario, esige
la ricerca di una continuità fra questi due poli opposti, che spieghi come essi si
contaminino a vicenda. Come si cercherà di mostrare in queste pagine la so-
S AGGI
luzione merleau-pontyana di tutte le aporie sta nel considerare il pensiero laddove esso confina con il non-pensiero, nel portare l’idea fino ai suoi estremi, fino al punto in cui essa si confonde con la negazione di sé e ci mette di fronte
al polimorfismo irriducibile della realtà. È qui, ai limiti 5 delle cose, che la riflessione filosofica deve concentrare le sue forze per comprendere la fonte da cui
hanno origine i significati adottati da una cultura.
Per portare avanti questo tipo di pensiero Merleau-Ponty sfrutterà uno dei
concetti particolamente in voga negli anni della sua produzione filosofica: il
concetto di struttura. Il presente articolo vuole pertanto mettere il luce come tale concetto incarni un ruolo decisivo nel momento in cui Merleau-Ponty si distacca da fenomenologia e strutturalismo per fondare un nuovo pensiero dell’Essere e offrire una nuova comprensione del rapporto del vivente con il mondo che lo circonda.
1. Struttura e Gestalt: nuovi strumenti per l’analisi trascendentale
Il concetto di struttura è centrale già a partire dalle prime opere, La struttura del comportamento del 1942 e Fenomenologia della percezione del 1945: in
queste pagine Merleau-Ponty si rifà esplicitamente dall’idea di Gestalt, principio della priorità del tutto sulle parti, elaborata dalla psicologia della forma6.
Nella prima opera Merleau-Ponty usa tale concetto per la descrizione e la spiegazione di fenomeni quali il comportamento animale e umano, l’integrazione
dell’individuo nell’ambiente, o, come nel caso dell’uomo, la percezione e la coscienza. Egli intende così superare alcune aporie della psicologia e della filosofia tradizionale, come le teorie associazioniste, il causalismo meccanicista, il
dualismo anima-corpo, spiritualismo-materialismo. Già da queste prime pagine tuttavia Merleau-Ponty mira ad una caratterizzazione particolare del concetto, scostandosi dalle conclusioni e dagli scopi della Gestaltpsychologie: egli rifiuta qualsiasi principio realista-materialista, l’idea che le strutture fisiche siano
il sostrato di quelle biologiche e psichiche.
La struttura, per essere compresa, deve essere colta come un significato, signification incarnée 7, di cui sappiamo disporre senza conoscerne punto per punto la definizione: essa coincide col rapporto immanente di senso che si instaura
tra l’organismo, in quanto disposizione, e l’ambiente. Per queste ragioni la struttura appare un essere fortemente ambiguo, ai limiti tra uno strumento coniato
dalla scienza e legato alla proprio contenuto materiale, e un concetto filosofico
appartenente alla sfera del trascendentale, in quanto espressione di un’unità di
senso, “congiunzione di un’idea e di un’esistenza indiscernibili”8, che mira a conciliare l’opposizione tra coscienza e mondo esterno, natura naturante e natura
naturata. L’aspetto strutturale caratterizza dunque l’apprendimento e l’uso dei significati, al punto che Merleau-Ponty vede il problema fondamentale dell’analisi
trascendentale risiedere proprio “nel dualismo delle nozioni di struttura e di significato”9. Tale scoglio può essere superato solo se al dualismo si sostituisce una
tipo di comprensione che avvolge e unisce i significati con la loro base materiale, la sfera spirituale dei concetti con il mondo della percezione.
103
104
Sarà questo infatti lo scopo della Fenomenologia della percezione: “far vedere nella percezione l’infrastruttura istintiva e in pari tempo le sovrastrutture che si
stabiliscono su di essa tramite l’esercizio dell’intelligenza”10. La struttura nella seconda opera esprime quello schema corporeo che organizza come fenomeno dinamico i rapporti tra il corpo e il mondo circostante, senza tuttavia ridurre questo
a pura manifestazione della coscienza rappresentativa, ma mantenendolo sempre ad una certa distanza, come un irriflesso irriducibile. L’essere oggettivo, secondo Merleau-Ponty, non è un’esistenza piena, ma una struttura opaca 11, un fitto intreccio di rimandi simbolici12 a partire da residui di irriflessione e spaccature,
aperture sul mondo circostante. Ne risulta pertanto una componente fortemente
dialettica che nella Gestalt viene meno focalizzata: è essa che permette alle tre
forme, sincretiche, amovibili e simboliche13, di integrarsi fra loro, alla coscienza
di vedersi un tutt’uno col corpo, infine a far sì che un tutto non sia semplicemente un’unità in sé ma un sistema aperto verso il mondo esterno. Merleau-Ponty
spiega questo tipo di rapporto utilizzando il termine husserliano di Fundierung,
relazione reciproca di fondante e fondato, basata su un’azione circolare e dialettica in cui l’invertibilità dei ruoli genera un movimento infinito14.
Tuttavia, con la Fenomenologia della percezione non tutte la aporie vengono risolte: il problema fondamentale della conciliazione della coscienza con il
mondo esterno, il fondamento reale della struttura che unisce interiore ed esteriore, viene risolto in ultima istanza con quello che Merleau-Ponty definisce cogito tacito 15 e che in numerose critiche, tra cui quella di Merleau-Ponty stesso
nelle note di Il visibile e l’invisibile 16, rappresenta uno scoglio al pensare in maniera radicale una filosofia che concili al suo interno sia la componente oggettiva sia quella soggettiva. Nel momento in cui si concepisce questo polo estremo, costituito di pura relazionalità, ci troviamo dinnanzi ad una sorta di struttura vuota, in cui l’assenza dell’elemento irriflesso, opaco, impone un arresto della dialettica. Solo accentuando le caratteristiche proprie della struttura
corpo/mondo Merleau-Ponty potrà uscire da questo impasse e non ricadere
negli intrecci delle intenzionalità soggettive.
2. Dal linguaggio gestuale al linguaggio come essere:
la scoperta della linguistica struttrale di Ferdinand de Saussure
Il concetto di struttura nel pensiero merleau-pontyano conosce un’interessante rivalutazione grazie alla riflessione sul tema del linguaggio e all’incontro
con la linguistica di Ferdinand de Saussure. La lettura del Cours de linguistique générale 17, nonché una forte influenza del pensiero heideggeriano18, inaugurano un punto di vista diverso sul linguaggio: non più fenomeno di espressione del corpo proprio19, ma oggetto a cui rivolgere un tipo di analisi slegata
dal contesto soggettivo, in quanto luogo privilegiato dell’Essere in cui i significati prendono vita, hanno origine. Possiamo riassumere brevemente i punti in
cui la linguistica saussuriana è visiblmente influente nel pensiero merleau-pontyano del linguaggio20. Innanzitutto la concezione binaria del segno: signifiant
e signifié sono indissolubilmente uniti come le due facce di un foglio, in un’uni-
3. L’istituzione: un altro modo di concepire la struttura
Merleau-Ponty afferma di derivare da Saussure la distinzione in una linguistica diacronica della parole e una linguistica sincronica della langue; in realtà
le due prospettive, sincronica e diacronica, sono utilizzate da Saussure esclusivamente in riferimento alla langue, unica sezione del linguaggio che è considerata struttura (o meglio sistema, dato che il primo termine non viene mai utilizzato da Saussure, bensì dai suoi successori ed interpreti). Questa interpretazione non del tutto ortodossa che Merleau-Ponty fa della linguistica saussuriana permette di insistere sullo sviluppo temporale come parte essenziale di
una struttura. Un linguaggio non è il semplice prodotto di un passato che si lascia alle spalle, esso si forma sulla sedimentazione dei significati acquisiti che,
riattivati, segnano una continuità nella quale tutto converge.
A tale scopo Merleau-Ponty adotta, a partire dall’Origine della geometria di
Husserl, il concetto di Stiftung. Il termine tedesco, tradotto col francese institution, indica il passaggio di un senso da Natura a Cultura fondando così significati “che si perpetuano nel tempo sebbene in maniera non sempre esplicita, attraverso l’apertura di campi di ricerche in cui essi rivivono”27. Il senso, venendo a coincidere con il proprio divenire storico, fa sì che ogni momento di gene-
S AGGI
ca entità che è il segno linguistico21. Merleau-Ponty interpreta questa teoria come un indizio che dà credito all’idea del linguaggio come sfera originaria: segno e significato, soggetto e oggetto, natura e cultura, sono indistinti: è qui per
tanto che le analisi sull’origine dei rapporti tra il soggetto e il mondo esterno trovano un terreno particolarmente fecondo. Non di meno Merleau-Ponty insisterà sul valore diacritico del segno, secondo cui il valore di questo non è dato positivamente ma si dà esclusivamente nella differenza con gli altri segni22, e sulla distinzione fra langue, fenomeno collettivo e sociale, e parole, fenomeno individuale23. In conformità a tali principi Merleau-Ponty si oppone ad una concezione sostanzialistica del linguaggio: questo è al contrario un linguaggio indiretto 24, una struttura che si dirama negli scarti generati dall’interazione continua di atti soggettivi ed oggettivi, diacronia e sincronia.
Tuttavia, come è stato più volte notato, Merleau-Ponty non applica fino in
fondo il pricipio della diacriticità del segno. La sua interpretazione di Saussure
è condizionata da un problema di fondo che gli impone di cambiare rotta: la
struttura binaria25 genera un rimando infinito da una parte all’altra senza spiegare adeguatamente come fra i due estremi si generi la novità, l’espressione
di un significato differente. Perché ciò avvenga bisogna che il linguaggio non
sia un puro schema vuoto, “non sia sempre linguaggio sul linguaggio”26, ma è
necessario che la parola si trovi già in seno all’essere e contenga in germe il
proprio senso, sebbene non in forma esplicita e intellettuale, ma come un significato trasversale, indiretto. Si deve dunque considerare all’interno di questo movimento dialettico, quindi all’interno del linguaggio stesso, un terzo elemento, il tiers che funge da suolo comune, nello scambio continuo di inserimento e sedimentazione, tra le componenti opposte.
105
106
si sia spiegabile attraverso ciascun momento dello sviluppo successivo evitando così di cristallizzarsi nell’idea di un fondamento singolo e statico da cui vengono dedotte delle conseguenze. Vi è un continuo rimando tra presente e passato, il senso come è stato acquisito o sedimentato e il senso come viene ripreso e nuovamente utilizzato. Nell’idea di fondazione come Stiftung, il quale
comprende al suo interno un momento di sedimentazione, è compreso inoltre
quell’aspetto della formazione originaria di un significato che mancava alla
Fundierung: è così che Merleau-Ponty riesce a fare fronte ai problemi della
soggettività del cogito tacito, senza per questo rinunciare al principio fenomenologico dell’importanza della ricerca del senso: l’istituzione dei significati deriva la propria efficacia dalla temporalità che riattiva continuamente i significati sedimentati, non dal tessuto intenzionale di un corpo soggettivo.
Per spiegare ulteriormente questo concetto Merleau-Ponty usa la bella metafora del silenzio28: questo coincide con l’orizzonte percettivo in cui il senso, i
significati si danno nel modo più originario, dando vita ad uno stile; secondo le
sue stesse parole: “ogni istituzione è un sistema simbolico che il soggetto incorpora come stile funzionale, come configurazione globale, senza aver bisogno di
concepirlo espressamente”29. Merleau-Ponty dunque prende la lingua considerata come un tutto e da struttura la trasforma in stile, conferendole così questo
potere ontologico di anticiparsi e fungere come suolo originario di uno sviluppo
dialettico. Ciò che permette il passaggio da una struttura all’altra, infatti, non può
essere una struttura ultima e formalizzata, la quale condannerebbe MerleauPonty a ripiegarsi alle soluzioni di un rigido deduttivismo. Allo stesso tempo, tramite la nozione di stile, siamo al riparo da una ricaduta nell’idealismo di una filosofia della soggettività, dal momento che esso non è la trasposizione immediata del sentire del soggetto, piuttosto è ciò che scaturisce inconsapevolmente dal commercio di questo con il mondo esterno, senza che l’opposizione tra la
sua prospettiva e le cose stesse sia resa in maniera esplicita.
Merleau-Ponty dedicò uno dei suoi cicli di lezioni al Collège di France al tema dell’istituzione30. Nel corso vengono analizzati “quegli eventi di un’esperienza che la dotano di dimensioni durevoli, in rapporto alle quali tutta una serie di
altre esperienze avrà senso”31. Ciascuna di queste esperienze apre una serie
infintita di dimensioni, campi comuni alle diverse imprese del sapere, andando
a costituire così una continuità strutturale all’interno della storia. È interessante notare come Merleau-Ponty usi il modello della Stiftung, ovvero l’idea di un
continuo decentramento che coinvolge il tutto in cui le sfere opposte
(privato/pubblico, soggettivo/oggettivo, interiore/esteriore, presente/passato) si
compenetrano reciprocamente, per interpretare alcune teorie e pensieri noti:
Freud, Panofsky, Max Weber, Rabelais (Merleau-Ponty si riferisce all’interpretazione di Lucien Febvre), Lévi-Strauss.
4. Merleau-Ponty e Lévi-Strauss: strutture a confronto
Fino ad ora si è voluto insistere sul concetto di Stiftung come modello di una
struttura che si sviluppa nel tempo: è chiaro dunque che la storia non può resta-
S AGGI
re al di fuori di una filosofia di questa impronta. Senza voler affermare una filosofia storicista che veda un fine oggettivo realizzarsi attraverso le diverse epoche, Merleau-Ponty individua un senso che segue il farsi dialettico della storia,
sebbene si tratti di un senso indiretto, non oggettivo. Il pensiero strutturalista,
inagurato dall’antropologia di Lévi-Strauss, parte da una visione molto differente del ruolo della storia32 e si pone anzi come obiettivo l’annullamento di ogni
pretesa metafisica da parte di questa. Nella sua opera Razza e Storia LéviStrauss mostra come ogni giudizio storico si fonda sull’idea di progresso, la
quale non è altro che una categoria propria del pensiero occidentale e della propria interpretazione delle altre civiltà. La prospettiva temporale non è dunque
essenziale alla società, al contrario essa appartiene ad un punto di vista esterno e posteriore: ogni società umana è sempre e comunque prima di tutto sincronica, caratterizzata da trasformazioni più che flussioni 33, che fanno sì che essa abbia una propria identità, una propria forma, innanzitutto al presente.
Sulla base di questa considerazioni Lévi-Strauss si propone di fondare
un’antropologia come scienza atemporale, di cui la storia non è che un accessorio casuale. Nell’opera Le strutture elementari della parentela, così come in
alcuni dei saggi di Antropologia strutturale, egli individua delle strutture originarie, resistenti alle modificazioni introdotte dalla storia e caratterizzate da un sistema meccanico regolare che porta risultati necessari, prescrittivi. Sebbene,
di fatto, queste strutture incontaminate non si verificano mai, “in mancanza di
influssi esterni, questo meccanismo funzionerebbe indefinitamente e la struttura sociale conserverebbe un carattere statico”34. Come si può dunque dedurre, Lévi-Strauss risolve il problema saussuriano del rapporto sincronia-diacronia cancellando la netta opposizione che separa i due poli, o meglio mostrando come anche il diacronico si manifesti nel sincronico, il quale solamente è
coerente, mentre il diacronico è sempre e solo dinamica agente sul sincronico,
senza organizzazione e senza struttura.
Il vero fondamento che regge il Cours, e dunque qualsiasi interpretazione
di tipo strutturale, non è l’opposizione fra sincronia e diacronia, collettivo ed individuale, ma il fatto che vi siano elementi differenziali dietro ad ogni fonema.
La pura differenzialità della struttura sincronica genera da sola il movimento, il
passaggio temporale da una struttura all’altra, ma dal momento che, come è
stato rilevato anche da Merleau-Ponty, essa non può rendere conto della trasmissione di significati positivi, tutto il discorso della struttura non potrà che
vertere solamente su significanti. Questi sono il vero oggetto delle analisi di Lévi-Strauss: sebbene non aspirino ad avere la determinatezza dei significati teorizzano la possibilità che l’intelletto attinga ad una struttura più radicale, più formalizzata, generando dunque una scienza più esatta. Tali considerazioni fondano l’interesse nei confronti del pensiero selvaggio35: intessuto di miti e forme
simboliche, esso è un pensiero che rifiuta di ricondurre ogni realtà alla spiegazione cosciente ma accetta di dimorare sul senso/nonsenso primordiale che è
quello della simbolicità e che è presente in ogni civiltà.
Per Merleau-Ponty invece il senso non è semplicemente un’illusione generata dal vuoto schema dei significanti: “il y a une intentionalité opérante. Mais il est
adhérent à recherche concrètes, à pratique picturale, et non sens libre, clos, de-
107
108
vant conscience pure”36. La storia e la società sono pregne di senso, sebbene
esso operi trasversalmente e si manifesti nelle strutture esclusivamente nei punti di vuoto, nella vita nei momenti di silenzio; si può anzi affermare che il senso
coincide con la storia stessa nel suo spessore temporale, nella continua apertura e comunicazione con gli eventi e con il singolo. Per comprendere meglio ciò
che costituisce il nucleo del nostro confronto, consideriamo un altro aspetto fondamentale della struttura: il simbolismo. Per Merleau-Ponty esso rappresenta di
certo il punto d’appoggio per uscire dal dominio della soggettività costituente, in
quanto rimanda ad una sfera anteriore ad essa; tuttavia esso non ci obbliga a rinunciare all’idea di senso, anzi ne definisce le caratteristiche: la funzione simbolica non è che l’espressione dell’ambiguità che caratterizza il mondo della percezione, sfondo silenzioso da cui il senso ha origine. Lévi-Strauss invece, secondo
un ragionamento contrario, riconduce l’ambiguità, l’alternarsi di senso e non senso riscontrabile nei differenti fenomeni sociali, all’onnipresenza della funzione
simbolica della psiche all’interno delle istituzioni umane37.
In breve, Merleau-Ponty ricongiunge il pensiero oggettivo all’esperienza
vissuta di un’intersoggettività attreverso la complementarietà delle due parti nel
mondo originario della percezione, mentre Lévi-Strauss dissolve l’esperienza
soggettiva nella scoperta delle leggi inconsce che governano l’organizzazione
strutturale. Merleau-Ponty, quindi, non giunge sino al punto di affermare la priorità del significante sul significato; egli vede piuttosto l’inseparabilità e la reciprocità dei due38. Un modello formalizzato non costituisce un principio di interpretazione valido in sé, una legge universale sostituibile ai casi particolari, in
quanto puro rilevamento di tipo nominale: non esistono strutture pure ma tratti fisionomici che assumono sensi diversi a seconda dell’Umwelt in cui sono
compresi. Precludere a una scienza come l’antropologia l’uso di significati positivi non elimina tuttavia la necessità di ricorrere alla filosofia, per scoprire il
senso grezzo, il principio strutturante che è la nostra esperienza vissuta, che
organizza la forma in cui i significanti si presentano e che costituisce, pertanto, una parte integrante della conoscenza che abbiamo dell’oggetto. Rinunciando al cogito tacito, all’idea che possa esistere una struttura vuota come ultima tappa del processo percettivo, Merleau-Ponty rinuncia a qualsiasi sorta di
formalismo: non si tratta di cogliere il singolo evento originario, il sostrato da
cui deriva la percezione, si tratta piuttosto di capire come la percezione inserisca l’uomo nelle pieghe dell’Essere.
5. Una nuova categoria dell’Essere
Il concetto di istituzione ci ha messo di fronte ad una realtà che non si lascia dominare totalmente dai nostri atti intenzionali, ma che presume sempre
un suolo di passività, di passato sedimentato da cui prendono le mosse le nostre azioni e vi restano legate in virtù di un senso non oggettivo, uno stile. Questa conclusione si fonda sulla constatazione di base che, in particolar modo
nell’ultimo periodo del pensiero merleau-pontyano, ha rappresentato l’apriori
incontestabile di ogni sua riflessione: “il mondo è già qui, nella sua trascenden-
S AGGI
za oggettiva, prima di questa analisi, ed è il suo senso stesso che sarà esplicitato come senso”39. Vi è un mondo comune, misto degli atti soggettivi e oggettivi, il quale si offre ad ogni istante come termine di interazione per le diverse forme di società. Anche lo studio delle strutture non può dunque prescindere da questo riconoscimento e ricadere nel dominio dell’oggettività pura della
scienza, esse sono piuttosto una testimonianza verace del legame che vincola le forme di cultura a questo mondo pre-oggettivo.
Questa sfera primordiale, in cui il segno e il significato, la forma e la materia, sono in-distinti, non è un fondamento deduttivo del mondo; ciò contrariamente alla concezione di Lévi-Strauss, il quale, sulla scia del discorso marxista sulle sovrastrutture, vede nell’inconscio il mondo veritiero svelato dall’analisi strutturale: una fonte incontaminata d’interpretazione dei comportamenti
sociali. In un passo di Le avventure della dialettica 40 Merleau-Ponty accusa il
marxismo di essersi limitato allo studio del mondo soggiacente senza avere
compreso la necessità di interpretarlo come una Natura, un tutto che ci avvolge e che non si trova solamente al di sotto della sfera della coscienza; la stessa critica può toccare anche Lévi-Strauss. Merleau-Ponty vuole così portare a
compimento quella che, secondo la sua interpretazione, è la chiave di lettura
fondamentale dell’ultimo Husserl, la filosofia della Lebenswelt. Studiare la Natura dunque non è solo applicare le leggi della fisica ad un oggetto estraneo alla coscienza, ma “attraverso il movimento della scienza, giungere a mettere in
questione l’essere-oggetto della Natura, pervenire alla Natura di cui siamo parte, alla Natura in noi”41. Ciò è concepibile solo se si parte dall’assunto che la
Natura non è l’opposto della cultura, così come la materia è opposta allo spirito, ma è l’altro lato di essa, è fatta della medesima carne. La sua originarietà
non è altro che un corollario del primato della percezione sulle altre capacità
conoscitive umane, e di quel residuo di opacità, irriflesso, che essa comporta
sempre, punti focali della filosofia di Merleau-Ponty a partire dalla Fenomenologia della percezione.
Il progetto ontologico finale di Merleau-Ponty, infatti, prende le mosse dai
corsi tenutisi al Collège de France tra gli anni 1956-1960 proprio sul tema della Natura. In queste pagine dense di esempi presi dalla biologia e dalla psicologia, il tema della struttura, che in questa sede riprende la denominazione di
Gestalt, ritorna prepotentemente ad essere centrale in un contesto del tutto simile a quello in cui era stato presentato in La struttura del comportamento. Ma
rispetto a questa prima concezione la Gestalt assume una più approfondita
cartterizzazione: le scoperte riguardo la natura differenziale del linguaggio verranno, infatti, applicate anche agli studi biologici e alle analisi del comportamento umano e animale. Ne risulta pertanto che la Natura è un tipo di organizzazione del tutto simile alla Stiftung: da una parte mantenimento presente delle cose passate, dall’altra presente delle cose future, ma mai puro presente,
Natura-flash.
Gli esempi più chiarificativi sono tratti dagli studi sull’integrazione tra organismo animale e ambiente circostante, Umwelt, di scienziati come Coghill, Gesell o von Uexküll. Merleau-Ponty assimila questo ambito a quello del linguaggio: così come l’istituirsi di un nuovo significato si dà in un contesto differenzia-
109
110
le, il comportamento si manifesta come rottura, come scarto rispetto ad uno
stato designato normale in base a rapporti di simmetria, di stimolo-risposta. Bisogna dunque ricercare alla base del funzionamento dell’organismo “un principio che sia negativo o assenza”42, che operi in virtù di uno scarto rispetto alla
situazione presente. L’idea di un principio che non sia semplice identità con sé,
ma non-differenza rispetto a sé, negazione della sua negazione, manifesta una
chiara influenza hegeliana e proprio per questo è forse la causa di numerosi
fraintendimenti del pensiero merleau-pontyano43. Tuttavia quando MerleauPonty afferma, riguardo lo sviluppo dell’organismo, che ogni momento, più che
contenere il proprio futuro in potenza, è appoggiato 44 sul futuro significa che ci
troviamo di fronte ad un esempio di struttura che non è mai totale, presenta dei
punti di vuoto e non esaurisce al proprio interno la possibilità dei significati e
delle risposte che possono essere date ad un determinato comportamento dell’animale ma è ad ogni volta un’“interpretazione di simboli”45.
Una concezione simile era stata espressa in riferimento alle tre forme (amovibili, sincretiche e simboliche46) dei comportamenti viventi, in La struttura del
comportamento. Era stato messo in luce come in ciascuna forma fossero presenti tracce delle altre due e si era riconosciuto in seguito, come facoltà dei viventi appartenenti alle forme simboliche, cioè l’uomo, la capacità di integrarsi
nella serie di rimandi generati dalla convivenza delle tre forme e fare propria tale attività simbolica di produzione di significati. Nel caso ora considerato non si
parla solamente di tre livelli differenti, all’interno dei quali l’uomo costituisce il livello più alto e pertanto coincide con la realizzazione più propria della funzione
simbolica, al contrario quest’ultima è ora riconosciuta come una proprietà della
Natura, che è quella di essere costruita da vari livelli che si intrecciano fra loro
e che rimandano continuamente l’uno all’altro. L’uomo partecipa di tale simbolismo, in quanto è egli stesso Natura, costituito della stessa carne di essa.
Per i motivi che abbiamo accennato la struttura come carattersitica dell’Essere non può più essere descritta a partire dal comportamento umano o animale. Per segnare il superamento definitivo della concezione di La struttura del
comportamento è necessaria una ridefinizione di alcune formule che all’epoca
rinviavano ancora ad una soggettività trascendentale. Il punto di vista da assumere è ora quello della Natura stessa: dobbiamo collocarci nel cuore di essa
per cogliere sul nascere il momento in cui essa si manifesta nel vivente. Come
è già stato messo in luce, sia La struttura del comportamento sia la Fenomenologia della percezione comportavano antinomie irrisolvibili; in particolare vi
sono alcune definizioni di Gestalt, presenti in La struttura del comportamento
che, nella loro formulazione, suscitano qualche perplessità47. Nella prima opera merleau-pontyana, infatti, non appare chiaramente come la struttura possa
mantenere la propria configurazione di significazione indecomponibile e allo
stesso tempo essere signification incarnée, dal momento che essa è ancora legata alle determinazioni della soggettività latente.
Tutto ciò non fa che rivelare i limiti di una concezione della Gestalt, se vista
da uno sguardo esterno e posteriore in grado di distinguere un senso oggettivo applicato ad una materia. Uno sguardo sulla Gestalt dall’interno è possibile
innanzitutto se si abbandona la prospettiva della soggettività trascendentale e,
6. Ai limiti della struttura: il chiasma
Durante il colloquio sul termine “struttura”53 Merleau-Ponty distingue alcune
accezioni fondamentali in cui il termine viene inteso. In un caso la nozione è tirata verso l’alto, cioè “la structure est un simple substitu de la notion de essence”, nell’altro caso la nozione è tirata verso il basso, designa semplicemente
una pura connessione di fatti registrati. Per pensare un’alternativa a queste
proposte, l’una che fa della struttura qualcosa di più del proprio contenuto l’altra che, in sostanza, la fa coincidere con esso senza conferirle alcun valore fi-
S AGGI
in secondo luogo, se si considera il senso come differenziazione, prospettiva
che in La struttura del comportamento non era ancora stata messa in primo
piano, (sebbene fosse già accennata nel discorso sulle componenti virtuali della struttura o nell’idea della figura su sfondo) ma che emerge a partire dalle
considerazioni sul linguaggio ed infine nei corsi sulla Natura. Scrive MerleauPonty in una nota del settembre 1959 “Che cos’è una Gestalt? Un tutto che
non si riduce alla somma delle parti: definizione negativa, esteriore – Connotati della Gestalt in opposizione all’ambito di in sé in cui ci si installa –”48. Il presupposto sbagliato sta nell’operare sulla base degli elementi positivi, oggettivi,
in sé, che vengono dunque ad assumere il ruolo di fondamento originario; ogni
definizione risulterà sempre insufficiente in quanto rappresenta l’unione degli
opposti che si vuole invece evitare; al contrario “la Gestalt implica dunque il
rapporto di un corpo percipiente con un modo sensibile i.e. trascendente i.e.
d’orizzonte i. e. verticale e non prospettico”49.
Continua Merleau-Ponty “il Gestalthafte, dice Heidegger, è qui lasciato da
parte”50: ciò che deve essere centrato dalla riflessione è il fatto che l’oggetto è
sempre dato ad una certa distanza e che vi è sempre, dunque, una parte che
sfugge alla descrizione. Vedere la struttura dall’interno significa porsi nel cuore di questa distanza, nel punto in cui i significati e il loro supporto materiale,
così come i significati tra loro, sono non-differenziati nell’inestricabile intreccio
dei rimandi simbolici, “non mediante osservazione interna, ma avvicinandosi il
più possibile alla Gestalt, comunicando con essa”51; significa scoprire la generalità laddove le cose si staccano dalla carne per restarne tuttavia sempre legati. In La struttura del comportamento il senso che era l’espressione del funzionamento della struttura sembrava ancora una sorta di entelechia, corrispondente alla proprietà caratterizzante di ciascun ordine: fisico, vitale, umano; tale senso era visto cioè come un attributo ontico e non poteva, in ultima analisi, risolvere il dualismo che lo separava dalla struttura52. Solo attraverso queste pagine Merleau-Ponty potrà finalmente disporre degli strumenti per superare l’impasse: passando da una filosofia trascendentale dell’attività sintetica
del soggetto ad una filosofia trascendentale della passività originaria. Proprio
grazie alla scoperta di questo suolo passivo originario, l’analisi trascendentale
non risulterà altro che il riconoscimento che significato e struttura non possono mai coincidere pienamente, pena il ritorno ad una struttura chiusa che esaurisce in sé l’insieme dei rimandi simbolici.
111
112
losofico, non è possibile fare semplicemente un passo indietro o avanti: le due
posizioni inagurano un punto di vista di per sé errato; è per questa ragione che
è necessario spingersi oltre54.
Se la struttura fosse un’essenza, appartenesse ad un ordine formale trascendente rispetto al proprio contenuto, essa si richiuderebbe su di sé, formerebbe un insieme che rende completamente ragione di se stesso senza dover
ricorrere alla contaminazione con altri insiemi, altri livelli. L’esperienza della
percezione, invece, ci testimonia di un rimando continuo da parte del nostro
corpo al mondo esterno e poi ancora verso il linguaggio e la cultura. Questo
principio deve essere compreso, abbiamo detto, come un’assenza, un negativo. Il carattere diacritico del segno è la chiave per comprendere che ogni struttura cela un senso che è un continuo divenire, un’apertura verso un orizzonte
in infinito allargamento. Ogni elemento di cultura, ogni parola, ogni significato
istituito attinge la propria verità da quella che Merleau-Ponty definisce struttura mondo 55, né un cielo delle idee né l’ammasso semplice delle cose esistenti, ma luogo della non-differenza, che fonda la compossibilità di tutte le cose.
Una volta rifiutato qualsiasi principio che sia di natura soggettiva o oggettiva a favore di un principio che sia assenza, scarto, negativo in quanto non-differenza, cosa avviene del concetto tradizionale di essenza? “Le vrai, l’essence, ne seraient rien sans ce qui y conduit”56, l’essenza dunque, essendo legata alla variazione eidetica che ce la fa intuire, non è un principio di compossiblità logica, non costituisce un principio primo da cui l’esistente deriva in virtù
di qualche necessità, ma deriva il proprio potere dal fatto che si rifà ad un’unica esperienza ed allo stesso mondo, “perché tutti i miei pensieri e i pensieri degli altri sono presi nel tessuto di un solo Essere”57. L’essenza, se è lecito usare ancora questa terminologia, è dunque un insieme di relazioni che testimoniano di uno stile, di una dimensione che raccoglie tutti gli elementi che vi partecipano in virtù di una necessità non logica. Essa “non designa altro che questi cardini dell’Essere”58, dal momento che il mio potere di dispiegare un campo, di riconoscere ciò che è possibile e distinguerlo da ciò che è reale, non arriva fino a rendermi capace di dominare il campo dispiegato e a fare del reale
una semplice variante del possibile.
Come possiamo leggere in una delle note di lavoro di Il visibile e l’invisibile
l’essenziale è ciò che west, “è la roseità che si stende attraverso la rosa”59, ovvero la struttura, il tessuto relazionale che si articola, è preso nello spessore
che coinvolge l’oggetto, la rosa, e il mondo circostante, “questo Ineinander che
nessuno vede, e che non è nemmeno anima del gruppo, né oggetto, né soggetto, ma il loro tessuto connettivo”60. L’essenza è dunque un’idea che non è il
contrario del sensibile, così come la struttura non si oppone al proprio contenuto. Esse non sono una seconda realtà rispetto ad un mondo materiale, ma
ne sono il risvolto e la profondità, costituiscono “un doppio fondo del vissuto”61,
allo stesso modo per cui ciò che è invisibile non è un invisibile assoluto, ma un
invisibile di questo mondo, “scarto in rapporto a un livello”62, ad una dimensione. Tutte le componenti della struttura, soggettive e oggettive, reali e virtuali (o
possibili), attive e passive, consce e inconsce non costituiscono delle sfere separate che interagiscono in seguito; al contrario esse, nella loro totalità hanno
S AGGI
origine in quel rapporto originario che le vede unite nella loro opposizione.
Questo tipo di rapporto, iriducibilmente duplice e reciproco, sarà espresso da
Merleau-Ponty attraverso l’immagine del chiasma, come un rivolgimento continuo dell’Essere su stesso, “che fa sì che l’uscire da sé sia rientrare in sé e viceversa”63.
La struttura deve essere dunque compresa a partire dal suo dispiegamento sensibile, di cui essa è unità per sconfinamento e non per sorvolo. Essa contiene tutte le possibilità perché sorge dal polimorfismo dell’Essere e conserva
quest’aspetto sotto forma di pregnanza, nel senso di produttività, fecondità, capacità di mettere a fuoco il visibile, obbedendo alla distanza che lo separa dal
vedente. Allo stesso tempo questa pregnanza non giustifica una teoria dell’innatismo ma riprende la concezione della Stiftung, esprime la sovrabbondanza
di senso che esige sempre una Nachstiftung. Che cosa risulta dunque da questo tipo di esperienza della struttura? Che essa è “una percezione “effettuatesi nelle cose””64, una totalità percettiva, non da intendersi come oggetto di percezione, ma come essere che ha lo stesso stile della percezione, che viene
colto nella sua spontaneità e nella sua generalità così come il corpo percependo si pone in un atteggiamento pre-oggettivo, pre-tetico. “Il mio corpo è una
Gestalt ed è co-presente in ogni Gestalt […] È un sistema diacritico, oppositivo, relativo il cui cardine è l’Etwas, la cosa, il mondo e non l’idea”65.
Come si è tentato di mostrare la struttura non è dunque uno strumento
d’analisi, non appartiene al dominio della metodologia scientifica e per tanto
non può essere confusa con la concezione strutturalista. Essendo una caratteristica dell’Essere, essa si manifesta nel contatto originario della percezione
col mondo, sfera che precede le analisi delle scienze. Essa non è testimone di
opposizioni nette, di una realtà più profonda da cui viene derivata una seconda, illusoria, ma rimanda ad una dimensione unica che si colloca ai limiti delle
cose, unendole e separandole allo stesso tempo, allo stesso modo di quel
chiasma, che Merleau-Ponty pensò all’interno della sua ontologia. Si potrà
obiettare che Merleau-Ponty fa un uso approssimativo, quasi metaforico del
termine: in effetti il pensiero strutturale di Merleau-Ponty non è che il modello
di una riflessione che riconosce la propria configurazione fatta di vuoti e pieni,
senso e non-senso e pertanto è portata continumente a confrontarsi con l’altra
parte di sé, con il suo limite.
La riflessione sul concetto di struttura, infine, per Merleau-Ponty, vuole essere una via che conduce ad una filosofia della Natura, rivelandoci che questa
non è un ammasso di individualità e pertanto un limite alla conoscenza, ma
esprime una logica percettiva che, lungi dal costituire un limite, fonda le basi
per una nuova interpretazione della realtà. In generale quest’indagine sulla
struttura è in consonanza con l’esigenza comune alle scienze e alla filosofia
del XX secolo di trovare una via d’uscita dall’impasse costituita dal’opposizione di esitenzialismo e naturalismo. La soluzione ottenuta da Merleau-Ponty (mi
riferisco qui alle problematiche e ai concetti che l’interpretazione della struttura ha svelato: il problema del significato, il simbolismo, le nozioni di reciprocità e di passività) può pertanto costituire un importante riferimento per il confronto ed il chiarimento dei fondamenti delle scienze umane.
113
1
300.
114
E. JAMES M., “Was Merleau-Ponty a structuralist?” in Semiotica, vol. IV, 1971, pp. 297-323, p.
2 Si vedano i seguenti testi: J. COMPTON, “Review of Maurice Merleau-Ponty: between phenomenolgy and structuralism” in History and Theory, n. 26, vol. III, 1987, pp. 365-373; J. DALY, “Merleau-Ponty: a bridge between phenomenology and structuralism” in Journal of British Society for
Phenomenology, n. 3, vol II, Oct. 1971, pp. 53-58; G. B MADISON, “Between phenomenology and
(post)structuralism. Rereading Merleau-Ponty” in Aa. Vv., Merleau-Ponty, hermeneutics and postmodernism, Albany, State University of New York Press, 1992, pp. 117-128; A. MEGILL, “Maurice
Merleau-Ponty: between phenomenology and structuralism” in American Historical Review, n. 91,
1986, p. 888; J. SCHMIDT, Maurice Merleau-Ponty between phenomenology and structuralism, St.
Martin’s Press, New York, 1985; Hugh J Silverman, Inscriptions: Between Phenomenology and
structuralism, Routledge & Kegan Paul, London 1987.
3 V. DESCOMBES, Le même et l’autre. Quarante-cinq ans de philosophie française (1933-1978),
Cambridge University Press et Les Editions de Minuit, Cambridge-Paris 1979, p. 89.
4 SC, p. 23.
5 L’espressione ai limiti fa inoltre esplicito riferimento al corso tenuto al Collège de France negli anni 1959-60 dal titolo Husserl aux limites de la phénoménologie (presente in Notes de Cours
sur l’Origine de la Géométrie de Husserl, suivi de Recherches sur la phénoménologie de MerleauPonty a cura di R. Barbaras, PUF, Paris 1998) e alle pagine di Il filosofo e la sua ombra (S, pp.
211-235) in cui Merleau-Ponty afferma di voler portare la fenomenologia ai suoi estremi e costringerla a confrontarsi con la non-fenomenologia (si vedano in particolare le pp. 231-232).
6 Per una breve bibliografia sulla Gestaltpsychologie rimando ai seguenti testi: K. KOFFKA, The
growth of the mind, Routledge & Kegan, London 1925; ID, Principles og Gestalt Psychology, Routledge & Kegan, London 1935 (Principi di psicologia della forma, Torino, Boringhieri 1970); W. KÖHLER, Gestalt Psychology, G. Bell, London 1930 (La psicologia della Gestalt, Feltrinelli, Milano
1961); ID, Principi dinamici in psicologia ed altri scritti, a cura di Paolo Bozzi, Giunti-Barbera, Firenze 1966; M. WERTHEIMER, Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie, Verlag der Philosophischen
Akademie, Erlange, 1925; ID, Productive Thinking, Harper, New York 1945 (Il pensiero produttivo,
a cura di Paolo Bozzi, Ed. Universitaria, Firenze 1959); K. GOLDSTEIN, Der Aufbau des Organismus,
Martinus Nijhoff, Haag 1934.
7 SC, p. 340.
8 SC p. 331
9 SC, p. 357.
10 FP, p. 96.
11 FP, p. 433.
12 I fenomeni strutturali coinvolgono strettamente la facoltà simbolica dei viventi, concepita ad
un livello pre-tetico come quella vita ambigua tra il senso che esprime e i dati materiali che coinvolge. Nell’uomo tale facoltà è intesa come capacità di sfuggimento (FP, pp. 239, 261) a partire
dalla situazione data, alla ricerca di nuovi significati da attribuire a quelli già presenti, in modo da
creare un mondo formato da oggetti ed elementi dotati di ambiguità che, a seconda della situazione, possano assumere valori differenti. Per una descrizione più dettagliata del simbolismo nella filosofia di Merleau-Ponty riamando al §IV del presente saggio in cui si tratta del confronto con Lévi-Strauss.
13 Si veda il secondo capitolo, I comportamenti superiori, di La struttura del comportamento.
14 Scrive ancora Merleau-Ponty a peoposito della Fundierung: “rapporto che non sia né la riduzione della forma al contenuto, né la sussunzione del contenuto sotto una forma autonoma” (FP,
p. 181). Sarà messa in luce nelle pagine che seguono l’mportanza del concetto di fondazione, inteso non secondo la legge di causa-effetto o come deduzione da un principio supremo, ma come
manifestazione di un agire circolare e dialettico, in cui non vi sia un solo principio da cui i fenomeni vengono derivati, ma un rapporto di reciprocità continua tra le parti.
Cfr. FP, p. 518.
VI, pp 188, 196.
17 F. DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale (1916), Payot, Paris 1972. Traduzione italiana a cura di T. De Mauro: Corso di linguistica generale, Roma-Bari, Laterza, 1967.
18 Per una trattazione più approfondita dell’influenza di Heidegger sul pensiero di Merleau-Ponty rimando ai seguenti testi: F. CIARAMELLI, “L’originaire et l’immediat. Remarque sur Heidegger et
le dernier Merleau-Ponty” in Revue philosophique de Louvain, 1998, n. 96, vol 2, pp. 198-231; Dastur, Françoise, “La lecture merleau-pontienne de Heidegger dans les notes du Visibile et l’invisible et les cours du Collège de France (1957-1958)”, in Chiasmi International, Pubblicazione trilingue intorno al pensiero di Merleau-Ponty, a cura di R. Barbaras, M. Carbone, L. Lawlor, Vrin-Mimesis-University of Memphis, Paris-Milano-Memphis, n. 2, 2000, pp. 373-38; F. DASTUR, Chair et
langage, Encre Marine, Fougères 2001; G. B. MADISON, “Merleau-Ponty et la contre-tradition”, in
Dialogue, 1978, pp. 456-479; J. SLATMAN, L’expression au-delà de la représentation. Sur l’aisthêsis et l’esthétique chez Merleau-Ponty, Peeters, Leuven 2003; B. WALDENFELS, “Faire voir par le
mots. Merleau-Ponty et le tournant linguistique”, in Chiasmi international, n. 1, cit., pp. 57-64.
19 Nella Fenomenologia della percezione il linguaggio è considerato una delle diverse forme
dell’essere-al-mondo di cui il corpo è il portatore e di cui costituice solo un caso particolare di significazione; il linguaggio pertanto viene descritto come fenomeno dall’origine gestuale. (Si veda
il capitolo IV della prima parte Il corpo come espressione e la parola, FP, pp. 244-274).
20 Per una trattazione più dettagliata della concezione merleau-pontyana del linguaggio e dei
rapporti con la linguistica saussuriana segnalo i seguenti testi di riferimento: M. CARBONE, “La forma precaria del linguaggio in Merleau-Ponty. Una lettura di La prose du monde”, in Fenomenologia e scienze dell’uomo, 1982, n. 2, pp. 137-145. F. DASTUR, Chair et langage, Fougères, cit.; F.
HEIDSIECK (a cura di), Merleau-Ponty, le philosophe et son langage, Recherches sur la philosophie
et le langage, Grenoble, n. 15, 1993. D. R. KOUKAL, “Merleau-Ponty’s reform of Saussure: Linguistic innovation and the practice of phenomenology” in Southern Journal of Philosophy, vol. 38, n.4,
wint 2000, pp. 599-617; M. Lagueux, “Merleau-Ponty et la linguistique de Saussure” in Dialogue,
vol. IV, n. 3, Dic. 1965, pp. 351-364; C. SINI, “Il silenzio del mondo e la parola”, in La prosa del mondo. Omaggio a Maurice Merleau-Ponty, a cura di A. M. Sauzeau Boetti, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, (Quattroventi, Urbino), 1990; pp. 91-99; Y. THIERRY, Du corps parlant. Le langage chez
Merleau-Ponty, Editions OUSIA, Bruxelles 1987; L. FONTAINE DE VISSCHER, Phénomène ou structure? Essai sur le langage chez Merleau-Ponty, Publication Universitaires Saint Louis, Bruxelles
1974.
21 F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, cit., pp. 83-85.
22 Ivi, pp. 139, 143, 147.
23 Ivi, pp. 17-25.
24 Si veda il saggio Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio (S, pp. 63-116).
25 F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, cit., pp. 98-106.
26 PM, p. 59, nota 34.
27 LSN, p. 56.
28 Si veda il saggio Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio (S, pp. 63-116).
29 EF, p. 77. Il concetto di stile designa l’insieme dei significati impliciti della percezione che
giungendo all’espressione coinvolgono tutto l’essere dell’individuo portando ogni sua azione a convergere verso un centro di significati già presenti. Esso designa dunque “l’emblema di un certo rapporto con l’essere” (S, p. 81).
30 M. MERLEAU-PONTY, L’institution. La passivité. Notes de cours au Collège de France (19541955), Belin, Parus 2003. Il riassunto del corso è presente anche in Resumè des Cours (RS), tradotto in italiano col titolo Linguaggio, Storia, Natura (LSN).
31 LSN, p. 56.
32 Per una breve bibliografia dei testi di Lèvi-Srauss di riferimento rimando alla bibliografia posta in coda al presente saggio. Per una comprensione del pensiero di Merleau-Ponty su LèviStrauss e lo strutturalismo è molto utile la lettura del saggio Da Mauss a Lévi-Strauss, in Segni,
cit., pp. 154-168. Tuttavia è indispensabile confrontare il discorso di tale saggio con le considerazioni che Merleau-Ponty espone nel suo corso del ’55 sull’Istituzione, dal momento che si notano
alcune discrepanze. Il saggio infatti offre la testimonianza di un’interpretazione piuttosto idiosincratica della concezione strutturalista di Lévi-Strauss, assimilandola fortemente alla propria idea di
15
S AGGI
16
115
116
una filosofia della Lebenswelt che riunisca le opposizioni di Natura e Cultura. Ciò, a mio parere, è
dovuto all’occasione particolare in cui il discorso venne pronunciato (nel corso sull’istutuzione del
’55, Merleau-Ponty, infatti, assume un atteggiamento più critico nei confronti di Lévi-Strauss): trattandosi di un intervento alla lezione inaugurale di Lévi-Strauss presso il Collège de France, mi
sembra piuttosto fondata l’idea che Merleau-Ponty abbia voluto fare un elogio dell’amico, presentando gli aspetti condivisi, piuttosto che un’analisi del suo pensiero mettendone in luce i punti di
dissenso. Pertanto il testo, a mio parere, non è da prendere alla lettera e soprattutto non può costituire la base dell’accusa secondo cui Merleau-Ponty farebbe un uso improprio delle strutture dello strutturalismo (DESCOMBES, Le même et l’autre, cit., p. 91).
33 Cfr. RS, p. 66.
34 AS, p. 344.
35 Queste affermazioni sono la base della critica che Lévi-Strauss rivolge alla filosofia della
soggettività costituente, in primo luogo contro la dialettica sartriana, come si può chiaramente leggere nell’ultimo capitolo di Il pensiero selvaggio (PS, p. 265).
36 IP, p. 84.
37 PS, p. 311.
38 Cfr. VI, p. 169.
39 VI, p. 190.
40 Si veda in AD, p. 241, Merleau-Ponty interpreta il materialismo storico come lo “stretto legame tra la persona e l’esterno […] la reintegrazione del mondo all’uomo”, e non semplicemente la
riduzione della storia alle sue componenti economico-materiali.
41 N, p. 310.
42 N, p. 229.
43 Mi riferisco alla critica di Vincent Descombes (in Le même et l’autre 1979, pp. 89-90) secondo cui Merleau-Ponty non farebbe altro che spostare le “je”, il soggetto personale, verso l’“on”, soggetto impersonale, senza superare di fatto l’idealismo hegeliano. In particolare Descombes accusa Merleau-Ponty di interpretare il simbolismo secondo il concetto hegeliano di spirito oggettivo,
vale a dire come la manifestazione di una ragione superiore che coincide con la realtà.
44 Cfr. N p. 229;
45 N, p. 258.
46 Si veda in secondo capitolo di La struttura del comportamento, I comportamenti superiori.
47 Si veda in particolare: D. SCHENCK, “Meaning and/or materiality. Merleau-Ponty’s notion of
structure” in The Journal of the British Society for Phenomenology, vol 15, n.1, 1984, pp. 34-50.
L’autore dell’articolo critica alcune affermazioni riguardo alla struttura tra cui: “congiunzione di
un’idea e di un’esistenza indiscernibili” (SC, p. 331), “operazione originaria che inserisce un senso in un frammento di materia, ve lo fa abitare, apparire, esistere” (SC, p. 338). Secondo Schenck
tali formulazioni rivelano un ancoramento alla distinzione materia/forma, essenza/esistenza ed alla metafisica sostanzialistica (Cfr. D. SCHENCK, “Meaning and/or materiality. Merleau-Ponty’s notion
of structure”, cit., p. 42).
48 VI, p. 220.
49 VI, p. 221. Il corsivo è mio.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Si veda SC, p. 357, nonché p. 4 del presente saggio.
53 P2, pp. 317-319.
54 Ibid. Merleau-Ponty cita poi una terza accezione del termine, che si colloca fra le due precedenti: questo uso del termine, che avviene soprattutto in matematica, designa una sorta di schema di costruzione. Questa accezione tuttavia non rispecchia pienamente le idee che Merleau-Ponty vuole portare avanti: sebbene rappresenti un’alternativa alle prime due, essa pone un’idea di
struttura che sostituisce semplicemente quella di oggetto matematico, trascurando l’assunto che
anche la matematica poggia su una Natura. Ho sottolineato la preposizione “fra” in riferimento
esplicito al discorso da me introdotto nell’introduzione del presente lavoro; la soluzione della via di
mezzo, anche in questo caso, non risolve il problema di considerare la Natura che soggiace, o meglio che sta ai limiti, delle due teorie che si oppongono.
55 VI, p. 40.
56 IP, p. 90.
VI, p. 129.
VI, p. 249.
59 VI, p. 192. Merleau-Ponty si rifà qui ad un’espressione di Heidegger.
60 Ibid.
61 VI, p. 220.
62 VI, p. 217.
63 VI, p. 215.
64 VI, p. 210.
65 VI, pp. 220-221.
57
S AGGI
58
Opere di Maurice Merleau-Ponty
SC
FP
EF
AD
S
VI
LSN
PM
N
NCOG
P2
IP
La structure du comportement, Presses Universitaries France, Paris 1942. Trad. it a cura di G. D. Neri: La struttura del comportamento, Bompiani, Milano 1963.
Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945. Trad. it. a cura di A. Bonomi:
Fenomenologia della Percezione (1965), Bompiani, Milano 2003.
Eloge de la Philosophie. Leçon inaugurale faite au Collège de France, Le jeudi 15 janvier 1953, Gallimard, Paris 1953. Traduzione italiana a cura di C. Sini: Elogio della filosofia,Editori Riuniti, Roma 1984.
Les adventures de la dialectique, Gallimard, Paris 1955. Traduzione italiana di F. Madonia, Umanismo e terrore e Le avventure della dialettica, a cura di A. Bonomi, Sugar, Milano 1965.
Signes, Gallimard, Paris 1960. Traduzione italiana di G. Alfieri, Segni (1967), a cura di
Andrea Bonomi, Il Saggiatore, Milano 2003.
Le visible et l’invisible, suivi de notes de travail, Gallimard NRF, Paris 1964. Traduzione
italiana di A. Bonomi, Il visibile e l’invisibile (1969), a c. di M. Carbone, Bompiani, Milano
2003.
Résumés des Cours. Collège de France 1952-1960, Gallimard, Paris 1968. Traduzione
italiana a cura di M. Carbone, Linguaggio, storia, natura. Corsi al Collège de France.
1952-1961, Bompiani, Milano 1995, pp. 55-58.
La prose du monde, Gallimard, Paris 1969. Traduzione italiana a cura di C. Sini, La prosa del mondo, Editori Riuniti, Roma 1984.
La Nature, Editions de Seuil, Paris 1995. Traduzione italiana a cura di M. Mazzocut-Mis
e F. Sossi, La Natura, Raffello Cortina, Milano 1996.
Notes de Cours sur l’Origine de la Géométrie de Husserl, suivi de Recherches sur la phénoménologie de Merleau-Ponty a cura di R. Barbaras, PUF, Paris 1998.
Parcours deux, 1951-1961, a cura di J. Prunair, Verdier, Lagrasse 2000.
L’institution, la passivité. Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Belin, Paris
2003.
117
Opere di Claude Lévi-Strauss
SEP
Les structures élémentaires de la parenté, PUF, Paris 1947; riedizione: Mouton et Maison des Sciences de l’Homme, Paris 1967. Traduzione italiana di A. M. Cirese e L. Serafini, Le strutture elementari della parentela (1969),a cura di P. Caruso, Feltrinelli, Milano 2003.
RS
Race et histoire, Unesco, Paris 1952. Traduzione italiana a cura di P. Caruso e G. Neri,
Razza e storia e altri studi di antropologia, Einaudi, Torino 1967.
PS
La pensée sauvage, Plon, Paris 1962. Traduzione italiana a cura di P. Caruso, Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano 1964.
AS
Anthropologie structurale, Plon, Paris 1964. Traduzione italiana a cura di P. Caruso, Antropologia strutturale (1990), Il Saggiatore, Milano 2002.
“Reponse à quelques questions”, in Esprit, n. 322, novembre 1963, p. 652
“De quelques rencontres”, in L’Arc, n. 46, 1971, pp. 43-47.
118
MONTESQUIEU SCIENZIATO
DELLA POLITICA E DELLA SOCIETÀ
In una dotta e densa monografia pubblicata di recente1, Domenico Felice,
specialista dell’opera e del pensiero di Montesquieu, prende in esame tre importanti innovazioni introdotte dall’Esprit des lois (1748) nel campo degli studi
giuridico-politici e filosofico-sociali: la considerazione del dispotismo come una
forma autonoma di Stato, il principio dell’autonomia e indipendenza del potere
giudiziario, la teoria secondo la quale ogni nazione possiede un suo “spirito” o
“carattere” peculiare che la definisce e la differenzia da qualsiasi altra.
Riguardo alla prima delle tre questioni indicate, Felice mostra come il filosofo francese, attraverso il suo concetto di dispotismo, punti dar corpo a quello che è il grandioso progetto che sta alla base dell’Esprit des lois: la costruzione di una scienza universale dei sistemi politico-sociali, mirante ad abbracciare – come egli stesso scrive nel 1750 – “le leggi, i costumi e le usanze di tutti i popoli della terra”2. La descrizione minuziosa del modello politico e sociale
del governo dispotico consente a Felice di metterne in luce i tratti fondamentali: la struttura costituzionale monocratica e senza legge (la nature), il ressort
psicologico (il principe, vale a dire la crainte/terreur, ben differente dai princìpi
degli altri governi), l’assenza dei corpi intermedi, la funzione moderatrice (ma
extra-costituzionale) della religione, le cause fisiche e morali che ne consentono la nascita e la lunga durata, la scarsità dei rapporti economici e sociali,
l’educazione finalizzata al servilismo del popolo, il diritto civile e penale, la fiscalità, l’ampiezza e il controllo del territorio, le tendenze imperialistiche e militaristiche.
Attraverso quest’indagine, Felice riesce a provare il carattere tipicamente
“analitico” della categoria montesquieuiana del dispotismo, onde vengono respinte le letture più diffuse, che le attribuiscono un senso soprattutto polemico,
“ideologico” o “allegorico”. La tripartizione delle forme politiche (repubblica,
monarchia e dispotismo), proposta da Montesquieu nell’Esprit des lois, indica
chiaramente che egli guarda al dispotismo come ad un tipo fondamentale di
governo. La distinzione tra monarchia e dispotismo risponde a due esigenze
principali, l’una di ordine pratico e l’altra di ordine teorico: da una parte, il filosofo bordolese desidera mostrare ai sovrani europei – francesi, in special modo – come i cambiamenti in “direzione assolutista” delle costituzioni monarchiche agevolino la trasformazione dei loro regni in regimi affatto incompatibili con
la vera natura del governo monarchico; dall’altra, trovando poco soddisfacenti
sia la classificazione tradizionale (democrazia, aristocrazia, monarchia) sia le
tesi sulla “corruzione” del modello, egli cerca una soluzione alternativa capace
di sostenerlo nel suo ambizioso progetto di rendere conto di tutte le società e
NOTE
di Piero Venturelli
119
120
di tutti i governi della storia, includendo a pieno titolo nel quadro generale delle forme politiche anche le realtà extra-europee, tanto antiche quanto moderne, in particolare asiatiche.
In effetti, non mancando di richiamare costantemente l’attenzione sulla presenza di interessi “scientifici” nell’ambito del pensiero montesquieuiano, Felice
rileva il carattere del tutto inedito della tipologia tripartita avanzata dal pensatore bordolese: la distinzione dei tre tipi primari o fondamentali – repubblica
(nelle sue varianti democratica e aristocratica), monarchia e dispotismo – avviene in base all’adozione simultanea del criterio descrittivo del chi governa (il
numero delle persone che detengono il supremo potere) e di quello assiologico del come colui o coloro che detengono il potere lo esercitano; donde, il gouvernement despotique si differenzia dal gouvernement monarchique unicamente circa il modo di esercizio del potere, e non già in base alla titolarità dello stesso.
La monografia prende poi in esame il contributo fondamentale di Montesquieu alla riforma del pensiero giuridico e costituzionale moderno. Attraverso
lo studio della sua peculiare filosofia della pena e delle sue concezioni intorno
al principio dell’autonomia della giustizia, del quale il Bordolese è l’autentico
scopritore, Felice mette in rilievo come il suo scopo sia duplice: da un lato,
Montesquieu intende elevare il potere giudiziario alla dignità di potere primario
o fondamentale dello Stato; dall’altro, egli punta a rendere questo potere indipendente dagli altri poteri principali dello Stato. Secondo Felice, è importante
sottolineare come, nella prospettiva montesquieuiana, la separazione del potere giudiziario costituisca “il tratto strutturale di un governo moderato o libero,
nonché il criterio o fattore discriminante tra monarchie europee e monocrazia
turca-ottomana, tra governo moderato e dispotismo, tra libertà e oppressione”3.
L’autonomia della giustizia, dunque, risulta la conditio sine qua non di qualsiasi Stato che ambisca a definirsi moderato o libero.
Felice dedica la terza parte del volume all’analisi dell’Essai sur les causes
qui peuvent affecter les esprits et les caractères (1736-1743). Questo scritto,
che è il principale fra quelli lasciati inediti ed incompiuti da Montesquieu, costituisce uno dei suoi più importanti “laboratori” intellettuali: ciò ha indotto Felice
ad analizzarlo dettagliatamente e a proporne – nell’Appendice B – la prima traduzione italiana integrale. Il filosofo di La Brède, nell’Essai sur les causes,
espone la teoria secondo cui la vita degli uomini e delle nazioni è caratterizzata dalla compresenza di un duplice livello di causalità: accanto a quella “fisica”
(o “materiale” od “oggettiva”), opera – infatti – quella “morale” (o “spirituale” o
“soggettiva”), che sta all’origine della categoria di “carattere generale” di un popolo. Di conseguenza, Montesquieu fa dipendere i caractères delle nazioni o
dei popoli da cause fisiche, derivanti dal clima, e – insieme – da cause morali, che – come egli scrive – “consistono nella combinazione delle leggi, della religione, dei costumi e delle usanze”4. L’Essai sur les causes indaga le molteplici causes che concorrono a dar vita a questo caractère général, cercando di
mostrare come esse concretamente “agiscano” sul mondo umano e in che modo entrino in reciproco rapporto.
Come osserva Felice, la compiuta elaborazione della categoria di “caratte-
NOTE
re generale” avviene, sotto il nome di “spirito generale”, nella terza parte (libri
XIV-XIX) dell’Esprit des lois e va a costituire “il fondamento della scienza universale ideata da Montesquieu”, aspetto – questo – che “ha valso alla sua opera la qualifica di “immortale” da parte di Hegel e a lui quella di “precursore”, se
non addirittura, di “fondatore” delle moderne scienze sociali da parte di alcuni
tra i massimi sociologi del XIX e XX secolo (Comte, Durkheim, Aron)”5. Sicché,
l’Essai sur les causes deve considerarsi una tappa fondamentale della maturazione del pensiero montesquieuiano, uno sviluppo portato poi a compimento da quel monumentale Esprit des lois “dove tutto il discorso sulla ‘doppia causalità’ sarà perfezionato e sistematicamente ‘allargato’ anche agli ambiti economico e giuridico, oltre che organicamente inserito nel grandioso e geniale
progetto di costruzione di una scienza universale dei sistemi politico-giuridici”6.
Lo studio dell’Essai sur les causes permette a Felice non solo di far notare
come il filosofo di La Brède si ponga consapevolmente all’interno di una plurisecolare tradizione di pensiero – risalente almeno ad Ippocrate – secondo la quale è possibile distinguere due classi di fattori causali, l’una di tipo “oggettivo” e
l’altra di tipo “soggettivo”; ma anche come Montesquieu condivida la neurofisiologia cartesiana e si riveli sorprendentemente assai aggiornato in fatto di ipotesi
e di scoperte della scienza medica. Avendo cura di mettere in luce passo a passo le congruenze tra la nozione di caractère général d’une nation o d’un peuple
e quella di esprit général d’une nation o d’un peuple, Felice si dimostra fedele alla bipartizione del saggio che separa le causes physiques dalle causes morales,
onde egli dapprima indaga i fondamenti fisiologici e “psicosomatici” della teoria
del Bordolese, poi passa ad esaminare gli effetti dell’educazione, della reputazione e le relazioni umane e culturali sui caratteri individuali e collettivi.
Affermando che i due livelli di causalità restano sempre concomitanti nell’analisi “sociologica” di Montesquieu, Felice contesta le numerose letture – antiche e moderne – che parlano, a questo proposito, di determinismo climatico
o geografico: il barone di La Brède, infatti, non manca di osservare più volte
esplicitamente che entrambi gli ordini di causes esercitano insieme la loro azione sull’uomo, sicché sono da rigettare sia il determinismo morale sia il determinismo climatico, vale a dire l’assolutizzazione degli elementi spiritualistici e
– allo stesso tempo – di quelli naturalistici. In questo quadro, tuttavia, Montesquieu riconosce che le cause morali prendono progressivamente il sopravvento a misura che ci si allontana dalle condizioni originarie dell’umanità: ad
uno stadio molto avanzato dello sviluppo delle società, questi fattori – come
egli asserisce – “contribuiscono a formare il carattere generale di una nazione,
e determinano la qualità del suo spirito, in misura maggiore rispetto alle cause
fisiche”7, laddove presso i popoli “barbari” e “selvaggi”, non esistendo “alcun tipo di educazione”8, resta predominante l’influsso del clima.
Di grande interesse è anche l’Appendice A, nella quale Felice ricostruisce
le concezioni della pace e della guerra nel pensiero di Hobbes e di Montesquieu. Questo confronto permette allo studioso di porre in evidenza i caratteri di due delle opzioni più rilevanti del pensiero politico-giuridico moderno e
contemporaneo: l’immagine autoritaria e “dispotica” del potere e quella anti-autoritaria e “moderata” (o liberale) dello stesso.
121
122
Secondo Hobbes, com’è noto, la vita rappresenta il summum bonum. Nello “stato di natura”, in una condizione – cioè – in cui non esiste alcun legame
civile né rapporto comando-obbedienza, risulta un’impresa assai ardua – a suo
giudizio – conservare l’esistenza individuale, in quanto non solo si deve far
fronte a guerre diffuse, ma vi è anche la minaccia permanente che i conflitti
possano prodursi. Per conseguire la pace e salvaguardare – così – la vita umana, il filosofo britannico ritiene necessario, ma non sufficiente, servirsi della ragione, la quale è, sì, capace di indicargli utili vie – sotto forma di “leggi naturali” – per arrivare alla meta prefissata, ma esse si rivelano del tutto impraticabili finché non s’instaura un potere coercitivo comune: di qui, l’esigenza di creare lo Stato. Secondo l’autore inglese, tuttavia, unicamente lo Stato assoluto è
in grado di “salvare” gli uomini dalla loro propria “natura”, trasformandoli – attraverso l’instaurazione di un regno della ragione, della coercizione e della disuguaglianza sociale – in portatori di vita (di pace) gli uni per gli altri (homo homini Deus).
La visione di Montesquieu sul tema della pace è radicalmente diversa: a
suo giudizio, la struttura politica delle relazioni esistenziali è costruibile a partire dal concetto che la guerra sia legata all’essenza della società. Secondo il filosofo francese, infatti, lo stato di guerra non è dovuto ad una tendenza originaria, ma deriva da cambiamenti intervenuti nella costituzione dell’uomo a seguito del formarsi della società e dell’accrescersi delle sue facoltà conoscitive.
Pertanto, nella prospettiva montesquieuiana, idee come quella dell’“assoggettamento” e della “dominazione” non appaiono “semplici”, bensì “complesse”,
sviluppatesi – come poi ribadirà, ampliando la prospettiva, Rousseau – allorché l’uomo viveva già in società coi propri simili. Osserva Felice che
Montesquieu non nega, quindi, il fatto della guerra, ovvero che lo stato
che precede quello politico e civile sia uno stato di guerra, ma sostiene
che esso non è tale originariamente, ossia che la guerra […] non è legata all’essenza dell’uomo, bensì a quella della società. Non lo stato di
guerra (o l’insocievolezza), ma lo stato di pace (o la socievolezza) è connaturato all’uomo9.
Secondo il filosofo francese, lo scopo della politica non consiste tanto – come per Hobbes – nell’eliminare la guerra attraverso la soppressione della “natura umana” cui essa è ritenuta insita, ma piuttosto è rappresentato dalla moderazione di quella che egli reputa la pacifica (o solo socialmente bellicosa)
‘natura umana’. Affinché l’esercizio della libertà sia davvero “regolato”, e dunque costruttivo, occorre dar vita – per Montesquieu – a “quel complesso e sofisticato sistema di ‘spartizione’ e di controllo reciproco dei poteri che è il governo moderato o limitato”10; soltanto in questo modo, a suo giudizio, può realizzarsi un autentico e proficuo pluralismo politico, sociale e culturale, cioè
“un’armonia derivante da ‘dissonanze’”, “un equilibrio dinamico, conflittuale tra
forze e interessi differenti”11.
NOTE
1 D. FELICE, Per una scienza universale dei sistemi politico-sociali. Dispotismo, autonomia della giustizia e carattere delle nazioni nell’Esprit des lois di Montesquieu, Olschki, Firenze 2005
(d’ora in poi: SU).
2 MONTESQUIEU, Défense de l’Esprit des lois, in Œuvres complètes de Montesquieu, publiées
sous la direction de A. Masson, 3 voll., Nagel, Paris 1950-1955, vol. I, B, p. 456; traduzione nostra.
3 SU, p. 78.
4 SU, p. 194; traduzione di Felice.
5 Premessa a SU, pp. VII-VIII.
6 SU, p. 134.
7 SU, p. 196; traduzione di Felice.
8 SU, p. 190; traduzione di Felice.
9 SU, pp. 161-162.
10 SU, p. 166.
11 SU, p. 168.
123
POSIZIONE GENERALE
DEL PROBLEMA DEL PENSARE
di Daniele Bertini
124
1. Mente, autocoscienza, coscienza, soggetto, sé, identità personale, sono solo alcune delle nozioni messe all’opera nel tentativo di comprendere il fenomeno
più sconcertante della nostra esperienza: noi stessi. Queste nozioni formano una
fitta rete concettuale, una maglia teorica dall’ordito complesso, la cui contestualizzazione richiede la specificazione particolare di altre nozioni parallele. A ben guardare l’arrovellarsi del pensare sulla questione del nostro essere sembra l’atto inesauribile di determinare sempre nuovamente il già determinato, l’arricchire di nuove qualità, visioni, intuizioni, concettualizzazioni, narrazioni, l’approdo già raggiunto, nell’apparente consapevolezza che tale approdo non possa ambire, da sempre e per sempre, a essere niente altro che una stazione di passaggio.
Tutto sommato il preliminare e immediato isolamento del fenomeno, che dovrebbe istituire i confini concettuali della problematica prescelta, pare evidentemente banale: si tratta di gettare luce sul fenomeno che noi stessi siamo, ossia
comprendere la natura della nostra costituzione ontologica. Ma all’apparente
banalità dell’immediatezza originaria si mostra da subito la complessità della
domanda. Perché non si tratta tanto di determinare qualche proprietà che ci appartenga, ma che genere di essere sia quello che viene messo in questione, ossia se sia una sostanza o un modo della sostanza, se sia un’ente semplice o
una funzione di un’ente complesso, se sia spiegabile parallelamente alle descrizioni operate da altre discipline scientifiche o se si tratti invece di qualcosa di
completamente diverso: la domanda deve perciò essere ben compresa e determinata prima di iniziare ad articolare una risposta. Infatti la stessa peculiarità da
molti attribuita alla difficoltà della questione, quella che si potrebbe dire la natura orizzontale della problematica, il fatto che non si possa mai uscire da noi
stessi nel porre il problema di noi stessi, sembra peculiare solo nella misura in
cui si siano già scelte alcune categorie ermeneutiche fondamentali, che consentano di orientare secondo certe direzioni interpretative le questioni originarie
dalle quali il problema stesso scaturisce; ossia solo quando si sia già distinto fra
ciò che ci caratterizza, sia la coscienza, il pensare, la semplicità spirituale, la
culturalità del nostro abitare l’esperienza, e ciò che è diverso da noi.
È evidente che non sia mia intenzione né proporre un’interpretazione del
problema, né un metodo per l’interpretazione. Volendo fare solo un po’ di luce
sulla domanda mi limiterei a introdurre un certo rigore terminologico, un apparato categoriale la cui unica ambizione sia quella di fornire strumenti per la pratica argomentativa indirizzata a un minimo di coerenza e di chiarezza. Chiaramente senza alcuna pretesa di una assoluta formalità.
3. L’assegnazione reciproca di cogito e mente non è un fatto casuale: l’ambito del mentale pervade la nostra esperienza soggettiva in modo analogo a
come l’esperienza cartesiana era un’esperienza di pensiero. La mente è in effetti equivalente alla res cogitans emergente dall’attività filosofica del dubbio
metodico, sebbene, almeno preliminarmente, sia priva di qualsiasi caratterizzazione o presupposto metafisico relativo alla sua natura ontologica2. Ciò che
infatti si mostra pienamente nella mentalità dell’esperienza è quell’elemento irriducibilmente presente in ogni sua forma, ossia io:
Ecco, ho trovato: è il pensiero; questa sola cosa non può essermi sottratta. Io sono, io esisto: è certo. Ma per quanto? Finché penso di sicuro: infatti potrebbe forse accadere, se io mi astenessi da ogni pensiero, di essere immediatamente del tutto eliminato3.
Chiamo evidenza ciò che indeterminatamente intendiamo con termini quali percezione, idea sensibile, dato sensibile, costituente percettivo, aspetto dell’esperienza, momento, o quant’altro. Nella definizione cartesiana della priorità ontologica del cogitare si esprime, a mio avviso, la tesi seguente: la mia ineliminabile partecipazione all’esperienza mostra come ogni evidenza dell’esperienza ha sempre un significato in relazione a una qualche mente particolare,
a cui tale aspetto deve essere necessariamente riferito. Tolto un simile autoriferimento dell’esperienza operato da una mente, l’esperienza si vanifica, si dissolve, si desostanzializza; infatti qualsiasi descrizione dell’esperienza possa
essere data, nessuna potrà mai superare la constatazione che l’esperienza, in
quanto experientia, appartiene a un qualche ente che compie l’atto di experire. Ora è evidente che la mente che esperisce l’esperienza, ossia che la prova, è sempre un individuo determinato, particolare. Non è tuttavia questa natura particolare che interessa mettere a fuoco nella comprensione della mentalità dell’esperienza, bensì il carattere peculiare dell’autoriferimento, l’attività
NOTE
2. Nella letteratura di tradizione analitica è invalso l’uso del termine mente
(mind) per qualificare il fenomeno della soggettività nel suo senso lato. Indipendentemente dalle caratterizzazioni che le particolari metafisiche danno a
tale termine, con mente si esprime l’intero ambito problematico della soggettività, dell’esperienza in prima persona, dei fenomeni della coscienza e dell’autocoscienza, del riferimento a sé stessi, e dell’uso dei pronomi personali. Proprio per questa sua generale vaghezza con questo termine possiamo fare riferimento al fenomeno stesso in esame, precedentemente a una sua qualsiasi
specificazione determinata. Non si vuole sostenere che un uso del genere possa essere neutrale, visto che la memoria semantica del termine mente è comunque necessariamente gravida della sua storia filosofica (basti pensare alla sua derivazione dal termine scolastico latino mens). Si vuole tuttavia in prima istanza caratterizzare la dimensione fenomenologica al cui interno si situa
il fenomeno di noi stessi: la mente è perciò, in questo suo senso generico, ciò
che qualifica la natura insopprimibilmente personale dell’esperienza, l’oggetto
proprio di quello che viene comunemente chiamato problema del cogito 1.
125
di ricondurre le evidenze che costituiscono l’esperienza di una mente determinata a quella mente, in quanto tessuto strutturale ineliminabile delle evidenze
stesse. Con mente dobbiamo allora intendere quel genere di connettivo ontologico che uniforma ogni singola evidenza dell’esperienza, in quanto lo riferisce a un ente determinato che ne è consapevole, e tolto il quale l’esperienza
stessa viene a cadere, a cessare.
126
4. Questa natura orizzontale della mente, proprio perché indeterminata da
un punto di vista metafisico, esprime banalmente una semplice qualità di ogni
esperire, quella di appartenere a qualcuno (ossia a ognuno di noi) che ci è immediatamente familiare4. Non è necessario compromettersi con problematiche
fondazionaliste, né con presupposti idealistici, per apprezzarne a pieno il valore euristico. È solo quando la mente passa a qualificare la natura sostanziale
o meno della soggettività individuale, quando da carattere dell’esperienza diviene res cogitans, quando diviene il fondamento indiscusso della conoscenza, che la mente perde la propria indeterminatezza concettuale, divenendo oggetto di speculazioni critiche o meno. Notoriamente, secondo la ricostruzione
storiografica comunemente accettata, l’esigenza fondazionalista è la spinta
motrice che induce Descartes alla posizione del cogito 5. La costatazione fenomenologica della natura mentale, cioè autoreferente, dell’esperire cede il passo alla postulazione di una sostanza semplice di cui tale mentalità sarebbe una
modalità. Conoscenza prioritaria e massimamente certa per chiunque filosofi
con ordine, la mia esistenza in quanto pensante è la via che conduce verso la
progressiva scoperta della verità6. Il filosofo si trova perciò nella necessità di
gettare un ponte fra la natura insopprimibilmente personale della propria esperienza e l’universalità del sapere che da tale particolarità si vorrebbe fondato.
L’ansia di fondazione che caratterizzerebbe il pensiero dell’età cartesiana non
sarebbe sostanzialmente altro perciò che la necessità di individuare un luogo,
se così posso esprimermi: il punto di scambio, il momento di passaggio, la matrice della traduzione che mostri l’equivalenza fra l’esperienza, soggettivamente determinata dalla sua natura mentale, e la conoscenza, universalmente offerta in una serie di regole indipendenti dalla loro particolare presentazione
empirica soggettiva.
Così posto, il problema della mente si articola in una serie di questioni fra
loro correlate: ?) relazione fra mente ed esperienza; posto che l’esperienza è
rinvenuta attraverso la mente, allora l’esperienza è uno stato della mente? Una
sua attività? Esiste solo in una forma insuperabilmente particolare e soggettiva? Ci sono solo menti particolari? O anche una mente universale cui le menti particolari ineriscono, o da cui sono formate?; ?) relazione fra esperienza e
mondo; se l’esperienza appartiene sempre a una mente, tale esperienza non
potrebbe tuttavia essere pensata come lo stato soggettivo di una realtà oggettiva? Il mondo non potrebbe essere una causa efficiente esterna all’esperienza?; ?) relazione fra mondo e conoscenza; poiché la conoscenza riguarda
l’universalità, come la soggettività dell’esperienza può relazionarsi al mondo
oggettivamente conosciuto? L’idealità della mente rende forse conto, conoscendo, del mondo che sta oltre l’esperienza, e da cui l’esperienza sarebbe
NOTE
causata?; ?) relazione fra mente e conoscenza; la mente si pone come fondamento della conoscenza o del mondo? Come pensare all’indipendenza ontologica del mondo se dipende dall’attività ontologica della mente?
In Descartes tali questioni sono tutte imbrigliate in unico nodo concettuale,
che potremmo pensare come derivante da una sorta di ermeneutica delle qualità. La distinzione fra le qualità primarie, vale a dire le qualità reali degli oggetti, e le qualità secondarie, le qualità che gli oggetti ci sembrano possedere in
virtù dell’azione delle qualità primarie sulla mente, appare a Descartes, seguito in questo da Hobbes, Spinoza, Locke, e Boyle, un principio esplicativo delle proprietà dell’esperienza dal valore e dalla potenza tanto generali che la relazione fra mente, esperienza, mondo e conoscenza giunge a formare un unico corpo concettuale7. Ciò che mi appare è a un tempo l’aspetto soggettivo,
secondario, di ciò che è oggettivo, primario8. Se l’intera esperienza sembrerebbe preliminarmente chiusa entro sé stessa, il movimento esplicativo fondato
dalla dialettica delle qualità spinge la mente costantemente oltre sé stessa verso la conoscenza oggettiva di un mondo che sta confusamente in una dimensione sospesa fra l’interiorità dell’esperienza e l’esteriorità del mondo oggettivamente conosciuto. Sono l’interiorità e l’esteriorità a condondersi profondamente. L’impresa intellettuale cartesiana sembrerebbe allora volta soprattutto
a conciliare l’insorgere epistemologico del conoscere con le determinazioni
universalistiche del medesimo. In tale attività ogni differenza tende a smorzarsi, tende alla diluizione, alla mescolanza. Ciò che resta inequivocabilmente
presente, la natura della presenza stessa, sembro essere soltanto io. Ogni evidenza dell’esperienza è accompagnata da tale autoriferimento. E in questo
procedere il tratto unificante del mentale sovrasta ogni specificazione. Pensiero, percezione, immaginazione, giudizio sono un unico tutto: “ma cosa sono allora? Una cosa che pensa. Cosa è questa? In verità una cosa che dubita, che
intende, che afferma, che nega, che vuole, che non vuole, che anche immagina, e che sente”9. Ciò che fa tutti questi momenti del mio esistere sostanzialmente equivalenti è la mia irriducibilità, la mia presenzialità soggettiva, e pertanto la mia costitutiva sostanzialità, il cogitare.
Direi pertanto che l’istanza fondazionalista cartesiana, presuntivamente affermata spesso proprio da chi intende scalzarla con slogan come quelli relativi alla morte del soggetto o dell’uomo, sia piuttosto un mito storiografico che
una reale attrezzatura teorica per la comprensione della fondamentale questione filosofica della soggettività. Descartes infatti è tutto interno alla necessità di
far convergere la propria attività scientifica, capace di ampie generalizzazioni
e di grandi successi esplicativi, con l’impossibilità di mettere fra parantesi la natura sostanzialmente autoreferenziale dell’esperienza. Più che dal fondare una
conoscenza, la sua impresa intellettuale sembra originarsi dalla necessità di
accordare quella conoscenza con l’esperienza. Più che individuare un momento genetico del sapere, Descartes sembra incapace di ridurre la pervasività e
l’autoevidenza della mente alle proprietà meccaniche della res estensa: sembra mosso dal dover affermare la sussistenza simultanea di due generi ontologici inesprimibili l’uno nell’altro10.
127
128
5. A mio avviso queste considerazioni pongono nella giusta luce un fatto molto rilevante e peculiare: nell’età cartesiana diviene problema decisivo per la comprensione filosofica il tema della percezione. È proprio perché la mente ha ampliato i propri confini territoriali, giungendo a inglobare entro sé stessa l’interezza
del mondo e della conoscenza in quanto proprie esperienze soggettive, che
l’analisi del formarsi per il soggetto dell’oggettività empirica acquista lo statuto di
indagine preliminare e fondativa rispetto a ogni altra disciplina filosofica. La teoria della percezione si articola così in una serie di ricerche che attraversano i vari campi della conoscenza, dall’ottica alla geometria, dalla medicina alla teologia,
dalle riflessioni linguistiche alla psicologia. In tale teoria i metafisici cercano la soluzione del dissidio fra pensiero ed estensione, cercano la mediazione fra mente e mondo, fra sostanzialità di generi differenti. Alla percezione è demandata
quasi la possibilità di una verifica empirica della validità della metafisica cartesiana. Il dissidio lacerante della sostanzialità sembra dover poter trovare un accordo nel percepire, momento di contatto, di tangenza, fra l’interno e l’esterno,
l’esperienza e il mondo, il soggetto e l’oggetto, la res cogitans e la res estensa.
Credo che la problematica della mente porti con sé questo retaggio tradizionale in modo ineliminabile. Nella misura in cui concettualizziamo la nostra
esperienza come esperienza di menti la necessità di comprendere la natura
del percepire si impone con una forza del tutto invincibile. Indipendentemente
dallo statuto che decidiamo di assegnare alla mente, indipendentemente dalla
specificazione determinata del mentale che scegliamo, abbiamo bisogno di
comprendere come una percezione possa sussistere per noi, e come tale percezione ci ponga in relazione con l’altro da noi; e anche quale valore tale percepito abbia per noi. Questa necessità ci mostra infatti cosa intendiamo in modo specifico con il termine mente. Il percepire ci pone forse davanti a un oggetto? È una nostra funzione, un’attività, una nostra modalità esistenziale? E
che cosa percepiamo? E siamo sempre la stessa mente in percezioni differenti del medesimo? E percepiamo tutti il medesimo?
6. Proprio questo rivolgersi dal pensiero su stesso alla ricerca del soggetto
determinato del percepire mostra l’enorme possibilità metafisica del tema della percezione. Distinguerò fra quattro diverse accezioni in cui la mente percepiente può essere pensata: 1) mente come soggetto delle percezioni; 2) mente come identità permanente nel tempo; 3) mente come sostanza metafisica;
4) mente come sostanza metafisica che esplica un’attività pratico-morale. Le
prime due accezioni hanno un valore fenomenologico, perché insistono sulla
presentazione nell’esperienza dell’attività di autoriferimento delle evidenze. Le
seconde due accezioni specificano la natura ontologica di ciò che si è presentato fenomenologicamente. Nella prima coppia il momento 1) è prioritario rispetto al momento 2), perché solo a partire dalla costatazione della nostra
identità soggettività autoriferiamo a noi stessi le singole evidenze di cui ci sentiamo soggetti. Nella seconda coppia il momento 4) è prioritario rispetto al momento 3) perché solo nell’attività morale si presenta a noi stessi la natura della nostra costituzione ontologica, quale che essa sia.
NOTE
7. Prima di argomentare a favore della terminologia appena introdotta vorrei mettere in guardia contro una versione fondazionalista del problema del cogito; versione che per quanto eccezionalmente affascinante deve a mio avviso
essere rifiutata perché assolutamente sviante e ingenerante confusione nella
problematica stessa. L’analisi di una simile interpretazione mostrerà infatti il
senso genuino della validità del problema, mettendolo al riparo da ulteriori
fraintendimenti e consentendo così di procedere innanzi, forti delle determinazioni raggiunte.
Facendo uso dell’apparato concettuale ereditato da Kant, Husserl propone
una lettura teoretica delle Meditationes de Prima Philosophiae, che mette l’accento proprio sull’enfasi fondazionalista e serve sostanzialmente a giustificare
una pratica del pensare come strategia fondativa11. Il punto di partenza della riflessione di Husserl è l’esigenza di porre un cominciamento radicale, ossia
porre innanzitutto fuori causa tutte le convinzioni finora ritenute valide,
comprese tutte le nostre scienze. L’idea direttiva delle nostre meditazioni sia, […], quella di una scienza da fondare in autenticità radicale e infine quella di una scienza universale12.
Attraverso tale cominciamento che attua il dubbio metodico cartesiano per
giungere all’indubitabile, Husserl mette fra parentesi ogni conoscenza fattuale
per cercare la giustificazione di ognuna di esse. La conoscenza è infatti un intendere, ossia un giudizio:
il giudicare è un intendere e in generale un pretendere che la cosa stia
così e così; il giudizio (ciò che è giudicato) è quindi solo qualcosa di preteso o meglio è il preteso contesto oggettivo oppure l’intenzione oggettiva, l’intenzione del contesto oggettivo.
Ora per Husserl l’attività del fondare è una modalità del giudicare, ossia fondazione e conoscenza sono identiche una volta che siano autentiche. Pertanto una conoscenza fondata non è altro che una conoscenza nel senso genuino del termine:
nella fondazione autentica i giudizi si danno a vedere come corretti, convenienti; la fondazione è cioè la convenienza del giudizio con il contesto
del suo stesso oggetto (una cosa o un contesto oggettivo)13.
Ciò che garantisce la correttezza della fondazione è l’accertamento dell’evidenza.
L’evidenza nel senso più ampio del termine è esperienza dell’ente, dell’ente così determinato, anzi essa è il pervenire da sé dell’ente alla vista
spirituale14.
L’evidenza assurge così a principio metodico che guida Husserl alla ricerca
della fondazione di una scienza autentica; vale a dire che il giudizio fondato de-
129
130
ve in ultima analisi attenersi a quell’evidenza in cui l’esperienza abbia mostrato come le cose stesse siano effettivamente presenti nei contesti correlativi del
giudizio.
Il passaggio al tema del cogito avviene alla luce del rinvenimento della sicurezza assoluta, ossia dell’assoluta indubitabilità che deve contraddistinguere il procedimento fondativo posto in atto dal dubbio metodico15. Se infatti nessuna scienza soddisfa i requisiti che una fondazione autentica richiede alle
particolari conoscenze, neppure il mondo può essere considerato effettivamente fondato. Non perché si possa ragionevolmente dubitare della sua esistenza, ma perché l’evidenza del mondo non ha quel grado di apoditticità che
possa valere da fondamento per la scienza autentica universale: una volta che
si indaghi il genere di evidenza che possiamo attribuirgli, “si scopre che l’evidenza in questione non può neanche pretendere al privilegio d’essere una evidenza assolutamente prima”16. È in virtù di questa costatazione che Husserl
sostiene che la credenza esistenziale nel mondo (seinglauben) può valere solo come evidenza di una pretesa all’essere (seinanspruch)17. Ma poiché ogni
fenomeno mondano non può assurgere che a questa pretesa d’essere, ossia
non può che testimoniare la propria fenomenicità, Husserl ritiene che l’intero
mondo della vita, presente a me che sono in cerca dell’evidenza apodittica che
fondi la scienza universale, sia classificato non come essere, bensì come un
semplice fenomeno d’essere. L’appartenermi tuttavia di un tale fenomeno non
è però fenomeno anch’esso, perché indipendentemente dall’intensione da me
posta in atto rispetto al determinato fenomeno d’essere considerato, tale fenomeno è per me costantemente presente. È anzi proprio la possibilità di prescindere dall’intenzione determinata che mostra il mio cogitare come l’evidenza
apodittica fondante. Tale prescindere significa in primo luogo che io possa
astenermi dal giudicare stesso. Significa che per me il fenomeno d’essere possa essere messo fra parentesi nella sua pretesa all’essere, e ciò nonostante io
non mi trovi ancora di fronte a un mero nulla; perché resta quell’elemento che
precedentemente abbiamo definito autoreferenziale, e che Husserl esprime dicendo che tale fenomeno d’essere resta comunque giudicato un per me.
Quello che piuttosto […] diviene nostro proprio, o più chiaramente, quel
che per ciò diviene proprio a me che medito, è il mio esperire puro con
tutti i suoi momenti puri e tutto ciò che che esso intenziona, l’universo dei
fenomeni, nel senso della fenomenologia18.
Il mondo nel suo complesso riceve quindi per Husserl la propria fondazione da questa attività pensante del cogito, perché l’analisi fenomenologica rileva in primo luogo, in quanto evidenza apodittica originaria, questa posizione
ontologica del cogitare di un io trascendentale.
8. Husserl, se è possibile, amplia ancora di più la pervasività del mentale
nell’esperienza. Il suo argomentare a favore del cogito pone il mentale non solo come dato irriducibile e irrinunciabile, ma anche come presente nella stessa
negazione d’essere. Se Descartes aveva ravvisato la res cogitans in ogni evidenza dell’esperienza, qualificandone la sostanzialità a partire proprio dalla
9. Torniamo quindi alla quadruplice caratterizzazione della mente proposta
al § 6. Valutiamo il senso delle determinazioni fenomenologiche della mente in
quanto soggetto della percezione e identità. La prima specificazione esprime
nella concretezza di una singola particolarità, la mia, lo statuto peculiare della
mia posizione rispetto alle evidenze che mi si presentano innanzi. L’equivalenza finora stabilita fra mente ed esperienza, ossia fra io e ciò che provo, ciò di
cui faccio esperienza, mi pone il problema di rispondere sostanzialmente a due
domande: quale differenza sussista fra me e l’esperito, e quale genere di esperienza di me stesso io faccia. È evidente che io posso pensare la prima questione solo assieme alla comprensione della seconda. Infatti data l’immanenza nell’esperienza tanto di me stesso che delle evidenze che percepisco, è nel
momento in cui accedo a me stesso che posso distinguere fra l’interiorità che
NOTE
presenza di una determinazione positiva qualsiasi del pensare, Husserl mette
fra parentesi il pensare stesso, destituendo di valore la sua determinazione,
perché si manifesti palesemente l’essere per me di ogni esperienza. Sono io
stesso nella mia natura, in ultima analisi persino nel mio sospendere il giudizio, e porre così l’evidenza stessa al di fuori di ciò che mi è evidente, a essere davvero presente a me stesso nel mio esperire.
L’autoreferenzialità dell’esperire, struttura fondamentale della mia irriducibilità, appare dunque all’opera non solo nei momenti in cui la mente è determinata a una qualche positiva attività, ma anche quando negativamente sospende l’interesse a determinarsi. Tuttavia l’impianto husserliano resta, a mio avviso, inaccettabilmente kantiano. Non tanto perché pone il fondare come obiettivo ultimo dell’intera analisi. Suo malgrado, le determinazioni raggiunte potrebbero comunque rivelarsi validamente illuminanti. L’autentica debolezza di tutto
l’argomentare è la struttura deduttiva, nel senso kantiano di deduzione trascendentale, che Husserl adotta. Infatti si mantiene quella confusione fra esperienza, mondo, conoscenza e soggettività, che se in Descartes era innescata
da una preventiva accettazione di due ordini d’esperienza, quello interiore del
cogitare e quello esteriore della res estensa, in Husserl è del tutto ingiustificata perché l’esteriorità è preventivamente messa fuori dal campo della considerazione filosofica. Non vi è alcuna dialettica delle qualità a rendere necessaria
una simile confusione. E l’intera argomentazione risulta infatti inevitabilmente
idealistica, nel senso deteriore del termine, perché associa senza possibilità di
appello, il per me che costituisce la mia esperienza, a un per me che dovrebbe essere proprio anche del mondo e della conoscenza. In questo senso il cogito cartesiano diviene per Husserl una soggettività trascendentale di stampo
kantiano, intenta a dare forma al mondo in virtù del proprio intenzionare.
Rilevare questa difficoltà è tanto più importante proprio perché dobbiamo
dissociare, nel comprendere noi stessi, il problema della soggettività dell’esperienza, ossia l’idea che l’esperienza dovrebbe essere prodotta da fantomatiche
strutture trascendentali da noi poste in essere, dal problema della nostra autoreferenzialità. Le ansie teoretiche che muovono il pensare, mi sembra che vadano ricercate nella necessità di comprendere la simultaneità di esperienza e
mondo, di interiorità ed esteriorità, di mente e conoscenza.
131
132
mi appartiene in quanto mente e l’esteriorità delle evidenze. Il rinvenimento immediato di me stesso a me che penso costituisce all’interno della esperienza,
che è appunto qualcosa che io provo, una divergenza fra la posizione soggettiva di me stesso, che è una posizione analoga a quella di uno spettatore, e il
dominio fenomenologicamente indipendente da me dell’insieme delle evidenze19. Questo insieme delle evidenze percepite sta di fronte a me che mi rendo
conto del loro essere a me esterne e congiuntamente mie. Il percepire mi si
mostra perciò come una relazione fra la mia soggettività e l’oggettività di una
certa evidenza percepita. In tale relazione io e l’evidenza stiamo come due generi complementari e differentemente affiancati senza mescolanza. Valgono simultaneamente due istanze diverse: l’eccentricità della mia mente rispetto a
qualsiasi evidenza, eccentricità che viene qualificata dalla mia irriducibilità e
della mia ineliminabilità da qualsiasi esperienza, e l’autonoma indipendenza
dell’insieme delle evidenze. Ora, dato che tale dominio proviene da un mio
esperire questo viene confusamente denominato esperienza, ingenerando così l’equivoco fondamentale di intendere tale esteriorità alla mia particolare
esperienza equivalentemente a un’esteriorità oggettivamente sussistente delle evidenze in un genere ontologico alternativo a quello della mia esperienza;
ossia le evidenze vengono concepite come inerenti in un sostrato genericamente chiamato mondo. Ma poiché tale mondo si pretende essere anche
un’esperienza, l’interiorità della mente e l’esteriorità delle evidenze si confondono con l’interiorità della mia esperienza e l’esteriorità del mondo. Questa
complessa costituzione dell’esperienza, in cui nel trovarmi come soggetto mi si
mostrano delle evidenze da me indipendenti che io percepisco, sorge pertanto da una processo di differenziazione in cui io accedo a me stesso.
Questa differenziazione è stata per lo più tematizzata in due modalità alternative. La prima di queste modalità presume una specie di autopercezione interiore della mente da parte della mente. Tale autopercezione si esplicherebbe
attraverso un rivolgimento dello sguardo dall’esterno verso l’interno: un presunto occhio interiore ci renderebbe manifesti a noi stessi. L’impossibilità di dubitare dei propri stati interni come stati autopercettivi, ci costituirebbe come
soggetti autocoscienti, come soggetti immediatamente trasparenti a noi stessi,
precedentemente a qualsiasi relazione con l’esterno, che diverrebbe così problematica20.
La seconda modalità, sviluppata dall’idealismo tedesco in contrapposizione
a questo approccio percettivo alla natura ontologicamente privilegiata della
mente, troverebbe invece il fondamento dell’autonoma autopresenzialità di me
stesso, che io costantemente provo, in una forma peculiare di sapere, quello
dell’autocoscienza: il sapere dell’io che pone sé stesso come proprio oggetto21.
La mente si mostrerebbe cioè come una coscienza di certi stati interni, strutturata in modo tale che questi stati interni siano l’oggetto posto dalla coscienza
a sé stessa; ossia la coscienza avrebbe sé stessa per oggetto, risultando perciò un’autocoscienza.
Entrambe queste caratterizzazioni della specificità della mente devono comunque essere scartate. Noi non facciamo mai esperienza di noi stessi né sotto forma di un sentire, né sotto forma di un sapere immediato. Abbiamo sicura-
10. Questa costanza permanente di me stesso che mi si manifesta nel succedersi delle percezioni viene qualificata per mezzo della nozione di identità
personale. Il soggetto percettivo è infatti un soggetto puntuale, rinvenuto a partire da una sorta di atomismo della percezione che considera le evidenze come fatti isolati e indipendenti gli uni dagli altri. È solo un’esigenza analitica ad
aver motivato una simile trattazione della soggettività. Nella misura in cui si voleva porre in piena luce la contrapposizione instaurata nel percepire fra me e
le evidenze, si è isolata una singola percezione mostrando così l’elemento che
resta sempre a qualsiasi sottrazione; ossia la mia presenza. Tale presenza però, per quanto esperita immediatamente come essere mio delle evidenze, è
sempre costituita da un complesso precipitato di evenienze, da una storia percettiva, da una continuità, che mi presentano come qualcosa di più composito
che una semplice presenza puntuale: io sono un soggetto che nella presenza
mostra la propria identità nel tempo. È chiaro come la natura di questa identità rappresenti un problema filosofico dai contorni inquietanti; e come in ultima
analisi fondi la propria difficoltà nella totale indeterminazione concettuale della
nozione di mente, richiedendo di scegliere e specificare ontologicamente il mio
statuto soggettivo, ed esponendolo così a ogni critica argomentativa.
Tuttavia la presenzialità che noi esperiamo di noi stessi è sempre esperita
come un’immediata autoidentità, come una chiara autocomprensione in cui ci
riteniamo il soggetto permanente delle evidenze per noi evidenti. Non si tratta
cioè di determinare quali motivazioni filosofiche possiamo portare per giustificare una tale autoattribuzione di identità, ma di rilevare semplicemente che tale autoattribuzione è un fatto ineludibile del nostro esperire.
Le due nozioni fenomenologiche che esplicano compiutamente la struttura
dell’identità sono, secondo la terminologia humeana, quelle di rassomiglianza
e causazione. Definiremo la prima relazione costitutiva e irriducibile, la seconda costituita e riducibile. Infatti la rassomiglianza
è una relazione senza la quale nessuna relazione filosofica può sussistere; poché nessun oggetto ammetterà una comparazione, se non quelli
che hanno un qualche grado di rassomiglianza23.
La rassomiglianza è quindi ciò che permette la costituzione di ulteriori rela-
NOTE
mente un sapere che ci riguarda, ma non ha il carattere trascendentale che pensatori come Kant o Fichte gli assegnano. Come pure noi sperimentiamo noi stessi in una forma che non è quella di un sentire percettivo, non ci sentiamo nel senso in cui vediamo un oggetto o tocchiamo un corpo. Il carattere di me stesso che
è sempre congiunto a ogni mia esperienza delle evidenze ha piuttosto il carattere di un’affezione permanente dell’insieme delle evidenze. Io sono una sorta di
orizzonte del mio esperire. Sono un qualcosa che è sempre dato, non nel senso
di una natura sostanziale, ma nel senso di una presenza intrascendibile immediatamente sperimentata: io sono sempre entro me stesso, sono al centro di ogni
accadimento della mia esperienza, sono, se così posso esprimermi, il mio costante riferimento. Io sono lo spettatore non percepientemi di me stesso22.
133
zioni, è una struttura del pensare in ultima analisi inanalizzabile: è infatti ciò
che viene presupposto da qualsiasi altra analisi, nella misura in cui vi è la necessità di operare raffronti fra i singoli elementi analizzati. Il porre un’identità,
una differenza, l’unità o una molteplicità, una continuità o una discontinuità, si
fonda principalmente sulla possibilità di confrontare le evidenze correlate, e
pertanto su una possibilità di individuare rassomiglianze. Proprio l’osservazione delle rassomiglianze fra successioni relative di eventi induce la mente a
esperire una forma di regolarità che è a fondamento della causazione.
Anche se i diversi esempi rassomiglianti che danno origine all’idea di potere non hanno alcuna influenza l’uno sull’altro, e non possono produrre
alcuna nuova qualità nell’oggetto, la quale possa essere il modello di
quella idea, l’osservazione tuttavia di questa rassomiglianza produce una
nuova impressione nella mente, che è il suo modello reale24.
Qualora la rassomiglianza non istituisse un raffronto fra i vari esempi di successione relativa, la mente non potrebbe quindi mai provare quel genere di coercizione associativa che pone in atto una relazione di causa effetto.
134
Infatti dopo aver osservato la rassomiglianza in un numero sufficiente di
esempi noi sentiamo immediatamente una determinazione della mente a
passare da un oggetto a quello che usualmente lo segue, e a concepirlo
in una luce più chiara in virtù di questa relazione. Questa determinazione è l’effetto unicamente della rassomiglianza25.
Questa natura costituita, originata, sperimentata, della relazione causale assegna alla mente un ruolo attivo e costitutivo nell’eleborazione delle associazioni causali che determinano la produzione di leggi generali da parte dell’immaginazione. La causalità ha una natura attualistica, è un atto della mente:
questa è […] l’essenza della necessità. Tutto considerato la necessità è
qualcosa che esiste nella mente, non negli oggetti; né è possibile per noi
formare mai un’idea più distante dalla sua natura, che considerarla come
una qualità sussistente nei corpi […] la necessità non è niente altro che
la determinazione del pensiero a passare dalle cause agli effetti e dagli
effetti alle cause, conformemente alla loro unione sperimentata26.
Alla luce di queste considerazioni definisco l’identità personale come la rassomiglianza dell’autoattribuzione delle evidenze a un unico ente, ossia a me
stesso; grazie alla quale la mia mente si riconosce come principio direttivo dell’esperienza della mia identità: ossia come attività volta a una relazionalità di tipo causale all’interno della serie fenomenica di evidenze che mi si fanno innanzi. Hume sottolinea come entrambi questi aspetti, rassomiglianza e causalità,
facciano parte della nozione che noi abbiamo della nostra identità. La rassomiglianza fra le nostre percezioni e il ricordo di esse conservato dalla memoria è
il principio che ci rende manifesti a noi stessi come identità permanente dei nostri processi percettivi:
la memoria non scopre soltanto l’identità, ma contribuisce anche alla sua
produzione, producendo la relazione di rassomiglianza fra le percezioni27.
La vera idea della mente umana, è di considerarla come un sistema di
percezioni differenti o di esistenze differenti, che sono unite assieme dalla relazione di causa e di effetto, e che reciprocamente si producono, distruggono, influenzano, e modificano l’un l’altra28.
Tale reciproca relazione delle percezioni e delle esistenze differenti non mi
è comunque indifferente, perché determinata dall’attività relativa della mente
sulle impressioni; motivo per cui Hume paragona l’identità personale a una sorta di buon governo in cui le singole parti, agenti indipendentemente le une dalle altre, sono dirette da un principio guida centrale che le dispone e le organizza per la buona riuscita della totalità.
Una volta che si consideri la natura costituita della relazione causale, apparirà evidente come l’attività direttiva della mente nell’unificazione causale delle
evidenze, mostri compiutamente l’autoriconoscimento di un’identità personale
nell’attività di integrazione delle evidenze all’interno della serie di evidenze che
io percepisco. Io non posso ridurmi semplicemente a tale serie perché in esse
provo simultaneamente una rassomiglianza e un principio d’ordine direttivo
delle medesime che sono costantemente autoriferiti a un qualcosa di simultaneamente identico all’autoriferimento, vale a dire me stesso. La mia identità si
struttura pertanto come la possibilità di integrare ogni nuova evidenza, in virtù
della somiglianza dell’atto di autoriferimento a me stesso con ogni altro atto del
genere, nell’insieme di evidenze che costituisce la mia esperienza; in modo tale che quel processo di integrazione è costantemente operato dal principio
d’ordine direttivo che io provo essere il risultato della mia attività: io sono sempre precedente ogni qualsiasi atto percettivo, perché posso identificarmi come
soggetto solo in quanto riconosco a me stesso la mia identità. È questo elemento identitario che costituisce la trama del mio autoriferimento, prima solo
astrattamente definito nella considerazione di me stesso come soggetto percepiente. Ciò che mi fa accedere a me stesso come soggetto, distinguendomi
dalle evidenze percepite, è proprio questa identità che io mi riconosco, in quanto permanente rassomiglianza e direzione dell’esperienza delle evidenze.
Questa mia permanente autoattribuzione di identità è pertanto sempre presupposta, perché è in tale immediato riconoscimento di me stesso che mi si rende manifesta la differenza fra me e il percepito; differenza che è stata individuata come la struttura di fondo della mia posizione soggettiva nel processo
percettivo. Io mi riconosco quindi come un’identità persistente in ogni singola
percezione puntuale, in quanto in ogni singola percezione il riferimento delle
evidenze alla mia presenzialità rassomiglia il principio direttivo che integra costantemente tale particolare evidenza nell’insieme della mia esperienza29.
NOTE
All’interno dell’identità percettiva così formata, la totalità delle percezioni
viene ordinata in quanto congiunta causalmente da me stesso.
135
136
11. La natura ontologica di questa identità soggettiva costituisce l’ambito tematico del problema della sostanzialità metafisica e morale della mente. Si
tratta principalmente di fondare argomentativamente la verità delle determinazioni riconosciute nell’ambito fenomenologico della mia esperienza delle evidenze, non più come un qualcosa di effettivamente provato da me, ma come
esatta comprensione ontologica di me stesso.
È proprio questo passaggio dalla fenomenologia all’ontologia che genera,
per lo più, l’ampio ventaglio di domande e ipotesi che contraddistinguono l’autocomprensione della mente: siamo sostanze indipendenti o modi di altre sostanze? Siamo semplicemente costituiti da un principio che muta nel tempo a
partire da un’unità caratteristica, o semplicemente ci formiamo senza alcuna
necessità attribuibile a noi stessi? Perduriamo nel tempo o siamo esseri sostanzialmente atemporali? Siamo liberi di agire o determinati da una necessità a noi esterna?
Mi limito qui a delineare tre grandi orizzonti interpretativi, senza alcuna pretesa di sistematicità o di comprensività. Chiamo questi orizzonti: a) deflazionismo fenomenologico; b) irriducibilismo; c) riducibilismo30. La prima posizione rifiuta a priori il problema di individuare il fondamento ontologico dell’identità fenomenologicamente riconosciuta nell’esperienza delle evidenze. Il senso in cui
la mia posizione soggettiva può essere qualificata come una forma di sostanzialità non può essere quello di rinvenire empiricamente un oggetto, eguagliando la mente a una evidenza possibile, a qualcosa che possa essere accertato.
Non si tratta pertanto di esporre oggettualmente la verità di una tale presentazione fenomenologica della mente, quanto di offrire un senso descrittivo delle
sue particolari occorrenze nell’esperienza che giustifichino l’attribuzione di una
sostanzialità perché necessaria nel piano logico dell’argomentare esplicativo.
Sono esempi di una simile posizione l’argomento proposto da Berkeley nel settimo dialogo dell’Alcifrone; e l’argomento di Hume precedentemente ricordato.
In entrambi i casi l’argomentare è volto a mostrare la possibilità di comprendere immediatamente il significato del termine identità personale, ed è quindi in
qualche modo associato piuttosto all’esperienza che noi facciamo di noi stessi, così come essa è concettualizzata e depositata nel linguaggio, che alla
comprensione di una natura ontologica che dovrebbe giustificare una tale concettualizzazione31.
La posizione irriducibilista si qualifica invece per la presunta chiarezza dell’impossibilità di comprendere la natura della mia identità in funzione di quegli
elementi che la caratterizzano, e che si manifestano nel processo percettivo
delle evidenze. Può ammettere tanto una versione sostanzialista, come nella
postulazione della res cogitans cartesiana, che una funzionalista-trascendentale, come nella affermazione kantiana della prorità logica dell’Ich denke rispetto al sistema delle categorie, ossia che presuppone il momento della sintesa
pura trascendentale a ogni effettuale fenomenicità, anche la mia32.
La posizione riducibilista infine scompone invece l’identità nei suoi elementi costitutivi per mostrarne la sostanziale inconsistenza ontologica e la natura
fondamentalmente derivativa e costituita di un simile rinvenimento fenomenologico. Anche per tale posizione si possono distinguere varie interpretazioni,
12. Tutte queste posizioni teoriche si caratterizzano per un necessario passaggio alla pratica, o meglio, per la costituzione effettiva della problematica della sostanzialità dell’identità nella sfera pratica dell’agire; quantuque tale costituzione possa spesso rimanere inconsapevolmente agente a livello sotteraneo e
restare perciò tematicamente inespressa nella trattazione del problema. L’esperienza della nostra identità è infatti un’esperienza costituita nella temporalità,
nonostante sia esperienza della temporalità di un tutto temporalmente già dato.
Abbiamo infatti più volte qualificato l’autoreferenzialità ineliminabile di noi stessi come una forma di presenzialità, come la presenza stessa di noi a noi stessi. È evidente che tale presenza è una forma temporale, è l’evenienza del presente, dell’essere immediatamente dato a me stesso nel processo di esperire
le evidenze. Infatti, siccome tale essermi dato consiste nel riconoscermi come
soggetto percettivo, ossia nel comprendere la natura identitaria della mia soggettività, la rassomiglianza costitutiva del mio essere principio direttivo dell’ordinamento delle evidenze che percepisco riferendo a me stesso, tale presenzialità si palesa effettualmente come una modalità fenomenologica della temporalità: io mi sono dato in quanto tutto presente di una permanenza nella successione delle evidenze. Ma non ogni forma di presenza è necessariamente temporale. Laddove la presenza dell’autoriferimento non si esplichi in modo percettivo, ossia quando io abbia esperienza di me stesso in modo tale da non poter
più percepire un’evidenza, perché incapace di accedere a me stesso in quanto
distinto dall’evidenza stessa, la presenzialità di me stesso sarebbe una forma di
autoriferimento in cui il mio autoriferimento diverrebbe l’autoriferimento dell’insieme stesso delle evidenze dell’esperienza, non più a me stesso come esperente, bensì alla totalità delle evidenze: ossia sarebbe l’eco dell’esperienza autoriferentesi a sé stessa tramite la mia presenza. Ora questa modalità tipica della mistica di esperire una forma non temporale della presenza è esattamente
quello che mi è tendenzialmente negato nella mia esperienza della presenzialità. Io sono sempre un momento temporalmente finito, perché differenziato, ossia capace di riconoscere una trascendenza fra la mia interiorità e l’esteriorità
delle evidenze. La mia presenzialità è perciò una forma temporale, e quindi radicalmente calata nella dimensione pratica in cui io accedo a me stesso attraverso l’esperire percettivo delle evidenze. Io mi sono dato da sempre come un
soggetto pratico, come un’identità che è sempre una determinazione pratica
della finitezza temporale che mi presenta nell’esperienza.
La maggior parte delle nozioni ontologiche che qualificano la natura della
mia identità soggettiva come sostanza hanno pertanto un valore di carattere
pratico, perché sono rivolte a determinare in ultima analisi la natura della finitezza della mia presenzialità, ossia la natura temporale della presenza che mostra me stesso come autoriferimento di ogni esperienza.
NOTE
che vanno dal riducibilismo materialistico, per il quale il mio pensare è
un’emergenza epifenomenica della mia costituzione materiale, alla posizione
elaborata da Spinoza nel libro secondo dell’Ethica, alla teoria idealistica hegeliana del riconoscimento.
137
13. Noterei allora che la chiarificazione ontologica del fenomeno che noi
stessi siamo presuppone soprattutto l’esplicazione dell’agire temporale finito
dato nella pratica. Ossia, l’accedere a noi stessi a partire dalla comprensione
delle determinazioni a noi presenti per mezzo della nostra presenza. La comprensione di noi mette cioè in campo una reciproca assegnazione di metafisica, ontologia e morale, senza la quale qualsiasi conoscenza resta sorda e muta. Privarsi di questo approccio olistico, negato da qualsiasi preliminare partizione del sapere in ambiti disciplinari distinti, significa precludere un’autentica
intellezione di noi stessi; ossia imporre che l’intellezione resti sempre niente altro che una comprensione parziale di qualche nostro aspetto33. L’eccessiva attenzione al quale tende a isolare una singola evenienza fenomenica, una singola struttura d’essere, una singola comprensione dell’esperienza delle evidenze, per porle a fondamento, in modo surrettizio, di una complessità maggiore; necessitante per l’effettiva comprensione di un’intelligenza effettuale dell’insieme.
138
1 Cfr. A. FERRARIN, Autocoscienza, riferimento dell’io e conoscenza di sé. Introduzione a un dibattito contemporaneo, “Theoria”, 1992/1.
2 Non è un caso che il dibattito filosofico che ruota attorno al body-mind problem, si costituisca
attorno all’attenta considerazione della posizione dualistica cartesiana; né che, dopo Descartes, le
posizioni filosofiche relative alla qualificazione della mente si riducano sostanzialmente alle tre immediate ricezioni spontanee della nuova problematica originatasi dal pensiero cartesiano: dualismo, idealismo o materialismo. Cfr. D. C. DENNETT, Content and Consciousness, Routledge & Kegan Paul, London 1969; parte I, cap. 1, § 1.
3 R. DESCARTES, Meditationes de prima philosophia, II, ed. Adam & Tannery, p. 27, linee 7-12:
“Hîc invenio: cogitatio est; haec sola a me divelli nequit. Ego sum, ego existo; certum est. Quandiu autem? Nempe quandium cogito; nam forte etiam fieri posset, si cessarem ab omni cogitatione, ut illico totus esse desinerem”.
4 Cfr. M. FRANK, “Linguisticità dell’autocoscienza”, in Filosofia ’90, a cura di G. Vattimo, Laterza Roma-Bari, 1991; Id., Sulla soggettività, “Iride”, 17, 1996.
5 Una versione recente, molto influente, di questa argomentazione tradizionale è quelle avanzata da R. RORTY, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton 1981;
ma anche nella cultura francese, Derrida e Foucault, a titolo di esempio, hanno ampiamente polemizzato con la presunta natura decettiva di ogni soggettivismo. Naturalmente la fonte comune di
tutti questi autori è Heidegger.
6 R. DESCARTES, Principia philosophiae, I, § 7.
7 Cfr. M. D. WILSON, Skepticism without indubitability, “Journal of Philosophy”, 1984.
8 DESCARTES, Principia philosophiae, I, § 69; II, § 4. Per una discussione di questo problema
rinvio a M.D.Wilson, “Descartes on the Perception of Primary Qualities”, in Essays on the Philosophy and Science of René Descartes, ed. by S.Voss, Oxford University Press, Oxford 1992; ID.,
“Descartes on Senses and Resemblance”, in Reason, Will, and Sensation: Studies in Cartesian
Metaphysics, ed. by J. Cottingham, Clarendon, Oxford 1994.
9 R. DESCARTES, Meditazioni metafisiche, II, ed.cit., p. 28, linee 20 e seguenti: “Sed quid igitur
sum? Res cogitans. Quid est hoc? Nempe dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, nolens,
imaginas quoque, & sentines”.
10 Elemento di particolare importanza è la forma letteraria che Descartes sceglie per comunicare la propria presunta fondazione. Tanto il Discourse de la méthode, che le Meditationes, presentano infatti un testo in prima persona che racconta il rinvenimento della verità da parte di un
uomo particolare. È l’esperienza della propria persona che Descartes mostra al sapere come pre-
NOTE
sunto fondamento; presentazione che giunge dopo gli studi di fisica e di geometria. La scienza cartesiana era già formulata, e ad essa si affianca il cogito come elemento ulteriore manifestamente
insopprimibile, irriducibile. Degno di nota è che l’esigenza fondazionalista dei Principia strutturi il
pensiero cartesiano come una sorta di ideologizzazione del materiale precedente (l’inizio della
composizione dei Principia è risalente al 1641, anno di pubblicazione delle Meditationes).
11 Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge,: Nijhoff, Den Haag 1963; tr. it., Meditazioni metafisiche, R.C.S libri & grandi opere, Milano 1994. Entrambi i testi husserliani contenuti,
tanto nell’edizione tedesca che in quella italiana, sono stati redatti nel 1929.
12 Cfr. op. cit. I, § 3: “alle uns bisher geltenden Überzeugungen und darunter auch alle unsere
Wissenschaften zunähst außer Spiel zu setzen. Die unsere Meditationen leitende Idee sei, …, die einer in radikaler Echtheit zu begründenen Wissenschaft und letzlich einer universalen Wissenschaft”.
13 Cfr. op. cit., I, § 4: “Urteilen ist ein Meinen und im allgemeinen ein BloßesVermeinen, es sei
das und das; das Urteil (das, was geurteilt ist) ist dann bloß vermeinte Sache bzw. vermeninter Sachverhalt oder: Sachmeinung, Sachverhaltsmeinung”; “in der echten Begründung erweisen Urteile sich als richtig, als stimmend, d.h. sie ist die Übereinstimmung des Urteils mit dem Urteilsverhalt (Sache bzw. Sachverhalt) selbst”.
14 Cfr. op. cit., I, § 5: “Evidenz ist in einem allerweitesten Sinne eine Erfahrung von Seiendem
und So-Seiendem, eben ein Es-selbst-geistig-zu-Gesicht-bekommen”.
15 La funzione fondativa del dubbio in Husserl appare indiscutibile se si guardi alla tematizzazione della contrapposizione fra scetticismo antico e moderno, nella serie di lezioni universitarie
che vanno sotto il titolo di Erste Philosophie, I. In particolare, ribaltando l’asserzione hegeliana relativa alla superiorità dello scetticismo antico, Husserl vede nel metodicità del dubbio cartesiano il
valore sovratemporale dell’atteggiamento scettico, ossia lo stimolo critico che spinge la filosofia all’esigenza di una fondazione assoluta di ogni sapere (cfr. Erste Philosophie, I, I, cap. 4, § 9).
16 Cfr. op. cit., I, § 7: “zeigt sich, daß sie auch nicht den Vorzug der absolut ersten Evidenz beanspruch kann”. Husserl fa valere le critiche tradizionali alla certezza della conoscenza sensibile
posta in essere da un’esperienza.
17 Cfr. op. cit., I, § 8.
18 Cfr. op. cit., I, § 8: “Was uns vielmehr […] zueigen wird, oder deutchlicher: was mir, dem meditierenden, dadurch zueigen wird, ist mein reines Leben mit all seinen reinen Erlebnissen und all
seinen reinen Gemeintheiten, das Universum der Phänomene im Sinn der Phänomenologie”.
19 La difficoltà espressiva di intendere noi stessi indipendentemente dalla metafora dello spettatore dovrebbe risultare evidente se si considera come Hume contestualmente alla proposizione
della propria teoria dell’io come “nothing but a bundle or collection of different perceptions, which
succeed each other with inconceivable rapidity” è costretto ad affermare che “the mind is a kind of
theatre, where several perceptions successively make their appearance; pass, re-pass, glide
away, and mingle in an infinite variety of postures and situations”; cfr. A Treatise of Human Nature, edizione critica a cura D. F. Norton e M. J. Norton, Oxford University Press, Oxford, New York,
etc. 2000, I.4.6.4. Per una interpretazione critica di questi passi che sottolineano la difficoltà di pensare all’io se non come a uno spettatore si veda W. L. ROBINSON, Hume on Personal Identity, “Journal of the History of Philosophy”, 12, 1974; R. FOGELIN, Hume’s Scepticismin the Treatise of Human Nature, chapter 8, Routledge and Kegan Paul, London 1985. Si ricorda che Deleuze, appoggiandosi alle frasi immediatamente successive di Hume, ha cercato di dimostrare come l’io dovrebbe intendersi come le scene stesse e non come il pubblico che osserva (cfr. G. DELEUZE, Empirisme et subjectivité, Presses Universitaires de France, Paris 1953). Si deve tuttavia notare come
l’argomentare di Hume mostri una difficoltà fondativa, una difficoltà per cui sembrano mancare gli
arnesi concettuali, un momento di irrisoluzione teorica per l’indeterminatezza, anche linguistica,
della questione (cfr. Treatise, ed.cit., 1.4.6.21). Del resto l’incertezza di Hume per la questione è
testimoniata dal seguito del Trattato e dall’Appendice; cosa che ha spinto vari autori a cercare la
risoluzione del problema al di fuori del primo libro. Si veda E. LECALDANO, “L’io, il carattere, e la virtù nel Trattato di Hume”, in Filosofia e cultura nel settecento britannico, II, a cura di A. Santucci, il
Mulino, Bologna 2000. Lo stesso Deleuze sposta la questione dell’identità dal piano dell’intelligenza a quello dell’immaginazione passionale. Tuttavia non ravvede in Hume alcuna difficoltà, e gli attribuisce anzi un intento quasi sistematico; cfr. G. DELEUZE, op. cit., pp. 57-59.
20 Cfr. I. TESTA, Familiarità con sé e relazione ad altri. Sulle aporie dell’autocoscienza riflessiva,
“La società degli individui”, 17, 2003. L’autore riconduce una simile prospettiva a Cudworth e Locke.
139
140
21 Cfr. E. TUGENDHAT, Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Interpretationen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1979, capitoli 1 e 3; tr. id., Autocoscienza e autodeterminazione. Interpretazioni analitiche, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1997.
22 Dato il carattere di questa discussione, volta solo ad argomentare un certo uso dei termini
per la comprensione del problema, mi trovo impossibilitato a rispondere alle critiche di carattere
linguistico relativo alla presunta insensatezza di una concezione non linguistica della mente.
23 Trattato, edizione citata, 1.1.5.1: “is a relation, without which no philosophical relation can
exist; since no objects will admit of comparison, but what have some degree of resemblance”.
24 Trattato, edizione citata, 1.3.14, p. 111: “Tho’ the several resembling instances, which give
rise to the idea of power, have no influence on each other, and can never produce any new quality in the object, which can be the model of that idea, yet the observation of this resemblance produces a new impression in the mind, which is its real model”.
25 Trattato, ed.cit., 1.3.14, p. 111: “For after we have observ’d the resemblance in a sufficient
number of istances, we immediately feel a determination of the mind to pass from one object to its
usual attendant, and to conceive it in a stronger light upon account of that relation. This determination is the only effect of the resemblance”.
26 Trattato, ed. cit., 1.3.14, p. 115: “this is […] the essence of necessity. Upon the whole, necessity is something, that exists in the mind, not in objects; nor is it possible for us ever to form the
most distant idea of it, consider’d as a quality in bodies. …necessity is nothing but that determination of the thought to pass from causes to effects and from effects to causes, according to their experienc’d union”. Proprio la sottovalutazione di questo elemento attualistico induce autori come
Kemp Smith, Deleuze, Lecaldano, a proporre una lettura naturalistica, quasi materialistica di Hume.
27 Trattato, ed.cit., 1.4.6, p. 170: “ memory not only discovers the identity, but also contributes
to its production, by producing the relation of resemblance among the perceptions”.
28 Trattato, ed.cit., 1.4.6., p. 170: “The true idea of the human mind, is to consider it as a system of different perceptions or different existences, which are link’d together by the relation of
cause and effect, and mutually produce, destroy, influence, and modify each other”.
29 Il problema di stabilire se questa precedenza logica dell’identità sulla singola percezione
puntuale, ossia dell’identità sul soggetto, abbia una determinazione temporale affine, oppure no, è
un problema che appartiene alla psicologia e alle altre scienze umane. Non si tratta cioè di comprendere effettualmente come si venga strutturando la personalità, ma invece di comprendere come ogni singolo atto percettivo presupponga, per il mio autoriconoscimento, un tutto già integrato
grazie al quale riferire tale percezione a me stesso.
30 Come tutte le etichette che le nostre aspettative teoriche impongono a qualsiasi dottrina, nell’inderogabile necessità di semplificarne il senso e la prospettiva, così consentendoci di prendere
posizione, anche queste sono tanto categoricamente costituite che l’analisi storica potrebbe senza dubbio mostrare la triplice inerenza di un medesimo pensatore, o di una medesima dottrina, a
tutti gli orizzonti. Credo tuttavia che il compito dell’analisi teorica sia per lo più quello di costruire
un senso dell’insieme dalla valutazione di unità di senso minori: gli argomenti. Direi quindi che la
generalità di questi tre orizzonti interpretativi può mantere il proprio valore ermeneutico, nella misura in cui si eserciti teoreticamente sul pensare emergente dall’argomentare.
31 Naturalmente in Berkeley è presente un senso molto più forte di sostanzialità, come si vedrà nei primi due capitoli; tuttavia essa è talvolta argomentata proprio da ragionamenti di carattere deflazionistico come quello ricordato.
32 I. KANT, Kritik der reinen Vernuft, sec.ed., Deduzione, § 16.
33 È chiaro come non si miri a un approccio dettato da una logica dell’interdisciplinarietà; quanto piuttosto a una pratica della filosofia che ne metta in risalto l’autonomia disciplinare, a partire
dall’autentica totalità comprensiva sua propria nell’intelligenza critica della fenomenicità.
LA REALTÀ DEL CINEMA
TRA MITO E PSICOANALISI
Se la realtà del cinema è illusione,
è evidente che tale illusione
è pur la sua realtà.
Edgar Morin
Quale rapporto intrattiene il cinema con la dimensione del mito? E quale
con quella dell’inconscio?
Sin dall’antichità il mito ha costituito il luogo creativo per eccellenza dell’elaborazione delle passioni umane, individuali e collettive. Le ricerche di Freud
hanno stretto ancor più il legame attribuendo al mito un ruolo costitutivo della
sfera dell’inconscio: ognuno di noi può rintracciare dentro di sé una quota di
questo o quel personaggio o evento mitico. Secondo la psicoanalisi la forma
del mito è indissolubilmente connessa con quella dell’inconscio. Mito equivale
quasi a struttura inconscia dell’io o, come afferma Mazzei (2005), “raffigurazione simbolica delle immagini che popolano l’inconscio”.
Parallelamente, nell’arco del XX secolo, il cinema si è affermato come una
nuova e moderna fucina di miti. Il cinema produce e crea nuovi miti, oltre a rielaborare quelli antichi. Per questa ragione ci si dovrebbe chiedere se il cinema,
grazie alla propria facoltà mitopoietica, non aggiorni tanto la realtà concreta
quanto la dimensione dell’intimo del soggetto.
I saggi contenuti nel volume Il mito: immagini dell’inconscio (a cura di M.
Maisetti, F. Mazzei e L.Vitalone), pubblicato in occasione del convegno Cinema e psicoanalisi tenutosi nel novembre 2005 a Milano, ha il merito di inserirsi all’interno di questo intricato dibattito. I contributi raccolti dai curatori provengono essenzialmente da psicoanalisti e psicologi. A riprova dell’interesse che
gli addetti ai lavori del mondo della psiche nutrono nei confronti del cinema, e
di quanto quest’arte, che ha nel doppio e nell’ambiguità tra reale e fantastico i
suoi tratti essenziali, si presti a essere attraversata da molteplici livelli interpretativi anche molto distanti dalla critica cinematografica o dall’estetica dell’immagine, e in particolare possa coniugarsi bene con le scienze della psiche.
L’insieme dei saggi pubblicati rappresenta da un lato il suggello del legame
tra mondo della psiche e cinema, e dall’altro il tentativo di provare la tecnica
psicoanalitica e psicologica come strumento di analisi dei film. Le diverse sensibilità degli autori offrono così una panoramica abbastanza ampia e variegata
sia di riferimenti filmici, sia di stilemi interpretativi.
La mitologia è una sorta di preconoscenza della psiche, un sistema sim-
NOTE
di Irene Angelopulos
141
bolico originario. Il termine stesso, che lega in un ossimoro narrazione fantastica (mithos) e ragione (logos), indica l’unico genere narrativo che può
raccontare la violazione di ogni principio di realtà, di ragione, di consuetudine sociale e, nello stesso tempo, come immagine incondizionata dell’inconscio, può indicare la verità profonda che accompagna e denota il filo
a-razionale della logica delle raffigurazioni interne. (Baldissera, 2005)
142
Quest’affermazione, che troviamo nel saggio della Baldissera Eco: una voce disincarnata tragedia della incomunicabilità, apre il sipario su una delle questioni fondamentali sulle quali si intesse la relazione tra cinema e psicoanalisi:
il rapporto tra reale e fantastico. È proprio questa duplicità intrinseca che caratterizza il mito a costituire la grande potenzialità del cinema, inteso come arte e forma di linguaggio. Il cinema racconta il reale (concreto o immaginato) a
partire dalla sua immagine. Più precisamente è l’immagine, doppio fantastico
e fantasmagorico, a “portare” la realtà sugli schermi.
Secondo Morin (2001) ogni film risulta come “lo sdoppiamento dell’universo in un universo riflesso”. Nel cinema il fantastico si irradia dal semplice riflesso delle cose reali. L’intuizione originaria di Lumière fu precisamente quella di
proiettare come spettacolo ciò che spettacolo non era, ovvero la vita quotidiana e i gesti abituali delle persone, comprendendo come la curiosità degli spettatori fosse rivolta innanzitutto al rispecchiamento della realtà: non al reale, ma
all’immagine del reale. La meraviglia è suscitata, sempre secondo Morin
(1966), da quella qualità particolare (detta fotogenia) che “non è nella vita, ma
nell’immagine della vita”.
Questo perché l’immagine è la risultante di un gioco particolare tra presenza e assenza. Non è possibile dissociare l’immagine dalla presenza dell’uomo
nel mondo, e tuttavia essa non ne è che un doppio, un riflesso: ovvero un’assenza. Di modo che l’immagine possiede contemporaneamente sia i caratteri
dell’oggettività, sia quelli dell’irrealtà. È proprio la compresenza di questi due
elementi a far si che l’immagine si carichi di quel fascino che ci permette di vivere, di fronte ai film (ma anche di fronte alla fotografia, anche se in misura diversa) emozioni. È il carattere doppio dell’immagine che inaugura il processo
di proiezione per cui noi viviamo (letteralmente) gli accadimenti dei film, e viceversa la nostra vita viene trasposta in quella dei personaggi che vediamo
agire sullo schermo. Come afferma Morin (1966) “doppio e immagine devono
essere considerati come i due poli della stessa realtà” e, all’interno della traiettoria che essi delineano, si costituisce il campo dei sentimenti. “L’immagine è
fisica, ma ricca della più ricca qualità psichica” (Morin 1966).
Il cinema provoca una percezione oggettiva, ma questa ha un secondo
aspetto: la qualità propria del doppio. Viceversa i riflessi e le ombre diventano
a loro volta basi di una nuova corporalizzazione e della costituzione di una realtà ulteriore. L’originale reale è percepito attraverso il suo doppio. Dunque contemporaneamente alle partecipazioni della vita reale, si risvegliano le partecipazioni proprie della fotogenia. Ne risulta che il medesimo processo (la visione cinematografica) volge simultaneamente verso l’oggettivazione e la soggetivazione. Ma la visione del doppio (simile all’allucinazione e al sogno) è
“l’estrema, fragile oggettivazione di una soggettività che, proprio mentre vede,
durante il film, lo spettatore ha agito in una sorta di trance prodotta dal
doppio cinematografico e quel che gli accadrà di pensare successivamente non appartiene più al mondo del cinema ma a quello della realtà:
lo spettatore uscito dal Doppio filmico, entrerà nella realtà, anch’essa
doppiata dal ricordo del film. A ben vedere tutto il cinema risponde a questo movimento: un Doppio che ne insegue un altro. (Grossini, 2005)
Ma Grossini arricchisce la riflessione di un ulteriore elemento: la condizione concreta dello spettatore durante la visione del film. Lo spettatore si trova
in una situazione particolare che oscilla tra la veglia e il sogno. Perso nel buio
della sala cinematografica, seduto immobile sulla poltrona in uno stato di rilassamento corporeo, la sua condizione è assimilabile a quella che sperimentiamo durante il sonno. Infatti, come afferma Metz,
il cinema è più percettivo di altre arti, se consideriamo l’elenco dei suoi
registri sensoriali, e ugualmente meno percettivo se si considera lo statuto di quelle percezioni. (Metz, 1977)
Nell’atto di vedere un film vengono ingaggiati larga parte dei nostri sensi,
ma all’interno di uno stato fisico che può essere definito catatonico, o per usare sempre un’espressione di Metz, esso ha qualcosa in comune col “sonnambulismo”. In questo senso l’esperienza filmica può essere associata a quella
onirica. A condizione che si operi una distinzione: mentre quelle del cinema sono immagini reali che attivano un’esperienza psichica, la produzione del sogno
consiste in un susseguirsi di operazioni che rimangono da un capo all’altro interne all’apparato psichico.
Il coefficiente di illusione è quindi molto superiore nel sogno. Doppiamente superiore: perché il soggetto “crede” di più, e perché ciò a cui crede è
meno “vero”. (Metz, 1977)
D’altro canto l’illusione onirica risulta più facilmente neutralizzabile di quella filmica in quanto essa è appunto “solo un sogno”, mentre al cinema si è consapevoli del proprio stato di veglia. Secondo l’interpretazione psicoanalitica, la
visione di un film può quindi essere comparata con la visione di un sogno in relazione al tipo di esperienza che si realizza, ma differisce da questa in relazione al valore che tale esperienza assume. Se durante o dopo un sogno so di
aver sognato (ovvero ho coscienza sia del contenuto del sogno sia del fatto
NOTE
perde ogni contatto con la realtà oggettiva” (Morin, 1966). Questo perché all’interno della percezione, nell’istante della correzione oggettiva, il cinema tende a suscitare una visione, nel senso visionario del termine. È volontariamente e deliberatamente che il cinema mantiene questa dualità in seno alla presenza oggettiva: esso fa percepire (nel senso pratico del termine) e dà a vedere (nel senso visionario). Si può quindi assimilare lo spettacolo cinematografico tanto alla visione onirica quanto alla percezione pratica, ma a condizione
che lo si faccia congiuntamente.
Allo stesso modo Giancarlo Grossini sottolinea nel suo saggio Il doppio che
143
144
che fosse un sogno e non realtà), durante un film percepisco come reale solo
ciò che è rappresentato nel film ma non il rappresentante, non il mezzo tecnologico che mi permette la visione.
La differenza tra la realtà del mondo e la presenza oggettiva del film ad immagine del mondo reale è che mentre il mondo reale ha la propria sostanza e
non ha bisogno di noi per esistere, il cinema ha bisogno, per vivere, della nostra presenza, del nostro sguardo e della nostra compartecipazione.
È proprio questa dialettica interna tra reale e fantastico, tra presenza e assenza, propria dell’immagine, a costituire il terreno sul quale si è sviluppato il
successo e il fascino che il cinema ha riscosso sul grande pubblico.
Il 1895, anno della nascita del cinema, comprende già in sé i genotipi del cinema: il realismo di Lumière e i mondi fantastici di Méliès. Il dato interessante è
che, negli sviluppi delle tecniche e dell’arte cinematografica, proprio i trucchi “magici” di Méliès (sovrimpressione, carrellata, primo piano, dissolvenza, ecc.) diverranno in seguito le tecniche dell’espressione realista. A dimostrazione, ancora
una volta, che se il cinema riflette la realtà, esso è anche qualcosa d’altro che
partecipa del sogno e attinge a tutto il mondo fantastico dell’immaginazione.
È proprio questa ambiguità o doppiezza intrinseca al cinema, questa capacità di metamorfosi per cui con lo scorrere della pellicola ogni dato può trasformarsi in qualcosa d’altro (in questo senso bisognerebbe aprire un discorso a
parte sul montaggio), a caricare le narrazioni cinematografiche di una valenza
mitopoietica. Per non dire che già la presenza stessa della metamorfosi come
tratto strutturale dell’arte cinematografica lo rende di per sé luogo mitico per
eccellenza della modernità.
Così Lorenzo Vitalone scrive nel suo saggio C’era una volta…
La favola, ovvero il racconto fantastico, è lo strumento più adatto per
esprimere il mondo dei sogni e per trasfigurare il mondo reale. […] Nella
favola si passa da una situazione che è reale al superamento dell’impossibile quotidiano, e attraverso questo processo della fantasia si può arrivare alla distruzione dell’antico per costruire il nuovo. (Vitalone, 2005)
Vitalone prosegue affermando come la forma narrativa della favola, così come quella del romanzo ottocentesco, sia stata soppiantata nella nostra epoca
dal cinema, che ha mantenuto vivo, e innovato, l’esigenza umana di trasmutare la realtà. La riflessione di Vitalone è, in questo senso, talmente radicale da
conferire al cinema fantastico e horror i caratteri essenziali del cinema toutcourt. In particolare la sua analisi si sofferma su quattro miti ricorrenti: Faust,
Dracula, Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Frankestein, i quali
per il loro significato profondo, da un lato rendono piena giustizia al significato liberatorio del fantastico letterario e cinematografico, dall’altro introducono nell’inquietante dimensione del “doppio”, regno dell’immagine cinematografica. (Vitalone, 2005)
L’elemento accomunante questi miti, nell’analisi che Vitalone ci offre, risulta
essere da un lato l’emergere di un’attitudine conoscitiva di tipo illuministico; là
della relazione che esiste tra arte e vita o meglio dell’interrelazione che
esiste tra una progettualità e una realizzazione, tra una potenzialità e un
vissuto. (Alberione, 2005)
Questo film, in sostanza, appare come la narrazione del processo creativo
che porta alla nascita di un’opera d’arte.
La vicenda è semplice: un vecchio e ricchissimo mercante, il signor Clay,
NOTE
dove con illuminismo si intenda non la costruzione di un sapere positivo, ma l’affrancamento dell’uomo dall’elemento divino e quindi la presa in carico del potere di scoprire e di creare la realtà. Dall’altro la volontà dell’uomo di superare i limiti sociali e conoscitivi che la realtà data ci consegna. Il fantastico offre precisamente questa occasione di oltrepassare le colonne d’Ercole del nostro mondo. Al punto che, agli occhi dell’autore, Frankestein può essere definito come un
moderno Prometeo, nel quale il rapporto tra uomo e scienza giunge a un livello tale da trasformare l’uomo di scienza in creatore che può decidere della cosa creata, fino all’atto estremo di imporle la morte. Morte che anziché significare il fallimento dell’esperimento umano, ne suggella invece il potere.
Il tema della fabbricazione di un essere vivente da parte dell’uomo è uno dei
temi più prolifici della storia del cinema che ha aperto, da Metropolis di Fritz Lang
a Blade Runner di Ridley Scott fino a giungere a tutta la produzione più recente
sulle intelligenze artificiali, squarci enormi su futuri possibili, a cui la realtà ha attinto a piene mani. Chi, passeggiando per le vie di Potsdammer Platz, non ha avvertito un sussulto riconoscendo nei grattacieli progettati da Renzo Piano gli scenari inauditi della città del futuro di Lang? O negli intrecci tra soprelevata, asfalto e metropolitane sotterranee su sfondi di architetture luminose, non si è sentito perdere nei cunicoli dei racconti di Ballard, autore della letteratura ma a cui il
cinema si è spesso ispirato? L’ibridazione dell’uomo con l’altro uomo, dell’uomo
con la macchina, della macchina con la città è forse uno dei miti più potenti che
il cinema del XX secolo ci consegni, dalle avanguardie sino alle grandi produzioni hollywoodiane.
Un’altra riflessione interessante che questo saggio ci suggerisce riguarda
non solo il potere del cinema di estendere i confini di un mito preesistente sino al punto di crearne nuovi capaci a loro volta di agire in modo incalcolabile
sulla realtà, ma anche la possibilità di ribaltarne le connotazioni affettive e psicologiche. Questo è il caso di Dracula e, più in generale, di tutta la saga sui
vampiri; i quali, solo col passaggio dalle leggende popolari alla fiction, abbandonano la veste di “straccioni dai tratti animaleschi” (Vitalone, 2005) per divenire eroi crepuscolari dai tratti nobili. Esseri a loro modo superiori, espressione del rifiuto dei valori economici e morali dominanti, e di una libertà differente. Sino a giungere al film di Abel Ferrara The Addiction in cui i vampiri sono
esplicitamente raffigurati come l’avanguardia critica della società, portatori di
una profonda domanda filosofica sul senso dell’esistenza.
Altrettanto interessante è il saggio di Alberione “Storia immortale” ovvero la
materia di cui è fatto il mito nel quale l’autore si sofferma analiticamente sul film
di Orson Welles Storia immortale. Questo film, ci dice Alberione, parla
145
146
decide di rendere reale una leggenda popolare tramandata dai marinai, secondo la quale un uomo riceve del denaro per passare una notte con una donna
bellissima. La messa in scena tuttavia non riesce, poiché il marinaio prescelto
(Paul) alla fine si rifiuta di raccontare di essere stato realmente protagonista
della leggenda. Il progetto di Clay, fondato sul potere del denaro di realizzare
qualunque cosa, si infrange lasciandogli come sola via di uscita la morte.
Probabilmente, suggerisce Alberione, il film può essere letto come testamento del lavoro cinematografico di Welles. Un autore vecchio e stanco, consapevole del potere e delle maledizioni del denaro, grande feticcio cui tutto il
lavoro del fare arte si deve misurare. Allo stesso tempo tuttavia, è possibile fornirne una lettura metadiscorsiva: Storia immortale come film sull’eterno bisogno dell’uomo di raccontare storie e della difficoltà di esprimersi, dell’eterno
scacco che l’opera impone al suo autore sfuggendole sempre di mano. Ma c’è
di più, c’è anche una riflessione del regista sul linguaggio cinematografico. Il
film inizia con un’apertura a iride: lo sguardo si dischiude in concomitanza con
l’incipit del film, quasi a significare come il cinema rappresenti il luogo sintetico per eccellenza, là dove il mondo può essere compreso e ricomposto attraverso il montaggio di una serie di inquadrature. Il cinema quindi non solo come tecnica o linguaggio, ma come forma di narrazione verbo-visuale: inventore di storie che, come in un gioco di specchi, rimanda ad altre storie dove il filo di Arianna si perde rendendo impossibile una qualsivoglia risalita all’origine,
ad una prima storia capostipite. Da qui deriva forse anche la riflessione più interessante che Alberione ci lascia, sul tempo del film inteso come futuro anteriore: “l’immagine nasce in un ‘poi’ e testimonia un ‘prima’.” (Alberione, 2005).
Il senso cronologico della storia si perde in un gioco di rimandi tra visione e ricordo.
Mi pare interessante, in quest’occasione in cui è permesso guardare un po’
da vicino la complessità che la parola mito acquista se messa in relazione col
cinema, affrontare la tematica del divismo: non del mito nel cinema, ma del cinema come mito. Me ne offre occasione il saggio di Zanti Viaggio in collina:
dall’Olimpo a Hollywood. La questione è talmente ampia da non poter essere
qui discussa in modo esauriente, tanto più che su tale tematica la bibliografia
appare sterminata; basti citare il testo di E. Morin I divi. Più modestamente vorrei limitarmi a sottolineare come la nascita del cinema abbia prodotto, come
conseguenza, soprattutto a partire dal dopoguerra, lo sviluppo di un ulteriore
fenomeno: quello del divismo. Fenomeno complesso di cui è necessario evidenziare almeno due aspetti: l’elemento psicologico individuale di riconoscimento dell’attore come colui che funge da medium con il personaggio, e l’interesse, via via sempre maggiore, con cui l’industria cinematografica si è rivolta
alla costruzione di una vera e propria aura magica intorno alle sue star. È Hollywood ovviamente a fare scuola in questo campo. Basti pensare a Marilyn
Monroe vera eroina della collina più soleggiata e famosa della California, la cui
vita si è interamente consumata sotto i riflettori, consacrandola a vita eterna,
simbolo per eccellenza di diva intramontabile. Rimasta per sempre immortalata nelle stampe che Andy Wharol le ha dedicato. In questo intreccio tra divi, industria cinematografica e le nascenti arti pop (di cui il cinema è forse proprio
la prima) risiede il germe di quella che a partire dagli anni ottanta verrà definita come “mitologia dell’apparire”. Così si può dire che
Ritroviamo un esempio di questa dinamica nel film di Martin Scorsese Re
per una notte, citato da Longhin nel saggio La comunicazione intrapsichica e
interpersonale. Re per una notte offre, secondo Longhin, la possibilità di osservare in profondità il fenomeno della celebrità e il contributo dell’arte cinematografica all’ossessione per essa. Diversamente dal modello pulsionale basato
sul desiderio sessuale che la psicoanalisi freudiana ci aveva lasciato in eredità, le fantasie del protagonista sono dirette verso l’ottenimento di un successo
quanto più vasto possibile. Il suo bisogno è quello di essere riconosciuto e adorato da folle di fan che lo applaudono e inneggiano al suo nome. Citando Gabbard, Longhin conclude con questa osservazione:
NOTE
Le vere divinità non abitano più sulle aspre cime dell’Olimpo, ma sulle soleggiate colline di Hollywood. (Zanti, 2005)
Il fascino della celebrità è uno dei temi dominanti della nostra cultura narcisistica. Il mezzo cinematografico, forse più di ogni altro aspetto della
cultura moderna, è stato funzionale alla creazione di questa infatuazione.
(Gabbard, 2000)
Per concludere vorrei porre un ulteriore interrogativo in merito a quel rapporto intricato che cinema e mito, mito e inconscio, inconscio e psicoanalisi intrattengono e che il libro Mito: immagini dall’inconscio ci ha permesso di indagare in alcune delle sue profondità.
Mito e psicoanalisi sono entrambi prodotti della cultura occidentale. Probabilmente il mito, nella sua origine pre-logica/ pre-socratica, travalicava i confini
spirituali dell’occidente. Certamente l’intuizione freudiana del nesso tra mito e
inconscio ha definitivamente radicato il mito alle forme del sapere occidentale.
Non è possibile dire la stessa cosa del cinema. Senza bisogno di recuperare
la ricchissima tradizione delle arti mimetiche orientali (basti pensare al teatro
delle ombre), il cinema sia dal punto di vista formale, sia da quello dei contenuti, realizza (grazie anche all’introduzione di tecnologie che permettono una
fruizione estesa delle opere) uno sdoganamento di narrazioni e forme narrative che attingono a immaginari completamente diversi dal nostro. Contemporaneamente, proprio il cinema sembra affermarsi come uno dei primi luoghi artistici in cui si realizza un vero e proprio intreccio di culture differenti.
Se mito-cinema-individuo intrattengono una relazione, tale relazione opera
inevitabilmente uno slittamento semantico di questi stessi termini. Se il cinema
può essere definito come una sorta di inconscio esternalizzato, bisognerebbe
chiedersi se, un secolo dopo la scoperta di Freud, anche la forma dell’inconscio non stia subendo delle metamorfosi.
147
Bibliografia
J.G. BALLARD, Tutti i racconti 1956-1962, Fanucci Editore, Roma 2005.
G.O. GABBARD – K. GABBARD, Cinema e psichiatria, Raffaello Cortina, Milano 2000.
M. MAISETTI – F. MAZZEI – L. VITALONE, a cura di, Il mito: immagini dall’inconscio, Milano,
2005.
C. METZ, Cinema e psicoanalisi, tr. it. Marsilio, Venezia, 1980.
E. MORIN, L’identità umana, Raffaello Cortina, Milano, 1999.
E. MORIN, Cinema o l’uomo immaginario, Silva, Milano, 1962.
Filmografia
Blade Runner, Ridley Scott, Stati Uniti, 1982.
Metropolis, Fritz Lang, Germania, 1927.
Re per una notte, Martin Scorsese, Stati Uniti, 1983.
Storia immortale, Orson Welles, Francia, 1968.
The Addiction, Abel Ferrara, Stati Uniti, 1995.
148
QUANTO È GENERALE LA SEMIOTICA GENERALE?
RIFLESSIONI SULL’AMBITO DELLA SEMIOSI A PARTIRE
DA SEMIOTICA E LINGUISTICA DI COSIMO CAPUTO
L’ultima opera di Cosimo Caputo, Semiotica e linguistica, come e più delle
precedenti (cfr. p. es. Caputo 2000, 2003, 2004), pone esplicitamente alcuni
problemi che non possono essere ignorati da coloro che si occupano di semiotica generale. Sono problemi che mi sentirei di riformulare così:
1) quale è la natura della semiotica generale, e quali sono le dimensioni dell’ambito che essa si propone di studiare?
2) quali sono i rapporti tra la semiotica generale e la linguistica? Quest’ultima occupa un posto speciale (che può arrivare, al limite, all’identificazione tra
le due) o è solo un oggetto tra gli altri?
In queste note vorrei prendere spunto dal testo di Caputo per fare qualche
osservazione su questi due temi. Ma prima di iniziare credo che si debba porre un assunto fondamentale, senza il quale nessun dibattito sarebbe possibile: bisogna affermare a chiare lettere il “diritto di cittadinanza” di una semiotica
generale, intesa, con Peirce (2003: 270), come “dottrina della natura essenziale e delle varietà fondamentali di ogni possibile semiosi”. Essa non si identifica con nessuna delle cosiddette “semiotiche speciali”1, e neppure con una semiotica del testo vista come unica semiotica possibile (o comunque come unica semiotica realmente importante e interessante), ma riveste un suo ruolo peculiare e ha una sua peculiare pertinenza.
1. Il lavoro di Caputo
Caputo, dunque, pone fin da principio della sua opera le due questioni suindicate (quale sia lo statuto della semiotica generale, e quali le sue relazioni con
la linguistica) e le affronta direttamente. L’operazione sincretistica dell’autore
(ovvero il “dialogo transatlantico” – come lo chiama a p. 9 – che impegna, oltre a lui, un numero sempre crescente di studiosi) trova in questo lavoro una
forma anche più coerente e organica che nei precedenti, testimoniando un affinamento e un avanzamento costante in una direzione di ricerca intrapresa ormai da vari anni – operazione cui Hjemlslev presta i mezzi, e Sebeok le finalità. In particolare, l’insistenza sulla forma della relazione segnica come tratto
unificante e primo problema dei semiotici di entrambe le sponde dell’oceano
pone dall’inizio, e inequivocabilmente, una questione cui qualunque autore che
abbia a cuore l’esistenza di una semiotica generale non può non porsi – una
questione di natura filosofica.
Proprio l’idea di una natura filosofica della semiotica generale (che si deve
NOTE
di Emanuele Fadda
149
150
soprattutto a Eco, ma dalla maggior parte degli allievi di Eco è stata decisamente rifiutata) fa sì che ci si debba rivolgere in primis alle relazioni tra semiotica, filosofia e linguistica. In questa ricognizione del campo Caputo si sceglie
come guida Emilio Garroni – un personaggio di cui è difficile sovrastimare l’influenza (spesso nascosta e paradossale2) su larghi settori del pensiero filosofia italiano e non solo – e con Garroni riafferma un primato del senso – la materia di Hjelmslev, la primità di Peirce, quel qualcosa che viene anche prima
della distinzione tra la realtà materiale e il linguaggio che la significa – che, se
non identifica la semiotica con l’estetica, quantomeno assegna una condizione
estetica generale alla semiosi.
Una dottrina di natura filosofica ed estetica, dunque, in cui la tendenza all’ampliamento del dominio e il richiamo alla centralità del linguaggio possano
coesistere – così come avviene nel pensiero di Sebeok. In questo contesto, la
posizione di John Deely (più vicina, peraltro, a quella di Peirce che non a quella dell’autore de Il gioco del fantasticare), cui Caputo dedica varie pagine, assume rilievo più per le sue potenzialità che per i suoi risultati concreti; e anche
la paradossale difesa della “translinguistica” di Barthes trova il proprio posto
naturale.
Queste, dunque, le proposte di Caputo sui temi in questione. Da esse vorrei muovermi per provare a fornire non una qualche risposta determinata, ma
quelle che mi sembrano alcune condizioni di ogni possibile risposta, partendo
da qualche breve cenno sulla storia degli studi semiotici in Europa.
2. Figure di una crescita metamorfica
La semiotica europea, fin dai suoi esordi riconosciuti, negli anni ’603, è stata sempre caratterizzata da forti spinte centrifughe, e in generale da interpretazioni assai diverse sull’ampiezza della gamma di fenomeni investigabili semioticamente. La prima forma assunta da tale disputa è stata quella che opponeva i sostenitori della “semiologia della significazione” (come Barthes) a quelli della “semiologia della comunicazione” (come Prieto4).
Del resto, i “comunicazionisti” – mi si passi il neologismo – non erano i soli a criticare gli studiosi che, come Barthes, vedevano una pertinenza dello studio semiotico su ogni aspetto della vita umana e sociale: l’accusa di “imperialismo” – motivata principalmente dall’allarme per l’affermazione subitanea della “rivoluzione strutturalista” nelle scienze umane, ma non solo – nasce praticamente con l’affermazione accademica degli studi semiotici in Francia, in Italia e in altre parti dell’Europa continentale.
Tale affermazione può dirsi completata al momento dell’apparizione del
Trattato di semiotica generale di Eco, che segna una cesura da vari punti di vista: anzitutto perché è l’ultimo (e oramai l’unico) manuale monografico di semiotica in cui tutti gli studiosi del settore si riconoscono a qualche titolo5; e inoltre, perché prende atto fin da principio del fatto della doppia tradizione (Peirce
vs. Saussure, filosofica vs. linguistica, interpretativa vs. strutturale/generativa
ecc.) – pur riuscendo, di fatto, a contemperare le due prospettive.
3. Formale e sostanziale
La classificazione appena presentata – che prescinde, peraltro, dal problema della possibilità in sé e della natura di una semiotica generale – invita a fare qualche riflessione.
– In primo luogo, non sembra corretto far derivare la delimitazione dell’ambito della semiotica da un criterio esterno, a-semiotico. Questo sembra il caso
della biosemiosi, almeno in alcune sue forme10, e di alcune versioni dell’antroposemiosi (che assumono in partenza la soggettività umana come unico possibile candidato alla segnicità)11.
– Inoltre, non si capisce perché l’ampliamento indefinito del campo della semiotica dovrebbe essere di per sé desiderabile, e l’opzione cosmosemiotica
dovrebbe essere allora la migliore. In questo senso, può essere utile opporre
il tentativo di Deely a quello di Peirce: la fisiosemiosi del primo, in effetti, non è
che virtualità, ed ha dunque a che vedere non con la semiosi piena, ma con un
campo del pensiero di Peirce che non ha avuto finora tutta la considerazione
che merita12: quello delle cosiddette relazioni degenerate
– Diversa è invece la situazione in Peirce, in cui la terzità è un principio formale che individua la semiosi come tale – e non una semiosi virtuale o preparatoria. Tale principio formale, come abbiamo visto supra al § 1, costituisce il
punto di partenza necessario non solo del libro di Caputo, ma di ogni indagine
NOTE
Da allora in poi – anche per l’evoluzione del pensiero dello stesso Eco6 – il
contributo di Peirce alla semiotica europea risulta sempre più determinante,
mentre lo strutturalismo conosce una parabola discendente. In generale, gli
esponenti delle due tradizioni tendono sempre più a isolarsi, e le letture “trasversali” come quelle di Jakobson, Barthes e dello stesso Eco perdono di rilievo.
Un fatto nuovo di questi anni è l’interesse sempre più pronunciato per la
biosemiosi, motivato anzitutto dall’opera di Sebeok7 e dal suo auspicio di una
semiotica globale che possa comprendere tutti i fenomeni che hanno a che fare con la vita.
Per riepilogare la situazione, mi servirò di una mia classificazione che ha
avuto altrove qualche fortuna8, ed opporrò quattro posizioni principali:
1) COSMOSEMIOSI: estende l’ambito della semiosi anche alle regolarità fisiche in ambito inorganico. Posizione sostenuta da Peirce (ma non dai suoi seguaci) e recentemente, da Deely.
2) BIOSEMIOSI: considera i campi della semiosi e della vita coestensivi. La
sua versione più nota è la semiotica globale di Sebeok.
3) ANTROPOSEMIOSI: considera la semiotica come una forma di studio della
cultura umana. Teorizzata dapprima da Eco nel Trattato, è una posizione oggi
condivisa soprattutto da studiosi della semiotica del testo9.
4) SEMIOTICA RISTRETTA: restringe il campo della semiosi allo studio della lingua e degli altri sistemi di comunicazione intenzionale (o comunque in qualche
modo codificata). Era la posizione di Saussure, ed è sostenuta ancora oggi da
alcuni saussuriani che potremmo dire “ortodossi”).
151
in semiotica generale. La funzione segnica in Hjelmslev e la struttura semiotica in Prieto13 sono proprio questo: un tentativo di definizione formale14 che prescinda da ogni elemento a-semiotico.
– Per questi motivi, non è il caso di far derivare le dimensioni dell’ambito
della semiotica dalla tradizione che si sceglie di privilegiare. Se infatti è innegabile che le semiotiche “grandi” sono per lo più post-peirceane, e le semiotiche “piccole” post-saussuriane15, è ben possibile avere semiotiche post-saussuriane “grandi” (come quella di Caputo, che deriva da una peculiare rilettura
di Hjelmslev) e semiotiche post-peirceane “piccole”.
– Infine (last but not least) l’unità minima della semiotica generale non dev’essere per forza il segno. Questo non significa, peraltro, che debba essere
per forza il testo, come vorrebbero in molti16, ma può essere anche un’unità più
piccola – come è il caso dell’indizio in Prieto. In ogni caso, non bisogna confondere in alcun modo l’unità minima teorica della semiotica generale (che è
dottrina17 di stampo filosofico) con l’unità minima di analisi della semiotica testuale.
4. Che cos’è “glottocentrico”?
152
Dopo aver affrontato il primo problema, rivolgiamoci dunque al secondo, ovvero ai rapporti tra semiotica generale e linguistica. Per farlo vorrei partire da
un punto di vista molto forte, quello del già citato J. Deely, il quale divide senz’altro la storia degli studi semiotici in una tradizione non glottocentrica, maggiore, e in una glottocentrica, che egli ritiene minore. Ovviamente, vi sono delle cose da dire tanto sul termine usato, quanto sull’assegnazione di importanza relativa alle due tradizioni.
Anzitutto, chiediamoci che significhi “glottocentrico”. Mi sembra che le possibili accezioni si riducano a tre principali:
a) La semiotica è glottocentrica in quanto le lingue e il linguaggio sono il suo
unico oggetto. In questo caso, mi sembra che la risposta debba essere decisamente un no;
b) La semiotica è glottocentrica in quanto tutto il semiotico va ricondotto alla lingua e/o al linguaggio. Anche in questo caso, mi sembra che non si possa
che negare una posizione di questo genere18;
c) La semiotica è glottocentrica in quanto le lingue e il linguaggio occupano
un posto fondamentale e sono per taluni aspetti irriducibili a qualcosa di più
semplice e di non linguistico. In questo caso, invece, ritengo che la risposta
non possa che essere positiva.
Quanto alle affermazioni di Deely, esse possono essere interpretate in due
modi: o la tradizione glottocentrica è minore perché non ha mai ottenuto risultati comparabili a quell’altra, oppure è minore perché è glottocentrica. Nel primo caso si tratterebbe di una posizione opinabile, ma su cui si può discutere,
nel secondo caso di una posizione semplicemente assurda: perché una tradizione dovrebbe essere minore soltanto perché minore è l’ampiezza dell’oggetto che essa rivendica?
NOTE
Qui non sono in questione, ritengo, le ambizioni e la raison d’être della semiologia auspicata da Saussure. Del resto, Amacker (1995) e De Mauro (1967,
2005) ci hanno insegnato che, contrariamente all’opinione di molti19, Saussure
si sia sobbarcato il carico di una rifondazione epistemologica della linguistica e
la scelta dell’inquadramento semiologico della lingua per spiegare che tipo di
cosa una lingua è, e dunque la lingua come tale sia sempre stata, per lui, fine
e non mezzo. Questo, però, non sposta di un centimetro i termini della questione che abbiamo posto, in quanto:
a) in primo luogo, non si può certo rimproverare a Saussure di aver fatto il
suo mestiere (che era quello del linguista) – e di averlo fatto nel migliore dei
modi;
b) ma soprattutto, il fatto medesimo che egli sia stato, per così dire, “costretto” a “inventare” una semiologia per chiarire la vera natura della lingua è la prova provata che in qualche modo la lingua non basta a se stessa. Saussure
compie lo stesso passo di Agostino (la riunificazione, cioè, del dominio della
lingua e di quello dei segni)20, ma ad un livello ulteriore, e partendo dalla lingua
– oggetto del quale egli ha compreso la natura come nessun altro prima di lui.
5. Conclusioni
In conclusione, credo che non si possa che richiamare all’atteggiamento
manifestato da Caputo non tanto e non solo attraverso dichiarazioni esplicite,
ma soprattutto implicito in tutto il suo lavoro: l’eliminazione di ogni tipo di steccato nella prospettiva del dialogo.
In questa prospettiva, credo che la congiunzione del titolo vada intesa non
come vel ma come et: credo che chi si occupa di semiotica generale abbia il
diritto e il dovere di ergere anche le lingue a proprio oggetto di studio, senza
per questo contrapporsi sterilmente alla linguistica “non filosofica” o “dei linguisti”. La linguistica dei linguisti è certamente uno degli ambiti cui la semiotica deve rivolgersi, assieme alla filosofia, alle scienze cognitive, alle scirnze sociali,
alle neuroscienze e a vari altri ambiti e discipline. Solo così sarà possibile tenere aperto e vitale un dibattito cui molti studiosi (di estrazione anche diversissima) possono portare il proprio contributo, che non può mai avere un termine
definito e una soluzione ultimativa21, ma anche per questo non può essere scavalcato con soluzioni preconfezionate e sottratte alla critica – un dibattito cui
Cosimo Caputo ci richiama ormai da anni.
Riferimenti bibliografici
AMACKER, René, 1995: Saussure “héraclitéen”: épistémologie constructiviste et réflexivité
de la théorie linguistique, in: Arrivé, Michel & Normand, Claudine (éd. par): Saussure aujourd’hui (Actes du Colloque Cerisy-La-Salle 1992), Paris, Publidix, pp.17-28.
153
154
BARTHES, Roland, 1964: Elements de sémiologie, Paris, Seuil [trad. ital.: Elementi di semiologia (a cura di A. Bonomi), Torino, Einaudi, 1966].
BOUQUET, Simon, 1997: Introduction à la lecture de Saussure, Paris, Payot.
CAPUTO, Cosimo, 2000: Semiologia e semiotica, Bari, Graphis.
Id., 2003: Semiotica del linguaggio e delle lingue, Bari, Graphis.
Id., 2004: Semiotica e comunicazione, Bari, Edizioni dal Sud.
Id., 2006: Semiotica e linguistica, Roma, Carocci.
DEELY, John, 2002: Baics of Semiotics, Bloomington, Indiana Un. Press [trad. ital.: Basi della semiotica, Bari, Gius. Laterza, 2004].
DE MAURO, Tullio, 1967: Introduzione, commento e note all’edizione italiana di Saussure (1916).
Id., 2005: Introduzione e note a Saussure (2005).
ECO, Umberto, 1975: Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani.
Id., 1984: Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, Einaudi.
Id., 1990: I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani.
Id., 1997: Kant e l’ornitorinco, Milano, Bompiani.
FABBRI, Paolo, 1998: La svolta semiotica, Roma-Bari, Laterza (2ª ed., con una diversa
introduzione, 2001).
Id. & Marrone, Gianfranco (a cura di), 2000: Semiotica in nuce, Roma, Meltemi.
FADDA, Emanuele, 2003a: L’aggettivo “semiotico”. Note sulla lettura di Hjelmslev da parte di Luis J. Prieto, in “Janus” (Quaderni del Circolo Glossematico) n. 3, Padova, Il Poligrafo.
Id., 2003b: Piccolo corso di semiotica, Acireale (Catania), Bonanno.
Id., 2004: La semiotica una e bina. Problemi di filosofia del segno da Ch. S. Peirce a F.
de Saussure e L. J. Prieto, Rende, CELUC.
GARRONI, Emilio, 1977: Ricognizione della semiotica, Roma, Officina.
Id., 1986: Senso e paradosso, Roma-Bari, Laterza.
Id., 1992: Estetica. Uno sguardo attraverso, Milano, Garzanti.
MANETTI, Giovanni, 1987: Le teorie del segno nell’antichità classica, Milano, Bompiani.
MAZZONE, Marco, 2005: Menti simboliche, Roma, Carocci.
PEIRCE, Charles S., 2003: Opere (a cura di M. A. Bonfantini), Milano, Bompiani.
PRIETO, Luís J., 1975: Pertinence et pratique, Paris, Minuit [trad. ital.: Pertinenza e pratica, Milano, Feltrinelli, 1976].
Id., 1989-95: Saggi di semiotica, Parma, Pratiche, 3 voll.
PRODI, Giorgio, 1988: La biologia come semiotica naturale, in: Hertzfeld, Micheal e Melazzo, Lucio (edd.), Semiotics theory and practice: proceedings of the Third IASS
Congress (Palermo 1984), Berlin, Mouton, pp. 929-951.
PRONI, Giampaolo, 1992: L’influenza di Peirce sulla teoria dell’interpretazione di Umberto Eco, in Magli, Manetti, Violi (a cura di): Semiotica: storia, teoria, interpretazione. Saggi intorno a Umberto Eco, Milano, Bompiani, pp. 89-98.
SAUSSURE, Ferdinand de, 1916 (CLG): Cours de linguistique générale (éd. Ch. Bally &
A. Secheaye, coll. A. Riedlinger), Paris, Payot [trad. ital.: Corso di linguistica generale, introd., trad., commento e note a cura di T. De Mauro, Bari, Laterza,
1967].
Id., 2002: Ecrits de linguistique générale (éd. par R. Engler & S. Bouquet), Paris, Gallimard.
Id., 2005: Scritti inediti di linguistica generale (a cura di T. De Mauro) [ediz. ital. parz. di
Saussure (2002)], Roma-Bari, Laterza.
VECCHIO, Sebastiano, 1994: Le parole come segni. Introduzione alla linguistica agostiniana, Palermo, Novecento.
VOLLI, Ugo, 2000: Manuale di semiotica, Roma-Bari, Laterza.
NOTE
1 In queste pagine vorrei tralasciare quasi completamente il tema della relazione tra la semiotica generale e le cosiddette “semiotiche speciali”. Una tale omissione non è motivata da scarso
interesse ma, al contrario, dal fatto che si tratta di un problema molto importante, in cui non mi sentirei di entrare solo per accenni.
2 Ma questo, per uno studioso che ha eletto il paradosso a proprio oggetto di studio precipuo,
e a forma principale della verità filosofica (cfr. p. es. Garroni 1986, 1992), non può che essere un
complimento…
3 In realtà, ci sarebbero buone ragioni per riconoscere come reale esordio della semiologia
strutturale Hjelmslev (1943), o anche il meno conosciuto, ma fondamentale, libro di Buyssens
(1943) – o addirittura alle poche righe ad essa dedicate da Saussure nel Cours; ma in questa sede sceglierò di partire dalla metà degli anni ’60, in cui appaiono opere fondamentali di Barthes,
Prieto, Greimas, Jakobson ed Eco.
4 Il quale si sarebbe “convertito” poi anch’egli, a partire dagli anni ’70, allo studio generale della significazione e dell’interpretazione (cfr. p. es. Prieto 1975 e 1989-95).
5 È risaputo, infatti, che i vari manuali di semiotica oggi in circolazione sono spesso improntati agli interessi e alle posizioni del singolo studioso che li scrive – o, al contrario, rappresentano
opere collettanee in cui i vari specialismi non riescono a fondersi realmente in una prospettiva comune.
6 Cfr. Proni (1992).
7 Il quale, peraltro, attinge a una vasta gamma di autori non (o non-ancora-consapevolmente)
semiotici, da J. von Uexküll a G. Prodi.
8 Cfr. Fadda (2003: 27 sg.) e Mazzone (2005: 17 sg.)
9 Ovviamente, in senso lato, e tale da comprendere ogni tipo di “intreccio” segnico che possa
ricevere il nome di “testo”.
10 P. es. Prodi (1988), in cui si identificano chiaramente semiosi e chimica organica.
11 In questo senso è leggibile, per certi aspetti, anche la posizione di Prieto.
12 Caputo rappresenta però una felice eccezione: cfr. Caputo (2004, 2006).
13 Sulla relazione tra questi due autori cfr. Fadda (2003). Per un’analogia più generale tra terzità in Peirce e struttura semiotica in Prieto cfr. Fadda (2004: cap. 1).
14 In quest’ambito, potremmo citare anche lo “spazio C” di cui parla Eco (1990), riprendendo
Peirce in chiave simile al comportamentismo, ma senza le rigidezze.
15 Ma è altrettanto innegabile che le posizioni originarie di Saussure e Peirce risultano essere
appannaggio di una schiera molto ristretta dei rispettivi “seguaci”…
16 Cfr. Fabbri & Marrone (2000: 8): “L’analisi semiotica (…) è analisi testuale perché riconfigura i dati sensibili da esaminare in precise forme (…). E la nozione di testo, in tal modo, non comprende soltanto i testi propriamente detti”; Volli (2000: 72): “I segni sono sempre in relazione con
altri testi, non esistono mai da soli (…). [L’]oggetto della semiotica è il testo.” Cfr. anche Fabbri
(1998).
17 Il recupero, da parte di Peirce prima e di Sebeok poi, dell’antico termine (lockiano, ma ancora prima scolastico e agostiniano) di “dottrina”, indica proprio il carattere interdisciplinare, generale e filosofico della semiotica.
18 In questo spirito, trovo condivisibile la polemica di Caputo (2006: 137-9) contro Cimatti e la
sua implicita riduzione della semiosi al linguaggio. Certo, tale presa di posizione mal si collega
con la difesa di Barthes citata supra al § 1 – anche se, probabilmente, Caputo risponderebbe
che nei due casi non è in gioco la stessa accezione di “linguaggio”…
19 Come ad esempio di S. Bouquet (cfr. Bouquet 1997), ma non solo…
20 Cfr. Manetti (1987) e Vecchio (1994).
21 A costo di forzare un po’ la posizione di Saussure, mi sembra di poter dire che si tratti di
un’estensione del terzo compito assegnato alla linguistica nel Cours: quello di delimitare e definire – costantemente, e sempre di nuovo – se stessa.
155
SENSO, RESPONSABILITÀ
E ANTROPOCENTRISMO RELAZIONALE
A PROPOSITO DI UN TESTO DI MARIO SIGNORE
di Susan Petrilli
156
Il problema del senso occupa nel libro di Mario Signore, Lo sguardo della responsabilità. Politica, economia e tecnica. Per un antropocentrismo relazionale,
Edizioni Studium, Roma 2006, 248 pp.) un posto centrale. È un tema costante
della ricerca di Mario Signore, tema che ci unì a lui nella partecipazione a un fascicolo di “Idee” del 1990 (13-15), Genesi del senso, dove tra gli autori, insieme
a Mario Signore, c’erano Augusto Ponzio, Cosimo Caputo, Patrizia Calefato,
Claude Gandelman di Haifa (con il quale A. Ponzio ha fondato la serie annuale
di Meltemi “Athanor”), Giuseppe Mininni, io stessa e altri collaboratori della scuola di Bari. In quel fascicolo pubblicai un saggio su Victoria Welby, che a questo
problema e all’altro ad esso connesso – che attraversa l’intera riflessione del libro di Mario Signore – quello del rapporto tra comportamento (in particolare, per
Welby, il comportamento linguistico) e valore, ha dedicato l’intera sua riflessione.
La questione della responsabilità dà un orientamento preciso alla riflessione sul
senso e sul valore. La husserliana “donazione di senso” da parte della coscienza intenzionale, si trova di fronte a ciò che, invece, ha già un senso per sé, e che
è proprio ciò che richiede o impone la modalità originaria della coscienza, non
come donatrice di senso, ma come cattiva o buona coscienza, come responsabilità, cioè l’altro, altri. È la situazione originaria che Lévinas indica come “coscienza non intenzionale” (Lévinas, “La conscience non intetionnelle”, 1983, in
Id., Entre nous, Grasset et Frasquelle, Paris 1991. trad. it. e cura di E. Baccarini, Tra noi. Saggi sul pensare all’altro, Jaca Book, Milano 1998, pp. 157-167).
Mario Signore dedica il secondo capitolo, “Per un’etica della responsabilità
come diacronia e an-archia”, della seconda parte (“Un’etica della responsabilità del pensare”) del suo libro Lo sguardo della responsabilità, (pp. 93-108) alla riflessione di Lévinas, un altro autore che è “tra noi” potremmo dire con il titolo dell’ultimo libro di Lévinas pubblicato in vita (Entre nous, cit), il cui sottotitolo, Essai sur le penser-à-l’autre, sul pensare all’altro, è, per quanto riguarda
l’etica della responsabilità del pensare, particolarmente significativo. Anche su
Lévinas Signore ci coinvolse in due fascoli monotematici di “Idee” (9-10, 198889, e 25, 1994, quest’ultimo intitolato Sulla traccia di Lévinas. A proposito di
questo autore, Mario Signore nella premessa di quel fascicolo (p. 7) scriveva
dire di Lévinas significa sottoporre alla prova estrema alcuni momenti
della filosofia occidentale del 900, accostrasi fino a farle circuitare, alle
forme più alte della fenomenologia, espresse da Husserl e da Heidegger.
Il rapporto con l’altro, con il volto nudo dell’altro, rapporto asimmetrico e di-
NOTE
scontinuo senza un terzo, qualsiasi cosa esso sia, che accomuni, costituisce
la pace primordiale, e il ritorno ad esso, protremmo dire, in linea con il linguaggio odierno delle “guerre giuste e necessarie”, la pace preventiva (v. A. Ponzio,
Introduzione a E. Lévinas, Dall’altro all’io, Roma, Meltemi, 2002, pp. 7-59, e A.
Ponzio, “The I questioned: Emmanuel Levinas and the critique of occidental
reason”, “Subject Matters” III, 1, pp. 1-43, seguito da una discussione da parte con interventi di A. Zachary Newton, Michel B. Smith, R. Bernasconi, G.
Ward, R. Burggraeve, B. Brergo, W, P. Simmons, A. Aronowicz). A proposito di
Lévinas e del comune interesse per questo autore con Mario Signore, voglio
ricordare anche l’importante sua relazione, “Il ‘principium individuationis’ in Lévinas. Nell’etica. Oltre l’ontologia” al Convegno Lévinas Vivant (pubblicazione
degli atti, Edizioni dal Sud, Bari 1998) organizzato da Augusto Ponzio nell’Università di Bari nei giorni 13-14 marzo 1996, l’anno successivo a quello della
morte di Lévinas.
Nel libro Lo sguardo della responsabilità, Signore si sofferma particolarmente su due elementi in Lévinas concernenti “il dispiegamento positivo della relazione pacifica, senza frontiere o senza negatività alcuna, con L’Altro”
(p. 96). Il primo riguarda il linguaggio come risultato primario di tale relazione, in cui parlare significa rivolgersi, in cui non vale la formula heideggeriana secondo la quale prima di essere in relazione con qualcosa è necessario
comprenderlo come essere: comprendere altri, se in termini di comprensione vogliamo descrivere il rapporto con lui, è dirgli la mia comprensione; l’altro “è l’unico essere che non posso incontrare senza esprimergli questo incontro”, sicché l’incontro non è conoscenza: nell’incontro c’è l’espressione
dell’incontro, “c’è un saluto – anche se come rifiuto di salutare” (Lévinas,
“L’ontologie est-elle fondamentale?”, 1951, in Lévinas, Entre nous, trad. it.
cit., p. 36). L’incontro è inseparabile dal tenere conto e dall’espressione di
questo tenere conto. Il linguaggio, come tener conto dell’altro ed espressione di questo tener conto, non è subordinato alla presa di coscienza della presenza dell’altro, della sua vicinanza, della comunità con lui, ma ne è la condizione. Altri nel mio rivolgermi verso di lui, a differenza del mio rivolgermi
verso un oggetto, è originariamente al vocativo, in questo senso è salutato,
anche se il mio rivolgermi a lui consiste nella decisione di non salutarlo. Questo vocativo, che attesta la non situabilità d’altri nell’orizzonte dell’essere, la
sua assoluta alterità, è la parola originaria, è ciò che dà origine al linguaggio
e quindi alla coscienza, ivi compresa la coscienza nei confronti di altri e dell’eventuale senso di vicinanza, di comunità, che si può avere con lui. In questa relazione, a differenza di quella in cui la coscienza intenziona un oggetto, ciò che è nominato è al tempo stesso interpellato; nominare significa qui
interpellare.
Il secondo elemento evidenziato da Signore riguarda l’economia, l’abitare,
perché per Lévinas la trascendenza del volto non esiste fuori dal modo, come
se l’economia, che comporta la separazione, occupasse un livello inferiore rispetto a una specie di “contemplazione beatifica” di Altri: la visione del volto come volto avviene a partire da un soggiornare nel mondo, da una forma, dice
Lévinas (Totalité et Infini, Nijhoff, La Haye 1961; trad. it. di A. Dell’Asta, introd.
157
di S. Petrosino, Totalità e Infinito, Jaca Book Milano 1990, p. 37). Osserva Mario Signore (Lo sguardo della responsabilità, p. 10):
Colta in questa prospettiva, l’economia appare l’elemento imprescindibile di qualsiasi relazione umana o interumana e non più l’elemento in forza del quale si produce la divisione e/o la contrapposizione. In questo caso si ridisegna il rapporto tra economia ed etica, non solo per la preconizzata moralità dell’economia, ma innanzi tutto per il carattere ‘economico? Dell’etica, se quest’ultima è individuabile all’interno, e soltanto all’interno, di una relazione. Raccoglimento e separazione sono, d’altra parte,
coessenziali all’esperienza economica, che si apre al volto e ne cerca
l’incontro, a condizione che questo non sia ‘a mani vuote’ e che le porte
non siano chiuse all’ospitalità d’Altri.
158
Lo sguardo della responsabilità: il titolo dice in maniera chiara e forte dell’intenzione del guardare responsabile, dell’assunzione della responsabilità come condizione del vedere. Non sguardo sulla responsabilità resa oggetto teorico, oggetto di contemplazione, di discettazione più o meno approfondita, ma
sguardo della responsabilità, dal punto di vista della responsabilità, di un soggetto che si riconosce responsabile, che non può esssere il “soggetto solo”, ma
soggetto in relazione, indissolubilmente coinvolto nel rapporto con il mondo e
con gli altri. Il titolo, come Signore stesso dichiara, vuole avere un significato
provocatorio, accostando lo sguardo all’“inevitabile tensione della responsabilità” (p. 9). Ne consegue la messa in discussione della distrazione dello sguardo, della sua “leggerezza”, delle sue possibilità di alibi, di scappatoie, della
possibilità di fingere, o di riuscire addirittura a convincersi, di non vedere. Guardare senza vedere: una fuga insostenibile di fronte alla necessità di presa di
posizione, all’obbligo di assunzione di responsabilità, una “perdita secca” di
un’“opportunità tutta umana benché scomoda” (ib.) di rispondere agli altri e noi
stessi del senso delle nostre azioni, dei nostri rapporti, delle nostre progettazioni e dei nostri immaginari.
La questione è specificamente di ordine filosofico, perché si tratta della ragione, della ragione occidentale, che anziché continuare ad esaltarsi nella sua
capacità di avere ragione dell’altro, con tutti i mezzi necessari, ivi compresa
l’extrema ratio della guerra, può ormai facilmente trovare, nel mondo odierno
minacciato com’è di distruzione totale, “una ragione forte”, come si esprime
Mario Signore (p. 10), per “posare lo sguardo, con nuova umiltà, sulle rovine di
un mondo e di una storia che mostrano sempre di più macerie, e spingere la
irrefrenabile fabbilità dell’homo faber, liberatosi impunemente dalla fatica di
pensare, ad aprirsi all’attitudine ‘trascendentale’ della riflessione, che kantianamente, se non definitivamente sopita, si esprime nel ‘bisogno di pensare’”.
Perciò la necessità dello “sguardo della responsabilità”, la necessità del
passaggio, il prima possibile, diremmo, dal pensare gli altri, come oggetti e cose, al pensare agli altri ed anche, quindi, al pensare agli oggetti e alle cose:
pensare a come essere in pensiero per il mondo e per gli altri, assumendosene in pieno la responsabilità.
La tematica della responsabilità è affrontata nel libro di Signore attraversando, come il sottotitolo indica, politica, economia ed etica, quali “luoghi” in cui si
esercita la responsabilità e da cui una riproblematizzazione dell’etica non può
prescindere. Gli autori coinvolti in questa disamina, che va dalle condizioni, possibilità e sviluppi della responsabilità del pensare alla questione di una nuova
antropologia e alla riproposizione del problema del senso, sono molti e diversi
tra loro per orientamento e collocazione: Kant, Dilthey, Weber, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Cassirer… Di quest’ultimo Signore (p. 37) sottolinea l’esigenza, rispetto a Kant, del passaggio da una critica della ragione a una critica della cultura o dell’allargamento dell’analitica dell’intelletto in modo da comprendere l’“ambito intero della comprensione del mondo”. In questa interpretazione
Cassirer non parte più dal semplice fatto della cultura, ma dal fatto della cultura di tutte le possibili, effettuali e vissute comprensioni del mondo”. A questo proposito vale la pena ricordare, dati gli autori a cui Signore nel suo libro principalmente si richiama, il famoso incontro di Davos del 1929 fra Cassirer e Heidegger, da cui Lévinas trasse la consapevolezza della fine di un certo umanesimo
e dell’avvio di una radicalizzazione dell’interrogazione filosofica sul senso dell’uomo. Humanisme de l’autre homme (Fata Morgana, Montpellier 1972; trad. it.
di A. Moscato, Umanesimo dell’altro uomo, Il melangolo, Genova 1985), è il significativo titolo di un libro di Lévinas del 1972, raccolta di saggi degli anni Sessanta, che rappresenta una tappa importante della sua riflessione su questa tematica). All’incontro di Davos è interamente dedicato il saggio di Xavier Antich
“L’umanesimo di Lévinas e l’incontro di Davos”, compreso nel fascicolo di
“Idee”, sopra ricordato, a cura di Mario Signore e intitolato Sulla traccia di Lévinas (pp. 91-96). Il saggio di Lévinas che ho già avuto occasione di menzionare,
“L’ontologia è fondamentale?” termina con queste conclusioni, che preludono,
diventando premesse, al libro del 1961, Totalità e Infinito, e con quest’altra affermazione, che sembra annunciare il libro del 1972, L’umanesimo dell’altro uomo, e rispondere all’incontro di Davos del 1929 fra Heideggere e Cassirer:
“L’umano si offre soltanto a una relazione che non è un potere”.
La questione dell’umanesimo dell’alterità è collegata con la questione del
linguaggio per la connessione – come abbiamo visto sopra, attraverso la precisa analisi di Signore – tra linguaggio e “relazione pacifica” con l’altro. Sotto
questo riguardo sono interessanti le considerazioni di Mario Signore in “Il silenzio primordiale al brusio della parola” (in La filosofia del linguaggio come arte
dell’ascolto. Sulla ricerca scientifica di A. Ponzio, a cura di S. Petrilli, Edizioni
dal Sud, Bari 2007, pp. 213-236) sul rapporto tra lingua e silenzio per il rischio
NOTE
Un “pensare responsabile” apre ad un’etica della responsabilità, capace
di superare la tradizionale risposta antropocentrica dell’etica della modernità, riconoscendo lo status morale non solo per gli esseri dotati di ragione, bensì per tutti gli esseri passibili di sofferenza. In quest’ambito (del
pensare responsabile) la teoria è essa stessa prassi (…). Ed anche se
non determina la prassi (in un rapporto di causa ed effetto), apre la strada ad una prassi migliore con la sua critica-smascheramento della falsa
prassi o del determinismo della prassi espressa dalla convinzione che è
così e non altrimenti (p. 31).
159
insito nella lingua di isterilirsi in formulazioni logiche sempre più prive di senso,
di ridursi a segno senza significato:
Il programma della fenomenologia, che porta Husserl a fare i conti con la
crisi della ragione e con la crisi della scienza, finisce con il dover inserire
anche il problema della lingua (…). La Crisi delle scienze europee diventa, conseguentemente, anche se non esplicitamente, l’opera non soltanto
dei limiti della scienza moderna, ma anche di una nuova teoria del segno
e del linguaggio che ne arresti il processo degenerativo (…) (ivi, p. 235).
Questa nuova teoria del segno non può prescindere dall’ascolto dell’altro,
in uno scenario che, come leggiamo in Lo sguardo della responsabilità,
mette a dura prova la ragione moderna con i suoi prodotti e invoca
un’analisi spregiudicata dei paradigmi e del loro esiti in una prospettiva di
“complessità” che indice “crisi” (p. 11).
160
Riprendendo un testo di Heidegger del 1962, La tecnica e la svolta, Signore
sottolinea il significato medico di “crisi”, che come tale richiede una terapia, la
quale non è possibile senza diagnosi. La crisi della razionalità moderna richiede
un’adeguata diagnosi, richiede che l’ascolto, nel senso della semeiotica medica,
dei suoi sintomi. Sicché – e questo mi sembra un importante punto di raccordo
tra la riflessione di Mario Signore nell’ambito dell’etica e quella che noi andiamo
conducendo nella scuola di Bari-Lecce (v. C. Caputo, S. Petrilli, A. Ponzio, Tesi
per il futuro anteriore della semiotica, Mimesis, Milano 2006) nell’ambito dello
studio dei segni – una nuova teoria del segno non può esonerarsi dalla responsabilità di ascoltare i sintomi in cui si evidenziano, a livello mondiale, i vari aspetti della crisi dell’attuale forma sociale caratterizzabile come fase della comunicazione globale. La semiotica, la scienza generale dei segni, sotto questo riguardo
recupera nell’attitudine all’ascolto il suo antico rapporto con la semeiotica medica, da cui storicamente deriva. Essa come semiotica globale, individuata l’inscindibilità di processo segnico (semiosi) e vita, e si occupa della vita anche nel senso che se ne preoccupa, cioè non solo nel senso conoscitivo ma anche nel senso che contribuisce umilmente e responsabilmente al compito di farla stare bene. La semiotica, malgrado tutti gli alibi che può fornirle lo specialismo e il settorialismo delle branche disciplinari in cui è articolabile non può sottrarsi a questa
responsabilità. Questo compito è specificamente umano, essendo l’uomo l’unico
animale capace di semiotica (v. J. Deely, S. Petrilli, A. Ponzio, Semiotic Animal,
Legas, Ottawa 2005), cioè capace di usare i segni per riflettere sui segni, l’unico
animale capace di presa di coscienza, dunque di responsabilità, una responsabilità che non riguarda solo la sua specie ma l’intera vita sul pianeta. Mi piace ricordare che anche questa piega, questo orientamento, dello studio dei segni che
abbiamo indicato come “semioetica” (v. A. Ponzio e S. Petrilli, Semioetica, Meltemi, Roma, 2003) secondo cui attualmente lavoriamo fu originariamente preconizzato in occasione della partecipazione con un saggio mio e di A. Ponzio intitolato “Bioetica, semiotica della vita e comunicazione verbale”, al fascicolo di
“Idee” dedicato a Questioni bio-etiche, promosso da Mario Signore.
NOTE
Se si tiene conto dunque della responsabilità dell’uomo a livello planetario
e della necessità, come Mario Signore si esprime, di una “nuova teoria del segno e del linguaggio” che questa responsabilità evidenzi e sostenga, si comprende quanto sia pertinente, per “richiamare” ciascuno alla propria responsabilità senza alibi, il sottotitolo del libro di Signore: per un antropocentrismo relazionale. Con esso si intende “una centralità non più egemonica, ma relazionata, dialogante, responsabilmente impegnata a muoversi in una realtà non
più semplificabile o riducibile” (p. 11).
161
LA FENOMENOLOGIA
E L’OLTRE-FENOMENOLOGIA
di Aniello Montano
162
Il laboratorio filosofico di Giovanni Invitto non conosce pause. È sempre attivo. Non smette mai di produrre idee e libri. Con il suo impegno intellettuale e
il suo dinamismo organizzativo, Invitto ha fatto di Lecce, della sua cattedra, un
punto alto di riferimento per studiosi italiani e stranieri, impegnati soprattutto
nella riflessione sulla filosofia francese del Novecento, tra fenomenologia ed
esistenzialismo. Un ruolo importante in questo “dialogo” ha svolto anche la rivista “Segni e comprensione”, attiva ormai da un ventennio, e da Invitto fondata e diretta. Della ripresa degli studi sulla fenomenologia e sull’esistenzialismo
francesi, su Maurice Merleau-Ponty e su Jean-Paul Sartre in particolare, Invitto è stato sollecitatore e protagonista attivo, a partire dai primi anni Ottanta del
secolo appena trascorso, dagli anni, cioè, immediatamente successivi alla
morte di Sartre. Da allora, si sono succeduti e avvicendati progetti di ricerca,
convegni, libri, seminari, che hanno contribuito non poco ad una più attenta e
puntuale esplorazione e attualizzazione di un settore d’indagine da alcuni considerato ormai estenuato e superato.
L’ultimo frutto di questo intenso e produttivo lavoro, è il volume collettaneo
La fenomenologia e l’oltre-fenomenologia. Prendendo spunto dal pensiero
francese, a cura di Giovanni Invitto, Mimesis, Milano 2006. Il libro raccoglie
saggi prodotti all’interno di una ricerca su “Fenomenologia, narrazione, riflessione etico-politica: testi e temi del pensiero francese del Novecento”, cui partecipano, oltre a quella di Lecce, le università di Bari, di Sassari, di Verona e di
Roma Tre. Approntati per attività seminariali tenute presso l’Università di Lecce, gli scritti sembrano rispondere tutti alla tesi della centralità lievitante della
fenomenologia all’interno della riflessione filosofica della seconda metà del Novecento. La matrice fenomenologica, diretta o indiretta, si lascia scorgere, infatti, nei tanti filoni in cui si dipana e si articola questa riflessione: dall’esistenzialismo all’ermeneutica, dal neotrascendentismo ontologico, al pensiero debole, dalla filosofia dell’alterità a quella della differenza. Accanto a questa evidenza, però, si lascia scorgere anche il bisogno dell’andar oltre, di approntare
forme nuove di comprensione della realtà. Il “perché ‘oltre la fenomenologia’”
sembra giustificato abbastanza chiaramente dal dibattito seguito alla conferenza leccese di Gianni Vattimo. “Andare oltre” significa non considerare la fenomenologia quasi fosse una scuola. Ad intenderla come scuola si rischia o di accettarla o di rifiutarla in blocco, senza la possibilità di cogliere al suo interno
motivazioni, articolazioni e sfumature teoriche differenti. Mentre differenti sono
non solo gli stili di pensiero dei diversi fenomenologhi, ma anche dei diversi
momenti dell’evoluzione del pensiero di ciascuno di essi. Basterebbe scorrere
NOTE
la ricostruzione delle tappe del farsi del pensiero di Vattimo ricostruito da lui
stesso: da Aristotele a Nietzsche, da questi ad Heidegger, letto in chiave debolista, a Gadamer, a Marcuse, al maoismo e a Schopenhauer, per ritornare alla
tradizione cristiana.
Il dialogo intessuto nel libro registra voci di studiosi italiani e stranieri: da
Franco Ferrarotti a Gianni Vattimo a Marisa Forcina, da Renaud Barbaras a
Santo Arcoleo a Raffaele Capone, da William L. McBride a Giovanni Invitto a
Daniela De Leo a Maria Lucia Colì. I temi vanno dalla riflessione puramente
teorica (Franco Ferrarotti, Fenomenologia della soggettività etica; Gianni Vattimo, Perché ‘oltre la fenomenologia’ ”) a una politica (Marisa Forcina, La politica del partire da sé. Antigone e le filosofe), fino a quella più marcatamente storiografica. All’interno di quest’ultimo tipo di riflessione si va dall’origine del pensiero francese novecentesco (Santo Arcoleo, “All’inizio fu la scienza”. Léon
Brunschvigc e le origini della filosofia francese del XX secolo) a quello praghese (Renaud Barbaras, Il problema dell’apparire in Patocka: Fenomenologia dinamica e dinamica fenomenologica); da Sartre (William L. McBride, Sartre e
Beauvoir all’asse del ventesimo secolo, Renaud Barbaras, Sartre: una fenomenologia dell’impossibilità della fenomenologia, Raffaele Capone, Sartre:
dalla morale esistenzialista alla morale dell’azione. Una rilettura degli scritti postumi, Giovanni Invitto, Per un’ermeneutica degli scritti postumi. Il caso Sartre)
a Merleau-Ponty (Daniela De Leo, Merleau-Ponty: la musica negli scritti postumi, Maria Lucia Colì, Il concetto di natura in alcuni inediti di Merleau-Ponty. Una
prima lettura).
Per la ricchezza dei temi e la varietà delle analisi critiche contenute, il libro
si presta a forme e a piani di lettura differenti. Non potendo dar conto di ognuna di essi, ci limitiamo a segnalare soltanto una questione per noi fondamentale e accomunante non pochi di questi saggi: la questione della validità o meno degli scritti postumi al fine di una migliore comprensione dei filosofi. Il tema
è messo a fuoco da Invitto, a proposito dei postumi sartriani. Ma vale per Merlau-Ponty, come per qualsiasi altro filosofo. Alla domanda se valga la pena
stampare e studiare opere rifiutate o comunque non ritenute meritevoli di pubblicazione dall’autore, alcuni propendono decisamente per una risposta negativa. A costoro, pubblicare inediti scartati dai loro autori, sembra un segnale di
debolezza o addirittura di crisi della creatività. Considerazione, questa, forse
non lontano dalla verità. E, forse, anche molto attuale. Pur accettabile in generale, però, essa non sembra valere sempre e comunque. Tra i casi in cui non
sembra perfettamente aderente al vero è quello specifico degli inediti di Sartre
(e per qualche verso di Merleau-Ponty). Sì, è vero! Si tratta di testi che la creatività prorompente del filosofo aveva scartato. Sono testi ritenuti non perfettamente rispondenti alla tensione e/o ai bisogni teoretici del momento. Ma si tratta anche di scritti corposi, che parlano ancora un linguaggio attuale, pieno di
senso e di interesse per noi e per le questioni che ancora ci intrigano, non ultima la crisi e la destrutturazione in cui versano la cultura e la società contemporanee.
Ripubblicare e studiare quei testi, perciò, potrebbe non essere un mero
esercizio di recupero e neppure un mero gioco finalizzato a ricostruire l’intero
163
164
corpus delle opere del filosofo. Non è un’operazione meramente quantitativa.
Risponde, invece, a due specifiche esigenze. Una di ordine filologico, l’altra di
ordine filosofico. La prima è quella di meglio comprendere il progressivo sviluppo di un pensiero, quello sartriano, che non a caso “ha fatto epoca” e ha segnato lo stile intellettuale di non pochi giovani di talento. Basterebbe ricordare
qui come gli inediti Cahiers pour une morale ci abbiano aiutato a capire il passaggio dal realismo esigenziale degli scritti sartriani fino a L’être et néant al
realismo dispiegato della Critique de la raison dialectique. La seconda esigenza, di ordine filosofico, è quella di saggiare la funzionalità di quelle riflessione
nel contesto teorico che ci impegna oggi. Ed anche qui, a giustificare l’opportunità della stampa e del successivo impegno di studio relativamente agli inediti sartriani, basterebbe richiamare alla memoria i tanti pensieri e spunti offerti da questi alla riflessione sulla morale e sulla storia, due tra le tematiche di
maggiore impegno discusse dalla storiografia attuale.
Nel caso specifico degli inediti sartriani, inoltre, è da condividere l’idea di Invitto secondo cui questi hanno confermato la sostanziale unitarietà del pensiero del filosofo. Pur conoscendo sviluppi e arricchimenti di notevole entità e
spessore culturali, tale pensiero, infatti, si snoda lungo una linea sostanzialmente unitaria e in grado di ricondurre a sostanziale unità i tanti e tanto diversi stimoli e fermentazioni intellettuali del filosofo. Non a caso le diverse espressioni della creatività di Sartre, dalle grandi opere filosofiche, al pamphlet di tipo politico, alle questioni di natura civile, ai saggi di critica letteraria, artistica,
musicale, alle grandi biografie, agli studi di psicologia fenomenologica, ai testi
teatrali, sono tutte attraversate e segnate dalla stessa tensione libertaria e coscienzialista.
Se Sartre è l’autore più discusso nel corso del libro, non per questo è l’unico punto di riferimento. Abbiamo gia fatto cenno alla molteplicità degli autori e
dei temi nonché degli spunti e degli interessi che emergono dal libro e che lo
rendono accattivante punto di riferimento per gli studiosi interessati a tali questioni. Autori temi spunti interessi, tutti connessi e facenti centro sulla convinzione fondamentale secondo cui, come scrive Ferrarotti nel suo saggio
l’uomo non ha natura allo stesso modo in cui si parla della natura della
tavola o della pietra o di un albero – nel senso che la natura dell’uomo
non rinvia ad una datità fissa, ma è invece concepibile solo come processo. L’uomo non è. Diviene ciò che fa. Più che homo sapiens è, in questo
senso, homo faber, e più ancora, homo historicus. L’agire umano è dunque cruciale per la definizione dell’essere umano.
SARTRE E LE EMOZIONI.
LA TRASFORMAZIONE MAGICA DEL MONDO
I limiti di una psicologia positiva
Vale la pena, oggi che i temi legati alle emozioni godono di un rinnovato interesse, riproporre e approfondire alcuni aspetti del pensiero di Sartre, nel tentativo di recuperarne elementi di grande attualità e importanza. Il filosofo francese scrive Idee per una teoria delle emozioni, saggio dal quale muoverà inizialmente questa analisi, alla fine degli anni ’30, adoperandosi in un primo tentativo di sistematizzazione di nozioni e problemi a suo vedere ineludibili per
chiunque volesse affrontare l’argomento. Nel saggio fanno la loro comparsa,
anticipandone l’evoluzione, i grandi temi de L’Essere e il Nulla, col sostegno di
due fondamentali convinzioni: il limite di una psicologia positiva e l’originalità
della posizione fenomenologica di fronte al problema dei rapporti tra la coscienza e il mondo. I rilievi critici indirizzati alla psicologia riguardano soprattutto la tendenza ad inseguire un’idea di scientificità mutuata dalle scienze naturali e la relativa riduzione dell’evento psichico a fatto fisico. Come vedremo, alle obiezioni seguono proposte alternative ricche di elementi di riflessione e attualizzate dal dibattito sulla coscienza che oggi vede impegnati diversi settori
del sapere, in primo luogo le neuroscienze. Le posizioni di Sartre sono nette e
gli argomenti tutt’altro che banali. Rappresentano, anzi, un momento tra i più
significativi della reazione anti-positivistica tra le due guerre e lo sfondo, ancora ricco e insuperato, su cui costruire un’alternativa di pensiero filosoficamente fondata.
Il saggio di Sartre sulle emozioni si apre con un riferimento a Peirce e alla
sua definizione di ipotesi come somma di risultati sperimentali che essa permette di unificare. Questa nozione dava lo spunto al filosofo francese per proporre una prima necessaria riflessione sul riduzionismo operato dalla psicologia quando, evitando di porsi questioni generali sull’essenza del proprio oggetto di ricerca, commette l’errore di ritenere che i “fatti” concreti contengano in se
stessi significati univoci. In questo modo la ricerca psicologica insegue l’illusione di individuare leggi universali attraverso un procedimento empirico-induttivo, raccogliendo e classificando eventi e fenomeni umani, “così l’idea di uomo
non potrà essere che la somma dei fatti constatati che permette di unificare”1.
Già dalle prime pagine emerge chiaramente una concezione dell’uomo e
della filosofia che ha caratterizzato tutto il pensiero sartriano, l’idea che la conoscenza che conta è quella filosofica e non quella scientifica. Si coglie, in
questa posizione, uno spunto di chiara matrice bergsoniana. Sartre, come Bergson, rifiuta l’idea di rapportare i dati interni della coscienza ai fatti fisici ester-
NOTE
di Marcello Marino
165
166
ni ma, soprattutto, rifiuta la visione di una conoscenza ingegneristica, progressiva e insensibile, e attribuisce alla filosofia il primato della conoscenza perché
capace di riconoscere tanto la centralità della coscienza quanto l’irriducibilità
dell’uomo e il suo libero arbitrio. Questo atteggiamento costituisce lo sfondo sul
quale gli argomenti di Sartre si sviluppano, una pre-condizione che Simone De
Beauvoir spiegava così: “non concedeva che all’artista, allo scrittore, al filosofo, a quelli che chiamava gli uomini soli, il privilegio di cogliere al vivo la realtà”2. Per il filosofo francese la realtà coincide esattamente con la conoscenza
che l’uomo ne ha.
Il Sartre delle Idee rappresenta già un tentativo deciso di affrancamento dall’idealismo francese tra le due guerre, un recupero del concreto attraverso l’interesse per l’uomo e la sua esistenza, in opposizione alle posizioni del suo
maestro Brunschvicg, esponente di una filosofia accademica, idealistica e di
matrice cartesiana. Sartre considera la conoscenza il motore della filosofia e la
coscienza il mezzo attraverso cui la conoscenza è resa possibile. È dunque
inaccettabile immaginare di arrivare alla conoscenza dell’uomo basandosi sul
fatto, perché ciò significa “basarsi sull’isolato, e cioè, con metodo positivistico,
preferire l’accidente all’essenziale, il contingente al necessario, il disordine all’ordine”3. Sartre – e in questo emergono ancor più chiaramente quelle tracce
di bergsonismo di cui tenterà faticosamente di liberarsi negli scritti della maturità – riconosce, seppure con una struttura argomentativa differente, la dimensione qualitativa dei fatti psichici, che non è minimamente rapportabile a quella quantitativa dei fatti fisici. A questo egli aggiunge l’idea di accidente quando,
stigmatizzando il percorso della psicologia, rileva che essa “ammette che l’uomo ha delle emozioni perché l’esperienza glielo insegna”4, e la loro comparsa,
in quanto contingente, è appunto un accidente, un evento isolato e isolabile.
La psicologia non si chiede perché e in quali condizioni la struttura della realtà umana rende possibili le emozioni, semplicemente le studia perché esistono. Se questo è vero dobbiamo altresì ammettere che lo psicologo ha già
un’idea dell’emozione, proprio perché definirà una linea di demarcazione tra le
emozioni e ciò che non lo sono, così Sartre si chiede: “come potrebbe infatti
l’esperienza fornirgli un principio di separazione, se egli non ne fosse già in
possesso?”5.
A tratti si ha l’impressione che il filosofo francese sia più preoccupato di demolire il metodo psicologico piuttosto che chiarire il proprio punto di vista sulle
emozioni. In realtà la critica all’approccio positivista è inevitabile e propedeutica alla proposta, contenuta nelle Idee, della fondazione di una psicologia fenomenologica. Tutto ciò si attesta come il risultato di quell’incontro con la fenomenologia che condizionerà, già dal 1933, una parte rilevante del percorso filosofico del padre dell’esistenzialismo francese. Non bisogna dimenticare che
Bergson e Husserl rappresentano riferimenti certi per Sartre ma anche un territorio costrittivo, che indurrà il filosofo se non a eclatanti ripensamenti, comunque a importanti ridimensionamenti di quegli aspetti del proprio pensiero ad essi riferibili. Il concetto di coscienza, che fa da sfondo alle Idee per una teoria
delle emozioni, mutuato dall’interpretazione bergsoniana, trova una sua prima
e fondamentale compiutezza proprio nell’incontro con la fenomenologia. Tutta-
NOTE
via sarà lo stesso Sartre, nell’approdare alla psicoanalisi esistenziale, a superare il progetto di una psicologia fenomenologica e a rimpiazzare il concetto di
coscienza con quello di “vissuto”, come avverrà nell’Idiota di famiglia. Ciò nondimeno farà con Husserl, il quale, aggiungendo all’Io psichico un Io trascendentale, “appesantisce” la coscienza, svuotandola del suo significato primordiale, che la vuole in se stessa trasparente e vuota, commettendo, agli occhi
di Sartre, l’errore di ricondurla nuovamente al solipsismo e ad una sorta di intimismo convintamente osteggiato dal filosofo francese. Anche in questo risiede il progressivo spostamento di attenzione di Sartre da Husserl ad Heidegger
che, in Essere e Tempo, invece, rifiuta qualsiasi idealismo della coscienza e di
assolutizzazione dell’Io.
Dunque perché una teoria delle emozioni sia possibile è necessario, prima
di tutto, concepirla come una strada per giungere alla realtà essenziale dell’uomo. Questo approccio, chiaramente fenomenologico, induce Sartre a muovere una critica aspra e circostanziata a tutte quelle teorie che, diversamente, intendono spiegare le emozioni attraverso il loro stesso processo, cadendo in errore perché, come egli afferma, “c’è incommensurabilità fra le essenze e i fatti, e chi inizia la sua indagine dai fatti non giungerà mai a ritrovare le essenze”6. Ecco che emerge chiaramente il grande merito di Husserl, che raccoglie
la necessità filosofica di porre rimedio allo “psicologismo” e, pur senza rinunciare alla dimensione esperenziale, fonda il proprio metodo sull’intuizione eidetica; nessuna psicologia è possibile se non implica l’assunzione di principi eidetici, “solo le essenze permettono di classificare e esaminare i fatti”7.
Questa ricerca dell’essenza, che lo stesso Merleau-Ponty tenne a sottolineare nella sua recensione all’opera di Sartre8, è un requisito imprescindibile
della conoscenza umana: così come, secondo Husserl, lo sviluppo della fisica
richiedeva la geometria in quanto eidetica dello spazio, quello della psicologia
non può ignorare una eidetica delle operazioni psichiche. Il compito della psicologia non è quello di interpretare i fatti ma di cogliere e interpretare i significati. Una psicologia fenomenologica, consapevole di questa necessità9, partirà dal considerare le emozioni, così come qualunque altro fenomeno psichico,
un “tipo organizzato di coscienza”10.
Ora, i fatti psichici altro non sono che reazioni dell’uomo al mondo, e per
questo presuppongono l’uno e l’altro, non è possibile immaginare alcun argomento ulteriore senza esplicitare, secondo Sartre, queste due nozioni. Ma questo presuppone anche la capacità di andare oltre lo psichico e la situazione
dell’uomo nel mondo, significa ricercare l’origine dell’uomo, del mondo e dello
psichico. Tutto ciò diventa possibile solo in presenza di quella riduzione fenomenologica che opera una necessaria “messa tra parentesi del mondo”. Le risposte possibili, una volta effettuata questa riduzione, saranno tali e avranno
un senso solo nella totale coincidenza tra la coscienza e chi la interroga. È evidente lo sfondo sul quale Sartre costruisce l’idea di una coscienza irriflessa:
“ogni coscienza è tale solo nella misura in cui è coscienza d’esistere”11. Si va
così delineando più chiaramente il ruolo della fenomenologia che, sola, potrà
studiare l’emozione come un puro fenomeno trascendentale, in quella che abbiamo visto essere una prospettiva eidetica che cerca di cogliere l’essenza del-
167
168
l’emozione in quanto tale, rinunciando ad indagare le emozioni particolari.
Questo è un passaggio cruciale nell’analisi del pensiero sartriano perché
emerge quella doppia natura del filosofo francese, stretto tra l’incombenza di
restituire alla filosofia un ruolo chiave nell’interpretazione dell’universo umano
e quella di affrancarsi dalla dimensione accademica e fare filosofia attraverso
la moltitudine di forme espressive con le quali si misurerà nella sua vasta produzione. Da una parte il Sartre che sceglie l’indagine fenomenologica, la ricerca dell’essenza e l’emozione come tipo organizzato di coscienza, dall’altra il
Sartre che racconta le emozioni, le fa vivere attraverso i personaggi delle sue
opere letterarie e teatrali, il Sartre consapevole del limite della filosofia quando, raggiunta una qualche teoria delle emozioni, rischia di dissolvere le loro
particolarità nella costrittività di una visione strutturata. Sartre sembra percepire il rischio e trova nello spostamento di attenzione dalla prospettiva husserliana a quella heideggeriana, la strada per la compiutezza di un pensiero in grado di impedire il dissolversi di una prospettiva fenomenologica anche in presenza di una filosofia del soggetto. Heidegger, in effetti, aveva proprio tematizzato la de-assolutizzazione del soggetto e il necessario rapportarsi alle cose
del mondo, tema caro a Sartre. In questo il filosofo francese intravede quella
stessa passione filosofica verso le problematiche esistenziali e morali che porrà al centro della propria filosofia. Così tutto il discorso sulle essenze sembra
– nella scelta della prospettiva heideggeriana – lasciare il posto alla fondamentale indagine sull’uomo, la sua situazione nel mondo e l’indissolubile rapporto
con la realtà che da questo deriva. Questa posizione è ampiamente chiarita in
“Un’idea fondamentale della fenomenologia”, nella quale stabilisce il senso di
una distanza da una visione solipsistica del soggetto e dichiara la sua vicinanza alla dottrina heideggeriana che, al contrario della filosofia francese dell’epoca, ripudia l’intimismo della coscienza, riporta in primo piano le “cose” e le situazioni reali e cerca in ogni modo di tratteggiare e chiarire il rapporto del soggetto con la realtà, “un esistente rigorosamente contemporaneo del mondo e
la cui esistenza ha le stesse caratteristiche essenziali del mondo”12.
“L’assunzione di sé”, che la realtà umana implica, produce quell’autocomprensione che si attesta non come qualità che viene acquisita dall’esterno ma
come propria maniera di esistere. “Dunque – dice Sartre – sono innanzi tutto
un essere che comprende più o meno oscuramente la sua realtà d’uomo, il che
significa che mi faccio uomo comprendendomi come tale”13. Non si tratta, come lui stesso chiarirà, di una condotta introspettiva – che si risolverebbe sempre nell’incontro con i fatti – ma della ricerca di un’ermeneutica dell’esistenza,
nella consapevolezza che ogni comprensione della realtà umana è fondamentalmente oscura e inautentica. Bisogna dunque considerare l’uomo come una
totalità sintetica dalla quale partire, alla ricerca di un’analisi della natura umana che si affermi come fondativa di un’antropologia, condizione unica per qualsiasi psicologia. Rimane comunque il ruolo della fenomenologia, lo studio dei
fenomeni e la realtà come apparenza entro la quale essi si manifestano. Sartre ravvisa in Heidegger una continuità col pensiero di Husserl laddove l’esistere della coscienza coincide col suo manifestarsi. In questa prospettiva Heidegger coglie in ogni atteggiamento dell’uomo il tutto della realtà umana, ed ecco
che l’interpretazione sartriana dell’emozione, come realtà umana che si assume e si dirige verso il mondo, rappresenta quel tutto della condizione umana,
quella coscienza del mondo che è coscienza nel mondo.
È evidente che in questa prospettiva non si può concepire una coscienza
che non annoveri l’emozione, dal momento che, come afferma Sartre, “un’emozione è proprio una coscienza”14. Dunque l’emozione, come modo d’essere della coscienza, non è altro che un modo di essere nel mondo della coscienza
stessa. Dobbiamo allora chiederci se è possibile concepire un modo d’essere
nel mondo senza emozioni e se una coscienza privata di questa dimensione è
propriamente una coscienza. La coscienza è sempre emozionata?
Determinante, per poter arrivare ad una qualche conclusione, è lo scarto tra
la lettura psicologica, tesa alla descrizione dei fatti, e l’orientamento fenomenologico, che invece interroga l’emozione perché ci riveli qualcosa sull’uomo. La
fenomenologia non è interessata a ciò che è ma a cosa questo ciò che è riveli
attraverso il suo manifestarsi. Come abbiamo detto quanto ci è dato vedere della coscienza nella sua immanenza al mondo non basta a spiegarla perché lo
stato psichico è comunque un fatto e, quindi, accidentale. Quello di cui abbiamo bisogno non è una descrizione ma una determinazione di significati, esercizio proprio della fenomenologia, che considera ogni fatto umano “per essenza
significativo”. L’emozione, dunque, ha una natura significante, “essa è nella
stretta misura in cui significa”15; il suo essere fenomeno della coscienza la strappa al rischio di un riduzionismo biologico che la confinerebbe entro i limiti dello
studio dei fatti fisiologici. A partire da queste premesse e stabilito che la coscienza è sempre coscienza-di-qualcosa, porsi sul piano esistenziale significa spostare l’emozione dal tutto-della-coscienza al tutto della realtà-umana, che non ci
appare più come somma di eventi ma come requisito irriducibile della condizione umana che si realizza nella forma “emozione”. L’esistenza del singolo si determina entro l’emozione che egli assume ed “è quindi impossibile considerare
l’emozione come un disordine psico-fisiologico. Ha la sua essenza, le sue strutture particolari, le sue leggi d’apparizione e il suo significato”16.
Ma l’emozione è anche una risposta al mondo attraverso reazioni organiche
e modificazioni fisiologiche, è una dimensione della corporeità che, nell’accogliere il mondo, ne determina un’interpretazione, un grado di accettazione, un’intensità. Questo è un tema puramente bergsoniano che però Sartre non incorpora
nella sua critica alle teorie dell’epoca, eludendo in qualche modo il problema della qualità dell’emozione relativamente alle forme sensibili attraverso cui essa si
manifesta. Il problema dell’intensità e la confusione con l’estensività, che Bergson attribuiva alle forme di interpretazione dei dati sensibili, è sicuramente sullo sfondo dell’analisi sartriana giacché egli ammette l’irriducibilità della coscienza ai fatti psichici e al contempo l’impraticabilità di un’unità di misura delle emozioni che utilizzi gli stessi criteri dell’estensività (spazio-temporale).
Definire un’emozione in termini di grandezza significherebbe ammettere
NOTE
Essenza e coscienza: la natura significante delle emozioni
169
170
una scala di misura nella quale è chiara la progressione e il rapporto contenente-contenuto, così come faremmo con i numeri. Questo ci indurrebbe a ritenere che un’emozione è più grande di un’altra perché la contiene, esattamente
come il numero quattro contiene il tre. Sartre supera questo aspetto del problema nel momento in cui dota le emozioni del carattere esclusivo e irripetibile che
la loro coincidenza con la coscienza comporta. Il primato della coscienza basta, da solo, a dimostrare il limite di quelle teorie che intendano fondare la propria interpretazione su progressioni o forme causali tra alterazione fisiologica
e coscienza. Quando afferma, contro la teoria periferica, che “una madre è triste perché piange” non è altro che un’inversione rispetto a “una madre piange
perché e triste”, il filosofo francese dimostra di voler prendere le distanze da
tutti quegli approcci che considerano l’emozione come effetto di ritorno sulla
coscienza delle alterazioni periferiche dell’organismo17. Tuttavia egli ritiene che
tali modificazioni fisiologiche si verificano ma la loro similitudine non implica
una similitudine tra le emozioni. In questo Sartre precorre i tempi, quasi immaginando i possibili risvolti di un tale approccio al problema delle emozioni, in
grado di spostare l’attenzione dall’emozione come esperienza totale e totalizzante a processo descrivibile privato della sua unicità. Nella teoria delle emozioni sartriana c’è già, seppure non in forma compiuta, la questione del soggetto e del suo rapporto con le cose, la dottrina dell’intenzionalità – che non abbandonerà nemmeno ne L’essere e il nulla e nella Critica della ragione dialettica –, l’idea di una coscienza irriflessa che non esiste allo stato puro e che ha
bisogno di “proiettarsi nel mondo. Dunque non c’è nessuna “interiorità” sulla
quale riflettere ma solo una coscienza di cui farsi carico. Una coscienza che,
nell’assumere la sua forma emozionata determina la mutevolezza dello stare
nel mondo attraverso le particolari, sfuggevoli emozioni che ci governano.
Emozioni che non sono il riflesso di un mondo esterno che determina attraverso stati fisiologici uno “stato interno” ma che, nell’irriducibile dialettica con il
mondo esterno ne determinano la sua qualità. Emozioni che, magicamente,
nell’intervenire nel rapporto uomo-mondo, determinano il mondo nella direzione della coscienza “emozionata”.
Il problema dell’interiorità rinvia alle osservazioni che Sartre muove all’interpretazione psicanalitica. Se l’emozione si può comprendere solo cercando in
essa un significato, “questo significato è, per natura, d’ordine funzionale”18.
Dunque ogni emozione avrà un fine. Sartre non nega la fondatezza di un’ipotesi finalistica dell’emozione, del suo affermarsi come risposta a eventi e condizioni, in un rapporto stretto tra causa scatenante e significato dell’emozione.
Questa donna ha la fobia dei lauri. Vede un boschetto di lauri e sviene.
Lo psicanalista scopre nella sua infanzia un doloroso incidente sessuale
legato a un cespuglio di lauro. Cosa sarà dunque in questo caso l’emozione? Un fenomeno di rifiuto, di censura. Non di rifiuto del lauro. Bensì
il rifiuto di rivivere il ricordo legato al lauro19.
Malgrado risulti in tutta evidenza il rapporto tra esperienza pregressa e risposta emotiva, ciò che al filosofo francese preme dimostrare è il legame stretto che si andrebbe a stabilire tra simbolico e rimozione. “L’interpretazione psi-
NOTE
canalitica concepisce il fenomeno cosciente come la realizzazione simbolica di
un desiderio rimosso dalla censura”20. Ne risulta che, qualora ci trovassimo di
fronte ad una coscienza implicita del nostro desiderio, saremmo di fatto in malafede21, nella misura in cui la fuga da se stessi viene ricondotta alla coincidenza tra l’io che inganna (o nega) e l’io ingannato. La psicanalisi, cioè, ignorerebbe il fatto che la coscienza è sostanzialmente una e dunque, come appena detto, quel me che si vuole ingannare non può che far parte dell’io che inganna22.
Questo indica in che modo “la coscienza si costituisca come significato senza
essere cosciente del significato che costituisce”23. Emerge chiaramente da
queste posizioni il rifiuto del filosofo francese di qualunque teoria dell’inconscio
che, appunto, gli farà successivamente dire: “La psicanalisi non ha princìpi,
non ha basi teoriche: è naturalissimo che s’accompagni – in Jung e in certe
opere di Freud – a una mitologia perfettamente inoffensiva”24. Non è un caso
che Sartre, in Idee per una teoria delle emozioni, citi Steckel, psicanalista che
aveva rifiutato la nozione freudiana di inconscio e che, pur riconoscendo una
dimensione causale dell’emozione, appare agli occhi di Sartre più credibile poiché supera (non riconoscendone un piano oggettivo) quella dicotomia della
simbolizzazione che il filosofo francese ravvisa nella psicanalisi. Sartre, infatti,
riconosce un’analogia tra il fatto cosciente e ciò che esprime, in altre parole: la
simbolizzazione è costitutiva della coscienza simbolica. Ciò nonostante, e malgrado questo sia un aspetto fondamentale della psicoanalisi, se la simbolizzazione è costitutiva della coscienza inevitabilmente la coscienza si costituisce
come simbolizzazione.
Quello che Sartre si chiede è come sia possibile stabilire un legame di causalità nella genealogia dell’emozione e, allo stesso tempo, un modello di comprensione tra i fenomeni studiati. La riduzione delle diverse condizioni entro cui
il femonemo psichico si configura alla serie di rapporti trascendenti i fatti studiati rappresenta, per Sartre, la contraddizione fondamentale della psicoanalisi e ne definisce il limite. Non vi è possibilità di cogliere la specificità del fenomeno se tale fenomeno diventa un elemento di conoscenza in forza della sua
apparizione; vale a dire che se si attribuisce ad un atto un significato (entrare
in un vagone in sogno corrisponde a compiere un atto sessuale), questo significato annulla il potere significante dell’esperienza soggettiva, inducendo lo psicanalista a leggere il fenomeno individuale attraverso la rete di interpretazioni
strutturate che egli si è dato.
Tutto questo appare immediatamente inconciliabile con l’idea di una coscienza irriflessa, che Sartre ha posto a fondamento delle sue argomentazioni psicologiche: “è la coscienza che si fa essa stessa coscienza, commossa per i bisogni di un significato interno”25. Consapevole delle obiezioni a cui una tale prospettiva si espone, ne anticipa le risposte ribadendo la necessità di sbarazzarsi
di un’idea che vuole una coscienza che, nell’organizzare le proprie emozioni come risposta al mondo, è anche in grado di cogliere tale adeguamento. Una coscienza dell’emozione riflessiva che, nell’ottica psicanalitica diventa passibile di
un controllo che ci mette nella condizione di padroneggiare la paura o frenare la
nostra collera, è l’annullamento stesso del riconoscimento di un nostro proprio
essere psichico, poiché questo stato viene ad essere modificato dall’emozione
171
172
come fatto di coscienza primitivo ma sganciato dalla coscienza in quanto tale.
Tuttavia è possibile riconoscere l’emozione come un modo di essere della coscienza e attribuirsi uno stato (essere in collera, avere paura, sentirsi tristi ecc.)
ma lo scarto tra la posizione sartriana e quella psicanalitica risiede nel fatto che
il filosofo francese rifiuta una coscienza-di-aver-paura che precede la paura stessa nell’ottica di una separazione o di una propedeuticità dimostrabile.
L’emozione non può essere separata dal suo oggetto e ripiegarsi in se stessa, non può essere concepita al di fuori dell’aver paura di o del sentirsi tristi
per. Tanto l’oggetto della paura quanto quello della tristezza rimangono costantemente presenti nell’emozione e in ciò che essa produrrà (la fuga, il silenzio
ecc.), come afferma Sartre: “il soggetto commosso e l’oggetto commovente sono uniti in una sintesi indissolubile. L’emozione è una certa maniera di cogliere il mondo”26.
Si comprende la necessità del filosofo francese di inquadrare la teoria delle emozioni all’interno del più vasto e complesso disegno filosofico riguardante la coscienza e che compiutamente si realizzerà ne L’Essere e il nulla ma,
seppure all’interno di una struttura argomentativa già ricca e articolata, i rilievi
alla psicanalisi sembrano soffrire di una necessità di rigore metodologico che
esclude interpretazioni meno radicali e che farebbero della psicanalisi un terreno di riflessione più facilmente “assoggettabile” al ragionamento filosofico.
Altre letture, a cominciare da Lacan, hanno offerto percorsi di riflessione diversi in cui la proposta freudiana viene interpretata come una pratica che si sostanzia prioritariamente nel discorso, sicuramente meno inclini alla traduzione
dei postulati psicanalitici in categorie filosofiche ma non per questo meno serie e ricche di spunti di riflessione che un grande progetto di interpretazione
dell’uomo come quello freudiano comunque meritava.
Ciò nonostante la proposta di Sartre mantiene la sua coerenza con i princìpi che la ispirano: l’idea di una coscienza irriflessa, un essere umano che si
realizza nell’esistenza e che nell’esistenza costruisce il suo rapporto col mondo, la ricerca di significati oltre i fatti descrivibili, l’unicità del mondo nel suo
essere colto dalla coscienza, l’emozione come modo di essere della coscienza. Inevitabile la critica alla psicanalisi, forse feroce, forse irrispettosa dello
spazio che questa si era ritagliata nel dibattito del tempo ma Sartre teme qualunque de-responsabilizzazione del soggetto nel suo rapporto col mondo e,
più di ogni altra cosa, lo preoccupano tutte quelle teorie riflessive, fuori dalla
dimensione pragmatica dell’esistenza, che si offrano all’uomo come alternativa alla sua condizione reale, prospettandogli l’esistenza di parti oscure e indefinibili entro le quali egli viene dissolto o, per pura convenienza, vi trova rifugio.
Intenzionalità e magia: lo sguardo emozionato sul mondo
L’irriducibilità della coscienza ci offre un mondo delle emozioni entro le quali l’uomo si comprende e si realizza, non uno stato o una condizione da governare ma una trasformazione del mondo.
Una trasformazione che va interpretata alla luce di quanto detto fino ad ora,
cioè concepita come un tutto entro il quale il soggetto è imprigionato, una tensione che non può essere considerata cosciente in quanto tale, proprio perché
in quel caso diventerebbe oggetto di una riflessione. Si tratta di un mutamento dell’atto intenzionale, che ci permette di vedere una cosa nota in una luce
nuova o una cosa nuova che non avevamo visto (o non eravamo riusciti a vedere) prima di allora. In questo modo si cerca di conferire una qualità, uno spazio entro la propria visione del mondo, una modificazione dei rapporti tra il corpo e il mondo, perché quest’ultimo cambi le sue qualità. Il corpo è ciò che la
coscienza dirige, non un mediatore ma una presenza irrevocabile, l’unica pensabile entro questa dialettica nella quale il rapporto con l’oggetto diventa la trasformazione magica dell’oggetto stesso: il “desiderio” o il “disgusto” determinano la qualità dell’oggetto davanti a me nel modo in cui si attestano come emozioni e non come conferimento razionale di una qualità.
Dunque il disgusto o il desiderio come condizioni esperenziali della coscienza e non come attributo di un processo o di fatti. Se la realtà è come ce la rappresentiamo, la coscienza è il mezzo attraverso cui questa rappresentazione
si realizza. Le emozioni, dunque, sono una rappresentazione del mondo in
quanto modificazione della coscienza, e questa trasformazione è tanto più magica quanto più coincide con la capacità soggettiva di vedere, interpretare e costruire il mondo in una luce propria. Questa neutralità del mondo, al quale attribuiamo soggettivamente significati, dipende in buona parte dalla nostra capacità di depotenziare gli oggetti della nostra vita carichi di contenuti affettivi.
L’uomo sperimenta spesso il desiderio di “appartarsi”, sottrarsi alle richieste del
mondo popolato di impegni, responsabilità, cose da compiere. Non è raro trovarsi nella condizione di aver perduto i mezzi o le capacità per rispondere a tali pressanti richieste, così, piuttosto che trovarne o organizzarne di nuovi si risponde con la soppressione dell’obbligo, rinunciando a rispondere attraverso
nuove soluzioni o nuove vie. In una parola si risponde con la tristezza, emozione in grado di neutralizzare il mondo, la sua realtà affettiva, così da sostituire
l’impossibilità di dare risposte con una nuova situazione, invertendo la condizione di partenza e facendo sì che il mondo non esiga più nulla da noi. Centrale negli argomenti sartriani il ruolo della tristezza, questo appartarsi, questa
posizione di ripiego che ci protegge dalla terrorizzante monotonia del mondo,
questa immensità che lui stesso definisce melanconica28. Nella tristezza è evidente la capacità magica di trasformazione del mondo tanto quanto nella collera risiede la dimostrazione della sua funzionalità.
Il nostro corpo, utilizzato come mezzo d’incanto, conserva però la capacità di
falsificare le emozioni trasformandole in “modi di condotta” quando dichiara, at-
NOTE
Quando le vie tracciate diventano troppo difficili o quando non scorgiamo
nessuna via, non possiamo più rimanere in un mondo così pressante e
così difficile. Tutte le vie sono sbarrate, eppure bisogna agire. Allora tentiamo di cambiare il mondo; cioè di viverlo come se i rapporti delle cose
con le loro potenzialità non fossero regolati da processi deterministici, ma
dalla magia27.
173
174
traverso l’esteriorizzazione, l’opposto di ciò che si prova realmente. Questa falsificazione è, agli occhi di Sartre, una prova ulteriore del carattere in precedenza
descritto delle emozioni giacché, proprio in questa consapevolezza, in questa finzione, rileviamo una capacità scenica, una commedia che non ha nulla a che vedere con il mondo emotivo, “è una gioia falsa, ricordandoci che la falsità non è
una caratteristica logica di certe proposizioni, ma una qualità esistenziale”29.
Emergono chiaramente i temi ispiratori della ben nota teoria della malafede
sartriana, la separazione della mimica come proprietà tipica dell’attore dalla simulazione come caratteristica peculiare dell’inautenticità. Colui che recita assume una condotta finalizzata a rappresentare l’emozione ma l’inautentico è
colui che simula un’emozione, assume un atto volontario nel quale la finalità
non è fittizia come nel lavoro recitativo. “La vera emozione è ben altro: vi si aggiunge la credenza. Le qualità intenzionate sugli oggetti sono colte come vere”30. Ciò significa, come Sartre stesso ammette, che l’emozione è subita, impossibile fermarla o uscirne sulla base di una decisione, la sua comparsa, come la sua scomparsa, non dipendono da noi. In questa condizione la dimensione della corporeità assume tutto il suo senso come esperienza fisiologica
dell’emozione, esperienza che non può essere isolata – come avrebbe voluto
la teoria periferica – e comunque non può essere ridotta a modi di condotta: “si
può cessare di fuggire ma non di tremare”31. Dunque l’emozione è anche il
comportamento di un corpo in un certo stato, cosicché un comportamento senza uno stato emotivo diventa semplice commedia.
Questo passaggio, a una prima analisi, appare piuttosto fragile poiché se
ammettiamo una condizione della coscienza non emozionata dobbiamo, per il
motivo che ne discende, immaginare un corpo che non subisce sempre l’emozione. La commedia, come dimensione del falso e dell’inautentico ci indurrebbe a credere che tutti i modi di coscienza alternativi a quello emozionato siano, appunto, falsi e inautentici. In verità il solo fatto di ammettere diversi modi
della coscienza – basti pensare alla percezione o alla coscienza dell’immagine32 – dimostra che Sartre non pensava all’assenza di emozione come al prefigurarsi della commedia ma certo gli argomenti a sostegno dell’ipotesi di una
diversa intenzione del corpo rispetto alla coscienza parrebbero contenere una
contraddizione irrisolta. Ciò che il corpo produce è l’effetto di ciò che la coscienza subisce e quindi questa diversa intenzione si risolve in una sorta di
nuova coerenza che non è relativa allo stato di coscienza ma all’intenzione razionale, “esistenziale” del soggetto. È proprio nella finzione che l’emozione si
annulla, l’inautenticità è propria dell’emozione quando questa risulta falsa nelle sue dimostrazioni o vive nella doppia natura di un corpo che non incarna
l’emozione che la coscienza assume. In altre parole, bisogna tener presente
questa duplice condizione del corpo che è vissuto della coscienza e oggetto
nel mondo. Così senza la “credenza” – unico fenomeno in grado di costruire
un nuovo mondo alla coscienza, la coincidenza tra il sentire (proprietà tipica
dell’emozione) e il provare (proprietà tipica del corpo) – non verrebbe a prefigurarsi, e il mondo magico dell’emozione entro cui la coscienza si “precipita”
completamente determinando un nuovo e spesso inatteso punto di vista sul
mondo, non si realizzerebbe.
NOTE
Sartre mutua il concetto di “magico” da Alain33 e lo interpreta come sintesi
di spontaneità e passività, il tutto all’interno di quella coscienza che si degrada
in modo irrazionale, trascinata da un punto di vista, una posizione e una prospettiva sul mondo. Il passaggio ulteriore, quello di una classificazione delle
emozioni in cui si propone di distinguere un’emozione nella quale c’è un soggetto che costruisce la magia del mondo e, viceversa, un mondo che si rivela
improvvisamente come magico, presenta molti limiti e sorprende che Sartre,
consapevole che tale classificazione è irrispettosa dell’impianto concettuale da
lui proposto, pur considerandola approssimativa, non si curerà mai di rettificarla e ampliarla a beneficio delle ipotesi formulate.
Ciò detto, il merito di Sartre è quello di prefigurare un punto di vista che, nell’offrirsi in controtendenza alle prime timide ipotesi biologiste e costruttiviste, affermava la necessità di attribuire significati e funzioni a un aspetto centrale delle esperienze esistenziali. Contro qualunque riduzionismo, l’interpretazione
sartriana difende, nella pluralità delle esperienze emotive, la singolarità dei
soggetti che le vivono. Dunque non “la” coscienza ma “le” coscienze, in una
moltitudine di rapporti con il mondo e con le emozioni; non un processo biologico intriso di una causalistica determinazione del mondo sensibile ma una
coincidenza dell’esperienza emotiva con la dimensione corporea del soggetto.
Questa coscienza irriflessa restituisce all’emozione una natura ontologica e irriducibile agli stadi fenomenici e determina una prospettiva che non ha perduto la sua pregnanza filosofica né la ricchezza di argomenti alternativi a gran
parte delle interpretazioni contemporanee. La coscienza è, senza alcuna timidezza, trattata da molti come un parametro sperimentale34, da altri come condizione dualista nella quale la mente cosciente si interfaccia al cervello attraverso “psiconi” che comunicano con “dendroni” localizzati nell’area sinistra del
cervello35, da altri come “processo” e, per questo, elemento che rientra nell’esclusivo territorio dell’indagine scientifica36. Non mancano approcci che, seppure articolati e ricchi di spunti di interesse, riconducono il rapporto tra emozioni e coscienza sempre e comunque all’interno della possibilità e capacità dell’uomo di trasferire nella dimensione empirica tutta la ricerca di significati loro
attribuibili37, sovrapponendo la descrizione di fatti e la chimica dei fenomeni, alla natura profonda e significante delle emozioni. Se tali approcci saranno in
grado di spiegarci eventi neuro-biologici nulla ci dicono sul rapporto uomomondo che a queste spiegazioni non è riducibile.
Dunque in presenza di un percorso che si prefigura non esaustivo per la costruzione di un’adeguata teoria delle emozioni, è giusto affiancare la forza di
apparati speculativi che, come quello sartriano, si pongono come scopo primario quello di indagare l’uomo nei suoi rapporti profondi col mondo, includendo,
in una qualche misura, fenomeni esistenziali in grado di sovvertire, falsificare,
alterare questo stesso rapporto. Caratteristica comune di questi percorsi, invece, è quella di essere attraversati da un desiderio di oggettivazione scientifica
che, nella stabilità delle conoscenze, strapperebbe ad ognuno il senso della
propria unicità privandoci non già della magia in quanto tale ma della possibilità di contemplarla nel nostro vissuto.
Il neo-riduzionismo restituisce a Sartre quello che il suo stesso riduzionismo
175
176
della “ragion-pratica” restituì alla “intuizione” bergsoniana: la necessità di recuperare dimensioni speculative che contengano prospettive articolate e arricchite dal desiderio di dotare le esperienze umane di significati e l’uomo di capacità per cercarli.
Tutto questo induce ad alcune conclusioni. L’idea della trasformazione – e
della natura “magica” che Sartre ad essa attribuisce – implica un doppio orientamento dell’uomo di fronte a ciò cui assegna un valore o una “verità”.
L’elaborazione razionale del vero (ad es. una legge scientifica) non è uguale
all’elaborazione soggettiva del vero (ad es. “ho fatto del male a Maria”). Qualora
le emozioni non fossero quelle che Sartre ci descrive, le due esperienze, sotto
forma di interiorizzazione razionale, sarebbero equiparabili per il semplice fatto
che, nell’esperienza col mondo, il soggetto le considererebbe appartenenti alla
stessa categoria (il vero). L’elaborazione (intesa come interiorizzazione) di una
verità provata e condivisa, implica un sostanziale accordo con il mondo, che si
realizza in un sistema di segni convenzionali attraverso i quali si dota di significato quel particolare oggetto di interesse. In questo caso il linguaggio, nelle sue
forme strutturate di comunicazione col mondo, determina in massima parte il percorso entro cui si perviene tanto alla conoscenza quanto all’accordo su di essa.
In un certo senso, la dimensione razionale dell’elaborazione di una conoscenza,
pur non escludendo un ruolo delle emozioni, ne determina un senso indipendentemente da esse, ammettendo, per così dire, un ruolo solo marginale delle emozioni che risultano comunque controllabili attraverso le forme dell’analisi razionale, risultando così in buona parte ininfluenti sul risultato finale.
Tutto ciò che è vero per me, invece, ingloba il complesso di emozioni entro
cui pervengo a tale “verità” come ciò che sento e che non ha bisogno di un linguaggio comune ma, anzi, lo sovverte attraverso l’unicità della natura delle
emozioni di ognuno. Il significato che in questo caso attribuisco al “vero” lascia
aperta la possibilità dell’indagine razionale ma non la contempla. Anzi, in questo caso è proprio il sistema di segni socialmente codificato che viene messo
in crisi, relegato ad una marginalità estrema come se non fosse parte integrante del modo in cui interiorizziamo un significato.
L’importanza dell’ipotesi sartriana risiede proprio nel rilevare la vicinanza
della conoscenza alle emozioni dando, a queste ultime, il compito di esaltarne
gli aspetti più immediatamente significativi, così da lasciarci intendere che solo in questa operazione di trasformazione il mondo assume un senso, diventa
– oltre che rappresentazione – sistema di segni e valori, contenitore e contenuto, al contempo, della fondamentale funzione percettiva dalla quale ogni
analisi della condotta umana deve partire. È una validazione del ciò che sento, in anticipo sul rischio – e i nostri tempi lo rivelano – di un primato della ragione esasperato nelle sue forme più estreme. Ma non è – come erroneamente si può pensare – un “sentimentalismo” vuoto e incantato, proprio perché
manca di quell’approccio assiologico che farebbe pensare ad una categorizzazione delle emozioni, distinguendole per grado, dalla migliore alla peggiore.
Sartre non incorre mai in questa tentazione, lasciando intravedere in che modo il sistema di valori che l’uomo attribuisce alle emozioni, si affermi come una
grammatica indipendente e successiva alle emozioni stesse.
1 J.-P.SARTRE, Esquisse d’une théorie des émotions, Editions Scientifiques Hermann, Paris
1939, trad. it. Idee per una teoria delle emozioni, Bompiani, Milano 2004, p. 157.
2 S. DE BEAUVOIR, L’età forte, trad. it. Einaudi, Torino 1961, p. 42.
3 J.-P. SARTRE, op. cit., p. 157.
4 Ivi, p. 158.
5 Ivi, p. 159.
6 Ivi, p. 160
7 Ibidem.
8 La recensione apparve sul Journal de Psychologie normale et pathologique, fondata e diretta da Janet e Dumas. Al primo si deve l’introduzione del concetto di “condotta” come comportamento intenzionale, in contrapposizione alla nozione di comportamento molecolare del primo comportamentismo nordamericano.
9 Cfr. J.-P. SARTRE, Un’idea fondamentale della fenomenologia di Husserl: l’intenzionalità, in
Che cos’è la letteratura?, trad. it. Il Saggiatore, Milano, 1960.
10 Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 160.
11 Ivi, p. 161.
12 Cfr. Un’idea fondamentale della fenomenologia di Husserl, cit., p. 281.
13 Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 162.
14 Ivi, p. 163.
NOTE
Le emozioni non includono la realtà ma la sovvertono, la esasperano, la
“trasformano”, appunto, attraverso una magia che non è il risultato ma il senso stesso di questa trasformazione.
Con una solo apparente forzatura si può sostenere che in questo particolare argomento Sartre conservi tracce di un naturalismo che riconduce a quel
rapporto, citato in apertura di questo lavoro, con una filosofia permeata di confluenze, nelle quali si incontra Gide e Bergson, ma anche Nietzsche. Non dimentichiamo che le Idee sono contemporanee de La nausea, testo infarcito di
un nietzscheanismo che si respira attraverso la visione di un uomo isolato e
lontano dalle masse, che vive l’ossessione e l’orrore per un mondo nel quale
gli uomini nascono liberi ma vengono aggregati e inquadrati. Le emozioni contengono quelle tracce di puro ateismo che Sartre, nel tessere le lodi di Gide, si
attribuiva come una sua personale avventura. Un ateismo nascosto tra i mille
rivoli di un’esperienza umana che è in primo luogo ricerca e solitudine, in cui
la forza propulsiva delle emozioni dà al soggetto un ruolo e una possibilità,
mettendolo di fronte alla sua unicità, che è insieme disordine e potenza, condizione e aspirazione. Ecco perché a Sartre non poteva che sembrare sospetta e grossolana quella psicoanalisi che si stava imponendo e affermando come un codice di interpretazione colmo di simbolismi e toni profetici. Rimane, di
quest’opera, il valore di un’intuizione a cui è stato dato poco seguito ma che
conserva spunti che non appaiono ancora completamente esauriti nel dibattito
che ad esse è seguito. Forse meritano, soprattutto alla luce delle odierne discussioni, maggiori approfondimenti i temi legati alla nozione di coscienza o al
ruolo della psicoanalisi ma, nondimeno, quelli connessi al rapporto tra emozioni e conoscenza, che restituirebbero alle ipotesi sartiane il vigore necessario
per una loro obiettiva rivalutazione.
177
Ivi, p. 164.
Ibidem.
17 Sartre ingloba, in questa critica, la teoria periferica di James e Lange e quella centralista di
Cannon e Bard e, in ogni caso, tutte quelle interpretazioni che, come la teoria intellettualistica,
stabiliscono una successione costante tra stato interno e turbe fisiologiche limitandosi semplicemente ad invertire (come nel caso della teoria periferica) tali successioni.
18 Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 178.
19 Ivi, p. 180.
20 Ibidem.
21 La relazione tra desiderio, coscienza e malafede è argomento che Sartre chiarisce e approfondisce ne L’essere e il nulla, in particolare nel capitolo introduttivo (Introduzione alla ricerca dell’essere) e nel capitolo I (Il problema del nulla). In particolare i temi della prova ontologica e quelli della malafede vengono utilizzati dall’autore per dimostrare tanto la fragilità delle ipotesi di coscienza come pre-costituita al mondo, quanto quelle di un essere umano incapace di assumere atteggiamenti negativi per sé stesso.
22 L’Essere e il nulla, trad. it. il Saggiatore, Milano 2002, pp. 88-89.
23 Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 181.
24 Critica della ragione dialettica, trad. it. di P. Caruso, Il Saggiatore, Milano 1963, vol. I, p. 55.
25 Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 183.
26 Ivi, p. 184.
27 Ivi, p. 188.
28 È utile ricordare che Melancholia era il titolo originario del romanzo La Nausea.
29 Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 196.
30 Ivi, p. 197.
31 Ibidem.
32 Cfr. L’immaginazione, trad.it., Bompiani, Milano 1962.
33 In diretta polemica con l’idealismo e il romanticismo, Alain (pseudonimo di Émile-Auguste
Chartier) aveva sviluppato temi sulla ineliminabilità di dati oggettivi da parte del pensiero e aveva
proposto un concetto di magico come “spirito trascinante tra le cose”.
34 Si veda in proposito J.B. BAARS, Inside the theater of consciousness. The workspace of the
mind, Oxford University Press, New York 1997.
35 Ipotesi riconducibile a J. E. ECCLES, A Unitary Hypothesis of Mind-Brain Interaction in the cerebral Cortex, in “Proceedings of the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences”,
1990, 240, pp. 433-451.
36 G. M. EDELMAN, G. TONONI, Un universo di coscienza, Einaudi, Torino 2000.
37 Un’indagine in questa direzione è stata condotta da A. R. DAMASIO, Emozione e coscienza,
Adelphi, Milano 2000. Il neurologo portoghese-americano tenta, dopo aver costruito una teoria della coscienza come “consapevolezza”, di coniugarla a una teoria del sé, affidando all’emozione il
compito di collante o, se si vuole, di mediatore privilegiato, in grado di “scoprire” la coscienza nelle sue forme possibili. Non mancano nelle ipotesi formulate dall’autore, i relativi agganci alla dimensione anatomica e ai fenomeni mentali descritti attraverso casi clinici.
15
16
178
LA RIPETIZIONE E LA NASCITA.
STORIA DELLA FILOSOFIA E PSICOTERAPIA
Nel panorama attuale degli studiosi che si occupano di filosofia e psicoterapia Armando ha un posto di rilevo. Egli ha potuto proficuamente svolgere le
sue accurate ricerche inerenti ai rapporti che legano le scienze umane, la storia e la psicologia grazie alla sua duplice formazione filosofica e psicoanalitica:
ha conseguito tra l’altro una laurea in filosofia, nel 1961, ed è stato membro
della SPI (Società Italiana di Psicoanalisi) sino al 19761. Ha insegnato Psicologia, Storia della Psicologia, Psicologia dinamica, Psicologia generale e Psicologia delle comunicazioni, per oltre un trentennio, in varie Università italiane.
Nel 2004 ha raccolto e pubblicato, in un unico volume2, i suoi principali scritti brevi, tra cui alcuni inediti, che trattano importanti aspetti della storia della filosofia e psicoterapia intitolato: La ripetizione e la nascita. Scritti di storia della
filosofia e della psicoterapia (1961-2004).
In questo articolo sarà presa in considerazione quest’opera di Armando soffermando l’attenzione in modo particolare su alcuni capitoli che, a mio avviso,
stimolano il dibattito attuale inerente ai rapporti tra filosofia e psicoterapia dopo anni di oblio.
Il volume rispecchia la storia personale dell’autore protesa negli studi e nel
perseguire un “ideale” di essere nel mondo che si riflette, per quanto possibile,
nella sua declinazione esistenziale. Con questo termine si vuole alludere al lavoro che l’autore dedica allo studio della realtà umana, volto ad esprimere un’esistenza che non sia caratterizzata solo da una semplice presenza, ma anche da
una possibilità di essere sorretta da una ricerca “storica”. Storia del nostro essere in rapporto con gli altri ma, anche, storia del nostro mondo in cui questo rapporto è inserito e, soprattutto, storia dei significati del nostro “essere” e del nostro “esistere” con gli altri. In altre parole si tratta della ricerca del senso della nostra vita. L’“esistere”, per l’autore, è proprio l’ex-sistere 3 cioè il “venir fuori” dopo
essere stato dentro qualcosa di storicamente determinato e che si esprime in
maniera significativa in un “essere gettato”, passionalmente, nel mondo. E questo esistere, per essere tale, presuppone un’attribuzione di senso, dopo aver incontrato le cose “in carne ed ossa”, per dirla in termini husserliani.
Le ricerche e gli studi che l’autore raccoglie in questo libro, tendenzialmente inseparabili dal suo modo di essere nel mondo, riflettono, appunto, questo
assunto; di conseguenza i processi di conoscenza e scientifici in esso contenuti procedono dal “noto all’ignoto”4. Non sembra esserci molto spazio per il
costruzionismo (o costruttivismo), forse perché, per l’autore, esso si allontana
dalla realtà delle cose, giacché non le incontra in un rapporto esperienziale,
appunto “in carne ed ossa”, e nemmeno nel loro evolversi storico.
NOTE
di Francesco Tarantino
179
180
Posto che questa premessa sia valida, e che rispecchi l’essenza di questo
testo, allora non è difficile coglierne il senso.
L’autore, innanzitutto, nel presentare il lavoro, ringrazia il direttore della collana, Nicola Lalli 5, in cui è inserito questo volume per aver evitato che gli scritti contenuti in esso fossero “consegnati prima del tempo all’inesistenza”. Già in
questa prima frase, è possibile riconoscere la vitalità di tali scritti. La “presenza” di questo volume, evidentemente, vuole rappresentare qualcosa di più di
una semplice forma apparente che si porrebbe solo in termini esistentivi, cioè
riferiti per esempio al suo essere materiale o in senso statico. Esso, se ben
compreso, stimola la problematizzazione della realtà, nella prospettiva esistenziale, che circonda il nostro essere con gli altri, per farci procedere verso un
processo di conoscenza dove l’“attuale” si pone senza soluzione di continuità,
con i suoi momenti (passati) storico-reali.
In altre parole gli scritti che costituiscono il volume, solo apparentemente diversi tra loro, stimolano un “vedere-sapere” che tende a disvelare i contenuti al
di là del significato esplicito e diretto. Il loro presentarsi, ai nostri sensi, ci sembra annunciare significati che escludono una semplice apparenza: è un libro
che tende a riportarci alla realtà storica delle cose, ci legge dal suo interno
giacché i momenti storici non possono essere scissi dai loro soggetti-attori e
quindi dalle loro emozioni cui partecipa anche la passionalità dello storico che
li comprende e li descrive al di là di una possibile (o “presunta”) oggettività
scientifica. In altre parole, la sua lettura, o “leggibilità” (légere = raccogliere,cogliere), stimola ad intuirne i significati oltre le forme letterarie ed espositive in
cui si manifestano. Così il significato del titolo stesso è fortemente presente, direttamente o indirettamente, in tutti i capitoli. Questi tracciano, oltre ad una “fenomenologia”, anche una storia della “ripetizione” ed in particolare mostrano
come movimenti culturali, in senso ampio, avrebbero dovuto portare a nuovi
cambiamenti finalizzati alla realizzazione umana, quale ideale di uguaglianza
degli uomini nella loro diversità, ed invece hanno proposto come nuovo ciò che
avevano combattuto come vecchio. Cioè la ripetizione del vecchio è proposta,
secondo Armando, addirittura come “finzione” del nuovo.
Quali sono questi “movimenti” che riproporrebbero il nuovo ed invece ne ripropongono solo una finzione? Essi si rapportano ai temi più importanti nel nostro essere, che riguardano la nostra vita, la nostra storia, il nostro modo di conoscere la realtà, di fare cultura, politica e cosi via. È opportuno elencarli con
le stesse parole dall’autore6 poiché si riferiscono allo stesso fenomeno ripetitivo, evidenziando come:
l’esaltazione umanistica della dignità dell’uomo riproponga il pensiero medievale della vanità del mondo, il discorso freudiano sull’inconscio una versione dell’idea religiosa del peccato originale, come la psicologia sperimentale sia una continuazione dell’idealismo, lo sperimentalismo di Dewey e la
sua concezione della democrazia una maschera per l’integralismo religioso, come la critica kantiana al visionarismo si risolva in un visionarismo della ragione, la rivolta esistenzialista rifluisca nel rispetto talora violento della
tradizione e la difesa marxista del proletariato riveli di fondarsi sull’assunzione acritica del presupposto della continuità dell’uomo natura.
NOTE
Ciò che l’autore di questo volume critica, è proprio il fallimento delle grandi
rivoluzioni sociali e culturali che, anziché pervenire ad un progresso umano e
scientifico, si sono risolte talora in una riproposizione di quanto combattuto; come se le rivoluzioni storiche avessero ricalcato le “rivoluzioni”, per così dire,
“orbitali” dove, appunto, si ritorna sempre sullo stesso punto di partenza, girando su sé stessi. Ciò che nei periodi di cambiamento epocale c’era di autenticamente nuovo e positivo è stato poi affossato dalla spinta di inerzia che ha riproposto il vecchio; con l’aggravante di essere proposto come nuovo in quanto ne riportava le apparenze che, nondimeno, rimandavano ad un’assenza del
nuovo stesso.
L’autore, tuttavia, non si ferma solo al fenomeno della ripetizione, ma indica anche il suo antidoto. Esso è rappresentato dalla nascita. Tuttavia, per Armando, la nascita non basterebbe. È necessario uno sviluppo sano di essa,
cioè è necessario un prendersene cura nel tempo, che richiama il tempo storico. È necessario che chi cura la nascita abbia presente la storia del passato in
quanto essa può fermare la ripetizione e promuovere lo sviluppo del nuovo. Insomma non basta nascere, è necessaria una cura di ciò che è nato che può
svilupparsi all’interno di un rapporto sano. Tale tema, pertanto, è un motivo
conduttore di tutto il libro. È l’“anima” stessa di questo scritto.
L’autore ritiene che la nascita debba rapportarsi alla “teoria della nascita” di
M. Fagioli la quale si fonda nel superamento del freudismo7. Tale teoria ha come nucleo fondamentale la “fantasia di sparizione”, il cui concetto è stato formulato nel volume dello stesso Fagioli edito nel 1972 intitolato “Istinto di morte e conoscenza”8, mentre l’“analisi collettiva” rappresenterebbe la “prassi” di
tale teoria9.
L’autore, tuttavia, pur non rinnegando né il valore della suddetta “teoria della nascita”, né l’arricchimento, affettivo e personale, derivatogli dall’incontro
con essa, critica, invece, sino al punto di prendere le dovute distanze, forse definitive, la prassi che essa mostra di seguire in questi ultimi anni, poiché, secondo lui, tenderebbe ad obbedire ai meccanismi della “ripetizione”.
Tra gli scritti proposti due a mio avviso, sono particolarmente significativi e
cioè “L’esistenzialismo e il problema del punto di vista della storiografia” e
“Considerazioni di un esegeta pigro. Sugli sviluppi dell’analisi collettiva dopo il
1996”. Il primo, che apre il libro ed è datato 1961, è una specie di DNA che contiene, metaforicamente, la mappa genetica dello sviluppo del pensiero di Armando. Il secondo, che compare come penultimo capitolo, traccia un bilancio
della ricerca dell’autore e soprattutto una critica della prassi sopra citata.
Il primo è fondamentale per capire l’intero impianto dell’opera per diversi
motivi: 1) rappresenta la fase iniziale della ricerca di Armando, 2) costituisce
un manifesto programmatico della sua ricerca, 3) espone il suo metodo d’indagine.
È opportuno soffermarsi su questo capitolo, fortemente attuale nonostante
sia del 1961, per capire come si sviluppano i temi della “nascita” e della “ripetizione”. L’autore vi critica la concezione sartriana della storia dove il “nulla” è
la meta dell’esperienza umana riportando tale concezione a un “…non vedere,
piuttosto che vedere il nulla…”10. D’altra parte il nulla identificato nel “non ve-
181
182
dere” (vedere è anche sapere) è determinato da un’incapacità di aprirsi alla
concretezza, cioè alle cose.
Armando11 oppone alla visione del nulla di Sartre, in quanto “negatività pietrificata”, una “negatività creativa”. Essa si nutre del senso dell’incompletezza
del nostro essere e conoscere. Parafrasando Husserl12, si potrebbe dire che risulta in un’intuizione che è un andare verso le cose (il motto di Husserl è: “zu
den sachen selbst!”), verso le forme stesse della realtà al di là delle apparenze. Insomma è il percorso solito di Armando, come già sopra esposto, di procedere, storicamente, da ciò che è manifesto a ciò che invece è sconosciuto;
e il primo non può che rappresentare una semplice apparenza che resta tale,
oppure un’apparenza che segnala qualcosa d’altro da ricercare o, ancora, una
forma apparente che scompare nel momento in cui segnala qualcosa da ritrovare.
Il processo di conoscenza storica o filosofico-storico per Armando rifugge
non solo da una visione hegeliana (idealistica) o razionalistica, come già detto, ma anche neo-positivistica e marxista. Peraltro la concezione marxista (materialismo storico) della storia, secondo l’autore, è fuorviante nella misura in cui
parte dal presupposto della contiguità natura-cultura. A tal proposito è chiarificatore il capitolo 10° (“Una critica a Marx negli anni 1976-1985”) cui accennerò più avanti. Egli, tuttavia, rifugge anche da una concezione della storia che si
rifà al “criticismo” o “neo-criticismo” e al pensiero filosofico da esso derivato. Il
capitolo 11°, dedicato a Kant, è fondamentale per capire la distanza del nostro
autore dalle forme di psicoterapia provenienti dal “costruttivismo”. Egli naturalmente non riduce, sic et simpliciter, la filosofia a storia giacché questa deve essere letta prendendo da essa una distanza che, appunto, può essere facilitata
dalla comprensione filosofica. Forse si avvicina alla concezione (sociologica)
storica di Weber, o addirittura a quella ermeneutica gadameriana (orizzonte
storico); ma poi non tanto, poiché Armando segue un suo percorso originale.
Egli infatti ritiene che situando i fatti storici reali in una rappresentazione “lineare”, l’esito sarà differente dalla “linea” stessa e dagli elementi che l’hanno
composta poiché la storia, più che un “legame” tra passato presente e futuro,
sarà il “presente” stesso13. Naturalmente, egli non pensa che ciò porti ad una
comprensione storica complessiva, ma che l’inserimento in essa di tale modalità interpretativa figurativa lineare potrà darle un significato originale, se vogliamo creativo di un senso più rispondente alla realtà, tale da renderla più
chiara e significativa. Ugualmente la ricostruzione storica non è mai semplice
perché pone il problema dell’interpretazione che può coincidere o meno con
l’esaltazione di alcuni momenti storici se non di un’intera fase storica oppure
con la sua degradazione; da ciò deriva la conseguenza che “…ognuno si fa la
sua storia”, ognuno diversa dalle altre impedendo l’“unità storica” stessa14.
Egli ritiene pure che “ lo storico non è mai sufficientemente libero dalla storia”15. Quindi, l’oggettività scientifica nella storia non è mai compiuta, anzi è
qualcosa a cui si tende senza mai raggiungerla pienamente. Lo storico si avvicina ad essa nella misura in cui tenta un processo di liberazione su sé stesso (in ordine alle sue passionalità che ne deformano l’interpretazione e al “momento” del suo inserimento nella storia stessa). L’avvicinamento dello storico
NOTE
al punto di vista dell’oggettività scientifica è una possibilità, in quanto il predetto processo di emancipazione non è mai completo e da ciò deriva16 “l’impossibilità dell’individuo di essere superiore alla propria storia.”
L’attività dello storico, per essere autentica, deve liberare le “emozioni percepite nella loro attualità” che costituiscono la base delle relative manifestazioni17. Ma, si domanda l’autore18 con quale logica lo storico procede: con quella
dell’identificazione di un astratto “principio generale di determinazione”, sempre umanamente sfuggente, oppure con quella di un’intuizione che identifica la
realtà umana in quanto “incontenibile in una determinazione”? È chiaro che per
Armando vale questa seconda logica.
Un altro capitolo importante, che si pone come passaggio tra questo primo
capitolo ed il penultimo, già indicato, è: “Freudismo e psicologia sperimentale:
l’analisi di E. Boring con Hanns Sachs”19. L’autore vi si sofferma sull’irrisolto
rapporto tra Boring e il suo maestro Titchner, che richiama gli altri rapporti irrisolti tra Freud, Jung, Adler, Rank e Breuer, nonché quello “magnetico” (la paura del transfert erotico) tra questi ed Anna O.. Forse è opportuno osservare che
il rapporto magnetico altro non è se non quello ipnotico, giacché Mesmer definiva magnetismo l’ipnosi. Di conseguenza, probabilmente, possiamo spiegarci come l’ipnosi, allontanata dal freudismo, non sia stata presa successivamente in considerazione quale disciplina accademica e continui ad essere studiata solo da pochi pionieri; e come la sua conoscenza sia rimasta avvolta in molte zone d’ombra, mentre può essere riconosciuta quale sorgente di numerosi
procedimenti psicoterapeutici, come Ellenberger20 ha dimostrato nella sua celebre opera La scoperta dell’inconscio. Sorgono a questo punto alcuni inquietanti interrogativi: perché l’ipnosi è stata quasi “depennata” come disciplina
(scientifica) accademica, tranne rare eccezioni? e perché lasciare lo studio di
essa ai pochissimi addetti ai lavori? ciò ha senso? come mai gli studi degli anni cinquanta di M.H. Erickson21 sull’ipnosi, in quanto “stato di consapevolezza
speciale” (tratto dalla normale vita quotidiana), hanno avuto uno scarso seguito? forse perché partivano da una concezione diversa da quella data da
Freud?
Lasciamo da parte questi interrogativi (che esulano dai contenuti del libro)
ai quali però ho cercato di dare una risposta con la pubblicazione, nel 2004, di
un mio volume intitolato “Nuove Frontiere in Psicoterapia Ipnotica. La prospettiva fenomenologico-esistenziale” 22 e proseguiamo con il commento dell’opera di Armando.
Due capitoli, e cioè il 2° e il 10°, poi, apparentemente molto diversi tra di loro, quanto appunto è la loro distanza temporale, sono invece accomunati, secondo Armando, dallo stesso tema vale a dire “la ripetizione” del vecchio. Il primo, scritto nel 1961, inedito, che si intitola “La funzione conservatrice del termine fortuna e della malinconia nell’Umanesimo fiorentino di fine Quattrocento”, evidenzia come la celebrazione umanistica ripresenti il pensiero medievale della vanità del mondo, mentre, il secondo intitolato “Una critica a Marx negli anni 1976-1985” pubblicato in “Studi filosofici” negli anni 1989 e 90, sostiene la non fondatezza della tesi marxista in quanto “negazione del suo significato di proposizione di verità umane”.
183
184
L’altro capitolo importante di questo libro che si pone senza soluzione di
continuità con il primo è “Considerazioni di un esegeta pigro. Sugli sviluppi dell’analisi collettiva dopo il 1996”. In questo scritto vi sono temi della storia personale della ricerca di Armando, del suo rapporto con l’“analisi collettiva” e del
suo allontanamento da essa.
Se per Armando è necessario, come è nel suo stile, chiarire, spiegare, puntualizzare fatti e riscontri storici, che concorrono allo sviluppo dell’“analisi collettiva”, invece, qualsiasi lettore, anche poco avveduto, di questo libro può facilmente rendersi conto di come tra il suo autore e quello della “teoria della nascita” (cioè Fagioli) vi sia stata sempre una distanza.
La distanza che Armando pone tra sé e lo sviluppo recente dell’“analisi collettiva”, in quanto non gli sembra “immune” dalla ripetizione, rimanderebbe,
quindi, al suo costituirsi come teoria e non solo agli ultimi sviluppi della prassi
della “teoria della nascita”, teoria che, tra l’altro, è ancora tutta verificare. Ciò
proprio perché egli ritiene che la realtà debba essere letta nella sua storicità,
dove il presente è collegato direttamente al passato, e questo allo svolgimento attuale.
A mio avviso, dunque, in altri termini, proprio tale approccio storico di conoscenza ha comportato una separazione di Armando dalla “teoria della nascita”
sin da quando l’ha incontrata e non solo adesso che ne “percepisce” una prassi fuorviante del suo senso originario, ovvero storico. Ma questa asserto può
anche essere un interrogativo che richiede un’analisi più articolata.
Il distacco23 che, comunque, si è posto ora tra Armando e gli sviluppi recenti dell’“analisi collettiva” è forse anche dovuto a una certa pretesa della teoria
della nascita di trascendere la storia, di essere senza storia e di costruirsene
una tutta sua; il che contrasta con la prospettiva storicista di Armando e con la
sua affermazione che “nessuno può essere superiore alla propria storia”. Infatti egli conclude il capitolo 16°, datato 2003, il quale segna, ulteriormente, la
separazione tra lui e l’analisi collettiva (e quindi la “teoria della nascita” e la sua
scuola) con questa frase:
La parola resta alla storia che non è alcun racconto, che sfugge sempre
al racconto, e all’esito incerto della prova, oggi massima, cui si sottopone nel tempo il suo inizio, la comparsa del valore dell’Anders dell’immagine umana che rende nulla il nulla24.
Come si può osservare il primo capitolo, datato 1961 (che apre questo libro), il quale non a caso insiste sull’importanza della storia, viene completato
con un altro capitolo, del 2003, che parte dal punto in cui quello si arresta. Si
può affermare che la storia di questo libro traccia il suo passato su una “linea”
che culmina nel presente stesso; e che tuttavia il suo risultato è qualcosa di più
della linea stessa nel momento in cui si vuole cogliere il suo senso autentico,
sempre teso in un incessante lavoro critico di analisi della realtà umana quale
storia di rapporti che si oppone alla ripetizione.
D’altro canto personalmente penso che, per ora, si possa ipotizzare che lo
storico della realtà umana, nel momento in cui sia rimandato da essa alla pro-
Così noi ad un certo momento ci grattiamo le orecchie e ci chiediamo stupiti e confusi: “cosa ci è successo?”, anzi: “chi siamo noi alla fine?” e contiamo di nuovo quei tocchi, già lontani, tutti quei dodici colpi vibranti delle nostre esperienze, della nostra vita, e del nostro essere – ahimé! e ci
confondiamo nel contare…
Armando, con questo libro, vuole proprio suscitare tale interrogativo?
1 Armando fu membro eretico della SPI, espulso nel 1976 per la critica all’Istituzione psicoanalitica (cfr. L. A. ARMANDO e altri, Il potere della psicoanalisi, Armando, Roma 1974) e per avere sostenuto l’infondatezza del freudismo sponsorizzando la teoria di M. Fagioli. La vicenda è narrata
in un volume dello stesso autore, Il pappagallo dei pirati. Seconda edizione di mito e realtà del ritorno a Freud, Armando, Roma 1976, pp.10-12.
2 L. A. ARMANDO, La ripetizione e la nascita. Scritti di storia della filosofia e della psicoterapia
(1961-2004), Liguori, Napoli, 2004.
3 Si veda il concetto di ex-sistere in G. INVITTO, Esistenza/Estetica, Capone, Cavallino di Lecce 1994, p. 10.
4 Si veda il capitolo I del volume di L. A. ARMANDO, Filosofia e psicologia nel primo Dewey, La
Nuova Italia, Firenze 1984.
5 N. Lalli è coautore insieme ad L. A. Armando ed altri di Il potere della psicoanalisi, cit.
6 L. A. ARMANDO, La ripetizione e la nascita, cit., p. 1.
7 La critica al freudismo da parte di Armando è già implicita in un volume comparso alla fine degli anni sessanta. Si veda a tal proposito L. A. ARMANDO, Freud e l’educazione, Armando, Roma 1969.
8 M. FAGIOLI, Istinto di morte e conoscenza,Armando, Roma 1972, si veda anche dello stesso,
La marionetta ed il burattino, Armando, Roma 1974 e Psicoanalisi della nascita e castrazione umana, Armando, Roma 1976.
NOTE
blematizzazione della sua oggettività scientifica e della sua inserzione soggettiva in un determinato rapporto e momento storico, ponga la questione di come tale realtà si debba leggere “fenomenologicamente”. Cioè di come questa
realtà umana possa essere resa “intelligibile” e “leggibile” in un processo conoscitivo (“epochizzato”) che parta dall’intuizione della realtà delle cose (in
senso husserliano) per poi procedere alla loro percezione distinguendo i dati di
fatto dalle loro essenze, ma anche queste dalla ricerca del loro senso. Questo
modo di procedere, nondimeno, richiama continuamente in causa il nostro vissuto (erlebnis) di essere in rapporto (consapevole ed intenzionale).
Di conseguenza il senso del nostro essere biologico, sin dalla nascita fisiologica, caratterizza il nostro essere come “semplice presenza”, mentre il significato del nostro esistere è dato dalla possibilità di essere in una forma liberamente ed autenticamente scelta a partire dalla realtà concreta di ogni giorno,
dalle cose e dal nostro essere in rapporto con l’altro e con esse come evidenziato per alcuni aspetti da Heidegger o Lévinas oppure Longhi25. Ma questa,
tuttavia, è una tematica che richiede uno studio specifico, in altra sede, e che
non è trattata in questo libro anche se ne stimola, in modo latente, la riflessione. La lettura del volume di Armando, invece, sembra evocare, in modo esplicito, una frase di Nietzsche26 a proposito di quei “cercatori della conoscenza”,
tratto dalla sua “Genealogia della morale” che mi piace riportare testualmente:
185
186
9 Una testimonianza della prassi dell’“analisi collettiva”, anni settanta, è resa nel volume di R.
SCIOMMERI, Seminari, Armando, Roma 1976.
10 La ripetizione e la nascita, cit., p. 5.
11 Ivi, p. 6.
12 VAN BREDA, Fenomenologia, Enciclopedia del novecento, Treccani, Roma 1977.
13 La ripetizione e la nascita, cit, p. 8.
14 Ivi, p. 9.
15 Ivi, p. 10.
16 Ibidem.
17 Ivi, p. 12.
18 Ivi, pp. 13-14.
19 Ivi, p. 4. Per un’analisi dettagliata si veda anche A. L. ARMANDO, L’invenzione della psicologia. Saggio sull’opera storiografica di E. Boring (1986), Edizione telematica 2005, sito web
www.antonelloarmando.it.
20 H.L. ELLENBERGER, La scoperta dell’inconscio, Boringhieri, Torino 1976.
21 J. HALEY, a cura di, M. H. Erickson, Le nuove vie dell’ipnosi, Astrolabio, Roma 1978.
22 F. TARANTINO, Nuove Frontiere in Psicoterapia ipnotica. La prospettiva fenomenologico-esistenziale, A.M.I.S.I., Milano 2004. Per una visione della psicologia nella prospettiva fenomenologica si veda anche il mio testo Tossicomanie ed esistenza. Aspetti psicologici e psicoterapeutici, Capone, Cavallino di Lecce 1995.
23 Cfr. anche l’intervista di I. Tommasi ad Armando su Pol.it: www.psychiatryonline.it/ital/armando2005.htm.
24 La ripetizione e la nascita, cit., p. 286.
25 Si vedano M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1970; E. LÉVINAS, Scoprire
l’esistenza con Husserl e Heidegger, Cortina, Milano 1988; L. LONGHIN, Compendio di psicopatologia fenomenologica, Capone, Cavallino di Lecce 1996.
26 F. W. NIETZSCHE, La nascita della tragedia. Genealogia della morale, Orsa Maggiore, Torriana, 1993, p. 123.
I RIFIUTI COME EMERGENZA FILOSOFICA
Il tema dei “rifiuti” che apre la collana delle pubblicazioni annuali curate dalla redazione della rivista “Kainos” è certo tra i più delicati e il tono con cui viene affrontato nella maggior parte dei saggi può forse suscitare a prima vista
sentimenti inquietanti. Ci vengono incontro, infatti, l’immagine di un’umanità
quasi bestiale, i segni della metafisica del male radicale, lo strapotere di forze
che superano inesorabilmente la volontà e le ragioni dei singoli, la denuncia
del fallimento o meglio dei peccati originali della modernità, ma non solo, perché appare posta in questione l’intera cultura occidentale. Le analisi sociologiche e di psicologia del profondo contenute in questo volume descrivono con
cura i meccanismi di violenza, di estraniazione o di fagocitazione dell’alterità
umana, ai quali le belle pagine introduttive si preoccupano di dare definizioni e
specifiche ben precise: produzione e accumulazione di rifiuti più o meno assoluti, scarti, rovine, macerie di oggetti e di soggetti, che possono essere di volta in volta gli apolidi, i profughi, gli stranieri.
Difficile contestare i dati che servono per queste descrizioni e la forza con
cui riescono a mettere a nudo la “coscienza sporca” che ci deriva da una serie
di realtà negative che non possiamo ormai permetterci di ignorare, perché sempre più ravvicinate per via dei molteplici strumenti di comunicazione che ce la
espongono a volte in tutta la loro crudezza. Com’è stato giustamente notato, occorre infatti riconoscere che la distinzione di Karl Jaspers tra “colpevolezza morale” e “colpevolezza metafisica” sembra oggi non avere più senso, proprio perché non possiamo più sentirci innocenti di fronte alla concreta visibilità della miseria e del dolore che avvolgono la vita di una gran parte degli esseri umani.
La reazione di sconforto che, come accennavo, può nascere da un sguardo complessivo ai diversi contributi al volume è in realtà una reazione squisitamente morale, cioè non solo emotiva ovvero dettata dalla paura e dal disorientamento che ogni esposizione del negativo porta con sé. In questo senso,
la prima domanda che si impone al lettore riguarda le sue possibilità di intervento nella situazione, la sua responsabilità individuale e sociale nei confronti
dei meccanismi di rifiuto. Essi, infatti, non solo minacciano di coinvolgere – in
parte o del tutto, prima o poi – l’esistenza di ciascuno, ma – ancor più – rischiano di mettere a repentaglio l’immagine dell’essere umano quale soggetto morale, ovvero capace di progettare la propria realtà in termini di valori sovraindividuali e di norme comportamentali adeguate. Di qui, una domanda più ampia
ma altrettanto scomoda: fino a quale punto è possibile difendere il lavoro filosofico come una via necessaria per sanare la situazione così scoraggiante che
questi saggi presentano?
NOTE
di Rosa Calcaterra
187
188
Stiamo parlando, evidentemente, del problema del rapporto tra teoria e pratica, tra filosofia e politica. Per coloro che intendano prescindere da meri esercizi retorici, affrontare tale problema richiede almeno di tenere in conto il dubbio
che fare filosofia possa significare, in fondo, sottrarsi ad un impegno sociale e
politico in prima linea. In altre parole, occorre forse ammettere che la riflessione filosofica riesce a incidere spesso solo in minima parte sulla realtà, anche
quando tende soprattutto a stigmatizzarla, perché infine i “giochi” della realtà, le
dinamiche del concreto si svolgono altrove. Tuttavia, occorre anche considerare che per chi continua a studiare e “fare” filosofia vale quanto meno la speranza che la riflessione filosofica abbia pur sempre costituito e debba continuare
ad essere – per usare le parole di Richard Rorty – “una voce nella conversazione dell’umanità” e, in parallelo, l’impegno a mostrare che farla tacere sarebbe
estremamente rischioso oltre che alquanto improbabile. Dicendo così, penso in
realtà ad un modo di fare filosofia che non può sottrarsi al meccanismo dei rifiuti, ma anzi si serve dell’atto del rifiuto come di un’arma privilegiata e costante per aprire spazi di significato e di valore che risultano bloccati o fortemente
compromessi. In questa luce, sono invero portata a difendere un “dovere di rifiutare”, oltre che un diritto di denunciare dei rifiuti. A ben guardare, ciò appare
implicito in molti saggi del volume, che nel complesso lasciano appunto emergere innanzi tutto la connotazione fortemente etica del discorso intorno ai vari
rifiuti operati a livello sia sociale sia individuale nella nostra storia recente.
La questione può essere formulata in altri termini: data la pervasività dei
meccanismi di rifiuto, quali vie e quali mezzi ha offerto la filosofia contemporanea per far sì che il termine “rifiuto” non di colleghi esclusivamente a strategie
di violenza e di potere? In proposito, si potrebbero certo ripercorrere una gran
quantità di pagine filosofiche, dal decostruzionismo alla fenomenologia posthusserliana, dall’esistenzialismo a tutto il pensiero della differenza, da Lyotard
alle filosofie femministe. In prima approssimazione, si può comunque dire che
il comune denominatore di questi filoni di pensiero risiede nell’attenzione al tema della temporalità, le cui diverse elaborazioni investono tra l’altro la nozione
tradizionale di “natura umana”. Da questo punto di vista, buona parte della filosofia contemporanea appare infatti centrata sul progetto di un consistente rifiuto (a ben vedere motivato dalle vicende storiche oltre che dall’analisi teoretica) dell’idea tradizionale per cui nel soggetto umano vi sarebbe un centro sostanziale, unitario e autosufficiente, che permarrebbe nel variare delle situazioni e delle esperienze. In poche parole, un rifiuto del paradigma cartesiano della realtà umana e del dualismo mente-corpo che lo sorregge.
Che poi questa prospettiva sia ben presente anche sul versante della cultura non strettamente filosofica, lo possiamo vedere, ad esempio, nel saggio di
Eleonora De Concilis, che discute il pensiero di Elias Canetti, sottolineandone
l’istanza antidualista che lo anima. L’autrice chiarisce come Canetti si sia impegnato a fluidificare “la tradizionale distinzione tra materia e spirito, tra corpo e
psiche, tra società e individuo”, di contro alle strategie teoriche che istituiscono
il primato della ragione sulla funzione corporea, dando alla “forma pura” un ruolo “incorporativo” assolutamente non neutrale. D’altra parte, il tema della temporalità e le sue ricadute sul concetto di natura umana si rilevano ampiamente
NOTE
nel saggio di Aldo Meccariello, dedicato ad Hannah Arendt. Meccariello giustamente tocca qui il problema di vedere fino a che punto sia possibile parlare di
“natura” piuttosto che di “condizione” umana e, chiaramente, non si tratta solo
di una questione di parole. In particolare, il punto più delicato è l’idea che rinunciare a definire la “natura umana” significhi anche rinunciare al denominatore
comune dei rifiutati e dei rifiutanti. In questo senso è da notare che se si mantiene questa locuzione insieme all’istanza definitoria che essa veicola, come la
Arendt tende a fare, appare difficile giustificare la sua tesi per cui il totalitarismo
tende a mutare la natura umana. Infatti, non solo pensare a “un cambiamento
di natura” implica una contraddizione in termini, ma – stando anche a quanto la
stessa Arendt ha mostrato in Vita activa – appare particolarmente difficile, se
non persino impossibile, definire la natura umana sia sul piano filosofico che su
quello psicologico. Resta tuttavia il fatto che l’intreccio tra “natura” e “condizione” è, in sostanza, un fattore portante di tutta la riflessione arendtiana.
Val la pena di ricordare che tale intreccio è un punto di forza della filosofia
pragmatista, di cui la Arendt deve aver quanto meno sfiorato la mentalità nei suoi
anni statunitensi. Mi riferisco ad autori come James, Dewey e Mead, che hanno
posto in primo piano la concretezza dei processi d’esperienza del mondo sia fisico sia sociale, indicandoli come il terreno di formazione e, allo stesso tempo, di
correzione degli apparati cognitivi e valutativi che di volta in volta vengono messi in atto. Peraltro, conviene anche sottolineare che la battaglia contro l’essenzialismo, condotta da questo come da altri filoni del pensiero contemporaneo in
nome della temporalità e della contingenza, non è necessariamente distruzione
o “riduzione in maceria” della nozione di natura umana. Piuttosto, si tratta dell’apertura di un nuovo spazio per la riflessione ontologica, uno spazio che si presta all’edificazione di un’identità soggettiva e sociale calibrata sul criterio del riconoscimento piuttosto che del rifiuto della diversità (della presunta “debolezza”
delle ragioni e dei sentimenti degli altri), che appunto si rende disponibile proprio
in virtù di un espresso e motivato rifiuto della logica dell’identità.
Gli autori e gli argomenti presentati nel volume suggeriscono che il passaggio di tale orientamento dal livello filosofico a quello pratico-politico richiede
un’ibridazione costante e meditata della filosofia con la sociologia, la psicologia, l’antropologia culturale e, infine, con la letteratura o la critica letteraria. Particolarmente indicativi in proposito appaiono i riferimenti a Calvino contenuti nel
saggio di Bauman, le riflessioni su Benjamin di Bruno Moroncini, le analisi di
Derrida prese in esame da Gabriella Baptist. Nel complesso il volume porta infine ad accogliere l’opinione di Rorty secondo cui il progresso morale va in direzione di una maggiore solidarietà umana e, pertanto, a pensare che dovremmo sentirci impegnati a riflettere con spirito critico e costruttivo sulla sua affermazione che la solidarietà “non consiste nella consapevolezza di un io centrale, l’essenza umana”, ma nel “saper togliere importanza a più e più differenze
tradizionali (di tribù, religione, razza, usi e simili) in confronto alla somiglianza
nel dolore e nell’umiliazione, nel saper includere nella sfera del noi persone immensamente diverse da se stessi”. Ma allora, probabilmente, ci troveremo costretti a riconoscere che, almeno finora, la letteratura forse molto più della filosofia ha contribuito in questo senso.
189
A. SAVIGNANO, Panorama della filosofia spagnola del Novecento, Marietti, Genova-Milano 2005, pp. 431.
190
La scarsa tendenza dei pensatori spagnoli ad organizzare in sistemi imponenti le proprie idee è spesso stata guardata con sospetto dalla Grande Filosofia. Proprio dalle pagine di questa rivista, Sergio Vuskovic Rojo ha ricordato come Bergson considerasse la filosofia spagnola alla stregua di una raccolta di
proverbi. Benché egli valuti ormai archiviata la questione, grazie soprattutto agli
sforzi intellettuali di Unamuno ed Ortega y Gasset (Segni e comprensione, n.
43, 2001, p. 5), i pregiudizi dell’intellighenzia europea sono però difficili da estirpare. Ne è ben cosciente Fernando Savater che nel salutare i lettori del lavoro
di Armando Savignano (Panorama della filosofia spagnola del Novecento), denuncia questa scarsa fiducia nella capacità ispanica di astrazione e di riflessione. “Si tratta di un pregiudizio, è opportuno ribadirlo, che fino a non molto tempo fa è stato condiviso da buona parte del pubblico spagnolo con i critici stranieri” (p. 11). Occupa un ruolo interessante, alla luce di questa virata della sensibilità europea, lo studio di Savignano che, organizzato in 16 agili capitoli, con
la chiarezza di sempre, ripercorre “gli aspetti più rilevanti del secolo XX”. E lo fa
attraverso il metodo delle generaciones, quale lo espone Ortega nel corso universitario del ’33, En torno a Galileo. Ogni generazione è composta da quanti
hanno la stessa età (zonas de fechas) e vivono in un circolo di attuale convivenza – scrive il filosofo –; in ogni oggi, in ogni presente coesistono varie generazioni e le relazioni che tra loro si stabiliscono, rappresentano il sistema dinamico di attrazione e repulsione, di accordo o polemica, che costituisce in ogni momento la realtà della vita storica. Ognuna rappresenta uno scorcio della storia
universale e porta dentro di sé l’eredità – in termini di Weltanschauung che ogni
generazione elabora – di tutte quelle che l’hanno preceduta.
Savignano inizia dunque questo affascinante viaggio intellettuale introducendo la generazione del ’98. Un “sentimento pessimista nei confronti della vita”, “un pensiero tragico, un’attitudine nichilista”, che – fatte salve le singole peculiarità – fecero maturare un atteggiamento scettico e irrazionale (pp. 15-20).
Sono questi i tratti salienti della generazione che rigettò i valori del periodo romantico e naturalista, in nome di un ritorno all’interiorità, all’infrastorico ed alla
sfera poetica. Promotore di questo gruppo di intellettuali, l’artista-filosofo Azorín (pp. 31-35), che vive “l’ansia esistenziale caratterizzata dalla tensione tragica tra coscienza e vita, tra apollineo e dionisiaco, in definitiva tra tempo ed
eternità”. Attorno a lui, tra gli altri, Pío Baroja (pp. 27-31), che intravede nel superamento della crisi di fine secolo un riconciliarsi con la vita, attraverso il raggiungimento dell’ideale etico, l’amore, l’accettazione della vita senza significato trascendente; il pensatore Ganivet (pp. 21-23), alla ricerca di idee guida per
una rigenerazione individuale e nazionale, onde poter superare “la prostrazione materiale spagnola ed aprire la via ad un rinnovamento spirituale”; il filosofo de Maetzu (pp. 23-26), che si appella all’ontologia tradizionale, ad un’utopica teocrazia spagnola ed elabora una ideologia cattolico-conservatrice ripresa
negli anni del falangismo. Ma sono senza dubbio quelle di Antonio Machado e
di Miguel de Unamuno le voci più autorevoli del gruppo del ’98, salvate dal-
RECENSIONE
l’oblio che ricade sulle altre (p. 35). Grazie alla sua particolare elaborazione del
rapporto tra filosofia e poesia, Machado (pp. 36-51) rappresenta una delle “più
alte espressioni ideologiche della generazione”. Rinnegando l’arte per l’arte, in
nome di un’arte per la vita, il pensatore andaluso fonde poesia e filosofia, “cogliendo così l’eterogeneità dell’essere mediante l’espressione poetico-lirica”.
Un’attitudine ribattezzata “metafisica del poeta”, che lo vede su posizioni analoghe a quelle dell’altro grande protagonista di questo periodo, Miguel de Unamuno (pp. 53-82). Considerato l’indiscusso capo spirituale del ’98, il filosofo
basco mise da parte la ragione, nella sua accezione razionalistica e scientistica, per far posto alle “ragioni del cuore”. Aprendosi alle tesi kierkegaardiane,
Unamuno riscopre l’importanza della “fede creatrice, l’equivalenza tra credere
e creare”, fa appello alla “soggettività etico-religiosa e ad un richiamo all’interiorità”. È Il sentimento tragico della vita l’opera fondamentale, in cui delinea i
tratti di una fede agonica, intravedendo nella religione l’unica capace di fornire
risposte alle istanze vitali sul destino concreto dell’uomo.
Nel suo lavoro, l’Autore non dimentica chi ha risposto in modi differenti alla
crisi di fine secolo. Appartengono alla schiera degli indipendenti George Santayana (pp. 114-120), fautore di un materialismo, simile al naturalismo evoluzionistico; e Ángel Amor Ruibal (pp. 120-130), sacerdote di Santiago de Compostela, che elaborò una teoria correlazionista nell’affrontare i problemi fondamentali della filosofia e del dogma.
Una temperie culturale con cui si confrontarono gli intellettuali del periodo
successivo. Ed è il 1914 l’anno che assiste alla nascita della più importante generazione nella storia della Spagna moderna, una delle più complete della storia europea del XX secolo (p. 134). “Europeismo, repubblicanesimo, scienza e
razionalità possono essere considerati i motivi ispiratori e gli ideali della generazione del ’14” (p. 136). Animatore dell’attività di questa generazione fu sicuramente il filosofo José Ortega y Gasset (pp. 139-189). Le Meditaciones del
Quijote e la conferenza Vieja y nueva política sembrano inaugurare l’attività del
gruppo di intellettuali. La sua aspirazione principale fu quella di “delineare, in
termini filosofici, una concezione della vita in dialogo con la circostanza spagnola”. La sua riflessione ebbe un carattere a-sistematico, ma è comunque
possibile individuare nelle Obras completas un’originale “teoria della ragion vitale e storica, metodo e sistema per cogliere la realtà radicale, insomma per
affrontare il problema metafisico”. Savignano fa rientrare a pieno titolo nella generazione orteghiana anche autori quali Eugenio D’Ors (pp. 93-101), il cui lavoro mira a fondere “illuminismo e tradizione, cultura e religione”; Fernando de
Los Ríos (pp. 240-241), che riflette sul significato umanista del socialismo; J.
Besteiro (pp. 241-243), che tenta di “conciliare scienza e filosofia nell’ambito di
un socialismo etico-umanitario”; Luis Araquistain (pp. 243-247), fervido sostenitore della rigenerazione spagnola. Ma il personaggio che ha incarnato la Repubblica fu certamente Manuel Azaña (pp. 247-251), col suo liberalismo radicale, che ricoprì la massima carica dello Stato dal 1936 al 1939.
Diverse le preoccupazioni della generazione del ’27, che dal modernismo
segna il passaggio all’avanguardia ed al surrealismo. Due le fasi che segnano
l’evoluzione del gruppo, nota Savignano: nella prima, il testo orteghiano La di-
191
192
sumanizzazione dell’arte, 1925, rappresenta l’opera su cui si confrontano i pensatori del periodo; nella seconda, prevale invece l’attenzione verso questioni sociali. Tra gli esponenti della generazione, Xavier Zubiri (pp. 204-236), allievo di
Ortega, in Spagna, e di Husserl ed Heidegger, durante i suoi studi tedeschi. Originale il suo approccio alla fenomenologia, con cui tenterà di superare le insufficienti prospettive del realismo e dell’idealismo; ma l’incontro con Heidegger gli
permise di avanzare verso la ontologia, che successivamente abbandonerà per
approdare a convinzioni metafisiche. Non è l’essere a fondare la realtà, bensì il
contrario; la filosofia studia la realtà in quanto tale, a cui è aperta l’intelligenza
senziente. E si trovò a sostituire Zubiri sulla cattedra di Metafisica, l’allora ventinovenne María Zambrano (pp. 279-317). Autorevole esponente della generazione, il suo contributo più originale consiste nella teoria della ragione poetica,
che “rappresenta un metodo per superare i radicalismi razionalistici ed idealistici, caratterizzati dalla volontà di sistema, che ritiene portatori di intolleranza, totalitarismo e violenza”. Con la ragione poetica cerca di riproporre quella perduta unità originaria tra filosofia, poesia e religione ed individua nel “discorrere per
metafore” la forma primaria di rapportarsi al reale. Differenti gli sviluppi di Eduardo Nicol (pp. 332-344), che ha affrontato la questione della crisi della metafisica, il problema antropologico e quello dello storicismo, elaborando una originale metafisica dell’espressione; o quelli di García Bacca (pp. 345-356), impegnato in una critica della ragione economica, per approdare in ultima istanza ad una
filosofia della tecnologia. Occorre ristabilire il primato dei valori rispetto alla teoria, secondo Joaquin Xirau (pp. 101-111), che elabora invece una metafisica
dell’amore. Impegnato invece nella definizione del suo “personismo agnostico
disincantato”, José Gaos (pp. 260-269), che critica l’uso metafisico della ragione, cui viene contrapposta una attitudine antropologica e soggettivistica; mentre Manuel Granell (pp. 269-272) sviluppa i suoi studi nel campo della logica,
per elaborare una logica della ragione vitale.
Ortega lo aveva detto: non è obbligatorio che ogni generación abbia grandi uomini. Decisamente più contenuto fu infatti l’apporto delle generazioni successive, di cui si apprezza invece lo sforzo teso all’introduzione in Spagna del
dibattito filosofico/culturale europeo (p. 416).
“Gli intellettuali della generazione del ’36 – che agirono nel periodo dell’ascesa e dell’affermazione del regime franchista – furono per la maggior parte espressione di un conflitto fra umanesimi” (p. 359). Capo spirituale è ritenuto Pedro Laín Entralgo (pp. 383-405), medico filosofo, che si situa nella tradizione della medicina umanista e nell’ambito della bioetica. Sulla scorta della
sua storia dell’arte medica, arriva ad asserire che la “medicina è problema” che
il medico deve quotidianamente affrontare, “collocandosi tra le scienze della
natura e quelle dello spirito, ovvero tra teoria e prassi”. Inscindibile da questa
visione, l’elaborazione della antropologia medica lainiana in cui assume un
ruolo decisivo “la virtù della speranza”. Elabora inoltre un originale approccio
al rapporto medico-malato, fondandolo su quella che egli chiama la amicizia
medica. Di altra natura le ricerche di José Luis López Aranguren (pp. 360-370),
che hanno riguardato i rapporti tra l’etica, la religione e la politica. Dopo una
prima fase di riflessione sull’ethos, negli anni ’60 pone l’accento sulla “morale
Simone Pantaleo
RECENSIONE
vissuta”, ribadendo l’importanza della missione dell’intellettuale. Concepito come moralista della società, libero da costrizioni di sorta, a lui spetta l’arduo
compito di additare la speranza e l’utopia mediante l’immaginazione creatrice.
Originale la posizione di José Ferrater Mora (pp. 370-381), che “elabora una
teoria della realtà” attraverso la via integrazionista, con cui corregge le insufficienze di una posizione mediante il continuo passaggio alla posizione opposta.
Più favorevoli le condizioni socio-politiche della generazione del ’56 (p.
407). Esponente principale di questo gruppo di intellettuali fu Enrique Tierno
Galván (pp. 408-416), che introdusse la filosofia analitica in Spagna grazie alla traduzione, seppur sommaria, del Tractatus di Wittgenstein. Elaborò una
concezione della filosofia come consapevolezza del limite; rifiutò la metafisica
e, sulla scorta di posizioni neo-positiviste, approdò all’agnosticismo.
Lungi dal voler considerare le generazioni aridi compartimenti stagni, cataloghi in cui stipare cronologicamente degli autori, Savignano propone una lettura trasversale dell’evoluzione del pensiero spagnolo, individuando nella filosofia catalana (pp. 87-111) e nella Scuola di Madrid (pp. 192-202) due positive
esperienze che hanno accomunato esponenti di differente estrazione generazionale. I primi passi di quella che Gaos ribattezzò “scuola di Barcellona” già si
muovono nel diverso approccio con cui ci si accostò in Catalogna alla crisi di
fine secolo. Lì si privilegiò il modernismo, almeno fino al 1906, anno in cui si
approdò al Noucentisme, a cui si devono le rivendicazioni dell’identità catalana. Protagonista indiscusso di quegli anni il poeta Maragall (pp. 90-93), ma appartengono a questa scuola anche D’Ors e Xirau, di cui si è già detto in precedenza. Mutua ispirazione, metodo ed orientamento dalla ragione vitale orteghiana, invece, la scuola filosofica che si inaugurò a Madrid, la cui attività si
esaurì con l’incedere della guerra, ma che rivisse anche successivamente come tradizione filosofica. Tra i principali rappresentati, Manuel García Morente
(pp. 196-202), Luis Recaséns Siches (pp. 272-273), oltre a Zubiri, Gaos, Zambrano. L’impegno filosofico del Novecento spagnolo può esser letto anche alla
luce dell’esperienza dell’esilio, come mette in evidenza l’Autore nel corso dell’intera trattazione; esperienza direttamente vissuta da gran parte degli intellettuali citati e che divenne perciò categoria culturale. Ad essa dedicano i loro
sforzi intellettuali numerosi autori, soprattutto di origine basca (pp. 321-331),
tra cui incontriamo Juan Larrea, José Bergamín, Eugenio Imaz.
193
ANGELA ALES BELLO:
TRA PASSIVITÀ E TELOS.
LA VALENZA TEORETICA
DELLA HYLETICA FENOMENOLOGICA
194
Il 2 febbraio 2007 nell’ambito del Prin Fenomenologia, narrazione, riflessione etico-politica, coordinato da Giovanni Invitto, si è svolto presso l’Università
di Lecce, il seminario Tra passività e telos. La valenza teoretica della hyletica
fenomenologica tenuto da Angela Ales Bello (ordinaria di Storia della Filosofia
Contemporanea presso la Pontificia Università Lateranense).
Il tema della hyletica fenomenologica è ampiamente sviluppato da Ales Bello nel suo libro Edmund Husserl: pensare Dio, credere in Dio (AMP 2005), in
cui la dimensione hyletica è fondamentale nella costruzione del soggetto umano per rendersi conto di tutta l’esperienza a cominciare da quella sensibile fino a giungere a quella di carattere religioso. Una intuizione questa, che può risultare utile per sviluppare una antropologia, che sul terreno fenomenologico
ha sempre avuto una valenza importante, come può essere constatato nella filosofia husserliana e steineniana.
La riflessione di Ales Bello sulla dimensione hyletica parte dall’assunto che
l’essere umano deve essere considerato come una stratificazione molto complessa, come dimostra, tra gli altri, Hedwig Conrad Martius (della quale pensatrice, recentemente, sono stati tradotti i Dialoghi Metafisici, Besa 2006). Ed è
la delineazione di una sorta di mappa molto complessa dell’essere umano e
del suo ambito gnoseologico, secondo l’interpretazione di Ales Bello, la chiave
d’accesso di questi fenomenologi per giungere all’antropologia.
Questa particolare curvatura assunta sia dal pensiero di Husserl, di Stein e
in parte di Conrad Martius, è ereditata, ma soltanto nelle prime riflessioni, da
Sartre e Merleau-Ponty. Tale complesso percorso, che ci dà anche la misura
della consapevolezza e del livello su cui si è mossa la riflessione fenomenologica, è descritto dallo stesso Husserl in quello che è considerato il suo testamento spirituale La storia della filosofia e le sue finalità (Città Nuova 2004)
scritto tra il 1936-1937, in cui il filosofo colloca la fenomenologia all’interno della storia della filosofia e traccia un bilancio della sua attività domandandosi
“che cosa abbia fatto di nuovo”. Questa novità è rinvenibile, come Husserl
stesso dichiara, nell’intenzione profonda della storia della filosofia, quale è l’inizio. Ed è proprio questo inizio, intravisto nella filosofia greca da Platone e Aristotele, che è portato allo scoperto, palesemente argomentato nella filosofia
husserliana. La direzione imboccata da Husserl non è una cronologica ricostruzione della storia della filosofia, ma, ed è qui la genialità, il relazionarsi con
alcune problematiche estrapolate dall’intero apparato tradizionale della storia
della filosofia. Questo dialogo, che Husserl ha continuo con la filosofia antica,
i sofisti, Platone e Aristotele, la filosofia moderna da Cartesio, all’empirismo, a
NOTIZIARIO
Kant, non muove dal loro pensiero, come può essere comprovato dalle date in
cui legge i vari filosofi, ma da uno scavo interiore che lo porta a rendersi conto, dell’assonanza delle tematiche con quelle di quei pensatori.
Si instaura, dunque, un colloquio continuo e diretto con le loro opere fino a
stabilire il punto di arrivo delle loro riflessioni in riferimento a quella che il filosofo riteneva essere la sua scoperta personale, cioè un territorio di inizio dal
quale partire, dagli altri filosofi intuito, da lui esplicitato.
Per mettere bene a fuoco con quali questioni di fondo Husserl si trovi a fare i conti per giungere all’elaborazione di questo territorio di inizio, Ales Bello,
sofferma l’attenzione sull’ambiente culturale in cui il filosofo si forma. È il luogo in cui si trovano due personaggi che fanno scattare nella riflessione husserliana l’idea del nuovo fondamento: Brentano che potrebbe essere considerato
il responsabile diretto e Freud l’interlocutore.
Brentano scrive La psicologia dal punto di vista empirico in cui tratta una
questione di fondo: gli stadi psichici di cui parlano gli psicologi possono essere analizzati in modo quantitativo e qualitativo. È chiaro, come sottolinea Ales
Bello, che la risposta quantitativa è sul versante di una visione scientifico-tecnica, l’altra è sul versante bergsoniano.
Questo approccio psicologico è ereditato nella filosofia husserliana e viene
sviluppato intrecciandosi con quello logico e matematico.
Ebbene in questo terreno culturale sono rintracciabili, secondo Ales Bello,
le due anime di Husserl, conciliate nelle opere logiche: Logica formale e trascendentale e Esperienza e giudizio. L’andatura della riflessione husserliana è
la seguente: dalla logica matematica nei primi scritti, al rintracciare la genesi
della matematica e dell’aritmetica nella psicologia. Riprendendo la psicologia
di Brentano, Husserl scrive La filosofia dell’artimetica (stampato nel 1891 con
sottotitolo Ricerche logiche e psicologiche con dedica a Franz Brentano). Tale
scritto crea una reazione non positiva negli ambienti dei logici e dei matematici, che asseriscono non essere possibile risolvere la questione in termini puramente di psicologia. Rotti gli argini codificati Husserl indaga un nuovo terreno
gnoseologico con uno sguardo ereditato dalla psicologia: aggiunge al processo conoscitivo il “ci rendiamo conto di”.
E questo “rendersi conto di”, come rileva Ales Bello, ha una stratificazione:
la nostra conoscenza passa attraverso una coscienza che ha diversi livelli: ad
esempio ad un primo livello sentiamo un suono, ma non “ci rendiamo conto di”,
ad un secondo livello – riflesso – “ci rendiamo conto di”.
Si assiste, dunque, ad uno sdoppiamento, l’aver coscienza del suono e la
reazione psichica: si capta il suono percettivamente e si reagisce al suono. In
altre parole c’è un livello di sensazione che noi recepiamo, questo recepire,
“rendersi conto di” è il vissuto coscienziale che corrisponde alla sensazione,
denominato dai fenomenologi Erlebnis. Termine, come sottolinea Ales Bello,
che in portoghese è tradotto con vivencia, secondo l’accezione proposta da
Ortega y Gasset, in italiano con la locuzione “ciò che noi stiamo vivendo”.
Ed è su questo cammino, come Ales Bello argomenta, che Husserl inscrive la coscienza, che non è un luogo, non è una scatola che contiene queste
cose, ma per usare una metafora di Stein è “luce interiore che ci accompagna”.
195
196
La coscienza è per Husserl una funzione, come puntualizza Alesa Bello riprendendo Idee I parg. 86 I problemi funzionali: “Ma i problemi più rilevanti sono i problemi funzionali, cioè quelli relativi alla ‘costituzione delle oggettualità
della coscienza’. Essi riguardano la maniera in cui le noesi (per esempio nei riguardi della natura), animando l’elemento materiale e intrecciandosi in sintesi
e continuità in cui viene unificato il molteplice, realizzano la coscienza di qualcosa in modo che in tale coscienza dell’oggettualità possa ‘annunciarsi’ in maniera concordante, lasciarsi ‘legittimare’ e determinare ‘razionalmente’ l’unità
oggettiva”. Il centro di questa attività funzionale è l’io. L’io puro è la struttura
presa in modo trascendentale e in teoria avulsa dai singoli, come Ales Bello nota, il riferimento è alla filosofia kantiana. A livello teorico questa struttura può
essere esaminata come staccata dagli esseri umani, ma è evidente che essa
non lo sia realmente, Husserl a tal proposito afferma che vive sempre all’interno di singoli esseri umani esistenzialmente configurati e psicologicamente determinati.
La dimensione coscienziale, secondo Husserl, è in movimento, fluisce e rimanda a sensazioni e reazioni psichiche, queste cioè vengono vissute coscienzialmente, e pertanto si possono chiamare Erlebnis.
È questo il nuovo territorio, che Husserl definisce il nuovo terreno d’essere
usando Sein per designare luogo, cioè territorio delle cose che ci sono, il territorio della coscienza con i vissuti che fluiscono. Questo flusso di vissuti, in cui
anche la riflessione è un vissuto che si colloca nel flusso della coscienza è metaforicamente illustrato dalla Stein come un grappolo di vissuti, organizzati in
modo che in un certo momento si manifestano. Qualsiasi azione, anche semplicissima, implica un grappolo di vissuti, dalla sfera passionale alla sfera intellettuale-valutativa, un continuum di vissuti che sono di qualità diverse.
Su questo territorio l’empiristi stavano lavorando, ma essendo questo il luogo del soggetto, anche Cartesio e Kant si erano avvicinati ad esso, senza mai
palesamente “toccarlo”. Secondo la chiave di interpretazione fenomenologica
questi filosofi non avevano commesso alcun errore, in realtà avevano assolutizzato alcuni principi lasciandone nell’ombra altri. Lo stesso Husserl nell’Idea
per una fenomenologia pura riprende il linguaggio cartesiano e lo utilizza per
argomentare intorno all’io penso, e sottolinea che il passaggio “penso dunque
sono” non è errato, ma come emerge dall’analisi di Ales Bello, troppo rapido.
Lo stesso vale per Kant, che se pur ha sviluppato diversi gradi della struttura
conoscitiva, l’intuizione, la sensibilità, l’attività analitica, intellettuale non giunge all’individuazione di questo territorio trascendentale, da intendere come
analisi strutturale della soggettività.
Didatticamente, per far comprendere questo territorio, l’immagine alla quale Ales Bello fa riferimento è quella della “lastra”: la dimensione coscienziale,
così come la propone Husserl è come se fosse una cosa trasparente, si passa attraverso, cioè, talmente ovvia, che si passa attraverso e non la si vede. In
altre parole, riprendendo l’esempio del suono: è così ovvio che noi ci rendiamo conto di sentirlo che il “rendersi conto di” non viene tematizzato. Il punto
nodale, come sottolinea Ales Bello, è che per Husserl vi è una dimensione di
sensazioni e di reazioni psichiche reale, Wirklich è il termine che usa nelle
NOTIZIARIO
Idee, cioè un qualcosa di reale e che si riflette coscienzialmente nella dimensione dei vissuti.
L’essere umano oltre alle dimensioni e all’io che è il centro funzionale ha
anche un principio identitario, profondo personale, questo nucleo ha la caratteristica di permanenza nel tempo, ha la capacità di giudicare il tempo, in un
certo senso di rendersi conto del passare del tempo, ha in sé degli elementi di
atemporalità.
Lasciando parlare il testo delle Idee II, Ales Bello commenta le seguenti frasi estrapolate dal par. 39 Significato del corpo vivo per la costituzione di oggettività superiori: “Anche al di là di questo, il corpo vivo è sempre partecipe di tutte le altre “funzioni della coscienza”, e ciò ha fonti diverse” – i termini corpo vivo, o vivente, o proprio, sono possibili traduzioni di Leib che comprende psiche
e corpo – “la localizzazione che si dà nell’intuizione immediata e il riferimento
col corpo vivo che in ciò si fonda sono propri non soltanto delle sensazioni sensoriali che esercitano una funzione costitutiva per la costituzione delle cose
sensoriali, degli oggetti che si manifestano nello spazio, ma anche di sensazioni relative a gruppi complementari diversi, così per esempio dei sentimenti
‘sensibili’, delle sensazioni di piacere e di dolore, del senso di benessere che
attraversa e riempie tutto il corpo, del dialogo generale derivante da un’indisposizione corporea, ecc. Rientrano qui dunque gruppi di sensazioni che per gli atti valutativi, per i vissuti intenzionale della sfera del sentimento, oppure per la
costituzione dei valori come loro correlati intenzionali, svolgono un ruolo di materiali analogo a quello che le sensazioni primarie svolgono per i vissuti intenzionale nella sfera dell’esperienza oppure per la costituzione di oggetti spaziali-cosali”.
Per indicare il termine “materiali” Husserl usa le parole tedesche materiell,
stofflich, ma anche la parola greca hyle: sfera di materiali che servono per gli
atti valutativi, come le sensazioni primarie, quelle fisiche (vista, tatto….) servono per i vissuti intenzionali nella sfera dell’esperienza, cioè per la costituzione
di oggetti spaziali-cosali. Husserl sviluppa questa analisi dell’hyletica nelle sintesi passive. Ales Bello apre una parentesi su queste sintesi in riferimento alla
questione del rimosso e ad una possibile relazione tra Husserl e Freud: entrambi parlano di magma impulsivo, di inconscio come territorio magmatico.
Nello specifico Husserl si sofferma a domandarsi quali sono le potenze che ci
impediscono di rivivere quello che era stato vissuto.
Il territorio dei materiali serve, secondo la riflessione husserliana, per la percezione e per l’organizzazione psichica, in cui ci sono degli strati impulsivi profondi. In questo si può cogliere una interessante vicinanza con Freud, in quanto entrambi avevano seguito le lezioni di Brentano, il quale aveva fornito delle
utili indicazioni sull’analisi qualitativa degli atti psichici. Percorrendo questo
sentiero Husserl giunge a elaborare una riflessione sugli impulsi profondi che
costituiscono i materiali.
C’è, dunque, un materiale ed è questa la hyle che vale per la costituzione
del mondo fisico, per quella del mondo psichico, è un materiale passivo, profondo, che “precede a”. Il materiale hyletico è studiato dalla sintesi passiva, in
quanto in questa si studiano le modalità profonde che sono di tipo associativo,
197
dissociativo, … Sono questi i passaggi, molto densi e suggestivi, dello scavo
archeologico compiuto da Husserl, che come pone in rilievo Ales Bello sono indicativi di una azione che si esercita su strati che non sono di per sé intellettuali.
In altri termini questa questione della dimensione hyletica è importate perché non è semplicemente un qualcosa di aggiunto, ma è una base costitutiva
dell’essere umano, ed è costitutiva nella globalità dell’essere umano stesso.
Ed è questo curvarsi del discorso che porta Husserl dalla logica in cui studia i
giudizi, esaminata in parte nelle Ricerche logiche e nella I parte di Logica formale e trascendentale, a ridiscendere a livello pre percettivo e al riandare alla
dimensione trascendentale. Tale percorso è valido sia per l’aspetto gnoseologico, che per quello sociologico, valutativo ed etico. Anche l’elborazione culturale è attività spirituale, che legandosi alla dimensione più profonda hyletica, tira fuori tutta una organizzazione, una ritualizzazione. Dunque, a livello della
hyle qualsiasi nostra manifestazione passa attraverso una complessa stratificazione, nessun elemento è eliminabile. Ales Bello rinviene la possibilità di una
applicazione anche nell’ambito della dimensione sacrale e religiosa, in quanto
quella è la dimensione in cui la sfera hyletica lavora a livello interreligioso, ma
anche a livello delle nostre religioni storiche, tutta la dimensione sacramentale
è una dimensione hyletica.
198
Daniela De Leo
Il secondo incontro con i componenti delle Unità di Ricerca di Roma Tre,
Verona, Sassari, Bari e Lecce del Prin 2005 si è tenuto venerdì 26 gennaio
2007 presso la Fondazione Nova Spes a Roma.
Roma
Gabriella Farina, responsabile dell’Unità di Roma Tre, ha illustrato la relazione dell’attività di ricerca della sua Unità. Un primo modulo del programma
dell’Unità, tendente ad individuare linee interpretative nuove ed originali, nonché a promuovere la diffusione di testi inediti del filosofo francese J.-P. Sartre,
ha avuto come nucleo tematico”A partire da J.-P. Sartre: Filosofie europee e Filosofie interculturali del Novecento”.
I primi risultati della ricerca sono stati:
1) la pubblicazione del secondo tomo della Critica della ragione dialettica.
L’intelligibilità della storia, a cura di P.A. Rovatti e presentazione di Gabriella
Farina, prima edizione in lingua italiana pubblicata da Christian Marinotti Editore;
2) la pubblicazione del secondo numero del Bollettino di Studi sartriani, Biblink editori, dedicato a Sartre e la storia, che raccoglie i contributi di Santo Arcoleo, Giuseppe Cacciatore, Antonio Delogu, Cristina Ficorilli, Raoul Kirchmayr, Amo Müster, Graziella Pagliano;
3) è in corso di stampa la prima edizione in lingua italiana del testo di J.-P.
Sartre, La liberté cartesienne, che raccoglie anche alcuni brani tratti dalle Meditationes di R. Descartes. Il testo è curato da Nestore Pirillo, pubblicato da
Christian Marinotti Editore e rappresenta un importante momento di riflessione
sul rapporto tra contingenza e libertà in Sartre.
Un secondo modulo del programma dell’unità coordinato da Lidia Procesi
registra i seguenti risultati:
1) la pubblicazione della prima edizione in lingua italiana del testo di F.
Eboussi Boulaga Autenticità africana e filosofia. La crisi del Muntu. Intelligenza responsabilità e liberazione, a cura di Lidia Procesi, Christian Marinotti Editore;
2) l’organizzazione della presentazione, curata da Jean Léonard Touadi,
Assessore alle Politiche Universitarie e Giovanili del Comune di Roma, che si
è svolta nell’Aula Dipartimentale “Valerio Verra” della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre, del libro di Filomeno Lopes, Le radici del pensiero africano. Dialogo tra la filosofia della storia e la teologia in Engelbert Mveng,
Harmattan Italia editore (30 novembre 2006);
NOTIZIARIO
FENOMENOLOGIA, NARRAZIONE,
RIFLESSIONE ETICO-POLITICA:
TESTI E TEMI DEL PENSIERO FRANCESE
DEL NOVECENTO
199
200
3) la celebrazione del centenario della nascita di Léopold Sédar Senghor,
svoltasi nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre il 30 novembre 2006. Hanno partecipato il Senatore Giovanni Pieraccini, Jean Léonard Touadi, E. Matassi, V. Pompeiano, L. Procesi e G. Farina.
L’attrice Caterina Deregibus ha letto alcune poesie di Léopold Sédar Senghor.
Un terzo modulo, che può costituire un filo conduttore originale ed ancora
inesplorato, è quello del confronto tra l’inesausto esercizio del pensiero francese contemporaneo sulle tematiche religiose (Deleuze, Ricoeur, Lévinas, Janicaud, Hénaff, Girard, Greisch, Courtine, Marion ecc.) con la riflessione di J.-P.
Sartre. È in ordine a queste tematiche, in particolare sulla questione della “laicità”, sulla domanda “quanto è religioso il cosiddetto scontro di civiltà?” – dibattiti dalla chiara ricaduta nell’attualità e che, tuttavia, necessitano di una prospettiva storica e di strumenti teorici adeguati – che si è orientata recentemente la ricerca di Laura Paoletti (cfr. L. Paoletti, a cura di, L’identità in conflitto dell’Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo, Il Mulino, Bologna 2005, in particolare il saggio introduttivo Cristianesimo e identità conflittuale dell‘Europa, e il
saggio Laicità ed interpretazione, in “InnovAzioni”, n. 4, settembre/Ottobre
2005).
Linee di programmazione:
1) è in programmazione il terzo numero del Bollettino che sarà dedicato a
Sartre e l’intercultura. Gabriella Farina ha sottolineato che chiunque sia interessato a presentare un intervento, di non più di 10 cartelle, dovrà far pervenire al Comitato scientifico nei prossimi giorni il titolo e inviare il saggio entro settembre 2007;
2) è in programmazione la nuova edizione in lingua italiana del testo di J.P. Sartre, Orfeo nero, a cura di Gabriella Farina, Christian Marinotti Editore. Il
testo ripropone all’attenzione dei ricercatori l’interesse che Sartre, a partire dal
1945, ha rivolto al problema “Africa” e all’universo della négritude;
3) è prevista una presentazione del libro di F. Eboussi Boulaga, cit., con la
partecipazionedell’autore e del professor Mariano Pavanello, antropologo africanista, dell’Università La Sapienza.
Verona
Chiara Zamboni, in qualità di responsabile dell’Unità di Verona, presenta
l’ambito della ricerca del suo gruppo. È un lavoro in fieri, orientato non tanto a
partire dagli scritti, anche se la specificità indicata dal coordinatore nazionale,
Giovanni Invitto, è lo studio dei testi, ma a lavorare per trovare nel testo, in
quanto testo, una forma dell’oralità. La proposta è quella di organizzare un seminario nel quale invitare delle pensatrici francesi che hanno una formazione
radicata nel Novecento. Si costituirà, quindi, un gruppo di lavoro legato alle tematiche filosofiche del Novecento. Chiara Zamboni sottolinea che queste pensatrici saranno invitate a parlare del rapporto tra contraddizioni contemporanee, cioè quelle contraddizioni che sono emergenti in qualche modo anche evidente, e quelle “non contemporanee”, cioè quelle contraddizioni che non sono
evidenti nel simbolico, orientando lo sguardo del femminile verso queste ultime contraddizioni.
Sassari
Antonio Delogu, in qualità di responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca di
Sassari, illustra l’attività del suo gruppo. Una parte del percorso di ricerca è stato dedicato a Sartre, e viene ricordata la giornata di studi svolta a Sassari, dedicata a Sartre e le arti. Un altro campo di indagine è rappresentato dalla filosofia di Jankélevitch. Presso l’Editore Cortina entro settembre 2007 si pubblicherà la traduzione italiana del Corso di filosofia morale di Jankélevitch, testo
pubblicato nel marzo 2006. L’importanza del libro è nell’agilità congeniale e
nell’impianto categoriale della distanza tra etica e religione, etica e ambito delle scienze umane. Un ulteriore ambito sul quale l’Unità di Sassari ha sviluppato la propria ricerca è stato quello del rapporto tra la fenomenologia francese
e quella italiana. Nello specifico è stato affrontato lo studio del pensiero di Capograssi. L’obiettivo prefissato è la pubblicazione, presso la Bompiani, dell’Opera omnia, letteraria e filosofia, in cui si evince il percorso interno di Capograssi e gli influssi del pensiero francese, di Bergson in particolare. Il progetto
prevede la pubblicazione dell’opera in francese, con la collaborazione di Santo Arcoleo. Una terza traccia è quella che riguarda lo svolgimento di una riflessione sul percorso della “fenomenologia pratica” francese: saper vivere come
saper esistere.
NOTIZIARIO
Le pensatrici che verranno invitate sono:
– Françoise Collin, che ha lavorato molto su Hannah Arendt e su Lévinas,
orientando i suoi interessi di ricerca verso lo sguardo sullo spazio pubblico e
sulla condizione femminile come sguardo sul mondo, non come sguardo di genere. Alcuni nuclei tematici che saranno affrontati nella relazione possono essere rintracciabili nell’intervento di Collin sulla rivista “Diotima. Per amore del
mondo”,
– Françoise Duroux, studiosa di filosofia antica, nello specifico su tematiche
etiche. Anche lei ha scritto sulla rivista “Diotima”.
– Christiane Veauvy, una sociologa, i cui interessi gravitano intorno al pensiero delle donne nel Mediterraneo, nell’intreccio tra contraddizioni e non contraddizioni. Queste problematiche potrebbero costituire lo sfondo di interesse
comune con le altre prospettive di ricerca sull’intercultura.
– Nadia Setti, docente e direttrice del Centre de Recherche d’Etudes Féminines dell’Università Paris 8, la cui indagine di ricerca è a cavallo tra letteratura e psicoanalisi. Lavorando nell’ambito della Cixous persegue la riflessione
della lingua come pulsionalità.
La modalità scelta per questo seminario, per realizzare l’ipotesi di ricerca
dell’oralità come testo, è quella di far svolgere due relazioni, di cui i testi saranno divulgati con largo anticipo. Sarà data preminente importanza alla discussione, da intendere come procedimento di pensiero. Al seminario si accederà
soltanto per invito. Le filosofe invitate a relazionare parleranno nella propria lingua. Il seminario si svolgerà il 23 aprile 2007 dalle ore 10.00 alle ore 19.00. I
contributi saranno pubblicati e si prevede anche la pubblicazione delle tematiche che emergeranno durante il seminario.
201
202
Bari
Giusy Strummiello, componente dell’Unità di Ricerca di Bari, illustra l’ambito di ricerca del gruppo. Il nucleo tematico intorno al quale ruota la riflessione
è la vita come questione filosofica e l’interpretazione dell’esistenza nella filosofia francese del Novecento. Questo progetto nasce dalla lunga esperienza di
Giovanni Cera, responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Bari, e dagli interessi di Giusy Strummiello sulla tematizzazione dell’esistenza nella filosofia
francese del Novecento. Come primi risultati la pubblicazione del libro di Cera,
Identità e vita, Collana Duepunti, Bari 2006.
È in preparazione, e verrà pubblicato nel 2007, un libro di Giusy Strummiello sul significato e il problema della vita in filosofia, in prospettiva teoretica, in cui si riprende un percorso che parte dalla filosofia aristotelica, attraversa la filosofia contemporanea e si soffermando su Bergson, Foucault e
giunge all’ultimissimo Derrida., dei volumi postumi Animale che dunque sono e Prendere infine a vivere. Inoltre, Giusy Strummiello relaziona sul suo
contributo Filosofia e metafilosofia in Erich Weil, portato al Congresso internazionale su Erich Weil, sottolineando che l’importanza di collocare il filosofo a pieno titolo all’interno della discussione attuale della filosofica come
prassi filosofica. In collaborazione con l’Università di Lecce e l’École Normale Supérieure di Paris sono in programmazione due giornate (4-5 maggio
2007) dedicate a Bergson in occasione del centenario della pubblicazione
della Évolution créatrice.
La prima giornata da realizzarsi a Bari, avrà come fuoco prospettico il problema religioso.
Sono previsti interventi:
– di Narbonne dell’Università del Canada, sulla presenza dei greci nel pensiero religioso di Bergson;
– di Breueer dell’Università di Lovanio sul tema la vita e il nulla;
– di Rocco Ronchi dell’Università dell’Aquila, sul quarto capitolo dell’Évolution créatrice;
– di Giusy Strummiello su Dio e la vita nell Évolution créatrice.
– di Worms, sulla questione del vitale, che costituirà l’elemento comune tra
le due sedi, quella di Bari e quella di Lecce. Gli Atti di tale giornata saranno
pubblicati.
Sono previsti, inoltre, nell’attività di programmazione dell’Unità di Bari una serie di seminari, presso l’Università di Bari, su questo tema della vita secondo l’impostazione teoretica. Tra gli altri, Narbonne terrà un seminario su Lévinas.
Lecce
Daniela De Leo, in qualità di componente dell’Unità di Ricerca di Lecce ed
in assenza del coordinatore del Prin nazionale, Giovanni Invitto, illustra l’attività del gruppo, in sintesi, da lei curate e riportate nella rivista “Segni e comprensione” (n. 58, a. XX, maggio-agosto 2006; pp. 170-173 e “Segni e comprensione”, n. 59, a. XX, settembre-dicembre 2006, pp. 148-150).
I primi risultati della ricerca sono stati:
1) la pubblicazione del volume Fenomenologia del mito. La narrazione tra
Ricerche di studiosi esterni al Prin, ma collaboratori
Aniello Montano, in qualità di collaboratore esperto, esterno al Prin, presenta
NOTIZIARIO
cinema, filosofia, psicoanalisi, a c. di G. Invitto, Manni, San Cesario di Lecce
2006, pp. 280;
2) la pubblicazione del volume La fenomenologia e l’oltre-fenomenologia.
Prendendo spunto dal pensiero francese, con c. di G. Invitto, con saggi di F.
Ferrarotti, G. Vattimo, M. Forcina, S. Arcoleo, R. Barbaras, W. L. McBride, R.
Capone, D. De Leo, M. L. Colì, Mimesis, Milano 2007 (nelle librerie a fine gennaio 2007);
3) la pubblicazione del volume L’enigma della trascendenza. Riflessi eticopolitici dell’alterità, a c. di N. Comerci, Editori Riuniti, Roma 2006, pp. 304.
Apporti nuovi, già definiti in sintesi nelle pubblicazioni citate, paiono in particolare, a parere del cordinatrore, quelli di Maria Lucia Colì, su inediti merleaupontyani che riguardano la natura, e di Daniela de Leo su inediti dello stesso filosofo, relativi alla musica. Si aggiungono le ricerche prevista dal progetto
di Giovanni Invitto, responsabile scientifico dell’Unità di ricerca leccese, Marisa Forcina, Angelo Bruno e Raffaele Capone.
Nel corso dell’anno 2006 si sono svolti i seguenti seminari tenuta da:
– Renaud Barbaras (École Normale Supérieure di Paris) su Sartre: une
phénoménologie de l’impossibilité de la phénoménologie e Le problème de
l’apparaître chez J. Patocka. Phénoménologie dynamique et dynamique phénoménologique;
– Frédéric Worms (Université de Lille III; Directeur du “Centre international
d’étude de la philosophie française contemporaine” all’Ecole Normale Supérieure de Paris) su Qu’est-ce qui est vital? De Bergson à aujourd’hui une discussion sur la philosophie française contemporaine (il testo apparirà in ”Segni e comprensione” di maggio 2007);
– William L. McBride (Purdue University di West Lafayette, Indiana) su Sartre e Beauvoir nell’asse del secolo ventesimo.
Nel 2007 sono previsti i seguenti seminari:
– 2 febbraio, Angela Ales Bello (Pontificia Università Lateranense) su La valenza teoretica della hyletica fenomenologia
– 20 e 21 aprile, V edizione del seminario su “Cinema, filosofia, psicoanalisi. - Il falso”
– 3-5 maggio 2007, Colloque su “L’Évolution créatrice e il problema religioso (1907-2007)”
enti promotori: École Normale Supérieure – Centre international de la philosophie française contemporaine, Paris; Association des amis de Bergson – Paris; Università degli Studi di Lecce; Università degli Studi di Bari; Dottorato di ricerca Lecce-Paris IV “Forme e storia dei saperi filosofici”; Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali di Lecce, con Frédéric Alain Worms; Jean-Robert Armogathe (Ecole des Hautes Etudes di Parigi); Ornella Pompeo Faracovi; Franco
Meschini; Giulia Belgioioso; Marisa Forcina; Giovanni Invitto e Santo Arcoleo;
– 14 e 15 giugno 2007, Mauro Carbone (Università Statale di Milano) su
Proust, l’11 settembre 2001 e il pensiero francese contemporaneo.
203
il suo lavoro di ricerca ampiamente articolato nel libro di cui è autore, Solitudine e
solidarietà, edizione Bibliopolis, Napoli 2006. Alcuni dei saggi raccolti in questo libro sono stati scritti tra il 2005 e il 2006 ed erano fino alla pubblicazione inediti. Altri, scritti e pubblicati, negli anni precedenti, sono stati ripresi, rielaborati nel libro
e arricchiti nella bibliografia essenziale. I primi due, Mondanità e contingenza della storia in Sartre e La morale sartriana come modalità dell’essere-per-altri,inediti, ed altri saggi editi. È dunque una raccolta di saggi in cui si sviluppa una sorta
di pensiero sull’esistenzialismo francese, nel suo radicamento profondo all’interno della fenomenologia, che si afferma a partire dagli anni Trenta del Novecento.
204
Conclusione dei lavori
Concludendo i lavori, Gabriella Farina ha invitato i partecipanti a riflettere su
un ambito che si è aperto nell’illustrazione spontanea e graduale dei lavori dei
singoli gruppi di ricerca, quello sulla filosofia pratica, riprendendo lo scarto tra
filosofia pratica e pratica filosofica, recuperando la componente etico-morale
del filosofare. Questo ambito coinvolge l’aspetto storico, etico, nel quale si articolano le riflessioni, i programmi e le ricerche delle Unità, agganciando intercultura e pensiero femminile. Chiara Zamboni sottolinea l’importanza del recuperare la dimensione della filosofia pratica, l’etica come riflessione all’interno
di un ambito esistenziale. E propone di tradurlo in una riflessione sull’impersonale dell’esperienza. La filosofia pratica mette in gioco l’ontologia. La filosofia
del pensiero nasce nell’esistenza in una dimensione etico-ontologica.
Montano sottolinea il concetto di “primato” della filosofia pratica. E aggiunge che se non si vuol scivolare in facili confusioni, in una base in cui la filosofia pratica è la ricaduta nel pensiero aristotelico-kantiano, cioè sulla base della ricerca dei valori, occorre pensare ad una nuova dimensione in cui discutere. La filosofia pratica sfocia in una sorta di guerra guerreggiata su che cosa
sia il bene. Occorre spostare lo sguardo sulla realtà altrimenti si scriverà una
appendice a questa grande enciclopedia della filosofia pratica. Trovare un filone: il primato della nozione massima del male del mondo piuttosto del primato
della nozione massimale di ciò che è bene e di ciò che è male nel mondo.
Chiara Zamboni interviene puntualizzando che l’esperienza è apertura e riprende Simone Weil: la filosofia come atto e pratica. Non si deve scivolare nei
valori, ma attraverso la sofferenza ottenere il guadagno del “sapere” che è portato dall’altro. L’esperienza, quindi, vista come impersonale, guadagno e come
elemento che può portare nella dimensione pubblica. Delogu interviene ponendo l’attenzione sulla pratica della filosofia come stile di vita. Santo Arcoleo, a
sua volta, apre una ulteriore riflessione sull’evoluzione del concetto di coscienza e una possibile analisi del rapporto della filosofia francese con quella americana, nello specifico con il pensiero di Nozick e Rawls.
Infine, si ricorda che è prevista, per l’anno 2007, l’organizzazione di una tavola rotonda conclusiva del lavori del Prin, sulle tematiche affrontate in questo
bienno dalle singole Unità di Ricerca.
sintesi a cura di Daniela De Leo
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA “SEGNI E COMPRENSIONE”
Volumi:
F. E. BOULAGA, Autenticità africana e filosofia, trad. e cura di L. Procesi, Marinotti, Milano 2007, pp. 278:
S. CAVACIUTI, Coscienza morale e trascendenza. Il problema morale in Maine de Biran:
Parte VII/1: Ricognizione della vita e degli scritti religiosi biraniani, F. Cesati, Firenze
2006, pp. 400;
Cuore di mamma e altri racconti africani, a c. di C. Ferrandes, S. Petrilli, A. Ponzio, J.
E., Konvolbo, Carabba, Lanciano 2006, pp. 54;
G. DELEUZE, G. CANGUILHEM, Il significato della vita, a c. di G. Bianco, con un saggio di
F. Worms, Mimesis, Milano 2006, pp. 136;
A. MONTANO, Solitudine e solidaritetà. Saggi su Sartre, Merleau-Ponty e Camus, Bibliopolis, Napoli 2006, pp. 190;
L. MURARO e A. SBROGIÒ, a cura di, Il posto vuoto di Dio, Marietti 1820, Genova 2006,
pp. 246;
F. NUZZACI, L’idea della vita. Saggio su Claude Bernard, Milella, Lecce 2006, pp. 374;
L. ROMANO, Niente da ridere, Marsilio, Venezia 2007, pp. 360;
S. PETRILLI, a cura di, Comunicazione Interpretazione Traduzione, Mimesis, Milano
2006, pp. 654.
Periodici:
Aesthetica Preprint. Supplementa, n. 19, dicembre 2006: Attraverso l’immaginazione.
In ricordo di Cesare Brandi, a c. di L. Russo; C.I.S.d.E., Palermo;
Antologia Vieusseux, n. s., a. XI, n. 33, settembre-dicembre 2005; Gabinetto scientifico
letterario G. P. Vieusseux, Firenze;
Foedus, n. 16, 2006; Associazione Artigiani e Piccole Imprese, Mestre
Giornale di Metafisica, n.s. n. 1, 2006; n. 2, 2006: Forme dell’argomentazione metafisica; Tigher, Genova;
Phenomenological Inquiry, v. 29, oct. 2005: Aesthetic Expression of the Moral Sentiment, edt. A. T. Tymieniecka; Hanover, New Hampshire, U.S.A.;
L’immaginazione, nn. 227, 228, 2007; Manni, San Cesario di Lecce;
Rivista di Filosofia, n. 1, 2007; il Mulino, Bologna;
Studia Patavina, n. 3, a. LIII, settembre-dicembre 2006; Facoltà Teologica del Triveneto, Padova.
205
206
207
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o Dipartimento di Filosofia e scienze sociali – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano.
Ogni cartella non dovrà superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche su floppy disk, usando un qualsiasi programma
che, però, dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Si può utilizzare preferibilmente anche l’e-mail: [email protected]. Il materiale
ricevuto non verrà restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche, previa comunicazione e approvazione
dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
208