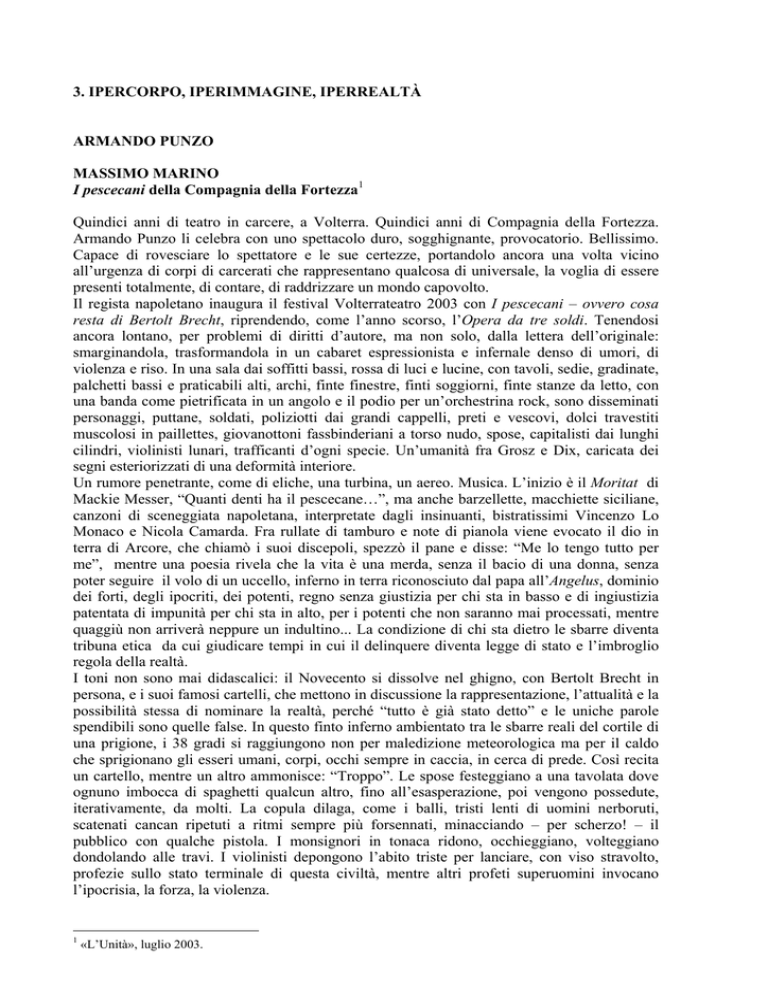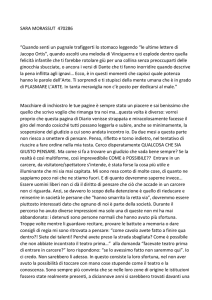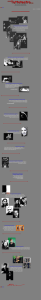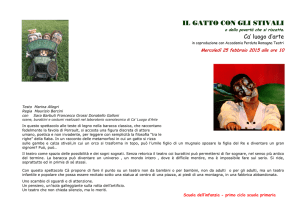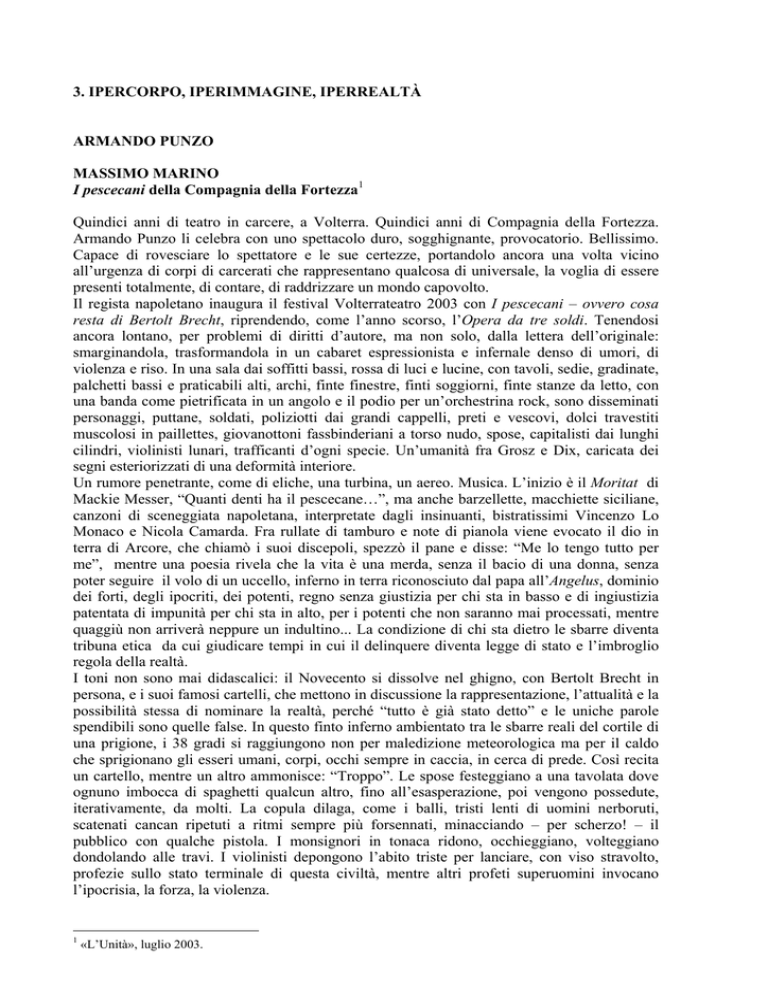
3. IPERCORPO, IPERIMMAGINE, IPERREALTÀ
ARMANDO PUNZO
MASSIMO MARINO
I pescecani della Compagnia della Fortezza1
Quindici anni di teatro in carcere, a Volterra. Quindici anni di Compagnia della Fortezza.
Armando Punzo li celebra con uno spettacolo duro, sogghignante, provocatorio. Bellissimo.
Capace di rovesciare lo spettatore e le sue certezze, portandolo ancora una volta vicino
all’urgenza di corpi di carcerati che rappresentano qualcosa di universale, la voglia di essere
presenti totalmente, di contare, di raddrizzare un mondo capovolto.
Il regista napoletano inaugura il festival Volterrateatro 2003 con I pescecani – ovvero cosa
resta di Bertolt Brecht, riprendendo, come l’anno scorso, l’Opera da tre soldi. Tenendosi
ancora lontano, per problemi di diritti d’autore, ma non solo, dalla lettera dell’originale:
smarginandola, trasformandola in un cabaret espressionista e infernale denso di umori, di
violenza e riso. In una sala dai soffitti bassi, rossa di luci e lucine, con tavoli, sedie, gradinate,
palchetti bassi e praticabili alti, archi, finte finestre, finti soggiorni, finte stanze da letto, con
una banda come pietrificata in un angolo e il podio per un’orchestrina rock, sono disseminati
personaggi, puttane, soldati, poliziotti dai grandi cappelli, preti e vescovi, dolci travestiti
muscolosi in paillettes, giovanottoni fassbinderiani a torso nudo, spose, capitalisti dai lunghi
cilindri, violinisti lunari, trafficanti d’ogni specie. Un’umanità fra Grosz e Dix, caricata dei
segni esteriorizzati di una deformità interiore.
Un rumore penetrante, come di eliche, una turbina, un aereo. Musica. L’inizio è il Moritat di
Mackie Messer, “Quanti denti ha il pescecane…”, ma anche barzellette, macchiette siciliane,
canzoni di sceneggiata napoletana, interpretate dagli insinuanti, bistratissimi Vincenzo Lo
Monaco e Nicola Camarda. Fra rullate di tamburo e note di pianola viene evocato il dio in
terra di Arcore, che chiamò i suoi discepoli, spezzò il pane e disse: “Me lo tengo tutto per
me”, mentre una poesia rivela che la vita è una merda, senza il bacio di una donna, senza
poter seguire il volo di un uccello, inferno in terra riconosciuto dal papa all’Angelus, dominio
dei forti, degli ipocriti, dei potenti, regno senza giustizia per chi sta in basso e di ingiustizia
patentata di impunità per chi sta in alto, per i potenti che non saranno mai processati, mentre
quaggiù non arriverà neppure un indultino... La condizione di chi sta dietro le sbarre diventa
tribuna etica da cui giudicare tempi in cui il delinquere diventa legge di stato e l’imbroglio
regola della realtà.
I toni non sono mai didascalici: il Novecento si dissolve nel ghigno, con Bertolt Brecht in
persona, e i suoi famosi cartelli, che mettono in discussione la rappresentazione, l’attualità e la
possibilità stessa di nominare la realtà, perché “tutto è già stato detto” e le uniche parole
spendibili sono quelle false. In questo finto inferno ambientato tra le sbarre reali del cortile di
una prigione, i 38 gradi si raggiungono non per maledizione meteorologica ma per il caldo
che sprigionano gli esseri umani, corpi, occhi sempre in caccia, in cerca di prede. Così recita
un cartello, mentre un altro ammonisce: “Troppo”. Le spose festeggiano a una tavolata dove
ognuno imbocca di spaghetti qualcun altro, fino all’esasperazione, poi vengono possedute,
iterativamente, da molti. La copula dilaga, come i balli, tristi lenti di uomini nerboruti,
scatenati cancan ripetuti a ritmi sempre più forsennati, minacciando – per scherzo! – il
pubblico con qualche pistola. I monsignori in tonaca ridono, occhieggiano, volteggiano
dondolando alle travi. I violinisti depongono l’abito triste per lanciare, con viso stravolto,
profezie sullo stato terminale di questa civiltà, mentre altri profeti superuomini invocano
l’ipocrisia, la forza, la violenza.
1
«L’Unità», luglio 2003.
Armando Punzo ha composto una danza di morte scatenata, vitale, che travolge, distanzia,
rapisce. In questo contromondo troviamo più verità che in quello reale. Urlano, soprattutto, fra
il Cielo in una stanza cantato in francese da Carla Bruni e le musiche jazzate della banda di
Pomarance, negli stridori acidi del complessino rock, i corpi: fisici forti, compressi, che si
trasformano in personaggi con i segni della degradazione di un’epoca, evocando la necessità
di una diversa libertà, di un mondo migliore. La canzone finale, un ritmato, forsennato Fuori
dal tunnel di Carapezza, unisce spettatori e attori in un ballo, un corteo, un abbraccio finale
che si vorrebbe non finissero mai.
Sabato 26, per la prima volta dopo molti anni, la Compagnia esce dalla Fortezza per
rappresentare I pescecani al Teatro Persio Flacco, alle 21.
MASSIMO MARINO
Il vuoto, ovvero quello che resta di Bertolt Brecht di Armando Punzo2
Dopo il premio Ubu per I pescecani, Armando Punzo torna a Brecht con un nutritissimo
gruppo di attori e attrici giovani, di diverse nazionalità e lingue, senza i carcerati della
Compagnia della Fortezza. Lo stesso significativo sottotitolo del lavoro costruito nel 2003
nella prigione di Volterra, Quel che resta di Bertolt Brecht, è preceduto ora da un titolo
perentorio: Il vuoto. Il nuovo spettacolo ha debuttato al Festival di Liegi, una rassegna che
interroga il presente con il teatro, la danza e la musica, che “si tuffa nel cuore del reale”, come
scrive il direttore Jean-Louis Colinet, che racconta i conflitti del mondo in cui viviamo con
artisti africani e sudamericani, ma anche con Ascanio Celestini, Emma Dante e Lars Noren.
Non poteva, allora, mancare un artista dirompente come Punzo. In una scena espressionista e
infernale, sghembi stanzini illuminati di rosso sovrapposti su più piani, buchi di caverne
civilizzate con i mobili inclinati da qualche terremoto, si agitano ladri, puttane, poliziotti,
bellimbusti, magnaccia, ecclesiastici. È tutto un copulare, un vivere e mostrasi di corpi
giovani, vecchi, segnati. Un’orchestra di pallide figurine di allucinato presepe è incastonata in
parte in uno dei piani più alti, in parte ai piedi del palco, condotta da un direttore spiritato,
pronto a trascinarla con salti frenetici verso ritmi insostenibili. Su un bordo della scena
impazza un complesso rock.
Come nello spettacolo visto in carcere, qui ripreso e approfondito, un can can ripetuto a ritmi
sempre più indiavolati rompe il quadro iniziale ispirato all’Opera da tre soldi di Brecht: il
bordello, il matrimonio di Mackie Messer che subito sodomizza la sposa sul tavolo nuziale,
vescovi alle prese con amplessi sadomaso, lascive gemelle siamesi, acrobati, esibizionisti,
nani. Il movimento di offerta e di dominazione continuerà per tutto lo spettacolo, mentre
alcuni personaggi gridano la violenza, la potenza, il sesso e il denaro come sole religioni
dell’uomo.
Nietzsche si incrocia con Marilyn Manson, il rock duro con le musiche di Kurt Weill, il cha
cha cha fa bum bum come un revolver, balletti si chiudono con sventagliate di mitragliatrici,
fra una struggente Indifferentemente che chiede «e damme ’stu veleno», liste di armi e un
lentissimo bacio lesbico. Pistole e pugnali danzano lungo i corpi in pericolose seduzioni, voci
di tentatori attirano nel buio, papi impiccati proclamano strozzati il mondo futuro. C’è di tutto
e di più, Grosz e Genet, in un dichiarare urlato, che sembra finire e ricomincia, che straripa
nella platea con cartelli, che chiama in campo Saddam e Bush, che rifiuta di parlare ancora del
presidente del Milan e della resistenza.
È un varietà grottesco che fa il vuoto per accumulo di troppo pieno, che piange l’impotenza
dell’arte a cambiare il mondo, che fa esplodere le nostre ossessioni di possesso, di immagine,
il nostro continuo venderci. Brecht è un residuo, una speranza naufragata, riassorbita, il gesto
e il canto di una tamburina che prova a guidarci fuori da un inferno nel quale non possiamo
non ricadere. Il teatro è cambiamento da inventare. La vita, soprattutto, è ancora da
2
«L’Unità», febbraio 2005.
trasformare, e la società, sembra dirci Punzo, trascinandoci in continuazione per strade che
sentiamo di aver già percorso, eppure ogni volta sgradevolmente nuove.
Lo spettacolo, guidato dalle scariche elettriche del narratore Stefano Cenci e dalle apparizioni
della carismatica, roca Gelsomina brechtiana di Martina Krauel, unisce attori che recitano in
italiano, francese e tedesco a un gruppo di figuranti e di musicisti reclutati in ogni luogo di
rappresentazione e integrati con un lungo laboratorio.
Punzo, secondo il suo uso, durante le repliche cambierà il montaggio delle scene, aggiungerà
o toglierà testi e canzoni, proclami, colpi allo stomaco e lampi di lacerata poesia. Questo
artista, anche fuori dall’emergenza del carcere, non rinuncia a sperimentare il teatro come
processo vivente, come tentativo di verità, di presenza totale e sorprendente al di fuori delle
rassicurazioni della forma, atto effimero capace di spaccare e ricostruire. Non interroga solo le
vecchie questioni senza risposta che Brecht ha posto. Ci chiede di rovesciare mille volte le
apparenze le certezze le cose e noi stessi, per guardare radicalmente, dolorosamente a fondo.
Coprodotto anche dal Teatro Metastasio – Stabile della Toscana, Il vuoto va in scena in prima
nazionale, sottotitolato in italiano, al Fabbricone di Prato dall’8 al 12 febbraio.
MASSIMO MARINO
Da istituto di pena a istituto di cultura. Intervista ad Armando Punzo3
Nel dicembre 2005 ho realizzato due interviste ad Armando Punzo intorno al suo lavoro con
la Compagnia della Fortezza. L’intervento nel carcere di Volterra, iniziato nel 1988 e
sviluppatosi come principale attività dell’Associazione Carte Blanche, ha prodotto spettacoli
annuali alla fine di laboratori svolti con continuità, con esiti artistici riconosciuti da pubblico e
critica. A fianco degli spettacoli realizzati in prigione è cresciuto un importante festival di
teatro, Volterrateatro. Punzo è riuscito a instaurare un rapporto particolare con il Ministero
della Giustizia, con la Direzione della casa di reclusione di Volterra, con le guardie
penitenziarie, trasformate in convinti collaboratori dell’esperienza, con le altre componenti
della prigione. Nel 2000 è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Compagnia, il Ministero
della Giustizia, l’Ente Teatrale Italiano, la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune e
l’istituto penale di Volterra per la costituzione del Centro Nazionale Teatro e Carcere.
Qual è secondo te la metodologia del lavoro teatrale in carcere?
Io non ho “una” metodologia. Io posso parlare della “mia” metodologia. Ognuno ha la sua,
quella che applica al suo laboratorio. Mettendo a confronto diverse metodologie si possono
estrarre buone prassi comuni.
Io, quando entro in carcere, abolisco innanzitutto l’idea di carcere dentro di me. Posso essere
in un posto come in un altro. Mi dico: «Vado in un luogo a fare teatro». Così è stato fin dagli
inizi, diciotto anni fa, quando abbiamo iniziato l’attività nel carcere di Volterra.
Molti pensano che la mia sia stata una scelta dettata da motivi ideologici o sociali. Invece,
semplicemente, in quegli anni volevo fare uno spettacolo con tanti attori e un giorno,
guardando il carcere di fronte al nostro teatro, ho pensato che lì forse c’era la possibilità di
farlo. Dopo qualche mese è arrivata dal Comune di Volterra, inaspettatamente, la proposta di
realizzare un laboratorio di due mesi con i detenuti del Maschio. È stato un incontro così
importante e ricco che da allora non siamo più usciti e abbiamo creato una vera compagnia di
teatro lì dove sembrava impossibile che questo avvenisse. Anche se è evidente che col passare
del tempo mi sono reso conto che non è mai solo un caso trovarsi in un posto o in un altro e
che evidentemente stavo cercando qualcosa che non trovavo nel così detto teatro ufficiale.
Bisogna sempre chiedersi: cosa voglio fare quando entro in carcere? Voglio rafforzare o
indebolire l’istituzione? Il mio intervento non è finalizzato al carcere, al detenuto. Cerco di
3
Questa intervista, fin’ora inedita, è stata realizzata nell’ambito della ricerca condotta da Massimo Marino su
Teatro e carcere in Europa, di prossima pubblicazione.
creare un’isola dentro il carcere: il teatro è un modo per eliminare il carcere. L’obiettivo è
trasformare un luogo.
Come fai ad “abolire il carcere”?
Entro. Faccio sentire una bella musica, leggo un testo… Sono sempre come pennellate per
cancellare il carcere, per fare apparire altre realtà. Voglio cancellarlo, il carcere, dentro di me
e dentro i soggetti che partecipano al lavoro.
Può sembrare solo una scelta artistica, questo modo di lavorare; in realtà è un modo di operare
che dà risultati. Io non voglio sostituirmi agli operatori sociali. Devo porre un obiettivo più
alto di quello che possono darsi l’istituzione, gli agenti, gli educatori, il direttore, i detenuti.
Devo alzare l’obiettivo, alzare l’ostacolo, fare appello alle forze migliori.
A volte parto da una musica, altre volte da un testo, da una proposta artistica, da un obiettivo
condivisibile. Questo è discriminante rispetto a altre esperienze: il fatto che possano crescere,
evolvere, oltre la normale socializzazione, proprio perché l’obiettivo è alto. Negli incontri
metto una musica, o leggiamo Seneca, Schiele, Brecht, Pasolini… E qualche detenuto lo nota
subito: quando mai avrei immaginato di poter avere un lusso tale, di stare a parlare con le
persone in galera, di discutere di opere letterarie, di poeti, di porre e porsi delle domande…
Entrando in un carcere con il teatro credo che si debba distruggere anche l’idea stessa di
carcere, lo stereotipo che generalmente alberga nella mente dello spettatore, dell’opinione
pubblica ma anche in quella di chi lo vive direttamente come detenuti, agenti, direttori,
giudici, amministrazioni statali e pubbliche amministrazioni.
Non ti poni, quindi, scopi direttamente rieducativi?
Io non credo al teatro usato per altri scopi, al teatro per i vecchi, per i bambini, per i matti, per
i carcerarti; non credo nel teatro come strumento per ottenere qualcosa. Se si pone
direttamente al centro il teatro in sé, potrai avere indirettamente altri effetti. Le ricadute sociali
sono degli “effetti collaterali”; lo scopo principale è quello di aprire un altro tempo e un altro
spazio. Noi sperimentiamo tecniche per entrare in un altro mondo: per misurare il nostro
mondo, quello dove stiamo.
Nel mio lavoro il carcere assume una doppia valenza: relazione forte con un aspetto della
realtà che ci appartiene e metafora di un carcere più ampio, che è il nostro, quello in cui tutti
viviamo. Dentro il carcere vediamo all’opera i risultati delle contraddizioni e delle illusioni
dei nostri tempi. Vedi uno spaccato della realtà esterna. Gli Istituti di Pena contengono
persone che vengono ormai da tutte le parti del mondo, e dal sud del mondo in particolare; lì
incontri una ricchezza di lingue e culture che può essere vista come un opportunità. La
Compagnia della Fortezza è di fatto diventata una compagnia internazionale.
Ho pensato che questo luogo inaccessibile, sconosciuto, estraneo da sempre alla città, visto
come una presenza negativa e ingombrante dovesse diventare un luogo di produzione teatrale
e culturale. Una marginalità poteva e doveva diventare un centro.
Fin dall’inizio ho lavorato per trasformare il Carcere di Volterra da Istituto di Pena in Istituto
di Cultura. Non ho potuto dichiarare subito apertamente le mie intenzioni ma con il tempo si è
avuta una tale trasformazione della natura di questo Istituto che oggi è sotto gli occhi di tutti.
Ho messo il teatro al centro della mia relazione con questa istituzione. Non ho pensato al
carcere, ai delinquenti, e nemmeno mi sono fatto affascinare da questo luogo: ho guardato alle
potenzialità degli esseri umani.
Il carcere mi interessa perché dimostra che gli esseri umani possono avere evoluzioni che ad
alcuni sembrano improbabili, impossibili. Siamo cittadini di un mondo molto discutibile: o
rimaniamo invischiati in questo mondo, o dobbiamo darci altre regole, nuove prospettive. La
nostra pratica di teatro ha dimostrato che l’azione artistica, la cultura possono produrre azioni
concrete che trasformano i luoghi e le persone.
Non credo al teatro “rieducativo” anche per un altro motivo: quello rimane incollato addosso
al carcerato, lo ricollega al suo vissuto, all’ambiente esterno dal quale proviene. Non c’è
salvezza là. Là è iniziata la sofferenza.
Rifiuti, quindi, l’indagine autobiografica?
Il discorso è diverso, più complesso. Non accetto di mettere direttamente in scena il carcere e i
suoi problemi. Ma una relazione con se stessi è necessaria, con l’autobiografia, con i luoghi di
provenienza, con un vissuto più ampio.
Se ci ripenso, quello che ho provato a fare, entrando nel carcere di Volterra, e questo devo
dire in maniera ostinata, decisa, scelta, è cercare di creare un’esperienza il più possibile
“distruttiva”.
Distruggere per modificare, era il mio obiettivo principale. Distruggere l’idea molto limitata e
comune a molti di teatro, attore, arte, artista, era ed è ancora il mio scopo. Distruggere quanti
più cliché e luoghi comuni possibili. Individuarli e metterli in luce. Eliminarli. Distruggere, di
conseguenza, entrando in un carcere con il teatro, anche l’idea stessa di carcere, lo stereotipo
che generalmente alberga nella mente dello spettatore, dell’opinione pubblica ma anche in
quella di chi lo vive direttamente come detenuti, agenti, direttori, giudici, amministrazioni
statali e pubbliche amministrazioni. Distruggere me stesso, i miei stessi limiti. Distruggere
tutte le resistenze. Spendere completamente la propria vita in un’esperienza, andare fino in
fondo, mettersi in difficoltà e scegliere sempre la strada più difficile, sapendo che alla fine è
sempre quella più conveniente.
Parlo di un tentativo di distruzione quasi fisica, una sorta di lotta quotidiana nella quale sai già
che in qualche modo, forse, perderai. Però è divertente farlo. È necessario.
Uso la parola divertente per indicare uno stato d’animo che partendo da un giudizio negativo
su alcuni aspetti della realtà che ci circonda e avendo la consapevolezza di far parte di una
minoranza non perde in ogni modo il piacere, la gioia e la determinazione della propria
azione.
Stanare, attraverso un’azione consapevole quotidiana, quelli che vogliono che tu perda, che
vorrebbero che tu perdessi, quelli che in qualche caso ti fanno perdere, obbligarli a svelarsi,
far emergere sempre nuove contraddizioni, nuove domande. Questo è il compito che mi sono
dato e il mio divertimento maggiore, un’occasione di crescita e di comprensione dell’essere
umano e della nostra cultura, unici per me.
Tentare di portare, provocatoriamente, negli ultimi diciotto anni, questo tipo d’esperienza
verso la normalità, è stato, in fondo, un lungo processo e un tentativo di distruzione di
resistenze culturali, personali e d’idiozie generalizzate inimmaginabili e anche quasi
impossibili da elencare. Ma non credo ci siano altre strade credibilmente praticabili quando
vuoi fare qualcosa che esula dagli schemi previsti.
Parlo anche, in concreto, di una sorta di distruzione economica, parlo di condizioni
economiche assolutamente penalizzanti per chi si occupa e vive di queste esperienze. Questo
tipo di teatro è realizzato, nonostante gli aiuti e i contributi, in sostanza con le briciole. Non
c’è nessuna relazione reale tra il bisogno di fondi che occorrerebbero e quelli che sono messi a
disposizione. Letteralmente, ti viene fatta pagare la scelta di contrapporti a un sistema teatrale
e culturale asfittico e mortale. E sarà sempre così. Mi è molto difficile immaginare o
addirittura credere, specialmente in Italia, che questo teatro, nonostante la gran qualità dei
suoi spettacoli, e il suo forte rapporto con i temi e le problematiche contemporanee, possa mai
sperare e ambire a maggiori finanziamenti e riconoscimenti istituzionali.
Il teatro convenzionale avrà sempre la parte da leone e difficilmente qualcuno proporrà di
aumentare i finanziamenti per il teatro e la cultura in modo da far crescere un confronto più
equilibrato con i diversi modi di intendere la funzione del teatro e della cultura.
Anche se non era il mio obiettivo principale, ma era inevitabile, adesso si parla del Carcere di
Volterra come di un carcere pilota per le attività, come di un carcere che è cambiato
radicalmente, aperto alla comunità esterna, dove la pena non è solo fine a se stessa e i
detenuti, gli agenti e tutti gli operatori hanno un tasso di vivibilità assolutamente migliore
rispetto a diciotto anni fa.
Anche questo è uno dei risultati di un gran lavoro di distruzione, di demolizione e non credo
ci siano altri termini per rappresentare meglio quello che è accaduto e accade in certe
situazioni e in certi luoghi rispetto alle resistenze che s’incontrano.
Come operi concretamente?
Io arrivo con delle proposte. Un tema, un testo, brani su cui lavorare. I detenuti partecipano e
scelgono su cosa effettivamente concentrarsi. Portano altri materiali.
Se ripenso a come ho iniziato, era subito chiaro il metodo, anche se poi, naturalmente, ha
subito vari adattamenti. Diciotto anni fa avevo come la sensazione che solo con loro, con i
detenuti, avrei potuto realizzare il mio progetto. Perché sono persone straordinarie (ma questo,
forse, l’ho scoperto dopo).
Il mio progetto iniziale consisteva nella creazione di un teatro, sono entrato in carcere per
realizzare il mio teatro, antagonista al mondo intero. Il lavoro in carcere, di solito, pone il
problema della saltuarietà dell’intervento, e impegna solo una parte della vita dell’artista. Per
me è stato diverso. Credevo che solo con loro avrei potuto realizzare questo teatro, un teatro
fatto di presenza. Loro non sono professionisti che possono fare le cose a comando: o ci sono,
con tutti se stessi, oppure io per loro non posso fare nulla.
Loro per me erano il meglio per realizzare il teatro. In realtà, per la società sono il peggio: ma
per uno, per me, erano (e sono) il meglio. È un approccio che serve al gruppo, a costruire il
gruppo. Io non volevo lavorare con attori, ma con non professionisti, con gente che avesse
molto tempo, curiosità e disponibilità. Certo, potevo lavorare con non professionisti di altro
genere. Ma lavorare in carcere mi sembrava una sfida superiore.
Sei andato in carcere, quindi, per fondare un teatro “diverso”?
Sì, per rifiuto del teatro istituzionale. Se tu non entri in carcere con una necessità e un’urgenza
tua, è più facile che l’istituzione ti ponga problemi insormontabili, ai quali prima o poi
cederai.
Lavorare su un testo diventa un pretesto: non serve a prendere coscienza del personaggio o
eventualmente di un ruolo sociale, ma a un lavorare quotidiano, a mettersi in discussione.
In galera, chi sceglie di fare teatro rinuncia ad andare a fare l’aria, a parlare della pena, forse a
progettare rapine. Si mette alla prova su una complessità.
Il rapporto tra attore e regista diventa una relazione di fiducia personale. Io non condivido con
loro solo uno spettacolo, ma un percorso di vita. Costruiamo un oggetto in comune, dove ci
sono sì personaggi, testo, parole, immagini, ma dove soprattutto si intrecciano rapporti che
fanno sì che quegli altri elementi abbiano effetto.
Puoi spiegare meglio la relazione che instauri con i detenuti?
Mi interessa l’idea e la pratica di un’arte “delinquenziale”.
Ho visto, dall’inizio della mia carriera a oggi, tante rappresentazioni assolutamente inutili,
banalmente rassicuranti. Ho visto video, filmati, ho letto di registi e artisti, grandi attori che
hanno messo in scena certi testi e ho pensato che bisognava trovare una strada diversa. Anche
se questo nella società in cui viviamo è in ogni caso compreso e previsto.
Non bisogna, trattandosi di detenuti, avere un adesione ipocrita e buonista. Questo ci mette al
riparo da una troppo facile e offensiva commiserazione. In fondo il mio teatro ha affrontato
attraverso la metafora del carcere, fin dall’inizio, il tema del rapporto con la diversità.
Mi piace ricordare un’espressione molto nota di Brecht: «Non lasciatevi sedurre», che mi
piacerebbe variare in «lasciatevi sedurre e fate attenzione a non lasciarvi sedurre». La
normalizzazione, da cui ancora riusciamo a difenderci, passa attraverso un facile e falso
atteggiamento buonista, una sorta di sentimento forzato che tenta di comprendere e inglobare
tutto. Un atteggiamento tipico della nostra cultura che ha bisogno di riportare a sé tutte le
diversità.
Penso, invece, che debba restare forte l’idea che noi non saremo mai quello che sono gli altri e
che per fortuna gli altri non saranno mai completamente come noi. Dovremmo imparare ad
ascoltare, comprendere e accettare anche le ragioni dell’altro. A un certo livello si possono
opporre all’idiozia e all’arroganza solo atti culturali, portare cultura, azioni simboliche.
La Compagnia della Fortezza, da questo punto di vista, nonostante tutto, non esiste ancora.
Esiste solo come provocazione, come azione simbolica. Se per esistenza s’intende anche il
fatto di vivere, come altri vivono, del proprio lavoro. Questo è il mio divertimento, il mio
lavoro: immaginare e lavorare affinché i miei attori-detenuti facciano qualcosa che sembra
non si possa fare e mettano in scena testi che sembrano non dovergli appartenere. Parlino di
cose di cui non dovrebbero parlare per il solo fatto di avere un passato delinquenziale.
Come operi per arrivare allo spettacolo?
Nelle fasi di lavoro il punto di partenza può essere anche l’improvvisazione. Oppure si
possono trovare nel testo parti consone, vicine a ognuno. I detenuti leggono il testo, scelgono
e trovano singole parole o situazioni che risuonano in loro, anche se spesso non sanno perché.
Trovano nelle parole di altri qualcosa che si radica in ognuno di loro.
Le parti da assegnare le scelgo poi io: corrispondono a dati caratteriali. Non possono essere
distaccate e fredde. Devono piuttosto marcare vicinanze: cerco tutto quello che nei personaggi
e nelle situazioni può risuonare dentro di loro, gesti, movimenti, pensieri. Negli stimoli
esterni, bisogna trovare un buon punto per sé.
Il lavoro decide chi è il primo attore. Ma è importante non far vivere una scelta come
emarginate per alcuni: bisogna trovare i modi per rendere condivise tutte le decisioni.
Ci sono, evidentemente, delle dinamiche da gestire: ci sono quelli che vorrebbero fare molto,
e non ne sono capaci. C’è tutta la dinamica di una compagnia di teatro e poi c’è la dinamica
del conoscersi, del relazionarsi in gruppo.
Pensi che il teatro possa anche essere “terapeutico”? Ossia che interpretando personaggi
diversi da sé si possa mettere in discussione la propria personalità?
È troppo semplicistico dire che attraverso un testo i detenuti “studiano” caratteri diversi da sé
e capiscono chi sono, e magari anche gli “sbagli” commessi: non significa nulla, nella realtà.
Tutto sta nella dinamica del processo; quanto dei loro dati personali, autobiografici, riescono a
entrare in questa dinamica.
Io provo a trovare gli spazi per tutti. Ma ci sono spettacoli che sentono più vicini e altri che
sentono più lontani. Quando l’obiettivo riesce a diventare comune, gli spettacoli sono più
forti. Quando lo spettacolo fa più presa su me che su loro, il risultato è più traballante.
Ogni lavoro cerca di risolvere i problemi aperti da quello dell’anno precedente. Così l’Opera
da tre soldi cercava di risolvere quelli suscitati da Amleto, e così via…
Cerchiamo sempre una motivazione forte, personale; altrimenti il teatro nasce morto, senza
l’urgenza di essere espresso.
Cerco di portarli verso un obiettivo comune. Cerco la coesione del gruppo, qualcosa che
amalgami i numerosi collaboratori esterni della compagnia e quelli che stanno dentro. E non
basta il teatro. Bisogna trovare motivazioni condivise.
Perché ti poni sempre l’obiettivo di arrivare a uno spettacolo?
L’obiettivo dello spettacolo è servito all’inizio per costituire il gruppo, poi per coltivarlo e per
far conoscere l’esperienza. L’istituzione carceraria diventa un istituto di cultura, che difendi e
fai sviluppare facendo spettacoli, mostrando il lavoro dei carcerarti al pubblico, agli operatori,
alla critica, organizzandovi intorno un festival, intrecciando rapporti con la società, con la
scuola, con l’università.
Poi difendi e sviluppi quello che hai costruito anche con le regole di lavoro: gli iscritti al
teatro sanno che non devono scatenare risse, che devono dimenticarsi di essere detenuti e così
via. Altrimenti tutto quello che abbiamo conquistato è messo in pericolo. C’è un insieme di
regole condivise. Il problema non è essere più bravo dell’altro, ma far crescere la compagnia.
L’istituzione ne beneficia indirettamente. Anche se l’obiettivo non è migliorare l’istituzione,
ma creare un teatro. Poi, se migliora la vita, si aprono anche più spazi nel carcere.
In realtà l’istituzione e la mentalità distorta che genera devono essere eliminate. Non si mostra
il lavoro in pubblico per mettersi in mostra o per avere eventuali benefici nella vita del
carcere. Certo, poi ognuno ha la propria motivazione. Ma è necessario trovare quella comune.
Nel teatro non ci sono alibi: non puoi fingere, sennò con il pubblico non funziona. È proprio il
contrario del modo di comportarsi che si assume nell’istituzione totale.
Io lavoro sul gruppo e su ognuno di loro, sulle capacità e sui limiti.
Quanto dura il lavoro per uno spettacolo?
Il lavoro per uno spettacolo si distende per un intero anno, tutti i giorni.
Sarebbe il sogno di tutti gli artisti: avere una compagnia stabile, che possa lavorare senza
limiti di tempo. È un impegno fuori dalle leggi del mercato, quello che tutti i grandi maestri
rivoluzionari della scena del Novecento hanno desiderato, da Stanislavskij a Grotowski. Nel
carcere crei le condizioni di quei teatri che si chiamavano “teatri liberi”.
È un’utopia che fa bene al teatro e, indirettamente, fa bene a loro, ai carcerati e all’istituzione.
Come ti rapporti, appunto, con l’istituzione?
Il lavoro con le istituzioni deve proteggere questo spazio. Noi costituiamo un terzo polo tra le
guardie e i ladri: importante, perché interrompe il conflitto a due; introduce un testimone, un
punto di vista altro da quello istituzionale.
Con le istituzioni ho parlato sempre attraverso il teatro e le sue esigenze. Ho chiesto un luogo,
una stanza, e per fortuna me l’hanno data molto piccola, così ho potuto usare tutto l’istituto:
alla fine nel carcere di Volterra non c’è spazio dove non ho fatto qualcosa. Ho trattato su tutto,
in modo puntiglioso: sulle modalità di accesso al laboratorio, sul tempo, chiedendo il maggior
tempo possibile, ragionando su un radicamento e sull’espansione dell’esperienza, facendo
tesoro di ogni cosa.
Sono stati importanti anche i contributi esterni: le persone che mi aiutavano a rinforzare la
credibilità e la concretezza del teatro. Il carcere riassorbe, ingoia: se inviti un mimo come
Bustric a fare i suoi giochi di prestidigitazione, le sue magie, rimetti in moto energie, processi.
Il carcere è un buco nero: il teatro è una presenza che può cambiarlo, dargli vita nuova. Far
vedere come si può usare la voce, presentare un artista che usa bene la voce da vicino, non da
lontano come la tv, suscita interesse, attenzione e rinforza l’esperienza.
Il carcere, in fondo, è lo specchio di quello che avviene fuori. Mettere al centro la cultura è
fuori dal mondo. Perché il buco nero del carcere è uguale a quello che c’è fuori. Il carcere è
un microcosmo della realtà esterna. Mutandone le regole, prefiguri una società diversa.
Quello che ti minaccia, dentro lo vedi chiaramente: fuori un po’ meno.
Hai sempre presentato gli spettacoli a un pubblico esterno e hai lottato perché la compagnia
potesse portarli in tournée. Perché?
L’apertura verso l’esterno è importantissima. Verifichi lo spettacolo, l’oggetto a cui hai
lavorato, superi gli ostacoli che vengono frapposti, verifichi i rapporti.
Finito lo spettacolo, importanti sono le tournée. L’intenzione è quella di non fermarsi mai,
tranne che per le vacanze estive. Lo spettacolo non è l’unico obiettivo. È un punto di partenza.
Lo scopo è lavorare insieme. Creare un teatro, cioè un altro progetto di realtà.
L’ambizione è la stessa che avresti in un teatro stabile: trasformare una dinamica sociale, un
luogo.
Il metodo sperimentato all’interno del carcere credi che sia applicabile anche in lavori
esterni?
Quando faccio un laboratorio fuori dal carcere gli iscritti vogliono capire tutto subito. Io sono
contro. Dico: lavoriamo, esploriamo, poi si vede. C’è il rischio di perdersi, è chiaro, ma anche
di aprirsi e di scoprire. Il tema non è la messinscena dello spettacolo: è altro. Lavorare su una
scena è una fase avanzata del lavoro: bisogna arrivarci, sennò si mettono insieme solo degli
stereotipi. Lo stesso avviene dentro.
La tua scelta di “cancellare il carcere” è condivisa dagli operatori dell’istituzione?
Il carcere nella sua pesante concretezza è la metafora di un carcere più ampio, di una
situazione sociale oppressiva, sclerotica, chiusa, escludente.
Il nostro lavoro dà senso anche a chi opera direttamente nell’istituzione. La direttrice del
nostro carcere dice: anch’io sono d’accordo che dovete fare solo cultura e non rieducazione.
Perché qualcosa si cambia, anche nella realtà carceraria.
Ma questo metodo non è applicabile solo al carcere: è un modello culturale.
Facendo teatro in carcere rifiuto la parola dominate oggi in Italia: “compatibilità”. Guardo
piuttosto alle esigenze delle persone. E ai maestri del teatro del Novecento. Il teatro in carcere
è un laboratorio di utopia.
Facendo teatro in una prigione io voglio sottolineare il dato culturale e sociale che può portare
la gente chiusa là dentro. L’attenzione dei media, il successo dell’esperienza di teatro in
carcere, permette di lavorare contro la marginalità. Il successo è il piede di porco per riportare
il problema fondamentale al centro. Chi aveva energia, una grande energia, e l’ha usata spesso
in una direzione illegale, può direzionarla altrove.
Io cerco di eliminare ogni idea di carcere. Perché il carcere porta sofferenza. Instauro una
libertà, altre regole, che sono quelle del teatro: cercare le abilità, l’energia, al di là della
situazione carceraria.
È un percorso di libertà che vuole rifare le regole della realtà; è una forma di costrizione per
rompere i muri, per cercare una via uscita. In carcere è importante confrontarsi con tutto
quello che è concreto, che ti mette alla prova.
ROMEO CASTELLUCCI
MASSIMO MARINO
Atlante di una tragedia infinita. La Tragedia Endogonidia della Socíetas Raffello Sanzio4
Si è concluso a dicembre il cammino della Tragedia Endogonidia, il progetto itinerante della
Socíetas Rafaello Sanzio, undici spettacoli in dieci città d’Europa. Finalmente possiamo
vedere dispiegato tutto il tracciato di un’opera che ha rappresentato una sfida alle
consuetudini della drammaturgia, della creazione scenica, della produzione teatrale, e
azzardare a comporre episodi, figure, invenzioni in un quadro unitario.
Per tre anni la compagnia di Cesena ha prodotto spettacoli a ritmi diversi, prima blandi, poi
sempre più stringenti, sorprendendo ogni volta, ma anche creando una rete di rimandi,
associazioni, sviluppi di immagini che ora ci sembra di poter padroneggiare. Il principio era
quello di tessere una tragedia d’oggi: in dialettica con la forma inventata nell’antica Atene,
eppure profondamente diversa. Una tragedia dell’eroe anonimo, che si oppone, esplora i limiti
delle norme, o forse semplicemente vive, e si scontra con il potere, senza una comunità che
accompagni la sua lotta, senza una polis, un coro che possa dare un senso più alto alla sua
sofferenza, al suo sacrificio. Non c’è compianto, non c’è catarsi, non c’è esemplarità, non c’è
società, ma solitudine e spersonalizzazione. Una realtà oppressiva colpisce con i suoi
simulacri, le sue rappresentazioni che non si riesce a scalfire, con tavole della legge pesanti
come pietre tombali, con poliziotti a volte simili a quelli delle comiche del cinema muto, a
volte feroci e impassibili come macchine delegate a macerare ogni divergenza.
Una tale tragedia non ha parole o ne ha poche, scritte, frammentate, dette con fatica, dissolte;
il testo è abbandonato: si assiste, come si vedrà, alla deriva degli alfabeti e dei sensi. Parla la
lingua del corpo, del pericolo fisico e morale, del mito, la vanità della lotta e lo svuotarsi della
storia. Non ha più personaggi ma “figure”, come scrive Romeo Castellucci, ideatore, regista,
inventore di scene, luci e costumi del ciclo, coadiuvato da Chiara Guidi per la regia, la
4
Il saggio è apparso nella rivista francese «Ubu-Scène d’Europe», nn. 35-36, luglio 2005.
composizione drammatica, sonora e vocale, da Claudia Castellucci per gli scritti, da Scott
Gibbons per le musiche originali, suoni elettronici tellurici. La figura è una tensione fra il
genere e l’individuo, qualcosa che abiura il personaggio e lo rende mobile.
La tragedia, prodotta insieme a festival e teatri francesi, belgi, tedeschi, inglesi, italiani, con
un finanziamento del Programma Cultura 2000 della Comunità Europea, in ogni episodio
prende il nome dalla città che la ospita, riprodotto in una sigla con numerazione progressiva.
Ogni tappa nasce come non replicabile, unica, messa a punto in relazione con un determinato
luogo e con un’occasione. Ogni episodio genera l’altro dall’interno come un organismo
monocellulare endo-gonide. Queste le regole di partenza, che saranno poi moltiplicate e
violate. Moltiplicate, perché a un certo punto iniziano ad apparire, accanto agli episodi
maggiori, le “crescite”, performance di durata variabile, perlopiù non superiore alla mezz’ora,
che sviluppano una o due figure di tappe precedenti, dando nuove soluzioni e cercando
imprevisti cortocircuiti. Violate, perché le tragedie nate per una città saranno poi replicate
altrove, dimostrando come “anonimi” non siano solo gli eroi, oggi, ma anche i luoghi,
intercambiabili perfino nei loro segni caratteristici. Una camera dorata può evocare una pittura
medievale avignonese ma può anche, semplicemente, sospendere la visione in una temporalità
astratta e sottrarre allo spazio naturalistico la prospettiva; un marmo ministeriale e obitoriale
possiamo ritrovarlo a Bruxelles come a Roma o a Parigi; il bosco come la visione sfumata
dalla nebbia stanno dentro ognuno di noi oltre che a Londra o nella Romagna. D’altra parte la
contraddizione è inevitabile in un organismo che si definisce già come un accostamento di
termini distanti, perché la tragedia finisce con la morte dell’eroe, mentre l’endogonide si
perpetua per partenogenesi.
La Tragedia Endogonidia opera sull’immagine che sfuma o, impercettibilmente, si sfoca, sul
suono delle azioni e delle cose, sulla presenza e l’assenza, sul colore e il buco nero, sul
riflesso, sulla deformazione e rottura degli specchi riflettenti. «Credo che tutto quello che
possediamo siano delle onde», scrive Castellucci nel primo numero di «Idioma Clima Crono»,
il giornale nero di lungo formato che ha raccolto, per otto numeri, più uno bianco dedicato
agli scritti composti in un seminario all’Università di Bologna, le memorie, le ipotesi, i riflessi
di questo palpitante divenire.
Onde, sfocature ed enigmi, sfide alla comprensione razionale materiate di folgorazioni che
lasciano nello spettatore il senso di una partecipazione, di una lotta fisica e psichica, di una
rottura, di una ricerca. Già dall’inizio semisegreto di Cesena, C. #01 Cesena (25-26 gennaio
2002), con un corpo polimorfo in trasformazione, donna uomo vecchio bambino, sesso che
espelle materie sotto la minaccia di una macchina automatica che dardeggia frecce, mostro,
essere oscuro, bios, liquidi, esplosione di sangue da gambe in latex pendenti. Ambiguità e
germinazione di forme sotto un display meccanico, di quelli da stazione, didascalia che
tornerà in altri episodi: maledice, lo spettatore e l’autore, chi ha concepito, fatto, visto,
promette una vendetta del logos, si sbriciola in lettere mancanti, in grumi di consonanti, in
frasi senza senso. Corpi vecchi, mascherati, che ballano, sussurri nel buio, dolore preparano la
visione finale di un corpo steso in terra in una pozza di sangue, Carlo Giuliani, il ragazzo
ammazzato dalla polizia a Genova per il G8 del 2001 come icona, con un uomo a torso nudo e
pantaloni da carabiniere che con voce evirata d’angelo intona un lamento, fino a che una
grande X non si incendia in proscenio e in proiezione lettere di umani alfabeti pulsano
impazzite. Gli elementi sono già tutti in questa tappa preparatoria, siglata dai simboli e dai
suoni affidati alla sonda Voyager come testimonianza della civiltà umana per gli spazi
galattici, rivolta a critici, organizzatori, artisti per dare un’idea del progetto e cercare le strade
produttive per renderlo possibile: il mistero, il dolore della trasformazione che non ferma
forme indominabili, la minaccia, la legge, lo sfaldarsi del significato di fronte al corpo e alla
violenza.
Le tavole della legge, bianche, mosaiche, appariranno al Festival di Avignone per A. #02
Avignon (7-15 luglio 2002), come pure il capro, origine della tragedia, che produce una poesia
materica percorrendo lettere trasformate da due donne in suono. Gli spazi sono due: uno nero,
dove assistiamo alla ripresa video del capro che si muove su una scacchiera di vocali e
consonanti; l’altro bianco, delimitato da un sipario con soprascritta una misteriosa sigla e due
nomi che associano la tragedia a lontani miti e favole, Ur e Oz. Un bambino in toga, due
donne che dietro una plastica incisa da colpi o pallottole piena di un liquido lattiginoso
leggono il tracciato dei segni calpestati dal capro, lettere che traducono gli aminoacidi
dell’animale all’alfabeto latino nella pretesa di un linguaggio inscritto nel corpo anteriore a
quello che rappresenta le cose, la materia nucleare prima della significazione della tragedia,
tragos-oidé, canto del capro. Uomini in costumi da soldati di Rembrandt, che offriranno al
bambino una pelle di montone e lo opereranno. Rivelazioni, in uno spazio ulteriore dietro il
sipario bianco, una stanza dorata, delle trasformazioni fisiche di Cesena, manifestate da un
clown che irrompe dall’esterno. Levitazione del bambino; rituali come un sacrificio. Finale
simile a quello di Cesena: il corpo morto di un ribelle, il canto, la croce di fuoco.
L’episodio rappresentato all’Hebbel Theater di Berlino, B. #03 Berlin (15-18 gennaio 2003)
cambia atmosfera: la scena diventa una nebbiosa Avalon e un ghiacciato paese degli
Iperborei, in un grigio che rende incerte figure che si sdoppiano o annullano, in un bianco che
rompe i riferimenti spaziali, evadendo da ogni concezione prospettica. Un velario appanna
tutto: una madre è al centro della scena, su un letto, con donne simili a vedove, a mannequin
guerrigliere, a infermiere che la accudiscono e la martirizzano. Madre orfana e senza volto che
piange una figlia morta, simula di estrarla ancora da sé e partorisce stracci, ritorna la sua
bambina, si masturba, esibisce un sesso che non può generare fra coiti di donne incappucciate
che mimano immaginari porno, fra sospiri ansimi vagiti risatine grida. Lo spazio
smaterializzato del cordoglio (o della rievocazione di un assassinio primigenio commesso
dalle proprie stesse mani) diventa un antro avvolto in scariche di energia baluginante, un
luogo illuminato da lune malate, da soli neri, minacciato dalle catastrofi sospese sulla nostra
terra. Il grigio di forme vaghe cede il posto a un paese ghiacciato di favola dove irrompono
pelosi abominevoli uomini delle nevi, pronti a costruire cancelletti da baita alpina. La scena è
lontana dal pubblico, assiepato nelle gallerie del teatro: nella platea siedono grandi conigli
neri di pezza, che saranno poi abbattuti da yeti debordati dalla cornice scenica. L’immagine è
devastante, fra lo sventolio di bandiere con grandi scritte misteriose, forse ebraiche: una
tomba in scena, le bianche tavole della legge, la bambina rediviva che danza, il lutto che
contorce la madre e quei corpi del coro-coniglio-spettatore abbattuti, come i ceceni e gli
ostaggi nel teatro Dubrovke di Mosca, subito fermati in agghiaccianti istantanee che hanno
fatto il giro dei mass media della terra per i nostri occhi voraci. Il sipario si chiude sulla tomba
richiusa, su un girotondo di yeti e su un concerto di canti di gallo che annunciano una qualche
livida alba.
Br. #04 Bruxelles (4-7 maggio 2003) è concentrato e violentissimo. Torna un’idea del tempo
circolare, dove gli effetti precedono le cause, dove la morte irraggia un’energia mefitica che
altera lo scorrere delle cose. Lo spazio sembra un marmoreo ministero o obitorio. Una
bambino di pochi mesi gioca, inconsapevole. Un’inserviente nera pulisce una macchia
invincibile. Una donna in gramaglie proietta una fiamma. Incombono nere tavole della legge.
Un vecchio in bikini a fiori veste paramenti sacerdotali e poi si trasforma in poliziotto Altri
due poliziotti entrano. Uno versa un liquido viscoso in terra, l’altro si spoglia. Assisteremo a
un pestaggio violento, violentissimo, il corpo picchiato dai tutori dell’ordine si contorce, si
rivolta nel sangue finto, si imbratta e finisce in un sacco a bestemmiare in una lingua fatta di
scarti di lingue, di suoni inarticolati raschiati in gola, nella pancia. Era quella la macchia che
l’inserviente puliva. La donna in nero si raserà i capelli e tutto diventerà come dopo
l’esplosione di un cancro, di una bestia radioattiva. Col vecchio che si spoglia, annulla i suoi
lineamenti con un passamontagna e sprofonda in un letto dove sparisce, come seme di
un’umanità terminale, esausta, indistinta e futura.
A questo punto il ritmo di produzione diventa incalzante: l’episodio presentato nella capitale
belga al KunstenFESTIVALdesArts è preparato parallelamente a quello che debutta in
Norvegia all’International Festival Norway, Bn. #05 Bergen (22-25 maggio 2003). Qui
vengono usati molti dei materiali di Avignone, in una specie di ricapitolazione di figure e
situazioni precedenti, con variazioni. Troviamo le due donne che intonano le lettere della
“poesia del capro” di fronte al liquido che scema a poco a poco rivelandone i volti (latte?
sperma del capro?); vediamo il capro stesso che si aggira in uno sfondo nebbioso. Una
vecchia viene sacrificata e una bambina appare al suo posto, rinnovamento del ciclo, regina di
favole venerata e minacciata, posta da quattro guardie con cappellacci da guardie di
Rembrandt ad assistere a un filmato di lettere pulsanti, di macchie in movimento, una visione
divina o lisergica che si muta in fungo atomico. Un ariete da guerra ricoperto di pelle caprina
incombe contro il pubblico. Spazi che si aprono uno dentro l’altro, bianchi prima, dorati poi.
Teatro nel teatro? E dentro, cosa c’è? Figure che non si possono spiegare: si dispiegano nel
mistero, con soffi, ansimi, sbuffi, terremoti per teatrali metamorfosi, offrendo il soma in pasto
a qualche potere pronto a divorare. Un uomo rosso resta in scena: si spoglia, rivelando un
fangoso corpo femminile, che si scopre ancora maschile, in una ginnastica che pare agonia.
Gli abiti, vuoti, ascendono al cielo e l’attore rimane inerte, adagiato sulla terra. Flusso,
conflitto, empatia. Olocausto sottratto alla comprensione e alla compassione; solitudine e
assenza di senso che rompono le maschere di spiegazioni e rassicurazioni.
Gli episodi di Parigi e Roma, ancora preparati in parallelo, apriranno questo mondo
baluginante ad apparizioni di figure storiche, mescolate a miti che si smontano, a cori muti
che si dissolvono, al cinema e alla fotografia come arti della riproduzione, di una ripetizione
del vivente che suona come terrore o come farsa. P. #06 Paris (18-31 ottobre 2003),
presentato negli spazi industriali dell’Atelier Berthier dell’Odeon per il Festival d’Automne,
ospita in scena un’orchestra che non suonerà una nota: si alza e fugge quando un Cristo
irrompe in scena fracassando le porte esterne. Un sacrificio di Isacco avviene poco prima che
la figura di un dio in cilindro e vestito rosso, simile alla figura di Bergen ma con la barba
bianca, faccia vedere il montone che doveva sostituire il ragazzo, vittima immolata su due
lavatrici in centrifuga, con l’acqua che dilaga e trasforma l’entrata di alcuni poliziotti in una
comica dei primi film dei fratelli Lumière. Groppe di cavalli sbucano dal muro; una sfinge,
una casa nera scossa da urla attraversano la scena. Bandiere francesi sbattono nello spazio
svuotato lottando contro rombi di guerra, e poi avvizziscono. Irrompe il Cristo e una donna
intabarrata come un’emigrante spreme un seno per nutrirlo, ma non sgorga neppure una
goccia di latte. Piovono automobili dalla soffitta della sala: saranno le croci cromate di un
Golgota contemporaneo, dove il Cristo si crocifiggerà, per esser poi deposto alla guida, in un
abitacolo, come noi tutti i giorni. Un rito di festa cinese, il liquido dell’eroe, coriandoli, fuochi
e pioggia di carta come neve disegnano qualcosa che assomiglia ai resti di una barricata di
qualche rivoluzione fallita: un vecchio si aggira fra le rovine, con le sembianze del generale
De Gaulle.
In R. #07 Roma, presentato per Romaeuropa Festival (21-30 novembre 2003), emergeranno
da uno spazio bianco, labirinto che falsa le proporzioni, che nasconde gli angoli, le entrate e le
uscite, due lati del carattere italiano, Mussolini e Arlecchino. E prima un essere
inconsapevole, come il bambino di Bruxelles, il bios puro, si muoverà vivendo: un vero
scimpanzé davanti a un monolite, con una citazione folgorante dell’odissea nello spazio di
Kubrick. Giovani preti con le fruscianti zimarre nere giocano a girotondo o a basket, come in
una famosa foto di Mario Giacomelli. E il grassone che sembra un papa re vestito di bianco, e
poi si precisa come un grottesco Mussolini, firmerà con loro un patto, la scellerata transizione
fra stato e chiesa (il riferimento è ai Patti Lateranensi del 1929), la spiritualità avvilita a norma
di stato. Ma fra la legge e la natura dell’animale stanno il delitto e la rappresentazione. Un
rosso uomo che già conosciamo vampirizzerà Mussolini, per poi trasformarsi in Arlecchino.
Un terremoto fa franare le scene e mutare orizzonte in una scena multicolore. Una donna
passa e si spoglia, si esibisce nuda davanti al carrello della spesa, vergognosa, inquisita da una
voce di colpa esterna. Irrompe un girotondo di preti e una forte campana li disperde. Il
palcoscenico si svuota nuovamente, in attesa di qualcosa: il pavimento si squarcia e torna
Arlecchino con un fucile; minaccia come un guerrigliero. Tutto diventa buio, squarciato da
lampi al magnesio, mentre una voce ripete: «Non devi guardarmi!». Lo scandalo della visione
e dell’esibizione, dell’attore e dello spettatore legati in un patto scellerato che chiede a
entrambi di uscire da sé, di apparire, di avere bisogno dell’altro per definirsi, ritorna come ai
tempi dell’Amleto del 1992, confliggendo con la storia e con la vita “naturale”, senza
risoluzione.
In S. #08 Strasbourg, rappresentato al Théâtre Le Maillon della città alsaziana (17-20 febbraio
2004), cambieranno completamente le figure, ma la concentrazione sull’atto della
rappresentazione sarà più forte. Lo spazio dell’ex fiera trasformato in luogo teatrale è unico.
Nel capannone chiuso da una vetrata un monte di terra sul fondo segna lo spazio scenico.
Oltre la vetrata scorre la normale vita della sera: nel palazzo del ghiaccio, di fronte, si gioca
una partita di hockey. Una parte degli spettatori può vedere i pattinatori volteggiare. Nel
piazzale arriva un torpedone che scarica attori-turisti che scruteranno il pubblico seduto
all’interno, e poi si metteranno a guardare un film che presto lascia lo schermo bianco.
All’interno, in un accampamento ai bordi del vasto, accidentato spazio desertico, prende vita
un muto popolo di donne africane, in abiti militari. Nel centro della vecchia Europa, al confine
tra Francia e Germania, in una terra contesa nei secoli, attraversata da armi e armate, si
fronteggiano due mondi. Si rispecchiano l’uno nell’altro il guardare di noi occidentali, persi in
uno spettacolo continuo, in una rappresentazione generale, e gli atti essenziali di quel muto
popolo dei deserti, che ricordano vagamente antichi riti o funzioni primarie o moti di
ribellione, alzarsi, inchinarsi, pregare, pestare il grano, raccogliere acqua che scarseggia. Il
muoversi delle donne nere è lento, spossato, fra avvallamenti e grandi zolle, sacrale, pacato,
senza speranza. Viene dissotterrata una bandiera rossa, brandita un’arma senza forza. Si
siedono in cerchio, sembrano ascoltare una terra esaurita. Un’Africa spolpata dal nostro
guardare e consumare. I fragili ripari di tela crollano, mentre una ragazza fragile e forte, irata
e rassegnata, sventola la bandiera rossa. Non c’è attesa di redenzione. C’è ascolto e presenza.
Fuori lo schermo è diventato rosso. Ma lo slancio si esaurisce. Le donne ripuliscono lo spazio
terroso e sfilano contro il vetro di fondo, ombre a specchio delle altre ombre accorrenti in
direzione opposta dei turisti nostro specchio. Tutti i fantasmi svaniscono: un carro armato
irrompe in scena, minaccioso, con il cannone puntato contro i nostri volti. L’unica cosa che
rimane, con la polvere smossa e il freddo esterno, mentre il buio avvolge tutto, è un oggetto
bianco simile alla pietra che riluce in un angolo della Melancolia di Dürer.
Con L. #09 London, presentato al Laban Theatre per il London International Festival of
Theatre (13-16 maggio 2004), ci ritroviamo di fronte a un quadro ottocentesco, un’immagine
avvolta in una nebbia alla Turner che rivela una donna contro un muro, un interno borghese,
figura chiara col volto nero che sembra tirare corde o esservi appesa, torturata. Si ribella, si
spoglia con gesti di rabbia, riveste solo di una maschera di tragedia il sesso; il suo corpo è
plasticamente teso, statuario, mosso, contorto, minacciato da blocchi che sembrano di marmo,
sporcato nel fango. Svanisce nel buio, lasciando solo un’ombra luminescente di sé in scena.
Le sue tracce saranno cancellate da una comica compagnia di pulizia. Poi vedremo apparire
un San Paolo in abiti ottocenteschi, come un capitalista di Dickens, che nutre una famiglia di
gatti della sua lingua, che fronteggia bambini travestiti da vecchi marinai in sciopero, che
trasmette, da leggere, le prime battute di una sua lettera ai Londinesi sull’obbedienza totale
alla nuova legge, quella dell’amore. Un corto circuito fra il nuovo tempo messianico proposto
dall’apostolo Paolo e le derive del capitale, che subito sfuma in una scena vuota dove l’Union
Jack combatte sotto rombi di battaglia, e una bambina e la donna, ora col volto bianco, stanno
appese, a manovrare il teatro o legate come prigioniere a una macchina di supplizio.
Ambiguità, rovesciamento della visione. Continua sfocatura del quadro, dove un dettaglio è
sempre incerto, sfumato, dove la visione in un angolo, in un particolare, è imprecisa,
sfuggente, imprendibile.
A Marsiglia e a Cesena, alla fine del percorso, lo spazio tornerà a duplicarsi (ma questa
tendenza alla germinazione e alla dilatazione è osservabile, diversamente, in più tappe). Nella
città francese, M #10 Marseille va in scena a Les Bernardines e al Théâtre du Gymnase con
due spettacoli diversi (20-26 settembre 2004). A Les Bernardines si replica due volte lo stesso
episodio, prima e dopo quello del Gymnase: l’ordine di visione risulta casuale, dipendente
dalla prenotazione del biglietto. Non c’è un’unica successione, né un finale privilegiato. La
parola irrompe nella Tragedia. La parola come flusso, come residuo, che non costruisce un
senso. Pittura sonora ambientale e evocazione di conversazione, di idee, di emozione,
incapace, comunque, di fondare un atto di conoscenza, di comunicazione, una verità. L’azione
dei Bernardines si apre come una cena ottocentesca: uomini in palandrana e cilindro, donne in
ampi abiti, chiacchiere. Poi i signori diventano spettatori e entra in scena un possente cavallo
nero, che sarà inondato di latte, lavato senza potergli sbiancare il manto. Una donna, invece
sarà spogliata, derisa, costretta a esibire le parti più intime, scrutata con compiacimento e
noncuranza, legata, fotografata. A ogni foto scenderà sul palcoscenico una lastra di vetro.
L’ultima istantanea viene rivolta verso il pubblico: e tutte le lastre esplodono in mille
frammenti. Nell’altro atto quasi non ci sono figure. Solo suoni e forme in mutamento, colori,
strisce e quadrati di luce mutevoli, aperture, chiusure, tagli di immagini astratte che evocano
Rothko, Fontana e altri maestri dell’informale. Un pulsare luministico entro cui appare una
vasca ribollente che richiama la materia primaria della Genesi, lo spettacolo che precedeva
immediatamente la ricerca della Tragedia Endogonidia. Alla fine esplodono macchie, quelle
del filmato di Bergen, con la loro minaccia psichica e atomica, contrappuntate dalla figura in
controluce di una donna che si inerpica in note dolcissime di cantate antiche smaterializzate
da Scott Gibbons.
L’ultimo episodio, C. #11 Cesena, rappresentato al Teatro Comandini (16-22 dicembre 2004),
è come un noir. C’è un’aria da film, un sapore anni cinquanta, l’aria di freddo, di mistero e di
favola. Un bambino entra, si mette a letto, legge un fumetto. Arriva una madre grassa e
amorosa, poi una donna delle pulizie di colore. Un uomo che sembra il padre, infine, aprirà la
porta a un gruppo di individui intabarrati, col cappello, che si rivelano come membri di una
polizia, funzionari di un potere generale e ramificato. Il tempo precipita e torna indietro. Fra
pose che mimano quadri antichi, un vecchio viene spogliato e cosparso di polvere bianca.
Inginocchiato, resta solo in scena. Sorride e ci guarda. Anche un cavallo, che mangia biada sul
letto ormai vuoto, ci guarda. E sembra sorridere. L’aria familiare diventa sempre più
misteriosa, cerimoniale, sacrificale. Si insinua il sospetto di un delitto, si dà la caccia al
bambino, al suo seme, secondo l’ordine di una fata (una favola, ancora, ansiogena), si esibisce
il capino mozzato di un gatto. Un siparietto, che mostra solo le gambe dei personaggi già visti,
rivela che l’inserviente nera è la capobanda e mostra gli uomini che torturano la madre. Il
contenitore di una pellicola cinematografica guiderà il pubblico nello spostamento nell’altra
sala dove, con la voce pomposa dei vecchi documentari, si assiste alla morte di un nugolo di
spermatozoi, l’esaurirsi della vita, la caduta, l’inerzia biologica. Poi si apre alla visione un
bosco fatto di rami veri, resinosi, buio, notturno, con voci, squarci di pila, di fari, abbaiare di
cani, l’inseguimento del bambino, ultima vittima, macchine che passano sullo sfondo, il
sacrificio. Dal corpo dell’infante ripiegato sarà tagliata la testa di un gatto… L’innocente, gli
innocenti, ancora sacrificati. Il buio nel quale abbiamo cercato di vedere, senza riuscire a
impedire la banalità misteriosa, quotidiana, del male. Ritornano, in questa tappa conclusiva,
ancora immagini di spettacoli del passato: l’ingrandimento microscopico degli spermatozooi
del Combattimento di Tancredi e Clorinda, i semi iscritti nella nostra natura fisica, nella lotta
del nascere e del morire; il buio del bosco di Hänsel e Gretel, un riferimento a uno dei lavori
più forti del ciclo del Teatro infantile, all’in-fans, colui che non può parlare per dire l’orrore
del mondo.
La riproduzione, lo scandalo del guardare, dell’esser guardati e duplicati, in pellicola, in foto,
in atti che arrestano la contraddizione del vivere e morire. La Tragedia Endogonidia ci lascia
questo, insieme ai frammenti dagli spettacoli organizzati nel Ciclo filmico di Cristiano Carloni
e Stefano Franceschetti e alla forza propulsiva che produrrà ancora varie “crescite”. Siamo
davanti a uno spettacolo aporetico, fatto di anime contraddittorie, che si dissolve e si fissa, che
si moltiplica e si ripete, che germina vite, trasformazioni, e genera morte e celebra sacrifici,
che tende alla figura in movimento e si chiude in immagini che aprono infinite risonanze
dentro lo spettatore, portandolo dalla maledizione dello sguardo, della rappresentazione, alla
concentrazione in una poesia difficile, interna, affacciata a esplorare i confini di un mondo in
rovina. La percepiamo, alla fine del percorso, come una ricerca-epopea che spinge il teatro
oltre i suoi limiti, per farne uno strumento di indagine, che cerca di riformulare quel mondo
cogliendone il ritmo oppressivo, mettendo in crisi le apparenze, ridefinendo un’etica possibile
attraverso il dolore e la gioia di un’estetica graffiante, rigorosa, inflessibile. Fino a disegnare
un atlante dei dolori e degli errori, dell’ambiguità e dell’insondabile, che fa vacillare tutto ciò
che sembra definito e spiegato una volta per tutte; un libro-esperienza di creazione di flussi
viventi, oltre il senso, più a fondo, più a fondo.
ROMEO CASTELLUCCI
Il sipario si alzerà su un incendio
L’arte contro la comunicazione. Strategie di una fuga, necessaria a sostenere la portata di questa epoca. Contro il
paesaggismo imperante nel teatro, creare un vuoto, una fessura nella realtà. In un intervento scritto per il
convegno La bellezza necessaria, tenutosi all’Arboreto di Mondaino (RN) il 21 e il 22 maggio, Romeo
Castellucci racconta la sua “scrittura” teatrale, contro l’economia dell’immagine, in cerca di rivelazione.5
Uno degli esiti politici del teatro che vedo ora è quello di andare fino in fondo alla propria
specificità di linguaggio. Senza timore della incomprensione, della impossibile
comunicazione, o traduzione, commento, spiegazione; senza l’ansia di giustificare la propria
assenza di discorso e dal discorso in generale; con una strategia attorno alle parole e attorno
alle immagini che organizza quella che appare, e quella che è, qualcosa come una nuova
realtà. Questo è, in sintesi, il movimento del teatro così come personalmente lo intendo.
La velocità del passo, della sua forma diventa una strategia di fuga, necessaria a sostenere la
portata di questa epoca. Essere sempre sopra, o sotto, o a destra, o a sinistra dell’oggetto, per
divenire il movimento improvviso che, all’ultimo istante, scarta in un’altra direzione - quello
scarto che rifiuta la risposta di fronte alla domanda della scena. Non vi può essere risposta a
quella domanda, ma la somma algebrica di una domanda posta a un’altra domanda.
Creare un vuoto, una fessura nella realtà. Ma una sospensione della realtà la si ottiene solo
attraverso una produzione di reale. Il teatro è veramente l’arte che più di ogni altra riesce a
rifare concretamente un tipo di realtà: non più come il gioco dei bambini che interrompe
temporaneamente le regole mondane, ma come un atto di conoscenza storica che, quelle
stesse regole, permanentemente interpreta, giudica e redime; da un altro mondo, da un altro
punto di vista; là dove scorre un altro tipo di tempo.
Non si tratta più di andare a teatro per confermare la propria conoscenza in merito a un codice
da tutti compreso e accettato. Il repertorio, di fatto, si è interrotto sotto i durissimi colpi di
Beckett – in seguito, evidentemente, ci sono stati altri scatti, altre grida, ma come fulgide
intermittenze destinate rimanere isolati lampi nella notte perchè il filo era già stato spezzato.
Non siamo più in grado di riconoscere una scrittura che parli a una comunità formata e in cui
tutti ritrovano una conferma, sia pur critica, sullo stato delle cose. Per ora. Occorrerebbe un
gigantesco Beckett all’incontrario. Ma, per quanto ne so io, non è ancora nato. Non esiste
ancora una drammaturgia che appartenga interamente a questa epoca. La drammaturgia di
oggi dovrebbe fare i conti con tutti i linguaggi che la circondano, la sovrastano e la assediano:
la pubblicità, la pornografia, la retorica politica, l’immagine televisiva, il cinema, la corrente
delle immagini che, in numero incalcolabile, scorre incessantemente nelle vene dell’etere.
Questi nuovi parenti, arrivati da poco, conoscono in tutto l’icasticità, l’hybris, l’economia
furiosa con cui trattare un’immagine. Al teatro non basterà più un diniego sdegnoso di fronte
alla bassezza di queste discipline; non gli basterà più dichiarare la sua antica stirpe di rango
superiore per una semplice ragione: non è più vero.
Il repertorio è, per definizione, una cosa morta. Pezzi di questo archivio sono spesso utilizzati
per il gioco colto del commento e della “riattualizzazione” in chiave contemporanea. Lo
studio dei suoi “personaggi” può divenire una infinita, estenuante variazione sul tema.
Questa è un’epoca, teatralmente parlando, tra le più conservatrici della storia del teatro
occidentale proprio in un momento in cui la posta in gioco si fa davvero alta in tema di
5
L’intervento è pubblicato nel sito www.arboreto.org.
immagine. Questa è la ragione per cui, giustamente, il teatro è considerato, a tutt’oggi, un’arte
minore.
In nessun’altra epoca si è messo in scena così a lungo il teatro del passato così come succede
ora nei teatri delle nostre città. Ma non è davvero questo il problema. I paesaggisti sono
sempre esistiti e, per quanto mi riguarda, hanno anche loro il diritto di cittadinanza.
Io credo che - una volta compreso che il palcoscenico non è più la casa del logos - una
possibilità di potenza del teatro possa essere quella di andare al di sotto dell’immagine, là
dove non batte mai il sole, al suo volto nascosto; innervarsi in essa per confondersi e lasciarsi
trasportare dalla sua corrente. Ogni vera immagine ha una storia e una via da percorrere in una
dimensione temporale inconoscibile. Anche il suo punto d’origine e la sua destinazione ci
sono precluse. Si tratta di intersecare queste traiettorie misteriose e attraversarle cercando di
riportare a casa la pelle.
Per questa ragione non si può dire di utilizzare un’immagine. Non si può fare dell’immagine
un’economia. Questo lo fanno loro. Per loro l’immagine è univoca e portatrice di un segno,
conduttrice di un sentimento perché ciò che trattano è, in realtà un segno, un pezzo staccato di
linguaggio. La vera immagine nessuno ancora la conosce. Non c’è nulla di mistico in questo:
penso soprattutto a Giacometti che si fermava di fronte al mistero e allo stupore di quello che
era sotto i suoi occhi esattamente “in questo momento”, in tutti i momenti della giornata.
Parlava della incredibile profondità dello sguardo di fronte a tutte le cose e i mille, diecimila
piani di profondità delle cose poste nello spazio “in questo momento”. L’immagine è lì, è
sempre stata lì, sempre sotto i nostri occhi. Nelle cose reali, sospendendo la realtà, attraverso
il reale di uno sguardo. L’immagine è sempre a fianco delle cose, appena un po’ più in là,
fuori fase di quella misura tale per cui, per eccesso di evidenza, noi non riusciamo più a
vederla. Mi viene in mente anche la lettera rubata di Poe. Quello che vogliamo vedere non
siamo capaci di vederlo perché è esattamente sotto i nostri occhi. Non siamo in grado di
vedere il reale della realtà. Artaud diceva che l’uomo deve ancora inventare la realtà. Lì c’è
già tutto quello di cui abbiamo bisogno. Lì c’è già un altro mondo, o come artaudianamente
diceva S. Paolo: il regno dei cieli è già in mezzo a noi. Questa frase è, a ben vedere, tutt’altro
che mistica.
Al teatro è chiesto quello che gli appartiene da sempre: affrontare il pericolo di morte della
Gorgone dell’immagine. È questa lotta con l’immagine che dà accesso a una immagine. Il
pericolo, che invochiamo, è che il suo sguardo si tuffi nelle nostre viscere, che ci possa tirar
fuori dalla tana. L’immagine, come suggeriva Deleuze, non appartiene al visivo - perché noi
siamo la sua pelle, i suoi muscoli e le sue ossa - ma piuttosto al dominio del tatto. Sguardo
aptico. L’inesausta potenza del teatro consiste in ciò che ancora lo distingue da tutte le altre
arti, da tutte le altre discipline: essere un al di qua.
Il riflesso che specchia e guarda la realtà cambiando punto di vista.
Cambiare punto di vista. Lasciarsi vedere eroticamente dalla realtà.
Sulla confusione di questo riflesso si gioca il destino del teatro. La confusione su cui corre
questo riflesso rimane innominabile, irriducibile. Questo campo irragiungibile dai nomi – non
perché mistico, ma perché troppo veloce – è la via di fuga su cui il teatro potrà salvarsi.
Io vado in un teatro, pago il biglietto e entro in una sala in mezzo a degli sconosciuti. Tra
pochi istanti il sipario si alzerà su un incendio.
L’esperienza del teatro credo sia fondata su questo. È l’esperienza intima dello spettatore.
Solo la sua. Davvero. Ogni rappresentazione avviene in lui, e non già per lui. La vera
rappresentazione nessuna la vede veramente. Gli autori e gli attori non c’entrano nulla.
Ritengo chiusa l’epoca dei grandi artisti della scena e dei maestri. Gli artisti non c’entrano più
nulla.
Allora, se è così, sono una serie di intimità ad essere coinvolte. Se ad essere in gioco è la
relazione di quegli spazi vuoti tra una intimità e un’altra, significa che è una comunità quella
che viene qui formata; formata idealmente per la prima e ultima volta, nella durata precisa
dello spettacolo. Un’ immagine diventa irradiante. Il problema non è più il bello o il brutto,
credo, ma l’esatto o il non-esatto. Abbiamo bisogno di una forma esatta, invincibile, che ci
trafigga con lo stiletto della precisione. Forse, Massimo, è questa la bellezza di cui parli?
Che cos’è questa capacità operante del teatro che ci sorprende? Io entro in un teatro. Può
essere un’esperienza sconvolgente per il mio corpo. Deve poter essere senza rimedio. Non c’è
più la comunicazione che appartiene al mondo dei segni, ma la rivelazione delle immagini.
Gli spettatori andranno a teatro, come individui, davanti a una immagine; pronti a raccogliere,
ogni volta, una sfida giocata sul campo dell’estetica che li inerisce fino alla radice dei capelli.
C’è una rivelazione. O meglio: è possibile che ci sia una rivelazione. Non c’è nulla da capire:
c’è una rivelazione. In quell’attimo immobile e atemporale si è trafitti dallo sguardo
trasparente della scena che illumina, solo per un istante, la solitudine dello spettatore. Una
solitudine nuovamente anonima e eroica, nuovamente capace di causare un inconcepibile,
necessario incontro con se stessi
È lo spettacolo che guarda lo spettatore? O forse è lo sguardo dello spettatore che si curva
fino a vedere la propria nuca; fino a vedersi, solo e di spalle, nella sala di quel teatro. La
persona nuda, sotto lo sguardo di tutti, è proprio lui, lo spettatore. La vergogna, chiamata in
causa e essenziale in ogni rappresentazione, è sempre stata la sua.
ÁRPÁD SCHILLING
MASSIMO MARINO
La realtà è uno show di plastica6
La parola è la grande protagonista della scena ungherese. Anche quando si sparano sullo
spettatore musiche techno o lo si investe con immagini proiettate. Il biennale Festival di
Drammaturgia Contemporanea di Budapest è un buon osservatorio per capire il teatro di
questo paese, sospeso fra una solida tradizione di realismo e l’aspirazione a rinnovarsi usando
altri linguaggi, ispirandosi a esperienze che vengono da ovest.
Nelle ultime edizioni questo festival ha segnalato definitivamente all’attenzione
internazionale una giovane coppia di artisti. Si tratta del drammaturgo István Tasnádi, trentun
anno, e del regista Árpád Schilling, ventisei. Capaci di rovesciare la realtà, spiazzando lo
sguardo dello spettatore. In Pubblic enemy, del 1999, raccontavano il Kohlhaas di Kleist
dalla parte dei cavalli dell’eroe, quelli ingiustamente sequestrati dai prepotenti signori, quelli
che scatenano la ribellione dell’eroe. Cavalli dotati, nello spettacolo, di cortesia e altre umane
qualità, in contrapposizione con la grottesca follia di un mondo umano animalizzato.
Il grottesco è una cifra ricorrente non solo nell’opera dei due, ma di molti dei nuovi
drammaturghi ungheresi. La realtà è ribaltata, posta in instabile e comico equilibrio sulle
mani, da raddrizzare. In Nexxt – Frau Plastic Chicken Show Tasnádi e Schilling ci trascinano
in uno studio televisivo, al ritmo di una scatenata orchestrina elettrica, in una scenografia
metallica. Un presentatore con la giacca laminata e la gestualità del venditore televisivo di
tappeti annuncia che assisteremo a una puntata del grande show di Frau Chicken, la caccia a
un serial killer teletrasmessa in diretta, con autorevoli commenti in studio. La presentatrice,
con treccine raccolte a crostata sul capo, appare trasportata da un carrello elevatore tra fumi e
luci da discoteca. Si pianta a un leggio. La sua immagine, ripresa dal basso, come nel Grande
dittatore, viene trasmessa sul grande schermo che chiude la scena. Attenzione - dice - perché
il criminale, il pedofilo, il ladro, l’assassino può essere seduto vicino a voi, può essere the
nexxt, tuu, tuu, tuu (luci sul pubblico, occhio di bue a scrutare, telecamere che riproducono
volti sul grande schermo). Poi il collegamento col ristorante, dove il serial killer
tranquillamente cena: un adrenalinico inviato racconta, travestito lo segue, lo intervista, lo
6
L’articolo è apparso in «Art’o - rivista di cultura e politica delle arti sceniche», primavera 2001.
placca… In studio, ospite, Alex di Arancia meccanica, opportunamente riabilitato, curato dal
virus della violenza, dimesso. Imbarazzato si tormenta le mani: i dettagli vengono ingranditi
sullo schermo. Un pestaggio, in studio, di un barbone, Frau Chicken chiede ad Alex di
colpire, per verificarne gli istinti. Il suo volto è sofferente… Ma il barbone altri non è che lo
psicologo, il vittimologo dello show, che seguirà l’arresto in diretta, che scruterà nel passato e
nel presente di Alex. Continua così, con tagli veloci, colpi di scena, stupri a ritmo di balletto,
flash back, incursioni nel locale, catture, confessioni, scatenamenti di pulsioni violente,
surreali scene splatter, commenti e ingessati dibattiti, seduzioni della conduttrice che si
trasforma in sensuale cantante dalle lunghe chiome sciolte o in querula “chi l’ha visto” o
“carramba che sorpresa”… Si ascolta anche un canto tradizionale di uno spettatore contadino,
un ungherese, di quelli di una volta, in questo mondo americano e plastificato. Fino all’arresto
del serial killer, all’arrivo felliniano di un cardinale che scatena una gara di pentimento in cui
è in palio la grazia, e poi un’ecatombe finale del killer che sembrava redento, Frau Chicken
sgozzata, e la fuga in elicottero del criminale con quella canzone straziante, ungherese, in
sottofondo. E in rutilante finalissimo la resurrezione di Frau Chicken che dà appuntamento
alla prossima puntata dello show.
Un gioco sul mondo della televisione, kitsch, pulp, eccessivo, ma anche molto coraggioso.
Capace di mettere gli spettatori al centro di un’alienazione che vivono tutti i giorni,
inondandoli con tanti materiali da produrre un inevitabile rigetto. Un effetto simile allo
straniamento brechtiano, ottenuto per saturazione, inondazione, superrealtà. In Ungheria la
televisione non è ancora così invadente come da noi. Da noi, dominati come siamo dal mezzo
catodico, uno spettacolo del genere nessuno lo ha ancora pensato.
ALVIS HERMANIS
MASSIMO MARINO
Dal realismo sociale al reality show7
Come pesci in un acquario: mangiano, guardano la televisione, si muovono, dormono,
litigano, reclusi in una casa di plexiglas che sembra uno studio televisivo, scrutati da una
telecamera a vista. I dettagli rubati a queste vite trascinate li vediamo ingigantiti su uno dei tre
schermi sovrastanti la scena; su un altro gli attori, abbandonati i personaggi, confidano
pensieri e smarrimenti, mentre in quello centrale scorrono immagini geometriche, ogni tanto
simili a svastiche.
By Gorky, presentato al festival modenese organizzato da Emilia Romagna Teatro, è un
capolavoro a firma di Alvis Hermanis. Per due ore, in lettone, tiene incollata l’emozione dello
spettatore a una struttura complessa che incrocia il realismo sociale e il “grande fratello”, lo
sfaldarsi del Novecento e il nostro presente mediatico, immagini video e attori, brani di Nei
bassifondi di Maksim Gorkij recitati fuori dalla gabbia trasparente, intorno a un tavolo in
proscenio, e lo scorrere di azioni quotidiane. Come in lavori di altri registi quarantenni dei
paesi dell’ex impero sovietico, una solida tradizione d’attore si cimenta con i segni più
dissonanti della nostra contemporaneità.
By Gorky si collega a The long life, un precedente lavoro “realistico” che trattava
dell’insopportabile vecchiaia, passato l’anno scorso al festival di Parma. Gorkij nel 1902
cercava di fotografare la miseria della metropoli ai tempi della prima industrializzazione;
situazioni e personaggi estratti dal suo testo si sovrappongono ai comportamenti noncuranti,
7
L’articolo è apparso su «Hystrio», n. 1, 2006. Lo spettacolo By Gorky è stato presentato a Modena nell’ottobre
2005 nel corso della rassegna VIE - Scena Contemporanea Festival organizzata da Emilia Romagna Teatro.
Questa la scheda: regia di Alvis Hermanis. Scene e costumi di Monika Pormale. Musiche di Armando Strazds.
Suono di Andris Jarans. Luci e proiezioni di Oskars Plataiskalns. Con Elita Klavina, Regina Razuma, Mara
Kimele, Jana Civzele, Maija Apine, Inge Alsina, Gundars Abolins, Alvis Hermanis, Andris Keiss, Andis Strods,
Aleksandrs Radzevics, Monika Pormale, Aivars Krastins, Jevgenijs Isajevs. Prod. New Riga Theatre, Lettonia.
solitari, intimamente aggressivi che si sviluppano all’interno della “casa”, sempre sospesi in
attesa di un gesto, di un sentimento, di un contatto fra esseri che si incrociano senza
riconoscersi, come in una danza di ombre. La molteplicità di piani ci svela qualcosa di
bruciante, con momenti di emozione pura, distillati da attori capaci di conquistare con uno
sguardo, un movimento, un tono di voce. Gorkij, letto “alla Stanislavskij” quasi come un
Cechov socialista, precipita nel tentativo di cogliere la realtà in flagrante di molte
avanguardie, si inerpica nella poesia di una danza con un sacchetto di plastica “alla Pina
Bausch” o in qualche gruppo vivente “alla Living”, in citazioni di Beckett, del circo, di
Beuys, per sfociare nell’iperrealismo del reality show. La vita si rivela un involucro in attesa
di una qualche forma di esibizione, un insopportabile “truccarsi l’anima”, un perdersi nella
più svagata o rabbiosa finzione che sembra vita di tutti i giorni. Si respira un vuoto pesante,
insieme a una disperazione in cerca di un po’ d’amore, o di una speranza, o almeno di una
consolazione come quella dell’arte. Intanto qualcuno si accontenta di un karaoke su una
nostalgica canzone, o di un energico massaggio sotto le note del Sigfrido di Wagner.
Un testo di Alvis Hermanis8
Venezia è una città che, per motivi ovvi, non ha mai ospitato un cavallo. Horatio de Verecol
spargeva merda di cavallo nelle piazze di primo mattino (trasportata dalla terra ferma in città
non senza difficoltà). Dopodiché, osservava la stupore dei Veneziani e dei turisti che
guardavano la merda sui ciottoli di piazza San Marco poi alzavono gli occhi al cielo dove
volavano soltanto colombi e aeroplani.
L’arte sembra includere la promessa di cambiare il mondo e quindi si potrebbe dire che,
tramite il suo vettore, l’arte rappresenti un’attività rivoluzionaria. Logicamente, se si segue
questo vettore in maniera consequenziale, l’arte penetra la dimensione la cui definizione più
appropriata sarebbe quella del terrorismo. A titolo d’esempio Hacim Bay lo chiama
“terrorismo poetico”. Di pari passo la più alta forma di critica d’arte sarebbe un assalto fisico
su un oggetto d’arte indesiderato, ovvero la jihad estetica.
Come è ben noto il “nuovo ordine mondiale” ha dichiarato il terrorismo suo nemico più
grande, e quindi la stessa cosa vale anche per l’arte. Chiaramente stiamo parlando di prodotti
d’intrattenimento di massa, perchè l’arte non è una merce di scambio, come tutti cercano di
farci capire quasi tutti i giorni. Eppure diventa praticamente impossibile resistere, e tutti noi ci
siamo lasciati sedurre dalla pressione pubblicitaria, dai soprusi dei professionisti del
marketing, direttori artistici, impresari; abbiamo progressivamente tradito i nostri ideali, ci
siamo arruolati nell’esercito degli zombie, ci siamo messi a far il loro gioco. La merda
d’artista in scatola si è venduta di recente per 80,000 dollari. Curt Cobain si trova a bordo di
un Jumbo Jet personale. Il direttore dell’Istituto di Latvia, il cui compito è di dare lustro
all’immagine del suo paese, suggerisce in maniera paterna che il gruppo folk “Ilgi” farebbe
meglio a cantare in inglese. Meriterebbe come minimo una torta in faccia per questa sua
proposta, ma mi viene il dubbio che se ne vanterebbe, visto che il suo nome si aggiungerebbe
all’elenco che include BilI Gates, Milton Friedman, il Principe Carlo d’Inghilterra, Andy
Warhol, Silvester Stallone, Oscar de la Renta, Topolino & Co.
Ovviamente il terrorismo politico non è un gioco da ragazzi. In Norvegia tre persone sono
state arrestate per aver lanciato aeroplani di carta contro l’ambasciata americana. È successo
durante i primi giorni di bombardamento dell’Afganistan.
Non c’è dubbio che siamo sotto sorveglianza stretta. Le telecamere lavorano sia in senso
positivo sia in quello negativo. I centri commerciali in Latvia, che sono diventati il principale
spazio d’aggregazione pubblica, sono gestiti da persone che hanno una preparazione teatrale.
Ci guardano nei loro monitor e noi siamo tutti attori nel loro film. Poche persone ne sono
consapevoli: esiste, però, un piccolo gruppo di artisti che eseguono nel campo di visione di
8
I testi che seguono sono tratti dal sito www.viefestivalmodena.com.
una telecamera anonima scene tratte dal teatro di Beckett e Jarry. L’unico spettatore è l’ignoto
agente della security.
Un membro di un gruppo d’artisti ci racconta: «Nei centri commerciali carichi di telecamere è
vietato ai clienti girare un film o fare fotografie. Scelgo un membro del personale e inizio a
fargli delle domande. “Che cosa sono quegli aggeggi misteriosi appesi al soffitto? Non sono
videocamere? Mi state riprendendo senza il mio consenso?” La commessa s’imbarazza, e
viene chiamato l’addetto alla security, che dà delle giustificazioni, dandomi poi del paranoico.
Quando dice che solo un ladro ha paura della videocamera, tiro fuori la mia e gliela punto
contro.»
Il teleschermo a casa mia si è trasformato in macchina di sorveglianza perché non sono io che
guardo lo schermo ma lui che guarda me e mi segue. Ad esempio, il telegiornale della sera
mantiene l’illusione della democrazia e della scelta politica perché i media lettoni adorano
tutto ciò che è americano e i politici lettoni sono ingenuamente orgogliosi di emulare Thatcher
e Reagan. L’illusione sta nel fatto che si sa da tempo che l’economia globale ha assunto le
funzioni della politica e quindi tutto questo gioco di partiti non è altro che una fiction
televisiva. La parola “fiction” sta bene qua perché l’arte è una finta, una parvenza di realtà
messa a fuoco per la camera.
Il XXI secolo sarà il secolo della manipolazione, e l’arte sarà valutata in funzione della sua
capacità d’essere utilizzata come strumento di manipolazione. Molti di noi lo sanno già, ad
esempio le accademie d’arte la cui funzione effettiva è diventata quella di preparare periti
pubblicitari.
Se parliamo di terrorismo poetico come alternativa e precursore di un’arte del futuro, si deve
ammettere che, messa così, l’idea suona aggressiva; ma non per questo deve essere violenta.
Ci sono eccezioni.
Un tizio chiamato Ronald C. Croniack, il quale aveva appena fatto una rapina in banca, si è
messo subito a distribuire banconote ai passanti che incontrava per la strada dicendo: «Ho
appena fatto una rapina in banca. Buona giornata.»
Prima, cioè, dell’arrivo della polizia. Se, durante la Biennale di Venezia, Bill Gates lasciasse
cadere da un aereo un milione di dollari lo chiameremmo installation artist o performance
artist. (Lo è già da mo’). Perché l’arte deve disseminare non idee e concetti ma gioia. Giusto?
E che cosa ci può dare gioia se non il denaro?
Tutti i giorni sono in circolazione un miliardo di miliardi di dollari. La civiltà ha trovato
finalmente la sua unica religione universale. Finalmente il mondo è unito. Prima c’era l’Età
della Pietra, poi l’Età del Bronzo, poi altre Età. Adesso siamo nell’Età del Denaro. La storia è
finita. Anche qua a Riga, in Latvia. C’è chi resiste ancora a questo nuovo ordine mondiale, ma
vi assicuro che non siamo noi. Ci siamo schierati, furbescamente, dalla parte dei più forti. La
guerra è scoppiata anni fa e si svolge oggi tutto attorno a noi: la più fragile delle poesie deve
affrontare le armi batteriologiche potentissime “made in Hollywood”. Per quanto elegante sia
il nostro ipocrita pattinaggio su ghiaccio, il tempo giunge in cui bisogna fare una scelta.
In Uganda, Africa, un cacciatore è stato processato per aver sparato alle scimmie con siringhe
cariche di tranquillante. Le scimmie sono state travestite da clown e poi liberate nella giungla.
Rimane a noi artisti e performers il compito di mantenere in uno stato di vigilanza lo spirito
umano. Un esempio. Il conducente di un autobus a Seattle, R. Wilson, intrattiene i suoi
passeggeri raccontando barzellette, aneddoti, e poesie composte a casaccio. All’interno della
vettura ha attaccato disegni di visi sorridenti, mentre sotto il sedile sono nascosti dolci e altre
delizie. Ci sono peluches per bambini, e assieme agli altri passeggeri canta spesso canzoni, tra
cui quella più amata recita:
«Ride, ride, ride the bus / Gently down the street.»
Malgrado tutto, si verificano malintesi.
Ad esempio a Londra, durante una processione per le strade, alcuni ragazzi che si trovavano
nei paraggi, hanno circondato l’attore che interpretava la parte di Gesù, e hanno sciolto le
corde che lo legavano alla croce, liberandolo. «Su! Corri! Corri! Ti copriamo noi.»
ALBERTO DI GENNARO
realtà+attore=fantasia. Conversazione con Alvis Hermanis9
Iniziamo dal pubblico dei suoi spettacoli...
Ho paura di essere identificato con qualcosa fuori di me, oppure d’essere etichettato e
rimanere per sempre legato a un giudizio irrevocabile. Quando si diventa rigidi come statue,
cadere è pericoloso: rimangono solo frantumi, tutto ciò che di bello esisteva si polverizza in
un istante. Se il mio nome rimane impigliato a ciò che di buono faccio ora, non ci sarebbe più
ragione di continuare. Non voglio che gli spettatori vengano ai miei spettacoli solo perché ne
ho fatti di buoni prima.
Ripensa oggi alle sue prime esperienze teatrali quando l’urgenza di fare teatro era diversa?
In generale non mi interessa quello che è già compiuto, quello che ho fatto in passato. Sono
invece proiettato verso lo spettacolo che devo fare. Verso qualcosa che non conosco in
anticipo. Le mie scelte vanno sempre ad indagare quello che ignoro, così trovo il modo
d’imparare. Mi pare triste trovare finalmente il proprio stile, un’unica via da seguire per tutta
la vita. Nel periodo cruciale per la Lettonia, tra il ’90 e il ’92, mi trovavo a New York. Al
tempo, non credevo che la liberazione della propria nazione potesse essere più importante
della libertà individuale. Dovevo prima di tutto aprirmi dall’interno ed esplorare e liberarmi.
Più tardi ho capito che il punto sulla carta geografica dove mi trovavo, non aveva alcuna
importanza e incidenza.
Quindi, sono tornato.
Crede ad un teatro con una funzione anche politica?
Per me il teatro è senza funzione, nel senso che non si può usarlo come strumento. Tanto più
se politico. C’era forse un senso quando l’opposizione andava fatta, con tutte le forze, contro
un regime che controllava le idee. Ma ora la Lettonia è un paese indipendente e in piena
crescita, Ci sono dei “giochi” economici che accadono ancora, ma è una situazione comune in
molti altri luoghi. L’arte deve spostare la propria attenzione verso la realtà.
Nel senso di guardare o nel senso di resistere?
Oggi, la resistenza non è da intendersi in senso politico. Si deve resistere e reagire agli
ostacoli che minacciano il proprio lavoro. Qualsiasi ostacolo. L’arte è il mio lavoro, ma è
anche uno specchio di come sono dentro. Se qualcosa ostacola il tuo lavoro, sei tu come
persona che devi rispondere.
Si parla oggi, anche nel campo dell’arte visiva, nel cinema, di “nuovo realismo”...
A mio avviso, la storia di ogni persona che si incontra per strada è molto più importante di
tutte le opere di Shakespeare messe assieme. Il tema che mi ha sempre interessato è la ricerca
della libertà individuale. E questo è connesso inevitabilmente alla realtà, a quello che ci
succede ogni giorno, ad una realtà non spettacolare.
Potremmo intendere l’arte come un’attività rivoluzionaria?
Sì, certo. L’arte include la promessa di cambiare il mondo. Al limite potremmo trattarla come
un’attività terroristica. Hakim Bey parla di “terrorismo poetico”. Ma il terrorismo culturale a
scopo, direi, umanitario, non è privo di rischi: qui a Riga sono state arrestate tre persone che
hanno fatto volare degli aerei di carta “contro” l’ambasciata degli Stati Uniti, quando sono
cominciati i bombardamenti in Afghanistan...
9
Pubblicato in «Teatro/PUBBLICO», aprile-maggio, 9.
E quanto invece di “disumano”, nel senso di tecnologico, nuovi media, linguaggi virtuali c’è
nell’ambito della sua ricerca teatrale?
Non ho il cellulare e il mio segretario è il portiere di questo teatro. Ma, a parte questa nota, il
teatro è l’unica forma d’arte che non può essere riprodotta o prestata in maniera indiretta,
quindi non mi sembra così importante, almeno per il teatro, che viviamo oggi in un’era
elettronica.
Comunque si confronta con i nuovi media. In uno degli ultimi spettacoli, Tâlâk (By Gorky),
metà del boccascena è coperto da un lungo schermo, su cui vengono proiettate immagini
d’interviste e immagini riprese in diretta sulla scena...
Sì. Ma come ho detto non seguo uno stile collaudato e congelato; in modo che tutto possa
accadere.
E come immagina si svilupperà il teatro?
Sono quasi sicuro che il teatro perderà completamente la funzione di procurare divertimento.
È chiaro che se qualcuno vuole divertirsi, il teatro sarà l’ultimo posto dove pensa di andare.
Ma con questo non intendo che il teatro sia un’attività esclusivamente intellettuale.
Cosa pensa dell’attore e come lavorate in rapporto alla realtà?
Un giorno scrissi: A+B=C ovvero Realtà+attore=fantasia. La fantasia non si genera per caso,
ma deve essere stimolata con costanza, continuando a provare con il proprio corpo e la propria
mente. Se un attore non sale sul palco almeno quattro o cinque volte alla settimana, non può
pretendere di diventare un buon attore. Il teatro è una professione che funziona come molte
altre. Io cerco di far rispettare una disciplina e credo sia doveroso prendere seriamente la
nostra attività. Non solo per essere credibili.
Ma, pensando a Tâlâk (By Gorky), non si percepisce un senso di ordine sulla scena...
Infatti quello che lo spettatore vede sul palco è la fantasia. Il teatro è la fantasia secondo cui la
realtà si rigenera attraverso il lavoro dell’attore.
Biografie
Alvis Hermanis nasce a Riga, Lettonia, nel 1965. Cresciuto come attore presso il dipartimento
di teatro del Conservatorio statale nella città di Riga, ne ottiene il diploma nel 1988. Inizia la
sua carriera nell’ambito del teatro e del cinema come attore. Dal 1993 lavora al New Riga
Theatre e fra il 1997 e il 1999 ricopre l’incarico di sovrintendente e direttore artistico. In
seguito, da allora si concentra su quest’ultimo ruolo. Al New Riga Theatre ha messo in scena
più di venti produzioni - di alcune delle quali è stato anche interprete e scenografo. Alcune
sono state realizzate su drammaturgie originali che portano la sua firma, o da suoi adattamenti
di opere in prosa, come Conversazioni sull’amore di Stendhal o Il ritratto di Dorian Gray di
Wilde.
Fra gli spettacoli messi in scena da Hermanis L’ispettore (Gogol), Il Gabbiano (Chekov), Mio
povero Marat (Arbusow), La Città (Grischkowez), Bungee Jumping (Tätte), Arcadia
(Stoppard), La Malattia della Morte (Duras) e Il Marchese de Sade (Mishima).
Numerose produzioni hanno attraversato i palcoscenici d’Europa e sono state ospitate e
premiate da festival internazionali in Lituania, Estonia, Polonia, Russia, USA, Canada,
Austria, Germania, Slovenia, Finlandia, Belgio.
Al Festival di Salisburgo 2003 Hermanis ha ricevuto il premio alla regia Montblanc young
directors project (la penna “Max Reinhardt”). Ha lavorato inoltre come direttore a Tallin e al
Teatro dell’Opera di Riga.
New Riga Theatre (Jaunais Rigas Teatris) è un teatro professionale di repertorio votato
all’innovazione, in sintonia con le esigenze dello spettatore attento al contemporaneo sia per
contenuti che per forme di spettacolo. I principi dell’impegno artistico del NRT sono
semplici: la ricerca di un’alta qualità professionale, estetica ed etica. Il teatro ha un repertorio
acuto e brillante di alta qualità, focalizzato su un pubblico moderno, istruito e socialmente
attivo. Nel 1997 il direttore artistico Alvis Hermanis ha assunto la guida del teatro. Si è
formato un nuovo nucleo artistico di diciassette attori, in Lettonia i più accreditati
professionisti della loro generazione. Nonostante sia un teatro statale, il New Riga Theatre
conserva lo spirito e il metodo di lavoro di un teatro studio rivolto costantemente ai principi di
un’arte non commerciale.