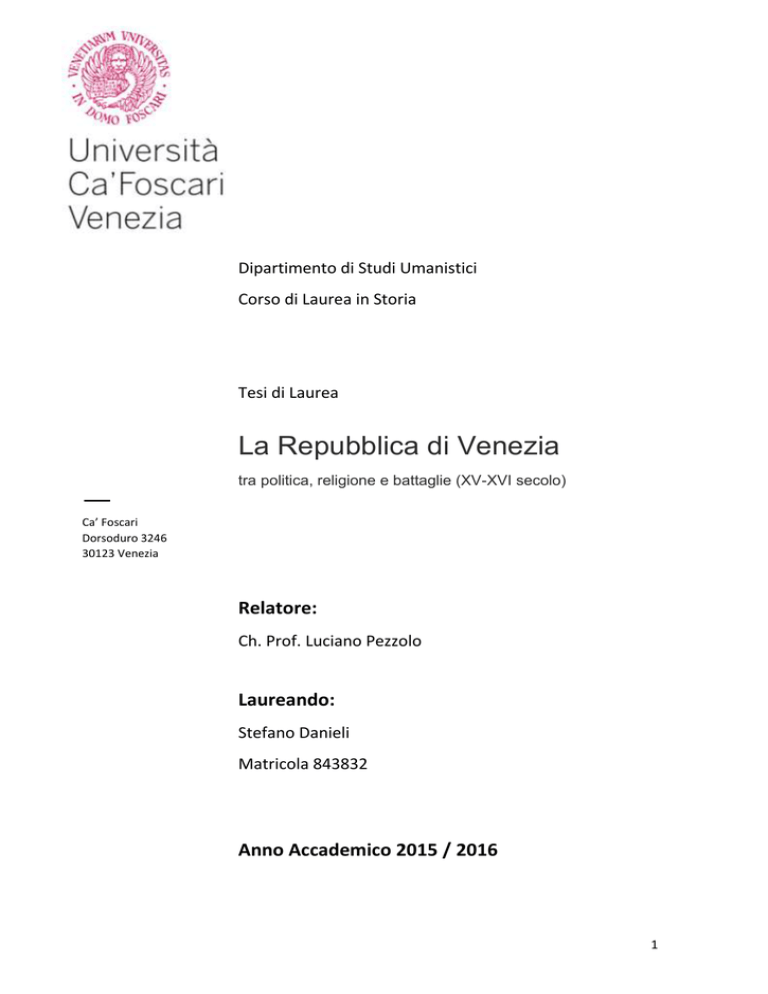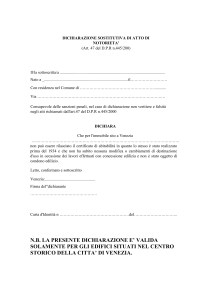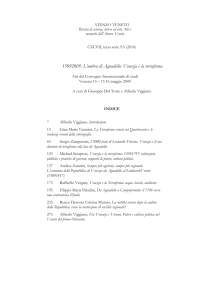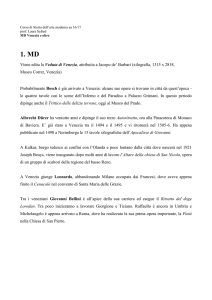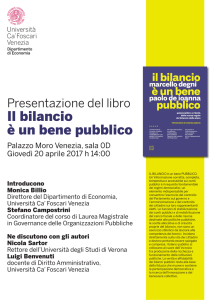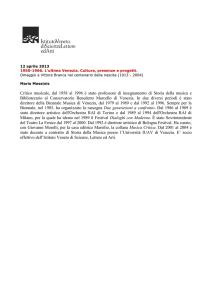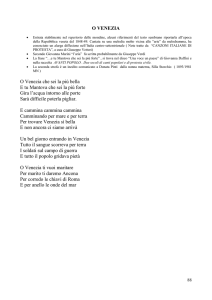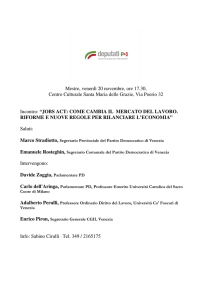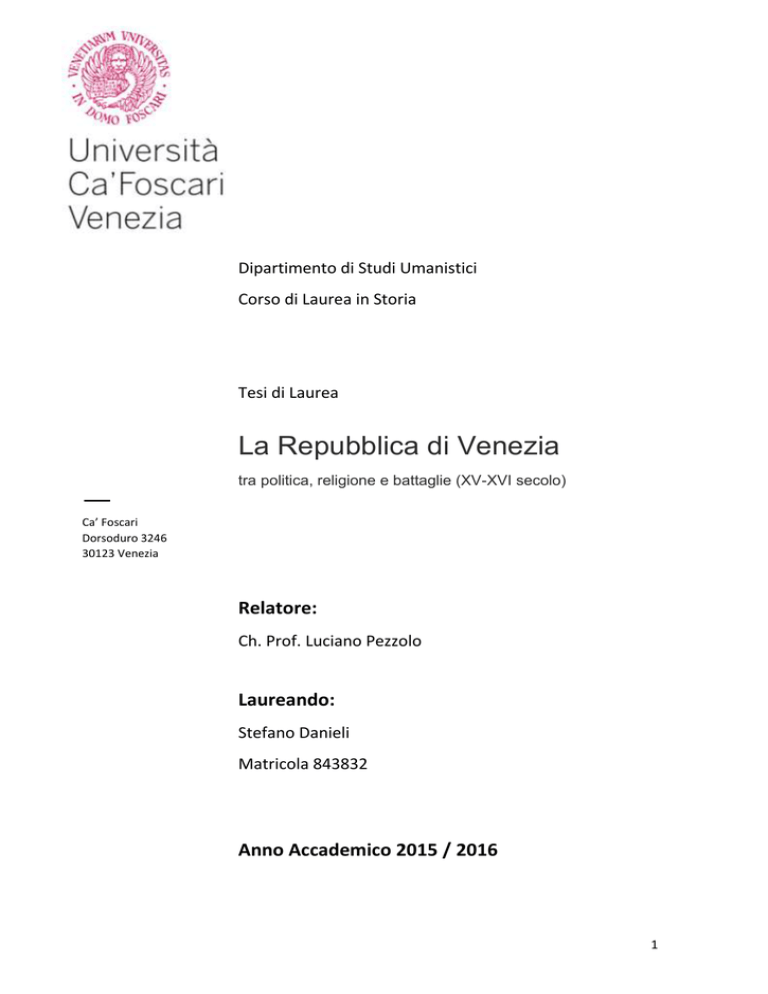
Dipartimento di Studi Umanistici
Corso di Laurea in Storia
Tesi di Laurea
La Repubblica di Venezia
tra politica, religione e battaglie (XV-XVI secolo)
Ca’ Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia
Relatore:
Ch. Prof. Luciano Pezzolo
Laureando:
Stefano Danieli
Matricola 843832
Anno Accademico 2015 / 2016
1
INDICE
Indice
pag. 2
Introduzione
pag. 4
Cap. I: TRA ARISTOCRATICI E SUDDITI
1.1 Tendenze aristocratiche
1.2 I patrizi ed il controllo delle città
pag. 5
Cap. II: ESSERE NOBILI
2.1 Le arti meccaniche
2.2 Il nobile è ricco
2.3 Da cavalieri a magistrati
2.4 Il sangue nobile
pag. 13
Cap. III: AMMINISTRARE IL DIRITTO
3.1 Stato società e giustizia
3.2 Privilegi e particolarismi
3.3 La pena punitiva
pag. 21
Cap. IV: “STADO DA MAR” E “STADO DA TERA”
4.1 La Venezia che precorre il tempo
4.2 L’Istria, la Dalmazia ed il levante
4.3 Unità e disunità di mare e terraferma
pag. 26
Cap. V: LE GUERRE D’ITALIA
5.1 Le origini medievali
5.2 Prime vicende
5.3 L’inaspettata alleanza
5.4 Attriti tra Venezia e la Chiesa
5.5 Interessi romagnoli
5.6 L’Europa contro Venezia
pag. 33
Cap. VI: COSA FU LA LEGA DI CAMBRAI
6.1 L’ origine
6.2 Tra sentimento religioso e senso politico dei veneziani
6.3 La disfatta di Agnadello
6.4 Il volere di Dio, degli astri e la fortuna ad Agnadello
6.5 L’estate 1509
6.6 L’assedio di Padova
pag. 43
Cap. VII: ALL’INDOMANI DI AGNADELLO
7.1 Contese spirituali e temporali
pag. 62
2
7.2 I veneti dopo la disfatta
7.3 Una struttura prettamente aristocratica
7.4 La venalità per necessità
7.5 Conclusione
Bibliografia
pag. 74
3
Introduzione
Nel XIV secolo la Repubblica di Venezia si afferma nello scenario italiano e mondiale,
consolidando il suo dominio in numerosi porti ed isole del Mediterraneo orientale,
creandosi così una forte economia. Allo stesso tempo allargò i suoi confini anche verso
l’entroterra veneto, grazie a patti di dedizione e vittorie militari. Venezia a fine 1400 è
al massimo della sua espansione territoriale.
La ricchezza della Serenissima era incalcolabile, tanto da far invidia alle maggiori
potenze europee.
Venezia poteva inoltre vantare di essere la capitale europea dell’arte, dove trovarono
luce artisti del calibro del Giorgione, del Tiziano e del Bellini. L’arte prometteva essere
uno dei maggiori articoli di esportazione per il commercio veneziano. Principalmente
era il vetro di Murano, il quale aveva raggiunto la massima espressione, ad essere
sinonimo dell’arte veneziana.
È quindi capibile la meraviglia che ci mostra il diarista Marin Sanudo, quando nella sua
cronaca del 1490 ci parla della ricchezza e della bellezza della sua patria,
dell’abbondanza degli alimenti, del buon mercato e del gran consumo che si faceva di
ogni bene. Per quanto da mangiare ci fosse a Venezia “com’è sera non ve n’è”, e questo
perché “tutti compera e vive da signori”.
Ed è proprio per tal magnificenza che il Veneto inizia a far paura ai potentati d’Europa,
i quali volevano far pagare le spese dell’ingrandimento territoriale della Serenissima in
Italia. Riemersero così le vecchie accuse: Venezia mirava a una monarchia italiana e
universale, volendo così far rivivere l’impero romano e impossessandosi della sua
gloria.
Quello stato così ricco e disposto a tutto per difendere la propria indipendenza, non era
ben accetto nel nuovo ordine europeo, era un elemento di disturbo che bisognava
eliminare, ma Venezia si dimostrò un osso troppo duro da rodere.
4
CAPITOLO I
TRA ARISTOCRATICI E SUDDITI
5
1. Tendenze aristocratiche
Il predominio del ceto aristocratico, il quale durante l’epoca veneziana temprò la vita
dei maggiori centri di terraferma, a tempi lontani risale le sue radici: tale era il risultato
del mutamento delle strutture politiche cittadine e delle strutture sociali, tale iniziò con
la crisi del Comune.1 e l’avvento della Signoria.2
Osservando le due principali Signorie del Veneto, la scaligera e la carrarese, notiamo
che in esse furono poste le basi della riscossa aristocratica, compiuta nei tempi
successivi. La democrazia comunale aveva raggiunto, in Padova e Verona, in momenti
prossimi alla crisi, la sua massima estensione, consentendo d’esercitare una forte
influenza al popolo delle Arti nella vita cittadina; cent’anni dopo, quando subentrò il
dominio di Venezia, l’importanza politica delle corporazioni era già stata perduta,
tuttavia la nobiltà e la grossa borghesia avevano acquisito incontrastate il ruolo di
dirigenti, ed erano ormai pronte ad unirsi insieme in una nuova aristocrazia.
Accanto a tali comparivano spesso ricchi borghesi, i “mercatores”, che sembrano
fossero ormai i soli, tra i “populares”, in grado di partecipare alla vita pubblica.
L’influenza politica da essi raggiunta va posta probabilmente in rapporto con la
crescente espansione di cui godeva, in particolare nell’ultimo trentennio del secolo XIV,
l’economia cittadina.
Da un punto di vista prettamente formale, gli organi costitutivi del Comune restano in
vigore, ma subiscono importanti e decisive trasformazioni.
Il maggior consiglio3 diventa così decisamente aristocratico; anche se le basi di tal
processo furono già poste negli ultimi decenni del Duecento, che per analogia si
possono ricondurre alla nascita stessa del Comune, ossia all’iniziale carattere semiprivato di esso cioè un’associazione volontaria di individui, che solo successivamente
aveva allargato la propria funzione a tutta la sfera pubblica, acquisendo un potere
territoriale. Questa dilatazione di autorità tuttavia, non si era accompagnata ad un
parallelo ampliarsi dei diritti verso coloro che ne divenivano soggetti: solamente coloro
1
Il comune di epoca medievale è una forma di governo cittadino, apparsa in Europa occidentale
successivamente all’anno Mille, tale si sviluppò fino a raggiungere riconoscimenti politici da autorità
reali o imperiali, e che in Italia arrivò ad ottenere di fatto l’indipendenza dalle autorità superiori
2
La signoria è una forma d’amministrazione locale che si affermò a fine XIII secolo, dove fin prima erano
presenti dei comuni, tal governo accentra i poteri nelle mani di una singola persona dotata di particolar
prestigio sociale.
3
Il maggior consiglio era la maggiore per numero delle magistrature presenti nella Repubblica
Serenissima, era dotata di poteri legislativi e funzioni di governo.
6
che appartenevano al Comune (vale a dire i membri della classe dirigente cittadina)
potevano godere di piena capacità politica. La democrazia comunale rappresenta un
capovolgimento ideologico e politico rispetto al mondo feudale.
La borghesia, in pieno sviluppo, fa continue pressioni: oltre al fatto che molti uomini
nuovi s’infiltrano nella classe dirigente, divenendo parte integrante della “comunanza”, i
ceti mercantili e artigiani esigono il rispetto dei propri bisogni per mezzo delle
corporazioni, le quali stanno diventano elementi costitutivi dell’organismo municipale,
eleggendo una parte degli Anziani, e, nella fase più avanzata di tale processo,
tenderanno a sovrapporsi ai consigli tradizionali del comune.
Il sistema aristocratico sta nascendo, ma, nonostante ciò che appare, non si può ancora
affermare che sia già instaurato. Mille persone, appartenenti ad altrettanti nuclei
famigliari, sono eccedenti in una piccola città per formare una vera e propria
aristocrazia. Inoltre il seggio non è trasmetto incondizionatamente all’erede: questi per
ottenerlo deve risiedere nello stesso quartiere. Le norme che regolano la successione dei
consiglieri defunti o rinuncianti, sono nate dalla preoccupazione di non turbare
l’equilibrio politico raggiunto tramite la rappresentanza ben distribuita dalle famiglie
socialmente rilevanti; si nota quindi come manchi il concetto di diritto di sangue per
appartenere alla casta dominante, il quale contraddistingue le vere aristocrazie.
Le loro idee sono quindi ora confuse, traballano tra il posto di Consiglio come una
specie di diritto reale ereditario, e la coscienza che tal posto abbia una sua funzione
pubblica che risponde alle esigenze del collettivo interesse.
Potrebbe sembrare in contraddizione il fatto che, nello stesso periodo in cui le
corporazioni pesavano maggiormente nelle vicende politiche cittadine, il Maggior
Consiglio assumesse sempre più carattere d’un corpo chiuso; nonostante ciò il popolo
delle Arti esercitava la sua influenza, non inserendosi negli organi municipali, bensì
attraverso i propri autonomi strumenti di potere: le associazioni di mestiere e la loro
Unione politica e militare.
Il maggior consiglio aveva perso, differentemente dai tempi trascorsi, la funzione di
maggiore organo rappresentativo dei cittadini, è ora un corpo privilegiato, non più
nominato tramite l’elezione popolare, in qualsiasi forma avvenga. Con simili criteri fu
riformato il maggior consiglio di Vicenza nel 1311, quando la città fu assoggettata alla
7
signoria scaligera. L’avvento della signoria segnò, anche in Verona, il declino delle
corporazioni e della democrazia comunale.
A Verona una riforma chiaramente oligarchica fu compiuta il 25 marzo 1350 da
Cangrande II4. Il Maggior consiglio e quello dei gastaldi5 delle Arti furono sostituiti,
anche se non formalmente soppressi, dai deputati “ad utilia”: una magistratura più
ristretta formata da cinque Anziani, sette gastaldi e dodici Sapienti, che duravano in
carica due mesi; alla scadenza il podestà e i ventiquattro deputati uscenti eleggevano i
successori. Questo sistema, che anticipava quello adottato da Venezia, in quasi tutte le
città soggette, doveva restringere a poche famiglie il ceto dirigente, e costituiva perciò
un decisivo passo avanti nell’evoluzione aristocratica della vita cittadina.
Nata grazie ceti artigiani, che intendevano usufruirne nella lotta anti-magnatizia, la
Signoria scaligera aveva condotto invece in breve volgere di tempo alla fine delle libertà
comunali alla rivincita dell’aristocrazia. Della perduta libertà era ben consapevole il
popolo.
La folla anonima, che rivolgeva il suo odio anti-scaligero contro gli statuti cittadini,
aveva individuato in questi il fondamento giuridico e quasi l’immagine concreta d’una
politica, che aveva soppresso la libertà a pieno danno del “popolo”. Il dominio
visconteo non modificò la tendenza dei predecessori, anzi promosse con nuove leggi la
supremazia del signore nei confronti degli antichi organi municipali.
Ciò che è ormai cancellato e non può più rivivere è il senso della libertà comunale, per
cui la città era concepita come entità politica autonoma, nella quale il potere si fondava
sul consenso dei cittadini. Ogni manifestazione autonomistica è ora contenuta
nell’ambito delle questioni amministrative locali, e spogliata di valore politico.
Padova e Verona, principali città della terraferma veneta, sono gli esempi più chiari ed
esaurienti delle mutazioni che si compiono all’interno dell’organismo municipale nel
passaggio dal libero Comune alla Signoria e infine al dominio Veneziano. In questi
centri il progresso economico e la crescita d’una borghesia di ricchi mercanti e di
artigiani, consentirono lo sviluppo del Comune fino alla sua piena maturità e alla fase
4
Cangrande II Della Scala, nacque nel 1332 e morì nel 1359, fu signore di Verona. Figlio di Mastino II,
successe il 13 sett. 1352 allo zio Alberto II. Si appoggiò a Venezia per dar contro ai Visconti. Fu ucciso dal
fratello Cansignorio, il quale voleva che i suoi figli diventassero i signori.
5
Il gastaldo ducale, nella Repubblica di Venezia, era l’ufficio dell’esecutore delle sentenze giudiziarie
civili e penali. Tal carica era riservata agli appartenenti alla classe dei cittadini.
8
estrema, contrassegnata dalla temporanea egemonia delle corporazioni artigiane. In un
secondo momento, magnati e ricca borghesia accettarono il nuovo reggimento, che, se
frustrava le ambizioni di qualche altro influente cittadino, aspirante al dominio
personale, non colpiva gli interessi dei ceti più elevati, anzi offriva loro garanzie di
sicurezza e di preminenza sociale.
Nella Signoria, infatti, vige la logica interna del suo sistema a combattere il potere
politico delle corporazioni artigiane ed a soffocare lo stesso Comune, perciò trasforma
gli organi comunali in strumenti del suo governo, condannandoli ad una progressiva
atrofizzazione.
Si rompeva quindi quell’instabile equilibrio, che approssimativamente per un secolo
aveva consentito alle diverse classi, saldate insieme nell’unità della vita politica
cittadina, di collaborare al governo del Comune. Così si ponevano le premesse del
monopolio del potere da parte d’un ristretto gruppo dirigente formato dalle famiglie
nobili e ricche.6
2. I patrizi ed il controllo delle città
In seguito alla conquista veneziana della terraferma, compiuta nei primi decenni del
Quattrocento, gli organismi comunali delle cittadine venete si avviarono ad assumere
forme di governo chiaramente aristocratiche. Il distacco tra la Dominante e le città
suddite, tra il patriziato veneziano e le classi dirigenti di queste, impedì ai diversi
membri della repubblica, di fondersi totalmente. Nonostante ciò non si deve
fraintendere il significato dell’autonomia concessa ai Comuni. Fu piuttosto il carattere
cittadino e aristocratico della Repubblica che ostacolò la formazione in tutto il suo
dominio d’una classe dirigente omogenea, la quale in altri paesi costituì la premessa
d’uno sviluppo unitario.
La sovranità veneziana si estese alla terraferma in base al diritto di conquista “iure iusti
belli”, ciò fu riconosciuto successivamente dal giurista padovano Marc’Antonio
Pellegrini7, e fu instaurata fin dall’inizio in forme che non pregiudicavano alla
6
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 3-37
7
Marco Antonio Pellegrini, nato a Camisano vicentino il 1° agosto 1530, morto il 5 dicembre 1616, fu un
avvocato fiscale e giureconsulto della Repubblica Serenissima.
9
Dominante la facoltà d’inferire nell’ordinamento e nella vita interna delle città soggette.
L’atto di dedizione, di norma, aveva preceduto nel tempo i “capitoli” destinati a
regolare i rapporti tra governo e amministrazione locale, e ne restava distinto. Venezia
non era disposta a consentire che la consueta prassi della spontanea dedizione,
improvvisata all’ultima ora dalle città conquistate, si spingesse tanto oltre da limitarla
sul piano giuridico e nel suo libero e pieno possesso, derivante dal diritto di conquista,
tanto che anche fronte ad una città non ancora occupata militarmente e capace di
opporre una resistenza, la Repubblica si dimostrava intransigente su tale punto. Ai
cittadini di Zara (ceduta a Venezia nel 1409 da re Ladislao D’Ungheria), i quali
pretendevano di negoziare certi patti prima di aprire le porte all’armata veneta, il
Senato8 mandò a dire che soltanto dopo la loro incondizionata sottomissione avrebbero
potuto inviare ambasciatori alla Signoria per esporre i propri desideri, poiché come
affermò il futuro doge Tommaso Mocenigo9 in carica di procuratore di San Marco e
Savio del Consiglio, “nec moris nostri domini est, ea, que debemus facere de gratia,
facere per pactum expressum”.
Senato e consiglio dei Dieci10, impongono con energia e chiarezza la loro volontà di
amministrare, oltre al campo fiscale, anche in materia statutaria tramite il diritto di
ratificare le riforme decretate dai Consigli comunali, manifestando la profonda e vigile
influenza del governo veneziano nell’evoluzione degli ordinamenti cittadini. Non
mancano casi d’intervento autoritari, “motu proprio”, del governo veneziano, per
modificare gli statuti comunali, soprattutto all’inizio della conquista e dopo la crisi della
lega di Cambrai: azioni la cui legittimità riposa sul principio del Senato, che ad esso era
sempre riservato “l’arbitrium” di riformare gli statuti delle città sottoposte al governo
veneziano.
8
Il Senato era chiamato anche Consiglio dei Pregadi, o dei Rogadi. Tale era un organo costituzionale
della Repubblica di Venezia, venne istituito nel 1229, si riuniva per discutere, e poi deliberare, a riguardo
della politica estera e problemi correnti che richiedevano un meccanismo di decisioni più veloce rispetto
al Maggior Consiglio.
9
Tommaso Mocenigo, nato nel 1343 e morto nel 1423, fu il 64° doge della Repubblica di Venezia dal 7
gennaio 1414 fino alla sua morte. Nel 1381 fu nominato provveditore d’armata, nel 1396 capitano
generale della flotta e duca di Candia nel 1403.
10
Il Consiglio dei Dieci, noto anche col nome di Consiglio dei X, o semplicemente i Dieci, fu uno dei
massimi organi di governo della Repubblica di Venezia dal 1310 fino alla sua caduta, che avvenne nel
1797. Era formato da dieci membri, i quali venivano eletti ogni anno dal Maggior Consiglio per
sorvegliare sulla sicurezza dello Stato.
10
Nonostante la ferma determinazione di questa condotta, Venezia, fino a che non siano
necessarie modificazioni per circostanze eccezionali, preferisce conservare i privilegi
concessi alle città, naturalmente gelose della loro restante autonomia.
Nonostante la Repubblica disponesse di forze potenti e d’un apparato statale tra i più
efficienti, il cui nocciolo era formato da un’aristocrazia numerosa e affinata nella pratica
di governo da una tradizione secolare, le strutture burocratiche e militari erano non del
tutto adeguate dal possedere l’ampiezza necessaria per svilupparsi ad ogni piano del
potere, sottoponendo alla propria autorità e controllo tutti i rami dell’amministrazione
pubblica nei territori soggetti. I rettori, nobili veneziani, come rappresentanti d’un
governo autoritario e dominatore, in linea teorica possedevano ampi poteri, erano in
grado d’intervenire in qualunque affare di qualsiasi importanza e di sindacare tutti gli
atti delle comunità: un “capitano”, nelle città principali, sopraintendeva alle cose
militari (fortezze, munizioni, cernide, genti d’arme, ecc.) e alla Camera fiscale,
estendendo la sua autorità su tutto il “territorio”; affianco a lui, con uguale merito, un
podestà, coadiuvato dalla propria “corte”, era giudice delle cause criminali e in alcuni
casi anche di quelle civili con maggiore importanza, manteneva l’ordine pubblico e
vigilava sul corretto funzionamento dei Consigli e degli uffici cittadini, secondo le
norme previste dagli statuti.
Contrariamente a ciò nell’effettivo svolgere la carica i rettori dovevano far largo
affidamento sugli organi comunali e sul ceto dirigente locale. Ciò creava tra le comunità
suddite e lo stato una situazione insuperabile, perché i cittadini padovani o veronesi o
bresciani assoggettati, in assenza della speranza di potersi presentare alle porte del
patriziato veneziano, si sentirono mai completamente parte della Repubblica.
Per rompere questa situazione sarebbe stato necessario che il patriziato dominante
avesse rinunciato spontaneamente ai propri privilegi, unendosi alla nobiltà suddita, ciò
avrebbe però significato colpire alla base la costituzione aristocratico-cittadina della
Repubblica. Sarebbe altrimenti occorso togliere ogni potere ai ceti dirigenti delle città
soggette, sostituendovi un esteso apparato burocratico centralizzato, in grado di far
fronte a tutte le complesse esigenze dell’amministrazione. A ciò contrastava in primo
luogo la mentalità dello stesso patriziato veneziano, fissato nel particolarismo
municipale e non disponibile ad assurgere a una concezione organica e universale dello
stato.
11
Era impensabile distanziare completamente dal potere i ceti dirigenti dei cittadini senza
una repressione. Nelle maggiori città assoggettate era ancora fortemente sentita una
tradizione d’indipendenza, nata nel periodo comunale e conservata anche in quello
signorile. Nei centri come Padova e Verona, i ceti dirigenti affiancavano la Signoria
della sua politica di espansione, giacché coincideva con i propri interessi, e così facendo
spinsero il loro senso del potere oltre i confini del territorio comunale.
Nonostante queste difficoltà, lo sforzo per accentrare il potere, effettuato dal governo
veneziano fin dagli inizi della conquista, fu notevole. Tal manovra servì per ridurre le
oligarchie cittadine ad amministrazione locale, sottopose i Comuni a rigorosi controlli,
ne mutò le basi e le strutture, rendendole armoniche col sistema aristocratico veneziano.
L’importanza irrevocabile e ultima dell’atto di dedizione è valorizzata dal fatto che
Venezia non è un signore, alla cui morte il potere ritornerebbe al Comune, ma si tratta di
uno stato molto forte e stabile, il cui governo durerà per secoli.
Tale atto di dedizione, non necessariamente fu l’estrema espressione del volere del
Comune, bensì, delle volte, il riconoscimento del diritto di conquista veneziano. Nella
sostanza, il rapporto tra la Dominante Venezia e le città presenti nel suo territorio è
impostato su un piano di sudditanza, in quanto Venezia è più forte d’ogni altro signore
del passato, e riesce a far valere maggiormente la propria volontà. D’ora in poi
deliberazioni importanti per la vita economica e sociale cittadina saranno prese a
Venezia.
Con la dominazione veneta inizia così una vera restaurazione, in vesti nuove, della
società aristocratica, separate dalle barriere dei privilegi e dei pregiudizi, prima ancora
che dalle leggi discriminanti. Venezia, su questa strada, aveva preceduto le altre città
della penisola. La “serrata” del Maggior Consiglio11, al cadere del XIII secolo, trasferì
la sovranità della “civitas” ad una casta chiusa di cittadini. Attraverso una serie di
provvedimenti via via più restrittivi l’aristocrazia veneziana aveva eliminato anche ogni
residuo formale del vecchio sistema politico: il “Comune Venetiarum” aveva lasciato il
posto al “Dominium”.12
11
La Serrata fu un atto di riforma del Maggior Consiglio della Repubblica di Venezia, avvenuto nel 1297.
Tal atto è comunemente ritenuto un colpo di Stato, tramite il quale l’aristocrazia veneziana impedì alle
classi popolari l’accesso al governo della Repubblica. In realtà si trattò di un ampliamento della classe
dirigente, effettuato con lo scopo di moderare la lotta tra le fazioni.
12
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 39-51
12
CAPITOLO II
ESSERE NOBILI
13
1. Le arti meccaniche
Concetto certo è che il gentiluomo, oltre ad aver ereditato un sangue nobile, deve essere
puro, cioè se stesso e nelle due generazioni precedenti, non dev’essere contaminato
dalla macchia delle “arti meccaniche”. In quest’ambiente quindi le “arti meccaniche”
assumono un preciso valore politico. Tal disprezzo e ostracismo, ora riaffermato con
valore politico, non è certo qualcosa di nuovo, essendo un tratto caratteristico della
società feudale. Tutte queste preclusioni, fin dall’inizio del Quattrocento, si trasformano
in precise norme degli statuti: ad esempio a Belluno nel 1416, nel regolamento del
“rodulo”, e poi negli statuti del Comune con la riforma del 1423.
Il riaffermare della “viltà” della popolazione artigiana, gli antichi pregiudizi e luoghi
comuni sulla sua incapacità di seguire gli affari pubblici, poiché gli artigiani sarebbero
perennemente occupati nelle loro botteghe e laboratori, ed inoltre perché l’ “ignobiltà”
della discendenza e del mestiere ne fa nascere uno spirito che per sua natura è rozzo,
non accostabile alle necessarie virtù che servono a reggere la cosa pubblica. Tali sono
tutti tentativi di giustificazione per elevare la dignità dei “nobili”, una realtà che, di
fatto, ci mostra uno stato d’animo fermentante l’antagonismo di classe. Così facendo il
concetto di “arte meccanica” si precisa e si amplia, fino a comprendere tutti i mestieri
contrari all’onore del gentiluomo, al quale si addicono soltanto la carriera negli uffici
pubblici e quella delle armi, e il “vivere d’entrata”, cioè vivere usufruendo dalle rendite
provenienti da beni immobili, per lo più fondiari.
Elementi di trasformazione si potevano notare anche nei costumi del patriziato
veneziano in quanto, al progressivo abbandono della mercatura si facevano strada i
grandi investimenti fondiari nella terraferma.
Segni di mutamento erano visibili anche nei costumi del patriziato veneziano, dove al
graduale abbandono della mercatura facevano riscontro i massicci investimenti fondiari
in terraferma.
Dal diario del Priuli13 (1509) possiamo estrapolare tal affermazione:
13
Priuli Girolamo, era un membro del patriziato veneziano, anch’esso mercante. Nacque nel 1476 e morì
nel 1547. Oltre all’attività di mercante era gestore di un banco di scritta presso Rialto, inoltre si dilettava
nella stesura di un diario.
14
“in questa benedectra citade veneta li marchandati hera li disprexiati et vituperati da
tuti et haveanno pochi honori, donde che molti marchadantti per simile rispecto
haveanno comprato deli sui danari, posessione et altro per vivere de entrade. Et questa
hera la ruina veneta…”.
Diventavano perciò possessori di tenute, nelle quali costruivano ville e vi andavano a
“solazo”, spendendo più degli utili ricavati dalle terre. Inoltre i più giovani, i quali
tempo addietro si dedicavano alla navigazione ed ai guadagni, ora:
“atendevanno ali solazi, a piaceri, a chaze et sparbieri, astori cum grandissima spexa,
et de merchadantti diventavano villano senza experientia delle chosse del mondo”.
Brescia fu la prima città che, già nel 1546, eliminò dai propri Consigli i cittadini
macchiati di “meccanica”, questa città precede, di conseguenza, le altre anche
nell’istituire inquisizioni contro i consiglieri sospettati di tal ignobiltà. Più passava il
tempo e più il contrapporsi alle mercature ed alle arti meccaniche diveniva sempre più
intransigente: era facile mettere il dubbio sull’ “onore” di qualche cittadino, ed
impedirgli così l’ingresso nel Consiglio. Inoltre la persona “civile” doveva vestire
sempre abiti adeguati al suo rango sociale e doveva ben guardarsi dal frequentare
persone di ceto inferiore.
Nei secoli precedenti, alcuni giuristi sostenevano che il dottorato era un titolo
sufficiente per essere nobile, tuttavia tal concetto nel Cinquecento non solo ha perduto
ogni validità, ma venne capovolto: non è più il solo dottorato che conferisce il titolo,
bensì è necessario un certo grado di civiltà, acquisito mediante la partecipazione ai
collegi professionali, per far si che il titolo accademico abbia effettiva efficacia.
Il concetto d’onore varia tuttavia dalle maggiori città ai centri più piccoli. Cioè
l’occupazione reputata “incivile” e “meccanica” nelle prime, non è reputata tale per i
cittadini di Adria o Bassano. A proposito dell’argomento dei lavori agricoli, negli statuti
del Comune di Adria si stabilisce.14
“che dal miedere et palinar le vigne soe et crisarle, non intendendo delle vigne d’altri,
in fuora, et cadauno che farà altre opere, come cavare fossa, andar ad opera a zapare,
et huiusmodi similia…se debba trattare, appellare, et nominare per rustico et villano”15
14
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 300-324
15
Statuta, ordines et provisiones civitati adriae
15
2. Il nobile è ricco
Opinione diffusa nella coscienza nobiliare, a partire dal Cinquecento, è“l’oro essere
tale alla condizione di gentiluomo, quale è il ferro al soldato”.16
Gli averi quindi, prima di tutto, “sono di grande aiuto e alla buona disposizione
interna, e all’esterna operazione della virtù”. Difatti la persona ricca si alimenta di cibi
buoni, che lo rendono maggiormente disposto alle discipline della mente, qualità che poi
trasmette ai figli, mentre il povero, nutrendosi di cibi grossolani, genera figli che come
esso stesso sono “anzi robusti di corpo che pronti d’ingegno”. Grazie al denaro l’uomo
può praticare “esercizi nobili e virtuosi; dove la povertà nell’arti vili e meccaniche lo
tiene del continovo occupato, per lo sostentamento della vita”.17
I concetti ora presi in esame non sono semplici considerazioni letterarie, ma sono frutto
di un costume e un modo di pensare molto radicati, che trovano applicazione negli
ordinamenti dei Consigli.
Esempio di tal applicazione lo troviamo a Padova, dove fu fissata a 12 soldi la quota
minima dell’estimo, “che rendino veramente entrata”, in quanto, se il censo fosse stato
inferiore non era possibile che un “uomo civile” potesse “farsi capace di un collegio
riguardevole”.
La convivenza tra il ceto formato dai cittadini dirigenti e quello dei proprietari fondiari e
immobiliari, che si era già notata nel Quattrocento, prosegue anche nei secoli seguenti
con un’evoluzione. Infatti, se da un lato la totale scomparsa dei mercanti accentua il
fenomeno, dall’altro il ceto aristocratico si viene progressivamente differenziando dagli
altri gruppi sociali economicamente simili. Assistiamo quindi a una maggiore frequenza
di casi di plebei ricchi possidenti e di nobili poveri, aventi quindi poche proprietà, che
per la maggiore, vivono grazie agli utili degli uffici pubblici.
16
Cit. Sperone Speroni, nato a Padova nel 1500 e morto nella stessa città nel 1588, fu scrittore e filosofo.
La sua era una famiglia padovana. Il padre era archiriatra di papa Leone X, mentre la madre Lucia era
parte della famiglia dei Contarini.
17
Cit. Paruta Paolo, nato a Venezia il 14 maggio 1540 e morto a Venezia il 6 dicembre 1598, fu storico,
politico e diplomatico. Nato da famiglia lucchese, intraprese i suoi studi a Padova, successivamente
diventò segretario di un consigliere dei X.
16
Tuttavia la nobiltà del Consiglio resta costituita in gran parte di proprietari che vivono
di rendita, invece dei cittadini possessori di terre nel contado ne interpreta gli interessi,
con l’attuazione della politica annonaria.18
3. Da cavalieri a magistrati
Il nobile, come lo s’immaginava nei tempi passati, che governa una terra e guida in
battaglie le proprie schiere, dove dal valor militare proviene la sua forza politica e il suo
prestigio, nutrito da spirito cavalleresco, onorato della fedeltà verso il proprio signore,
questo è il modello d’un mondo ormai perso, il quale sopravvive solo in poche zone del
territorio veneziano, particolarmente nel Friuli.
Tuttavia i nobili cittadini non si estraniano totalmente dagli ideali e dai costumi
cavallereschi, come quel Francesco Brenzon, membro dell’ambasciata veronese che il 4
febbraio 1517 rinnovò a Venezia l’antico giuramento di fede, il quale rivolto al doge
esclamò:
“Serenissimo Principe, son Francesco dil Brenzon vostro sviserato servidor, qual ha
patido danni grandissimi, prexon, exilio e altro per la fedeltà soa verso questa
Illustrissima Signoria…, et non dimanda altro premio so non un segno di fedeltà ch’è la
cavalaria, qual sempre vol aver in nome di questo Excelentisimo Stado nel petto e con
quelo vol morir”. Il doge19 in seduta stante lo elevò alla milizia.
Nonostante si facesse una copiosa letteratura che elevava la virtù militare, alla quale si
voleva associare l’origine della nobiltà, pochi gentiluomini abitanti in terraferma si
dedicavano alle armi ed al loro esercizio.
La via prescelta per diventare nobili non era quindi la spada, ma la toga da magistrato o
da pubblico ufficiale, sebbene il gentiluomo porti il ferro, cioè la spada, al suo fianco
come simbolo di status. Conseguentemente mutavano anche i campi di battaglia di
questi nobili con la toga, ora tali campi si trasformano in Consigli ed uffici cittadini, il
suo esercizio quotidiano è l’amministrazione pubblica, che tenta di piegare a proprio
vantaggio, le sue armi sono le “ballotte” di pezza che si utilizzavano per votare, le
18
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 330-334
19
Il doge in carica era Leonardo Loredan, nato a Venezia il 16 novembre 1436 e morto il 21 giugno 1521,
fu il 75esimo doge, era una persona saggia e abile nell’affrontare le insidie turche e la Lega di Cambrai. A
seguito della sua morte venne fatta un’inchiesta con oggetto l’appropriazione di fondi statali, venne
reputato colpevole e gli eredi dovettero risarcire lo Stato.
17
relazioni familiari ed il clientelismo. In concreto, nello stato feudale la nobiltà era
associata all’investitura d’un feudo, invece presso il patriziato cittadino la nobiltà si
associa all’ufficio.
All’inizio del Quattrocento il giurista Paolo di Castro20, illustra come la natura e
l’origine della “gentilezza” variano in base alle leggi ed alle consuetudini locali, citando
come esempio Venezia, “ubi omnes qui sunt de officiis publicis seu consilio sunt
nobiles et tamen hoc in aliis civitatibus non reperitur”. Era diffuso tra i giuristi il
concetto che l’ufficio in genere conferisse una “dignitas”, però questa non comportava
di per sé la nobiltà.
Il principio, da secoli attivo a Venezia, che l’appartenere al Consiglio conferisse titolo
di nobiltà, si diffuse nello “stado da tera” tra la fine del Quattrocento e gli inizi del
Cinquecento, dopo che il ceto dirigente divenne un’aristocrazia, il trionfo indiscusso di
ciò avvenne con le “serrate”, che lo tradussero in forme giuridiche precise. Senza falsi
pudori, il gentiluomo concepisce apertamente la carica pubblica soprattutto come
“onore” e “utilità” e come mezzo di prestigio e di guadagno. Il Consiglio di Brescia, con
la serrata del 1488, emana una norma che elimina ogni possibilità di forestieri e non
originari, di essere assimilati agli antichi cittadini rispetto ai privilegi, immunità, uffici
ed onori.
Solitamente, le magistrature con maggior valenza politica, le quali rappresentano, per
così dire, il governo della Repubblica, non venivano retribuite. Esse quindi sono ambite
solamente dai più ricchi e potenti per ragioni meramente di prestigio, ciò avvenne
perché si configurano come posizioni chiave nell’amministrazione della città e nel
controllo della distribuzione degli uffici.
Affiancate ad esse, in ogni città esistono molteplici cariche pubbliche remunerate,
contese dai nobili, poveri e ricchi che siano, in quanto, con l’avvenire della dominazione
veneta, i ceti dirigenti di ogni città avevano perso parte degli uffici pubblici esistenti
precedentemente. Nei centri maggiori del territorio, un tempo governati da podestà
cittadini, ora Venezia manda suoi gentiluomini, ciascuno dei quali accompagnato da un
proprio cancelliere. Inoltre nelle città le cause criminali e le civili di maggior rilievo
20
Paolo di Castro, chiamato anche Paolo Castrense, nato a Castro (Lazio) nel secolo XIV, e morto nel
1441, fu insegnante e giurista inizialmente presso Avignone, poi Siena, Firenze e dal 1429 fino alla morte
a Padova.
18
sono devolute ai compiti del podestà veneziano ed alla sua corte. Nondimeno gli uffici a
disposizione dei “cittadini” restano comunque numerosi.
Oltre all’utile, nei Consigli e negli uffici, il nobile ricerca l’onore. S’impone quindi la
forza del costume e della comune opinione, che lo stesso Paruta affermò: “quell’onore
che è segno apparente di virtù, non può essere in niun modo vero onore”. Ecco
presentarsi per l’onore uno sdoppiamento di significato, per cui, anche in assenza del
suo fondamento morale, conserva intatta la sua efficacia nel piano pratico, che fuori da
ogni retorica e moralismo, è ciò che conta.21
4. Il sangue nobile
I pensieri sulla quella cosiddetta nobiltà “civile” considerata come privilegio di sangue,
circolano in tutto il mondo giuridico italiano.
Di fatto in larghe zone è ancora diffuso il feudo, ed in altri luoghi l’aristocrazia è ancora
in posizione di predominio, inoltre laddove sorgono i maggiori centri comunali, nelle
grandi famiglie sopravvivono gli ideali nobiliari, le quali tendono a conservare le
antiche tradizioni.
Nel trattato “De imperatore militum deligendo”, il gentiluomo veronese Bartolomeo
Cipolla22, espresse concetti chiaramente aristocratici, terminando con l’idea secondo la
quale, chi ha meritato la nobiltà con la propria virtù è da considerarsi “più nobile”
rispetto a chi l’ha ereditata. Con tale affermazione notiamo che la famiglia è ora il
tassello politico fondamentale.
Per garantire la purezza del sangue nobile sono emanate anche norme, secondo cui per
essere gentiluomo la nascita dev’essere legittima. A tali si aggiunsero altre leggi
restrittive, approvate prevalentemente nel Settecento, eccetto alcune città come Treviso,
che già verso la fine del Cinquecento, si richiedeva anche la “civiltà” della madre. Non
21
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 338-350
22
Cipolla Bartolomeo, nato a Verona nel 1420 circa, e morto a Padova il 10 o 11 maggio 1475, fu giurista
veneto, uno dei più importanti del millennio scorso, i suoi scritti furono largamente ripubblicati negli
anni; nella sua vita svolgeva anche la funzione di ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia.
19
sono però solamente antichità e purezza a costituire la forza della propria casata, in
quanto ad esse bisognava aggiungere coesione morale ed un buon patrimonio.23
23
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 287-296
20
CAPITOLO III
AMMINISTRARE IL DIRITTO
21
1. La politica del diritto
Per quanto riguarda le origini del diritto veneto, per più secoli Venezia non fu governata
da leggi scritte, regolando la sua vita civile ed i rapporti tra privati, basandosi sulle
consuetudini.
Il mutamento avvenne nella seconda metà del XII secolo perché fu redatta la prima
legislazione scritta, destinata a diventare sempre più varia e ampia. Uscì quindi nel 1181
la “promissio maleficiorum” redatta dal doge Jacopo Tiepolo24, testo giuridico che sarà
il cardine del diritto veneto. Una svolta significativa avvenne nel 1242, quando lo stesso
doge Tiepolo, ancora in carica, diede il compito a quattro giuristi, “dissertissimos nobile
et discretos25”, di rivedere la legislazione nella sua totalità, per integrarla e riordinarla, e
per finire redigere un corpo statutario, i cosiddetti “Statuta” del “Comune
Veneciarum”. Tale sistemazione non sarà però definitiva, già all’inizio del XIV secolo
si apporteranno delle correzioni.
Escluso dalle fonti del diritto, restava il diritto romano, o diritto imperiale,
esclusivamente per decisione politica presa in quanto Venezia si stava affermando su
territori da essa distanti, e voleva dare il senso che il suo potere fosse totalmente
indipendente da altri, e quindi indipendente fosse la sua sovranità, eliminando ogni
dubbio sulla sua soggezione, presente e passata, nei confronti di altri signori,
principalmente verso l’Impero romano d’Occidente, il “dominus omnuim”. Ecco quindi
che il suo rifiuto del diritto romano, espressione dell’universalità imperiale, fu
l’emanazione dello “ius proprium”.
Lo storico Enrico Besta26 ha inoltre messo l’accento su una particolarità del diritto
veneto, cioè sul suo principio di territorialità, “che nel continente si attuò con grande
difficoltà, laddove a Venezia si realizzò fin nelle età più remote”27. Il principio di
territorialità, cioè l’obbligo, da parte di tutti coloro che si trovavano all’interno dei
confini della Serenissima, di rispettare le leggi di quella terra, qualunque fosse la loro
24
Tiepolo Jacopo, nato a Venezia in data ignota, morto a Venezia il 19 luglio 1249, fu il 43esimo doge
della Repubblica Serenissima in carica dal 6 marzo 1229 al 2 maggio 1249, il suo dogado finì in quanto
abdicò e si ritirò a vita privata.
25
Da tradurre
26
Besta Enrico, nato a Treviso il 29 giugno 1874 e morto a Milano il 12 luglio i1952, fu giurista e storico
italiano. Iniziò i propri studi di storia del diritto all’Università di Padova. Pochi anni ci mise per divenire
uno dei maggiori studiosi della materia. Raggiunse fama internazionale approfondendo molti temi
storici, in particolare riferiti al periodo medievale.
27
Enrico Besta, il diritto e le leggi civili, cit, p. 309
22
zona di provenienza, ci fa notare il principio ad esso conseguente, quello dell’unità del
diritto in un territorio governato dal stesso signore.
È interessante notare come i governanti veneziani, tal cosa la ricorda anche Besta,
proiettavano il loro diritto nei centri minori della Repubblica, pur lasciando a ciascuno i
loro statuti e le loro particolari consuetudini.28
2. Privilegi e particolarismi
Aspetto sicuramente interessante e sorprendente dell’amministrazione della giustizia
nello “stato da tera” era la varietà e l’estensione dei privilegi. La Repubblica, pur
restando sovrana, concesse alle città ad essa sottoposte di mantenere le proprie strutture
giudiziarie. Molteplici privilegi giuridici furono concessi nel Friuli, dove il feudalesimo
era ben saldo. In tal luogo notiamo come Venezia, al momento della dedizione, rispettò
la suddivisione tra clero, nobili castellani e comunità del parlamento friulano,
togliendone però le funzioni più importanti ed inviando ad Udine un proprio
luogotenente, per governare tali territori.
Il Friuli, precisamente ad Aquileia, c’era la sede del Patriarca, il quale si opponeva
all’espansione della giurisdizione della Serenissima sul territorio arciducale. Il
patriarcato aquileiese fu finalmente assoggettato negli anni venti del 1400, ma tale fu
per lungo tempo motivo di scontro e tensioni con la Chiesa. Di ampi privilegi potevano
godere le città di Cividale e Pordenone, le quali, non dipendendo dall’autorità del
luogotenente di Udine, la Repubblica inviò in loco un suo provveditore.
Privilegi di altra natura erano goduti da città come Feltre, Belluno, Vicenza e Verona,
nelle quali era ancora presente la magistratura del Consolato. Ad esempio a Vicenza il
Consolato aveva grandi poteri in materia giuridica. Composta di dodici nobili, eletti dal
maggior consiglio della città vicentina, avevano carica quattro mesi e come a Verona,
esso concorreva all’ordinaria amministrazione giudiziaria, con poteri deliberativi.
Giurisdizione del Consolato vicentino che era più ampia che quella veronese. A Vicenza
un console incaricato, assieme ad un notaio cittadino, poteva formare i processi senza la
supervisione del “giudice del malefico”.29
28
29
Cozzi Gaetano, Stato società e giustizia nella repubblica veneta, Jouvence, 1985, pp 21-28
Ius civile vicentinum, cit, c. 14
23
Sebbene questi fossero ampi privilegi in materia giuridica, nella pratica il Consiglio dei
dieci non era del tutto estraniato dalle procedure poiché esso era in grado, quasi in ogni
momento, di comprendere le dimensioni dell’emergente criminalità, potendo notare di
conseguenza l’importanza sociale degli imputati, la natura, il tempo ed il luogo del
crimine. Tale verifica avveniva anche grazie all’aiuto diretto dei sudditi, i quali
attraverso le suppliche, correggevano le distorsioni e le mancanze dell’apparato
burocratico-giudiziario ordinario.
Non indifferente deve restare l’attenzione verso le condizioni effettivamente difficili in
cui doveva agire l’amministrazione giudiziaria del tempo. Le distanze, notevoli se
consideriamo le zone più lontane della Repubblica, potevano anche essere superate
tramite corrieri organizzati, ma preoccupante era principalmente l’insicura condizione in
cui si trovavano le vie di comunicazione, soprattutto in quei luoghi di attraversamento di
confine dove gli “svaliggi” erano frequenti. Agivano negativamente quindi, sul sistema
giudiziario, delle condizioni difficili che rompevano il corretto funzionamento e
isolavano maggiormente determinate zone.30
3. La pena punitiva
Il carcere come pena trova le sue origini nella necessità di sorvegliare gli imputati,
anche se, gradualmente, l’uso di condannare a periodi detentivi più prolungati si estese,
sino a diventare a tutti gli effetti una pena. Nella comprensione di ciò ci può essere utile
porre a confronto le pene notando così un divario tra l’uso del carcere e quello della
galera, la quale essendo molto esteso, dovette limitare notevolmente il primo.
Il limitato uso del carcere come pena si presuppone sia dovuto alle condizioni
d’insicurezza delle prigioni, non adatte a trattenere insieme condannati e persone in
attesa di giudizio. Il poco spazio e la scarsa igiene facevano sì che i prigionieri erano
spesso soggetti ad epidemie, da cui venivano decimati. Al tutto si aggiunge che,
principalmente nella terraferma, i prigionieri avevano a che fare con estorsioni e
vessazioni dei carcerieri. Le evasioni erano quindi frequenti. Aspetto particolare della
vita carceraria dell’epoca era che i carcerati, giacché tali, andavano incontro ad ingenti
30
Cozzi Gaetano, Stato società e giustizia nella repubblica veneta, Jouvence, 1985, pp. 176-192
24
spese dovute al loro sostentamento, e per causa delle continue imputazioni contro di
loro. Tali erano tra le cause più frequenti della nascita del banditismo.31
31
Cozzi Gaetano, Stato società e giustizia nella repubblica veneta, Jouvence, 1985, pp. 216-220
25
CAPITOLO IV
“STATO DA MAR” E “STATO DA TERA”
26
1. La Venezia che precorre il tempo
Venezia non ha inventato il patriottismo, il colonialismo, l’imperialismo32 (antiche
realtà che solo successivamente riceveranno i loro nomi), tuttavia li ha praticati in tutti i
suoi possedimenti, vicini o lontani33. Notiamo come nelle coste della Dalmazia o nelle
isole greche, il leone di San Marco venne affisso sui muri di città o fortezze che siano,
proclamando con orgoglio la supremazia ed il dominio della Serenissima in quei luoghi,
imponendosi come una marchio di proprietà.
Gli elogi alla grandezza di Venezia mai finirebbero, anche se il maggiore è riservato al
suo governo, con la sua efficacia ed alla saggezza delle sue decisioni. Lo studioso
Franco Gaeta34 in un suo articolo afferma che Venezia fu il primo stato moderno
d’Europa: una città-stato che possiede gli stessi tratti caratteristici dello stato territoriale,
ma che tale acquisterà solo dopo molti anni od addirittura secoli.
L’obiettivo di Venezia è stabilire e mantenere l’ordine interno, ciò avvenne grazie alla
sua abilità nel fissare e far rispettare, al di là delle casistiche individuali e dei vari
gruppi, le leggi, che a tutti venivano imposte, nobili compresi.35
2. L’Istria, la Dalmazia ed il Levante
I territori conosciuti come Istria, Dalmazia e Levante erano la parte più antica dei
domini veneziani, i quali costituivano il cosiddetto “stato da mar”, che si sviluppò con
l’aumentare del potere commerciale e politico della Serenissima. Ben presto quindi le
vicende di questi luoghi, s’intrecciarono con quelle della capitale, ed in molti casi,
anticipatamente rispetto alla terraferma, furono sottoposti al suo controllo.
32
Col termine patriottismo ci si riferisce all’impegno, su più piani, (politico, militare, intellettuale, ecc.)
per l’affermazione, la difesa e l’accrescimento dei valori che la patria esprime.
Col termine colonialismo si definisce l’espansione di una nazione su altri territori e popoli esterni ai suoi
confini, ciò avviene per rendere più facile il controllo economico ed il commercio in questi luoghi.
Imperialismo è il termine che sta ad indicare il nuovo colonialismo avvenuto tra il 1870 ed il 1914, esso
consiste nel tentativo dei governi d’imporsi su altri paesi per sfruttarne le risorse, di qualunque genere
esse siano.
33
La Serenissima, al massimo della sua espansione, cioè tra il XIII ed il XVI secolo, includeva gran parte
dell’Italia nord-orientale, l’Istria e la Dalmazia, inoltre possedeva numerose isole del Mar Adriatico
(chiamato all’epoca Golfo di Venezia), e dello Ionio. Si aggiungono il Peloponneso (Morea), Creta
(Candia), Cipro e gran parte delle isole greche, oltre a molteplici città e porti del Mediterraneo orientale.
34
Gaeta Franco, era uno storico italiano, nato a Venezia nel 1926 e morto a Roma nel 1984, fu
professore all’università dal 1968, insegnando storia moderna a Roma. Il suo nome è principalmente
conosciuto per le opere riguardanti le vicende politico-culturali del Quattrocento-Cinquecento, con
particolare accento alla storia di Venezia.
35
Braudel Fernand, Venezia, Il Mulino, 2013, pp. 63-67
27
Nelle località appena citate, il nuovo governo favorì in qualche caso il popolo, il quale
era spesso soggetto a vessazioni, ciò fece prender vita ad alcune riforme statutarie di
carattere aristocratico, inoltre difese il potere delle consorterie nobiliari che si vedevano
contrariate dai moti rivoluzionari del popolo, il quale era organizzato in “università”36 e
manifestava a favore dei propri diritti.
Nella zona istriana le serrate dei Consigli avvennero ben presto, si pensa che in alcuni
centri si possano essere verificate in precedenza alla conquista veneziana e forse anche
alla famosa serrata del Maggior Consiglio di Venezia nel 1297.
Proseguendo verso sud, ci imbattiamo nelle città dalmate e albanesi, che già al XII
secolo sembra risalire il dominio dell’aristocrazia. Sui patti di dedizione di questi
luoghi, possiamo notare come agli inizi del XV secolo avvenga l’assoggettamento delle
città dalmate al governo veneto, da tali patti giunge alla luce come la nobiltà, in quei
luoghi, era chiusa ed arroccata nei Consigli municipali. Venezia dovette riconoscere di
fatto questo stato di cose e conservarlo perennemente, respingendo le rivendicazioni del
popolo, le quali tendevano a smantellare le forme aristocratiche dei Comuni.37
3. Unità e disunità di mare e terraferma
Mare e terraferma nel loro significato economico, erano corrispondenti a traffici
economici ed investimenti fondiari, tuttavia con la lega di Cambrai, in particolar modo
con la notizia della sconfitta di Agnadello, a Venezia il senso di sconforto si diffuse sia
fra i senatori che fra la popolazione. Immediatamente si diede per persa la terraferma e
si pensò solamente alla difesa della città di Venezia.
Tutto ciò è per noi la riprova della frattura dell’avvenuto sconvolgimento di quel
sistema, che si pensava pacifico ed immutabile, e ci mostra come, stando al sentimento
collettivo che se ne ebbe, non fu, quella di Agnadello, solamente una sconfitta militare,
ma in gioco c’era la minaccia del declino economico, c’erano tensioni sociali, perdite
territoriali, insomma ne venne colpita la natura dello stato veneziano e ne vennero
colpiti i valori sui quali, il patriziato veneziano, lo aveva edificato.
36
Nel medioevo il termine università aveva il significato di corporazione, insieme di persone associate. Il
significato con cui tutti associamo tal parola è il suo secondo significato, preso da quando a Bologna, alla
fine del XII secolo, la parola fu applicata alla corporazione degli scolari.
37
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 161-166
28
Si dovette accentuare la pressione fiscale tramite imposte straordinarie, il debito
pubblico aumentava vertiginosamente, i titoli furono svalutati, e ciò determinò una
contrazione della ricchezza privata.
Il carattere nobiliare della laguna si faceva pubblico, collettivo e statuale, prevalendo
sulla sfera privata dello stesso. L’uguaglianza cetuale del patriziato, la sua solidarietà
sociale in particolari momenti di crisi, la compenetrazione tra sentimento religioso e
politico, costituivano il fondamento dello stato cittadino. Ecco che l’idea di stato, per
come inteso dai veneziani, doveva essere composta di due elementi essenziali: il primo
era la coscienza veneziana dello stato e il suo dominio territoriale.
A riguardo del dominio territoriale Antonio Morosini38 testimonia l’interesse dei
veneziani per l’entroterra padano, “pavano” e “lombardo”, il quale accennò anche ai
dubbi che i lagunari avevano a riguardo de la “gran combustion” in cui si trovò “tuta
Lombardia” quando Giangaleazzo Visconti39 morì40
“ma è da saver che le dite novitade torna in grando dano de Veniexia, e questo per
chaxon che uno grando tempo el Po stede serado, per muodo che le merchadantie non
andava suxo ne zoxo segondo huxanza, e la citade de Veniexia rezeveva uno grando
dano de sal che non podeva andar in Lombardia, per chaxion che in vita del predito
miser lo ducha hogny ano quelo toleva sal da Veniexia per valor de duchaty cento milia
d’oro e holtra; de la qual per molty any dapuo niente de vegniva tolto, ma i dity se
forniva da Zenova in gran dano dy Veniciany e chon volentade dy predity Zenovexi”41
Mare e terraferma che dunque erano contesti economico-geografici complementari, e
non alternativi come ci vengono presentanti nella “ducalis excellentia” di Andrea
Contarini.42
Agli inizi del XV secolo, il mare si armonizzava con la terraferma, con essa si fondeva,
nel quadro di una capitale, Venezia, che restava ad essere commerciale, nonostante gli
38
Morosini Antonio, si pensa nacque a Venezia nel 1368, produsse un manoscritto autografo, dal quale
se ne ricavano le informazioni essenziali per la biografia. Non fornisce però indicazioni del casato o della
contrada di residenza che potrebbe ricollegarlo con gli uomini che vissero a Venezia allo stesso tempo.
39
Visconti Gian Galeazzo, fu figlio di Galeazzo II Visconti e Bianca di Savoia, fu il primo Duca di Milano e
signore di svariate città tra le quali Bologna, Verona, Feltre e Vicenza.
40
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, pp. 167-175.
41
Cronique d’antonio Morosini, cit, I (1396-1413), Paris, 1898, pp. 22-24
42
Contarini Andrea, nato a Venezia nel 1300 e morto il 5 giugno 1382 nella stessa città, fu il 60esimo
doge di Venezia. Ebbe una giovinezza scapestrata, ma successivamente maturò, divenendo, nonostante
fosse contrario alla nomina, doge della sua città. Il dogado del Contarini fu uno dei più importanti,
consacrando Venezia come dominatrice incontrastata dei mari per i secoli successivi.
29
investimenti fondiari cominciavano a prospettare come una fonte di entrate sempre più
redditizia.43
Una volta divenuta dominio territoriale, la terraferma comprendeva, già dalla metà del
Quattrocento, anche la “Lombardia”44, tal termine poté capitare che venisse usato
anche per nominare la terraferma in generale.
Conflitto tra mare e terra che si ripresentò con lo scorrere del XV secolo, poiché la
sconfitta militare portò a ripensamenti e considerazioni che andavano di là di essa. Si
cominciava a pensare alla terraferma in termini di lassismo e ricchezza di facciata, così
facendo andò a consumarsi l’armonia fra il mare e la terraferma, il contrasto finiva con
l’andare a mettere in dubbio il sistema di valori politici e sociali su cui, dall’inizio del
Quattrocento, la Repubblica si era retta.
Il Priuli a riguardo si espresse nei suoi “Diari”, in quelle pagine destinate a riportare il
clima del 1509 all’indomani della battaglia di Agnadello. Nella sua ottica, dopo la
sconfitta militare, quello strappo provocato dalla crisi fu anche frattura fra terraferma e
mare, dove tali espressioni stavano ad indicare due modi d’essere veneziani,
identificando quindi condizioni sociali, politiche e culturali. “La terraferma desidera
solazi”, mentre i veneziani erano “nutriti in tante delicateze et morbidi et lascivie, …,
che heranno impoltoniti, inviliti et infiminati…”, di risposta i veneziani vedevano la
terraferma come investimento improduttivo:
“et in anni cento pochi mancho, che queste citade di terraferma sonno state soto lo
imperio veneto, se puol considerare veramente il grande numero de danari spexi, cum li
quali, modo loquendi, haveriano comprata tuta Ittallia. Et questo procedeva, perché
questi Senatori Venetti heranno tanto inebriatti et obfuschatti in questo Stado italico,
che non guardavanno danari né spexa alchuna per fortificharlo…”45
In questo caso il Priuli, fronte alla perdita del dominio di terraferma, ci lascia una sua
opinione a riguardo, ripensando all’esagerato costo di quello stesso dominio, così
facendo metteva in discussione le scelte politiche del XV secolo, ponendo anche come
un bene la perdita della terraferma, perdita la quale avrebbe consentito alla Repubblica
un ritorno agli antichi costumi:
43
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 176.
Storicamente il termine Lombardia aveva un’accezione più ampia rispetto ad oggi, in quanto indicava
tutti i territori dell’Italia settentrionale.
45
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 183.
44
30
“queli, che navigano, al tuto avanzanno qualche cossa, et he molto meglio cha atendere
a posesione et carete et chavali, che non possono essere salvo cum spexa grande, et
navigando se sparagnanno le spexe, che he il tutto, et sempre se ha veduto che li grandi
guadagni et utilitade sonno venute dal mare et dale navigatione, et le spexe grande se
fanno in la terraferma…”.46
Le parole usate dal diarista anticipavano quelle che saranno scritte a riguardo del
comportamento della piccola nobiltà e dei rettori in terraferma nei confronti dei sudditi,
e in maniera più generale, cerca di capire le cause della paurosa sconfitta. Non
dev’essere lasciato a parte che il Priuli tocca il motivo delle “armi proprie”47
“Et veramente, se li Padri Venetti voranno mantenire et conservar statto in Ittallia,
sarà necessario che li loro nobelli venetti, et dico deli primi, facino lo exercitio et
mestiero dele arme, et se metino alo armigerio exeercitio et loro medemi fare li facti
soi, come fanno tutti li altri Signori del mondo, per non infidarsse in persone alliene et
forestiere, altramente non potranno conservar stado in Ittallia: et ahora tropo
chiaramente se n’è veduto experientia”48.
Il Priuli condanna la terraferma vista come investimento improduttivo, contraria alla
logica del risparmio e come causa principale di spese superflue sia private che
pubbliche. Quel vivere in “villa”, tanto criticato dai lagunari, rivelava una realtà più
complessa di quella che poteva apparire all’epoca, era un qualcosa che superava il lusso
esteriore, una realtà economica e sociale non feudale, non capitalistica, composita, nella
quale erano presenti sia il capitale commerciale, ma anche la rendita fondiaria.49
Persone come il Cornaro50, erano convinti che Venezia non avesse “più bisogno d’usar
la via del mare per dar da vivere al suo populo”, il tutto unito alla necessità “che
l’atteration non procieda più avanti”, ciò a significare l’importanza di investimenti
nella terraferma: per il Cornaro il mare non doveva essere più la sola fonte economica
del benessere veneziano, ma a tale si doveva affiancare anche lo sfruttamento della
terra.
46
Priuli, Diarii, IV, cit, p. 45.
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 185.
48
Priuli, Diarii, IV, cit., p. 45.
49
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 186.
50
Cornaro Alvise, spesso chiamato Luigi, nato a Padova nel 1467 e morto l’8 maggio 1566, fu un nobile
veneziano, ricordato per i suoi quattro libri dal titolo di Discorsi.
47
31
In effetti la “naturale inclinazione all’agricoltura” del Cornaro mostrò un rapporto
attivo, dinamico e produttivo con la terra, il quale si manifestò nel “ridurre i luoghi
inutili a utilità”, cioè ritrarli a coltura
“et in verità l’agricoltura del retrare è la vera archimia, perciò che si vede che tutte le
grandissime ricchezze di monasteri et di qualche privato cittadino si sono fatte per
questa via, e non solamente si vede le private persone, ma le città esser fatte grandi e
potenti per questo mezzo…”.
Scopo del Cornaro era indurre la Signoria veneta ad assumersi l’onere di seminare
coltura in nuove terre, come compito di un’istituzione che “per l’autorità sua”, mirava
al “ben pubblico”. Il Cornaro si impegnò, in questa prospettiva “come agiente” dello
stato, e proprio allo stato poneva le sue condizioni.51
Posizioni dure e restrittive erano poste, nei confronti dei contadini, all’interno del
“manuale di risparmio domestico” di fine Cinquecento. Con tal scritto ci si trova fronte
ad una serie di preconcetti, dove i dettagli delle regole suggerite o fissate, sono
rivelatrici di pensieri riguardanti la società, l’economia, i rapporti tra gli uomini etc. Ad
esempio, il capitolo ottavo di tal scritto, affermava di provvedersi di servi che non
bevessero vino, che non avessero mogli o concubine, e che se la serva fosse brutta
“che non habbia né marito, né bertone, acciò che la casa proveduta per un anno non si
voti in una settimana, et apransi ben gli occhi; perché poi, oltre al danno, è
vergogna”.52
51
52
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 193.
Ivi, pp. 208-209.
32
CAPITOLO V
LE GUERRE D’ITALIA
33
1. Le origini medievali
Nella seconda metà del 1400, in penisola, le maggiori potenze europee cominciarono ad
affacciarsi, la loro volontà era d’imporre la loro presenza. Gli stati in questione erano
Francia, Impero germanico, Ungheria, Borgogna e la Spagna, i quali si scontrarono più
volte per risultare dominatori della scena italica. Nessun signore d’Italia poteva ambire
a tal totale dominio, giacché avevano sviluppato la cosiddetta “politica dell’equilibrio”
cioè prevenzione e contenimento dei conflitti.
La Francia primeggiava in Europa per quanto riguarda il desiderio d’espansione, tanto
che nell’occidente europeo era lo stato più vasto. A dar avvio alle cosiddette “guerre
d’Italia”, furono proprio i monarchi francesi rinascimentali, i quali potevano dichiarare
guerra senza chiedere l’opinione di alcun altro organo del Regno.
Notiamo come Spagna e Francia guerreggiavano con l’intenzione di imporsi come
dominatrici in Italia, così facendo potevano obbligare la Chiesa di Roma ad effettuare
una riforma sotto il loro controllo. Ciò ci suggerisce che tali dispute non presero
solamente una dimensione militare, ma anche una dimensione ideale-simbolica.
Tal principio possiamo notarlo già dalle origini di tal conflitto, cioè con la discesa nel
1494 di Carlo VIII53 re di Francia, il quale proponeva un programma riformatore il cui
scopo era ricattare il Papa, che in quegli anni era Alessandro VI Borgia54, il quale fu
minacciato di convocazione a giudizio fronte ad un tribunale conciliare. Successore di
Carlo VIII fu Luigi XII55, il quale utilizzò la riforma della Chiesa come un’arma,
alimentando il pensiero del rinnovamento religioso, per poi sfruttarlo a proprio fine, così
da condurre il papato romano alla sua subalternità, per meglio progredire con i piani
espansionistici.56
53
Carlo VIII, nato ad Amboise (Francia) il 30 giugno 1470, e morto ad Amboise il 7 aprile 1498, fu Re di
Francia, discendente della dinastia dei Valois era l’unico figlio del re Luigi XI, e gli succedette alla morte,
cioè il 30 agosto 1483, in carica anch’esso a vita.
54
Alessandro VI Borgia, nato col nome di Roderic Llancol de Borja, italianizzato poi in Rodrigo Borgia,
nacque a Xativa (Spagna) il 14 gennaio 1431 e morì a Roma il 18 agosto 1503, fu il 214esimo papa della
Chiesa cattolica dal 1492 fino alla morte. Fu un papa rinascimentale alquanto controverso, anche per
aver riconosciuto la paternità di vari figli illegittimi, tra cui Cesare e Lucrezia Borgia.
55
Luigi XII, conosciuto col soprannome di il Padre del Popolo, nacque a Blois (Francia) il 27 giugno 1462 e
morì a Parigi l’1 gennaio 1515, fu re di Francia dal 1498 alla morte. Figlio di Carlo d’Orleans e Maria di
Cleves, fu l’unico membro del ramo dei Valois-Orleans a diventare re.
56
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530) Il Mulino, 2009, pp.7-13.
34
2. Le prime vicende (1494-1495)
Come già premesso, le guerre d’Italia ebbero inizio nel 1494 con la calata di Carlo VIII,
re di Francia, affiancato da circa venti mila uomini, ai quali se ne aggiunsero altri dieci
mila inviati dai suoi alleati italiani come Ludovico il Moro ed Ercole d’Este. Una volta
attraversate le Alpi occidentali, percorsero la Penisola verso sud senza alcun contrasto, e
quasi senza colpo sferrare conquistarono Napoli, con tal atto la Francia divenne la
dominatrice dello spazio italiano.
Il primo dubbio che assalì i francesi fu di come avesse reagito il ducato di Savoia nel
momento in cui, una volta attraversate le alpi, avrebbero invaso le loro terre. La
duchessa Bianca di Monferrato57 però, viste le dimensioni dell’armata d’oltralpe, diede
loro una buona accoglienza. Dobbiamo ricordare che i trenta mila uomini al comando
del re Carlo VIII rappresentavano circa il triplo di quelle che poteva disporre in campo
di battaglia una potenza come Venezia.
Ciò dimostra però che, un’alleanza a tre, esempio tra Venezia, Napoli e Milano, sarebbe
stata sufficiente almeno a determinare una situazione di stallo, rallentando l’armata
francese verso il meridione. A livello teorico, cioè sulla carta, tal coalizione esisteva, in
quanto il re di Napoli era alleato con Firenze e col papato, il tutto fatto con l’obiettivo di
sbarrare l’avanzata francese. Il sistema interstatale tuttavia era scarsamente unito e gli
elementi di divisione annullarono quelli di unione.
Se tal alleanza tra gli stati italiani avesse preso vita sarebbe stata già una mezza vittoria,
in quanto si sarebbe creata una situazione di fermo. Tal situazione sarebbe stata
favorevole ai condottieri della Penisola, in quanto la strategia logoratrice era incarnata
nell’arte della guerra in Italia ed affiancata ad essa c’era un gran lavoro diplomatico.
Carlo VIII, nel 1494 momento della sua calata, conscio di tal abilità italiana, adottò una
strategia di guerra del tutto contraria, preferendo condurre una guerra lampo, quindi una
guerra “corta e grossa”, nel quale non c’era spazio per la diplomazia. Insomma il re di
Francia voleva esibire una schiacciante superiorità militare, e fronte a ciò gli italiani
trovarono la scusa per classificare i francesi come “barbari”.58
57
Bianca dei Paleologi di Monferrato, nacque a Casale di Monferrato nel 1472 e morì a Torino il 30
marzo 1519, fu moglie di Carlo I di Savoia, che a sua volta fu principe di Piemonte e conte d’Aosta,
Moriana e Nizza dal 1482 al 1490.
58
Con la calata francese si scrisse una pagina di storia militare, con particolare attenzione per le armi, in
quanto, proprio in quest’occasione comparse nel campo di battaglia il cannone, il quale fu protagonista
delle battaglie fino al Novecento.
35
Vista la situazione, a Roma i cittadini erano preoccupati in quanto non volevano essere
succubi di un assedio. Cominciarono così a protestare contro i disagi dovuti per
l’interruzione delle vie di comunicazione verso il settentrione. I disordini crebbero e
Ferrandino59, figlio del re Alfonso II d’Aragona60, non riuscì a mantenere il controllo
della città ed il 25 dicembre 1494 se ne andò rinunciando a tentare la difesa, tutto ciò
mentre il papa Alessandro VI si rifugiò tra le mura di Castel Sant’Angelo. Era il giorno
31 dicembre quando Carlo VIII e la sua armata entrarono nell’Urbe.
Molteplici furono i cardinali che, una volta entrato a Roma, si allearono con Carlo VII,
incitando l’arresto del pontefice e la convocazione di un nuovo conclave. I cannoni
transalpini furono puntati contro Castel Sant’Angelo per obbligare il papa alla resa, egli
non cedette e minacciò di esporre le reliquie più preziose in caso di bombardamento.
Senza che alcun colpo fu sparato, piogge torrenziali furono la causa del crollo di alcuni
pezzi delle mura di Castel Sant’Angelo, e tale fu interpretato come un segnale divino.
Ecco quindi che Alessandro VI si arrese, e l’11 gennaio 1945 firmò un trattato tramite il
quale prese accordo per il libero passaggio alle truppe francesi. Carlo VIII riconoscente
lasciò il pontefice alla sua carica.
La persona moderna sorriderà fronte all’individuare la mano di Dio come causa del
crollo delle mura, tuttavia bisogna ricordare che nella cultura dell’epoca si ricercava
perennemente il soprannaturale come causa e finalità degli eventi. In effetti, per i
potentati d’Italia, il disastro divenne irreparabile quando la gente si convinse che dietro
a tali invasioni straniere c’era il volere divino. Carlo VIII lo si vedeva come vincitore
perché favorito dal Cielo.
Superati i confini del regno napoletano, l’armata degli Aragona non ingaggiò battaglia,
poiché le popolazioni locali insorsero invocando i francesi come liberatori. Era il 22
febbraio 1495 quando Carlo VIII entrò trionfante a Napoli.
Venezia, all’inizio del 1495, promosse una campagna per contrastare l’avanzata
francese alla quale aderì anche Alessandro VI. Perché la riscossa vantava del favore
pontificio, la coalizione poteva assumersi il ruolo e titolo di Lega Santa, di contro Carlo
VIII minacciava ritorsioni in campo ecclesiologico. A causa di ciò il pontefice
59
Ferdinando II d’Aragona, noto come Ferrandino, nacque a Napoli il 26 agosto 1469 e morì a Somma
Vesuviana il 7 settembre 1496, fu re di Napoli per meno di due anni, dal 1495 al 1496.
60
Alfonso II d’Aragona, nacque a Napoli il 4 novembre 1448, morì a Messina il 18 dicembre 1495, fu
duca di Calabria e poi re di Napoli per circa un anno, dal 25 gennaio 1494 a gennaio 1495.
36
immediatamente si mosse per ampliare la composizione di questa nuova lega, la quale si
univa grazie all’odio verso la Francia. L’accordo fu preso a Roma nel 1495,
precisamente il giorno 31 marzo, dove si assicurava l’unione tra Venezia, Milano ed il
papato, supportate esternamente da grandi stati come Inghilterra e Spagna, le quali
avevano anch’esse interesse di ostacolare la Francia.
I veneti non avevano dubbi sul fatto di poter togliere di scena gli oltremontani in
qualsiasi momento, eliminando il loro interferire al di qual delle Alpi in qualsiasi
momento. Con tale convinzione la Lega Santa concesse alla Repubblica Serenissima di
esporsi militarmente, ingaggiando un esercito con più di venti mila soldati. Il comando
venne dato al capitano generale Francesco Gonzaga61. Vedendo tal fermento, il re di
Francia assieme a dieci mila combattenti si incamminò verso nord.
Il capitano delle forze venete, cioè il Gonzaga marchese di Mantova, volendo evitare lo
scontro frontale, divise i propri battaglioni in più ranghi, in modo da riuscir a sferrare un
attacco a tridente. La battaglia ebbe luogo presso Fornovo sul Taro il 5 luglio 1495, ma
gli avvenimenti non furono come previsti da Francesco Gonzaga. La lega riuscì a
vincere sulla retroguardia francese, la quale si dette alla fuga, tuttavia gli stradiotti
veneti, invece che assalire anche l’avanguardia francese, ne depredarono la retroguardia
già vinta.
Inoltre, a far fallire il tutto s’aggiunse la cattiva condotta del contingente milanese il
quale, alleato del Gonzaga, non avrebbe dovuto permettere ai francesi il passaggio nella
Pianura Padana lasciandoli passare senza contrastarli, ma bloccarli. Si suppone che ciò
avvenne perché Ludovico il Moro62 pensava ad un potenziale accordo con Carlo VII,
inoltre non voleva concedere a Venezia la gloria di potenza vincitrice sui francesi.
Serenissima la quale da quel momento cominciava ad esser vista da tutti come l’unico
stato in Penisola capace di contrastare le transalpine ambizioni.
61
Francesco II Gonzaga, nacque a Mantova il 10 agosto 1466, morì a Mantova il 29 marzo 1519, distinto
per la sua intensa attività militare, fu figlio del marchese di Mantova Federico I Gonzaga.
Successivamente alla morte del padre, avvenuta nel 1484, divenne signore di Mantova e lo rimase fino
alla morte. La sua città vide uno dei periodi di maggior splendore della sua storia.
62
Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, nacque a Milano il 3 agosto 1452 e morì a Loches (Francia) il 27
maggio 1508, dal 1479 fu duca di Bari, successivamente divenne duca di Milano, dal 1494 al 1499. Il suo
regno in Milano fece si che la città conobbe un pieno sviluppo rinascimentale. Fu patrono di Leonardo
da Vinci e di altri artisti di rilievo della sua epoca. È noto inoltre che fu lui stesso a commissionare
l’Ultima Cena a Leonardo.
37
Nello stesso anno Ludovico il Moro aumentò i contatti con l’imperatore del Sacro
Romano Impero, il quale fu invitato a scendere a Roma compiendo alcune azioni a
favore della cristianità, o almeno in difesa della giurisdizione imperiale. Ecco
presentarsi come obiettivo lo “stato da tera” veneto, accusando Venezia di aver
assoggettato territori che spettavano all’Impero.
Stretti gli accordi con il Moro, Massimiliano d’Asburgo63, imperatore del Sacro
Romano Impero, scese in territorio veneto nel 1496, portando con sé non più di quattro
mila combattenti, perché contava dell’impegno militare del duca di Milano, ma tal aiuto
non arrivò e l’imperatore subì gravi sconfitte, decise così di tornare in territorio
austriaco.64
3. L’inaspettata alleanza
Carlo VIII, a seguito di un incidente, morì senza eredi l’8 aprile 1498, il trono di Francia
spettava ora al cugino, il duca Luigi d’Orleans, salito al trono col nome di Luigi XII, era
tra i pretendenti anche del trono del ducato di Milano.
Immediatamente ordinò al maresciallo Gian Giacomo Trivulzio65 di prendere possesso
della Lombardia, utilizzando le armi. Tali pretese s’incrociarono con il volere dei
veneziani di spodestare il Moro, i veneti accolsero l’alleanza francese in previsione di
una campagna anti-sforzesca, dopo la quale la Serenissima avrebbe ricevuto un tratto di
pianura lombarda. Motivo per cui i veneziani non erano preoccupati della presenza
francese ai loro confini, è perché gli oltremontani risultavano forti in campo di battaglia,
ma pessimi amministratori dei territori conquistati e li perdevano con la stessa facilità
che li avevano avuti. Nel 1499 fu stipulato in segreto a Blois l’accordo franco-veneto.66
4. Attriti tra Venezia e la Chiesa
63
Massimiliano I d’Asburgo, nacque a Wiener Neustadt (Austria) il 22 marzo 1459, morì a Wels (Austria)
il 12 gennaio 1519, fu imperatore del Sacro Romano Impero dal 1493 alla morte. Grazie alla politica
matrimoniale e alle eredità fu il fondatore dell’impero asburgico, nonostante le sconfitte militari subite
in diverse campagne, non esitò mai a parteciparne personalmente
64
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 23-75
65
Gian Giacomo Trivulzio, nato a Milano nel 1440, morto ad Arpajon (Francia) il 5 dicembre 1518, fu
militare e politico.
66
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 83-85
38
Appena stipulato il trattato di Blois, la Serenissima Repubblica dovette trascurare gli
eventi della Penisola per circa tre anni, ciò avvenne perché dovette affrontare i turchi,
che ingaggiati da Ludovico il Moro, tentarono di assalirla, e solo dopo aver sventato la
minaccia ottomana, i veneziani poterono rientrare nella scena italiana. Invasione turca
che fu sventata grazie anche al sostegno papale, il quale aveva il potere d’indire una
crociata in favore della cristianità, e con tale si potevano raccogliere fondi e mezzi
militari da impegnare nella guerra; tal aiuto papale fu però dato solo previo consenso
della Serenissima di creare uno stato romagnolo per Cesare Borgia.67
Contro l’impero ottomano si allearono, firmando un trattato a Buda nel 1501, la Chiesa
romana, Venezia e l’Ungheria. I Turchi, fronte a tal stipulazione di alleanza ripiegarono
ed il sultano, che in quel tempo era Bayezid II68, immediatamente trattò la pace, con la
quale Venezia poté ritornare dominatrice nell’Adriatico.69
Nel 1501 la Chiesa, nella figura di Cesare Borgia, cominciò ad assaltare dei territori
sottoposti alla giurisdizione veneziana. Nell’aprile assaltarono Faenza, ma il motto degli
assediati era “Marco! Marco!”, ciò dimostra come i faentini vedevano la Repubblica di
San Marco come loro difensori contro l’avanzata del figlio del papa.
L’attrito tra Repubblica di Venezia e la Chiesa era riemerso a causa della pace col turco
e perché Venezia diede riparo ai nobili che per causa del Valentino non possedevano più
uno stato.
Nell’agosto 1501, Alessandro VI si dimostrava avverso alla pace di Venezia col turco,
mentre nel settembre il Giustinian70 scriveva come tal pace pareva al pontefice
“sola esser causa de interromper tutti li sui mali pensieri contrari al ben publico et alla
quiete de Italia”.71
67
Borgia Cesare, politico e uomo d’armi, nacque a Roma nel 1475 e morì a Viana nel 1507. Figlio di
Rodrigo, che divenne papa col nome di Alessandro VI (1492) lo nominò cardinale. Nel 1498 fu investito
dal re di Francia col ducato di Valentinois, da cui il suo soprannome di duca Valentino. Grazie al padre
riuscì a crearsi uno stato personale.
68
Bayezid II, nacque il 3 dicembre 1447 e morì il 26 maggio 1512, era il primogenito del sultano
Mehmed II e di tale fu successore, governò come sultano dell’impero ottomano dal 1481 al 1512.
69
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 103-106.
70
Giustinian Antonio, nacque a Venezia teoricamente nell’anno 1466. Conseguì nel 1493 la laurea in
artibus all’Università di Padova, coltivò poi studi filosofici e teologici, per poi diventare insegnante.
71
Giustinian, dispacci, I, cit., p. 114.
39
In aggiunta, verso la fine dello stesso mese il Papa espresse al Giustinian il disgusto per
via che a Venezia, riferendosi ai principi spodestati dal Valentino, fossero arrivati
nemici e “rebelli” della Chiesa:
“… semo certificati ch’el duca de Urbino è a Venezia, ben veduto ed accarezzato da
quella Signoria, e se dice etiam che lei li dà buona provvisione, che è cosa che ne
offende, essendo lui nostro rebello, coma sa questa Signoria; la qual in questa cosa non
fa verso de nui quel che se conviene alla bona amicizia che abbiamo con lei, anzi par
che tutti nostri rebelli non abbino redutto in altro loco che in quella città, la qual è
refugio delli nostri inimici”.
L’ambasciatore veneziano Antonio Giustinian, uomo dignitoso e con grande abilità
diplomatica rispose al pontefice, anche se quest’ultimo non ne fu soddisfatto in quanto
marcò che Venezia “era libera”, e quindi “ognuno aveva adito de andar”; Aggiunge poi
che quell’accoglienza che Venezia dava non diminuiva “la reverentia et osservantia”
verso la Chiesa, concluse affermando che la stessa Chiesa doveva preferire che quei
signori stessero a Venezia, piuttosto che in altri luoghi72, “dove potriano trova animi
più disposti contro la Santità Sua e la Excellenzia del Duca”.73
Vista la situazione politica che comunque restava incerta, il Pontefice replicò
“Sempre ha l’occhio a quel che farà la Illustrissima Signoria Vostra; così con quanti el
parla, si come per buona via intendo, sempre domanda – che faranno i Veneziani? – da
un canto se conforta e spera nella fede di quell’excellentissimo Dominio, che mai
manca delle promissioni ch’èl fa; dall’altro poi la coscienza propia e cognizion da sé
stesso el fa dubbioso; e va così versando con la mente sua, ora sperando bene et or
temendo male di quella”.74
Nonostante tutto il pontefice cercava un’intesa con la Repubblica Serenissima.
Nell’agosto 1503 arrivò in laguna la notizia della morte del Papa Alessandro VI, ed
immediatamente il Senato cominciò le operazioni per smantellare il ducato del Borgia in
Romagna. La prima fase vide i signori spodestati dal Valentino tentare di riprendersi i
loro stati. In quelle terre romagnole e marchigiane i sostenitori di San Marco avrebbero
dato vita a delle insorgenze, il cui fine sarebbe stato accogliere le truppe della
72
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, pp. 93-96.
Giustinian, dispacci, I, cit., p. 129-130
74
Villari Pasquale, Dispacci di Antonio Giustinian, vol I, Le Monnier, Firenze 1876, p. 176
73
40
Serenissima e dei suoi rappresentanti, così da sancire il passaggio della sovranità non
con le armi, ma tramite gli atti di dedizione.
Il successore di Alessandro VI fu Pio III, pontefice dalla politica anti francese, il quale
non accettava l’attuale stato della penisola. Dopo nemmeno un mese il neo eletto Papa
morì per anzianità. In sua sostituzione fu nominato pontefice Giuliano della Rovere con
il nome di Giulio II, la fumata bianca avvenne il 31 ottobre 1503. Quest’ultimo Papa
godeva di ampia autorevolezza, tanto da fargli stringere alleanza con più potenze, prima
tra tutti Venezia e poi la Francia, le quali conseguentemente si illusero di avere un Papa
amico75.
5. Interessi romagnoli
L’illusione di un Papa favorevole alla propria politica fu presto smantellata, tra Giulio II
e Venezia ci furono principalmente contrasti. Il maggiore tra tutti riguardava la richiesta
del Pontefice di non intromettersi nel ducato di Romagna. Ciò fece scartare la possibilità
di iniziative comuni future, volte ad eliminare la presenza francese in val Padana.
I veneti rifiutarono le proposte fatte dal Papa, in quanto le classificarono come poco
lucrose per loro, questo perché avrebbero dovuto cooperare senza immediati vantaggi.
Dopotutto le minacce di Giulio II non facevano paura alla potenza veneziana.
In quel contesto, Luigi XII, dopo aver subito una sconfitta a Garigliano tentò di
recuperare l’amicizia veneziana. Grazie a tal amicizia la Serenissima fu sicura di
procedere con l’annessione dei territori romagnoli prima assoggettati a Cesare Borgia.
Rimini fu la prima città occupata e poi nel 1503 Faenza. La Repubblica ora era la
dominante anche nella Romagna.
Tali azioni però non furono gradevoli a Giulio II, che nulla poteva fare fronte alle
dedizioni che i contadi, come quelli di Imola e Cesena, facevano a favore di San Marco.
La rabbia del Pontefice era alle stelle ma i veneziani non cambiarono il loro piano
d’azione, non consci di come il Papa poteva rivalersi, tal atto di sottovalutazione fu
determinante, poiché Giulio II era anche un esperto diplomatico.76
75
76
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp.104-105.
Ivi, pp. 106-110.
41
6. L’Europa contro Venezia
Già agli inizi del 1504 la diplomazia dello stato della Chiesa si mosse, proponendo ai
sovrani di Francia, Spagna, Sacro Romano Impero e Ungheria-Boemia, l’accordo di un
attacco congiunto di cui Venezia ne sarebbe stata succube.
Massimiliano d’Asburgo non accolse, almeno per il momento, il pensiero del pontefice,
a differenza di suo figlio Filippo il Bello77, che al contrario rispose affermativamente
alle sollecitazioni papali. Ad accogliere tal proposta fu anche la Francia e quindi Luigi
XII, il quale vide tal accordo come un modo per riconsolidare la sua presa sulla
Lombardia.
Il pontefice si tolse ora dalla prima linea dell’alleanza così da non figurare tra i
contraenti del patto, firmato nel castello di Blois il 22 settembre 1504. Il tutto si articolò
come un triplice documento, dove nei primi due si prometteva al Luigi XII l’investitura
del ducato di Milano, invece con il terzo trattato, l’unico che poi prese vita nella pratica,
ci si alleava per un assalto alla terraferma veneta, senza però specificarne i tempi e le
modalità d’assedio.
Sebbene il tutto dovesse essere stato segreto, papa Giulio II fece si che qualche notizia
arrivò nelle aule del potere veneziane, sperando che la nova inducesse la spaventata
Serenissima a cedere i territori romagnoli. Sebbene sapessero del nuovo accordo, i
veneti non indietreggiarono dalla loro linea, sicuri del loro credere che, anche quel
trattato, sarebbe rimasto solamente l’ennesimo pacco di documenti.
Massimiliano d’Asburgo, non cedendo alle lusinghe papali, tentò da solo d’ingaggiare
battaglia contro Venezia, convinto del fatto che, in caso di vittoria, teneva aperta con la
Francia la questione dell’investitura del ducato di Milano.78
77
Filippo d’Asburgo, detto Filippo il Bello, nacque a Bruges (Belgio) il 22 luglio 1478, morì a Burgos
(Spagna) il 22 luglio 1478. Fu figlio dell’imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano I d’Asburgo e
della duchessa Maria di Borgogna, fu re consorte di Castiglia e Leon.
78
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp.110-115.
42
CAPITOLO VI
COSA FU LA LEGA DI CAMBRAI
43
1. L’origine
Massimiliano d’Asburgo, re del Sacro Romano Impero, nel 1508 si mosse verso Roma
con lo scopo di essere incornato imperatore e col volere di sottrarre il Friuli al dominio
della Serenissima. I veneti non si fecero cogliere impreparati, ci fu battaglia nel Cadore
dove le truppe di Bartolomeo d’Alviano sconfissero quelle germaniche. Con tal vittoria
la Repubblica si aggiudicò anche il titolo di dominatrice dell’area orientale, zona che
fino a quel momento era contesa tra le potenze confinanti. Con animo avvilito per la
sconfitta, Massimiliano chiese alleanza al re di Francia, Luigi XII, il quale
immediatamente accettò.
Così facendo si ravvivò quella coalizione europea ai danni di Venezia, già firmata nel
1504 a Blois, ma che solo ora portò ad una effettiva alleanza offensiva. Quest’ultima
alleanza fu stipulata a Cambrai nella giornata del 10 dicembre 1508, con lo scopo
ultimo di contrastare i turchi, ma nel trattato veniva esplicitamente affermato che prima
di iniziare battaglia contro gli ottomani, necessitava dominare su Venezia, la quale era
vista come stato che creava divisione tra la cristianità.
Il trattato di Cambrai fu accolto poi anche da altri regni europei, i quali insieme avevano
già concordato come dividersi i territori in caso di vittoria: alla Francia sarebbe spettata
la Lombardia orientale; al Sacro Romano Impero il Veneto, il Trentino ed il Friuli; al re
di Napoli i porti della Puglia; al regno d’Ungheria la Dalmazia; al ducato di Savoia
l’isola di Cipro, al duca di Ferrara il Polesine; al marchese di Mantova le città di
Peschiera ed Asola, mentre a Firenze la città di Pisa. Anche il papa abbracciò tal
concordato, poiché una clausola del patto stabiliva che alla Santa Sede sarebbero
spettati tutti i territori della Romagna che furono occupati dai veneziani. Fu fissata nella
data del 1° aprile 1509 l’inizio delle ostilità.
I veneziani erano quindi totalmente privi di alleati e aiuti esterni. In extremis
ipotizzarono di contattare in aiuto il sultano turco, ma poi preferirono combattere da soli
contro quest’enorme alleanza. Tal decisione fu presa con orgoglio ritenendo che la loro
potenza, la potenza del leone di San Marco fosse ancora distante dall’essere esaurita,
inoltre l’alleanza europea non metteva molta paura. Al comando dell’esercito veneto fu
posto il condottiero Bartolomeo d’Alviano affiancato dal Pintigliano79.80
79
Pintigliano era il soprannome di Niccolò Orsini, conte di Pintigliano, nato a Pintigliano nel 1442 e
morto a Lonigo nel gennaio 1510, fu un condottiero militare mercenario. Dal 1496 si mise al soldo della
Repubblica di Venezia col grado di capitano generale delle forze della Serenissima.
44
2. Tra sentimento religioso e senso politico dei veneziani
Era il 20 febbraio 1509 quando Biagio Buonaccorsi81 scrisse a Niccolò Machiavelli82
che i veneziani si stavano armando, et aiutonsi con le messe et paternostri”.
Tal frase contiene in se quell’immagine comune del diffuso sentimento religioso del
patriziato veneziano, notando una stretta reciprocità tra la giustizia umana e quella
divina. La guerra che gli alleati di Cambrai vogliono ingaggiare contro Venezia appare
loro ingiusta, in quanto la giustizia divina, e quindi Dio che è giusto, non può volerla.
Di qui nasce la necessità di rimettere i peccati e di non bestemmiare per evitare di
offendere Dio. Questo è visto come l’unico metodo per ottenere la vittoria, perché il
divino sa che è ingiusta una guerra contro una società di giusti.
Per Venezia la lega di Cambrai fu uno scossone sia politico sia economico, altro tipo di
scossone fu quello che avvenne alle ore 20.45 del giorno mercoledì 26 marzo 1511,
quando una scossa sismica, ricordata anche dai posteri, si assistette nel veneziano. Il
Sanudo ce la ricorda in un suo scritto, accostando il terremoto politico a quello fisico:
“Etiam dil palazo, sopra il balcom grande di la sala dil mazor consejo, casete la zima,
qual era alta, con una justicia vi era; ma San Marco di marmo stete saldo e non
caschoe; e, non voglio tacer, che in corte di palazo cazete uno merlo di quelli è sopra
dita salla di gran consejo, in mezo, a casete la mità di merlo ch’è di marmoro con ziglij
suso intajadi, et cadendo si vene a impiantar li in corte, a pe’ di la scala de piera, in
una piera viva, col capo dil ziglio in zoso; e molti ave questo per bon auguro esser
caduta la prudentia, e se li auguri fosseno a questi tempi, direbeno: guarda, guarda
Venetia, sapi esser prudente a questi tempi, chè dies mali sunt; non meter il pè a fallo,
come hai fatto già do anni, perché, si con prudentia non ti governerai, questa
republicha potrà patir assà detrimento, e vedi il divo Marcho rimaso intacto sopra il
palazo, cussì rimarà questa cità fidele di Jesu Cristo, e conservatrice di la fede
catholica, defendatrice di la chiexia, et che amava justicia; e, si l’è caschata, fa la
ritorni; benchè non molti dicono, ivi, sopra il balcom, non era justicia, ma Jo tengo de
sì”.
80
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp.115-117.
Buonaccorsi Biagio, nacque a Firenze nel 1472 e morì nel 1522, fu uomo politico e letterato fiorentino,
inoltre era notaio e collega del Machiavelli nella segreteria dei Dieci della guerra.
82
Machiavelli, il cui nome completo era Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, nacque a Firenze il 3
maggio 1469 e morì a Firenze il 21 giugno 1527, fu storico, filosofo, scrittore, politico e drammaturgo
italiano.
81
45
Quello sopra riportato è un passo molto positivo, nel quale il diarista di origini
veneziane esprime, col pretesto del terremoto, lo stato d’animo che era diffuso in quel
periodo all’interno della società veneziana. Veneziani che traevano gli auspici vedendo
crollare altro attorno a se, ma non la statua del Leone di San Marco. A cadere è propria
il simbolo francese, il giglio, di qui la facile contrapposizione che riflette una
dimensione emotiva popolaresca, un sentimento patriottico comune. È curioso
aggiungere come dal maggio 1509 fu emanato un provvedimento che vietava di vestirsi
alla francese.
Proseguendo la lettura di quanto ci riporta il Sanudo possiamo affermare che la fede
cattolica non è religione di stato, bensì un pilatro portante dello stesso e della società.
Senza quella fede non avverrebbe solamente il crollo o la rovina della Serenissima, ma
verrebbe meno la ragion d’esistere della Repubblica stessa.83
3. Agnadello 1509
La fatidica data del 1° aprile si stava avvicinando, ma si andavano diffondendo voci che
affermavano il ritardo nei preparativi delle truppe imperiali, inoltre neppure l’esercito
francese sembrava pronto alla battaglia. Vista la situazione il condottiero delle truppe
venete, l’Alviano, voleva sferrare l’attacco iniziale, ingaggiando battaglia nei territori
del ducato di Milano. Il Pintigliano, uomo d’arme più paziente dell’Alviano, dimostrò la
sua contrarietà a quest’azione, quest’ultimo era sostenuto anche dal Senato veneziano il
quale preferiva condurre una guerra di contenimento, e per tal decisione l’esercito di
San Marco stette accampato nel Bresciano, sull’Oglio. Il Pintigliano tendeva ad usare
più cautela in quanto l’esercito francese contava circa quaranta mila uomini, cioè circa
dieci mila più di quello veneto.84
Gli oltremontani vantavano un esercito formato da 8.000 mercenari85 provenienti dalla
svizzera, di cui il 60% alabardieri, il 30% picchieri ed il 10% balestrieri86. Gli svizzeri
83
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, pp. 11-16
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp.110
85
Mercenario, noto anche come soldato di fortuna, è un soggetto che, senza far parte di una nazione o
fazione, prende parte ad un conflitto armato, solamente per ottenere un compenso economico, non è
quindi spinto da doveri di cittadinanza, patriottismo o qualsiasi altro ideale.
86
Alabardiere è il fante specializzato nell’utilizzo dell’alabarda, cioè un’arma inastata, a punta, tagliente
da entrambi i lati. Picchiere è il fante che prende le prime linee nello schieramento di battaglia, utilizza la
picca cioè un’arma inastata con punta metallica, di lunghezza variabile tra i 4 ed i 6 metri. Balestriere è
un fante specializzato nell’uso della balestra, cioè un’arma da lancio molto temuta per la sua lunga
gittata della freccia.
84
46
avevano la fama di essere quasi imbattibili sul campo di battaglia, dove quasi privi di
protezioni si presentavano armati di picche lunghe anche oltre i 5 metri, inoltre erano
addestrati con ferrea disciplina e feroce determinazione.87
L’esercito veneto, che come già detto era numericamente inferiore a quello francese,
schierava in campo dieci mila cavalieri, suddivisi in due mila lance, un lanciere con un
sergente e un paggio più un balestriere a cavallo, equipaggiati come la gendarmeria con
tecniche individuali simili88. Oltre alla cavalleria ci sono circa altri ventidue mila fanti.89
Tornando alle dinamiche della battaglia vediamo come l’accamparsi in posizione
arretrata dell’esercito della Serenissima permise ai francesi di passare i confini ed
occupare così Treviglio. Strategia conservatrice e logoratrice del Pintigliano che
facilmente fu compresa dai francesi, i quali rapidamente occuparono nel territorio
diversi centri abitati indifesi. A causa di ciò anche il capitano Pintigliano decise di
tralasciare quella guerra contenitiva e che era il caso di lanciarsi all’inseguimento delle
armate d’occupazione.
Era il 14 maggio 1509 quando l’avanguardia delle truppe venete con i relativi
comandanti raggiunse il paese di Pandino, in attesa dell’arrivo della retroguardia.
Quest’ultima si trovava nelle vicinanze della località di Agnadello90, la quale, verso le
ore 13.00 venne avvistata dall’esercito francese, capitanato da Gian Giacomo Trivulzio,
che diede subito ordine di sferrare l’attacco. I veneti non si sottrassero minimamente
allo scontro. Nel frattempo la notizia giunse a Bartolomeo d’Alviano, il quale con le sue
truppe si precipitò ad Agnadello. Grazie alla strategia dell’Alviano si riuscì a contrastare
la cavalleria francese, aprendo un passaggio verso il centro del quadrato d’armata
avversaria, dove si trovava lo stesso re di Francia Luigi XII. Il Pintigliano si rifiutò però
di fornirgli copertura, per tal decisione si passò così dalla possibilità di vittoria alla
disfatta. La fanteria veneta cedette, e della situazione ne trasse vantaggio la cavalleria
francese che inseguì i fuggiaschi. Il tutto si concluse prima delle ore 16.00.91
87
Moro Federico, Venezia in guerra, Studio LT2, 2011, pp. 164.
Sanudo, diarii, XVI, cit., p.210.
89
Moro Federico, Venezia in guerra, Studio LT2, 2011, pp. 166.
90
Pandino è una piccola cittadina in provincia di Cremona, all’epoca era parte del ducato di Milano.
Agnadello è un paese in provincia di Cremona, ai confini con la provincia di Bergamo.
91
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 118-121.
88
47
Conseguenza della disfatta fu che circa la metà dell’esercito veneziano defezionò,
contando così solamente circa quindici mila unità, i quali, condotti dal Pintigliano, si
accamparono al riparo ponendo il campo tra Mestre e Marghera.92
Il Ruzante , ci lascia nei suoi scritti l’immagine di come doveva essere quel luogo dopo
la battaglia, probabilmente un terreno con sopra di esso molte ossa e corpi di contadini
morti, qua e là brandelli di panno rosso e bianco, tali erano i colori che la signoria di
Venezia aveva deciso fossero delle divise di quei “boni homini”, come scriveva il
padovano Buzzacarini , “de Trevisana, de Padoana, de Vesentina, de Veronese,
Bresani, Bergamaschi e del Friuli, e del Polesene”, che l’Alviano aveva fatto
“cernire”.93
Luigi XII ha trionfato, per la Serenissima inizia l’ora più buia.
4. Il volere degli astri, di Dio e la fortuna ad Agnadello
A quel tempo un sentimento diffuso era che non ci si potesse opporre alla “fortuna”,
cioè al “Cielo”, il quale è ora inteso nella sua dimensione astrologica e non religiosa.
Dio era l’unico in grado di opporsi alla “fortuna”, e per tal motivo spesso ci si
appellava a Lui.
Luigi Da Porto94 scriveva che “per certo nulla vale il consiglio umano contro la
disposizione dè cieli, e contra lo strano scherzare che fa alle volte la fortuna con noi”.
Il Da Porto nei suoi appunti ci fa anche notare che lui osservava alcuni segni
premonitori, avvenuti in precedenza del fatale scontro di Agnadello, e strettamente
collegati alla battaglia. Nasce così, tra verità e leggenda, la storia del ciarlatano
bergamasco che si recò “in casa Corner nella contrada di San Benedetto”, che era
l’alloggio del capitano veneziano Alviano il quale era in compagnia del nobile
vicentino. Il bergamasco si presentò loro come “un uomo vestiti di due pelli d’orso, che
i curvi omeri e l’ispido petto gli copriano, avendo tutti il resto del suo corpo nudo”, non
curandosi di tutti coloro che sedevano al tavolo del condottiero, si rivolse direttamente
all’Alviano, ed ad alta voce affermò:
92
Ivi, pp. 110-113
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 149
94
Luigi da Porto, nacque a Vicenza nel 1485 e morì nella stessa città il 10 maggio 1529, fu scrittore e
storiografo veneto. Parte di una nobile famiglia vicentina, presto fu educato all’uso delle armi e alla
letteratura presso un parente ad Urbino.
93
48
“O signore, tu ti accingi per gire a far la guerra contro lo re di Francia in Lombardia,
dove un buon asinello ti converrà aver sotto, se tu ne vorrai campare; perciocchè io
sono filosofo naturale, e spesse fiato con inusitata astrologia indovino le cose future; e
volendo vedere la fine di questa guerra, l’ho speculata in questa maniera: Tolsi
stamane questo ferro, ed il figurai per Viniziani, il quale battendo ad una parete (che
Francia s’immaginava che fosse), l’ho veduto con poca noia della parete farsi curvo
per non spezzarsi; per che presuppongono, che così abbiano a far i Viniziani, che
piegheranno per non rompersi”.95
Questo fatto per il Da Porto stava a significare che la “fortuna” si era già sbilanciata
non in favore dei veneziani.
Tutto ciò ci suggerisce come la lega di Cambrai e la successiva battaglia di Agnadello,
per il popolo non furono soltanto scontri militari, ma avversioni astrologiche e divine
contro di loro. Per il Da Porto la sconfitta era dovuta dall’invidia degli astri verso la
prosperità della Repubblica Serenissima.
Non molti anni prima, cioè nell’appena trascorso settembre 1506, anche negli scritti del
Machiavelli, precisamente nei suoi “Ghiribizzi”96 al Soderini97, leggiamo alcune sue
osservazioni sul tema della “fortuna”
“et veramente chi fosse tanto savio che conoscesse i tempi et l’ordine delle cose, et
accomodassisi a quelle, harebbe sempre buona fortuna, o egli si guarderebbe sempre
dalla trista, et verrebbe a esser vero che il savio comandasse alle stelle et a’ fati. Ma
perché di questi savi non si truova, havendo gli uomini prima la vista corta, et non
potendo poi comandare alla natura loro, ne segue che la fortuna varia et comanda agli
huomini e tiengli sotto il giogo suo”.98
Dall’altra parte del fronte invece, qualche poeta contemporaneo francese, chiaramente
avverso a Venezia, scriveva:
Tremblez, tremblez bourgeois veniciens,
95
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 150-152
Ghiribizzi, sono una raccolta epistolare con destinatario Giovan Battista Soderini. In tali vi si espone a
livello teorico che solo il felice “riscontro” fra il “modo di procedere” dell’uomo e la “qualità dei tempi”
in cui ci si trova ad operare, danno luogo alla vittoria.
97
Soderini Pier, nacque a Firenze il 18 maggio 1450 e morì a Roma il 13 giugno 1522, fu uomo politico e
gonfaloniere a Firenze dal 1502 a 1512. Era uomo fidato di Piero de’ Medici, tanto che per lui svolse il
ruolo di ambasciatore presso il re Carlo VIII di Francia.
98
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 153
96
49
vous avez trop de tresors enciens
mal conquestez; tost desployer les fault.
Rois, princes, ducz, jeunes et enciens,
seigneurs, marquis trouveront les moiens
dedans brief temps de vous livrer l’assault;
considerez votre cruel deffault,
et que pecune qui est tresmal acquise
effacera le regnon de Venise.99
Vari furono gli eventi tradotti come premonitori della prossima battaglia e che si
contrapponevano al benessere delle terre venete, alcuni dei quali furono la congiunzione
di Marte e Saturno, i pronostici del ciarlatano bergamasco, l’incendio dell’Arsenale, il
lupo a Vicenza, il fulmine di Cremona e l’invidia delle stelle, tutto ciò sintomo che
stava per finire la pace e la prosperità nel dominio veneto, che diversamente di altri
luoghi nella penisola, in questi luoghi ne avevano goduto pienamente. Ecco quindi ora
tornare i “paternostri”, le messe, le processioni e la pratica devozionale come “armi” da
sfoggiare contro gli astri.
Nel 1509, dopo Agnadello, molteplici furono le precessioni in Venezia, di cui Martino
Merlini ne parla in una sua lettera datata 23 giugno del medesimo anno affermando che
avveniva il canto delle litanie, devozione di uomini e donne, riconoscimento davanti alla
misericordia divina dei peccati commessi “el biastemar, la pocha justitia e gran
superbia, uxure, ranpine, sodomie e sacrilegi”.
In effetti, lo stesso Claude de Seyssel100, ci attesta come le stesse devozioni furono fatte
anche dai francesi, sia prima sia dopo la battaglia, nel primo caso propiziatorie dopo
invece di ringraziamento
Il Seyssel aggiunge poi, in termini chiaramente ostili alla Repubblica di Venezia, che la
lega di Cambrai si presentava come una crociata. Restando ancora alle sue parole,
afferma che Luigi XII si mosse contro i veneziani perché preoccupato per “le bin public
de toute la Chrestientè”. Del titolo di “Princes Chrestiens” si adornavano coloro che
avevano trattato per “un commun accord aux affaires de la Chrestientè” contro i
99
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 158.
Claude de Seyssel, nacque ad Aix les Bains (Francia) nel 1458 e morì a Torino l’1 giugno 1520, fu
arcivescovo cattolico. Studiò giurisprudenza all’Università di Pavia e divenne successivamente
professore all’Università di Torino. Dal 1501 al 1512 fu anche amministratore apostolico della diocesi di
Lodi.
100
50
veneziani che si erano resi colpevoli di un atteggiamento ostile nei confronti della
Chiesa e del papa.
Abbiamo quindi ora le carte in regola per poter parlare di crociata più che di lega di
Cambrai. Veneti che furono messi al bando della cristianità, quindi una crociata voluta
da Dio, oppure dalle congiunzioni astrali, accompagnata da segni premonitori, il cui
momento cruciale disseminò nel campo di battaglia ossa di contadini morti: questa per
Venezia fu la lega di Cambrai.101
5. L‘ estate 1509
“L’anderà parte, che tutti i conseglieri, avogadori et altri zentilhomeni nostri, che hano
over haverano offitij e magistrati, de qualunque sorte et condition se voglia, in questa
cità nostra, principiando a di primo del mese de marzo proximo, siano tenuti servir per
mesi 6 proximi senza alcun salario; i salarij de i qual, integre et senza alcuna
diminution, prevegnino et siano de la Signoria nostra”.102
Tal norma, risalente al 22 aprile 1509, promossa con 1503 si, 54 no e 5 non sinceri103,
decreta che i magistrati veneziani dovranno rinunciare al salario per alcuni mesi, ciò ci
fa intuire le grandi difficoltà finanziarie in cui si trovava la Repubblica. Questa
decisione non è tuttavia completamente valida per i rappresentanti della Serenissima
presenti nella terraferma, in quanto non si voleva correre il rischio di rendere incerta la
fedeltà del servizio, in questo momento necessari nello stato d’emergenza in cui si
trovava Venezia.104
Conseguenza di questa legge fu quella di portare un’intonazione etico-politica alle
scelte e decisioni del patriziato, diede saldezza alle istituzioni e fece si che il
patriottismo veneziano s’indentifico totalmente con lo stato. Di tal identificazione due
sono le manifestazioni evidenti: la prima è il senso religioso che si unisce alla coscienza
politica, la seconda è cosa viene visto come mezzo d’emergenza per far fronte alle
“occorrentie” del momento.
101
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 162-163.
Sanudo Marin, VIII, cit. p. 101-103
103
Il bossolo, era il termine utilizzato a Venezia per l’odierna urna, cioè un contenitore che poteva essere
triplice o duplice. Era utilizzato nella versione tripla quando nella votazione erano ammessi voti di parte
(si), i voti de Non (no) e quelli dubii o non sinceri (era una forma d’incertezza di voto simile, ma non
uguale nella sostanza, alla moderna astensione); il bossolo, era invece duplice quando veniva ammesso
solo il voto de Parte ed il de non.
104
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, p. 28.
102
51
Oltre alla raccolta del denaro tramite tutti i mezzi possibili, come mutui o prestiti
volontari, oppure la rinuncia dei salari da parte della classe dirigente, s’univa un rituale
religioso suggerito dal patriarca, cioè un digiuno propiziatorio previsto per i giorni 23,
24 e 25 maggio “per placar la ira di Dio; e cussì fo ordinato e tutta la terra dezunoe”.
Il cronista Sanudo nei suoi scritti riporta di avvenimenti particolari, avvenuti in vari
territori dello stato, ai quali conseguirono un incondizionato patriottismo. Ad esempio ci
mostra il contrasto fra le grida di “Franza! Franza!” oppure di “Chiesia! Chiesia!” da
un lato, e di “Marco! Marco!” dall’altro, dove l’evangelista era inneggiato dalla folla
presente a Ferrara, il tutto a fine aprile 1509. Anche i deputati di Cremona scrissero
delle lettere ai rettori fra l’8 ed il 12 maggio dello stesso anno, ed in tali riportano
“Li nostri soldati stano de bona voglia et in cervello, havendo havuto dinari et la
victoria contra francesi; et altro non se crida se non: Italia! Italia! Marco! Marco!
Questo sol nome, infixo ne l’animo de tutti lo concertanti de l’onnipotentissimo exercito
ducale, fa un glorioso core et pieno de indubitata victoria…”.
Nello stesso momento il Sanudo appunta nei suoi scritti che i cittadini bresciani sono
“disposti a patir ogni cossa e difendersi vigorosamente”.
Succedette tuttavia anche, una volta che i rettori lasciarono la città, che a Vicenza alcuni
cittadini s’armarono inneggiando all’Impero, i quali dovettero però affrontare il
contrasto dei popolani fedeli alla Repubblica. A registrare l’episodio datato 7 giugno, fu
il Sanudo.105
Come attestava Luigi Da Porto, quella dei Trissino era una casata “delle maggiori in
quantità e qualità”, che fossero presenti a Vicenza. Leonardo106, che per il Da Porto era
un “uomo di straordinario ardimento” dopo che fu accusato “per omicidio commesso
una notte nella persona di un nobile cavaliere”, anche quest’ultimo vicentino, e che “fu
della giustizia de’ Viniziani da ogni loro città e luogo sbandito”, riparò a Trento,
entrando in amicizia con Paul von Liechtenstein107, segretario di Massimiliano.
Quest’ultimo lo nominò cavaliere notando il coraggio e la capacità, del Trissino, nella
105
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, pp. 30-37.
Trissino Leonardo, nacque a Vicenza nel 1467 e morì a Venezia il 3 febbraio 1511. Quella dei Trissino
era una delle famiglie più potenti della città. Non si conosce molto della sua infanzia e adolescenza,
sappiamo che nel 1493 sposò Tommasina, figlia del conte Trento.
107
Paul von Liechtenstein, nacque circa nel 1460, discendente da una famiglia di ministeriali. Il padre
Balthasar lavorara per il vescovo di Trento e per l’arciduca Sigismondo del Tirolo. Paul, sposato con
Barbara von Schrofenstein, ebbe un figlio.
106
52
caccia per luoghi impervi, diventando così uomo vicentino in casa d’Austria, ma allo
stesso tempo nemico dei veneziani. Fu grazie al ruolo di “Cesare” all’interno
dell’Impero,
che
poté
accogliere
la
dedizione
di
Vicenza,
comportandosi
“modestamente, e senz’alcuna ambizione”. Unica critica che il Da Porto mosse contro il
Trissino fu perché aveva distrutto un San Marco di pietra, in quanto con tal gesto aveva
“distrutto così nobil lavoro e di tanta bellezza”. L’atto appena riportato fu all’inizio di
uno scontro che vedeva contrapposti “imperiali” e “marcheschi”, avvenuto nei pressi
di Montebello “luogo vicentino posto sopra la strada di Verona, pieno di uomini
marcheschi e molto fieri”, e proprio in quel luogo, alcuni fuggiaschi di Cremona, del
leone marciano andato a pezzi ne raccolsero i testicoli e, per spregio, decisero di
mostrarli pubblicamente, i cremonesi furono aggrediti, parecchi feriti ed alcuni uccisi.
Quella sopra riportata è un semplice aneddoto il cui scopo è esprimere quale aria si
respirava, successivamente alla disfatta di Agnadello, nella terraferma, dove si vedeva
chiaramente il rancore antifeudale dei subalterni contro la nobiltà locale.
Il 20 giugno giunsero nuovi funzionari imperiali a Padova ed i padovani:
“faceano cosse da mati per questi todeschi, li Zudei non desiderava tanto el Mesia
quanto facea questi mati cytadini, questi imbriagi senza uno bon costume, et questo
feceno per farse benivoli cum questi governadori che mandava lo imperadore”.
Marin Sanudo inoltre riportò nei suoi Diari il riassunto di un’orazione che tennero i
rappresentanti della città di Padova, i quali erano grati all’imperatore per averli liberati
dalla tirannide veneziana:
“3000 tyranni veneti, i qualli, per la vicinità, continue ogni suo infortunio e danno,
rodando le nostre povere viscere, si ha reffato et consumatone talmente, che di homeni
rationali, quodammodo siamo umbre e simulacri pervenuti. Et quella cità di Padoa, che
se dice esser de’ paodani,non hè parte alcuna che sia sua, non le mure, non caxe, non
chiexe, né officij, ne beneficij, ni preminentie alcune; e cussì fora di la terra, né campo
coltivato, ni monte, ni piano, né bosco, né valle, né lagi, niente è che più sia nostro, ma
tutto extorto e tiratone da le mane per essi venetiani, parte con uxure, parte per altre
vie indirete…”.
Sentendo affermare ciò la reazione di Girolamo Priuli fu composita, ed espresse i
sentimenti del suo animo:
53
“Et questi citadini padovani dimostraronno uno cativo animo et pessima voluntade
versso la Republica Veneta, et molto pegiore dimonstratione haveanno facto questi
citadini patavini di quello haveanno facto li citadini de altre citade rebellate al Stato
Veneto. Et questo procedeva, per voler dechiarire la veritade del tuto, perché questi
citadini se tenivanno malissimo contenti deli nobelli et citadini veneti, perché si hera
statto tolto loro posessione, le chaxe loro et li loro beni dali nobelli et citadini et
populari veneti, non perhò sforzatamente, né violentemente, ma comprato per magior
pretio di quello valevanno et cum consentimento de loro vendictori et tochato il justo
loro pagamento. Et questo perché li citadini nobelli et populari veneti, quali heranno
charigi de danari, non guardavano a pretio alchuno, né a danari per comprar una
chasa, una posessione, over livello, over in altro in la citade et teritorio padoano et
strapagavanno il piui assa di quello valvevanno dicte robe, et li citadini veneti et
nobelli, per pagar assai queste posessione et chaxe, haveanno comprato quassi li duo
terzi dele posessione et chaxe deli citadini et populo patavino, et, aveno tochati li
danari, li haveanno spexi et se vedevanno loro over li sui heredi spoliati dele sue
posessioni et chaxe et non potevano patire che fusseno pervenuti in mano dei Venetiani,
et maxime non se vedendo avere ne danari ne posesione, perché li danari heranno stati
malissimo spexi et butati via. Et per simel cagione questi citadini patavini portavanno
tanto odio ali Signori Venetiani, che non potevanno sentire il nome loro, et speravanno
loro, ahora che lo Imperator ellecto dominarà questa loro citade, potere essere
reintegratti deli suoi beni et posessione et chaxe et havere il tutto indriedo; et perhò
desideravanno la ruina dela Repubica Veneta, ridondendo maxime in tanto benefitio
loro”.
È semplice intuire come i cittadini ed i nobili della terraferma avessero la speranza di
ottenere dall’imperatore Massimiliano “privilegij, comodi et apiaceri”, come il Priuli
riporta. I padovani si obbligavano a finanziare l’Impero con centomila ducati d’oro ogni
anno, che venivano riscossi il giorno di Sant’Antonio, inoltre dovevano mantenere al
suo comando duemila cavalli e duemila fanti.
In cambio, chiedevano la concessione dei possedimenti e delle case “di fuora et in la
terra di Padoa, come nel teritorio, di raxon di vinitiani”.108
108
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, pp. 40-49.
54
6. L’assedio di Padova
Luigi XII, in seguito ad Agnadello, era certo che la val Padana era sotto il suo controllo,
a dargli tal certezza fu il crollo morale che si produsse all’interno dello “stado da tera”
tra maggio e giugno. I cittadini veneziani erano impauriti, in quanto il declino militare
fu visto come una punizione divina, a causa della “hibris” con la quale la Repubblica
aveva lasciato le sue origini di città marittima in cambio dell’espansione in terraferma.
Il ceto dirigente veneto superò il disorientamento, in quanto fu presto chiamato a gestire
il problema del proseguirsi di una guerra che gli alleati di Cambrai avevano iniziato col
fine di eliminare la potenza della Serenissima.
Ecco che Luigi XII, rispettando gli accordi presi a Cambrai, cessò l’offensiva, in quanto
aveva già occupato le terre che sarebbero spettate a lui, cioè quelle ad est del Mincio.
Nonostante tal atto francese, il pericolo per la Serenissima non era svanito, ma in arrivo
da nord, organizzato dalla casa d’Asburgo, dove nel giugno parte del suo esercito calò
in terra veneta occupando Verona, Vicenza, Padova, Bassano e Feltre.
Le oligarchie delle città sopra citate defezionarono immediatamente, mettendosi al
servizio dell’imperatore, facendo così perdere la sovranità in quei luoghi alla
Serenissima. Treviso fu l’unica che restò fedele a Venezia. La Repubblica di San Marco
era ora orgogliosamente sostenuta dai contadini veneti, i quali insorsero in suo favore,
esigendo di tornar parte del suo dominio. La rabbia di questi contadini si espresse con
un contributo attivo, ed essenziale, alla lotta di resistenza contro chi invadeva le terre
del loro amato stato.109
Avanguardia imperiale che, essendo di limitate dimensioni, non fu in grado di fare
arretrare le forze che, il 17 luglio, il Pintigliano schierò in campo per recuperare Padova.
Fatto ciò il condottiero veneto dovette prepararsi per reggere un assedio inevitabile, in
quanto appena arrivata la notizia della perdita di Padova, il re dei Romani spedì nella
medesima città un numeroso esercito.
In questa traballante e pericolosa situazione, oltre ai combattivi contadini, gran parte dei
patrizi veneziani mobilitarono i loro soldati, in quanto era in gioco la sopravvivenza
dell’intero “stado da tera” e dell’intero stato veneto.
109
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 121-123.
55
Come già detto, i contadini accorsero in gran numero per difendere Padova, nella quale,
appena riconquistata Andrea Gritti110 entrò in Padova “cum equitibus levis armature,
armigeris, peditibus et maxima turba rusticorum”.111
Il Sanudo ci ricorda che “di le Gambarare veneno zercha 700 homeni villani, armati,
con sier Filippo Paruta quqondam sier Nicolò”112. Filippo Paruta era un patrizio
veneto, mentre Nicolò Gallo era un cittadino, il quale era alla testa di quei 700 contadini
che erano disposti a difendere le Gambarare.
Il Sanudo ricorda, in quanto testimone oculare che i veneziani, godendo del favore delle
campagne, non solo accettavano le scaramucce col nemico, ma a volte le cercavano. Si
vede quindi genti veneziane che saccheggiavano i banchi degli ebrei, o le case di quei
deputati “ad utilia”, che ora erano di provenienza transalpina.
All’interno della città di Padova, prima della riconquista da parte del Pintigliano, era in
perenne aumento la tensione e il malumore, in quanto gli occupanti erano parecchio
rissosi. Quando i veneti riuscirono a riprendere Padova il 17 luglio, la trovarono quasi
totalmente sguarnita: era difesa da circa 300 fanti, capitanati dal Trissino.
Il 18 luglio il Trissino rifiutò di arrendersi, ma il giorno successivo dovette accettare la
capitolazione del castello in cui si era rinchiuso in ritirata, in quanto le sue mura furono
squarciate da colpi di artiglieria veneziana113. Nonostante ciò la maggior parte delle
forze imperiali non era ancora sconfitto perché accampato tra Bassano, Asolo e
Cittadella.
In casi critici come questo viene ad emergere tutta la solidarietà di cui i veneti
dell’epoca erano capaci. Contadini e patrizi uniti nel combattere verso un unico
obiettivo, la salvaguardia della propria patria. Mentre i primi combattevano nei quadrati
come fanti, i secondi erano alla testa di tali, al loro comando.
Contemporaneamente a Piove di Sacco avvenne un piccolo tumulto, conclusosi con
l’impiccagione di un cittadino che era ritenuto “causa di gran mal contra la Signoria”.
Ad Arquà e Monselice appena arrivò ai contadini la notizia che i veneziani liberarono
110
Gritti Andrea, nacque a Bardolino il 17 aprile 1455 e morì a Venezia il 28 dicembre 1538, fu mercante,
militare e politico veneto, inoltre fu il 77esimo doge della Repubblica di Venezia dal 1523 alla morte.
111
Bruto, Annalia, in Gloria, cit., p. 56.
112
Sanudo, VIII, cit., p. 522.
113
Bruto, Annalia, in Gloria, cit., p. 57.
56
Padova, si mossero al grido di “Marco! Marco!” per liberare la stessa Monselice
passata in precedenza sotto il controllo del duca di Ferrara.114
Quando i veneziani ripresero Padova,
“molti gentiluomini ne fuggirono quasi nudi; molti eziandio ne furono presi in diversi
modi, ed in Vinegia imprigionati; contro à quali furono formati per lo Consiglio de’
Dieci grandissimi processi, senza, (…), dar modo di alcuna difesa”115.
La reazione degli imperiali contro i contadini fu immediata muovendo le forze di
Massimiliano verso Bassano,
“currebant theutones ipsi per villas paduani districtus depredantes, interficientes
rusticos et comburentes domos usque ad Tergulam, ad villam Comitis et alias partes
Citadelle”116
Già ai primi di agosto Gabriele Emo, capitanando “gran numero di villani”, voleva
l’appoggio della cavalleria, “per non meter in pericolo ditti contadini inspauridi”.117
Massimiliano d’Asburgo furioso volle usare tutte le sue forze nell’assedio di Padova.
Nel caso per lui si riservasse un insuccesso, sarebbe andato disfacendosi il suo onore e
la sua credibilità all’interno della politica italiana. Per distanziare tal pericolo l’Asburgo
si fece aiutare da Luigi XII, il quale cedette dei soldati per rafforzare l’esercito
imperiale. La potenza d’urto degli austriaci non riuscì a rompere le fila degli agguerriti
difensori veneti.
Era il 20 agosto 1509 quando contadini e lavoratori meccanici erano pronti alla difesa di
Padova, ultimo baluardo della terraferma veneta. Furono fatte chiudere le botteghe, i
“populares” della città ed i “rustici” che in città si rifugiarono per sfuggire alla truppe
imperiali, “omnes libenter laborabant sempre acclamantes Marco, Marco!”. Ciò ci
mostra lo stato d’animo e la mobilitazione collettiva delle classi meno agiate, la cui
eccitazione era tenuta alta con incitamenti verbali di Andrea Gritti, e anche, seguendo la
logica di tutti gli avvenimenti del tempo, con una paga di dieci soldi ciascuno “quia
posita fuerat certa angaria, que exigebatur a vicibus pro solvendis dictis operariis”.
114
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, pp.366-370.
Ivi, cit, p. 373.
116
Bruto, Annalia, In Gloria, di Padova dopo la lega stretta in Cambrai, cit., p.58
117
Sanudo, IX, 14
115
57
Fuori dalle mura di Padova furono incendiati molti edifici, cosicché le truppe d’oltralpe
non potessero trovare ripari. Eccezion fatta per due ville di proprietari veneziani ed un
monastero di frati certosini.118
Vicenza a quel tempo era ritenuta buon centro osservatorio, ed in quanto territorio
imperiale, il Da Porto ci informa che in casa propria, anche se dipinto anticamente su di
un muro, non si poteva possedere alcuna effige di San Marco. Se ciò avveniva si era
considerati nemici dell’imperatore e se ne subivano personalmente le conseguenze, tali
erano l’imprigionamento ed il pagamento di una somma di denaro mutabile in base al
volere imperiale.
Era settembre quando iniziò l’assedio delle truppe imperiali presso la città di Padova, le
quali mai riuscirono a chiudere il cerchio attorno alla città, in quanto i veneti difensori
erano tenaci nel combattere e riuscivano continuamente a spezzarlo. Erano comunque
devastanti i colpi d’artiglieria che venivano sparati contro le mura con lo scopo di aprire
delle brecce, ma gli assalti che si ripeterono per tutto il mese di settembre, vennero
sempre contrastati e respinti. Gli ultimi giorni di settembre furono i più duri, nei quali si
ebbero veri scontri tra offensori e difensori che misero in scena sanguinose battaglie.
In modo particolare, il 24 settembre, gli imperiali assaltarono un bastione della città, e
fu in quel momento che in Padova risuonarono le campane e “quasi totus populus
cucurrit ad arma”. Passarono solamente due giorni quando i collegati di Cambrai
ritentarono, loro malgrado a vuoto, un assalto, ciò avvenne mentre alcuni soldati
veneziani andarono a scontrarsi con gli austriaci tramite una sortita. Tra le fila venete
cominciò a girare la voce che il 29 settembre era il giorno dell’azione decisiva delle
truppe imperiali. Nell’attesa di ciò giunse il fatidico giorno, i soldati dell’Impero
utilizzarono delle scale per salire le mura della città, ma i difensori le ribaltarono e
sommersero i nemici “cum balistis, archis, sclopetis et aliis artellariis”, tanto da
provocarne la ritirata in quanto, dopo quest’estremo tentativo di occupare la città,
l’imperatore Massimiliano si arrese alle malattie che si diffondevano tra i suoi uomini,
alla scarsità di viveri e alla mancanza di fiducia che stava dilagando tra i suoi uomini.
Il Pintigliano aveva vinto grazie all’applicazione della sua iniziale strategia, cioè
strategia logoratrice, che qui fu in grado di sovrastare al primo vero assedio sostenuto in
penisola, dal momento della calata del 1494.
118
Bruto, Annalia, cit., p.61.
58
La spina nel fianco restava ora la Francia, che dominava la scena in val Padana, ma che
non stava bene a nessun principe dell’epoca, primo tra tutti Ferdinando il Cattolico119,
che si dimostrò ora contrario alla totale cancellazione di Venezia come potenza
territoriale. Un’inaspettata inversione di tendenza l’ebbe il papa Giulio II, il quale si
affrettò ad aiutare la Serenissima dopo il tracollo, il cui scopo era solamente costringerla
a cedergli la Romagna, iniziò così una cooperazione con Venezia. Questa cooperazione
tra Venezia e lo stato della Chiesa aveva anche lo scopo di contrastare Luigi XII, il
quale voleva porre la Chiesa romana sotto il suo controllo.
Conversione pontificia che lo portò a siglare, separatamente dagli altri membri della
Lega di Cambrai, un trattato di pace il 24 febbraio 1510. Con tal atto non cessava la
guerra, ma ne venivano soltanto mutati gli obiettivi.
Nei fatti per la liberazione di Padova, come nella battaglia di Agnadello, notiamo che si
rivelarono le caratteristiche base dello stato veneto, la solidarietà tra ceti, il dualismo tra
dominante e dominio. Si trattò anch’esso di un avvenimento che mostrò larga
partecipazione di massa, nonostante ci fossero stati precedentemente momenti di
fratture tra classi sociali. In questa situazione tutto fu però messo da parte, in quanto
l’interesse veneziano, privato e pubblico era a rischio, la “furia rusticorum” era carica
di risentimento anti-feudale.
I vertici della repubblica Serenissima, essendo coscienti del gran merito dei contadini
nella riconquista di Padova, decisero di concedere loro esenzioni fiscali per la durata di
cinque anni. Questa decisione, nonostante il gran bisogno di entrate avesse Venezia in
quel periodo, riflette ancora una volta la solidarietà interclassista veneta.
Il Guicciardini120, nei suoi testi, riporta l’importanza del successo nella difesa di Padova
per Venezia:
“E dallo acquisto e difesa di tanta città dipendeva non solamente lo stabilimento o
debolezza dello imperio de’ tedeschi in Italia ma ancora quello che avesse a succedere
della città propria di Vinegia. Perché difendendo Padova poteva facilmente sperare
119
Ferdinando il Cattolico, il cui nome era Ferdinando di Trastamara, in spagnolo Fernando o Fernan,
nacque a Sos (Spagna) il 10 marzo 1452 e morì a Madrigalejo (Spagna) il 23 gennaio 1516. Fu re di Sicilia
col nome di Ferdinando II, poi re consorte di Castiglia come re Ferdinando V, poi re d’Aragona, Valencia,
Sardegna, Maiorca e re titolare di Corsica, Conte di Barellona, poi re di Napoli come Ferdinando III, poi
reggente di Castiglia e poi re dell’Alta Navarra.
120
Guicciardini Francesco, nacque a Firenze il 6 marzo 1483, morì ad Arcetri il 22 maggio 1540, fu
scrittore, storico e politico fiorentino. È noto ai contemporanei per la sua stesura del testo Storia d’Italia.
59
quella republica, piena di grandissime ricchezze e unità con animi prontissimi in se
medesima né sottoposta alle variazioni alle quali sono sottoposte le cose de’ principi,
avere in tempo non molto lungo a recuperare grande parte del suo dominio”121.
A riguardo della solidarietà sociale e politica tra patrizi e contadini veneti, è curioso
notare che si espresse non soltanto nell’atto di difendere Padova, ma anche col
trasferimento degli stessi contadini che dalle campagne andarono verso Venezia, alla
ricerca di sicurezza dalle truppe imperiali.
Era un esodo di contadini allo sbando, tanto che i diaristi veneti la descrissero
commossi. Contadini che
“dubitando la rabia inimicha, scampavano cum li sui bestiami et cum le sue femine et
cum li putini in brazo…”; molti ne venivano uccisi, altri, che riuscivano a scappare, “se
redusseno a Venetia cum la sua fameglia et roba, et furonno ben visti et aceptati et
charezzati dali sui patroni, perché pochi heranno quelli vilani, che non haveanno ad
lavorare posesione di Venetiani, et heranno ben visti et acharezati”.122
A metà settembre 1509 si potevano vedere porci e pecore addirittura in piazza San
Marco. L’immagine dei contadini che migrano verso Venezia, insieme ai loro cari ed ai
loro averi, nella sensibilità veneziana rivive un’analogia con le mitiche origini della
città, e per questo motivo l’accoglienza era sentita come dovuta, era impossibile che
proprio i veneziani non dessero asilo ai contadini in fuga da questi nuovi barbari, i loro
padri avevano fondato Venezia proprio fuggendo dai barbari. Inoltre il governo non
accettava nemmeno che le donne dormissero nelle calli o sui ponti, quindi provvide a
ciò con una norma che stabiliva che i nobili ed alcuni cittadini di ciascun sestiere,
dessero loro alloggio.
“a questa povera gente, la qual meritava essere subvenuta, favorita et adiuctata da tuta
la citade veneta per la sua grande et svisserata fede verso la Republica”.
Furono anche adibiti all’accoglienza degli edifici pubblici, e ancora venne salvaguardata
la salute di questi migranti attraverso un controllo sanitario123
“Heranno venuti a Venetia tanta moltitudine et numero di vilani, vilane, puti, pute
scampati dali inimici, che non se trovava alogiamento de darli. Niente di menno a tutti
121
Guicciardini, storia d’Italia, cit., II, pp. 790-791.
Priuli, Diarii, cit., p. 304 .
123
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974, pp. 375-407.
122
60
fu dato alogiamento meglio che se poteva (…) quali per la fede versso la Republica
Veneta meritavanno non solamente essere subvenuti et adiuctatti, ma abrazatti et
charezatti et aceptatti in le loro proprie camere deli primi Padri Veneti”.124
124
Priuli, Diarii, cit., p. 320.
61
CAPITOLO VII
ALL’INDOMANI DI AGNADELLO
62
1. Contese spirituali e temporali
Quando Luigi XII comprese che il pontefice si stava organizzando per cacciarlo dalla
Penisola, si adoperò per sferrare un attacco decidendo l’Emilia come campo di battaglia.
Giulio II perse Bologna, inoltre fu colpito dal re di Francia anche sul piano
ecclesiologico. La Chiesa gallicana confermò la sua indipendenza da Roma, e lo stesso
Luigi XII si mosse per far si che i cardinali filofrancesi si staccassero da Giulio II e
convocassero un concilio, tenutosi a Pisa l’1 settembre 1511125, per riformare la Chiesa,
accusando lo stesso pontefice di simonia.
Dopo essersi assicurato del sostegno spagnolo, il papa si appellò al mondo ecclesiastico
italiano, alla sua solidarietà, per evitare la spaccatura della Chiesa. Convocò così a
Roma il Concilio Lateranense V che ebbe sede il 19 aprile 1512. Sicuro che la diatriba
non si sarebbe conclusa grazie alla diplomazia, Giulio II promosse una coalizione
militare italo-europea, nota come Lega santa, nella quale trovarono accordo la Chiesa, la
Spagna, Venezia e, poco tempo dopo, anche l’Inghilterra.
Il raggiungimento di un accordo con la Confederazione elvetica fu per il pontefice una
vittoria diplomatica, in quanto i nuovi alleati misero a disposizione di Giulio II le loro
famose fanterie mercenarie. Tali furono impiegate dal papa come milizia personale, ed è
a questo momento a cui risale la figura della Guardia svizzera in Vaticano.
La lega santa fornì sicurezza a Venezia per la guerra di riconquista del suo “stato da
tera”. Il successo della Repubblica fu quasi totale, poiché tutte le città vennero riprese,
ad esclusione di Verona e Cremona.
È facilmente comprensibile come, dietro alla riscossa veneta, c’era la volontà pontificia
di ridimensionare il controllo francese in Penisola. Luigi XII era tuttavia determinato ad
eliminare l’alleanza veneto-pontificia, e per tal scopo ingaggiò un numero di soldati pari
a venticinque mila.
125
Il concilio fu convocato a Milano il 16 maggio 1511 e si tenne a Pisa nel settembre 1511. A
parteciparvi furono i cardinali Bernardino Lopez de Carvajal, Federico Sanseverino, Guillaume Briconnet
e René de Prie, oltre a diciotto vescovi e abati, quasi tutti francesi. Il concilio fu successivamente
trasferito a Milano e poi ad Asti, e infine nel giugno 1512 a Lione, dove venne terminato senza il
raggiungimento di alcun risultato. La reazione di Giulio II fu quella di scomunicare i cardinali a lui avversi
e convocare il concilio Lateranense V.
63
Il re di Francia mise il suo esercito nelle mani del condottiero Gaston de Foix126, il quale
decise di puntare su Ravenna, tuttavia il comandante dell’esercito rivale, Ramon de
Cardona127, preferì sottrarsi alla battaglia sperando di proteggere comunque la città
accampandosi nei suoi dintorni. Aiuto sostanziale ai francesi fu dato dall’artiglieria di
Alfonso d’Este128, la quale fornì un essenziale fuoco di copertura. Coperti da una
pioggia di proiettili, i cavalieri ed i fanti attaccarono in campo aperto, dove gli ispanicopontifici furono sorpresi, e la sortita fu loro fatale. Alfonso d’Este sebbene fu messo a
conoscenza che i suoi cannoni colpivano senza distinzione gli spagnoli e gli alleati
francesi, continuò a farli sparare, senza riguardo per alcun esercito.
Gaston de Foix poteva ritenersi vincitore già con la prima sortita e la conseguente
distruzione della cavalleria difensiva. Questi diede comunque ordine di continuare
l’attacco nel campo degli avversari, commettendo il fatale errore di mettersi alla testa di
una carica ed in tale situazione venne ucciso.
Il totale delle perdite nella battaglia di Ravenna fu elevatissimo, tanto che anche per i
vincitori si vide un principio di rovina. Conseguentemente a tal fatto il pontefice Giulio
II si preoccupò di prevenire un qualsiasi tentativo d’invasione dello Stato della Chiesa,
sollecitando gli svizzeri ad invadere Milano, questo serviva per creare un diversivo
nell’andamento dei fatti. La calata degli svizzeri fu un qualcosa di stravolgente, tanto
che entro la fine del giugno 1512 avevano già fatto fuggire i francesi non solamente
dalla Lombardia, ma anche dal confinante Piemonte. Con l’avvento degli svizzeri e la
liberazione dai francesi, Giulio II lanciò una parola d’ordine cioè “fuori i barbari”.
Nelle loro azioni, gli svizzeri furono accompagnati anche dagli spagnoli.
Così assistiamo ad un apparente ritorno al passato assetto delle “cose d’Italia”,
apparente in quanto si intravedeva un predominio spagnolo che dal Mezzogiorno
cominciava a stendersi verso la Toscana e la Liguria. Tal situazione non piaceva
minimamente al pontefice, in quanto circa un anno prima di morire dichiarò in privato
126
Gaston de Foix-Nemours, nacque a Mazeres (Francia) il 10 dicembre 1489 e morì a Ravenna l’11 aprile
1512. Per le sue vittore fu soprannominato “Folgore d’Italia”. Già molto giovane divenne comandante
generale dell’esercito di Luigi XII. Finì la sua vita trafitto da una picca durante la battaglia di Ravenna a
22 anni.
127
Ramon Folc III de Cardona-Anglesola, italianizzato Ramon de Cardona, nacque a Bellpuig (Catalogna)
nel 1467 e morì a Napoli il 10 marzo 1522. Fu generale delle truppe della Lega Santa e vicerè di Napoli
dal 1509 alla morte.
128
Alfonso I d’Este, nacque a Ferrara il 21 luglio 1476 e morì a Ferrara il 31 ottobre 1534. Egli fu il terzo
duca di Ferrara, Modena e Reggio. Succedette al padre Ercole I d’Este all’età di 29 anni. Fu uomo d’armi
e politico.
64
di detestare gli spagnoli, e per tal motivo cercò una nuova intesa con l’Impero. L’intesa
tra i due venne stipulata nel novembre 1512, ma tale fu l’ultimo atto del papa.
Successore di Giulio II fu il Cardinale Giovanni de’ Medici129, nominato pontefice a 37
anni nel giorno dell’11 marzo 1513, con nome di Leone X.
In contrapposizione dell’asse papato impero, venne stipulata una nuova alleanza i cui
firmatari furono Francia e Venezia. Per la Serenissima tal patto gli serviva per la
riconquista dello “stato da tera”. Grazie a questa nuova intesa venne liberato il
condottiero veneto Bartolomeo d’Alviano dalla prigionia, il quale immediatamente
riprese il comando dell’esercito veneto. L’Alviano già nel 1513 si scontrò con le truppe
imperiali presso la piccola cittadina della Motta, in provincia di Vicenza, ma
inaspettatamente fu sconfitto. Tal evento portò la certezza, tra i governanti della
Repubblica, che la riconquista della terraferma sarebbe stata ancora lunga. L’obiettivo
veneto fu raggiunto tra il 1516 ed il 1517, quando furono liberate e riprese Brescia e
Verona.130
2. I veneti dopo la disfatta di Agnadello
Per quanto riguarda lo scontro di Agnadello, il Machiavelli si soffermò sugli aspetti
tattici e strategici della battaglia di Agnadello:
“I Viniziani, né tempi nostri, se non volevano venire a giornata con il re di Francia,
non dovevano aspettare che l’esercito francioso passasse l’Adda ma discostarsi da
quello, come Cingetorige. Donde che quegli, avendo aspettato, non seppono pigliare
nel passare delle genti la occasione del fare la giornata, né fuggirla; perché i
Franciosi, sendo loro propinqui, come i Viniziani disalloggiarono, gli assaltarono e
ruppero. Tanto è che la giornata non si può fuggire quando il nimico la vuole in ogni
modo fare”131.
La sua riflessione sulla battaglia di Agnadello fu un’analisi e una critica dei veneziani
che in una “giornata, perderono quello che in ottocento anni, con tanta fatica, avevano
acquistato”.
129
Giovanni de’ Medici, conosciuto come Papa Leone X, nacque a Firenze l’11 dicembre 1475 e morì a
Roma l’1 dicembre 1521, fu il 217esimo papa della Chiesa cattolica dal 1513 alla morte. Era figlio di
Lorenzo de’ Medici e Clarice Orsini. Leone X portò splendore rinascimentale presso la corte pontificia.
130
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, pp.117-125.
131
Machiavelli, arte della guerra e scritti politici minori, cit., pp. 438.439.
65
Martino Merlini, concedeva a Venezia un’agonia più lunga d’una sola giornata di
battaglia, il 23 giugno 1509 scriveva:
“chosse inaudite che mai omo del mondo se pensasse, che in mancho de 20 zorni el
stado de Venetia se perdesse et andasse in questo modo”.
Ad un punto assai avanzato era giunta l’evoluzione aristocratica, quando nella primavera
del 1509, in seguito alla disfatta di Agnadello, Venezia perse in pochi giorni quasi tutti i
possedimenti della terraferma. Per sette anni le città venete e lombarde furono contese
tra gli eserciti combattenti. La lunga crisi, la più grave che la Repubblica avesse mai
conosciuto dopo la guerra di Chioggia, fece precipitare in lotta asperrima e aperta i
contrasti di classe, allineando i diversi ceti sociali, l’un contro l’altro armati, con gli
opposti schieramenti in campo.
Niccolò Machiavelli, inviato a Verona presso Massimiliano D’Asburgo, era rimasto
impressionato dalla disperata fedeltà de contadini verso la Repubblica:
“e tutto di occorre che uno di loro preso si lasca ammazzare per non negare il nome
viniziano. E pure iersera ne fu uno innanzi ad questo Vescovo, che disse che era
Marchesco, e che Marchesco voleva morire, e non voleva vivere altrimenti; in modo che
el Vescovo lo fece appiccare; né promessa di camparlo, né d’altro bene lo possè trarre
di questa opinione; dimodochè, considerato tutto, è impossibile che questi Re tenghino
questi paesi con questi paesani vivi”.
Già il 29 giugno alcuni barcaioli tumultuavano al Portello, alzando una bandiera
veneziana al grido di “Marco, Marco!”. Dopo liberata Padova dagli imperiali, “omnes
artifices”, precettati dai veneziani, chiusero le botteghe e corsero a lavorare alle mura e
alle fosse, “et omnes libenter laborabant semper acclamantes Marco, Marco”. Quasi tutti
i popolari accorrevano in armi unendosi ai soldati sugli spalti minacciati dai nemici.
Il patriziato veneziano, infatti, oltre a provocare con la sua politica protezionistica in
favore della Dominante e col fiscalismo il lento soffocamento delle industrie e dei
commerci nella terraferma, aveva declassato i ceti dirigenti delle città soggette al
modesto rango di amministratori subalterni di provincia, dal momento che era
costituzionalmente incapace di assimilarli. In breve, il patriziato veneto si comportava da
conquistatore, senza tollerare alcuna forma d’integrazione. Da ciò soprattutto derivò la
costante frattura tra la classe dirigente veneziana e quella delle terre suddite, fonte di
continuo malessere, di proteste, di ostilità. Il ceto “cittadino” della terraferma conservava
66
e in una certo senso accentuava la sua preminenza sulle classi subalterne, trasformandosi
in aristocrazia. A sua volta tuttavia era scaduta ad un rango inferiore e doveva soggiacere
all’egemonia d’una casta dominante assai più forte. Questa condizione d’inferiorità era
quotidianamente inacerbita da episodi che ledevano gli interessi e ferivano l’orgoglio.
Quando di schianto sembrò crollare la potenza veneta, i “cittadini” credettero giunto il
momento della libertà “lux orta est in tenebris”, scrissero sui muri di Padova: e furono
pronti a sollevarsi, levando quindi le insegne imperiali, essi speravano di ottenere
nell’ambito dell’impero molti privilegi; il loro programma era dunque di pervenire ad
uno status di città libera, sotto la debole sovranità dell’imperatore.
Da questi programmi delle classi dirigenti cittadine, dalle diverse conseguenze che il
mutamento politico avrebbe provocato, nessun vantaggio invece potevano aspettarsi i
popolari. Innanzitutto Venezia era la grande consumatrice per la quale lavoravano gli
artigiani e i coltivatori di tutto il Veneto, inoltre rappresentava il grande mercato
internazionale dove trovavano uno sbocco molti prodotti agricoli e industriali della
terraferma. Di là di questi divergenti interessi economici, entra in gioco l’antagonismo
che divide le due classi. Il governo veneziano era stato un argine alla prepotenza
“cittadina”, un’autorità che poteva impedire, e talvolta lo impediva, abusi e
sopraffazioni a danno delle classi inferiori. Quindi l’affetto dei popolari per San Marco
era dovuto anche in ragione dell’odio verso i “cittadini”.
La crisi dello stato Veneto, scuotendo l’autorità e la forza dei poteri costituiti, che con la
loro funzione mediatrice e coercitiva avevano attutito e contenuto sotto la superficie i
contrasti, pose bruscamente faccia a faccia, senza schermi protettivi, i diversi ceti
sociali, mise a nudo le contraddizioni che corrodevano la società entro le stesse mura
cittadine.
Più che l’atteggiamento dei popolari, la fedeltà quasi fanatica dei contadini verso
Venezia colpì il pensiero dei contemporanei e dei posteri, e divenne uno degli argomenti
preferiti di quanti esaltarono il governo della Repubblica, sostenendo che era equo e
illuminato, volto alla difesa delle classi umili e in particolare delle popolazioni rurali.
Nelle campagne i veneziani si presentavano in due vesti diverse: come suprema autorità
politica e come possessori di terre. Non si può dire che sotto questo secondo aspetto essi
suscitassero particolari simpatie. Nell’animo semplice dei contadini che lavoravano le
proprietà veneziane, il crollo della Repubblica risvegliò l’antica istintiva aspirazione al
67
possesso della terra: con la fuga delle autorità politiche, sembrava ad essi che anche i
padroni se ne fossero andati per sempre, lasciando liberi nelle loro mani i campi, gli
animali e le fattorie. Dissipatesi, infatti, le prime illusioni e superato il disorientamento
iniziale, fu chiaro ai contadini che la fine della dominazione veneta aveva l’unico
risultato di lasciarli in balia degli odiati “cittadini”. Vale qui ciò che si è detto a
proposito dei popolari: per quanto conservatrice l’autorità veneziana era pur sempre un
potere superiore a cui si poteva ricorrere, talvolta con successo, per contenere o
impedire gli abusi. I nemici di Venezia rimanevano stupefatti vedendo il grande favore
del popolo e dei contadini per la Repubblica. Il Priuli afferma che:
“et ettiam pensavanno in loro concepto che li Venetiani fossenno persone bone et juste
et dabene, avendo il favore di questi miseri contadini. Tamen cum veritade questa hera
la cauxa di questa sublevatione rustica in favore veneto, perché li citadini de tute le
citade dela terraferma heranno contrarii et inimici del nome venetto et, essendo li
citadini et vilani contrari sempre l’uno a l’altro, per questo rispecto li contadini
heranno favorevoli al nome veneto…”.132
3. Una struttura prettamente aristocratica
Quando, riconquistata definitivamente tutta la terraferma ad eccezione di Cremona, e
firmata la pace col trattato di Noyon133 (Agosto 1516), Venezia gradualmente ripristinò
la normalità amministrativa, rimettendo in funzione i Consigli e le magistrature delle
città suddite, tuttavia due furono i problemi principali che le si posero innanzi. Dopo
l’amara esperienza del 1509, a nessuno sfuggiva quanto fosse pericoloso reintegrare nei
suoi primitivi poteri e privilegi quel ceto dirigente “cittadino”, che nella sua grande
maggioranza si era manifestato ostile alla Dominante. Bisognava poi non deludere
troppo bruscamente i ceti popolari, i quali, identificando il loro spirito anti-aristocratico
con la fedeltà alla Repubblica e accomunando così le sorti alla causa di essa, avevano
acquistato non lievi benemerenze, ed in alcune città erano riusciti per tale via ad
impadronirsi di modeste ma non trascurabili posizioni di potere.
132
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp.167-185.
133
Il trattato di Noyon, venne firmato il 13 agosto 1516 tra Carlo V di Germania e Francesco I di Francia.
Tal accordo mise fine alle battaglie della Lega di Cambrai. Tal trattato venne promosso dal Papa Leone X.
68
La soluzione che Venezia diede a queste problematiche situazioni dimostra ancora che
per il patriziato veneto non si prospettava alcuna alternativa alla struttura aristocratica, e
che la classe dei nobili e “cittadini”, per quanto infida e ribelle, rimaneva pur sempre
l’unica legittima e naturale depositaria del diritto di amministrare le città. La necessità
d’un riassetto interno delle principali città di terraferma si presentò alla Repubblica
alcuni anni più tardi.
Soltanto nella primavera del 1517, infatti, il consiglio dei Dieci provvide con una serie di
decreti a mettere ordine nelle amministrazioni locali, con l’evidente proposito di
assicurare una netta maggioranza agli elementi fedeli. Il problema fu posto all’attenzione
dei Dieci tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile da preoccupanti segni
d’inquietudine che venivano dalle città di terraferma.
Il caso di Padova era estremamente inquietante. Le vicissitudini storiche avevano voluto
che in uno dei centri principali, il più importante per la difesa della terraferma,
dominasse la nobiltà più ostile a Venezia, da ciò era discesa la particolare veemenza e
tenacia della rivolta del 1509, cui Venezia aveva risposto con la repressione più aspra e
spietata, giustiziando illustri cittadini padovani e confiscando senza troppi rispetti i beni
dei ribelli. Nei rapporti con Padova, la Repubblica dovrà usare sino alla sua fine la mano
pesante134: “questi nobili [padovani] dunque, sono di genio altero e superbo: per
reggerli, et umiliarli, vi vuole la sferza”135.
Anche la soluzione transitoria, decisa l’8 marzo 1516 dal Consiglio dei Dieci, dimostra
che Venezia avvertiva l’esigenza di assicurare al governo della città una base più larga
del vecchio ceto dirigente, ancora incapace di riprendere il Comune nelle proprie mani
senza grave turbamento della quiete interna, tanto più necessaria mentre l’esercito
imperiale dilagava nuovamente nel Veneto e nella Lombardia.
Se Venezia non pensava neppure ad un’eventuale alterazione della struttura gerarchica e
aristocratica delle amministrazioni cittadine, era tuttavia ben disposta a iniziare un
radicale rinnovamento del ceto dirigente, laddove per motivi di sicurezza dello stato
fosse richiesto. È questo il caso di Verona, dove la nobiltà, ricca ed influente e perciò
temibile, aveva manifestato un’aperta e irriducibile avversione alla Repubblica. Il
governo veneto voleva soltanto operare un ampio ricambio nella classe dirigente, non già
134
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 244-247.
135
Marini Pompeo, ricordi politici, cit., cc. 37 v.-39 r.
69
porre il Consiglio cittadino su una base democratica. I veneziani non erano però disposti
a prestare ascolto alle ragioni di coloro che essi stessi di proposito avevano voluto
esautorare: opposizioni “frivole” le qualificò il provveditore generale Zuan Paolo
Gradenigo136, esortando i rettori a non tener conto, perché i nobili veronesi era bene
“tenerli bassi”. Il consiglio dei Dieci decise di respingere ogni protesta, incaricando i
rettori di persuadere con fermezza i dimissionare a recedere, “non acceptando modo
aliquo alcuna sua excusatione ne refundason”.
Col passare del tempo però la forza della ricchezza, del prestigio sociale e della
tradizione finirà per prevalere, rimettendo il Comune nelle mani del vecchio ceto
dirigente, del resto già largamente rappresentato nel Consiglio del 1517.137
4. La venalità per necessità
All’indomani della disfatta di Agnadello, Venezia visse il suo periodo di maggior crisi
nel campo del costume, della religione, della coscienza pubblica, dell’economia e delle
finanze. In questo momento avvenne un mutamento nel piano del funzionamento della
macchina statale, ciò fu imposto dalla situazione di emergenza ma anche dal senso
religioso della politica.
Tutto ciò portò i patrizi veneziani a decidere di vendere delle cariche per sopperire alle
necessità. Il primo caso avvenne l’8 marzo 1510, a causa dei “termeni in liqual se
attrova el stato nostro”, che “sono de sorte che ad la conservation et augumento de
quello è necessario come a cadauno è noto ritrovar bona summa de danari”, si
aggiungeva che tal raccolta di denaro doveva avvenire “cum minor angaria et graveca
de i Zentilhomeni et citadini nostri che possibel sia: ma è iusto et honesto che la
signoria nostra se adiutj del suo”.
Ad essere vendute non potevano esserle le maggiori cariche, ma lo erano tutte cariche
ed uffici d’importanza secondaria.
L’assegnare determinate cariche, previo pagamento di denaro, finì col perdersi nello
stesso anno 1510, nel generale tentativo di prelevare denaro mediante ogni mezzo.
136
Gradenigo Zuan Paolo, italianizzato Gian Paolo, nacque a Venezia, nel sestiere di San Marco, nel 1456.
Persona coraggiosa e infaticabile fu nominato comandante degli stradiotti che operavano contro i
Francesi in Piemonte.
137
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 255-261.
70
Anche in questa situazione furono gli ebrei ad esserne le vittime, in quanto il 19 aprile
venne emanata una norma la quale stabiliva che la comunità ebraica doveva pagare
cinquemila ducati, a cui se ne aggiunsero altri ottocento cinquanta in quanto gestori dei
banchi di Padova, inoltre in data 23 settembre si invitava gli ebrei a estinguere i loro
debiti col fisco entro la prima settimana di ottobre, chi non l’avesse fatto sarebbe stato
multato con un sovrappiù del dieci per cento.138
È chiaro come il proseguirsi della guerra anche per l’anno 1510 metteva alla luce lo
sforzo di mutamento legislativo e amministrativo della dominante. L’attenzione si
spostò dai rapporti sociali al funzionamento delle istituzioni, alla flessibilità di
affrontare situazioni di emergenza.
Vendita delle cariche a Venezia che si dimostrò essere non l’acquisto effettivo di una
magistratura, ma il porsi come candidato per il futuro ballottaggio, ecco che non era
l’ufficio direttamente ad essere venduto, ma il desiderio di ottenerlo. Il fine era di
raccogliere più fondi possibili vista la situazione di guerra e di bisogno. Nel settembre
era stabilito che:
“tutti quelli zenthiloeni che vorano depositar ducati 100, havendo compito anni 18
possano andar a Consejo”.
La venalità sembrò arrestarsi in seguito alla riconquista di Verona, avvenuta nei primi
mesi del 1517. Vediamo quindi come la macchina veneziana non s’inceppava mai, si
adattava agli avvenimenti esterni, notiamo anche come i provvedimenti legislativi non
erano così stravolgenti da mutare il complesso delle istituzioni ed il costume politico,
per quei valori tradizionali, morali e religiosi, che esso rappresentava.139
Tra i vari provvedimenti uno in particolare colpiva il broglio140, si sospettavano e si
punivano coloro che, nel periodo delle elezioni in Pregadi o in Maggior Consiglio,
s’incontravano tra le scale del palazzo, o nelle sale, e venivano sospettati di combutta
per presunte raccomandazioni.
138
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 432-433.
139
Ivi, pp. 439-443.
140
Broglio è un’attuale espressione italiana derivante dal termine veneziano Brolo. Fu consuetudine dei
membri nella nobiltà impoverita quello di riunirsi in uno spazio antistante al Palazzo Ducale di Venezia
per commerciare i propri voti. Tal luogo di ritrovo portava il come di Brolo o Brolio, dal latino Brolus, cioè
“orto”. Veniva così chiamato perché dove si trova ora piazza San Marco prima si trovava l’orto del
monastero di San Zaccaria.
71
Nel 1526 il governo, tramite le sue emanazioni normative, voleva colpire anche i gesti
che potevano dar la sensazione dell’esistenza di clientelismi o gruppi. I principali gesti
che suscitavano tali dubbi erano il stringersi la mano, abbracciarsi, congratularsi con chi
aveva ricevuto una carica, tutto ciò era considerato indegno per la Repubblica, oggetto
di “incredibel murmuration di cadauno maxime di forestieri”. Dietro a tali leggi c’era
l’effettiva naturale preoccupazione che dietro a tali gestualità si celavano dei reali
brogli. Furono quindi stabilite delle punizioni pecuniarie, di cui la metà andava
all’accusatore e l’altra metà la s’investiva nell’arsenale141.
Nobili dunque, che potevano ambire alle cariche dietro pagamento di denaro e non più
solamente grazie alla virtù. Si voleva però che la carica cui aspiravano rimanesse
comunque pura, incontaminata, “immaculata”, e quindi esente dal broglio. Lo sforzo
legislativo fatto mira proprio a questi fini: da un lato c’erano provvedimenti sui
matrimoni e sui figli, i quali dovevano attestare e dar certificazione sull’esser nobili,
dall’altro c’era l’attività dei censori, il cui compito era salvaguardare la procedura
elettorale.142
Il Consiglio dei Dieci affermava che “cussì chi darà e chi riceverà alcun danaro o altra
cossa per aver officii” venissero entrambi banditi da Venezia “in perpetuo”.
5. Conclusione
Le guerre d’Italia vennero a concludersi con la proclamazione della pace universale, tal
decisione prevedeva la discesa a Roma del papa e di Carlo V, ciò serviva per dar vita
all’incoronazione dell’imperatore. Carlo V venne però incoronato, nel 1530, a Bologna
in quanto il papa non voleva concedere troppi trionfalismi al re dei romani.
La cerimonia si tenne il 24 febbraio 1530 in San Petronio. Carlo V vide così sfumare la
sua ambizione di diventare il traino della riforma della Chiesa europea, e per
compensare ciò il 5 aprile 1536 fece un solenne ingresso a Roma che fece riconoscere
l’imperatore come padrone della Penisola.143
141
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento, Unicopli,
1993, pp. 464-465.
142
Ivi, p. 471.
143
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009, p. 198
72
Con la fine di questa guerra fu riconosciuto a Venezia il suo dominio territoriale, ne
segna tuttavia la fine del dominio veneziano in Puglia, ciò non era cosa insignificante in
quanto solo due anni prima le città di Brindisi, Monopoli, Gallipoli, Polignano, Bari,
Trani e Lecce si erano aggiunte ai domini veneziani, diventando così guardie alla porta
del Golfo.
Dal 1535 notiamo come muta l’obiettivo della politica veneziana, il cui unico obiettivo
diventa contrastare la presenza spagnola in penisola. Ciò ci fa comprendere come il
Leone di San Marco aveva ancora la forza e la capacità di ruggire. Come disse Alvise
Zorzi, tal obiettivo ci fa comprendere parte della tradizionale concezione politica
veneziana, dove libertà significa innanzitutto indipendenza.144
144
Zorzi Alvise, La repubblica del leone, storia di Venezia, Bompiani, 2001, pp. 309-310.
73
BIBLIOGRAFIA
Besta Enrico, Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, F. Visentini,
Venezia, 1900
Braudel Fernand, Venezia, Il Mulino, 2013
Cavallin Gianfranco, Gli Ultimi Veneti, Zephyrus, 2009
Cervelli Innocenzo, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Guida editori, 1974
Cozzi Gaetano, Stato società e giustizia nella Repubblica veneta, Jouvence, 1985
Moro Federico, Venezia in guerra, Studio LT2, 2011
Pellegrini Marco, Le guerre d’Italia (1494 – 1530), Il Mulino, Bologna, 2009
Rosini Giovanni, Storia d’Italia di Francesco Guicciardini vol II, cugini Pomba e comp. Editori,
Torino, 1853
Ventura Angelo, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e del Cinquecento,
Unicopli, 1993
Vilari Pasquale, Dispacci di Antonio Giustinian, vol I, Le Monnier, Firenze, 1876
Zorzi Alvise, La repubblica del leone, storia di Venezia, Bompiani, 2001
74