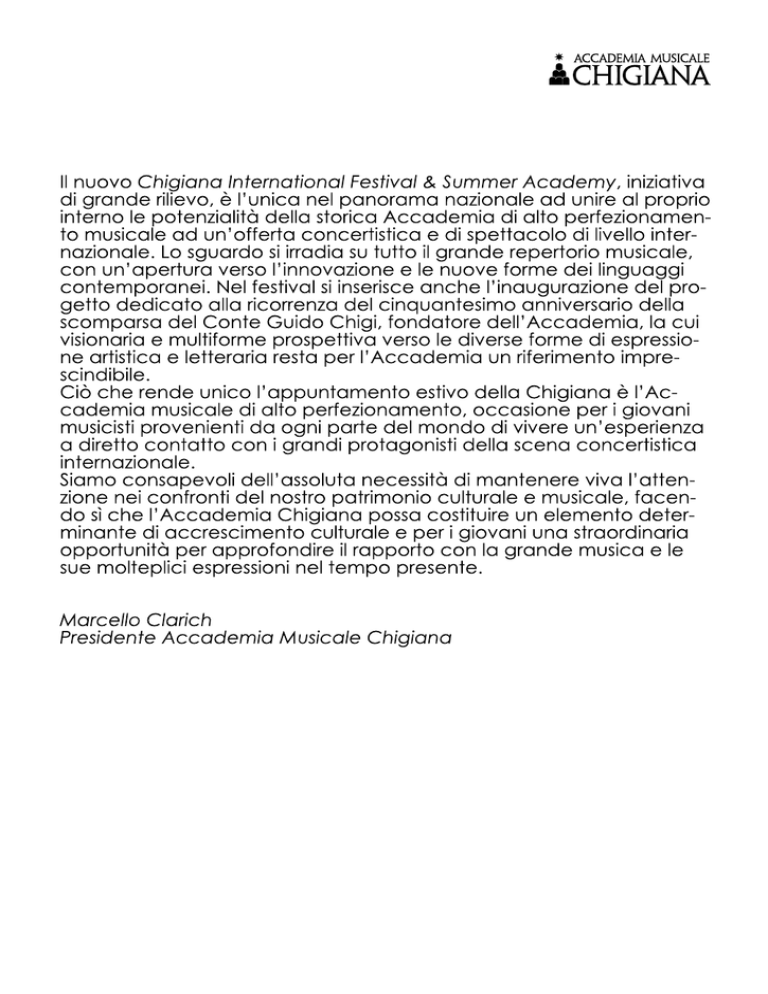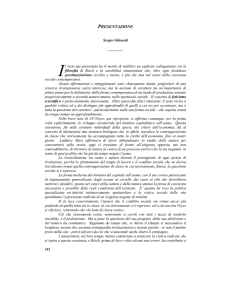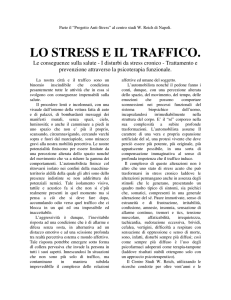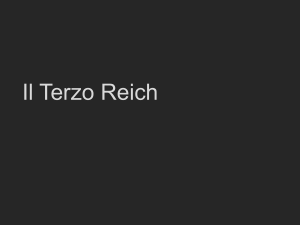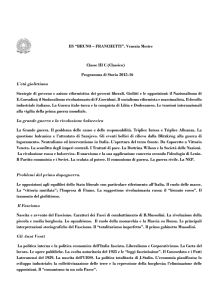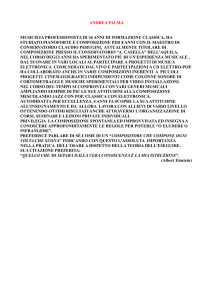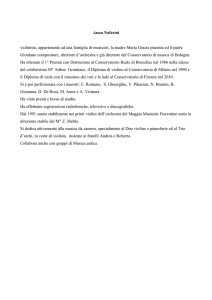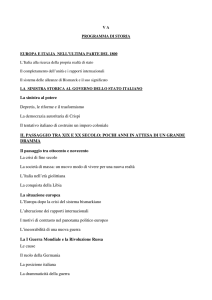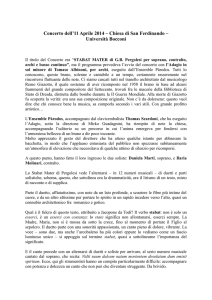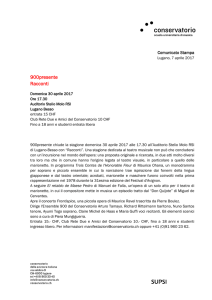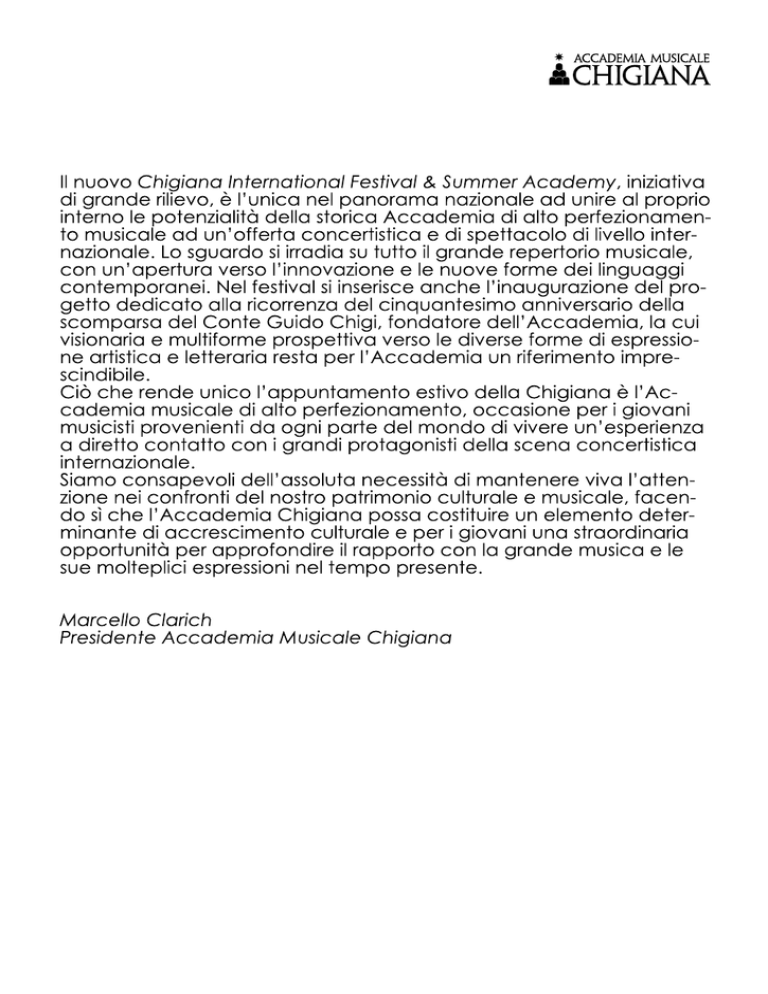
MARTEDÌ 4 AGOSTO
PIAZZA PROVENZANO
ORE 21.15
Steve Reich
New York 1936
Drumming
per quattro coppie di bongos accordati, tre marimbe, tre
glockenspiel, soprano, contralto, ottavino e fischio
Parte I
per quattro coppie di bongos accordati
Parte II
per tre marimbe, soprano, contralto, ottavino
Parte III
per tre glockenspiel, soprano, contralto, ottavino
Parte IV
per quattro coppie di bongos accordati, tre marimbe, tre
glockenspiel, soprano, contralto, ottavino, fischio
Antonio Caggiano
percussioni e direttore
Silvia Lee
soprano
Chiara Tavolieri
contralto
Pierluigi Tabachin
ottavino
Chigiana Percussion Ensemble
Irene Bianco *
Simone Buttà *
Federico Ciammaruconi *
Giulio Centoni *
Fabio Macchia *
Luca Paolucci *
Matteo Rossi *
Filippo Sinibaldi *
* del corso di Percussioni di Antonio Caggiano
DRUMMING DI STEVE REICH. DAL CORPO ALLA CARTA
(E RITORNO?)
GIORDANO MONTECCHI
Abbiamo tutti ben presente l’intramontabile e controversa questione
della ‘incomunicabilità’ fra musica e linguaggio verbale: per gli uni
non esistono parole adeguate ad esprimere il senso musicale, mentre
per altri la musica è una sorgente inesauribile di immagini e significati
disinvoltamente verbalizzabili.
In realtà i partiti che si fronteggiano su questo terreno non sono
due, ma una miriade. Certamente però, in musica, ci sono parole
portatrici di una loro specialissima inadeguatezza, e tali da essere
quasi sistematicamente respinte al mittente da parte dei compositori
o musicisti che se le vedono assegnare. Sono gli ‘ismi’, parole come
impressionismo, neoclassicismo, minimalismo, eccetera. Parole che
vengono respinte spessissimo a ragione, poiché quell’etichetta di
comodo funziona molte volte come un machete, che riduce momenti,
autori, opere straordinariamente ricchi e sfuggenti, proprio per la
ricchezza e complessità delle loro intime contraddizioni, a moncherini
asettici e insignificanti. È il caso della musica cosiddetta minimalista, di cui Steve Reich viene
considerato l’esponente più illustre, e nel cui repertorio il poderoso
Drumming spicca come uno dei vertici. Controversa l’etichetta, minimal, applicata a musiche spesso pullulanti
di suoni e di esecutori, e spesso abnormi per lunghezza e dimensione.
Ma controversa anche la cosa in sé, cioè la musica così definita,
impostasi con prepotenza da protagonista sulla scena musicale
americana e anglosassone dei tardi anni Sessanta. Il successo della minimal music combacia con l’epoca in cui le
avanguardie andavano attrezzandosi per celebrare la propria fine, a
fronte di una nuova ondata, dal basso come dall’alto, culturalmente
polimorfa e contraddittoria come non mai (Sessantotto, rock music,
post-modern e, appunto, minimal, in arte come in musica).
E così, nell’opinione corrente, ecco la minimal music di Steve Reich,
Philip Glass, Terry Riley eletta a icona stessa della musica postmoderna.
Musica che, nonostante l’appellativo, a fatica si riesce a ricondurre
nel concetto di ‘minimalismo’. Un concetto che, insieme al carattere
postmodern, si addice semmai molto di più alla musica di John Cage
che a quella di Reich e compagni.
Nato attorno al 1965 dalla penna del filosofo Richard Wollheim, per
definire opere in cui l’intervento dell’artista, nonché la distanza dagli
oggetti della vita quotidiana, erano ridotti al minimo (al limite fino a
scomparire del tutto), in musica il termine ‘minimalismo’ ha acquisito
un senso assai diverso per indicare una prassi compositiva incentrata
sul trattamento di elementi minimi, cellule sonore di estrema semplicità,
sottoposte a un trattamento di elaborazione e variazione per minimi
passaggi, molto dilatati nel tempo e immediatamente coglibili
all’ascolto.
Si tratta di una concezione in origine squisitamente e radicalmente
sperimentale – dunque nuovamente d’avanguardia – che in effetti
faceva tabula rasa di molti assunti teorici dell’arte compositiva antica e
moderna, in modi forse più radicali dello stesso strutturalismo di Darmstadt.
Ma rispetto a Darmstadt e dintorni la minimal music aveva una
caratteristica assolutamente spiazzante e paradossalmente
scandalosa: piaceva a molti, a troppi. Non ultimo per il fatto che in
essa si ripristinavano quasi immancabilmente un centro tonale, un
diatonismo consonante, una pulsazione regolare, ossia tutto ciò che
la neue Musik del Novecento aveva tolto di mezzo come intollerabili
detriti passatisti.
Da qui le polemiche a non finire, col minimalismo finito sul banco degli
imputati con l’accusa di essere musica furbesca, emblema di uno
scaltrito disimpegno che secondo molta critica modernista caratterizza
il postmodern nel suo complesso.
Drumming di Steve Reich offre un magnifico, impo- nente paradigma
di tutte queste tematiche.
In questa composizione del 1971 la cui durata, a seconda delle scelte
degli esecutori, può oscillare fra i 60 e i 90 minuti, confluiscono gran
parte dei motivi e degli interessi di Steve Reich che in quegli anni
chiarifica concettualmente nei suoi scritti e concretizza nelle sue
composizioni molti dei temi chiave della minimal music o, come altri
(Ivanka Stoïanova ad esempio in un suo celebre saggio) preferivano
denominarla, «musica ripetitiva».
Forse – ma il termine era troppo poco friendly perché attecchisse nel
linguaggio comune – si sarebbe dovuto chiamarla process music,
poiché di questo si trattava essenzialmente. In Music as a Gradual
Process (1968) proprio di questo parla Reich: l’idea di una musica che
non racchiudesse ‘esotericamente’ complesse procedure costruttive e
di sviluppo il più delle volte assai ardue da decifrare, ma che fosse essa
stessa un processo assolutamente trasparente, i cui mutamenti, le cui
fasi si susseguissero per gradi, in modo del tutto coglibile all’ascolto.
La prima delle quattro parti che costituiscono Drumming si apre
con una figura che è un’esemplificazione di assoluta, archetipica
essenzialità: una singola nota La# eseguita all’unisono da due, tre o
quattro percussionisti su un tamburo intonato e ripetuta con pulsazione
costante per un certo numero di volte (la partitura lascia agli esecutori
la possibilità di scegliere fra un numero minimo e massimo di ripetizioni di
questa prima battuta). A un certo punto (batt. 2) uno dei percussionisti
introduce una seconda nota, un Si. Gli altri seguono a piacimento,
fin quando entra una terza nota, e così via, fino al completamento
di una formula ritmico-melodica (batt. 8) che costituisce il pattern
fondamentale su cui si basa l’intera composizione. Drumming si snoda
infatti con un metro costante e invariabile articolato entro una misura di
12 crome (la partitura pubblicata nel 1971 non reca un’esplicita indicazione
metrica, mentre la revisione del 2011 riporta l’indicazione 3/2:6/4).
In tema di essenzialità, croma e pausa di croma sono le uniche
figure di valore presenti in partitura. Altrettanto scarna e inflessibile
è l’organizzazione delle altezze: sei diesis in chiave e sempre quelle
sette note dall’inizio alla fine, in un quadro di diatonismo integrale
che non ammette nessuna alterazione, se non un Si# introdotto da un
glockenspiel nella 3a sezione.
Le quattro parti della composizione sono affidate a organici
nettamente differenziati, quasi a compensare con una particolare
ricchezza coloristica l’uniformità della pulsazione che attraversa tutte
e quattro le sezioni. La prima parte è per 4 coppie di bongos intonati,
rimpiazzati a tratti da due voci maschili che ne imitano le sonorità; la
seconda è per 3 marimbe e, analogamente, due voci femminili. La
terza parte è scritta per 3 glockenspiel, fischio e ottavino, mentre la
quarta schiera l’organico al completo.
Le diverse sezioni si susseguono senza interruzioni e, anzi, si
insinuano gradualmente una nell’altra, con una sorta di raffinato
Klangfarbenrhythmus, cioè un ritmo timbricamente cangiante,
ottenuto mediante un progressivo avvicendarsi degli strumenti in
dissolvenza, grazie anche a un’accurata alternanza di bacchette dure
e morbide.
Il respiro formale della composizione, nella piccola come nella grande
dimensione, è la risultante di alcuni procedimenti combinati fra loro, in
parte originali, in parte derivati da antiche tradizioni.
Il primo elemento è il virtuosistico interlocking degli esecutori:
un’incalzante coreografia di braccia e bacchette impegnate a
disegnare una vorticosa trama a hoquetus, risultante dall’embricarsi di
suoni e silenzi intercalati nelle varie voci (si veda sotto la figurazione di
batt. 10). Altro fattore fondamentale è l’alternarsi di fasi di progressivo
addensamento, nelle quali le pause vengono gradualmente sostituite
da suoni (come in apertura), a fasi di progressiva rarefazione, in cui, al
contrario, sono i silenzi a zittire via via i suoni.
Agli esecutori è affidato inoltre il compito di far emergere dalla trama
formicolante, dei profili caratteristici, dei patterns risultanti che per un
certo periodo di tempo possano imporsi all’ascolto, per essere poi
via via modificati attraverso procedimenti principali di trasformazione
quali l’introduzione di un nuovo pattern in sovrapposizione ad altri, la
graduale modifica di un contorno melodico mediante la sostituzione
di una nota con una nota diversa, oppure la sostituzione di una
nota con una pausa, o viceversa. A ciò si aggiunge quell’originale
artificio compositivo denominato da Reich phase-shifting o più
semplicemente phasing. In italiano lo si può tradurre come ‘slittamento
di fase’ o ‘sfasatura’, ma spesso, con un tecnicismo greve quanto
linguisticamente improbabile, viene reso con il termine ‘defasaggio’.
Il phasing non è altro che un controllatissimo ‘andare fuori tempo’ in
modo da sfasare con precisione millimetrica l’esecuzione di due parti,
le quali, ad esempio, dall’unisono si ritrovano per così dire in controfase,
dando quindi origine a un nuovo pattern melodico-ritmico.
Il primo episodio di phasing ha luogo a battuta 9. Allorché la figura
definitasi a battuta 8 (vedi sopra) è divenuta familiare all’ascoltatore
attraverso una ripetizione protratta, uno dei due esecutori accelera
leggermente il proprio metro, cioè va letteralmente fuori tempo, facendo
in modo, nell’arco di 20-30 secondi di spostarsi in avanti di 1/4 esatto.
Al termine di questo calibratissimo ‘caos’ temporaneo, a batt. 10,
viene ripristinato il sincronismo della pulsazione, ma come si può
vedere, il pattern che adesso ne risulta si presenta come un hoquetus
di effetto sensibilmente diverso rispetto alla figura di batt. 8.
Nel corso del suo svolgimento, Drumming tocca momenti di
complessità polifonica e poliritmica ben maggiori rispetto a
queste esemplificazioni, specie nei momenti che impegnano
tutti e nove i percussionisti previsti. Ma i congegni base che
presiedono alle progressive metamorfosi dell’organismo sonoro sono
fondamentalmente questi.
Il grande interrogativo, ma anche l’aspetto forse più spiazzante di una
composizione così organizzata è la sua capacità di coinvolgere o
meno l’ascoltatore nell’arco di una lunga durata.
La trasparenza, questa glasnost musicale elevata a principio
fondamen-tale, secondo alcuni banalizza, distrugge o riduce al
minimo (appunto) quel margine, quell’aura di mistero o di ambiguità
polisemica connaturata alla dimensione estetica. Ma la questione è
assai più complessa.
A parte certi preconcetti di ordine estetico-teorico che spesso
inquinano i discorsi inerenti questo tipo di musica, in realtà il flusso di
informazioni generato da questa sorta di perpetuum mobile deve
molto, anzi moltissimo all’intelligenza e alla sensibilità del compositore
nel dosare sapientemente la quantità e la qualità dei mutamenti.
L’arte del catturare o il rischio dell’annoiare sono separati da un
confine molto labile, ma è proprio lì che si gioca tutto.
Naturalmente – e anche se lo collochiamo in chiusura non è affatto
un argomento secondario – per Reich, come per altri suoi compagni
di viaggio, fondamentali nella concezione di brani come questo
sono lo studio e l’assimilazione di strutture poliritmiche e polifoniche
parzialmente analoghe, tipiche delle musiche tradizionali, in
particolare africane e asiatiche: dalle polifonie dei pigmei, al gamelan
indonesiano, alle danze delle comunità Ewe del Ghana dove Reich
aveva sog-giornato nel 1970, poco prima di mettersi al lavoro su
Drumming.
Le formule poliritmiche, le strutture a hoquetus, la tecnica delle varianti
formulaiche che caratterizzano le danze ewe sono tratti rintracciabili
in Drumming come in molte altre composizioni di Reich. Per contro,
sarebbe vano cercare in quelle danze qualcosa di simile alla tecnica
del phasing. Al di sopra delle affinità, infatti, fra la musica da concerto
di un compositore occidentale innamorato delle musiche tradizionali e
la loro originaria fonte di ispirazione resta una profonda distanza, non
solo geografica o antropologica, ma tecnologica: la distanza che
corre fra la cultura dell’oralità e la forma mentis del segno scritto.
Là la musica nasce dal corpo, che da generazioni e generazioni
plasma e guida la ragnatela dei ritmi, anche i più complessi. Qui la
musica nasce invece a tavolino, come progetto, rielaborazione o
ricreazione analitica di codici e stilemi estrapolati dal loro contesto
d’origine.
È una tecnologia legittima, affascinante, rivolta al progresso (e non
certo alle nostalgie); ma i cui risultati sono inevitabilmente altro rispetto
ai modelli ispiratori.
Certo, nella soggiogante iterazione di Drumming, come in molta
musica di questo genere, affiorano spesso echi, reminiscenze di una
natura sonora remota, forse edenica. E come sempre la risposta a
questa musica da parte di chi ascolta si posiziona nello spazio che
va dall’abbandono estatico alla consapevolezza straniante. Ci
soccorre qui una frase indimenticata di Curt Sachs: «ad ogni progresso
corrisponde una perdita».
ANTONIO CAGGIANO
Formatosi come percussionista al Conservatorio dell’Aquila e come
compositore al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, nel 1987 dà vita
con Gianluca Ruggeri all’Ensemble Ars Ludi con cui partecipa a importanti
festival e rassegne nazionali e internazionali, intrecciando rapporti di
collaborazione con alcuni fra i maggiori compositori contemporanei. Attivo
per molti anni nelle maggiori istituzioni lirico-sinfoniche italiane, dal 1998 al
2003 è stato timpanista dell’O.C.I. diretta da Salvatore Accardo. Nella sua
esperienza di professore d’orchestra ha collaborato con importanti direttori
quali Bernstein, Sinopoli, Chailly, Maazel, Gatti, Morricone, Sawallisch, Chung,
Mehta, Frühbeck De Burgos, etc.
Lavora in qualità di solista con diversi gruppi da camera ed è docente di
strumenti a percussione presso il Conservatorio di Frosinone. Si interessa da
sempre alla commistione di linguaggi artistici diversi. Scrive musiche per il
teatro, la danza e collabora con artisti visivi.
Ha tenuto corsi di interpretazione sulla letteratura per strumenti a
percussione al Cantiere Internazionale d’arte di Montepulciano, seminari
alla Sibelius Academy di Helsinki e stages in varie parti del mondo.
SILVIA LEE
Il soprano Silvia Lee si è laureata all’Università Nazionale di Seoul e ha
proseguito gli studi presso il Conservatorio di Musica Refice di Frosinone con
Danilo Serraiocco. Attualmente si sta perfezionando con il mezzosoprano
Bruna Baglioni.
Debutta giovanissima il ruolo di Bastienne (Bastien und Bastienne, Mozart) a
Seoul, dove ha anche interpretato Gilda in Rigoletto di Verdi, Barbarina in Le
Nozze di Figaro di Mozart e Despina in Così fan tutte di Mozart, ruolo con cui
ha debuttato in Italia.
CHIARA TAVOLIERI
Inizia gli studi musicali presso il Saint Louis College of Music con Nicky Nicolai,
Maria Grazia Fontana, Marco Siniscalco, Emilio Merone, Antonio Solimene,
Gianfranco Gullotto, Pierpaolo Principato. In seguito affina la tecnica
vocale con Raffaella Misiti, Antonio Juvarra, Tommaso Monaco. Lavora
come corista in diversi show televisivi e radiofonici quali: Domenica In, I
raccomandati, Il Tappeto Volante, Il ruggito del coniglio.
In seguito si dedica al solismo e all’insegnamento, attività già avviata dal
2004. Collabora con gli Ypsos, Primiano De Biase, Susanna Stivali, Manuela
Pasqui, DejaVoice e con l’orchestra di percussioni di Antonio Caggiano
con il quale mette in scena Drumming di Steve Reich. Incide in studio per
Damiano La Rocca (Le Mezze Stagioni 2011), Lello Arena (La festa delle
donne, 2005), Roberto Giglio (La Quinta Stagione, 2006), Stefano Scatozza
(2013), Elvio Monti (Inno di Mameli, 2006).
PIERLUIGI TABACHIN
Pierluigi Tabachin si è diplomato al conservatorio di Padova con Marianne
Fischer, arricchendo inoltre la sua formazione con, tra gli altri, Raymond
Guiot e André Jaunet.
Come solista e in diverse formazioni cameristiche ha tenuto concerti per
importanti festival e istituzioni di Europa e Stati Uniti.
Appassionato di musica antica, da diversi anni si dedica all’esecuzione
del repertorio barocco e classico con strumenti originali, collaborando tra
gli altri con orchestre quali La Stagione Armonica di Sergio Balestracci e Il
Complesso Barocco di Alan Curtis.
Compare in diversi cd che vanno dal repertorio con strumenti antichi alle
composizioni di autori contemporanei. È titolare della cattedra di flauto al
Conservatorio Refice di Frosinone.