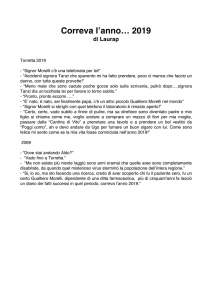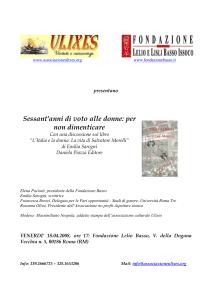6 — per Giovanni Morelli
Giovanni Morelli e
la Fondazione
di Venezia
Q
per Giovanni Morelli
uando poco si conosce di una persona eccellen-
te, molto giocano i propri ricordi nel costruire
per sé quanto gli altri hanno avuto la fortuna di
sperimentare direttamente nella dimestichezza
dei colloqui e nelle aule della didattica. Giovanni Morelli mi era collega a Ca’ Foscari, ma là non lo avevo conosciuto. Vi era arrivato più o meno quando io me ne andavo
verso La Sapienza a Roma e vi divenne professore ordinario proprio quando io vi tornavo dopo quattordici anni di
assenza. Ma eravamo in tanti e le occasioni generali di incontro erano poche. Forse solo la vicinanza disciplinare
avrebbe potuto aiutare, ma in questo eravamo tanto lontani. O almeno io lo credevo: musicologia e finanza pubblica sembrano (o sembravano a me) temi epistemologici
assai distanti fra loro.
Poi fuori dall’Università, nei vaporetti che recentemente
ci portavano entrambi alla Giudecca, ho iniziato un colloquio vero con Giovanni e
lui subito mi ha spiegato che
il mio impaccio verso i suoi
temi e la sua incertezza verso i miei erano solo aspetti tecnici del maneggio della conoscenza. Nella musica – nella produzione della
musica, non solo nella diffusione – contavano molto
per lui gli aspetti economici
e io a mia volta non mi trincerassi dietro affermazioni banali come «non la capisco la musica» perché in essa
vi sono metodologie formali certamente non incomprensibili, se solo si vogliono percepire; e poi la musica si capisce – diceva – sentendola! Ed io per ascoltarlo
saltavo la mia fermata per scendere dal vaporetto alla sua,
tornando poi indietro a piedi.
Così iniziando ad occuparmi, nel solo tentativo di rinforzarne il conto economico, di questa iniziativa editoriale
della Fondazione di Venezia, intitolata alla «Musica e dintorni» (che oggi si avvia a compiere sette anni), ho di nuovo incontrato Giovanni nel gruppo dei Garanti che ho
chiamato a validare l’assetto scientifico della rivista, e di
nuovo ne ho scoperto un altro aspetto: una ulteriore grande competenza sui «dintorni». Ne sapeva di economia, eccome; il paesaggio musicale era il suo tema per la lettura
della società contemporanea e se ne intendeva di palinsesti per i diritti e fuori diritti, del gioco dei copyright, della solitaria musica della camera da letto, dei supporti tecnologici, delle reti radiofoniche, della musica per il cinema
e – con mia grande confusione – della musica ascendente del cinema. Il titolo del suo ultimo libro che mi regalò
ad aprile con amicizia, Prima la musica poi il cinema, assuonava per me il celebre interrogativo dell’abate Giovanni Ca-
sti con cui Richard Strauss apre il suo Capriccio e così il cerchio epistemologico si chiudeva nella configurazione totalizzante della musica come infrastruttura culturale della
vita umana. Tanto quanto l’economia, scienza (forse) assai
più giovane e così pervasiva della quotidianità.
Ora scenderò dal vaporetto alla fermata giusta, ricordando l’insegnamento che pure in età matura si può avere da
chi sa. ◼
Giuliano Segre
Direttore editoriale
Per Giovanni Morelli
L
a cura di Leonardo Mello e Ilaria Pellanda
Giovanni Morelli ci
ha lasciati increduli. Con lui, da quando più di un
anno fa era stato istituito il Comitato dei Garanti
di VeneziaMusica e dintorni, i rapporti si erano infittiti,
e negli ultimi tempi, in alcuni incontri presso il suo studio a Palazzo Malcanton Marcorà, stavamo predisponena notizia della morte di
do una serie di approfondimenti cui dedicare spazio ed
energie nel prossimo futuro, a cominciare dal soundscape,
una delle tematiche da lui più volte messa in evidenza, assieme a tutto quanto riguardasse la produzione musicale
giovanile, tra i suoi fuochi d’interesse più accesi.
I rapporti con noi della rivista erano improntati a
una cordialità affettuosa ma senza fronzoli, badando
sempre al sodo. E nel momento di costruire il numero di settembre la sua assenza si è fatta stridente e ha
aumentato la tristezza dei primi giorni, vestendola di
un grande senso di mancanza e spaesamento. Per reagire concretamente a questo stato d’animo, abbiamo
preso d’impulso due decisioni per noi importanti. La
prima, di ampio respiro, è quella di continuare a occuGiovanni Morelli, Venezia, 2011.
Tutte le immagini (salvo diversa indicazione)
ci sono state gentilmente messe a disposizione
da Margot Galante Garrone.
per Giovanni Morelli — 7
Cats
A
di Margot Galante Garrone
Giovanni, subito dopo la guerra, avevano regalato un gattino di nome Roberto, poi sparito misteriosamente, tanto che, a distanza di 18 anni, ed
esattamente nel 1964, quando ci conoscemmo, Giovanni
ne lamentava ancora la mancanza.
Io, invece, allevata nel culto di Raiberti, a sette anni avevo imposto ai miei genitori un gattino trovato sulla tomba di famiglia, a Vercelli. Che poi sparì, non troppo misteriosamente (ero una bambina sospettosa).
Quando, nel 1964, iniziò, con la nostra, la storia parallela dei nostri gatti, due fratellini siamesi di tre mesi, Hänsel e Gretel (così li chiamammo, per onorare i nostri due
nomi) vennero a vivere con noi a Porretta Terme, nella
Con Silvius, 1994.
grande villa di un dentista compiacente.
E poi, Venezia. Campo Bandiera e Moro.
Un quarto piano pieno di luce.
La prima gattina che mi portò Giovanni con il caffè
della mattina (per 47 anni mi portò il caffè a letto) fu
chiamata Palida, con una elle sola. Trovata assiderata in
Campo. Avevamo anche due diamanti mandarini in una
gabbietta celeste. Andrea un giorno arrivò a tavola con la
testa di uno degli uccellini in mano. La gatta aveva aperto la gabbietta. Ai miei pianti disperati rispose: «Diamolo alla Palida, tanto ormai è morto».
Era un bambino epicureo.
Infine, e per sempre, la Giudecca.
1968. Con la Palida e uno dei suoi figli, Pipo.
La Corte Mosto, allora, era brulla e sterrata. I due gatti
correvano, scavavano buche, si rotolavano…
Erano da due anni arrivati in città, a Castello, Barbara
e Tom Walker. Non ci parve vero di affidare ai due amici
un’altra figlia della Palida, una sorianella tigrata (i soriani
si distinguono in tigrati e maccarelli: questi ultimi erano
i preferiti di Giovanni).
per Giovanni Morelli
parci delle questioni da lui sollevate: dal citato paesaggio sonoro alle pratiche compositive sommerse, dall’uso di tecnologie avanzate nella formazione musicale alle «polifonie viventi», per citare soltanto alcuni argomenti già messi in un’ideale scaletta con Morelli e affrontati pubblicamente nell’ultimo convegno da lui voluto e organizzato, quell’«Over Zero» di cui abbiamo
offerto una cronaca nel numero precedente (cfr. vmed
n. 41, pp. 34-35). In questo modo, restando incolmabile il vuoto, ci sembrerà almeno di continuare, nel nostro piccolo, il percorso iniziato con lui.
La seconda decisione si realizza in queste pagine, che
dedicano un omaggio corale alla sua figura. Pur consapevoli che probabilmente non gli avrebbe fatto molto
piacere essere al centro di tante parole, data la grandezza della sua figura (intellettuale e umana) ci è sembrato
tuttavia necessario riunire subito, a pochissima distanza dalla sua scomparsa (e pur in un periodo dell’anno
infausto e problematico come il mese di agosto), alcuni
contributi che potessero, almeno in parte, raccontarla
nelle sue moltissime sfaccettature. Partendo da queste
premesse abbiamo costruito – grazie all’aiuto di Margot Galante Garrone e Andrea Liberovici e ai fondamentali suggerimenti di Mario Messinis, Michele Girardi e Paolo Pinamonti – una lista di colleghi, allievi, amici ed estimatori della sua opera, iniziando ovviamente dalle istituzioni cittadine con le quali collaborava assiduamente. In brevissimo tempo – un miracolo che soltanto Morelli poteva compiere – abbiamo
ricevuto un numero di adesioni (e conseguentemente
di interventi) che sorpassa di gran lunga ogni precedente previsione. Al nostro invito – volutamente libero sia nell’approccio che nelle grandezze – ciascuno ha
risposto a proprio modo: chi ricordando aneddoti inediti, chi descrivendo uno dei tanti settori d’intervento
in cui Morelli era attivo, chi mettendone in evidenza la
fama internazionale, chi creando ad hoc brevi saggi su
argomenti musicologici sviluppati insieme a lui... Lungi dall’aver raggiunto l’esaustività, grazie alla passione
e alla commozione di tutti coloro che ci hanno risposto speriamo di aver fornito una panoramica variopinta e poco retorica, che raccoglie riflessioni, ricordi e testimonianze personali invece che vuote formule commemorative. ◼
Quando i Walker ripartirono per le Americhe, affidarono la piccola a un pugile del quartiere, che subito la abbandonò in calle. Naturalmente Giovanni si precipitò a
prenderla e la portò alla Giudecca. La chiamammo «la
Walker».
Presto i gatti divennero nove. Il nostro vicino, il sarto
Tempo, protestava a gran voce: «Masa gati, masa gati».
Noi non ci sapevamo capacitare di questa crudeltà reiteratamente annunciata. Perché ammazzare i gatti? Finché Giovanni un giorno salì le scale dei Tempo e fece una
scenata memorabile, minacciando denunce e ritorsioni
nel caso i gatti fossero morti ammazzati. A nulla valsero
le rassicurazioni dei Tempo sull’equivoco dialettale (masa gati = troppi gatti): da quel momento i gatti vissero in
casa, con qualche rara sortita in giardino, dove intanto
Andrea, libero e creativo bambino sessantottesco, passava le ore a dipingere di giallo le rare foglie di un olean-
8 — per Giovanni Morelli
dro striminzito.
Quando i gatti furono 22, allestimmo in soffitta una
nursery per le tre gatte che dovevano allattare i 19 gattini appena nati. Con vero spirito comunitario, non distinguevano i propri figli da quelli delle altre madri. Lo spirito del ‘68 aveva invaso anche il solaio.
Affidati i gatti svezzati a famiglie «sicure» decidemmo
di tenerne soltanto tre o quattro.
Pipo era un vero macho, le tre gatte rimaste molto disponibili, e i gattini nascevano tutti in bagno, assistiti dalla nostra ormai convalidata abilità ostetrica.
Passarono gli anni.
per Giovanni Morelli
Il giorno che rapirono Aldo Moro, la Mignotta partorì tre gattini sul divano: Giovanni si appropriò subito del più piccolo, un maccarello che battezzò col nome di Frasso. Gli altri due, anch’essi figli di Mignotta, furono chiamati Socialista e Putola. Il Socialista rispondeva soltanto alla domanda: «Sei socialista?» Tutto l’arco costituzionale veniva invocato con domande pressanti da noi e dai parenti in visita. «Sei comunista?» Silenzio. «Sei democristiano?» Silenzio. «Sei fascista?». Silenzio. «Sei Socialista?»
Alla parola «socialista» alzava la testa, ti guardava dritto
negli occhi e lanciava un miagolio di assenso.
Venne poi da Milano Pilo il nanetto (rimasto nano per
10 anni, dopo un pestone, spero involontario, di mia madre), venne il nero Gaspar de la nuit detto Gasparino, poi
Ormindo, Màsago (dall’endecasillabo dell’amico Sandro
Parronchi: Mai donna fu goduta più di Màsago. Era infatti
una gatta, Màsago, felicemente ninfomane).
E ancora: la Fratocchia, Satana (gatto angelico), Rufus
(abbandonato in una cabina telefonica di Alassio), Passigli, la Pulce (da me sottratta a una perfida bambina tedesca di Kematen).
Una sera d’estate,
nel 1989, mentre alle
Zattere mangiavamo
una Margherita e una
Piccante, sentimmo
un miagolio disperato provenire dall’acqua. A una bricola
era attaccato un piccolissimo gatto nero,
terrorizzato. Entrai
nel ristorante e chiamai i pompieri, che a
quei tempi accorrevano subito. Arrivarono in sette con un
barcone, afferrarono il gattino, lo diedero a Giovanni, che
se lo fece scappare di
nuovo in acqua. Intanto i pompieri erano spariti.
Giovanni si sporse dal pontile fra gli
applausi dei turisti,
mentre io lo tenevo per i piedi, e ce la fece a riprendere il
piccolo. Alcuni ragazzini appena tornati dal Lido ci regalarono un asciugamano per avvolgere il piccolino, a patto
che il gattino fosse battezzato col nome di Enzo Maiorca.
Ed Enzo rimase, per 17 anni (non fu questa comunque
l’unica immersione in laguna di Giovanni. Una mattina
di gennaio, alla stazione di Santa Lucia, si calò in acqua
per salvare un gatto che stava annegando, e che poi, naturalmente, entrò a far parte della «piccola tribù»).
Andavamo spesso in treno a Firenze col Frasso, che
soffriva di mal di pancia durante il viaggio, soprattutto
nella lunghissima galleria del famoso attentato. Un giorno «la fece», proprio mentre il treno sfrecciava in galleria.
Subito avvolto nel Gazzettino, il prodotto fu gettato fuori dal finestrino, rientrando immediatamente nello scompartimento attiguo al nostro, dove una coppia di anziani
stava pacificamente dormendo.
Vennero poi altri due Frassi, tanto è vero che si creò una
vera e propria dinastia. D’altra parte era tradizione della
mia famiglia paterna, a cui mi ispiravo nelle grandi decisioni, quella di inventare dinastie di gatti (negli anni trenta la dinastia dei gatti vercellesi dei Galante Garrone era
detta «dei Mignin»).
Tutti i Frasso dormivano con Giovanni, sul cuscino. Io
mi accontentavo del Socialista.
Nel ‘92 arrivai dall’Alto Adige con Silvius (absit injuria
verbo), che ora ha 19 anni e vive di panna montata.
Poi venne la Supa, unica superstite di sette gattini morti
in un magazzino di Santa Maria del Giglio.
E ancora: Bebbuzzo Sgadari di Lo Monaco, unico gatto
di razza dopo i siamesini (a cui fu dato il nome del nobile amico di Giuseppe Tomasi di Lampedusa). Era un persiano crema, donatoci da Andrea, di ritorno da un viaggio newyorkese.
In Piazza Dalmazia, a Firenze, in un torrido agosto,
avevano abbandonato un gatto nero
adulto, che era finito
all’enpa (Ente nazionale protezione animali) di via Ricasoli,
meta giornaliera delle nostre passeggiate
nel quartiere.
Naturalmente lo
portammo a Venezia, e gli allestimmo
una casetta in giardino, perché si rifiutava di entrare in casa. Fu chiamato Rusticacio, dal nome
di un composto per
la pastasciutta allora molto usato da
noi (a base di aglio e
peperoncino).
Questo gatto merita un’attenzione particolare. Perché particolare è la sua
per Giovanni Morelli — 9
Venimmo accusati da un’aristocratica vicina, vecchia
amante di un noto Capo di Stato, di averle fatto sparire il
SUO gatto nero, che, a detta di lei, era terrorizzato da Rusticacio. Ci disse a chiare lettere che se il NOSTRO gatto fosse sparito (così, a suo dire, le avevano rivelato due
maghe lautamente prezzolate) il SUO gatto sarebbe ritornato a casa.
Con grande imprudenza non facemmo caso alla proposta delirante. Tanto è vero che un giorno del ‘96, alle Idi
di Marzo, Rusticacio sparì con la signora.
A nulla valse cercarlo in tutta Venezia (poteva essere salito su una barca, ci dissero alcuni trasportatori ormeggiati davanti a casa).
Azzardai allora un trucco: le scrissi che io sapevo dove
era il SUO gatto, le annunciai che avevo a mia volta consultato una maga, e che le avrei comunicato il luogo dove
si trovava il SUO gatto, se lei mi avesse restituito il MIO.
Una brutta favola che finì con niente di fatto.
Ma a grandi passi eccoci al 2000.
Nel 2006 prendemmo un altro Frasso a Firenze, poi un
piccolo abbandonato (detto il Guercino per via dell’occhio sinistro un po’ piccolo), e poi ancora, a Burano, un
gatto crema che Giovanni battezzò Cresima, dal colore del mantello simile alle tonache (o tuniche?) dei cresimandi. E ancora un altro piccolo molto malato, che chiamammo Segre, per l’espressione da perseguitato con cui
seguiva i nostri movimenti.
Cresima sparì il 28 febbraio del 2010. Col cancello chiuso. Nei soliti dieci minuti d’aria in cui gli si permetteva di
girare in giardino. Forse rapito.
Faceva freddo. Girai per un mese esatto per la Giudecca (Giovanni già non era più in grado di seguirmi) scuotendo un bidoncino di latta pieno di croccantini, e gridando «Cresima, Cresima!», seguìta dallo sguardo ilare
dei pensionati che giocavano al gratta e vinci dietro i vetri appannati del bar del quartiere. Venne la neve. Cercavo i segni dei polpastrelli sul bianco, mi avventuravo
di notte in zone malfamate, sempre implorando «Cresima!» a gola spiegata, piangendo. Tutti i pontili erano invasi dalla foto di Cresima e dalla promessa di una mancia
davvero improbabile per le tasche di un professore, ancorché universitario.
Finché una sera di fine marzo ricomparve, neanche
troppo malconcio. Segnalato dal gentile proprietario del
bar dei pensionati, che l’aveva riconosciuto dal colore e
dal miagolio timido e insistente.
Ma è venuto il momento di parlare di Giovanni, che
solo di striscio è stato finora nominato, e del suo ultimo
grande amore felino.
Il maccarello Erasmus ci fu portato da un’impiegata
animalista dell’Università di Verona, nel 2007. Subito diventò Il Gatto di Giovanni.
Imparò a svegliarci, gettando in terra la mattina alle sei
un piattino di metallo, per avere subito la sua razione di
croccantini. Imparò a «ringraziare» il suo «babbo» per
le coccole e i vizietti speciali, e imparò a dormire con le
zampine nei capelli di Giovanni, ignorandomi del tutto.
Era il suo gatto.
Le rare volte che si assentava per qualche convegno,
Giovanni cercava un telefono pubblico (non volle mai
il telefonino, neanche in ospedale) e mi chiamava: Passami Erasmus, diceva, prima ancora di salutarmi. Io appoggiavo il ricevitore all’orecchio del gatto e si parlavano a lungo.
Era un amore senza precedenti. I vari Palida, Mignotta,
Frasso, Bebbuzzo Sgadari di Lo Monaco, Enzo, Màsago,
Pilo, Supa, Ormindo, Giustino, Socialista erano spariti:
dalla sua mente prima che nella realtà.
Alla fine di giugno, quest’anno, Cresima morì (e preferisco sorvolare su questo fatto tristissimo).
Giovanni mi costrinse a cercare un altro gattino il giorno stesso, possibilmente dello stesso colore di Cresima.
Lo trovai. Aveva un mese e mezzo. Giovanni lo battezzò Leibniz.
«Perché?» gli chiesi. «Perché è intelligentissimo», disse
al primo sguardo, «e perché i nomi dei gatti devono avere una sibilante». Ma aveva l’aria triste di chi sa benissimo
che quel gattino non lo vedrà crescere.
Il 30 giugno Giovanni fu ricoverato. La sera stessa andai a trovarlo con Andrea, portandogli quattro fotografie di Erasmus da tenere sul cuscino la notte prima
dell’operazione.
Venezia, 14 agosto 2011
Il coraggio
della bontà
I
di Andrea Liberovici
n questo momento, in queste prime ore,
non posso che cogliere il gentile invito a scrivere di Giovanni, scegliendo la distanza. Piegando la mia riflessione
ad un artifizio teatrale, o meglio alla categoria del travestimento. Sicuramente, conoscendo Giovanni, quello che sto
per adottare è un travestimento estremo e forse azzardato,
in cui perfino il décor, i costumi, per non parlare dell’epoca, sono geograficamente e oggettivamente lontanissimi dalla sua ricerca
ma
chissà. L’amore che Giovanni nutriva per John Cage forse legittima la scelta di questo palcoscenico.
Per vari motivi, negli ultimi anni, sto leggendo e studiando il Sutra del Loto, considerato il Re dei Sutra del
buddismo mahayana. Questo meraviglioso libro, pieno
di visioni e intuizioni filosofiche semplici e profonde al
tempo stesso è popolato da una moltitudine di Budda e
bodhisattva dai nomi suggestivi ed evocativi tanto più
per chi si occupa di musica. Bodhisattva Suono Meraviglioso o bodhisattva Percettore dei Suoni del Mondo
(che è uno dei miei preferiti), ma anche bodhisattva Re
della Medicina e via dicendo. La figura centrale di questo sutra però è il bodhisattva Mai Sprezzante. Figura
centrale perché con il suo esempio concreto, nella vita quotidiana, trasmette l’insegnamento corretto della
saggezza e della profonda e millenaria filosofia buddista. Mai Sprezzante infatti, viene chiamato così perché
s’inchina sinceramente davanti ad ogni essere vivente
pronunciando questa frase: «Nutro per voi un pro-
per Giovanni Morelli
storia.
per Giovanni Morelli
10 — per Giovanni Morelli
fondo rispetto; non oserei mai trattarvi con disprezzo o arroganza. Perché? Perché voi tutti state praticando la via del bodhisattva e conseguirete certamente la
Buddità»1.
Nella storia di Mai Sprezzante si narra di come questo atteggiamento provocasse reazioni opposte e spesso molto virulente. Mai Sprezzante infatti, inchinandosi indistintamente ai sovrani come ai pescatori, per
Questa era la bontà di Giovanni. Unico gesto rivoluzionario possibile nella società del conflitto. Un gesto
di estremo coraggio, e nel caso di Giovanni, un gesto
costante, applicato ad ogni aspetto del suo vivere perché alimentato dal suo inesauribile spirito di ricerca e
studio della vita come entità organica e non scissa dalla parcellizzazione dei saperi, dalle discipline accademiche e soprattutto dal mercato. Oltre queste illusioni, c’è la realtà, rappresentazione di tutti i fenomeni che, laicamente, possiamo definire come Laborintus. Chi ha il coraggio d’inoltrarsi analiticamente nel labirinto, senza farsi distrarre e sedurre dal mondano, non può che essere conseguentemente generoso con chi questo coraggio,
per molteplici ragioni, non lo trova. Buono quindi, per intima convinzione e consapevolezza del
peso (controcorrente) che si era scelto, al fine di
tracciare una mappa nella selva dei segni per sé,
ma soprattutto per gli altri.
Per questa ragione mi piace concludere questo
piccolo contributo, con la frase che i suoi allievi
hanno affisso sui muri della facoltà, ringraziandoli come fratelli e sorelle, per la loro genuina capacità d’ascolto: «Non ci dimenticheremo il Prof.
Giovanni Morelli che per tanti anni ci ha aiutato a capire».
Grazie.
intimo rispetto della profonda uguaglianza fra gli esseri viventi al di là delle classi sociali, metteva, di conseguenza, in crisi le medesime. Fu quindi oggetto di
grande amore e anche di grandi persecuzioni. Senza
porgere mai l’altra guancia (non è modalità buddista)
né rispondendo al conflitto con il conflitto, Mai Sprezzante si difese «semplicemente» perseverando e approfondendo le sue convinzioni col coraggio della consapevolezza e della bontà, come riverbero della sua illuminazione. Il tempo gli diede ragione. Anche il peggior
nemico, irritato dal sapere e dalla mitezza di Mai Sprezzante, e accecato dalla propria gelosia, arroganza e vanità, alla fine si risvegliò.
La traduzione letterale di Budda è: Illuminato o Risvegliato. Risvegliato alla vera entità di tutti i fenomeni. In
estrema sintesi si può quindi affermare che la parola stessa: Budda, può essere tradotta con la parola Vita. Risvegliarsi alla vera entità di tutti i fenomeni, quindi
«illuminare» con la consapevolezza il proprio vivere e
quello degli altri, secondo il buddismo, è potenzialità
di ogni essere umano che può accedervi attraverso tre
azioni coraggiose: la fede nelle potenzialità illuminate di
ogni singolo individuo, lo studio ampio (non soltanto
del sutra e della filosofia), e la pratica della condivisione, con atteggiamento mai sprezzante verso i propri simili. Non si nasce illuminati ma lo si può divenire.
Se penso a Giovanni illuminista/illuminato, vedo,
nel suo comportamento, molte analogie con queste tre
azioni coraggiose. Analogie svincolate dall’aspetto mistico del buddismo ma intrinsecamente legate alla nobile tensione umanistica di questa filosofia/disciplina:
Fede come fiducia nel sapere, Studio della vita nella sua
molteplicità e totalità, e desiderio (Pratica) di porgere
la sua ricerca al mondo in forma di dono, di dialogo e
soprattutto d’ascolto sincero, generoso e mai sprezzante
(Giovanni odiava solo il copyright).
Il Sutra del Loto (traduzione di Burton Watson, Esperia, 1998)
1
I seguenti interventi sono pubblicati secondo il loro ordine d’arrivo.
Gianfranco Vinay
Lo sguardo obliquo di Giovanni
«Sguardo obliquo» è oggi espressione un po’ inflazionata dai molti usi per lo più metaforici: mostre artistiche che
intendono promuovere poetiche intenzionate a liberarsi
di stereotipi visivi e concettuali1; titoli di saggi dedicati a
intellettuali che hanno sondato i loro campi di ricerca ponendosi da ottiche nuove, anticonvenzionali e interdisciplinari2; fotografie come quella, celeberrima, di Robert Doineau commissionata da «Life» nel 1948 in cui un marito
a fianco della moglie getta uno sguardo appunto obliquo
alla «croupe» di una donna nuda ritratta di schiena in un
quadro appeso nella vetrina della boutique. E molti altri.
Ma non riesco a trovare espressione migliore per descrivere lo sguardo di Giovanni Morelli ritratto al mio fianco in una fotografia scattata a Torino tanti anni fa (io ho
ancora una criniera abbastanza folta e Giovanni non ha
ancora i baffi) in occasione della presentazione, alla Fiera del Libro, di un testo di un più giovane collega per i
tipi della De Sono. Giovanni fissa il suo sguardo di sotto in su, in uno spazio che si intuisce non essere quello
circostante, bensì tutto mentale, con un sorriso furbetto
da cui traspare un’eccitazione ironica che probabilmente
(non ricordo più) si sarà sfogata in una delle sue battute.
Questa fotografia mi è tanto più cara oggi, come riCon Margot, Andrea Liberovici e la gatta Palidina (1967).
per Giovanni Morelli — 11
Ad es. «Lo sguardo obliquo» è il titolo di una mostra di 6 artisti
che ha avuto luogo nello Spazio Tadini di Via Jommelli 24 a Milano nel 2009, oppure, di una più recente del fotografo Giuseppe Pitrone, che si è svolta presso le Officine delle Arti di Agrigento nel
maggio di quest’anno.
2
Cfr. M. Caterina Federici – Fabio D’Andrea, Lo sguardo obliquo. Dettagli e totalità nel pensiero di Georg Simmel.
3
È questo lo scopo principale che si prefigge un convegno che avrà
luogo nella seconda metà di marzo all’Università di Paris 8-Saint
1
Con Gianfranco Vinay
(da «Avidi Lumi», anno iv, numero 11, febbraio 2001).
Denis. Tale convegno, dedicato alla memoria di Giovanni Morelli,
si propone di rivisitare la sua opera e la sua figura nel contesto della
musicologia italiana dal secondo dopoguerra ad oggi e in relazione
agli scambi culturali fra Italia e Francia.
Nel suo scritto Gianfranco Vinay fa riferimento a un saggio da lui
dedicato a Morelli nel 2001: si tratta di Vingt ans apres. Genesi, sviluppi e viluppi della musicologia satirica, uscito
nel quadrimestrale palermitano «Avidi Lumi». Su indicazione
dell’autore lo riproduciamo integralmente.
Vingt ans apres.
Genesi, sviluppi e viluppi
della musicologia satirica
di Gianfranco Vinay
The truest respect which you can pay
to the reader’s understanding, is to
halve this matter amicably, and leave
him something to imagine, in his turn,
as well as yourself.*
laurence sterne , Tristam Shandy, II, 11
Nella ridda di ricordi che mi assalgono rimemorando
quella mattina del 21 novembre di vent’anni fa (1981) a
Palazzo Tumminello, sede della Società degli Amici della Musica di Palermo, vivissimi sono il profumo del caffé
servito da inservienti premurosi e cortesi, e il tavolo imper Giovanni Morelli
cordo di quello sguardo così caratteristico della mimica e della fisiognomia di Giovanni, che riassumeva un
suo modo di essere, di pensare, di porsi nei confronti del
mondo e della vita. Tanto più cara, perché oggi quello
sguardo si è spento nella sua concretezza esistenziale e
visibile. Dei suoi echi verbali sono pieni gli scritti pubblicati in libri e riviste note, ma molti anche dispersi in
rivoletti meno accessibili, che meritano una maggior visibilità e una maggiore diffusione, anche e specialmente internazionale3 .
Il dolore per la sua scomparsa mi toglie oggi la forza e
la concentrazione per ragionare sugli ultimi sviluppi del
suo pensiero e della sua scrittura, alle quali dieci anni fa
avevo dedicato un saggetto che terminava appunto con
la fotografia di cui ho parlato prima e che ripropongo
oggi in sua memoria.
Solo poche parole sui suoi ultimi libri. Gli Scenari della lontananza (e specialmente il capitolo introduttivo) mi
hanno accompagnato nel corso di un decennio in cui mi
sono molto occupato di Salvatore Sciarrino, compositore
particolarmente rappresentativo di questa categoria estetica declinata nei diversi saggi che compongono il libro.
Prima la musica, poi il cinema, che Giovanni mi aveva inviato prima dell’operazione, l’ho appena sfogliato, perché volevo leggerlo attentamente nel corso dell’estate e
discuterne con lui. Ma una curiosa coincidenza mi ha
colpito. Il libro finisce con alcune riflessioni morelliane
sulla famosa Accademia musicale del 22 dicembre 1908
in occasione della quale Beethoven ha presentato
e diretto, fra svariate composizioni, la Quinta, la
Sesta sinfonia e la Fantasia corale op. 90 che preannuncia la Nona. Bene, in uno dei corsi che tengo all’Università di Paris 8, che ha come soggetto
di studi un capolavoro della musica, sviscerato in
tutte le sue problematiche analitiche, storiche ed
estetiche, quest’anno per la prima volta ho trattato l’insieme delle opere di Beethoven presentate in
occasione di quel concerto per metterne in risalto
affinità e differenze e per approfondire il rapporto fra quell’evento, la biografia e il contesto politico e sociale dell’epoca.
Non è la prima volta che, a insaputa l’uno dell’altro, mi è capitato di occuparmi di soggetti trattati
anche da Giovanni quasi in contemporanea. Questo tipo di coincidenze, di affinità elettive, e di dialoghi che traevano spunto da esse, mi mancherà
moltissimo. Ma mancherà specialmente, a me e a
noi tutti, il suo sguardo obliquo, da cui sprizzavano scintille vivissime di ironia, genialità, inesausta curiosità e generosità.
bandito di dolcini dolcissimi e variopinti. Di cui i musicologi ivi presenti potevano servirsi a volontà (e si servivano, si servivano...). Al dissiparsi di questa nuvoletta
aromatica, di questa palermitana madeleine, un’immagine nitida, anzi nitidissima, mi appare. L’immagine di un
musicologo, nella sala adiacente a quella dei dolcini che,
posto di fronte ad un’assise di colleghi attenti, incuriositi ma anche un po’ perplessi, proiettava diapositive di un
bestiario molto speciale: il rinoceronte di Dürer, un ibis
che si fa un clistere, un elefante che si suona la proboscide; immagine, quest’ultima, confusamente schizzata da
Leonardo sul Codice C di Windsor, che si può anche interpretare come un uomo selvatico («omo salvatico» o Wild
Man) che suona il flauto. A conclusione della relazione, il
medesimo musicologo proiettò le diapositive della storia
baccanaria per Giovanni Vespucci e la Liberazione di An-
per Giovanni Morelli
12 — per Giovanni Morelli
dromeda, entrambe di Pietro di Cosimo.
Chi non si lasciò troppo distrarre dalla bizzarria, dall’abbondanza e dalla varietà delle immagini proiettate e riuscì a seguire le argomentazioni che le accompagnavano e ne motivavano la scelta, poté rendersi conto che
l’intento del collega era di mettere in dubbio la possibilità di fondare una scienza iconologico-musicale basata sul principio della rilevanza musicale (tanto organologica che performativa) della rappresentazione. Il bello
è che questo ragionevole dubbio veniva instillato nelle
coscienze dei colleghi proprio nel momento e nell’occasione in cui i musicologi a congresso stavano cercando
di innestare la scienza iconografica sull’albero già frondoso della musicologia.
Chi, per troppo giovane età o per indisponibilità a sobbarcarsi le fatiche del viaggio a Palermo residendo in terre lontane non poté (o non volle) assistere a quella performance critica aromatizzata al caffé e dolcificata dalle paste di mandorle, poté tuttavia farsene un’idea (e lo
può del resto ancor oggi) leggendo la versione scritta
dell’intervento pubblicata qualche anno dopo sulla «Rivista Italiana di Musicologia»1. Un’idea abbastanza fedele perché se la forma espositiva amabilmente ironica riproduce l’intonazione espressiva dell’esposizione orale,
la successione dei paragrafi e i loro titoli un po’ inconsueti («Le cesoiuzze e il coltellin dolente»; «s.o.s: il Rinoceronte»; «L’Ibis si fa un clistere»; «Di sopra in giù»;
«Tromboni truccati da trombe») specialmente se confrontati con quelli più conformi alla norma accademica
degli altri saggi contenuti nel medesimo volume, comunicano il senso di sorpresa e di smarrimento labirintico
nei meandri dello scibile sicuramente provato da molti
musicologi presenti a Palazzo Tumminello in quel mattino di novembre di vent’anni fa.
Mi piace apporre l’aggettivo «satirico» a questo stile ermeneutico e coniare dunque l’espressione «musicologia
satirica» per indicarlo, non solo a motivo dell’ironia che
trasuda dall’atteggiamento critico del relatore, ma anche
perché questo aggettivo, nel caso in questione, rinvia opportunamente (almeno questa è la mia intenzione) al significato originario e latino di «satura», che era nell’uso
quotidiano un piatto misto di frutta e legumi devotamente offerto agli dei. «Musicologia satirica», dunque, anche
e specialmente perché come già il genere letterario della
satira, questa musicologia è un misto di frutti (e legumi,
se si vuole) colti dall’orto del sapere e offerto in pasto ai
lettori. «Musicologia morelliana» avrei anche potuto definirla essendone il fondatore, Giovanni Morelli, anche
l’unico suo adepto.
Per dovere di esattezza storica il vero e proprio atto di
nascita della musicologia satirica (che dorinavanti non
virgoletterò più, dandola per definizione categoriale ormai acquisita) non era stato l’intervento palermitano su
Le salvatiche rilevanze, che se vogliamo usare una metafora ispirata dalla tradizione sacramentale cristiana, dovremmo piuttosto considerare come il suo battesimo in
presenza di una rappresentanza della comunità scientifica. Era stato un articolo pubblicato sulla stessa «Rivista Italiana di Musicologia» qualche anno prima. Partendo da considerazioni lessicali sul termine «rag», dalle illustrazioni effigiate sui frontespizî dei rags di Scott Joplin, dalle tecniche di lavorazione della canna da zucchero, dalla biografica artistica e psico-etno-social-patologica del pianista compositore nero sullo sfondo dell’Ame-
rica post-abolizionista, Morelli in questo articolo elaborava una teoria (nel duplice senso gnoseologico e processionale del termine) interpretativa dei rags di Joplin, dei
suoi turbamenti e malattie, della sua accidentata carriera
compositiva. Un articolo che attraverso una fitta rete di
concordanze metaforiche fra tutte queste costellazioni
semantiche veniva componendo stroficamente (nel senso tragico-coreutico di strojh) un’«odissea filosofica», come era esplicitamente indicato nel titolo2 . E si sarà capito che è in ossequio a queste origini odisseiche della musicologia satirica morelliana che ho ritardato l’ingresso
del protagonista sulla scena di questo mio racconto, come già Omero nel prototipo di tutte le odissee.
Per rendere giustizia all’epopea musicologica morelliana dalla sua nascita e battesimo palermitano ad oggi dovrei ora dilungarmi in un numero di pagine eccedenti di
molto i limiti imposti dalla ripartizione paritetica dello
spazio equamente concesso ad ogni collaboratore della
rivista trilingue su cui scrivo. Non potendo far ciò adotterò un criterio euristico basato sulla ricerca di ricorrenze tematiche ed espressive che, ossessivamente reiterate,
vengono a identificare un atteggiamento critico, una cifra intellettuale, uno stile. Un criterio simile, basato sulla messa in evidenza di particolari e anche di dettagli al
fine di pervenire all’identificazione di uno stile nel senso buffoniano del termine («le style est l’homme même»)
somiglia un poco al metodo d’indagine di Giovanni Morelli senior (quel Giovanni Morelli inventore del metodo
analitico nell’ambito iconografico, Über Prinzip und Methode, che aveva compiuto, come Giovanni Morelli junior,
studi medico-anatomici, ma lui in Germania un secolo
prima, e che amava firmarsi Ivan Lermolieff-Schwarze).
Con l’unica ma vistosa differenza che la finalità dell’indagine di Giovanni Morelli senior era attributiva, con conseguenti terremoti nel mercato dell’arte, mentre nel nostro caso l’autore è noto, e l’identificazione del suo stile
non produrrà effetti economici di sorta.
Mi pare di ravvisare nell’adozione del principio jamesiano (di William James) secondo il quale l’ordine reale
del mondo è costituito da null’altro che una «contemporaneità collaterale» uno dei fondamenti basilari del metodo critico morelliano3 . Compito del musicologo satirico,
alias Giovanni Morelli junior, è di render ragione di questa contemporaneità collaterale, ricostituendola attraverso un gioco di incastri di elementi appunto collaterali indagati nei loro caratteri specifici e costitutivi. Nel quarto di copertina del Morbo di Rameau, il romanzo musicologico di cui sono protagonisti i nipoti di Fuzelier e di
Rameau fra loro dialoganti su Les Indes Galantes, quell’opera stramba ed enigmatica dei loro reciproci zii, la musicologia morelliana viene definita «interdisciplinare».
Oggi, dodici anni dopo l’uscita di quel libro, il termine
è terribilmente inflazionato e usurato, ma già allora era
equivoco nella sua eccessiva genericità.
Certo, la musicologia morelliana è interdisciplinare, ma
ciò che la contraddistingue rispetto all’interdisciplinarità
comunemente intesa è la sua articolazione speculativa ed
espressiva «a gnommero», per usare un termine gaddiano. Anziché ingabbiare le manifestazioni della creatività musicale (e non solo di quella) nelle scatole cinesi del
pensiero categoriale, la narrazione morelliana si sdipana
«come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta
una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche
[Don Ciccio Ingravallo, commissario capo protagonista
di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana] nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo4 ». Ho citato Gadda Carlo Emilio, autore satirico quant’altri mai, ma su questa linea di ascendenza
culturale e stilistica vanno subito fatti i nomi di Laurence Sterne, Lewis Carroll, Gertrude Stein, Giorgio Manganelli, per non menzionare che i moderni.
Il precetto steiniano secondo cui «una cosa semplice
deve esser semplice attraverso la complicazione» è una
delle tante affinità elettive che rendono particolarmente stretto il vincolo culturale fra la poetessa americana
e Giovanni Morelli. Frutto abbastanza recente di questo sguardo nello specchio della prosa poetica steiniana
è la traduzione del testo di Four Saints in Three Acts in due
parti di cui la prima in versi e la seconda in prosa 5 . Tanto per dare un’idea dell’esito delle fatiche del traduttore
e dello spirito della traduzione, cito l’inizio del secondo
quadro del primo atto:
ST. TERESA II WITH DOVE / BEING PHOTOGRAPHED / BY ST. SETTLEMENT / 197. Altos Chorus I
SAINT Teresa could be photographed having been dressed
like a lady and then talking out her head changed it to a nun
and a nun a SAINT and a SAINT so
che diventa
In un Secondo Quadro / in cui ritratta vedi / Santa Teresa con colomba in mano / appare col piccione / ritratta dalla Santa / Santa Composizione / fotograficamente / 197. CONTRALTI [DEL PRIMO
CORO] / Essendo là vestita / come una dama, Santa / Teresa
ora potrebbe / esser fotografata /e discutendo poi / sulla sua
testa, loro / potrebbero cambiarle / la testa in una testa / di
suora e dalla testa / di suora in testa di santa così.
Corredo alla traduzione è una «satura» morelliana farcita: dall’analisi dell’opera indagata da tutte le prospettive, dai santi da cui è abitata, dalla storia topo-bio-grafica della comunità artistico intellettuale degli americani a Parigi con particolare accento sui due protagonisti dell’impresa (Gertrude Stein e Virgil Thomson) presi singolarmente e in coppia, da una nota del traduttore
in cui i molti problemi incontrati sono esplicati in ventun punti quante sono le lettere dell’alfabeto italiano. E
da diversi altri ingredienti che qualora venissero elencati allungherebbero troppo questo scritto.
A Eugenio Montale, poeta molto amato da Morelli, è
assegnato sovente il ruolo di un bardo preludiante, di un
Femio che in apertura delle odissee filosofiche «a gnommero» avvolge il lettore col suono della concava forminx
intonando un canto6 che aleggia poi sull’intera narrazione con i suoi accenti ora lirici, ora satirici, ora tutt’e due
le cose assieme. La citazione di un passo di un elzeviro montaliano sul ruolo sociale e sul significato culturale della claque nell’opera italiana dell’Ottocento e del
primo Novecento apre un lungo e succosissimo saggio
morelliano su «L’opera nella cultura nazionale italiana»
pubblicato in calce alla fine del sesto volume della Storia dell’opera italiana delle Edizioni di Torino7 (e dunque a
conclusione dell’intera impresa critico-storiografica che
però conclude senza iniziare, essendo tutt’oggi deficitaria dei primi tre volumi). Il testo di Oboe, poesia montaliana di intonazione lirico-satirica, introduce il paragrafo
iniziale («Paragrafi di un parapiglia») di uno scritto che
si propone di narrarci il perché e il «Come [wie es eigentlich gewesen] Cristina, regina e amante non fu accolta
nel regno delle eroine dell’opera romantica» 8 .
Nella «Diceria della Musicalità 9 », che sviluppa il tema
suggestivo della «musicalità come elaborazione del lutto
della musica perduta», Montale non preludia in apertura,
ma occupa una posizione centrale con una delle sue liriche più famose («Portami il girasole ch’io lo trapianti/nel
mio terreno bruciato dal salino [...]») che Morelli, per avvalorare la sua tesi, collega all’aria tripartita metastasiana.
Con Metastasio tocchiamo uno dei punti nevralgici delle odissee musicologiche morelliane. Con il Poeta Cesareo Giovanni Morelli intrattiene un rapporto speciale e
privilegiato, assommando Metastasio in sé tutte le virtù,
le allegorie, le figure onnipresenti nella coscienza critica
e nell’immaginazione ri-creativa del musicologo satirico. Fra cui, importantissime, quelle del Grande Malato
d’Ipocondria e del Grande Terapeuta Tranquillizzante,
che spiccano nel secondo romanzo musicologico di Morelli dal titolo eloquente: Paradosso del farmacista. Il Metastasio nella morsa del tranquillante10 . La musica, la musicalità e la creatività più in genere non solo come terapia, ma
anche e specialmente come espressione della malattia e
della fisiopatologia psichica e somatica, è uno dei nuclei
essenziali dell’ermeneutica morelliana, già fin presente
in quel saggio su Joplin cui abbiamo attribuito un ruolo
fondante, ma che poi viene ripreso un po’ ogniddove. Si
veda, ad esempio, nella prima parte del già menzionato
saggio su Cristina di Svezia, l’interpretazione dell’opera lirica come rituale onirico compensativo, come «processo di cancellazione [...] dei disturbi della vita mentale
epigenetica quotidiana intervenuti sulla struttura genetica.
Ovvero un processo di cancellazione delle modalità interattive [forse indesiderabili, forse inutili] al livello della coscienza, sopravvisute ed eccedenti alle necessità del
suo esercizio di esistenza. Ovvero un processo-laboratorio chimico-fisico-biologico di “oblio buono”»11. Oppure si veda ancora, in un esteso saggio sul tempo narrativo (in epica, nel romanzo, in musica e nel cinema12)
l’onnipresenza del paradosso di Schrödiger effigiato in
una vignetta con gatto vivo e/o morto all’interno di una
scatola trasparente, ossessivamente ripetuta in cima di
ognuna delle sessantacinque pagine.
Immagini di gatti, questa volta aggiogati in coppia (Eerste Katje e Tweede Katje) in un marchingegno rotante
ideato dal dottor Gaub, compaiono alla fine del Morbo di
Rameau per illustrare l’interpretazione, ovviamente patologica, della creatività del compositore Indes galantes13 .
Una malattia felina dei gatti ospiti di Giovanni Morelli
chez lui è all’origine della conoscenza dei due farmacisti, Speranzo e Acciari, morti per assunzione di un ennesimo Placebo auto-somministrato, la cui introduzione nel Paradosso del farmacista imprime un’impennata poliziesca alla narrazione.
Il ritorno «a gnommero» di simili e altre immagini ossessive contribuisce ad un tempo a rinforzare i tratti stilistici della narrazione morelliana e a riconfermarne la vocazione satirica, ironica e autoironica, parodistica e autoparodistica. Un discorso a parte meriterebbero i saggi in
cui Giovanni Morelli tratta di Luigi Nono14 o delle affinità poetiche fra Jabes e Nono15 , ma anche altri «gnommeri» lo meriterebbero, come la «quasi una fantasia» sul
verso 34 della scena quarta del secondo atto del Mer-
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 13
14 — per Giovanni Morelli
cante di Venezia («I mean my casements»16) attorno cui si
sdipana un lungo gomitolo di riflessioni critiche, estetiche, antropologiche. Ma anche...
La rilevanza del motivo patologico-medico-terapeutico delle narrazioni morelliane mi giustifica ad aggiungere un’altra interpretazione del termine «satira» utilizzato per identificare la musicologia di Giovanni Morelli: quello di sale saturo, di saturazione chimica che sedimenta poco a poco, come la pioggia di concetti filosofici nella coscienza dei suoi lettori, con effetto «retard»,
secondo i casi, le dosi assunte e le costituzioni. E se ogni
tanto bisogna ripercorrere dei passi per meglio cogliere significati più o meno reconditi, tanto meglio. In una
civiltà del «panta rei» in cui il flusso del tempo non è regolato dalla fatale inesorabile scansione eraclitea, ma da
una dissipazione quotidiana antitragica e banale, scandita da immagini suoni notizie immediatamente evacuate, i labirinti morelliani possono esercitare una benefica
azione anti-diarroica.
da «Avidi Lumi» (anno iv, numero 11, febbraio 2001)
per Giovanni Morelli
* «Il più sincero omaggio che possiate rendere all’intelligenza del
lettore è di spartire il compito, e di lasciare ch’egli, a sua volta,
inventi la sua parte, come voi la vostra».
1
Giovanni Morelli, Le salvatiche rilevanze. Indagine su Piero. Una
digressione sul metodo», in «Rivista Italiana di Musicologia», vol. xviii,
1983, n. 1, pp. 102-126.
2
Giovanni Morelli, «Tu lampada, tu asciugamano, tu piatto, tu Maple
Leaf, tu zucchero...» Una odissea filosofica nelle concordanze metaforiche di
Joplin, in «Rivista Italiana di Musicologia», vol. xiv, 1979, n. 2, pp.
395-435.
3
Alla luce di questo principio Giovanni Morelli interpreta il
frequente impiego del verbo «to sum» nel testo steiniano di Four
Saints in Three Acts. Cfr. Giovanni Morelli, Very Well Saints / A Sum
of Deconstructions/Illazioni su Gertrude Stein e Virgil Thomson (Paris
1928), Olschki, Firenze, 2000, p. 82, nota 70.
4
Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana,
Garzanti, Milano, 1982, p. 3.
5
Pubblicata nel 1992 sul libretto stampato in occasione della
versione marionettistica di Four Saints in Three Acts messa in scena a
Torino dalla compagnia «La fede delle femmine» e poi ristampata
in Very Well Saints, cfr. nota 3.
6
Libera parafrasi da Omero, Odissea, XVII, 261-263: «[...] peri
de sjeas hluq iwh / jormiggos glajurhs ana gar sjisi
ballet aeidein/ Fhmios [...]».
7
Giovanni Morelli, L’opera nella cultura nazionale italiana, in Storia
dell’Opera italiana, vol. VI, edt, Torino, 1988, pp. 395-453.
8
Pubblicato negli «Atti del Convegno Internazionale “Cristina di Svezia
e la musica”», Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1998, pp.
239-304.
9
Giovanni Morelli, Diceria della Musicalità./Nella musica, nella
letteratura-in specie italiana, in alcune loro storie, in «Atti del Convegno
Internazionale “Lingua e letteratura italiana: istituzioni e
insegnamento”», Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1999,
pp. 225-270.
10
Pubblicato da Marsilio, Venezia, 1998.
11
In Giovanni Morelli, Come Cristina, regina e amante, non fu accolta
nel regno delle eroine dell’opera romantica, in «Atti del Convegno
Internazionale “Cristina di Svezia e la musica”», cit., p. 250.
12
Giovanni Morelli, Né «nuvole né orologi». Sul «pas saccadé» delle grandi
e piccole manovre del tempo narrativo. Preamboli (epica, romanzo, musica,
cinema), in «Circuito cinema», quaderno n. 53, Venezia, Comune di
Venezia, 1995, pp. 8-72.
13
Giovanni Morelli, Il morbo di Rameau, Il Mulino, Bologna, 1989,
p. 219 e p. 231.
14
Giovanni Morelli, Terza pratica: Nono e la relazione compositiva
memoria/oblio, in aa.vv., Nono, a cura di Enzo Restagno, edt,
Torino, 1987, pp. 227-235; Giovanni Morelli, Luigi Nono, in
«Belfagor», 1995, 295, pp. 35-68.
15
Giovanni Morelli, Mettre en page la subversion («Hors de soupçon,
OK»), in «Drammaturgia», 2, 1995, pp. 190-228.
16
Giovanni Morelli, «I mean my casements.» Nota al verso 34 della
scena quinta del secondo atto del «Mercante di Venezia», in «Quaderni di
Venezia arti», n. 2 (scritti in onore di Nicola Mangini), Venezia,
Università di Venezia, 1994, pp. 61-79.
Giordano Montecchi
Per una bizzarra ma infallibile serie di circostanze Giovanni Morelli non l’ho mai incontrato di persona, conoscendolo solo tramite telefono, un paio di lettere e, naturalmente, gli scritti. Anzi no, non solo. Anche tramite comuni amici o colleghi che spesso, nel conversare, di Morelli ricordavano un pensiero, uno scritto, un certo suo
modo d’essere che lo rendeva così amabile, e di cui quei
resoconti erano sempre la conferma affettuosa e colma
di gratitudine.
Forse chi mi ha chiesto di ricordare Morelli – perché
io? ho risposto d’istinto – sapeva la mia profonda ammirazione per lui, ammirazione condivisa con qualche carissimo amico, al punto da ravvisare nel pensiero, nello stile, nella maestria letteraria di questo romagnolo divenuto veneziano un modello, un unicum nell’orizzonte
della musica e della critica. Dico «critica», piuttosto che
«musicologia», intendendola nel senso intellettualmente
e artisticamente più elevato, quello di Kant o di Wilde.
Imbattermi, anzi imbatterci (poiché spesso l’incontro e
a volte anche la lettura erano a due o a tre) in un testo di
Giovanni Morelli era innamorarsi innanzitutto del prosatore. Si trattasse della chiosa alle Lezioni di Reynaldo
Hahn o dell’euforica finzione del Morbo di Rameau, incancellabile romanzo critico («critico» per l’appunto) la cui eccitante e ludica ricchezza stilistica ed inventiva un Umberto Eco direi non abbia mai raggiunto – poco importa.
Il primo hook era squisitamente letterario, pressoché
infallibile, con quel suo paradigma testuale golosamente metaforico, straripante di suggestioni a cascata, ermeneutica che sfociava in arte.
Nello scrivere Morelli era un magnifico compositore,
artefice di melodie verbali e architetto di temi, variazioni, sviluppi, riprese. Ed era maestro ineguagliabile di modulazioni, vale a dire molteplicità, sguardi plurimi, altri,
rivelatori – e sorridenti – rivolti agli oggetti delle sue riflessioni. Maestro che ha insegnato molto a molti, ai più
giovani e fors’anche ai meno giovani di lui – perché è di
un maestro partito anzitempo che parliamo.
Non ho una frase capace di riassumere la lezione di Morelli, ma forse in quel «romagnolo diventato veneziano»
c’è una chiave possibile, identitaria e un filo stereotipata, nel senso della radice popolare e schietta che si sposa
felicemente all’esprit più colto e raffinato. Morelli spirito
libero, dolcemente scalpitante, accademicamente ingovernabile. E il cui grande racconto potrebbe intitolarsi
La felicità del testo, qualcosa di più ricco generoso e umanistico del plaisir barthesiano.
per Giovanni Morelli — 15
Paolo Puppa
Per Giuvà
da Pablito
S’è spenta in un certo senso la luce nell’Ateneo veneziano,
non solo nel nostro dipartimento delle arti, oggi fuso coi
filosofi. Sì, Giovanni Morelli ci ha lasciati e in qualche modo andandosene in punta di piedi, alla sua maniera, ci ha
reso tutti più poveri. Sparendo, annullandosi, come capita
alle persone care, è rientrato nondimeno dentro noi tutti.
Difficile adesso coniugare questa creatura fosforescente
all’imperfetto, il tempo verbale dei defunti. Perché tra lui
e l’imperfetto non c’era connessione alcuna. Il fatto
è che più invecchiava più si apriva al futuro. L’ombra in cui si mimetizzava come i suoi gatti discreti
non gli impediva di trovarsi caparbiamente dentro
le grandi progettualità, tra Fondazioni, Enti, Centri di ricerca internazionale per ogni appuntamento calendariale di ricorrenze e di celebrazioni. Non
si trattava di presenzialismo o di carrierismo. No,
solo la voglia di spendersi, attingendo alla sua mostruosa memoria da autentico archivio bibliografico, utilizzando le risorse dei suoi contatti internazionali, per far camminare le idee, trovar gambe,
braccia e supporti finanziari. Ma la medesima perizia veniva impiegata nella dedizione con cui si centrifugava a seguire i curricula e i crediti dei suoi corsisti nella snervante e sempre modificata architettura della riforma universitaria. In più, nonostante
la sua anagrafe, sprigionava un’inesausta curiosità,
inusuale (per la nostra generazione), verso il nuovo,
da lasciarsi alle spalle anche il giovane più scatenato
nell’ up to date tecnologico. Certo, non sentirò più il respiro ridotto ad un gemito affannoso, il fruscio dei passi in
pantofole (la sua divisa, quando nello studio contiguo al
mio riceveva gli studenti con infinita disponibilità), non
vedrò più i capelli arruffati sulla fronte che invano tentavo ogni volta di rimettere a posto, il suo sorriso di angelo
malizioso che ti scrutava fino in fondo, mescolato ad una
serietà comportamentale e intellettuale che esigeva da sé
prima che dagli altri. Negli ultimi mesi, aveva già rinunciato al mitico carrello con cui lo si incrociava sui ponti vicino alle Zattere, nella contiguità col Billa, grondante di scatolette per i suoi tanti, troppi felini per un asmatico come lui. Una fatica ormai insostenibile per il suo fisico malandato, anche se continuava egualmente a sfoggiare camicie e cravatte ogni giorno differenziate, nel suo
inesauribile, civettuolo guardaroba. Nei giorni precedenti il fatale ricovero ospedaliero, giorni in cui s’era quasi ingrigito e trascinava le gambe penosamente, continuava a
sembrarmi indistruttibile, nonostante gli indizi evidenti.
«Consolati, la morte non è poi quella brutta bestia che diIn motoscafo (anni settanta).
cono, è molto naturale, più di altre, il povero nostro maestro l’aveva di certo molto introiettata, ne è stato buon
testimone espressivo e adesso forse se la gode come prova di distanza», questo mi ha scritto in uno degli emails
che ci scambiavamo, dove mi chiamava Pablito e io lo ribattezzavo Giuvà. In quel caso, l’occasione era l’improvvisa scomparsa di Sinopoli, fuggito dalla vita nel pieno
delle sue forze. In effetti, non appena qualcuno in facoltà
o in dipartimento veniva a mancare ostentava un’imperturbabilità che lo preservava dalle parole di circostanza,
dalle lamentazioni dei corridoi, dalle cerimonie di congedo. Non era cinismo, il suo, semplicemente un buon senso allenato nella sua matrice illuminista, nel secolo libertino dei prediletti Rameau e Diderot. Solo durante l’operazione subìta dalla sua Margot al cuore (sempre un cuore di mezzo in questa triste storia!), la voce gli si incupiva con pudore. Scriveva in modo denso e spesso criptico,
una continua digressione di parentesi quadre e tonde, essais dove il punto arrivava ansante (per il fruitore, non per
lui), dopo una serie interminabile di subordinate. Pointes
ermeneutiche che sfoltivano forse i lettori, una vertigine
del pensiero in cui quasi con gusto presocratico mesco-
per Giovanni Morelli
Fra le tante cose voglio pensare che Morelli, passeggiando fra Seicento e Novecento, abbia insegnato, a giovani
e non, l’arte della molteplicità, ossia la critica dell’intolleranza come antidoto all’intolleranza della critica e alle sue tante derive deterministe. Incomparabile lezione
di estetica, di spiazzante e illuminante acume interpretativo, la strada maestra per amare insieme Luigi Nono
e Nino Rota, la passione e il candore.
lava i saperi più lontani grazie a incroci bizzarri e audaci.
Estetica musicale e matematica, medicina-scienza alchemica e letteratura, poesia e filmografia (vedi il suo canto
del cigno sorprendente, Prima la musica, poi il cinema, dove
retrodata i fratelli Lumière alle macchine narrative settecentesche e ancora indietro nel tempo), per non andare
oltre negli scenari interdisciplinari. In breve, le moderne
arti del trivio e del quadrivio, catapultate dall’energia (verdiana, anche se non sopportava i suoi troppo popolari melodrammi) del filologo musicale le une sulle altre con ritmi che oserei definire sensuali, sfociavano quali fiumi in
piena nel mare magnum della sua tensione esegetica. Nelle
note a piè di pagina, nei cambi di carattere in calce spesso
più espansi del testo primario, celava di frequente la chiave
per penetrare nel gioco aforismatico dei suoi essais. In certi casi, vedi il geniale e misterioso Paradosso del farmacista, la
sua scrittura, mimetica in modo virtuosistico dell’oggetto,
di volta in volta flessibile rispetto alla tipologia diversa di
scrittura su cui si sporgeva, calibrando il tempo musicale
e variando all’improvviso il punto prospettico, veniva il
sospetto che si divertisse alla nostre spalle. Perché si era
di fronte spesso ad una pedantesca parodia degli acca-
per Giovanni Morelli
16 — per Giovanni Morelli
demici, ad una cura omeopatica contro la hybris della specializzazione. In quegli snodi, vedi il capitolo funambolico «Pars extrema: svanire è dunque la ventura delle venture», tra accenti dickensiani degni dei Pickwick Papers per
la coppia di farmacisti di provincia metastasio-dipendenti cui si rivolge l’io narrante alla ricerca di medicamentiplacebo anti epilessia del gatto di turno, si dispiegava un’ilarotragoedia da opera buffa settecentesca. Ma il tutto veniva
scandito con moduli picareschi e insieme tocchi da gothic
novel, da rievocare per me lo stile compulsivo con cui David Forster Wallace infittiva le sue culte pagine sul tennista Federer o sui congressi delle pornostar. La medesima
valorizzazione dell’insignificante (in apparenza), del dettaglio, di ciò che viene di solito relegato in basso.
Giovanni nelle sue investigazioni solitarie aveva qualcosa del Brand ibseniano, del profeta niciano, rassegnato a
trovare su in cima pochi compagni all’altezza. Rischiava
così di ingolfarsi in un sofferto autocompiacimento, sequestrato nelle trame finissime delle sue argomentazioni. Se lo accusavo per burla di sfiorare atteggiamenti autistici, mi rispondeva con garbo che le cose non sono mai
semplici! Ma sapeva allo stesso tempo, nella pagina invasa
dai suoi segni onnivori, e coll’astuzia fortiniana della colomba, spalancare béances, spiragli, spazi vuoti. Soste gradevoli, dischiuse dalle citazioni raffinate e spesso poetico-narrative che si concedeva, nella loro lingua originale per la competenza dei tanti idiomi foresti che possedeva, ma quasi sempre corredate della relativa traduzione,
a salvaguardia didattica dello studente e del non dotto. Si
divertiva pure a donare piccoli collage di immagini, dagherrotipi allusivi, sciarade iconiche cui forzava lo sprovveduto interlocutore a trovare in fretta un senso, ogni volta meravigliandosi «Non puoi non riconoscerlo!». Perché
la sua bontà, da tutti apprezzata, sapeva anche esalare allo
stesso tempo odori sulfurei. Un che di daimonico, nell’accezione precristiana, volteggiava infatti nei suoi modi miti
e bonari, intolleranti solo nei riguardi dei toni alti e sgraziati, dell’aggressività sfoderata da certi colleghi nelle riunioni istituzionali. E allora lo sguardo gli si accendeva
di bagliori che intimorivano. L’intricante ragnatela della
sua sintassi sapeva altresì sciogliersi e trovar pace miracolosamente nelle filastrocche, nei cantabili, nelle ariette,
dopo tanti ardui recitativi, con cui ci deliziava. Sarebbero da raccoglierli tutti queste nugae, dalle datazioni incerte o fatte regredire ad arte, che lui svalutava ufficialmente a bagatelle, tanto continuative comunque da far pensare ad un manierismo crepuscolar-mélo compatibile con
«son coeur mis à nu». Ognuno di noi ne conserva qualcuno. Lancio qui un’idea editoriale: raccogliamoli e facciamo uscire l’altra faccia della luna, dove travasava una delle sue tante anime, quella felliniana-rotiana per intenderci. Mi limito a darne solo due brevi esempi.
Il titolo recita Canzone triste del passerotto che si è rotto un’ala e langue in un canto della grondaietta sul tettuccio del capanno, a
Rimini,1952. Eccone un frammento:
C’è una barca in mezzo al mare
Con le vele gialle e blu,
fino a lei vorrei volare
ma le ali, ahi, non le ho più.
Ed ecco il secondo: Canzonetta triste da cantarsi affacciati al
finestrino del treno fermo, a lungo, nella stazione di Villafranca sulla poco servita linea Mantova-Verona, 2001
Stazioncina addormentata,
non ti desta il campanello?
le finestre son serrate
ed è chiuso anche il cancello,
niun discende e niuno sale,
tutto intorno resta eguale.
Le sue anime erano tante, come detto. Nel saggio su
Eugène Pottier, poète, ouvier, communard, spalma una serie
di identità oltre i prismi pirandelliani: «1. il sindaco fourierista-proudhoniano della Commune, 2. l’anarchico magniloquente, 3. l’epicureo, contemplatore malinconico,
del cosmo per quel che è e prosegue arrivando a ben 21
tessere di un epitaffio musivo che intende risarcire l’autore misconosciuto, condannato ad una «gloria oscurata dalla immortalità», ossia dall’essere relegato alla creazione solo dell’Internationale, il canto delle utopie rivoluzionarie nel mondo, «eruzione di eticità (senza aggettivi,
per favore)». E del povero Pottier pubblica per riscatto
l’elenco completo dei titoli relativi ai suoi testi.
La medesima stratificazione si ritrova altrove. Anche
in un ulteriore passo del nostro epistolario elettronico,
dove mi confidava, in termini di un refrain joyciano o
tardofuturista, il groviglio inestricabile dei suoi pensieri,
delle metafore ossessive e dei miti personali del suo privato. Il gusto risulta quello solito delle mappature, delle
liste interminabili con cui circondava l’oggetto, che fosse personaggio, persona, frase musicale, sequenza pittorica o filmica non cambiava la sostanza del suo occhio
plurimo: «Gatti, gattesei, cats, gatti, gattesei, cats, treni,
concorsi, moduli, treni, concorsi, moduli, albe, insonnie,
bozze, albe, insonnie, bozze, giardini, spray, ossi, giardini, spray, ossi, verbali, spartiti, e-mail, verbali, spartiti, e-mail, insonnie, Andrea, respiri, insonnie, Andrea,
respiri, tesi, suoni, scadenze, tesi, suoni, scadenze, paure, sorrisi, sussurri, paure, sorrisi, sussurri».
Festa della parola, balletto di una koinè ebbra, inevitabilmente censurata nella più smorzata comunicazione
orale. Una lezione, la sua, scapigliata, erede un po’ delle dossiane Note azzurre, un’erudizione vigilmente ludica
di stampo borgesiano, un’immaginazione, ancora, pronta allo scatto, all’illuminazione che gli dettava impensati connubi tra parti lontane della sua biblioteca. Lo rivedo curvo davanti al computer acceso, magari in fregola nello stendere l’indice delle voci, in chiusura di un
nuovo saggio, nomi propri compresi, nell’eterno piacere
dell’inventario! Infine, a chiudere questo prolisso ricordo, un altro prelievo dai nostri scambi, là dove imita la
posa sveviana di Zeno consapevole ad un tratto dell’apparato complesso di ossa e nervi che presiedono ad ogni
minimo moto del corpo. Sono piccoli incidenti, stavolta, suonati con un registro comico, se pensiamo alle vicende recenti: «Sai bene che non chiedo di meglio che
far venire al mondo qualcosa di innocuo. Che dirti d’altro, che per alleviarmi il fastidio al ginocchio sinistro e
il mistero della sua causa, sono riuscito a farmi male stamani al gomito sinistro, l’altra articolazione degna del
ginocchio per proprietà funzionali, andando a sbattere
da fermo, mentre legavo la bici sporgendo un po’ il braccio in fuori, contro la cabinetta di un’Ape che ha fatto il
possibile per riuscire a rasentarmi all’interno spazio del
marciapiedi. In effetti la colpa è mia, dovevo stare a casa. Quel che mi consola è che di questo doloretto al
gomito, rispetto a quello del ginocchio, d’oscura causa,
ho piena nozione di causa».
Gian Paolo Minardi
L’ultima digressione, fatalmente senza cadenza – o quasi-cadenza secondo la stupefatta ritualità dell’amatissimo
Kurtág – questa di Giovanni, maestro dell’artificio con
cui giocava come nessun altro tanto penetrante, incredibilmente diramata, era la sottile intensità che nutriva quel
suo aprir finestre, apparentemente divaganti, su orizzonti spesso inesplorati, o conosciuti come quelli suggeriti nell’ultimo libro, durante la cui lettura Luisa ed io siamo stati colti dallo sgomento della notizia; uno sguardo sul cinema con un singolare capovolgimento di prospettive nel rapporto con la musica. Un gioco avventuroso con quattro campionature, ognuna terreno di avvincenti, iperbolici rimbalzi, appunto, condotto, come
in ogni suo scritto, con quella segreta voracità nel frugare entro gli interstizi più impensati che lo portava a collezionare «inoffensivi corsivi» come a innescare estrosamente un vero e proprio «concerto di tic intertestuali»,
provocanti anche, sorprendentemente rivelatori di spazi amplissimi dai quali il senso della storia, della musica
soprattutto, affiorava di colpo come un fantasma che si
fa realtà, ben più complessa in quanto liberata dai vincoli
che ci portiamo addosso. È il senso di uno spazio diverso
che avanza col tempo, da lui osservato con quella «lontananza» – uno dei fili conduttori questo del suo pensiero
indagatore – attraverso la quale pareva avvertire il consumarsi disarmato del dramma della contemporaneità.
Universo che Giovanni ha percorso in lungo e in largo,
sospinto da quella conoscenza senza limiti, quasi puntigliosa, alla quale non sembrava sfuggire alcun dettaglio
– col correttivo talvolta di quella sua inconfondibile ironia dal tono bonario, antiaccademico, che lo portava a
scusarsi col lettore, «questa elencazione, di cui per primo
so di dover deprecare la sfarzosità» – e che tuttavia pareva non celare quello scetticismo di fondo che lo portava
ad indicare «come modello tragico per una sacra rappresentazione» l’ultimo soliloquio, in Sprechgesang, del Moses,
«O parola, parola che mi manchi». Un’ombra che sfiorava
fugace e interrogativa quel suo sorriso, indimenticabile.
Maurizio Agamennone
Un sorriso «felino»
Il sorriso «felino» e il suo pensiero radicale sono due piste in cui vorrei proporre la mia riflessione su come Giovanni Morelli percepisse l’agire musicale nella complessità della storia culturale. È noto che amasse i gatti: la sua
casa alla Giudecca ne era affollatissima, se ne prendeva
cura assiduamente, ne portava uno con sé ogni volta che
scendeva da Venezia a Firenze, e pure certi tassisti fiorentini avevano imparato a conoscere questa sua esigenza e la destinazione. Dei felini aveva la medesima formidabile sensibilità che gli consentiva di percepire con sicurezza quali processi, personalità, energie, istanze e spinte creative si muovessero in un ambiente, in uno spazio
culturale, circoscritto o esteso, assunto a «terreno» della
sua analisi, riflessione e scrittura: dall’opera veneziana,
allo scenario globale della musica cólta contemporanea,
dalla scrittura strumentale di Mozart al «candore» di Nino Rota, a una nuova, possibile, «scuola musicale veneziana», dagli informatici furori musicali giovanili in garage e bed-room, alle polifonie viventi nell’Europa orientale, alle musiche di Berio (di cui conservava ed esponeva soddisfatto, nel suo studio universitario, la partitura
dell’Ecce, composta dal Maestro in occasione del Congresso della Società internazionale di musicologia tenutosi a Bologna nel 1987) e Nono, così diversi e lontani,
ma entrambi accomunati dalla sua amicizia e stima, per
non parlare delle innumerevoli presenze della musica nel
cinema, nella radiofonia e nel web, che frequentava e conosceva come pochissimi. Pure dei gatti aveva la saggezza silenziosa di chi sa molto, ma non ne spreca la ricchezza in enfatiche, chiassose ed euforiche narrazioni, la amministra con riservatezza e prudenza, ne suggerisce alcuni impulsi e poi ne indica altri e altri ancora ad allievi,
studenti, amici, colleghi e collaboratori, e pure ne scrive, con maggiore ampiezza e uno stile molto complesso,
su livelli densi e integrati, attraverso strati sovrapposti di
senso che possono apparire misteriosi a una prima e veloce lettura. Poiché la sapeva lunga – ancora, come i gatti –, era pienamente consapevole che le più diverse pratiche musicali sono messe in atto attraverso processi assai sofisticati che risultano solo in parte immediatamente palesi e sensibili, rimanendo, numerose altre componenti, implicite, conservate in memorie remote, simbologie nascoste, codici riservati, immagini sfocate, discorsi obliqui, oppure celate dietro automatismi quasi inconsapevoli e non infrequenti manìe compulsive: nel music
making, quindi, nell’agire musicale, oltre la musica, intesa come immediata emergenza acustica, c’è un universo
profondo di connessioni e rinvii che appartengono pienamente alla cultura, con direzioni molteplici e costrutti
multiformi: in questo senso, mi pare si possa pienamente ascrivere la sua sensibilità e opera di studioso alle prospettive critiche della antropologia musicale più recente,
vivace e mobile scenario di ricerca e riflessione per chi
si occupa di attori sociali che agiscono e fanno musica,
pensandone e parlandone, uno scenario in cui egli stesso
si trovava a essere protagonista dialogante, dal suo posto
di osservazione e ascolto, insieme con i musicisti, compositori, strumentisti, vocalisti, registi, fisici acustici e ingegneri del suono, direttori artistici, cronisti, critici, analisti, impegnati direttamente nella produzione musicale e
nel «discorso» relativo.
Il pensiero radicale costituisce la piattaforma critica su
cui si è innestata efficacemente la sensibilità «felina»: il
suo radicalismo era effetto di una matura opzione libertaria, di istanze profondamente egualitarie ma non per
forza antagonistiche e aggressive. La prospettiva libertaria, perciò, si esplica in una costante ricerca di confronto
e dialogo e, sul piano scientifico, in una sorta di relativismo teorico-metodologico che allestisce, misura, adatta e perfeziona i propri strumenti di analisi e indagine in
mobile e fluida coerenza con le mutevolezze e differenze espresse dai numerosissimi oggetti di studio frequentati. Nelle sue ricerche e attività didattiche è largamente
rilevabile una fertile realizzazione degli assunti politici
e metodologici, soprattutto nella demolizione – radicale, appunto – delle gerarchie presenti nella tradizione di
studi musicologici, cui, peraltro, non mi pare fosse pienamente «interno» e «allineato», forse anche per i suoi studi
originari di medicina. Di più, in assonanza con le espe-
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 17
per Giovanni Morelli
18 — per Giovanni Morelli
rienze più innovative degli studi di «storia culturale», pur
non trascurando affatto i grandi e alti rami della cultura musicale euro-americana, tendeva a individuare pratiche, personalità, prospettive e testi fortemente connotati e «locali», tali da apparire, forse, appartati, marginali
o estremi: una palese testimonianza è nel suo incontenibile interesse e affetto verso teatranti e cineasti «irregolari», singolari e «periferici» rispetto al mainstream dello
spettacolo dal vivo e radio-televisivo, quali István Gaál
e Jean-Marie Straub, anche per le loro sofisticate predilezioni musicali (di quest’ultimo esponeva, ancora nel suo
studio universitario, una pagina dattiloscritta di copione dei pavesiani Dialoghi con Leucò, recante le annotazioni manoscritte dello stesso Straub sulle condotte di recitazione). Ma, aggiungo, altrettanto emblematica è stata la sua lunga e complessa ricognizione – sperimentata
all’interno di avventurosi corsi universitari – sui suoni e
le musiche nel rito e nella festa, dalle multiformi e crepitanti fonosfere locali, all’innodia religiosa, civile e politica, ai modi dell’intonazione cantata nella preghiera e nella conduzione della Parola dai testi scritturali. Entrambi siamo stati appassionati di innodia, non solo quella rivoluzionaria, e nessuno come lui mi ha mai fornito fonti sonore così preziose, da una emozionantissima Internazionale zulu al Soviet Anthem registrato da Paul Robeson, politalentoso alfiere dell’emancipazione degli afroamericani, per questo e altro finito nelle grinfie investigative di fbi e cia: si tratta di fonti oggi accessibili in rete, ma lui le traeva, quasi sempre, dal suo sterminato archivio personale.
Pure, esplicita testimonianza di questa sua curiosità
verso pratiche e persone «periferiche», e della «pari dignità» che vi conferiva, è stato il suo forte interesse verso le vicende del programma Polifonie in viva voce, originariamente realizzato insieme da Fondazione Giorgio Cini, Teatro La Fenice e Ca’ Foscari, un unicum veneziano
nel mondo, per la sua persistenza nel tempo e la varietà
delle pratiche polifoniche proposte e documentate: dalla Corsica alla Georgia caucasica, dalla Sardegna all’Albania, passando per il trallalero genovese, il béi dell’Amiata, la diafonia delle Bistrishki Babi (le nonne di Bistritsa,
piccolo villaggio a dieci chilometri da Sòfia, la cui prassi
polifonica è stata riconosciuta quale «patrimonio immateriale dell’umanità» dall’Unesco), le polifonie più vicine di area veneta e friulana, l’«epica» vocale di Bajo Doria (Canavese, Piemonte), per finire (2010) con la polifonia maschile proveniente dalla Çamëria (regione a cavallo
tra gli attuali territori di Albania e Grecia, teatro di sanguinose operazioni di «pulizia etnica» e luogo originario di una dolorosa diaspora, quasi ignorata dall’Europa
contemporanea) e, invece, continuare (novembre 2011)
con le diafonie vocali e strumentali di Krk, la più grande isola dell’Adriatico. Un programma, Polifonie in viva voce, che ha pure ospitato a Venezia i più importanti specialisti di area, a presentare e commentare l’azione dei cantori e strumentisti, e che avviammo insieme quasi per
caso, nell’ormai lontano 1997, all’insegna del più stretto
understatement, senza fanfare, né marketing, e che resiste tenacemente: un programma che poi Giovanni ha
seguito sempre con grandissimo interesse, suggerendoci pure una idea singolare – una delle tante, sue! –, dedicata a un altro cineasta «periferico» ma centrale nella rosa dei suoi affetti e interessi: la realizzammo, con procedure non frequenti in un contesto accademico, nella for-
ma del «seminario conviviale» intitolato Strategie identitarie indirette. Echi di polifonie nel cinema di Otar Iosselliani (novembre 2005)… un programma a cui stavamo lavorando ancora, per l’edizione 2012, fino all’ultimo, progettando di invitare Frederic Rzewski a ragionare e dialogare intorno a una lontana composizione del 1969, Last
Judgement per trombone solo, in cui la polifonia emerge
dalle risposte d’eco all’azione diretta del solista, generate nell’ambiente della performance.
Come si vede, il sorriso «felino» di Giovanni e la sua
radicalità guardavano a una pluralità di esperienze musicali che può apparire sbalorditiva e labirintica, a raccontarla adesso: a starci dentro, a quella pluralità, insieme con lui, si percepiva invece una solida sicurezza, una
calma quasi olimpica. Giovanni sapeva bene che le differenze musicali rilevabili nelle costruzioni culturali prodotte da homo sapiens sapiens possono apparire inconciliabili, al primo ascolto e a prima vista: invece, non sono
affatto tali se intese come la manifestazione di un possibile «altro sé» – piuttosto che un irriducibile «altro da
sé» –, cui guardare con curiosità e da ascoltare sorridendo, conservando la capacità di stupirsi ed emozionarsi…
senza fanfare e strafare.
Massimo Cacciari
Nessuno ho conosciuto che non volesse bene a Giovanni. È la prima cosa che mi viene in mente di lui, e cancella
quasi ogni altra. Forse perché fosse «buono», condiscendente, arrendevole? No, l’opposto. Poteva essere di un’ironia tagliente, farti comprendere con una parola o un’occhiata quanto banali, o, peggio, ignoranti fossero le tue osservazioni, le cose che dicevi. Era un breviloquio sempre
quello di Giovanni, ma sostanziale. Giovanni era un uomo
sostanziale, nel senso letterale del termine: nel variare dei
tempi e dei luoghi avvertivi sempre che in lui vi era una
sostanza permanente, che non si sarebbe consumata. La
sostanza «sta sotto», è difficile da cogliere, non ama manifestarsi, detesta esibirsi, ha in dispitto logorree di ogni
genere – ma dura, resiste, insiste – e tu, alla fine, la avverti e ne provi una stima invincibile. La sostanza ha pudore. L’uomo sostanziale è innamorato di pudore e decenza.
Espone senza mai imporsi. Ha sempre l’aria di preferire
«ritirarsi», ma mai quella di «concedersi» quando tu lo interpelli. È lieto di incontrarti, è generoso nel risponderti
– ma tu sai che possiede una interiore «riserva» che ti resterà sempre inaccessibile. L’uomo sostanziale lavora e lavora, è infinitamente curioso, sa essere amico, è fedele –
ma ogni sua manifestazione è raccolta in quel fondo, che
è silenzio. Quello da cui proviene ogni musica, e in cui
ogni musica ritorna e si rigenera. E io so di far piacere a
Giovanni, a questo punto, non parlando dei comuni ricordi, delle comuni amicizie, delle tante passate e fallite speranze. Ciò che conta e ha davvero valore nella vita sarebbe pura vanità pensare di esprimerlo a parole.
Elvidio Surian
Non ho parole abbastanza adatte per esprimere il mio
dolore per la scomparsa del caro amico e collega Giovanni Morelli; scomparsa che lascia in me un vuoto profondo.
Ho incontrato Giovanni per la prima volta nel 1973, e
per Giovanni Morelli — 19
Gino Benzoni
Grazie, Giovanni
Giovanni Morelli non c’è più. Tocca prenderne atto.
S’è spento, dopo qualche giorno di coma farmacologico,
a Mestre, nell’ospedale dell’Angelo il 12 luglio di quest’anno, del 2011. E l’annuncio, come da lui disposto, a cremazione avvenuta. E, quindi, niente cerimonia solenne nel
cortile di Ca’ Foscari, nessuna possibilità d’esequie ufficializzate. Se n’è voluto andare con discrezione, di proposito schivando ogni sottolineatura nel lutto, ogni eventualità d’orazione funebre. E se tra i necrologi comparsi nella
stampa locale nei giorni immediamente successivi – quello della Fondazione Levi, quello dell’Istituto Veneto, quello della Fenice, quelli dell’università – manca quello della Fondazione Cini, è così rispettata alla lettera la volontà
di congedo non sottolineato nella e dalla sede più direttamente colpita, proprio perché la più abituata alla sua continuata presenza, dall’irruzione repentina del vuoto irrevocabile d’un’assenza dolorosa.
In anticipo una fitta d’impotente sgomento l’ho provata la sera del 14 giugno proprio a San Giorgio. Era in
corso quel che si suole chiamare un evento. S’inaugurava
l’apertura del labirinto intitolato a Borges. Per l’occasione bella gente, elegante, s’affolla nei due chiostri. Il cielo
stellato sopra, un catering sapiente, sollecitante, invogliante sotto. E il tutto avvolto dalla dolcezza d’un tepore tardoprimaverile. Chiacchiere in ordine sparso, presentazioni, baciamani, sorrisi, riconoscimenti, guarda chi c’è,
chi si vede, chi si rivede. Un garrulo andirivieni lungo il
quale Giovanni ed io ci sfioriamo, ci risfioriamo. E poi,
in attesa del concerto, mi si siede accanto, di proposito.
Non è che i posti siano numerati. E, mentre le luci si stan
spegnendo, mi comunica che si deve ricoverare. Faccio
sempre più fatica a camminare, mi spiega. Come una constatazione riassuntiva. E come gravida del presagio che
quella fatica non avrebbe più avuto modo di affrontarla.
M’aveva detto addio, pensavo durante il concerto, paralizzato dall’afasia, dall’incapacità di una parola adeguata.
Con sollievo l’obbligo l’ho evitato al riaccendersi delle luci, a fine concerto. Giovanni stava conversando con una
signora. Quel che aveva da dirmi, quel che voleva dirmi,
me l’aveva detto. Punta affiorante d’un iceberg di straordinaria ricchezza interiore, di sterminata cultura – studi
giovanili di medicina, all’attivo un manuale d’anatomia
adottatissimo nei licei artistici e nelle accademie, docente universitario trascorrente dalla storia della musica alla musicologia sistematica, dalla storia e critica del testo
musicale alla musica nel e per il cinema; saggista guizzante e balenante, impervio e spericolato, epperò rigoroso nella severità d’un autocontrollo penalizzante ogni
esibizionismo; in grado d’incontrare nello stesso giorno
Zarlino e Nono, Monteverdi e Kurtag, melodrammi e
colonne sonore – questo faentino con ostinato residuo
emiliano nell’accento invenezianato, ingiudeccato, nelle sue quotidiane sortite dai domestici gatti, dalle domestiche carte, dai domestici affetti. E addosso, se inverno, una giacca pesante a sostituzione del cappotto; oppure, se primavera inoltrata, se estate, una camicia fuori
dai pantaloni. E, sempre, a mo’ di proiezione incorporata, il carrello – di quelli per la spesa – coi libri in uscita e
con quelli in entrata.
Perfezionato tra noi – lui e me – una sorta di ritualizzato appuntamento in vaporetto. Egli, salendo alle Zitelle, controllava se, nascosto dietro il giornale, io, salito
a San Basilio, c’ero. Se c’era posto si sedeva di fronte. In
caso contrario m’alzavo e con lui mi spostavo all’esterno. Assieme, una volta scesi a San Giorgio, percorrevamo il breve tratto sino al cancello della Fondazione; assieme andavamo dalla Bianca, un po’ segretaria d’entrambi. E, intanto, il baratto di qualche vicendevole parola, a
proposito del più e/o del meno. Uomo in certo qual modo al 5% Giovanni – nel senso che il sommerso si manifestava con estrema parsimonia, con intermittenti accensioni nello sguardo, con ironici ammicchi –, di questo 5% mi son nutrito per anni, non senza, l’ammetto, la
presunzione di percepire, come da questo sbirciando, il
silenzio profondo del mare. Da un lato – oggi come oggi – questa percezione non m’è più data. Dall’altro, nella misura in cui, col nodo alla gola, ne serbo il ricordo
struggente, l’assenza rinnova la presenza. Grazie, allora
Giovanni, da parte mia, ogni giorno.
Alan Curtis
La musicologia italiana ha perso la sua luce più vivida.
Ancora peggio, il mondo ha perso un carattere brillantemente eccentrico, onesto, gentile, mite, un intellettuale di
ampi interessi, di universalità unica e di enorme generosità. Suppongo che qualunque studioso, nel campo musicale e non solo, che abbia messo piede a Venezia negli ultimi quarant’anni abbia beneficiato della sua generosità.
I suoi scritti sono di grande importanza, ma rappresentano solo una piccola parte delle informazioni che elargiva liberamente a studenti, amici e persone che non aveva
mai incontrato prima. Personalmente ho imparato molto
dai suoi scritti, ma forse anche di più dalle conversazioni
con lui negli ultimi cinquant’anni. Ancora ricordo, quando preparavo la mia prima edizione della Poppea di Monteverdi, che Giovanni chiarì per me alcuni difficili problemi linguistici nel libretto, e mi aiutò a ricostruire un
testo per il duetto di Valletto e Damigella (che inizia così: «O caro/cara» e poi è lasciato incompleto a meno della parola «godiamo» alla metà del brano).
Gli ho anche chiesto informazioni sulle regole di sillabazione in italiano, domandando ad esempio perché Ottavia deve cantare «Di-sprez-za-ta regina» e non «Disprez-za-ta», che a me sembrava suggerire un’interpretazione più espressiva. Ricordo bene quando diceva: «Ignora le regole, fai ciò che ritieni convincente». Ci saranno
mai altri docenti come lui al mondo? Ma il suo aiuto in
argomenti di questo genere è solo la punta di un iceberg.
Era tipico del suo carattere che la maggior parte delle
sue buone azioni fosse realizzata dietro le quinte. Infatti
sospetto che non saprò mai tutti i modi in cui mi ha aiutato. Ricordo una volta, quarant’anni fa, quando in una
conversazione uscì fuori l’argomento di Gluck, e mi
per Giovanni Morelli
da allora il nostro rapporto non si è mai interrotto. E così
scorrono nella mia memoria i bei momenti che abbiamo
passato insieme a Venezia, nel corso dei convegni annuali alla Fondazione Cini e in altre occasioni; i lavori che abbiamo pubblicato a quattro mani… Certo è che lui mi ha
dato, a livello sia professionale che umano, più di ciò che
io gli ho dato. Ciao indimenticabile John, ti ricordo con
affetto; ci manchi.
20 — per Giovanni Morelli
chiese se conoscevo Paride ed Elena. Quando risposi di no,
mi disse: «È un paradiso. Devi ascoltarla», e mi portò a
casa sua alla Giudecca per farmi ascoltare una vecchia e
gracchiante registrazione di un’esecuzione radiofonica,
con Ileana Cotrubas. Poco dopo dirigevo quest’opera al
Teatro Olimpico di Vicenza e non sono mai stato capace
di capire come mai fossi stato chiamato, ma sospetto che
dietro questa circostanza ci fosse Giovanni. So per certo che c’era lui dietro il mio ingaggio per gli Orazi e Curiazi di Cimarosa all’Opera di Roma, per il quale utilizzai la sua edizione, con il debutto di un giovane soprano,
ancora sconosciuto, di nome Anna Caterina Antonacci.
Giovanni era stato uno dei primi a «scoprirla», e anche
prima della produzione di Cimarosa, lei cantò a Padova, con la mia direzione, estratti dall’Alceste di Gluck, un
ruolo nel quale, molti anni dopo, avrebbe trionfato sulle maggiori scene italiane e ovunque. Ancora, sospetto
che Giovanni sia stato dietro la scelta sia del repertorio
che dei solisti. Durante il mandato di Italo Gomez, come
direttore artistico de La Fenice, naturalmente ricevette
credito per alcune programmazioni molto originali. Ma
come avrà fatto a sapere di rarità come La finta pazza di
Sacrati? Giovanni aveva un modo di disseminare informazioni che erano non solo interessanti, ma erano quelle giuste al momento giusto. Ci mancherà grandemente.
per Giovanni Morelli
Pasquale Gagliardi
Conobbi Giovanni Morelli nel 2002, qualche giorno dopo essere stato nominato Segretario Generale della Fondazione Cini. Avevo chiesto di incontrarlo per conoscerlo
e parlare delle attività dell’Istituto per la Musica che aveva diretto fin dalla sua istituzione, nel 1985, e che aveva in
pochi anni trasformato in uno dei centri di ricerca musicologica più apprezzati nel panorama internazionale. Ricordo che all’orario prestabilito per il nostro incontro lo
trovai sulla soglia del suo ufficio, che mi aspettava in piedi con quell’espressione tenera e indagatrice che ti catturava al primo sguardo e che da uomo buono e curioso qual
era riservava praticamente a tutti.
Parlammo a lungo della Fondazione Cini, dell’Istituto
per la Musica, dei numerosi fondi e archivi che custodiva, delle attività da realizzare, dei libri da pubblicare e,
più in generale, dei progetti per il futuro. Ebbi immediatamente la percezione di una grande competenza che veniva esaltata dall’atteggiamento umile e dimesso con cui
Giovanni abitualmente si presentava. Tuttavia, limitarsi
a sottolinearne la competenza e l’umanità significherebbe perdere un aspetto fondamentale della sua personalità: a mio modo di vedere, infatti, egli era anche un uomo molto originale, con un gusto naturale per il coup de
théâtre. E nessuno tra quelli che lo hanno conosciuto bene potrà mai credere che al primo appuntamento Giovanni si sia potuto accontentare di dare di sé un’impressione umile e dimessa, anche se competente, al proprio
interlocutore.
Durante la nostra conversazione Giovanni giocherellava con una cassetta, che teneva fra le mani come se custodisse qualcosa di insolito o di prezioso su cui voleva
richiamare la mia attenzione. Alla fine della nostra amabile chiacchierata, spinto dalla mia incontenibile curiosità gli chiesi cosa ci fosse dentro. Gli occhi di Giovanni
si illuminarono, avevo abboccato alla sua esca: mi dis-
se che era una sorpresa per me e mi chiese di ascoltarla
appena ne avessi avuto l’occasione. Quando ebbi la cassetta tra le mani, lessi l’etichetta incollata su uno dei due
lati: Corale Polifonica dell’Università Cattolica di Milano, Teatro Verde, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia, 1958. Sgranai gli occhi incredulo. Nel 1958, oltre
quarant’anni prima, facevo parte della Corale Polifonica dell’Università Cattolica: si trattava della registrazione di un concerto al quale avevo partecipato anch’io come corista e che avevo totalmente dimenticato. Ero letteralmente senza parole. Come aveva fatto a recuperare quella registrazione di cui ignoravo l’esistenza? E come faceva a sapere, prima ancora di conoscermi, che ero
parte di quel Coro? Mi sembrò un miracolo, un vero atto di magia, qualcosa che si può solo ammirare e che non
si riesce a spiegare.
Naturalmente quello fu solo il primo atto «miracoloso»
di Giovanni al quale assistetti. La sua attività di ricerca
era una miscela inspiegabile di rigore scientifico, accostamenti inediti, ipotesi ardite, citazioni impensabili, scoperte inaspettate, di fronte alle quali, ogni volta, ti chiedevi «come facesse». Una domanda alla quale egli rispondeva invariabilmente sorridendo e abbassando gli occhi.
Sotto la sua spinta, anche l’attività editoriale dell’Istituto si è andata sempre più caratterizzando per la quantità e l’originalità delle pubblicazioni. Grazie a lui oggi l’Istituto pubblica due riviste annuali dedicate rispettivamente alle arti acustiche (aaa/tac «Acoustical Arts and
Artifacts: Technology, Aesthetics, Communication») e
cinematografiche (aam/tac «Arts and Artifacts in Movie: Technology, Aesthetics, Communication») e cura
numerose collane specialistiche quali «Studi di musica
veneta» dell’editore Olschki, l’edizione nazionale dell’opera omnia di Andrea Gabrieli e (in collaborazione con
l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi) Drammaturgia musicale veneta edita da Ricordi.
I prodigi di Giovanni Morelli non erano solo di natura
intellettuale. Se mi si chiedesse qual è l’eredità più preziosa che egli ha lasciato alla Fondazione Cini citerei l’incredibile patrimonio di fondi e archivi dei musicisti italiani del Novecento che, sotto la sua spinta, si è formato a San Giorgio. Grazie a lui sono confluiti sull’Isola i
Fondi Casella, Rota e Togni, che costituiscono – insieme ai Fondi Malipiero, Respighi e Sartori – un patrimonio documentale di inestimabile valore. Probabilmente,
dopo Vittorio Cini e alla pari con Vittore Branca, nessuno come Morelli ha arricchito la Fondazione Cini di
«risorse culturali», che saranno fonte di studi e ricerche
originali per molti anni a venire.
In più occasioni ho, infine, ricordato come la Fondazione Giorgio Cini sia stata per lunghi anni la seconda casa di Giovanni Morelli. Il suo andirivieni tra la Giudecca e San Giorgio con il carrello della spesa carico di libri
è una immagine familiare a tutti i dipendenti della Fondazione. La sua mancanza lascia un vuoto letteralmente incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di apprezzarne la competenza e l’amabilità. L’impegno della Fondazione oggi è quello di proseguirne l’opera multiforme, l’unico vero modo di conservarne e onorarne la memoria.
per Giovanni Morelli — 21
Quando pensi a Giovanni Morelli sùbito sono le doti umane che occupano tutto il campo, prima ancora di quelle
dello studioso, pur tanto influenti e disseminate; ma poi,
mentre queste si potrebbero almeno in parte elencare,
quelle restano inafferrabili a ogni aggettivo singolo: quel
sorridere e significare solo con gli occhi, ironico di sé ma
anche di te che ne venivi scoperto; l’intelligenza, l’umorismo, la battuta spiritosa e prontissima, la delicatezza, l’affetto dissimulato, la bontà: l’unicità della sua persona non
si riesce a coglierla in un volto particolare, perché, forse,
più che in qualunque altro caso, consisteva in un assieme di tutti quegli aspetti, mescolati poi in un modo non
meno unico a formare qualcosa di imparagonabile; tanto
che pensare oggi a dover fare a meno di Giovanni, oltre
a turbarci nella dolorosa confusione del vuoto, non ci riesce immaginabile per la quantità di luoghi fisici e morali in cui la sua figura si era insediata come punto di riferimento, autorevole e confidente: sapere che c’era bastava a
dare un senso di sicurezza, di benessere.
Mite, ma non per debolezza; poteva essere non conciliante, duro, irremovibile nelle convinzioni profonde o
nell’autonomia dei comportamenti; come, fin troppo ahimé, nell’ignorare i precetti e le manie del salutismo moderno. Nei messaggi scritti, nell’aprire una conversazione telefonica, di solito amava non dichiararsi per nome,
quasi volesse far scivolare la sua persona tra parentesi,
entrare in scena senza annunciarsi; ma poi, con tutto il
suo understatement, era facile sentire quanto fosse fiero del
suo lavoro, consapevole dei risultati ottenuti: bastava lasciarsi portare in giro per la Fondazione Cini e sentirlo
parlare delle raccolte, delle collezioni di documenti perfettamente schedate, pronte all’uso dei volenterosi; oppure quando senza falsa modestia dava conto delle ricerche promosse dalle tesi di laurea assegnate e svolte sotto la sua vigile cura, e poi dei convegni, delle serie ininterrotte di pubblicazioni. Solo in parte la sua incredibile capacità lavorativa è testimoniata dai suoi libri; amava
sopra tutto gettare ponti, trovare agganci, lanciare proposte con una fantasia creativa che individuava sùbito
tempi e modi di attuazione; rarissimo, in un intellettuale così fervido, il suo senso della realizzazione, la visione
precisa, economica direi, del lavoro da fare. Nell’irritabile genus dei professori universitari nessuno l’ha mai visto
irritato; e se azzardavi un commento malevolo su qualcuno, la malizia cadeva nel vuoto, e ne sentivi un disagio
per averci provato con mancanza di tatto.
Punto sempre discusso il suo modo di scrivere, ritenuto difficile se non ermetico, disperazione di chi non vi
leggeva l’equivalente della sua persona amabile e diretta; scrittura sempre mossa, irta di svolte improvvise, ellissi, subordinate e parentesi; naturalmente certe asprezze espressive erano volute, ma in genere quella difficoltà
era dovuta a un misto di sofisticata elaborazione e di stile parlato; l’accumulo barocco dei dati, allineati con cura minuziosa, maniacale, era continuamente attraversato da una trama umoristica, che in mezzo alla sconfinata dottrina, al reperto raro insinuava il dato comune, il
fatto di cronaca, il caso di attualità: che spiazzava il lettore con un lampeggiare di impreviste allusioni, spesso
da ricercare e proseguire negli scantinati delle note; tanUna foto degli anni ottanta.
to che occorreva tornare indietro, rileggere, ricomporre.
Fatica? Certo, ma quale pensiero solido e nutriente non
richiede una simile fatica di assimilazione? E in questo
stile stratificato entrava in gioco un’altra facoltà unica di
Giovanni: rarissimo vederlo a qualche manifestazione,
sempre chiuso nella specola delle sue biblioteche; eppure sembrava aver visto tutto, l’ultimo spettacolino, l’ultimo film, l’ultima pièce teatrale, passando dall’opera musicale più rara, all’operetta, al musical: era il segno di una
attenzione rivolta a tutto, di un’apertura ad ogni manifestazione della mente senza gerarchie e privilegi: era,
in fondo, il segno di un amore dichiarato per la vita; lo
stesso che fra i disinganni dell’ironia traspariva dall’uomo. Indimenticabile.
Alessandro Spina
Agli eredi e agli amici di Camillo Togni, alla sua scomparsa nel 1993, si poneva il problema del suo archivio, testimone di cinquantasette anni di attività (1936-1993). Giustamente si pensava di affidarlo a una istituzione pubbli-
per Giovanni Morelli
Giorgio Pestelli
ca per la sua conservazione e per essere a disposizione di
studiosi ed editori. È noto che forse la maggiore raccolta
di documenti sulla musica del xx secolo è alla Sacher di
Basilea. Ma una visita alla Fondazione Cini di Venezia ci
convinse che la sua gestione era esemplare, custodiva già
l’archivio di Alfredo Casella e di altri illustri musicisti del
Novecento. Casella fu maestro di Togni ai tempi della Accademia Chigiana, prima della famosa svolta verso Vienna (così si espresse lo stesso Casella perfettamente conscio delle possibilità eccezionali del suo allievo). Fu allora dunque che incontrammo all’Isola di San Giorgio, sede della Fondazione, il compianto Giovanni Morelli. Giulio Bruno Togni, fratello maggiore di Camillo e suo erede, non esitò a decidere: «Portiamo tutto a Venezia, sempre cara a Camillo». Si ricorderà che al Teatro La Fenice
si eseguì molto spesso musica sua, fin dal 1946, e lì avvenne la prima rappresentazione dell’opera Blaubart su testo
del poeta prediletto: Georg Trakl (1977). Così, nel risolvere un problema, entravamo in relazione, l’erede e chi,
come il sottoscritto, dava una mano, con un personaggio
di esemplare calore umano, mimetizzato da una naturalezza assoluta, di grande cultura, musicologo capace di
22 — per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli
raffinatezza illimitata (tanto qualche volta da sfiorare l’incomprensibile, per chi, di nuovo come chi scrive, non aveva una preparazione musicale sufficiente). Fu dunque firmato l’accordo (23/3/2000). Oggi, all’Isola di San Giorgio, sorta di supremo scrigno in muratura, c’è una stanza
con la bella targa «Archivio Camillo Togni».
Dopo di allora il rapporto rimase costante. Morelli promosse la stampa dell’epistolario di Togni (coi musicisti
italiani e stranieri, colleghi ed esecutori, tre volumi stampati da Olschki, Firenze), di un bel cd con alcune opere
da camera giovanili, per lo più sconosciute; sollecitò la
ricostruzione del Concerto per pianoforte e orchestra, restato
incompiuto, a cura di Paulo de Assis, che curò pure un
volume con la partitura e tutte le chiarificazioni necessarie, eseguito in prima assoluta sempre al Teatro La Fenice dallo stesso De Assis come solista (8 ottobre 2006).
Si potrebbe continuare, in ogni iniziativa veneziana c’era la sua mano.
Così adesso, al compianto per la morte di Morelli si associa il pensiero di un’assenza che pesa, si è portato l’esempio di Togni ma come detto la sua opera, a Venezia,
fu costante e illuminata in favore della musica del secolo scorso.
Per finire voglio ricopiare la sua ultima lettera a me diretta, tracciata con mano incerta, era già gravemente ammalato, e dove la sua figura mentale compare intatta:
Fondazione Giorgio Cini – Istituto per la musica – Il Direttore
Carissimo,
avevo appena riposto il rutilante Diario di lavoro, e il monografico, rilucente di Humanitas, conscio di godere del prosatore italiano che decisamente apprezzo oltremodo e oltre ogni
confronto, che ecco mi giunse il nuovo numero della rivista
coi suoi eccitanti tronconi tematici. L’affanno che mi sta affliggendo non mi consente di approfondire come dovrei l’espressione della mia ammirazione e la gratitudine per la qualità e la quantità dei doni. Forse a tu per tu, se Dio lo concederà, spero, abbastanza presto, di trovare le parole nell’occasione di un fortunato incontro. Un caro affettuoso saluto, Giovanni Morelli.
Venezia, 24 marzo 2011.
Morelli morì il 12 luglio.
Era capace pure di una deliziosa nota scherzosa, lo divertiva il mio ricorrere a pseudonimi e in una precedente
lettera elencandoli la indirizzava a Cari Amici. Perfetto!
Francesco Lombardi
Tanto io dormo
«Giovanni come sei vestito?» Ernesto Talentino, al telefono nel suo ufficio di vice Segretario Generale della Fondazione Cini, chiedeva per mio conto l’informazione utile a me che dovevo incontrarlo per la prima volta. Credo
fosse all’inizio dell’autunno 1990, Giovanni Morelli aveva una camicia rossa, dei pantaloni bianchi e l’immancabile carrello della spesa pieno di libri. Non stentai a riconoscerlo sui gradini della chiesa alle Zattere, nonostante
la riva affollata di turisti, anche perché qualche giorno prima, in ansia per l’incontro con una persona di cui sapevo
pochissimo, avevo chiesto a Paolo Donati, a quel tempo
responsabile della programmazione musicale di Radiotre,
se per caso lo conoscesse.
«Ah, il Tenente Colombo! È bravissimo, anche se leggere le sue cose è un’impresa, e poi, appunto, somiglia al
Tenente Colombo della serie televisiva».
Non credo di aver mai visto Giovanni Morelli con un
impermeabile e tantomeno con un sigaro. Però l’artistica
stazzonatura dei vestiti, un certo modo di guardarti, di
avvicinarsi ai luoghi e alle persone, davano conto di una
affinità con il celeberrimo investigatore interpretato da
Peter Falck. La cosa era abbastanza risaputa, tanto che
anni dopo in una delle stanze dell’Istituto per la Musica
della Fondazione qualcuno lasciò una xerocopia di un’immagine del Tenente Colombo – io – che altri – lui – appesero a buona guardia della macchina per le fotocopie.
Il mio incontro con Morelli era legato al progetto di
portare l’Archivio personale di Nino Rota alla Fondazione Cini. La considerazione della critica e dell’Accademia
per Nino Rota aveva toccato a quel tempo, una decina
di anni dopo la morte del Maestro, una delle sue punte
più basse. Rota, ancora popolare per le sue colonne sonore – Fellini e Il Padrino fra tutte – era considerato sostanzialmente inaccettabile per le musiche sinfoniche e,
in generale, per tutto il suo copioso catalogo extra-cinematografico. C’erano ovviamente vistose eccezioni anche fra interpreti e critici di nome, ma ogni qual volta si
cercava di dare un posto a Rota nel novero dei compositori italiani del Novecento, l’istinto primario era quello della rimozione. Se poi si passava all’ascolto della cosiddetta critica militante, partivano ancora bordate piuttosto violente. L’Accademia, invece, cercava di ignorare quello che tutt’al più poteva essere considerato un talentuoso musicista di formazione classica che si era dato
alla musica leggera. Tutto questo, a cascata, procurava a
chi si occupava del repertorio rotiano una serie di difficoltà con gli editori e con la qualità, il genere delle persone che si avvicinavano alla sua opera. L’editore principale di quel tempo, Casa Ricordi, riteneva di aver fatto
anche troppo accettando dopo la morte del Maestro di
farsi carico di qualche altro titolo. I fan e gli studiosi rotiani erano poi persone in genere più legate al mondo del
cinema e del collezionismo di memorabilia. L’Archivio
personale del Maestro era, nonostante queste attenzioni a volte poco limpide e i numerosi traslochi fra Roma,
Milano e Bari, un unicum. Rota era infatti uno di quei
disordinatissimi che conservavano tutto e, proprio questo disordine, aiutò nei sedici anni precedenti la donazione a preservare in massima parte il suo lascito. Era presumibile che Morelli fosse curioso e bendisposto, visto
che aveva accettato di incontrarmi molto rapidamente.
Quello che non sapevo, invece, erano i motivi profondi
di una curiosità che durante quella conversazione si manifestò come un sincero interesse all’accoglimento delle carte rotiane presso la Fondazione. Non potevo quasi
crederci e gli specificai subito che, se si fosse giunti alla
meta, bisognava trovare uno studioso con tutti i crismi
accademici, in grado finalmente di dare una sistemazione a quella massa di carte. Qui avvenne il primo scarto
«morelliano». Dopo avermi fatto capire che sarebbe stato un percorso lungo e difficile, il cui esito lui non poteva garantire, mi disse chiaramente che se le carte fossero arrivate a Venezia sarebbe toccato a me, che avevo fatto sul campo l’esperienza necessaria con il primo catalogo provvisorio dell’Opera, sistemarle. Non voleva dover
istruire o delegare nessun altro non potendo, per evidenti ragioni di tempo, occuparsene lui in prima persona.
Uscii da quell’incontro, abbastanza stordito, felicemente stordito. C’era qualcuno, ed era il direttore dell’Istituto per la Musica della più grande e prestigiosa Fondazione Culturale Italiana che era pronto ad «adottare» Nino
Rota. Non mi disse mai nulla delle battaglie che dovette
affrontare dentro la Fondazione, ma alla fine, nel 1995,
fu firmato l’atto di affidamento e l’anno successivo il Fondo Rota era, anche dal punto di vista fisico, una realtà.
In quei cinque anni di limbo ebbi modo di toccare con
mano quanto il progetto del Fondo Rota fosse ritenuto
nell’ambiente musicale qualcosa che si collocava a metà strada fra la bizzarria e l’eresia pura. Silenzi imbarazzati, facce attonite e ricordo ancora bene l’esclamazione
stizzita di una dirigente dell’allora maggior editore musicale italiano: «Il Fondo Rota non si farà! Alla Cini non
avranno mai i soldi per fare una cosa del genere…». Siccome questo vaticinio era stato accompagnato da uno
consimile di una sua collega, che aveva dichiarato con la
stessa sicurezza che un certo direttore non avrebbe mai
eseguito una sola nota del Maestro, smentita pochi mesi
dopo dalla registrazione di un intero cd dedicato a Rota
sotto la celebre bacchetta, io avevo cominciato a prendere queste reazioni come un segnale di buon augurio.
Oggi, a sedici anni dalla sua costituzione, le attività del
Fondo e quanto queste abbiano contribuito alla diffusione dell’opera e alla ricollocazione critica del Maestro,
sono sotto gli occhi di tutti. Ma quello che credo qui sia
doveroso cercare di fare, dal punto di vista privilegiato
nel quale questa vicenda mi ha collocato, è piuttosto un
tentativo di sistemare questa che è stata una delle tante
avventure culturali di Morelli, nel quadro della gigantesca partita a scacchi che lui aveva ingaggiato con il pensiero moderno. Nino Rota, artista considerato da molti
inattuale e allo stesso tempo assolutamente sincronico
con le committenze del suo tempo, a cominciare dalla
musica per il cinematografo, poteva essere molto di più
di un caso di studio, di una operazione di recupero valutativo critico di un’opera e di un contesto decisivi nel secolo che stava finendo. Poteva essere, il caso Rota, una
vera e propria mossa del cavallo, in grado di saltare steccati e trincee critiche, malferme e obsolete già all’atto
della loro nascita, quanto pervicaci nella loro resistenza
perché erette a baluardo delle molteplici battaglie ideologiche del Novecento acciocché gli angeli del male non
avessero mai più a manifestarsi. Dunque, un autore come Rota che subì in piena coscienza la Storia del secolo
scorso con tutti i suoi sconquassi, mantenendo una rotta personale e solitaria, costituiva un’occasione da non
perdere. E da lì, infatti, nacquero indagini che, a partire
dalla Storia del Candore, convegno in due tappe del 1999
a celebrazione del xx della scomparsa del Maestro, diedero una bella rimescolata a tutti gli approcci legati alla musica applicata, all’impatto che l’era dei media e della riproducibilità su vasta scala dell’opera musicale ebbero sui musicisti dell’era moderna. Ma se la figurazione
scacchistica del cavallo è pertinente, nel caso di Morelli non può mancare quella felina. Così il caso Nino Rota può prendere le sembianze di una preda portata, con
uno scatto repentino, in luogo sicuro, da dove sia possibile poter procedere, attraverso la consultazione con altri consimili, ad una mappatura e segnatura del territorio, in grado di allargare il proprio orizzonte. Uno alla
volta, in separata sede, io e altri interlocutori venivamo
allora consultati su temi e spunti offerti dall’opera rotia-
na. Ho un ricordo piuttosto vivido di queste sessioni di
laboratorio dove, in modo del tutto informale, Giovanni poneva un tema che aveva magari discusso il giorno
precedente con qualcun altro all’Università e chiedeva
un commento. Poi, a seconda dello sviluppo della conversazione, ti riportava altri pareri che aveva raccolto o
quella che si stava maturando come sua convinzione,
provocandoti a procedere nella ricerca di una soluzione
o di uno step successivo. Questo ping pong al coperto,
coinvolgeva una rete di relazioni che custodiva gelosamente fino al momento di un incontro personale dove,
immancabilmente, guardando i due «estranei» li introduceva vicendevolmente con la formula: «Ma voi naturalmente vi conoscete già…». Invece ci si conosceva solo per il relato di un dibattito mediato, che alla fine aveva
generato il convegno, l’incontro, la pubblicazione, il concerto per il quale ci si incontrava fisicamente per la prima volta. Questa rete di relazioni gli consentiva di intervenire e/o di venir chiamato ad intervenire su uno spettro amplissimo di situazioni e progetti, mettendo quindi
alla prova in continuazione i risultati del lavoro di questo singolare gabinetto sperimentale nel quale i materiali documentari che via via era riuscito a raccogliere presso l’Istituto per la Musica della Fondazione Cini, costituivano l’indispensabile materia prima.
Ad un certo punto però l’autore, il caso di studio, prendeva, almeno per lui, lo stato di materiale inerte e diventava quindi inutile alla ricerca pura e persino molesto alla quotidianità se invece mostrava pervicaci doti di vitalità ed attraeva nuovi studiosi in loco. Un po’ come un
figlio che pur non volendosene andare di casa agiva da
adulto autonomo nello spazio domestico. Non era giusto
dedicargli le attenzioni di una volta, ma allo stesso tempo era necessario ancora provvedere alla quotidianità e
sopportare anche dei (piacevoli) intrusi. Intanto, i frutti
generati dall’esposizione all’Opera di Rota e di altri maestri del xx secolo erano maturati in una serie di protocolli saggistici, come li aveva definiti lo stesso Morelli, di
cui quattro sono stati recentemente pubblicati da Marsilio raccolti sotto l’intitolazione:
Prima la musica poi il cinema
Quasi una sonata: Bresson, Kubrick, Fellini, Gaál
Già nel titolo, densissimo, c’è tutto Giovanni Morelli:
– Il legame moderno/Settecento con la parafrasi del titolo dell’opera di Salieri-Casti: Prima la musica [e] poi le parole che risuona anche nel libretto di Clemens Krauss per
il Capriccio di Richard Strauss1.
– La forma classica quadripartita della sonata anche se
perturbata da un «quasi».
A leggere l’indice dei nomi, limitandosi ai musicisti, Cristoph Willibald Gluck (1714-1787) prevale con il maggior
numero di citazioni seguito, a grande distanza, da Bach
e Stravinskij. Non vi è invece traccia di alcun compositore «cinematografico». Fra i non musicisti è l’amatissimo Denis Diderot (1713-1784) a ricorrere più frequentemente. È, insomma, questo ultimo libro un ritorno a
casa, fra autori amati e studiati da una vita, arricchito
in modo esponenziale da una lunga fase di studio della musica del secolo appena spento e delle committenze che i media della riproducibilità audio e video hanno
generato. Questo ritorno a casa, se pure completamente
ri-sincronizzato al presente, mi porta inevitabilmen-
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 23
per Giovanni Morelli
24 — per Giovanni Morelli
te ad un altro ricordo personale che mi è rimasto particolarmente impresso. Un giorno al termine di una telefonata che non doveva essere stata proprio idilliaca, lo
udii esclamare: «Io sono un illuminista! Mi devono lasciare in pace. Punto!»
Illuminista certo, di vasti interessi, va bene. Capace di
catalizzare e costruire imprese archivistiche, universitarie ed editoriali che avrebbero richiesto la partecipazione di eserciti di collaboratori e che poi compiva perlopiù
in solitario o con non più di una o due persone alla volta. Ma anche permeato di un pessimismo quasi cosmico, sempre sul punto di trasformare questa incredibile
energia fisica ed intellettuale in una deflagrazione implosiva. E su questo pessimismo esibito al limite dell’assurdo, capitava di imbastire delle piccole commedie dell’arte, nelle quali mi trovavo ad essere una spalla compiacente e, almeno in questo, affine a questo suo tratto.
Così, quando venne a dirmi che pochi giorni dopo si sarebbe operato con
il tono più piano e neutrale del mondo,
senza fare alcune delle solite catastrofiche battute, mi prese una certa inquietudine e cominciai a fare un sacco di domande ansiosamente stupide.
E a me che chiedevo un po’ querulo:
«Ma poi come sarà, dopo l’operazione
e i medici? Come si chiama il chirurgo?»
«Sono bravi, tutti bravi… Non lo so,
tanto io dormo…»
«Ma dai non fare il solito…»
«Tanto io dormo…2 ».
Si alzò, scendendo i gradini che portavano al suo ufficio alzò un poco il braccio destro girandosi verso di me:
«Ciao…»
1
Capriccio, conversazione per musica in un
atto di Clemens Krauss e Richard Strauss
«…prima la musica, dopo le parole…»
rappresentata per la prima volta a Monaco il
28 ottobre 1942. Prima la musica [e] poi le parole,
divertimento teatrale di Giovan Battista Casti,
musica di Antonio Salieri, rappresentato per la
prima volta a Vienna il 7 febbraio 1786.
2
Digressione I. L’obbligo fondamentale della catarsi
«…Questa benevola confinarietà con il sogno è ancora recepita da
Henry Bergson nel suo saggio Sur les données immédiates de la coscience.
Scrive senza sfumare il tema, come si suol dire “papale papale”
Henry Bergson, il filosofo intuizionista, padrino della Recherche:
Lo scopo primario dell’arte è di addormentare le potenzialità attive della
personalità e di avviarci così a uno stato di perfetta docilità ove
si realizza l’idea che ci viene suggerita e dove si simpatizza con il
sentimento motivante la creazione.
Pertanto, se di sedazione si tratta, si tratta di una sedazione forte,
quasi una tenue anestesia».
Da: Il postiglione Cronos – Barry Lindon e ancora il«cinema del Settecento»,
p. 51, in Giovanni Morelli, Prima la musica poi il cinema – Quasi una
sonata: Bresson, Kubrick, Fellini, Gaál, Venezia 2011.
Fabrizio Borin
Forse, l’ultima pubblicazione di Giovanni Morelli è Prima la musica, poi il cinema (Marsilio, aprile 2011) e il sottotitolo esplicativo Quasi una sonata: Bresson, Kubrick, Fellini,
Gaál rimanda ad alcuni saggi dedicati appunto al binomio
musica-cinema. Naturalmente – secondo il ben noto ed
ineguagliabile stile Morelli – non certo nel senso tradizionale dell’indagine usualmente applicata alla sintesi delle
due forme linguistico-espressive quando applicate al linguaggio del film, ma contributi pieni di quelle folgoranti
aperture estetiche, intuizioni critiche e culturali che caratterizzano la scrittura dell’amico e collega recentemente scomparso.
In riferimento a questo aspetto, non è possibile ignorare una tenera e tenace «tenzone» cine-musicale – o musico-cinematografica, come avrebbe puntigliosamente precisato Morelli
– risalente agli anni novanta nell’espressione di
una dialettica che, partendo dalla sua inesauribile curiosità intellettuale, si spostava sul sottile gioco di dare prevalenza, da parte sua, alla sfera musicale e sonora considerando marginale la dimensione visiva. Se cioè un segmento filmico con cui doveva aver a che fare risultava consumato, usurato e rovinato nell’immagine o nel colore, a lui –
in special modo fino ad
una decina di anni or sono – interessava assai poco: l’importante era che
il sonoro fosse integro e
la musica, in particolare, non miagolante, come sovente accadeva nelle registrazioni su nastro
effettuate da copie di copie televisive o ricavate da improvvidi telecinema para-artigianali.
La querelle era sostanziale, professionale e intellettuale e tuttavia Giovanni riusciva anche a stupire per la prodigiosa memoria visiva con la quale commentava o chiariva passaggi, inquadrature singole o intere sequenze di
cui ricordava tutto, o dettagli di film sui quali capitava
di intrattenerci.
Un segno chiarissimo che quella forma di «disinteresse» visivo – che talvolta innervosiva chi, come il sottoscritto, credeva ed insiste nel credere nell’immagine – non
era poi così accentuato come Morelli voleva far credere.
La situazione, fatte le opportune varianti, era, da un lato, più o meno quella di Pirandello quando si scagliava
contro il cinema «parlante» per poi andare molto di frequente a vedere film e, dall’altro, l’assoluta estraneità del
compositore Nino Rota per le immagini dei film di Fellini delle cui musiche è stato l’esclusivo celestiale compositore fino alla fine degli anni settanta.
per Giovanni Morelli — 25
Luigi Berlinguer
Un musicologo sui generis, non certo solo un esegeta.
Con una robustissima dotazione filologica, che gli è servita per suffragare tesi ardite, fra le quali ad esempio quella (dimessa ma decisa) della primazia della musica sul cinema – senza nulla togliere sinceramente alla valenza artistica dello specifico filmico. Prima la musica, poi il cinema
è uno degli esempi della risolutezza con cui sosteneva le
sue tesi e del rigore con cui ne documentava l’analisi. Cito
questo ultimo episodio scientifico per dire con esso della forte personalità di Giovanni Morelli, e del contributo
da lui dato non solo nel suo campo disciplinare, ma anche
nell’azione culturale complessiva, generale, cui ha sempre
mirato – a mia conoscenza – ben al di là del proprio specifico professionale. Anche la cura, il rigore, dedicati alla
gestione dei fondi documentari dei maggiori musicisti ita-
liani del Novecento si inseriscono nel quadro.
A me, non musicologo, ma certo amico di Giovanni,
piace in questo rapido ricordo richiamare l’intreccio fra
il suo spessore culturale-tecnico e la forte sensibilità «politica» nel proporre la «musica per i giovani». Niente demagogia aperturista, ben inteso. Inflessibile. E tuttavia
responsabile curiosità nel cogliere la necessità di aprire
l’azione intellettuale ed educativa ai nuovi bisogni culturali della società contemporanea. Né posso dimenticare
l’attenzione mostratami per la battaglia volta ad affermare che la pratica musicale deve costituire parte ineludibile del bagaglio culturale di base di ogni essere umano,
e quindi è necessario iscriverla obbligatoriamente nelle
«arti del quadrivio» di oggi, per tutti, fin dall’infanzia,
come esercizio effettivo per tutti di imparare a scuola a
cantare o a suonare uno strumento. Fare musica tutti, indispensabile arricchimento degli individui e dell’intera
società. Credo che noi tutti gli dobbiamo un pensiero riconoscente anche per questo aspetto della sua personalità e della sua azione: per ciò che questo può significare per il successo di una solida e qualificata modernizzazione del nostro impianto educativo.
Enzo Restagno
Ci vedevamo di rado il caro Giovanni e io. Con quella sua
allure un po’ da orso e una gentilezza unica parlava quasi bisbigliando. Poche parole e ammicchi lievi sprigionavano un’ironia capace di demolire in un istante i più collaudati castelli in aria. Era però con le parole scritte che
Giovanni spendeva con nonchalance da miliardario i tesori
di un sapere vastissimo, mirabilmente distribuito in tanti
campi diversi. L’idea di non poterlo più incontrare mi rattrista moltissimo ma la sua intelligenza e la sua generosità
continueranno a vibrare ancora molto a lungo.
Emilio Sala
Che cos’è un maestro? Non saprei rispondere, naturalmente (anche perché il vero magistero lo si capisce sempre dopo). Però potrei dire, parafrasando un famoso saggio di Thomas Mann (quello su Wagner del 1937), che un
maestro (vero) è colui che riesce ad accendere in te l’ammirazione. Che è cosa ben diversa dalla dipendenza o dalla
identificazione o dalla sottomissione suscitate da un lea­der
ipnotizzatore (di solito un falso maestro). L’ammirazione
che dico io non è frutto di un’idealizzazione. Non è semplice devozione. I dubbi, le riserve, le critiche, le delusioni,
gli inevitabili edipismi, gli incidenti di percorso, per nulla intaccano l’ammirazione. Ed è una fortuna. «L’ammirazione è infatti la cosa migliore che abbiamo; anzi, se mi
si chiedesse quale sentimento […] io ritenga più bello, più
felice, più atto a farci progredire, più indispensabile, senza esitazione risponderei: l’ammirazione». È quest’ultima
una forza produttiva, fecondante, che ci spinge a crescere, a trovare la strada, a dare il nostro contributo: insomma «è la radice di ogni talento: dove manca, dove muore, nulla più germoglia, là è l’impoverimento, il deserto».
Questo prologhetto è solo – si parva licet – per (tentare di)
esprimere il senso di gratitudine che provo nei confronti
del mio maestro Giovanni Morelli.
A dire il vero, durante la Bildung universitaria ho avuto
per Giovanni Morelli
Nei lustri successivi, e solo per merito delle immagini e
della musica, non certo per le mie impari anche se strenue
difese cinefile, la bilancia si è progressivamente spostata dalla qualità prioritaria della Musica rispetto al Cinema
alla precedenza incontrovertibile che Morelli affidava al dominio musicale, fino ad arrivare, negli ultimi anni, alla
ferma convinzione che il cinema, anche se incautamente si ostinava e si ostina ad ignorarlo o a non volerlo in
definitiva ammettere, è musica e che i veri autori dei film
sono prima musicisti e poi anche registi. Ovvero che alcuni, come ad esempio Jean-Luc Godard, e soprattutto
il Godard dagli ottanta in avanti, facevano musica con
le immagini dei loro film. E lunghe erano le discussioni su Passion o King Lear, su Notre musique fino all’ultimo
Socialisme. Insomma, la questione non stava tanto nelle
problematiche connesse alla dimensione teorico-pratica
dei tradizionali principi ejzenstejniani del montaggio o
anche sulle riflessioni postsemiotiche successive, quanto nell’aura creativa sottesa alla dimensione del tempo e
del ritmo che quelle sezioni di montaggio erano in condizione di suggerire solo previa una estrema attenzione «astratta» del regista per le immagini che, scaturendo dalla musica, approdavano al cinema. In questo senso allora, anche Bresson, Kubrick, Fellini, Gaál, ma pure Jean-Marie Straub e Danièle Huillet o Otar Iosseliani erano autori di sonate, compositori di musica per gli occhi.
Il che non ha impedito al generoso Morelli di assumersi, tra i non pochi corsi universitari professati a Venezia,
anche quello – chiaramente molto seguito ed apprezzato dagli studenti – di Storia della musica per film: una lezione culturale indimenticabile da parte di un musicologo finemente colto ed insieme aperto alle urgenze dei
linguaggi del contemporaneo. Insomma, uno che, al pari del già citato Rota, in ambito critico-estetico e di analisi delle fonti ispirative della musica e dello spettacolo,
non faceva distinzioni elitarie tra «pratiche alte» e «pratiche basse».
E oggi, da che l’amico caro, il collega speciale, il maestro anti-maestro Giovanni Morelli, apparentemente, ci
ha lasciati soli regalandoci però la sua scrittura impareggiabile insieme alla forte traccia della sua speciale presenza umana, quelle sue imperiose asserzioni culturali a
me mancano molto. Ma basterà leggerlo e ricordarlo ancora per godere sempre della sua grande e rigorosa fantasia creativa, una vera musica per l’intelletto.
per Giovanni Morelli
26 — per Giovanni Morelli
due maestri. E il primo (in ordine cronologico) fu Francesco Orlando. Comparatista e musicologo, con una grande
passione per la riflessione teorica, Orlando era, per dirla
con le sue parole, un homme à systhème. I libri e le partiture
erano collocati nella sua biblioteca secondo l’ordine cronologico assoluto. Wagner non solo vicino a Verdi, ma anche a Büchner e a Kierkegaard (a parità di anno valeva naturalmente il mese in cui l’autore era nato). Ho già scritto
altrove di come noi catecumeni musicofili della cerchia orlandiana aspettassimo con trepidazione l’arrivo del nuovo
docente di Storia della musica. Orlando ci aveva annunciato quello «strano» personaggio di cui apprezzava l’intelligenza critica, ma anche temeva l’estro capriccioso (ricordo la sua faccia quando, qualche anno più tardi, gli prestai
un articolo di Giovanni, ancora più labirintico del solito,
che conteneva un capitolo intitolato L’ibis si fa un clistere).
Venne così il gran giorno e in un’aula del piano terra di
San Sebastiano (allora sede didattica della facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Venezia) entrò Giovanni pieno di appunti, penne di tutti
i colori, libri, dischi, cassette. Era
il 1978 (o il 1979?).
Abituati com’eravamo alla sistematicità e al rigore metodologico
orlandiani fummo presi in contropiede dall’eccentricità e apparente disordine
dell’argomentare
(o divagare) morelliani. Quando
poi andai per la
prima volta a casa sua, pensai che
se Francesco avesse visto come erano sistemati i libri
nella biblioteca di
Giovanni (cioè –
almeno apparentemente – a caso)
sarebbe rimasto
traumatizzato. In realtà, ero io nei pasticci: non senza
una certa schizofrenia culturale, la mia ammirazione era
agitata da due venti e anelava pur tuttavia a una sintesi.
Le lezioni di Giovanni erano, esattamente come i suoi
libri, fatte (soprattutto) di digressioni. La non-linearità
dei percorsi da lui proposti era di tipo prevalentemente associativo, a «scatole cinesi», quasi ipertestuale (si direbbe oggi). Se riuscivi a superare le resistenze iniziali,
inevitabili, ti trovavi in un gioco per cui a un certo punto tu stesso dovevi, stabilito un certo quadro, condurre
la partita. Il corso verteva sul problema dell’unité de mélodie di Rousseau, sulla Querelle des bouffons, sulla storiografia
della musica francese tra Rameau e Gluck, ma poi rimbalzava un po’ da tutte le parti e rischiava continuamente di sfuggirti di mano (a volte ti sembrava che sfuggisse
di mano pure a lui). L’esame poteva svolgersi (per i kamikaze che se la sentivano) in uno spirito seminariale:
ognuno sviluppava in proprio un aspetto preso in esame (o anche solo sfiorato) a lezione. Anche Orlando faceva così, e ricordava che «seminario» viene da «seme»,
è un luogo in cui si semina. Tornando a Giovanni, la sua
disponibilità nel fornire informazioni, materiali, fonti,
persino suoi libri, agli studenti era leggendaria. Era anche quello, per lui, un modo di seminare. Quando lessi il
Tristram Shandy (sempre per il suo corso), ricordo che ebbi l’impressione che quello fosse per Morelli il «libro dei
libri». Mi resi anche conto che Giovanni stava cercando
di porre le basi di tutto il suo insegnamento futuro: l’estetica, l’ermeneutica, la musica come oggetto culturale
(e dunque inseparabile dalle sue rappresentazioni) da ricostruire e ridefinire continuamente, in un percorso infinito e sempre provvisorio. Benché (perché?) labirintico e tortuoso, quel corso era stimolante e fecondante: mi
segnò senza che me ne rendessi conto (il vero magistero
può funzionare anche così).
Se ne sono andati a un anno di distanza l’uno dall’altro.
In pienissima attività. Giovanni aveva appena pubblicato il suo ultimo libro, intitolato Prima la musica, poi il cinema. Me lo aveva dato quando ci siamo visti l’ultima volta, alla Fondazione Cini, in giugno. Il punto di partenza
della ricerca è che per ricostruire una corretta «genealogia» del cinema – una genealogia a dominante musicale
– bisogna andare oltre il pre-cinema (camere oscure, lanterne magiche, prassinoscopio, teatro ottico, ecc.). Come ha scritto Jean-Louis Comolli, «il progresso tecnico
non è il motore dell’evoluzione del cinema ma è piuttosto l’effetto». Ne abbiamo parlato per un po’, poi mi ha
detto che doveva operarsi di lì a qualche settimana. Da
anni annunciava in un tono tra il semiserio e l’ipocondriaco la propria morte, ma questa volta il suo tipico humour noir era un po’ meno paradossale ed esibito: mi accorsi per la prima volta che aveva una gran paura di morire. Non ha mai fatto molto per curare la sua salute, anzi, erano diventati rituali i suoi inverni senza cappotto,
il suo rifiuto delle vacanze, ecc. ecc. Che la paura si fosse trasformata in una strana forma di attrazione? A furia di accarezzarla, la morte incominciò a fargli le fusa,
sì che la tema si volse in disìo…
Caro Giovanni, anche se nella tua attitudine anticatartica e antiteleologica probabilmente sorriderai dal luogo dove ti trovi, dove are all equal now, anche se forse (in
quel luogo) starete cantando i versi di Heine – «Der Tod
ist gut, doch besser wär’s, | Die Mutter hätt uns nie geboren» – e tutto vi sembrerà essere tornato al non-senso originario, anche se tutto nel mondo è burla, voglio dirti
che ne valeva proprio la pena. La mia/nostra gratitudine, la mia/nostra ammirazione, fortunatamente intatte,
continueranno qualcosa (un petit rien non del tutto irrilevante, credimi) che mi permetterai di chiamare, faute de
mieux, il tuo magistero.
Carmelo Alberti
Un silenzio inesprimibile. A Giovanni Morelli
C’è un silenzio che non si può esprimere. Semmai, è possibile lasciarlo sospeso nell’intervallo tra le parole. Nella
vita di ogni giorno, invece, sta incantucciato dietro uno
sguardo distolto, un passo incerto, un sospiro ingoiato.
Da sempre Giovanni Morelli agisce per sospendere il
tempo. Perciò, esorcizza le piccole faccende, quelle ir-
per Giovanni Morelli — 27
Il tempo, struttura-base della storia delle civiltà e, insieme, dell’esistenza individuale, è la cifra che contrassegna l’emergere della musica. Per Morelli il tempo è il
paradosso necessario, a partire dall’esperimento mentale studiato da Erwin Schrödinger (il «gatto di Schrödinger»), che pone sullo stesso metro le possibilità attive e
passive dell’infinitamente piccolo e della magnitudine.
Sul piano soggettivo, poi, il modello evidenzia l’organizzazione del ritardo tra reazione neuronale e reazione
corticale agli stimoli.
Nel suo «romanzo» della critica musicale, Il morbo di Rameau (Bologna, il Mulino, 1989), Morelli immagina i ripetuti incontri di due «perdigiorno» al Café de la Régence a Parigi. Jean-François e Pierre-Louis s’accaniscono
nel sostenere differenti interpretazioni «radicali» in merito a Les Indes Galantes (1735), i cui autori, rispettivamente della musica e del libretto, sono i loro zii Jean-Philippe
Rameau e Louis Fuzelier. Di volta in volta, non appena
s’acquieta il tono della dotta polemica, il saggista-narratore fa emergere la voce del testo poetico. Così, nella seconda Entrée delle Indes, durante l’esotica Festa del Sole
degli Incas in Perù (Fête du Soleil, scène v), l’aria di Huascar celebra l’eterna vitalità dell’astro luminoso, che s’estende oltre l’ambiguità delle stagioni, e così si conclude:
De la nuit le voile sombre
Sur vos attraits n’étend jamais son ombre,
Tous les temps, aimables vainqueurs,
Sont maqués par vos faveurs!
Nella saletta degli scacchi, dopo tante discussioni, il
giovane Rameau percepisce il «giusto silenzio», quello che coglie i giocatori mentre studiano le mosse sulla scacchiera. «Il silenzio non nasce dall’arbitrio di due
o più individui… il silenzio è una specie di essenza, forse un profumo. Un manto che accomuna due modalità…
“d’accecamento”» (pp. 143-144).
Il procedimento non s’arresta ancora. Sul finire del saggio affiora la Sinfonia della stranezza di un eccentrico medico-scienziato che, vent’anni dopo la rappresentazione
delle Indes, illustra agli attoniti nipoti la funzionalità di
un teorema, mostrando loro una macchina azionata dal
«movimento coordinato di due gattini» (p. 231). La macchina della volontà, sperimentata analizzando nuclei di
malati, svela l’esistenza di una terza facoltà, oltre la obstruens e la dirumpens. Essa è «un’anima capace di essere
un modulo convertibile. (Convertibile in male, in altro, in
meglio)», in grado d’attivare «nuove realtà». Così è per l’opera di Rameau, genio ammalato da «febbri» patologiche e dalle smanie del secolo dei lumi: le Indes sono un
capolavoro che oltrepassa di gran lunga il dualismo tra-
dizione/rinnovamento. Insomma, se si va al di là del testo, si
comprende come l’arte affondi le radici nella «compromissione neurologica» dell’artifex, ovvero nelle «folgorazioni» figurali dello «spazio-tempo unitario nello spazio-tempo esploso e viceversa» (p. 249).
In tal senso vale altrettanto bene sfogliare lo studio di
Morelli Musica e malattia (in Enciclopedia della musica, ii, Il
sapere musicale, Torino, Einaudi, 2002). Ovvero, per i musicisti «grandi-malati» l’affezione è «un modo di vita», definito dalla creazione di un «tempo intermedio» sottratto alla morte: «E tale tempo, è un tempo che… possiede
una sola risorsa», quella di tradursi in scrittura «“terminata” prima che la morte lo interrompa» (p. 413).
Ogni corpo si muove entro il vortice temporale, cercando una difficile sintonia con gli altri corpi. Alcuni trovano un’interrelazione provvisoria. Una prima immagine:
tre persone sedute sopra una panca, in un lungo corridoio, osservano chi passa, senza parlare. Un’altra immagine: alcuni uomini s’appoggiano al parapetto di un ponte, davanti a un rio veneziano, ritardando il saluto serale. Eppure, tra il silente scorrere del tempo è facile che
s’annidi la maestria.
Morelli è un artefice del senso, è colui che sa accompagnare l’allievo-mai-allievo nel flusso ininterrotto della percezione. Giovani e meno giovani, studenti e colleghi, dapprima smarriti e disorientati, poi rasserenati e
ridenti, hanno potuto ritrovare nella conoscenza ciclica
di Giovanni Morelli un solido punto di riferimento. La
magia dei suoi atti consiste nella perenne ricerca della
giusta/impossibile forma. Alla base c’è il convincimento che ogni gesto deve trovare la vera configurazione, in
un sistema periodico d’irradiazione e di ricomposizione.
Il fulcro dell’insegnamento morelliano è costituto dalla sintesi temporale di ascolto e visione (come si può
comprendere dal suo ultimo libro, laddove parla dell’«insistenza narrativa nella temporalizzazione – “mise
en temps” – del racconto»: Prima la musica, poi il cinema,
Venezia, Marsilio, 2011, p. 25). Larghi frammenti di creatività, tratti dalla memoria del mondo, in apparenza
slegati, finiscono per ricomporsi nella mente, per lo più
dopo un intervallo, sempre sotto l’ala del pensiero libero, preludio a una scommessa culturale assoluta. Al pari dei suoi scritti: getti d’idee concatenate, simili a fili di
un ordito lieve, aperto, aereo, eppure solido, sotto l’egida dell’utopia. O, se si vuole: «creazioni di tempi critici
fra Io e Storia» (G.M., Massimo Mila, «Belfagor», 30 novembre 1989, p. 680).
Non a caso, nel corso degli anni Giovanni Morelli ama
costruire interminabili elenchi di nomi, di opere, di frammenti, simili a filamenti che passano attraverso la cruna
del tempo. Un esempio prezioso del passaggio dal concetto di forma alla non-forma è visibile nel «diluvio di titoli
classici», nell’elenco ininterrotto che accompagna la sua
riflessione su Il «classico» in musica, dal dramma al frammento
(in: I Greci, 3. I Greci oltre la Grecia, Torino, Einaudi, 2001).
Succede, a volte, che una composizione scaturisca dalla
ricerca incessante di un «tema fondamentale». Il connubio tra una scrittrice irrequieta, qual è Gertrude Stein, che
nel 1926-1927 scrive il play The Four Saints in Three Acts, e
il compositore Virgil Thomson, che in quel periodo soggiorna al 17 del Quai Voltaire parigino, si sviluppa intorno alla validità/inconsistenza e alla «ritualità senza cre-
per Giovanni Morelli
risolvibili e continuamente replicate, pronunciando frasi criptiche, ancor più sibilline del solito. La sua espressione enigmatica, generalmente, provoca in chi ascolta
una sospensione, nel tentativo di capire. Durante quella pausa, pare di prendere il volo verso una dimensione
eterea, forse vana, eppure liberatoria. Allora, sul viso di
Giovanni s’allarga un sorriso felino. Il vocabolario dei
suoi atti risulta talvolta imprevedibile, perché è illimitato. Un esempio di quotidianità: al supermercato è normale ch’egli s’accosti alla parete per lasciare passare gli altri.
Come mai? «Mi esercito a essere paziente», risponde sornione, mentre si diverte a sfidare il cronometro collettivo.
28 — per Giovanni Morelli
denza» di un catalogo turistico-culturale (d’ambito spagnolo) della santità. A questo Morelli dedica uno straordinario studio, Very Well Saints. A Sum of Deconstructions.
Illazioni su Gertrude Stein e Virgil Thomson (Paris 1928), Firenze, Olschki, 2000. Da un lato s’innalza il «sistema fonologico» steiniano che prefigura con efficacia rappresentazioni di processioni, visioni, cori di santi; è un’apoteosi della ripetizione (fonetica, ritmica, di assonanze e
traslitterazioni iconiche, e altro ancora), che rammenta
– come scrive il geniale musicologo – una «plasticità attraverso la iterazione» (p. 90), una miriade d’insistenze iper-realistiche, come sintesi della vita. Dall’altro si scorge un
compositore altrettanto sperimentale che sceglie di «far
fare a quei santi un ragtime… Sincopare, jazzare appunto». A un certo momento le strade si sovrappongono: i
Four Saints non sono più in tre atti, ma in due ben diversificati, prossimi al cedimento verso un tempo limitato
ad una sola giornata. Come esclama il primo coro nella
prima parte (404, p. 141):
per Giovanni Morelli
Ovvia ovvia ovvia che giornata
Che ben tre giorni interi
Più uno se n’è andata.
E, alla fine del secondo atto, in un’atmosfera notturna,
si legge un’efficace sequenza, che equivale a una sintesi: «803. Sant’Ignazio si mette in riga, voltato a destra o
a sinistra, di lato. 804. Ognissanti. 805. Per i santi. 806.
Quatto santi. 807. e altri santi. 808. Cinque santi. 809.
per gli altri santi. 809. [L’]-[u] ultimo atto. 810. che è un
fatto [Silenzio]» (p. 149).
Finale di partita. Tra le pagine di Scenari della lontananza (Venezia, Marsilio, 2003) Morelli incide con incredibile precisione l’evanescenza dell’«immagine» di Luigi
Nono, dopo-Nono, che «avvolto nel mantello là nel momento in cui ode il flebile suono quasi-un-silenzio della
esperienza del sacrificio si sta dunque cancellando». Dal
tempo affiora un «altro ritratto di figura in piedi non più
nel lontano libro dei partages, delle sovversioni, delle prove, dei margini, delle interrogazioni, ma nel gran libro
della grande Storia della musica» (p. 138).
Luglio 2011. L’incedere incerto, il braccio piegato all’indietro, i capelli spenti, il respiro ansante: così s’allontana verso il canale della Giudecca, un essere consapevole
fino in fondo di avere un appuntamento decisivo con il
tempo, un uomo sapiente e insostituibile, che ha tentato
in tutti i modi di prefigurare, a sé e agli altri, le fasi della
malattia e le sue soluzioni formali/materiali. In cuor suo
sa che la soglia da superare è incognita, perciò attraente, come l’abisso dell’eternità e del nulla. L’andare senza
fermarsi e senza dolersi mette in moto l’esorcismo delle
tante vite possibili, contenute nello scrigno del tempo.
E adesso? Adesso… chiede silenzio.
Mercedes Viale Ferrero
Riflessioni sulle «fantaCorti» nelle messinscene
delle opere in musica, 1815-1867
Nel 1985 Giovanni Morelli mi invitò a Venezia per tenere
alcune lezioni a un gruppo di suoi allievi, qualcuna in sede universitaria e altre, per un uditorio allargato di amici, alla Fondazione
Giorgio Cini. Gli argomenti li concordammo insieme e i suoi sugge-
rimenti furono preziosi; tra i temi scelti, tutti collegati alla storia della scenografia e della messinscena, vi erano l’orientalismo e in particolare il mito illuminista della Cina, i balletti secenteschi e i loro valori
allegorici, il rapporto tra «vero» e «verosimile» nelle immagini sceniche, la raffigurazione dei centri del potere, dunque delle Corti, nelle
opere in musica. Ho ricordato, in questi giorni, tanti momenti degli
incontri, delle conversazioni, degli scambi di idee con Giovanni e ho
ripreso in mano gli appunti e le «scalette» del 1985 che in realtà avevo continuato a consultare e a utilizzare anche in seguito, per scritti e per comunicazioni in occasione di convegni. Tra queste ultime ho
recuperato quella, non pubblicata, che ora propongo qui; la si potrà
trovare alquanto datata e superata da studi recenti, ma l’intenzione è
stata di connotarla come una memoria e quasi un ritorno al passato.
Stendhal, nella Vie de Rossini, racconta che per la «prima» di Elisabetta d’Inghilterra a Napoli erano giunti «d’Angleterre des dessins fort soignés au moyen desquels on
pût reproduire, avec la dernière exactitude, le costume
de la sévère Elisabeth. Ces habits [...] se trouvèrent convenir admirablement à [...] la belle Colbrand». In realta i
disegni erano arrivati da Milano, erano opera del torinese Giacomo Pregliasco e la loro «exactitude» era discutibile: la vera Elisabetta avrebbe probabilmente trovato
scandaloso il «décolleté» della sua controfigura canora,
che per parte sua avrebbe certamente trovato scomodissimo e per nulla seducente l’abito della Virgin Queen.
In altre parole, la messinscena di autenticazione storica,
teorizzata da tempo e unanimemente approvata al momento della Restaurazione, poteva subire qualche ritocco, in questo caso per conciliare «le prestige des souvenirs» e «l’effet de l’étonnante beauté» della prima donna.
Vi erano, naturalmente, anche altre e più importanti ragioni di deviare dal retto cammino: talvolta per difficoltà
cognitive, quando uno spettacolo era ambientato in una
situazione storica remota o comunque poco frequentata.
È il caso del soggetto di Alfredo il Grande/ Alfred le Grand
/ Alfred: né Sanquirico a Milano né Despléchin a Parigi né i Grieves a Londra portarono in scena architetture
«sassoni»; del resto il loro scopo non era la ricostruzione
archeologica ma l’evocazione di avventure cavalleresche
in un mondo medievale che gli spettatori identificavano con lo stile gotico. Sanquirico non ricerca modelli di
edifici autenticanti nemmeno in Anna Bolena, perché interpretando correttamente lo scenario dettato da Felice
Romani segue un programma significativo che prevede
interni via via più oppressivi, e un solo esterno, per il breve momento di felicità dell’incontro di Anna con Percy
nel parco del castello di Windsor. Poco importa se l’edificio teatrale ricorda solo vagamente quello storico, importa invece che sia recinto da una cancellata, quasi una
gabbia dalla quale la sventurata protagonista non avrà altre vie d’uscita che il carcere, la follia, la morte.
La possibilità di applicare con qualche leggerezza il rigoroso codice di ambientazione storica era condizionata, per altro, dal consenso e dalle aspettative del pubblico che suggerivano e quasi imponevano il codice alternativo della identificazione dei luoghi: nessuna meraviglia quindi se nella piazza dei Santi Giovanni e Paolo di Marin Faliero compare con anticipo di due secoli il
monumento a Bartolomeo Colleoni, o se a sfondo della Piazzetta nell’Otello di Rossini già si vede sull’isola di
San Giorgio la chiesa palladiana. Ne I due Foscari Piave
e Verdi correranno ai ripari avvertendo che l’isola era, a
quei tempi, folta di cipressi; eppure a Verdi probabil-
mente non sarà spiaciuto che Rigoletto, dalla censura trasformato in Viscardello e trasferito in Inghilterra, fosse
riportato a Mantova dagli scenografi con la visione non
solo del sincrono castello di San Giorgio ma anche della anacronistica cupola juvarriana del Duomo. In altre
parole: gli scenografi non operavano a caso o a capriccio; occorre quindi indagare le loro scelte significative,
per molta parte collegate alla fortuna dei soggetti storici che dopo la Restaurazione compaiono con crescente
frequenza sui palcoscenici, alcuni più di altri. Il privilegio goduto da un luogo che geograficamente corrispondeva alla Gran Bretagna nell’immaginario spettacolare
si spiega con la dilagante popolarità dei romanzi storici di Walter Scott, ma non solo, anche col fascino di una
Corte che conobbe episodi tragici, drammatici conflitti, oscuri intrighi: quanto dire un materiale rielaborabile
in varie forme letterarie e figurative e conveniente a plurimi generi teatrali, dal mélo alla tragédie lyrique al balletto e naturalmente all’opera in musica. Analoga attrazione fu esercitata da una città che l’invenzione trasformò
in uno scenario di tragici eccessi: Venezia. Non proprio
una «corte», comunque luogo in cui regnava un potere
occulto tramato di inganni, di odi e foriero di sventure.
Il problema era: come visualizzare sui palcoscenici questo materiale storico – letterario – illustrativo? E come
presentarlo al pubblico connotandolo come un panorama frequentato e quasi familiare? Il primo passo fu la
formazione di modelli, ad opera principalmente della
«terrible imagination» (per usare le parole di Stendhal)
di Alessandro Sanquirico. Il quale non fu l’unico «inventore» ma più di ogni altro documentò tenacemente la sua
opera impegnandosi anche in una impresa litografica divulgativa, la Nuova raccolta di decorazioni sceniche edita da
Giovanni Ricordi e così vantata nel manifesto associativo (1827): «Encomiare l’utilità di simile collezione è cosa superflua [...] offrendo non scarsa materia di studio, e
sicura guida per determinare il Genio e i Costumi delle
diverse Nazioni dei tempi andati, e più particolarmente del Medioevo, in cui tanto variarono le vicende d’Europa». Poiché Giovanni Ricordi era un editore musicale,
l’immagine scenica veniva a collegarsi strettamente alla
composizione operistica: musica e scena erano promosse e diffuse contestualmente. L’impresa finì quando Sanquirico abbandonò l’attività scenografica (1832) ma l’idea
del modello si era affermata. Una rapida campionatura ci
permette di accostare alla Sala di Elisabetta d’Inghilterra di
Sanquirico (modello, Scala 1827-1828) la Sala di Elisabetta d’Inghilterra di Metrodoro Conti (derivazione, Arezzo,
1831-1832). Oppure vedere la Sala nel castello di Windsor per Anna Bolena di Sanquirico (1830, Milano Teatro
Carcano) trascritta con poche varianti da Francesco Bagnara per l’Anna Bolena alla Fenice di Venezia 1833-1834.
Il modello funziona anche quando lo spettacolo è diverso ma la situazione è analoga: le Tombe di Sanquirico per l’Amleto di Mercadante ispirano Liverani per l’Ernani di Verdi. Se si potevano, anzi si dovevano stabilire
dei modelli tematici, ne conseguiva che ogni luogo rappresentato doveva avere un significato corrispondente ad
una specifica situazione drammatica. Questa correlazione, molto evidente negli scenari settecenteschi e in particolare in quelli metastasiani, si ritrova anche nell’Ottocento: ma altri sono i personaggi che abitano nelle effimere architetture sceniche e altre le loro vicende, sicché
i percorsi sono o nuovi o con segni distintivi mutati. L’i-
tinerario di una visita panoramica può iniziare dall’ambiente più connaturato e necessario ad una sede del potere: la Sala (regia, ducale, dogale, nobiliare eccetera) autenticata dalle immagini delle fonti dinastiche o politiche di quel potere, a ragione come nella Sala per Elisabetta
d’Inghilterra ma anche a torto come nel caso di Simon Boccanegra che, primo Doge di Genova, non avrebbe potuto
esporre le effigi dei predecessori immaginate da Filippo
Peroni. Una variante nuova del tema è la Sala d’armi intesa come «status symbol»: già nel 1828 Sanquirico aveva radunato le armature come prova di nobiltà dei Cavalieri di Valenza di Pacini, due anni dopo Victor Hugo definisce una volta per tutte la tipologia del luogo in Hernani, e se ne ritrova l’eco rafforzata nell’Ernani verdiano.
Dalla Sala e dall’Armeria ci si può trasferire all’aperto in
Parchi e Giardini: che non sempre mantengono l’originario significato rasserenante: se Verdi introduce nella
ripresa di Reggio Emilia del Simon Boccanegra il Giardino
dei Grimaldi come pausa di sollievo in un cupo percorso drammatico, in Kenilworth, ballo di Gaetano Gioja, il
Parco è introdotto da un minaccioso ingresso fortificato, sintomo preoccupante tanto più se visto dalla grotta
in cui il traditore Varney tenterà di trascinare l’eroina (la
fonte della scena di Sanquirico non è Scott ma un derivato, il mélo parigino Le château de Kenilworth).
Il Carcere era stato, negli scenari settecenteschi e più
specificamente metastasiani, un luogo iniziatico: subìto
ingiustamente dal protagonista ne saggiava la costanza,
la forza d’animo nella sventura; la liberazione nel «lieto
fine» ne provava l’innocenza e premiava la virtù. Nessuno esce libero e giustificato dalle Carceri ottocentesche:
non Beatrice di Tenda, non Anna Bolena, non Roberto
Devereux, non Jacopo Foscari, non Manrico, non Rodrigo. Conclusiva dovrebbe essere la scena del Sepolcro,
che invece ha connotazioni variabili. Il Sepolcro è, certo, luogo di morte di Giulietta e Romeo amanti sventurati, ma è anche luogo di riconciliazione delle fazioni rivali dei Capuleti e Montecchi. In una accezione che ha come
lontano suggerimento il Lucio Silla di Mozart, come riferimento letterario I Sepolcri di Foscolo e come modello immediato Hernani di Victor Hugo, le Tombe sono visibili presenze delle memorie del passato e taciti incitamenti alle azioni future per i congiurati di Ernani. Nelle
scene, dunque, si riflettono le motivazioni e le passioni
dei personaggi, e si compone un quadro teatrale destinato a suscitare a sua volta le reazioni e le emozioni degli spettatori. Sui palcoscenici rivivono – in opere e in
balli – momenti della storia, vera o trasmutata in fantastoria, che espongono drammatici contrasti tra eroi leali e subdoli traditori, vittime e tiranni, oppressi e oppressori, in un ampio raggio di situazioni. Quasi inevitabile è il passaggio dalla oppressione privata di una vittima incolpevole (Pia dei Tolomei) o anche colpevole (Parisina) alla oppressione politica e dinastica (Maria Stuarda) e infine alla schiavitù di un popolo (Nabucco ma anche Macbeth e Les Vêpres). Diretta conseguenza fu l’efficacia politica di questo sistema comunicativo che aveva
immediata risonanza nel pubblico. Il sistema, peraltro,
aveva strutture narrative abbastanza flessibili e qualche
volta è difficile stabilire i confini significativi dei ruoli.
Elisabetta è al tempo stesso carnefice e vittima in Roberto Devereux, in Oberto Cunizza e Leonora, all’inizio rivali, si scoprono entrambe vittime di Riccardo che da quel
momento sarà la vittima della loro vendetta. Si potreb-
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 29
per Giovanni Morelli
30 — per Giovanni Morelli
be continuare finché giunti al termine cronologico stabilito – 1867 – incontriamo in Don Carlos l’ambivalenza
di Filippo, tiranno che deve amaramente riconoscere la
vanità del potere. Altrettanto ambivalente è lo scenario
di Don Carlos che in apparenza può sembrare un esempio paradigmatico delle fantacorti: il soggetto è storico ma i personaggi lo sono solo in parte e i luoghi realmente esistenti sono reinventati dai pittori dell’Opéra di
Parigi in modo da comporre una immagine ideale della
corte, una società elitaria che corre alla caccia nella foresta, prega nel chiostro, si intrattiene in un sito ridente, si
diletta di balli e mascherate, si dispiega con fastoso apparato in una pubblica piazza, rabbrividisce in un carcere. Ma il momento decisivo dell’opera è posto nell’unico
ambiente ristretto e austero in cui la corte non è presente: allora il significato dello scenario cambia, il Gabinetto di Filippo ne diventa il fulcro rivelatore mentre gli altri luoghi ci appaiono come una sequenza di gusci cerimoniali, come una sia pur sontuosa cornice spettacolare. «Cornice» scrive Verdi in una lettera a Giulio Ricordi
(18 maggio 1883) nel corso della revisione in quattro atti
di Don Carlos: «Voi mi parlate di Filippo, ma badate bene
che se volete che quell’opera abbia un’esecuzione come
si dovrebbe, e che non ha mai avuto in Italia, ci vogliono buonissimi l’Inquisitore ed il Frate. Guardate bene il
poema e lo spartito e vedrete che sono quei tre gli attori ed i motori dell’opera. Tutto il resto è cornice». I miti
della fantastoria sono uno ad uno demoliti da Verdi. Per
Filippo: «Filippo non era così tenero». Per Don Carlos:
«il vero era uno scemo, furioso, antipatico». Per Rodrigo: «Posa essere immaginario, che non avrebbe mai potuto esistere sotto il regno di Filippo». S’intende che qui
Verdi si riferisce al tessuto drammaturgico e non allo
scenario, ma nella stessa lettera contraddice anche la Disposizione scenica che nel finale prescriveva: «appare Carlo v col manto e la corona reale». E Verdi: «Carlo v appare vestito da Imperatore! Non è verosimile. L’imperatore era già morto da diversi anni». Nel Don Carlo riformato Verdi conserva l’apparizione ma la vorrebbe diversa:
«non mi spiacerebbe che [...] fosse come un mazzo d’oro
completamente splendente» (idea suggestiva, difficile da
realizzare con i mezzi tecnici del tempo).
Verdi scrive tutto questo ben sedici anni dopo la «prima» di Don Carlos a Parigi 1867 e soltanto quattro anni
prima che sul palcoscenico della Scala compaia Otello,
inedito eroe corroso dal dubbio. Ma già in Don Carlo (cito Gilles de Van) «Verdi descrive con stupenda modernità il crollo dell’uomo romantico, la fine [...] delle sue velleità eroiche». Per concludere: il lungo regno delle fantacorti è definitivamente tramontato.
Giuseppe Maria Pilo
HWV 50a. Sulle tracce di Esther
Domenica 30 gennaio si celebrava anche qui il Giorno
della Memoria 2011. Per questo le istituzioni cittadine, e
il Comune di Venezia in specie, promossero la produzione, espressamente realizzata, del Masque Esther ossia Haman e Mordechai di Händel (HWV 50) nella prima versione del 1718, che fu messa in scena al teatro Malibran per
l’interpretazione di una giovane compagnia di canto: Sara Bino, Angelo Goffredi, Leonardo Cocon, Velthur Tognoni e del Quadrivium Ensemble sotto la direzione del
direttore israeliano Dan Rapoport curatore anche della
traduzione ritmica in italiano, con la regia e i costumi di
Alexandra Wilson, volendosi in tal modo rappresentare la
Shoah attraverso la storia biblica di Esther, trasposta negli anni della seconda guerra mondiale: Esther, la protagonista giovane ebrea nipote di Mordechai, catturata dai
nazisti e costretta a prostituirsi al servizio di Achashverosh (Assuero) comandante della polizia segreta, il cui vice, il brutale capitano delle ss Haman, emette un decreto
per l’eliminazione fisica di tutti gli ebrei. Esther, incontrata segretamente dallo zio Mordechai che la supplica di
intercedere presso Achashverosh per impetrare la cancellazione del decreto di Haman, sacrificando la propria vita compie la missione; ma, a differenza che nella storia biblica, nel xx secolo – e qui sulla scena – non ci fu lieto fine, non ci fu grazia per gli ebrei, milioni ne furono sterminati: distrutte e cancellate la loro cultura e la loro lingua. Alla fine della rappresentazione, Mordechai intona
il Kaddish, la preghiera ebraica in aramaico su due melodie ebraiche, di Ravel: «Sia magnificato e santificato il Suo
grande nome, nel mondo che egli ha creato conforme alla
Sua volontà, venga il Suo Regno durante la vostra vita, la
vostra esistenza e quella di tutto il popolo di Israele, presto e nel più breve tempo. […]». Il tutto con grande sensibilità e pertinenza interpretativa.
Non conoscevo Esther; e ciò tanto più mi sollecitò a
cercarne e acquisirne in quei giorni un’edizione discografica: vi riuscii, molto fortunosamente, a causa, me ne
avvidi, della estrema rarità della cosa; ciò che sembra in
qualche misura accompagnare la realtà stessa dell’opera e assimilarsi a essa. Di Esther non è chiara la genesi e
non sono chiari gli sviluppi della realizzazione. Scontato il precedente della tragedia omonima di Racine, un
altro punto fermo per me, che professo tutt’altra disciplina, era il venir meno di Händel dalla scena londinese per quasi un anno e mezzo dopo il famoso concerto
sul Tamigi – donde la celebre Watermusic e le sue quattro
Suites – del luglio 1717: certamente Händel, in quei mesi, aveva lavorato moltissimo, più del solito; ma, per me,
punto fermo, come? e perché? In possesso della Sixteen Edition dell’opera realizzata da Harry Christopher, i
miei dubbi si accrebbero: mi trovavo in presenza non già
di un Masque bensì di un corposo Oratorio, ampiamente e canonicamente strutturato in tre parti. Come capirci qualcosa? Chiedendo lumi alla scienza e all’affettuosa
magistrale confidenza di Giovanni Morelli.
Come mi aspettavo, per averne fatto tante volte esperienza e tratto profitto, ancor prima di rispondermi attingendo alla sua sterminata dottrina, Giovanni dissipò
i miei dubbi con il brillare ridente dei suoi occhi. Era il
suo modo umanissimo di comunicare, di dire «ti ascolto,
sono qui per te»; e di introdurre, poi, una concisa, quanto limpida e splendida, amicale «lezione» – non senza far
interloquire di tanto in tanto, quale «testimone» diretto,
lo stesso Christopher.
Händel, in quel giro di tempo, si trovava a Cannons, la
proprietà di James Brydges, il conte di Carnarvon. È una
circostanza importante, perché in quell’ambiente prese vita un’iniziativa originale che ebbe molto seguito, il «Cannons Concert», nel cui ambito prese tra l’altro avvio, sulla
fine del 1715, il rapporto fra Händel e Nicola Francesco
Haym, singolare figura di strumentista, librettista e compositore il cui nome, come tutti sappiamo, ricorrerà molte volte nell’opera del Maestro. In quella fase, Händel
per Giovanni Morelli — 31
Pierluigi Petrobelli
Assolutamente originale tanto nell’impostazione culturale quanto nella molteplicità delle manifestazioni, l’acutissima intelligenza di Giovanni Morelli aveva al suo
centro la musica.
In questa sede vorrei soprattutto evidenziare quanto e in quante forme egli si sia
prodigato, con un impegno uguale soltanto alla discrezione con la quale quest’impegno si manifestava, per la musica e per la vita musicale di Venezia. Sul piano istituzionale con l’insegnamento universitario nella
Facoltà di Lettere e Filosofia di Ca’ Foscari,
formando nel corso degli anni decine e decine di allievi, incoraggiando e stimolando
nel lavoro di ricerca metodi e prospettive
anche non convenzionali. Di rilevanza non
minore per ampiezza di interessi e ricchezza di risultati è stata la sua partecipazione
alle diverse attività connesse con la musica della Fondazione Cini. Uso di proposito una terminologia generica,
perché il graduale evolversi istituzionale dell’attenzione alla musica della Fondazione ebbe in Morelli nel corso degli anni un discreto e insieme fondamentale protagonista, in costante sintonia con le iniziative di Vittore
Branca e di Gianfranco Folena: dalle pubblicazioni dedicate ai centenari vivaldiani alla creazione della Drammaturgia musicale veneta sino alla nascita dell’Istituto specificamente dedicato alla Musica dove, accanto al monumentale lavoro delle trascrizioni di Don Siro Cisilino, si
sono nel tempo aggiunti gli archivi musicali e documentari di altissime figure della musica italiana: Gianfrancesco Malipiero, Nino Rota, Camillo Togni, Luigi Cortese, per ricordare soltanto alcuni nomi.
Ugualmente rilevante – e altrettanto discreta – la collaborazione all’Archivio Luigi Nono, del cui Comitato
Direttivo Morelli fece parte sin dall’istituzione dell’ente. E bisogna pure ricordare la sua appartenenza all’IstiLa copertina del xxviii numero della collana
Drammaturgia musicale veneta, Edizioni Ricordi, Milano 2010.
tuto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, pionieristico sostenitore degli argomenti musicali. Ma non si esaurisce
qui la lista delle discrete – e rilevanti – benemerenze del
nostro amico scomparso. La sua disponibilità nei confronti del Teatro La Fenice e della collaterale Fondazione Amici della Fenice. Questa mia è un’elencazione certamente incompleta, perché basata unicamente sulla memoria e sulle esperienze personali; mi scuso pertanto sin
d’ora se qualche altra benemerenza di Giovanni ora mi
sfugge. Il quadro complessivo – ne sono certo – in ogni
caso non cambia.
Come ho detto all’inizio, ho voluto di proposito limitare l’elencazione alla vita musicale e culturale veneziana, ma le benemerenze di Giovanni a livello nazionale ed internazionale sono altrettante e di eguale portata. Basti semplicemente ricordare la sua costante, completa disponibilità nei confronti di studiosi, di studenti,
di ricercatori di ogni nazionalità che a lui si rivolgevano
per essere illuminati sugli argomenti più disparati. Dotato di quella straordinaria cultura che gli conoscevamo e dell’altrettanto straordinaria memoria, era ben ra-
per Giovanni Morelli
compose gli undici cosiddetti «Anthems di Chandos», più
propriamente noti come «Anthems per Cannons», il Te
Deum di Chandos in si bem. maggiore, e, oltre a un certo
numero di composizioni per cembalo, due opere di vasto respiro, fra loro opposte per ispirazione e contenuti tematici: la prima, registrata da alcune fonti tra le più
precoci come «La Pastorale» poi nota con il titolo di Aci
e Galatea; la seconda, anch’essa dapprima indicata semplicemente come «L’Oratorio», assunse poi assetto stabile come Esther, ed è il nostro HWV 50a: titoli, entrambi,
non riferiti alle due opere prima delle rispettive rappresentazioni a Londra nel 1732; un’unica copia manoscritta di HWV 50a della metà degli anni venti del Settecento reca il titolo Haman & Mordechai, a Masque ed è il titolo che Friedrich Chrysander usò nel pubblicare l’opera
nella sua edizione del 1882 per la Händel Gesellschaft.
Giovanni mi fece scorrere come in un film questa fitta
sequenza di dati con totale facilità, come se nella sua vita non si fosse occupato d’altro.
ro che non sapesse o non potesse soddisfare la richiesta
che gli veniva rivolta. Questa che ad una superficiale lettura potrebbe sembrare un’arida elencazione di dati, era
nella realtà la manifestazione concreta e costante di una
impareggiabile generosità; della quale col tempo avvertiremo sempre più la triste mancanza.
Barbara di Valmarana
È al tuo volto che sono andati i miei pensieri più tristi
quando ho appreso che te ne eri andato, mio caro Giovanni, amico e maestro, punto fermo e sicuro per me, buono e
comprensivo, un sostegno in tutto e un apporto essenziale quale consigliere della Fondazione Amici della Fenice.
Anche se il ciclo della vita ha una conclusione, è impensabile l’idea di non incontrarti più. Dover accettare
questa insensata realtà, che è la morte delle persone che
più amiamo e che fanno parte degli affetti più profondi,
è troppo difficile.
Tu non saresti contento di tutto questo parlare e anche
Margot non lo sarà, ma l’affetto e la grande considera-
32 — per Giovanni Morelli
zione che noi amici e i tuoi colleghi nutriamo per te hanno disatteso questa tua innata riservatezza.
Lascio alle persone più competenti ogni considerazione sul tuo lavoro «a scuola» (così ti riferivi all’università
dove insegnavi), alla Fondazione Cini e sui tuoi libri così densi e determinanti per la storia della musica. Da parte mia posso esprimere solo il grande vuoto che sento.
Barbara
per Giovanni Morelli
Daniela Goldin Folena
Cultura gatti musica traghetti:
su Giovanni Morelli
La sequenza potrebbe far pensare ad un quiz televisivo,
a quelli che obbligano a scoprire, in puro stile enigmistico,
un’inedita associazione semantica tra parole casualmente
accostate. Ma non è così: se mi si chiede di definire Giovanni Morelli l’istinto mi porta a farlo non elencando le qualità
che lo caratterizzano inconfondibilmente nelle espressioni,
nel tono di voce, nel carattere, negli atteggiamenti, nel modo di camminare, e così via, ma proprio mettendo insieme
oggetti-idee che ai miei occhi costituiscono lo sfondo naturale da cui emerge la figura dell’amico-studioso; oggettiidee semplicemente evocati, secondo il suo stile, non da lui
esibiti o dichiarati. Va da sé che cultura qui è impiegata nella
sua accezione più ampia, che comporta conoscenza, competenza, curiosità. Dire di Giovanni che è uno «specialista
di» è estremamente riduttivo, perché nel caso suo non colpisce tanto la quantità delle sue conoscenze, quanto la loro ampiezza e varietà. Con atteggiamento improntato sempre alla discrezione, alla «parsimonia verbale» e all’understatement, Giovanni ha la risposta pronta a qualsiasi quesito –
indipendentemente dalla sua competenza professionale acquisita –, data magari in tono dubitativo e problematico:
dalla biografia del grande artista, al dato bibliografico ricercato, alla medicina, alla storia spicciola, alla collocazione di
una fonte musicale, ecc. Senza che si creino nell’interlocutore complessi di inferiorità; questo dà invece la sensazione
che non ci siano problemi irrisolvibili, che la razionalità e la
misura bastino a sdrammatizzare le situazioni.
Alla considerazione astratta, nel mio personale ritratto di
Giovanni si aggiunge subito un elemento di quotidianità e
di «fisicità». Anche senza aver frequentato molto la sua casa,
sento che i gatti hanno lì un ruolo importante; e non posso
che pensare a gatti discreti, tolleranti, per definizione sornioni e pure dotati di singolare socialità: animali che prevedono una vita attenta a quella del padrone, ma parallela, indipendente, non invadente, sia pure con tendenza all’originalità e talora al gioioso e disinteressato «predominio», quale pare concretizzarsi anche nella intelligente, sorridente ed
elegante Margot.
La musica: frequentatrice assidua, per necessità di sopravvivenza direi, dei luoghi della musica, non posso dire che
quei luoghi siano l’occasione più ovvia di incontro con Giovanni. Nel caso suo, il suo fortissimo legame con la musica
si realizza per me in una straordinaria generosità didattica:
mi sono sempre chiesta come faccia a regalare ogni anno ai
suoi studenti un numero imprecisato e assolutamente non
usuale di corsi monografici. Segno della sua capacità di trasmettere ai giovani il vero senso della bellezza della musica
anche comunicandone la ricchezza delle esperienze; non in
nome dell’abusata e discutibilissima idea che «tutta la musi-
ca è bella», ma – almeno nella mia percezione – nella convinzione che l’intelligenza creativa, artistica, sente la necessità di realizzarsi nelle forme e nei modi più diversi, e che i
giovani, spesso neofiti, devono poter apprezzare la musica
nel suo evolversi o almeno in tutte le sue potenzialità. Ma
Giovanni continua a seminare musica attraverso i suoi allievi diretti che, anche in questo degni interpreti delle attitudini del maestro, insegnano, ricercano, organizzano, fanno
e fanno fare musica. Agli occhi di chi, come la sottoscritta,
ha avuto la fortuna di incontrare tanti grandi maestri, Giovanni è un vero maestro per avere insegnato ai suoi studenti ad andare per così dire a briglie sciolte per la loro strada,
vale a dire a coltivare professionalmente le proprie attitudini musicali frequentando ciascuno gli specifici individuali
campi d’interesse e sfogando quell’interesse dovunque se ne
presenti l’opportunità, vale a dire non necessariamente nel
mondo accademico.
E infine i traghetti: simbolo della straordinaria mobilità
di Giovanni, sempre in funzione delle richieste altrui. Giovanni non va al lavoro per prendere quotidianamente possesso del proprio studio e delle proprie aule di lezione; si ha
invece l’impressione che vada nei luoghi deputati al lavoro
sempre predisposto ad incontrare problemi, anche spiccioli, che si risolvono con i continui trasferimenti per via d’acqua. Capita così di associare Giovanni all’idea del «transito»:
lo si incontra mentre si dirige verso il vaporetto che prenderà per andare a recuperare qualcosa di necessario in una determinata occasione, o qualcosa che ha dimenticato a casa
o altrove, o una cosa rara da lui posseduta di cui ha bisogno
un amico, ecc. Traghetto, transito: oggetti e idee che comportano il senso della partenza ma anche del rientro. Che
negano insomma il senso dell’abbandono da parte di chi si
immagina – come si ripete in queste poche righe – sempre
al presente.
Nuria Schoenberg Nono
Mi riesce difficilissimo scrivere qualcosa su Giovanni
Morelli. Vengono in mente solo le stesse cose che dicono
giustamente tutti: quanto è stato importante per la cultura a Venezia, come era sempre disponibile ad aiutare gli
altri con le sue conoscenze in musicologia, organizzazione culturale, e in tanti altri campi. Uomini come lui sono
talmente rari che non ci sono parole che possono esprimere la generosità umana, l’intelligenza, il senso dell’umorismo, e tante altre qualità sue, che tutte insieme facevano
di lui un uomo al quale tutti volevano bene. Ma non solo questo: molti di noi dipendevano anche da lui per consigli, insegnamenti e altro. Senza esagerare, credo che si
possa dire che è una figura insostituibile nella scena culturale di Venezia. Dire che ci mancherà moltissimo sembra dire troppo poco. Non so dire altro.
Roberto Calabretto
La musica secondo Pasolini tra Johann Sebastian Bach,
Laura Betti e il fascino del canto popolare
L’incontro con Pier Paolo Pasolini è stato uno dei momenti più importanti della mia vita. La lettura degli Scritti corsari e
del Sogno di una cosa, la visione di Accattone e del Vangelo
secondo Matteo rimangono ancor oggi delle esperienze che hanno
molto contribuito alla mia formazione. Quando ho iniziato ad
occuparmi del poeta friulano, Giovanni Morelli mi invitò, con mia
grande sorpresa, ad un convegno dedicato a Nino Rota. Lo stupore nasceva dal fatto che, apparentemente, nulla sembrava unire questi due artisti. Com’era tipico delle iniziative che Giovanni organizzava, questo convegno era dedicato al Candore e, sotto questa insegna, effettivamente i due potevano darsi reciprocamente la mano.
Era questo il miracolo dei percorsi che animavano la mente di Morelli che organizzava giornate ed incontri di studio creando incroci
inaspettati in cui personalità e discipline talvolta lontanissime s’incontravano. Una virtù rara, questa, che solo poche persone illuminate possiedono. Una virtù che anche i suoi testi rivelano per cui colgono sempre il lettore «impreparato» di fronte agli scenari che le loro
pagine aprono con straordinaria ricchezza, suscitando stupore ed invitando ad alzare lo sguardo dal fatto, l’evento narrato, per abbracciare ampi orizzonti in cui i problemi si delineano perseguendo geometrie singolari e di rara bellezza. Tutto è sostenuto da una scrittura in grado di reggere le continue e apparenti divagazioni, mutando
sempre di registro senza mai assumere le pedanti sembianze accademiche ma piuttosto invitando il lettore a porsi costantemente delle domande e a dialogare con il testo, o con se stesso.
Quando ho iniziato ad occuparmi di musica per film ho sempre
trovato in lui un punto di riferimento per ogni dubbio e chiarimento oppure un valido sostegno per definire percorsi di ricerca. Mi sono sempre chiesto quando potesse trovare il tempo per vedere tutti i
film che conosceva e mi inchinavo di fronte alle sue conoscenze enciclopediche che gli permettevano di spaziare nei diversi ambiti della musica e del sapere in genere con grandissima facilità e finissima
acutezza. Nella sua sconfinata produzione ho trovato magistrale la lettura del cinema di Andrej Tarkovskij e, ancor più, l’ultima fatica ( Prima la musica, poi il cinema) che ho letto ancora
una volta rimanendo affascinato dai percorsi che queste pagine riescono ad intrecciare. In effetti, come gli confidavo entusiasta l’ultima volta, solo lui era in grado di scrivere libri del genere, al di fuori di ogni considerazione scontata e forieri di grandi aperture i cui
lasciti andranno accuratamente raccolti e meditati.
Insegnante straordinario, le sue lezioni erano delle vere e proprie
folgorazioni, Giovanni è ancor più stato una persona di rara umanità che ho avuto la fortuna di incontrare e frequentare nel mio
cammino. A lui, più di ogni altro, ho guardato come devoto allievo
nella sua sapienza, nella sua leggerezza e ironia che gli permettevano di guardare le cose e le persone nell’anima, e nel suo candore.
«L’unica azione espressiva forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà»: così Pasolini ha cercato di definire la musica in Poeta delle ceneri con un vero e proprio
adagio in cui si può cogliere il fascino che il mondo dei
suoni ha sempre esercitato nel suo immaginario. Un fascino enorme, profondamente suggestivo, che ha condizionato la sua poetica cinematografica e ha lasciato il
segno, anche se in maniera meno evidente ma pur sempre importante, nella sua narrativa e poesia. Nella parabola artistico-esistenziale di Pasolini la musica non costituisce un semplice oggetto d’indagine, come in altri
registi o scrittori, ma risulta essere una delle chiavi privilegiate per accedere al suo universo e al suo pensiero.
Già negli anni giovanili egli si era avvicinato a Ludwig
van Beethoven in termini «assoluti». Folgorato dall’ascolto delle sue Sinfonie, in una lettera a Franco Farolfi
del 1941 confidava all’amico di non cercare più «la musica oggettiva, descrittiva, ma la musica vivente per se stessa: spettacolo non di figure o caratteri umani, né di bellezze della natura, ma spettacolo vivente per la contrapposizione di sentimenti puramente musicali». Lamentava così i rimasugli di descrittivismo presenti nella Sesta
Sinfonia ed esaltava la Settima in cui, al contrario, «tutto
vi è unicamente musica e ritmo». Dopo Beethoven sarà, poi, la volta di un ulteriore incontro, molto più decisivo e significativo per il regista che, negli anni della sua
primavera friulana, conoscerà la musica di Johann Sebastian Bach, la Ciaccona e l’amatissimo Siciliano, grazie a
Pina Kalč. Pasolini si avvicina alla musica del Kantor tedesco poeticamente, grazie a quell’intuito straordinario
che gli permetteva di cogliere nella natura di questi suoni l’ideale accompagnamento per le scene madri di alcuni suoi film, Accattone in primis, i cui protagonisti sono i
vari sottoproletari, emarginati dalla società, che la musica di Bach invece eleva scoprendo l’intima sacralità della loro vita. Affascinato dalla musica di Bach, Beethoven e, non ultimo, di Wolfgang Amadeus Mozart, Pasolini manifesta invece un netto rifiuto nei confronti delle
avanguardie e dell’arte astratta che negavano il passato
perché non lo conoscevano, e rifiutava le loro aspirazioni, lontane dal suo «sogno di una cosa» radicato nell’umanesimo marxista.
Il rapporto, e i relativi giudizi, nei confronti della tradizione operistica è complesso e sollecitato da molteplici istanze. Pasolini non amava l’opera e, quando non manifesta critiche profonde e radicali, nel migliore dei casi rivela una certa indifferenza nei suoi confronti. Le ragioni di questo suo atteggiamento sono spiegabili sulla
base di diverse motivazioni tra cui la generica, e in questo caso superficiale, identificazione melodramma-cultura borghese. D’altro canto, questa sua avversione è invece giustificata da alcune considerazioni che investono
la natura dei rapporti fra il linguaggio musicale e quello poetico, per cui, a suo avviso, la musica operistica, nel
dilatare semanticamente la musicalità del verso poetico,
lo vanifica rendendo le sue parole del tutto insignificanti,
come si legge in un suo profondissimo adagio dedicato
alla Traviata verdiana. Vaghe allusioni al teatro simbolista francese oppure a quello di Kurt Weill lasciano intuire come egli fosse alla ricerca di nuovi modelli in cui la
musica e la poesia avrebbero potuto incontrarsi seguendo percorsi differenti.
La complessità dei rapporti che uniscono Pasolini alla musica comprende anche una serie di riflessioni sulla
musica popolare nei suoi molteplici aspetti. La sua posizione nei confronti di queste culture, e la denuncia della
loro scomparsa, s’inserisce all’interno della nota polemica maturata nei cosiddetti «anni corsari» contro l’omologazione – «un popolo avanza al suono di una marcia fatta di cattiva musica», scriverà per descrivere metaforicamente questa situazione – che ha distrutto i dialetti e gli
idiomi popolari. Sempre sulla base di questo sentimento nostalgico, egli sposta la propria attenzione anche al
di fuori dei confini nazionali, avvicinandosi alle culture musicali extraeuropee. I riflessi di questo suo interesse traspaiono, ancora una volta, nel suo cinema e nella
letteratura. Basti pensare alle lunghe sequenze di canti
e motivi bulgari e rumeni in Edipo re e Medea, agli assoli
di Gato Barbieri con il suo sax negli Appunti per un’Orestiade africana, oppure ad alcune pagine de L’odore dell’India, in cui egli si sofferma a descrivere la musica indiana.
A completare questo ricchissimo quadro, va infine ricordato l’interesse nei confronti della canzone. Un interesse che nasce nel 1956, anno in cui Pasolini prende parte ad una tavola rotonda promossa da «Avanguardia» per
rinnovare la tradizione della canzone italiana e confe-
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 33
34 — per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli
rire ad essa maggiore dignità. Egli stesso scriverà alcuni testi per Laura Betti a cui dedicherà quattro canzoni
per Giro a vuoto: Macrì Teresa detta pazzia, Valzer della toppa, Cristo al Mandrione e Ballata del suicidio. A distanza di
pochi anni ammetterà anche il fascino provato nei confronti delle «canzonette», dichiarando che «niente meglio delle canzonette ha il potere magico, abbiettamente
poetico, di rievocare un “tempo perduto”». Proprio per
questo il Festival di San Remo e Canzonissima diverranno il bersaglio della sua polemica. Le loro canzoni, oggetto di venerazione del grande pubblico, esprimevano
una facile realizzazione simbolica dei desideri degli italiani proponendo miti banali e degradati con un linguaggio poverissimo e sciocco.
I tasselli dell’universo musicale pasoliniano che qui abbiamo sinteticamente proposto, e inevitabilmente sintetizzato con il rischio della banalizzazione, testimoniano
come nella sua vita la presenza della musica sia stato un
comun denominatore della sua esperienza di intellettuale, regista, scrittore, pittore e poeta che del mondo dei
suoni ha subito il fascino. Proprio a partire da questi impulsi sono nati gli adagi musicali che costellano le pagine della sua narrativa, i suoi percorsi poetici e le colonne
sonore del suo cinema in forma di poesia. Ci piace allora concludere questa nostra breve riflessione con la citazione poetica da cui è partita e che meglio di tutte rivela
quanto abbiamo cercato di dire.
Ebbene, ti confiderò, prima di lasciarti, / che io vorrei essere scrittore di musica, / vivere con degli strumenti / dentro la
torre di Viterbo che non riesco a comprare, / nel paesaggio più
bello del mondo, dove l’Ariosto / sarebbe impazzito di gioia
nel vedersi ricreato con tanta / innocenza di querce, colli, acque e botri, / e lì comporre musica / l’unica azione espressiva
/ forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà.
Giampiero Cane
Con Giovanni Morelli ci lascia una delle personalità più
sfaccettate, intelligenti, aperte e gentili che abbia avuto la
musicologia nel dopoguerra, un uomo che fu calamita e
vaso di poliedriche qualità.
Non solo i suoi interessi sempre furono molteplici, ma
essi fruttificarono nel tempo mescolati l’uno con l’altro
in un pensiero «terzo», fusi l’un nell’altro e suggestivi e
chiari dietro l’apparente confusione portata dallo spiazzamento, dalla deterritorializzazione delle componenti dell’insieme.
Credo fosse per molti irritante, in quanto percepito come sfuggente dall’universale, immotivato nei percorsi,
se non incomprensibile. Con lui il compito sembrava costantemente quello di trovare altrove, fuori dal campo in
cui le cose date paiono stare naturalmente, gli strumenti
per rivelarle meglio negli aspetti d’insieme e di significato, mentre magari per le questioni di dettaglio, grammatica e sintassi dove possibile, funzionava appieno il territorio di apparente pertinenza.
Era uno studente di medicina, ai primi anni, quando lo
conobbi, ma presto abbandonò l’università per seguire il
proprio demone ben più complesso, forse cogente. Non
so se da quegli studi, ma mostrerà in seguito una certa
passione per i farmaci, terapie dei corpi e delle menti, ai
quali continuò a pensare con disposizione socratica e il-
luministica, non raramente usando della descrizione dei
loro effetti per ragionare di qualcosa di musica.
Ma, anche in lui, quest’ultima non pareva destinata a
diventare materia di professione: alla fine degli anni cinquanta inizi del decennio successivo, amava molto suonare l’organo, ragion per cui frequentava, direi senza alcun altro interesse, certe chiese dove gli era permesso
suonare. Credo la sua prima sortita pubblica sia stata per
una recita, nella quale la storia di Don Giovanni, non fedelissima, se non ricordo male, a Da ponte, si mescolava
con Marionette di Kleist. Al testo direi avessero lavorato
collegialmente, la regia direi fosse di Guidobaldo Grossi, la scena forse di Piero Copertini, degli attori ricordo
soltanto Luciana Negrini, allora fiamma amorosa di Alberto Panighi, ottimo fotografo, d’impostazione naturale al reportage, ma nella vita impegnato in tutt’altro. Da
dietro le quinte veniva il suono della tastiera di Giovanni
che improvvisava variazioni dalla musica di Mozart, una
recita alla Jean Paul della furia romantica, spassosissima.
Tra gli amici di allora c’era un ottimo incisore, Carlo Santachiara, un adorabile disegnatore, Bruno Bandoli, un poeta ancora in potenza, poi a Roma amico di
Kunellis, Marco Gherardi, un pittore, Piero Copertini,
mai entrato nel mercato, e un politico scissionista, Savino Marinelli che sapeva tutto su Leopardi; tutti, tranne
quest’ultimo, oggi nell’al di là, figure defilate dalla ricerca del successo, tutte vispe ma con misteriose ragioni di
malessere, non palesi però ancora nei vent’anni che erano in quei tempi i loro. Anche Giovanni giocava a dipingere, un occhio a Klee, uno a quel che conosceva di Giacometti o di Wolls; amavamo tutti Southerland e Moore,
ma si cominciava a sentire un effetto America, tra jazz
(Parker), cinema (Kazan) e pittura (Pollock) mentre lo
spirito leggero portava Santachiara e Morelli a pubblicare le loro tavole di cartoon in certi libretti che uscivano
dall’editore Sampietro, il cui maggior collaboratore per i
rapporti coi creativi era Adriano Spatola, forse non ancora poeta visivo, ma curioso postsurrealista, molto vicino
a Giorgio Celli, altre intelligenze che se ne sono andate.
Non so come e non so perché, ma certamente per meriti acquisiti, a un certo punto Giovanni, prima della metà dei sessanta, entrò all’Accademia, a Bologna, per insegnarvi Disegno anatomico. Credo suo padre avesse avuto la medesima cattedra da qualche parte in Emilia. Dopo un paio d’anni, egli mi diede infatti un volumone didattico della materia che era un libro originariamente di
suo padre, ch’egli aveva riveduto e ampliato. Ogni tanto
andavo a trovarlo in classe.
Non saprei se l’avesse ispirato la relazione quasi immediata tra la scrittura di Parini e l’immagine di quel di cui
egli dice, ma in una delle mie visite trovai che mezza classe se ne stava in corridoio, mentre l’altra metà era in aula: ciascuno studente aveva davanti a sé, finto o vero che
fosse, un osso dello scheletro e lo descriveva a parole,
quale mero oggetto, senza nominarlo. I risultati dell’osservazione sarebbero poi andati a chi al momento stava
fuori, che avrebbe ricavato dalle descrizioni verbali un
disegno. Quindi le parti si sarebbero invertite.
Quantomeno era una mossa geniale per impegnare nella scrittura studenti che nulla avrebbe nella scuola spinto a scrivere.
Quando incontrai Giovanni, ero forse più rossinista che
rossiniano, e amavo Stravinskij, Ravel, lui Verdi, Boulez, Webern; qualche anno dopo ciascuno dei due an-
per Giovanni Morelli — 35
Alla fine degli anni ottanta.
dere per il terrorizzato Bandoli corso in camera di Margot e Giovanni cercando aiuto contro fantasmi rumoreggianti di là, dove lui dormiva.
La notte dell’allunaggio, sono in debito, finalmente mi
metteva in condizioni per me piacevoli. Venezia non è
una città per biassanot (per sciupanotti), men che meno alla Giudecca. Soffrivo sempre di solitudine notturna, ma
finalmente, quella notte tutti, ed eravamo i soliti, erano
determinati a star svegli fintanto che l’evento fosse avvenuto. Quando la tensione si fece acuta per l’allunaggio, m’addormentai.
Giovanni, che grossomodo dormiva dalle 23 alle 5 quella notte s’addormentò dopo di me.
Con lui ho perso un fratello che ormai vedevo piuttosto raramente. Non m’è mai piaciuta granché quella città, ma quando lui aveva ancora tempo finiva coll’essere
piacevole sia lo stare in casa che l’uscire insieme. Fra Cini,
università e altri impegni, a Giovanni era diventato quasi impossibile ormai disporre di sé. Se il tempo è denaro,
il tempo libero, intendo, ormai non ne aveva quasi più.
Marcello Conati e Teresa Camellini
Era la mattina del 17 settembre 1977. Gli studiosi si stavano riunendo nel salone della Fondazione Cini per partecipare a una tavola rotonda sull’opera italiana organizzata da Gianfranco Folena. Fu in quell’occasione che conobbi Giovanni, presentatomi da
Petrobelli. Mi accennò al tema della sua relazione, «l’aria di follia». Mi colpì il suo atteggiamento dimesso,
quasi fosse, la sua, una
presenza marginale. E
invece avevo davanti a
me, senza ancora saperlo, colui che sarebbe diventato il maggiore musicologo italiano
per ampiezza e profondità di argomenti
– da Haendel a Verdi,
da Stravinskij a Scott
Joplin, da Vivaldi a Nono – all’insegna di un anticonformismo senza eccezioni che è stata una lezione per tutti
noi. Gli devo molto come studioso. Gli devo moltissimo
come amico. Per l’ampiezza delle sue vedute e per la profondità del suo sapere era diventato il nostro indispensabile consigliere, cui dobbiamo alcuni suggerimenti per la
fondazione dell’Istituto Memoria & Durata e i suoi rapporti con la Fondazione Cini. (m.c.)
Ma è nella singolare geometria delle anime e delle menti che bisognerebbe cercare per spiegare il virtuosistico e
affascinante modo di svolgere il lavoro da parte del prof.
Giovanni Morelli, per me Giovanni, capace di ascoltare
i giovani musicisti, e studiosi, incoraggiarli, senza venire meno nella severità di giudizio e sostenerli dopo averli messi alla prova: grazie, Giovanni, per avermi fatto fare questa esperienza.
Nell’ambito delle prossime celebrazioni verdiane che
per Giovanni Morelli
che quel che amava l’altro. Quanto al jazz non c’era problema: musica per lui fenomenologica, per me ideologica almeno un poco, fenomenologicamente non ci portava a contrasti. Nelle visioni di Berio e Maderna un po’
di più, ma con Nono, come dire?, un’incolmabile distanza. Non saprei, ma...
Ma non so in che anno, la sera della Festa del Redentore, capita che, a mezzanotte circa, Nono viene portato
a casa di Giovanni, in punta della Giudecca, non so da
chi, ed entra nel salone, due divani, un tavolo rettangolo, un paio di poltrone, due lunghi tavoli scrivania, ma
soprattutto ormai portastrumenti, cioè registratore, amplificatore, giradischi, proiettore, sintonizzatore, mangianastri e altre cose, tra libri e partiture, e, nel rettangolo
tra i tavoli un pianoforte a coda. Il M.o Luigi che probabilmente aveva libato alquanto al Redentore di tutto ciò
non s’accorse minimamente per cui solo dopo un qualche tempo di conversazione se n’uscì «ma v’occupate di
musica?», dicendo. Giovanni l’amava sorridendo, ma gli
attribuiva anche, contemporaneamente, qualità superiori nel senso acustico.
Fu certo più divertente, in quella stessa casa alla Giudecca, incontrare Melandri che, indipendentemente l’uno dall’altro, evidentemente ambedue conoscevamo. A
Bologna lo incontravo facilmente in zona universitaria
in un’enoteca frequentata anche dal suo protegée Roberto
Dionigi. Enzo aveva appena pubblicato La linea e il cerchio (Il Mulino). Io mi ci stavo consumando, senza prenderne possesso, Giovanni non so perché il
parlar d’altro era pressoché un dovere, visto che il
filosofo quella sera era piuttosto terreno e mondano, romagnolo (come Giovanni del resto, faentino) e i suoi maggiori interessi andavano a una
«ragazzuola» che lo accompagnava.
Il nuovo che ci impedì i consueti, amati conflitti fu John Cage.
Qui, ora che piango la morte di Giovanni, incapace di raggiungere Margot o Andrea, il figlio
di lei e Liberovici, praticamente da sempre adottato da Giovanni, vorrei solo ricordare a chi mi
legge un libro di educazione musicale che firmammo insieme, Musica senza padri, e la colonna sonora di un film, La lunga linea bianca, che facemmo insieme. Non credo di poter parlare di
quel ch’essi sono.
Ma, per raccontare di lui, della sua casa, dei suoi
amici, dirò della notte dello sbarco sulla luna, ma
prima di un’altra circostanza.
Tutti sapevamo che Bruno Bandoli (di cui sopra) aveva una ridicola paura dei fantasmi. Non ricordo chi fossimo alla Giudecca quella sera, ma a tavola si parlò d’uno scheletro probabilmente murato in una qualche parete dell’antica casa. Il «perfido» Giovanni aveva preparato un nastro con suoni da film dell’orrore, catene, lamenti incomprensibili e altro, dopo una mezz’ora di silenzio. Lui fece partire il registratore mentre s’andava a
letto. Io e probabilmente Piero si dormiva di sopra. Giovanni e Margot in camera loro, Andrea (Liberovici) nella sua e Bruno lì su un divano del salone nel quale di lì
a poco dall’esserci scambiati la buona notte, egli rimase
solo, assopendosi.
Non ne sapevo nulla, ma il giorno dopo fu tutto un ri-
36 — per Giovanni Morelli
si svolgeranno a Parma a ottobre del 2011, l’Isitituto Memoria & Durata, codiretto da Marcello Conati e me, dedicherà a Giovanni Morelli il progetto «Verdi e la musica nuova», da lui sostenuto sin dall’inizio sia dal punto di
vista musicologico che musicale proprio per il suo interesse ad alcuni livelli di associazione tra la musica di Verdi, la musica del Novecento e quella contemporanea. L’Istituto m&d lo ricorderà, inoltre, anche come etno-musicologo nella terza rassegna dei «Canti della Tradizione
Orale», che si svolgerà a Fumane di Valpolicella il prossimo marzo 2012. (t.c.)
per Giovanni Morelli
Fiamma Nicolodi
Quello che ho sempre ammirato in Giovanni era la sua
capacità di unire un’intelligenza fuori del comune, una
grande versatilità di interessi e competenze (dal cinema
alla letteratura, alla medicina, alla sociologia, ecc.) con
uno spirito organizzativo di grande lucidità ed efficienza
(qualità che generalmente non si conciliano, tendendo le
prime verso l’astrazione, le seconde verso la specializzazione, l’ultima verso la prassi).
Lo conobbi nel 1979 alla Cini. Anche per una come me,
che ha poca memoria per i numeri, questa data è difficilmente dimenticabile. L’allora direttore del Gabinetto
G.P. Vieusseux di Firenze, Alessandro Bonsanti, mi aveva affidato per l’anno successivo l’organizzazione di una
Mostra e di un Convegno per celebrare i cent’anni della
Generazione dell’80.
Per la ricerca dei materiali cominciai dai privati: Paola
Masino (erede del lascito Bontempelli), Laura Dallapiccola, Elsa e gli eredi di Vittorio Gui, Elsa Respighi, Aurelia e Virginia Torrefranca, Maria Stella Labroca, Lele
d’Amico e Suso Cecchi, Bruno Pizzetti, Andrea Pirandello, Angelica Savinio, e molti altri. Quindi mi mossi
verso i Musei e i Teatri che potevano ravvivare con i loro
quadri , bozzetti, figurini carte e documenti, altrimenti noiosi per i visitatori (Civico di Torino, Depero di Rovereto, Comunale di Firenze).
Sapevo che la Cini possedeva, in un’ampia stanza, la ricostruzione dello studio di Respighi, una parte dei suoi
autografi musicali, alcuni libri e qualche lettera. Giulietta
Malipiero, l’ultima moglie di Gian Francesco (li conoscevo entrambi da anni), capitò in uno dei giorni delle mie
perlustrazioni alla Fondazione veneziana, per portare (a
spizzichi e bocconi, come usava fare) parte del materiale del marito ormai defunto, che poi sarebbe stato interamente collocato lì.
Deda Muraro mi affidò nelle mani di Giovanni, che
era responsabile della sezione musicale, il quale dimostrò subito un grande spirito collaborativo, una perfetta conoscenza del posseduto e mi aiutò moltissimo a districarmi nelle carte che cercavo (e anche in quelle che
trovai senza cercarle).
Quando si trattò di donare l’Archivio di Alfredo Casella, di cui unica erede era mia madre Fulvia, la scelta
fu immediata. Lei si accollò il compenso della schedatura del fondo del padre a quattro borsiste, che lavorarono
un intero anno nello studio del piano di sotto a quello
dove abitavo, che avevo messo a loro disposizione. Giovanni fece pubblicare i quattro volumi della schedatura
(Catalogo del fondo Alfredo Casella, Firenze, Olschki, 1992),
che resta a tutt’oggi un lavoro scientifico di prim’ordine,
al quale i musicologi ricorrono con frequenza.
La donazione del Fondo, avvenuta di lì a pochi anni a
Venezia, alla presenza di Bruno Visentini (allora presidente), di Morelli, della sottoscritta e di mia madre (conquistata dall’ironia, dal fine acume e dalla diplomazia
di Giovanni, con il quale rimase sempre in contatto) fu
molto rapida. Ci furono dopo poco altre donazioni convergenti con il panorama culturale posseduto dalla Cini: i Fondi di Nino Rota, di Aurel M. Milloss, di Camillo Togni, che Giovanni faceva schedare e desiderava venissero conosciuti attraverso pubblicazioni di notevole
risonanza scientifica.
Seguirono negli anni successivi i ben noti Convegni della Cini, di cui Giovanni era l’ideatore, insieme con Gianfranco Folena e Maria Teresa Muraro. Vi andavo spesso e trattengo ricordi indimenticabili non solo dell’accoglienza principesca, di cui oggi non esiste più traccia nei
Convegni italiani e stranieri, ma della scelta dei temi e
dei relatori, dai quali imparai sempre molto.
Un’altra tappa che approfondì la nostra conoscenza fu
quando, al corrente delle sue illimitate curiosità, mi rivolsi a lui per un progetto ministeriale che mi frullava
per la mente (all’epoca si chiamava murst ex 40%), ma
che necessitava di una messa a punto scientifica e pratica.
Mi recai da Morelli a Venezia e ne ebbi delle idee, come
al solito, non solo illuminanti, ma realmente fattibili. Si
trattava di un «Lessico della letteratura musicale italiana
dal 1490 al 1950»: una banca dati informatica (fornita di
cd-rom), che venne finanziata per diversi anni. All’inizio
ad essa collaborarono, a partire dal 1989, solo musicologi (fra i primi: oltre alla sottoscritta e Giovanni, appunto, Marco Beghelli, Renato Di Benedetto, Fabrizio Della Seta, Maurizio Giani, Anna Quaranta, Adriana Guarnieri, Marcello De Angelis). A questi si aggiunsero due
storici della lingua italiana, Paolo Trovato e Fabio Rossi, e due informatici, che portarono il loro indispensabile contributo. Con un inevitabile ricambio fisico-generazionale, alla fine il gruppo coinvolse oltre una quarantina di persone. Tre volte l’anno, avvenivano delle riunioni collegiali a casa mia (che si diradarono poi nel tempo quando il progetto era ormai ampiamente rodato), in
cui si discutevano i «campi» da riempire inizialmente su
cartaceo, le modalità di lavoro, si correggevano le schede e Giovanni affidava ai presenti dei test in modo da arrivare a un’omogeneità di vedute nella scelta e nella definizione dei lemmi.
Il lavoro era affiancato da una serie di convegni, dove
i partecipanti del lesmu, che avevano lavorato su determinati testi (trattati, saggi, riviste, epistolari, biografie,
ecc.), esponevano i risultati delle loro ricerche.
Il primo Convegno si svolse nel 1993 e fu ospitato, grazie alla consueta, generosa disponibilità di Giovanni, alla Cini. Ne uscirono due volumi in onore di Gianfranco
Folena: Le parole della musica i (a cura di Nicolodi e Trovato, Olschki 1994) e ii (a cura di Maria Teresa Muraro,
ivi, 1995).
Negli anni i nostri rapporti rimasero sempre ispirati a
una reciproca stima e fiducia (ma ero più io ad avere bisogno di lui che viceversa).
Ci scrivevamo per e-mail o ci telefonavamo; frequenti gli incontri ai convegni più disparati, oppure a Venezia quando andavo per alcuni spettacoli della Fenice ben
selezionati e a me per lo più ignoti, a Firenze (dove aveva casa), o se doveva incontrarsi con il comune amico
Daniele Olschki per svariate pubblicazioni della Cini.
L’ultima volta che l’ho visto è stata a Firenze il 24 maggio del 2011. Con Gossett, Chegai, Della Seta, Toscani,
Fabbri e Guarnieri, Mila De Santis e io lo avevamo invitato a Firenze per un Convegno del Dottorato di spettacolo (che quest’anno spettava alla musica). Giovanni
mi scrisse che doveva fare una coronarografia: sperava
di non essere ricoverato proprio quel giorno, ma che comunque il suo contributo era già stato scritto e nella peggiore delle ipotesi ce lo avrebbe inviato. Invece venne e
parlò da par suo di un tema intrigante che verrà pubblicato prossimamente negli Atti del nostro Dipartimento di Storia delle arti e dello spettacolo di Firenze: «Dopo la morte apparente: tre vie di rinascita (incompatibili) per il teatro del Novecento». Evitò, come era solito fare, il pranzo-comitive, ma partecipò attivamente al dibattito offrendo spunti di riflessione a tutti i partecipanti (studiosi e dottorandi).
Gli scrissi il 3 luglio una lettera nella quale mi complimentavo per il suo bel libro su musica e cinema, ma non
ebbi riscontro: la qual cosa, stante la sua sollecitudine nel
rispondere mi inquietò non poco.
Dopo il silenzio, inframmezzato da alcune notizie allarmanti degli amici Messinis.
La sua scomparsa resta un lutto incolmabile non solo
per una vecchia amica, che continuerà a ricordarlo pensando sempre a lui come a un consulente fraterno, ma per
tutto il mondo della musicologia e della cultura.
Ellen Rosand
La morte di Giovanni Morelli, il 12 luglio 2011, ha privato il mondo musicologico di una delle sue luci più brillanti. Un uomo dotato di talenti prodigiosi, energia e pazienza, con una sovrumana attitudine al lavoro e ai rapporti
di amicizia. Giovanni era – e rimarrà – un mito vivente.
La sua carriera è stata ricca di paradossi. Sebbene avesse una formazione accademica in medicina, ha dato importanti contributi in un campo completamente diverso, la musicologia. Nato e cresciuto in Emilia Romagna,
è stato uno studioso di Venezia. Il suo lavoro copriva la
gamma completa della musica veneziana, dal Seicento
ai giorni nostri, sebbene i suoi interessi tracimassero oltre la laguna, a nord verso Francia, Germania e Austria,
a ovest verso gli Stati Uniti, persino a oriente, verso la
Cina, e spaziassero ben oltre la musica, fino alla gamma
completa delle discipline umanistiche: arte, storia, letteratura, psicologia, filosofia, cinema.
La sua reputazione a livello internazionale è considerevole sebbene sembri che soltanto uno dei suoi innumerevoli lavori sia stato tradotto (il suo saggio per la Storia
dell’opera italiana) e solo alcune tra le sue pubblicazioni abbiano ottenuto recensioni all’estero. In effetti, sebbene
la sua bibliografia sia costituita da oltre duecento voci,
soltanto alcune di queste si possono reperire tra i libri e
le riviste disponibili nelle biblioteche internazionali; altri necessitano di scoperta da fonti effimere, in particolare dai programmi stagionali dei teatri veneziani. Morelli si è recato a poche, se non addirittura nessuna, conferenza all’estero, ma ne ha ospitate a dozzine a Venezia,
sotto gli auspici delle varie istituzioni alle quali era associato, la Fondazione Cini, Ca’ Foscari e il Teatro La Fenice. Ha offerto l’ospitalità della sua Venezia a studiosi
provenienti da numerosi Paesi, in una vasta gamma di
settori, tutti da lui «professati». E grazie alle sue doti di
curatore, gli esiti di queste conferenze sono stati conservati in un notevole numero di Atti, pubblicati quasi annualmente a cominciare dalla metà degli anni settanta.
In effetti, Morelli sapeva esattamente chi invitare a queste conferenze. Lettore vorace in diverse lingue, era dotato di un autentico orecchio per le voci dominanti in ogni
settore; queste includevano studenti con dottorati nuovi di zecca, provenienti dall’estero, la maggior parte dei
quali egli aveva incontrato di persona, quando si erano
rivolti a lui per consulenze in merito ai loro progetti su
Venezia. Questi erano stati mandati dai loro professori,
che, a loro volta, avevano incontrato Morelli in passato,
a una precedente conferenza della Fondazione Cini o in
una biblioteca di Venezia.
Sebbene scrivesse in italiano, la sua padronanza delle
lingue straniere, incluso l’inglese, risultava dovunque evidente. Il suo ovvio piacere nel trovare il titolo perfetto,
volutamente allusivo, complesso o malizioso – Il morbo di
Rameau o Il paradosso del farmacista o Prima la musica, poi il cinema – si estendeva in modo memorabile anche all’inglese, persino per i testi italiani But stop my House’s ears, I mean my Casements, per un articolo sulla musica e l’architettura nel 2001 Very Well Saints: a Sum of Deconstructions per
il suo breve volume su Four Saints in Three Acts di Stein e
Thomson del 2000; You lamp, you handtowel, you plate, you
maple leaf, you sugar, per il suo studio inerente a Metaphorical Concordances di Scott Joplin, del 1979. E l’elenco potrebbe continuare.
Morelli era una presenza a Venezia fin dai primi anni
settanta, quando vi faceva regolarmente la spola dalla sua
cattedra di disegno anatomico all’Istituto di Belle Arti di
Bologna per la sua ricerca di musicologia. In seguito alla
sua nomina a Ca’ Foscari nel 1978, tuttavia divenne un’istituzione nelle biblioteche e negli archivi veneziani. Magari non era un viaggiatore a livello internazionale, ma a
Venezia era sempre in movimento: dalla Giudecca a Ca’
Foscari all’isola di San Giorgio, talvolta diverse volte al
giorno, con soste alla Marciana, o a qualche archivio o
altre mete intermedie. Occasionalmente, la routine veniva interrotta – durante le sessioni di esami all’Università, per esempio, quando si fermava all’ateneo per giorni
interi. Fissare un incontro con lui era una vera sfida. Se
riuscivo a raggiungere la Marciana all’ora giusta, lo trovavo lì. Se ero in ritardo, e lui mi aveva aspettato, potevo trovare un messaggio che mi aveva lasciato, o una bibliografia che aveva pensato di trascrivere per me, assieme ad alcuni suggerimenti su dove reperire il materiale. In uno di questi elenchi, che includeva riferimenti bibliografici a fonti di rilevo nella Biblioteca Nazionale di
Firenze, mi indicò quali volumi fossero ancora inaccessibili a causa dell’alluvione del 1966.
Sarebbe impossibile per qualsiasi singolo studioso valutare la sua vasta e varia produzione. A Ca’ Foscari teneva corsi di Storia della musica contemporanea, Filologia musicale, Musicologia sistematica, Storia e critica del
testo musicale. Tuttavia, persino una lista delle materie
che sono state oggetto dei suoi studi, non può che risultare incompleta. Esse spaziano dall’opera del Seicento a
Metastasio, Vivaldi e Rameau, da Boito e Verdi a Schoenberg, Thomson/Stein, Joplin, Casella, Malipiero, Nono, Kurtaje e Nino Rota. Molti tra i suoi primi contributi
al mio stesso settore, l’opera del Seicento, sono classi-
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 37
38 — per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli
ci che continuano a essere citati. Questi includono studi
documentali fondamentali (in particolare Tre controversie
intorno al Teatro San Cassiano con Thomas Walker (1976),
oltre a saggi interpretativi (come ad esempio il notevole
Scompiglio e lamento che scrisse per il programma dell’Egisto, che ha curato per La Fenice nel 1982). Ma, nuovamente, un simile elenco potrebbe difficilmente dare un’indicazione esauriente della gamma dei suoi contributi agli
studi sul Seicento. Non include la sua sorprendente scoperta nel 1985 della Finta Pazza di Sacrati sull’Isola Borromeo, opera perduta da lungo tempo (che segretamente – e immediatamente – ha condiviso con me) o l’ambiziosa Drammaturgia musicale veneta, la serie di trenta volumi che include facsimili di importanti spartiti, che ha curato assieme a Lorenzo Bianconi a partire dal 1982 e che
solo ora sta giungendo alla sua conclusione.
Era difficile stare al passo con la sua prodigiosa produzione, non solo per i numerosi settori coinvolti, ma per
la qualità lungimirante del suo pensiero e il carattere assolutamente personale della sua scrittura, spesso più affine alla poesia che alla prosa, alla filosofia che alla storia. Un recente commento del critico Roberto Calabretto al suo libro, Scenari della lontananza: La musica del Novecento fuori di sé (2003), rispecchia la mia personale esperienza: «La lettura di un testo di Morelli coglie sempre il
lettore impreparato». Sì, mi posso sentire impreparata,
ma continuo a leggerlo con ammirazione e umile piacere
e a consigliare le sue opere tra i miei studenti, a quelli in
grado di affrontare l’originalità, la ricercatezza e la complessità del suo pensiero e del suo linguaggio.
Morelli era generoso nelle sue amicizie. Molti tra i miei
colleghi americani ed europei lo consideravano un amico intimo. Nell’ambito di volumi celebrativi, alcuni dei
quali anche organizzati e curati da lui stesso, Morelli
ha omaggiato molti di loro: Carpitella, Conati, Cornoti,
Degrada, Magini, Milloss, Mongredien, Pirrotta, Nuria
Schoenberg, Schneider, Strohm, Walker, Ziino e Rosand.
La sua rara combinazione di lungimiranza e competenza, già evidente dagli inizi della sua carriera, deve aver
conquistato la benevolenza delle «autorità accademiche»
del passato di Venezia, poiché egli assunse gradualmente
ruoli di responsabilità praticamente in ogni centro importante di studi musicali della città – dal Dipartimento
di Musicologia e Scienze dello Spettacolo a Ca’ Foscari, dove ha insegnato per oltre quaranta anni, all’Istituto per la Musica presso la Fondazione Cini, di cui divenne il primo direttore nel 1985. Sotto la sua guida, le attività di ciascuno di questi enti si sono sviluppate in maniera esponenziale, al punto tale che Venezia è ora all’avanguardia nella cultura musicale contemporanea, una
risorsa per studi che spaziano oltre la storia essenziale
dell’opera barocca, fino a includere il jazz, la musica per
il cinema e l’etnomusicologia.
Morelli è stato, a mio parere, l’unico responsabile della buona salute della musicologia veneziana odierna. Soprattutto grazie agli sforzi di quest’unico individuo, in
pubblico e in privato – tramite gli istituti che dirigeva e
tramite i suoi personali contatti e le sue amicizie – Venezia, un tempo un autentico deserto, se messa a confronto con altri importanti centri di ricerca come Firen-
ze o Roma, è divenuta un luogo fertile per la fioritura di
ricerche musicologiche di ogni genere. La sua morte lascia un terribile vuoto al centro. È difficile immaginare
che possa esistere un altro singolo individuo in grado di
compiere ciò che lui ha fatto per la sua città d’adozione.
Sarà impossibile sostituirlo.
Carlo Carraro
L a notizia della morte di Giovanni Morelli (14 maggio 1942 – 12 luglio 2011), che dal 1978 ha insegnato musicologia a Ca’ Foscari divenendo un punto di riferimento per la vita musicale veneziana, è stata data con ritardo
e in sordina dalla famiglia, per suo stesso volere: uomo
mite e schivo, Morelli non amava la pubblicità e il clamore e ha scelto di andarsene silenziosamente, con lo stesso
atteggiamento con cui aveva vissuto per tutta la vita. Eppure, è bastato che la notizia trapelasse sui giornali e nei
siti internet perché un’enorme quantità di persone – soprattutto studenti ed ex allievi – inviasse messaggi nei social network e diffondesse improvvisati necrologi all’interno dell’università. Mi è capitato di vederne uno affisso sul cancello di una delle nostre sedi: poche parole di
uno studente, che voleva ringraziare così per tutto quanto aveva ricevuto da lui.
Un professore di straordinaria umanità, oltre che di profonda dottrina: così lo ricordano anche i colleghi, e così
lo definirebbero anche coloro che lo hanno incontrato
nelle istituzioni veneziane cui Morelli si legò, prestando
loro la propria competenza e la propria sensibilità. Tutte le principali fondazioni culturali cittadine che hanno
anche la musica tra i loro campi d’interesse – tra cui, ovviamente, la stessa Fondazione di Venezia – hanno potuto contare su Giovanni e si sono rivolte a lui non solo
per le sue conoscenze, ma soprattutto per la sua capacità di tracciare percorsi culturali innovativi, di anticipare
tendenze future, di intercettare la sensibilità delle nuove
generazioni. Anche per questo la sua morte ha così colpito i giovani: nonostante egli fosse giunto quasi al termine della sua carriera accademica, Morelli aveva ancora
la capacità di interessare i giovani, di coinvolgerli e addirittura di stupirli più di tanti colleghi meno anziani di lui.
La freschezza del suo pensiero gli ha consentito di dare,
negli anni, un impulso determinante agli studi cafoscarini sulle arti e sullo spettacolo: oltre che burocratico presidente, egli è stato ispiratore e promotore di interi corsi di
laurea dedicati a un settore che dev’essere centrale nelle
strategie di un ateneo come Ca’ Foscari, cioè quello della conservazione e produzione della cultura artistica. C’è
da sperare, ora, che la sua eredità non si disperda e qualche cosa di lui resti ancora nella vita del nostro ateneo.
Andrea Zanzotto
La scomparsa di Giovanni Morelli è un lutto ancora fresco, per cui non riesco a parlarne facilmente. Tanto più che
è molto difficile dire qualcosa di un vero e proprio genio,
che non ha mai voluto farsi notare. Ed è difficile in primo
luogo capirlo, perché scrive ermeticamente, ma ha una
potenza di pensieri e di associazioni che pochissimi posseggono, se non nessuno. Tra noi c’era una grande sintonia, e nelle nostre conversazioni passavamo con disin-
per Giovanni Morelli — 39
*Il testo di Andrea Zanzotto nasce da una conversazione con il poeta
realizzata a Pieve di Soligo il 12 agosto.
Marzio Pieri
Gli innocenti cancheretti
La rivoluzione che vogliamo chiamare barocca
(pre-pro-illuminista) [quella che ci ha acquarellato
Frances Yates nel suo libro dorato sull’illuminismo
barocco] inventa questa legge: tutto sia detto
come se
le cose non avessero nome, come se i fatti non
avessero terminologia, come se i temi fossero sempre
linguisticamente estranei alla coscienza.
G. Morelli, L’Egisto [di Faustini & Cavalli(1643)1]
Exit G. M. Si vorrebbe richiamare per lui l’esempio del Sileno, tali e infiniti tesori uscivano di quella cella. Ma nulla in lui dell’orrida
parvenza satiresca, la pelosità come scrisse lui
quasi a scusarsi di avere utilizzato, in un incipit, il solito apoftegma del lupo del pelo e del
vizio. Non era uomo da proverbî, in realtà,
parlatore riservato ma diluviale scrittore, faceva sùbito intendere che la lingua è un male
necessario, una testura di trabocchetti; tanto
peggio se uno credeva di potersi pontare sulle frasi fatte. Come Benjamin e qualche altro
scrittore del fu-contemporaneo (una presa di
distanza ironica che rubo da una sua pagina)
Morelli forse sognava il libro fatto solo di citazioni (meglio se accompagnate da amnesia
o diffrazione circa l’autore, il tema od il luogo
di provenienza, sicuro qualche lettore, ora l’uno ora l’altro
li avrebbe ritrovati da sé [fuori di una possibile, anche pallida consistenza l’ipotesi marinistica di un ‘furto ben celato’, o di un furto tout court /Morelli dava molto più che
prendesse e sempre sempre, come una fontana stregata/,
non da escludersi tutto il picassiano, o strawinskiano, ‘io
non cerco; trovo’]) ma con la consapevolezza che solo il
moto che le aveva richiamate, poteva, sposato all’Ironia,
salvarle, dall’autocomburio. Vedete quest’ultima virgola?
Di troppo; si rifà ad uno dei suoi modi prediletti di scartare
la frase dall’automatismo, il lettore dalla troppo appagatamelodizzante soddisfazione. Non temeva di farsi cogliere
in scivolo d’anacoluto, di tendere ben altro che proustianamente il castello di carte delle proposizioni accumulate e circuitanti, en abîme o tromba-delle-scale ascendente
a comporre una specie di periclitante, effimero tempio o
sepolcro indiano. Allora sarà meglio richiamarsi (con la
mente a un altro maestro d’ironia, Montale) alla dissimi-
glianza proclamata fra il Bel Soriano e la Lince. La Bella
Lince, la Belle dame sans merci. Era Lince e Soriano insieme e nessuno ebbe mai il menomo riguardo nell’essere
pronto, provvido dissipatore del suo a favore di qualsiasi
altro, non importa se simpatico o meritevole. Credo che
ogni peccato fosse da lui previsto e perdonato come in anticipo, tranne la stupidissima legge del Copyright. Tempi
iniqui ci toccò di traversare, pèste di senescenza vanagloriosa e pettegola; conobbi anche un Brutto Soriano, che
mise in pompa se stesso una volta che ebbe scovata per sé
la dizione: ‘musicologo’; esigeva il diritto d’autore anche
su una schedina da lui firmata di recensione discografica. Per colpa sua fallì (e lo avevano pure pagato bene!) la
StopIt di Bianconi & Pestelli, e, con essa, l’irresponsabile
edt. Tarde non furon mai gratie diuine.
II
Cancheretti? Nella franante disposizione su due o tre
schiere per scaffalatura, guai se un libro che cerco non
vien fuori alla prima. Non posso verificare se di cancheretti si trattasse, o cancherini,
la parola che mi colpì la prima
volta che lo ascoltai, G. M., nella gran sala delle riunioni alla
Cini. Parlava di Metastasio e
la lettura confluì poi nel libro
dell’’85, Paradosso del farmacista.
Il Metastasio nella morsa del tranquillante. Metastasio era stato
colto, da Morelli, in flagrante
nel suo eterno lamentarsi di vaghi disturbi, distonie neurovegetative, affanni da scadenze
e, nell’insieme, un sottoporsi
da solo al lavoro di uno squadrone. V’era, in Morelli, una
attorialità geniale, gli piaceva
provare le ‘parti’ allo specchio
degli interlocutori; gouldianamente, perdipiù, telefonici. Io,
che in fatto di distonie non l’ho
ceduta certo al Metastasio, non
posso dimenticare la sua voce,
bisbigliata, lontanissima, nella
cornetta che è la mia dannazione. Sollevo il ricevitore e sono colto da sordità. Duravano a lungo quei bisbigli, quei soffii; si era al confessionale o nella penombra di uno studio psicanalitico, quella
psicanalisi della quale Morelli faceva sempre lietissimo
uso in quanto la conosceva meglio di un professionista
e tanto da potersene, poi, anzi a una volta sola, prendere
gabbo? Giovanni deversava nella nostra (nella mia) irrequieta tensione decifratoria il diario di mali innumerevoli che ci affrettavamo a inscrivere al registro degli immaginarii, altrimenti avremmo dovuto (era il minimo)
prendere il primo treno per Venezia, cercare di salvarlo.
E, difatti, non ci siamo riusciti. Ma, in quel lagno divagatorio, l’attenzione scattava, repentina e tenente. Ho altre volte ricordato come la mia esperienza di malipieriano in partibus risalga a Gianfranco Folena. L’esperienza
del lavoro comune all’Adone per gli Scrittori d’Italia, per
intervento un tantino ignobile di circostanze accademico-editoriali pressanti, aveva lasciato qualche piaghet-
per Giovanni Morelli
voltura da un argomento all’altro, dalla poesia alla musica, dalla musica al cinema, quasi senza accorgercene. Il discorso si avviava naturalmente, ma quando entrava in scena il potente musicologo io mi ritraevo di fronte alle sue
conoscenze infinite. Avevo letto il suo ultimo libro, che
parla di quattro opere cinematografiche, e avevo messo
via delle domande da fargli alla prima occasione. Sondare il suo pensiero era complicato anche per la sua espressione italiana: direi che giocava a nascondino, mentre con
grande umiltà rivelava le cose.*
per Giovanni Morelli
40 — per Giovanni Morelli
ta, qualche cancherino nel rapporto fra il Maestro padovano e il giovanotto di belle speranze in cui oggi mi riesce riconoscermi, non senza perplessità. Dunque mi prese affatto di sorpresa una telefonata della segreteria della Cini, nella persona di Maria Teresa Muraro, che a nome di Folena mi invitava a metter sù, alla svelta, un mini-convegno celebrativo dei dieci anni dalla scomparsa di Gianfrancesco Malipiero. Si erano mossi tardi e la
grande musicologia internazionale era ormai tutta impegnata con un macro-convegno a Reggio Emilia. Obiettai che io, di Malipiero, conoscevo solo il magnifico libro einaudiano, con quel titolo stupendo, Il filo d’Arianna. Saggi e fantasie, da me scovato su una bancarella in anni (miei) di fustigante insolvibilità; ebbimo anche noialtri i nostri anni di bel precariato. Certo, quel libro era
sùbito diventato uno dei miei libri; ma come facevano a
saperlo alla Cini? E, ascolti, zero o quasi zero. A Firenze
avevo (ma forse me lo sono solo sognato) assistito a una
ripresa delle Sette canzoni, affidata a un maestro sostituto
dopo che vi si era immolato Scherchen. «A me accadono sempre cose esagerate» (fu il commento di Malipiero). Se non è un sogno (sarebbe stato il ’66, anni che a riordinarli mi ci vorrebbe un biografo stipendiato), ricordo solo l’applauso che strappò l’Olivero, con lo scoppio
deliro conclusivo della terza canzone, Il ritorno. Incontro
di tre magnetismi, in un loro gioco mortale. Si era lontani dalla invenzione del cd, che avrà anche relativamente
peggiorato l’ascolto, rispetto ai costosissimi e riottosi vinili, ma ha reso disponibile una messe di cose rimbucate
in sottotetti o infognate sotterra che neanche era dato,
allora, immaginare, se non in qualche sogno pantagruelico. Oggi, ch’io sappia, in cd, di Malipiero manca solo il
Torneo notturno, e, temo, anche la Favola del figlio cambiato.
Ma ogni cosa a suo tempo. Non batterono ciglio. Ebbi
un baule con tutti i libri, i libretti, manoscritti e altre robe preziose di Malipiero, su quelli lavorai alla dartagnasca e ci ritrovammo, tra Venezia e Asolo, nei bollori di
un’estate da poco trascorsa, in una mano di fedeli all’ombra del più libero, dèdito e stravagante compositore italiano del Novecento2 . Nel teatro (riaperto per l’occasione, tutto polvere scricchiolìi e fasci di luce stracca spiovente di cosa in cosa) ci fece visita, per l’intera durata del
concerto, il pipistrello, l’anima segreta del grande musicista. Avevano invitato anche Pirrotta, gran signore della rinascente musicologia italiana, e l’ottimo Waterhouse, che di Malipiero tutto sapeva, quanto al périssable, ma
neanche sospettava che riesce, criticamente, inoperante voler giudicare la musica di Malipiero – le riuscite e gli
smacchi coi criterî di Benedetto Croce, filtratigli dal Mila. Sono lontani i tempi di Guglielmo Scotipera e l’Inghilterra si è dimenticata di quello che importa il Sublime.
III
Ora, il segreto di Giovanni Morelli è appunto classificabile come Immissione /del Sublime/ nella musicologia; e come Immillazione /del Giudizio/ nella scrittura. Come unione ‘alla pari’ di Paradosso e Verificabilità.
Il paradosso (come pei cancheretti del Metastasio in farmacia) è che esso, di norma, per Morelli non si affida al
momento ‘logico’, o discorsivo, del giudizio, a una percezione ‘filosofica’ dell’atto critico, ma nemmeno /paradosso nel paradosso, per un uomo di così inesausto sapere/ a una sorta di teorema, o scacco-matto, ‘filologi-
co’, vuoi una serie di operazioni rigidamente prescritte,
che se non intervengono errori di calcolo, di procedura, garantiranno del raggiungimento finale di un verumfactum incontrovertibile. Non è accidentale che l’ultimo libro di lui, in questo che doveva essere l’anno della sua momentanea scomparsa, Prima la musica, poi il cinema. Quasi una sonata, non sia un libro stricto sensu di argomento musicale ma una amorosa proposta (una volta di più) di ribaltamento delle prospettive, per cui dalla
rilettura di quattro autori cinematografici (Bresson Kubrik Fellini e il meno universalmente noto Gaál) appassionatamente musicofili, si ottiene una «interpretazione
del cinema come momento evolutivo di alcune poetiche
musicali poi precipitate in stato di crisi e di estenuazione
della loro potenzialità comunicativa». Così legge la scheda in quarta di copertina e la parodia dello stile liquidosindacalese potrebbe essere l’ultimo sberleffo (preterintenzionale?) del nostro grande amico. In fondo, in quello che resta il suo capolavoro-precoce (e, come tale, tuttora ch’io ricordi consegnato alla sede originaria, si pensa ormai di fatto irreperibile, che fu il programma di sala
della Fenice, allora non ancora cacciariata, nell’occasione del primo passaggio extra-insulare della messinscena scozzese /Glasgow/ dell’Egisto di Faustini & Cavalli,
allestito da Raymond Leppard, [Giovanbattista britannico della Barock Renaissance, che poi lo scavalcò spregiudicatamente] e dall’americano John Cox), Morelli dichiarava, col gesto di mascherarlo, il proprio complesso
metodologico: il richiamarsi al materialismo storicistico
(lontano dal materialismo storico, ideologico, non meno che dall’idealismo, inibito alle sorprese dell’empiria e
prammaticamente schematico) e una lucida ossessione
genealogica, usata come scandaglio e come defigurazione-rifigurazione problematico-esplorativa. In parole più
semplici: l’opera, qualunque opera, nel senso irrevocabile
dell’operare cose determinate in una situazione determinata
che vale, ogni volta, da eterno pregiudiziale e revocabile (opera) e in quello perfezionista e cangiante [a mettere
in azione due pure coppie di ossimori] (opus), (ammesso
e non concesso che, a dirlo così, riesca davvero più semplice) non vive altrimenti che in funzione di un pubblico, di quella particolare idea del pubblico che se ne siano fatti gli inscenatori del prodotto offerto. Si vince (o,
più spesso, si perde) ‘per una volta sola’. Mentre cala il
sipario, i due Dulcamara sono già sulle poste per ignota destinazione.
IV
Ecco come il Barocco e il Sublime coincidono. L’arte non ha altri diritti da invocare. Morelli direbbe: «una
stagione di ricerche»3 . Va da sé la fuga scandalizzata di
quelli che cercherebbero il fungo dell’eterno anche sotto la capocchietta (più spesso velenosa) di un madrigale
o di uno schizzo tracciato col carboncino. Morelli spiega bene come il fare operista viva piuttosto nel segno
della rinuncia e della fobia, compensative. «... modi per
la persuasione radicale della audience al senso di onnipotenza fatto rappresentazione». Chiedo venia di rammentare che il cambio d’ordine, il passo ad altra stagione (del
Barocco ritrovato) sarebbe avvenuto solo qualche anno dopo (1987), col colpo di mano di Billie Christie (e di
Jean-Marie Villegier e Carlo Tommasi) nella ‘terra [recintata, inibita] di nessuno’ dell’Atys di Lully. Copro-
per Giovanni Morelli — 41
Si assiste alla creazione di un vocabolario, di un ‘fraseggio’ ad hoc, – «una stagione di ricerche», «una questione di conoscenza» – che a noi cresciuti nella letteratura,
ma aperta sulle musiche a perdita d’orecchio, ricordava,
remotamente, il più antico e ‘precisissimo’ Carlo Bo (il
Mallarmé del 1945), e, attraverso lui, le ricche Miniere di
Francia. Fu questo, essenzialmente, che salvò una parte
della mia generazione dalle pastoie dell’idealismo di sinistra: si poteva passare, senza obiurgazioni, da Bo (dal
suo Serra?) a Rivière a Barthes a Derrida (La pharmacie
de Platon, prima versione «Tel Quel» 1968, poi raccolto ne
La dissémination quattro anni più tardi, non dovette essere estraneo al Metastasio in farmacia di Morelli) a Foucault anche o proprio perché si era litigato col suo allievo Derrida, insomma «il mondo viveva». Questo ci mise
in urto con quasi tutti i maestri, pudibondi, gratta gratta, del loro esser stati fascisti. Eh!
V
Ma ci siamo dimenticati, frattanto, di Morelli al telefono. Alla mia ‘puntata’ malipieriana aveva fatto séguito
un altro invito, anche questo piuttosto sbalorditivo, ora
proprio da parte di Morelli (solo quei «cancheretti» mi
avevano fatta prendere in considerazione vitale l’umanità del poeta Trapassi, da me fin allora considerato, e lo
scrissi, il «braghettone della cattiva musica», vulgo l’imbalsamatore formalizzante della spinta libertina barocca, oltre il secolo ad essa più opportuno), a collaborare a
un libretto che lui stesso aveva concepito, Il tranquillo seren del secol d’oro. Musica e spettacolo musicale a Venezia e Vienna fra Seicento e Settecento 5 , e dove a me toccò di stilare un
invito al Tito di Cesti. Ancora mi imbarazza la resistenza
ottusa che mantenni rispetto agli inviti (sempre discreti,
sornioni, possibilisti, come a Lui piaceva mostrarsi) di
Giovanni a una lettura in coppia, del Tito veneziano, con
la Bérenice di Racine. Annasai che c’era stato dietro qualche pasticcio e finalmente scopersi la faccendaccia brutta di Luigi Re Sole che deve, per la ragion di stato, abbandonare la sua, di Berenici, la Maria Mancini figlia di un
barone romano astrologo e negromante (averlo saputo
allora!) e nipote del cardinal Mazarino, che si oppone a
quella flagrante e scandalosa liaison. Luigi pianse e disse
di sì (al cardinale), lei fu sposata a un disamato, ne fuggì, fu chiusa in un convento, ne fuggì, lascia un libro che
si vorrebbe leggere: La Verità nel suo preciso aspetto. Certo
era bella, una morettina coi capelli ricci, stonata in quella corte dove si andava col passo dell’Oca. Io, invece, me
la cavai per la tangente, m’ero dimenticato che il saggerello ebbe una pre-lettura torinese, quando al Carignano la solita compagnia della dianzi citata Poppea (il Complesso Barocco di Curtis) mise in scena l’opera di Cesti
& Beregan. Mi fu d’aiuto il fatto che fra i miei ascolti discografici rientravano già due mie cotte, quella per la Calisto di Cavalli (nella sontuosa edizione di Glyndebourne,
ricostruita e diretta come un musical da Raymond Leppard e messa in scena da Peter Hall, vivaddio senza imbragature pseudofilologizzanti /che filologia è quella che
drena le acque e gli spiriti del teatro?/, dal lontano 1972,
edita dalla argo, una divisione della Decca, con Baker,
Cotrubas, Bowman, Teresa Kubiak e Hugues Cuenod
[una ninfa di Diana], sulla coperta del box un presupposto Agostino Tassi, – lo Stupratore, o Iniziatore Violento dell’Artemisia, sì, l’Artemisia Gentileschi, figliuola dell’Horatio caravaggista, insomma una faccenda di
Penelli –, Diana e Calisto, che si serba alla National Gallery di Londra) e quella per l’Orontea di Cesti & Cicognini6 , un decennio dopo pari pari, adattamento e direzione musicale di René Jacobs, allora trentaseienne, con un
‘Continuo’ nel quale si leggono oggi, con lieve trasalimento, i nomi di William Christie di Jaap ter Linden di
Konrad Junghänel... e soprattutto mi aiutò, agli occhi di
Morelli, il fatto che, nella fase calante del decennio precedente, io avevo pur èdito l’Adone e la Galeria del Marino. Non si facciano pettegolezzi.
VI
Il fatto è che il mirabile saggio (di certo preparato e
per Giovanni Morelli
duzione Paris-Firenze-Montpellier, immediata la distribuzione discografica da parte della Harmonia Mundi,
mentre ancora le majors ‘non osavano’. E dire che i ‘Tre
Tenori’ erano là da venire. La Fenice, del resto, non era
stata a guardare; l’effimera, e per questo a noi carissima,
collana ‘Musica/Aperta’ della Fonit Cetra, serbò prontamente la traccia sonora (inadeguata, per forza di cose,
al Gesamtkunstwerk del Barocco) di due ragguardevoli tappe del pionierismo post-antico4 , propiziate dalla circostanza della Biennale Musica ’79, L’Orfeo di Sartorio,
diretto da René Clemencic, con regia di Giancarlo Cobelli e scene e costumi di Lauro Crisman, e l’Incoronazione di Poppea, del Complesso Barocco di Alan Curtis, andata in scena il 5 settembre 1980, regia scene e costumi
di Sanjust. L’heroica riesumatione sartoriana era, nel fascicolo preparato per accompagnare i dischi, arricchita
da una riproduzione anastatica, ‘parlante’, come le ‘cose’ parlano, del libretto di Aureli, che rimetteva l’opera in
situazione anche per via della grafica, e da una premessa di Mario Messinis. Il tema della Biennale (come lo illustra la sempre lucida prosa messiniana) pare in singolare concomitanza col pensiero presto attivo e attivante
di Giovanni Morelli, solo da pochi anni approdato a Cà
Foscari, per insegnarvi musicologia, dopo i tredici anni
bolognesi (Accademia di Belle Arti). «La scelta di un simile tema [“i rapporti tra musica e mitologia, nella esperienza moderna e contemporanea, ma anche nell’opera
barocca veneziana”] nacque anche dal rinnovato interesse che le nuove generazioni rivolgono agli archetipi mitologici e ai valori primari come ricostituzione e ricupero dell’universo linguistico, dopo le tendenze decompositive e meramente fenomenologiche, tipiche degli Anni Sessanta». Quella che chiamano, stringendosi nelle
pieghe di un mantello del tutto scolorito e inaffidabile,
«la Storia», è una frana di forze che, quando lo decide la
gravità e la legge della impenetrabilità dei corpi, insomma la fisica, il moto extra-umano della materia, la nostra
intrinseca spendibilità, assume certe attitudini – spesso
oscene, o improbabili, o ridicole – di giacitura, di fissabilità; le stesse leggi decidono quando è maturo il momento che il franare ripigli, riavanzi. Verso il basso. La
frase successiva di Messinis potrebbe essere stata scritta
da Morelli (non è per nessuno un mistero la loro generosa complicità): «Si propose una questione di conoscenza: l’incontro della musica con il mito e la mitologia, determinatosi storicamente, per alcune istanze non ancora sufficientemente chiarite /corsivo mio/ di socializzazione, di
confronto e di verifica attraverso i tempi».
per Giovanni Morelli
42 — per Giovanni Morelli
redatto come esemplare, esemplare in quel senso che si
è detto, valido per 4-5, dieci anni; non si capisce donde il Filologo si ritenga immune dalla Attenzione Ambasciante, e dalla Istantanea Ricalcolazione di un qualunque giocatore di Borsa, con l’Infarto nel taschino...)
sull’Egisto è, fra innumeri altre cose, («disgrega i pensieri», scrisse dell’Adone, l’avvocato veneziano e librettista
/forse/ monteverdiano Busenello) un gioco, finalmente intelligente!, e senza virtuose mutrie, con l’Adone del
Marino. Era convinto che me ne sarei accorto. Lui (sentimento che io lodo) non si avvaleva, per leggere il poema, delle due edizioni ‘moderne’ fiorite in contemporanea, post tot tantosque casus, sul mercato editoriale, proprio
del resto in articulo mortis, perché di lì a non molto le due
illustri collane di classici italiani avrebbero chiuso, con
breve scandalo, i battenti per sempre. (Può accadere di
peggio; nel 1979 una legge francese aveva escluso dalle
scuole l’insegnamento della filosofia: dovette accorrere
Derrida. Nessuno dunque si senta più autorizzato a darci lezioni di Bastiglia). L’uso che Morelli fa dei versi del
Marino, giurerei da una qualche ristampa secentesca lasciata intatta alla Cini per due o tre centurie d’anni, è incalzante e sbrigativo, come d’uno che prende degli appunti; sembra un rapido culto celebrato agli Iddij del Refuso, sacro (è noto, almeno dal Tesauro) agli scrittori barocchi. Io quel poema ce l’ho quasi tutto in testa ma debbo sorprenderne i lacerti diffusi qua e là dall’amico baroccheggiante per ritrovarne il fresco, lo spregiudicato,
la ‘vita vera’. Debbo dirlo? Mi ritrovo come alle prove
di un’opera seria, o di una pastorale comica, o di un pasticcio con canti, o di una recita di puttanelle e studenti.
Vengono spifferi omicidi da finestre di legno male sprangate, lezzi dal sottopalco, eco di lazzi da macchinisti, genieri. Un guitto s’inginocchia (sei tu donna o diva?) e fa
un bagno nella polvere mai rimossa. L’unica scopa, del
resto, scapitozzata, serve da lancia o da cavallo.
VII
Dissi a Giovanni, quasi per dar respiro alle mie orecchie (ho detto della mia sindrome anti-telefonica) e porre un argine all’ansia ed all’asthma che tracimavano in
quel suo bisbiglio: «Sai che ho messo insieme la raccolta completa dei libretti di Malipiero? Non mi ero accorto che ne avesse scritti tanti», dopo la rottura con Silvio
Benco e l’equivoca collaborazione, congiurata da Bontempelli, con Pirandello. Li avevo messi insieme, quei libretti, in uno dei miei, per quella decina d’anni, più frequenti passaggi da Venezia, in una botteguccia che sfocia
sulla piazza del monumento a Tommaseo. C’è, sull’angolo, o c’era, una pizzeria dove sedemmo, in anni per tutti
noi più lieti, con mia moglie e con un altro malipieriano,
l’allora mio amico Minardi. La botteguccia, mi fu detto, apparteneva a un figlio o discendente di Wolf Ferrari e vi si trovava, in pochi metri quadrati, di tutto (tranne i dischi) che interessasse la musica. Spartiti per canto, partiture d’orchestra, libretti, edizioni musicali, cartoline autografate, magari (ma non ne feci richiesta) una
bacchetta spuntata di Nino Sanzogno, malipieriano onnivoro chiomadargento. Con poca spesa, incuriosito, riempii delle cartucce malipieriane una borsa della spesa.
Certo, lasciai cadere al telefono e, giuro, senza intenzione, che qualche musicologo avrebbe dovuto occuparsene. Fàllo tu, disse Giovanni con decisione immediata.
Eh... sì, provavo a schermirmi; partivo di lì a poco per
le vacanze, appena sceso alla camera affittata nella poco ospitale Berceto, sull’Appennino parmense, mi viene incontro l’affittuaria gridando «la vogliono al telefono». Erano dalla Marsilio, già pronti col contratto e con
una proposta di scadenza non impossibile.
Dieci anni fa mi cercarono da una grande casa editrice francese, volevano inaugurare una edizione francese
(testo e traduzione a fronte) delle opere del Marino, forse incoraggiati dal fatto che la Francia è ormai di fatto
/e finché dura / la fucina neo-barocca (o post-moderna) più attiva e con un pubblico che sembra insaziabile. Ora celebrano l’anniversario della riscoperta-pioniera di Atys. Mi dissero che non mi avrebbero dato una lira (ma, questo, per me è una costante) e che si aspettavano una consulenza operativa, a partire, intanto, dalla mia edizione della Galeria e da una traduzione inedita di una studiosa (estranea all’università) che avevo conosciuto, per lettera, nei suoi ultimi tempi di lavoro e di
vita. Mandarono le bozze, corressi, rispedii; per un anno o due, di solito prima dell’inizio di qualche vacanza,
l’intermediario italiano seguitò a telefonarmi facendo il
meravigliato che non avessi ricevuto le bozze definitive.
Dice che la traduzione la sta rivedendo il direttore («prestigioso») di collana e che, debbo capirlo, non può stare a giornata sui versi del Marino. E io mi chiedo se non
sia questo l’eterno.
VIII
Un altro motto di Giovanni: «Bisogna aver letto, visto,
conservato tutto». Si era in quella sua misteriosa abitazione alla Giudeca. Lui diceva sempre così, a memoria della rima boitiana «cieca: Giudeca». In realtà, sapeva tutto.
Non ne faceva mistero e non ne faceva tesoro da serbare
gelosamente. Molti lo credono veneziano, ma la sua nascita era stata a Fano7, sessantadue anni dopo che vi era
nato Bruno Barilli, che tutti credono parmigiano. Personaggi e scrittori affascinanti, unici, ma Barilli era un
grande mistificatore, un decoratore policromo di carri
viareggini, laddove, si è capito, Morelli dava vita, con le
sue parole da lui disposte in giaciture scomode e atonali,
mai viste prima, non proprio al Nulla, come Marino dice, di Annibale Caracci, ne La Galeria:
Chi diè l’essere al nulla,
Ecco che’n nulla è sciolto.
Chi le tele animò, senz’alma giace.
Al gran Pittor, che porse
Spesso ai morti color’ senso viuace,
Morte ogni senso, ogni colore ha tolto.
Ben tu sapresti hor forse
Farne un altro, Natura, eguale a quello,
S’hauessi il suo pennello.
Alle ombre: alle ombre delle Idee. (Tagliente: «Bruno
non usava l’ironia ed è stato bruciato. [Il cardinale, poi
santo (dal 1930)] Bellarmino ha aiutato Galilei a fare un
doppio discorso, a ironizzare, e a dire, abiurando, pane
al pane (tanto per sopravvivere) e vino al vino (fra le righe, per rinvii o incredibilmente o negando senza negare) per amore della libertà futura» 8).
per Giovanni Morelli — 43
IX
Milano, Ricordi, 1984.
Improgrammabilmente, le due opere di séguito venivano a
ricostituire lo schema bipartito dell’Adone, la prima parte (e
l’ultima) mitologica, la seconda parte (o gigantesco Intermedio)
erotico-avventurosa sul modello dei romanzi alessandrini.
7
Qui memoria o emozione mi hanno tradito. Morelli era nato a
Faenza, il 14 maggio del 1942.
8
Egisto, p. 622. «Non è Marino ma Galilei a sostituire [...] la
parola flauto con una perifrasi [...] lo scopo recondito è metodico:
raggiungere uno straniamento tematico assoluto e gettare semi
coscienziali a maturarsi in prossime bestemmie o in schemi di
esperienze predisposte a pezzi e inserite nell’inverosimile spazio
della ‘curiosità straordinaria’».
5
6
Si sono riaffacciati intanto i cancheretti. Il Paradosso del
farmacista era finito, letteralmente, ai miei piedi, sur un’estrema scansia rasoterra, per un errore di collocazione
(mio o di qualche officiosa casalinga) che lo aveva sviato
dalla mini-sezione morelliana dei miei libri; era con un
piccolo serto di altri volumi di quella superba collezione celestina, che Morelli diresse per Marsilio. Erano gli
«innocenti cancheretti», il diuturno lamento dell’ipocondriaco Cesareo Poeta. Da essi Morelli, e chi altri, se non
lui, aveva la capacità, la disposizione analogica e la ‘precisione’ di riuscire a dominare, con trapassi ‘a vista’ (come negare che, rileggendolo, provo le sensazioni
che mi diedero, allora, allora, il primo Sanguineti,
il teatro di Ronconi, anche ben oltre il loro effimero incontro per l’Orlando furioso, sparpagliato come
squartato Orfeo per una summa mobile di loci deputati) e l’intera produzione dell’inesauribile verseggiatore ‘in tragedia’ (quelle tragedie che avrebbero goduto, come scrisse a suo tempo il De Sanctis, di una sorta di prosecuzione vitale nel fatto
che facevano tanto ridere), e la «ottimistica flemmatizzazione dell’intera Europa intellettuale del secolo» decimottavo.
per Giovanni Morelli
E, in chiusa dell’essay, Morelli dettava il programma / «Mi trovo a proporre a me da me all’uso mio,
allora, un testo [metastasiano] che possa essere trattato immaginosamente come se fosse un soggetto,
un caso o una persona, o un soggetto storico (se
mai si vorrà storicizzarlo) che potesse essere considerato un po’ malato ma anche un po’ in cura... »/:
Rimasto così, un po’ vivo e un po’ morto: oltre le
sue date di scadenza. Trattarlo dunque, possibilmente, avendo come primo obiettivo della cura il
non ucciderlo, quel testo ancora un po’ sano, nel
corso di un’operazione che non può volerlo in alcun
modo curare, già che la natura che il testo s’è conquistata è quella di una buona salute d’ordinanza...
Così, Giovanni, la tua voce: di sopra gli sciacquìi
della laguna... Non c’è altro cammino che camminare. Addio.
Scompiglio e lamento (Simmetrie dell’incostanza e incostanza
delle simmetrie) L’Egisto di Faustini e Cavalli (1643), a cura
di Giovanni Morelli, Gran Teatro La Fenice, OpereConcerti-Balletti 1981-1982.
2
Tempestivi uscirono gli Atti: Malipiero scrittura e critica, a
cura di Maria Teresa Muraro. Premessa di Gianfranco Folena,
Appendice a cura di J, C. G. Waterhouse, Firenze, Olschki,
1984 (contributi di Pirrotta, Minardi, Pieri e Waterhouse e nella
appendice sedici articoli di Malipiero dal 1912, anno della nascita
di mio padre, al 1949, quando scoprii «il Vittorioso»).
3
Egisto, p. 596.
4
Così Morelli, all’explicit dell’Egisto: «... Una risoluzione tematica
/quella dell’Egisto/ molto diluita, evitabile, cauta, straniata,
certamente non tragica, certamente non religiosa, scientificamente
indagabile, post-antica» (24 marzo 1982).
1
Al computer alla Giudecca.
Paolo Pinamonti
Il magistero libertario di Giovanni Morelli
Nessuno, fra tutti quelli che hanno avuto la possibilità, ma soprattutto la grande fortuna, di conoscere Giovanni Morelli, anche solo per pochissimo tempo, il tempo di un breve incontro nel suo studio all’Università, o
alla Fondazione Giorgio Cini o anche solo per la strada,
poteva rimanere indifferente di fronte alla figura intellettuale di questo straordinario e generossisimo studioso.
per Giovanni Morelli
44 — per Giovanni Morelli
Morelli aveva il dono rarissimo di porsi di fronte a qualsiasi interlocutore con una disponibiltà totale, fosse il collega che gli chiedeva una particolare informazione bibliografica, sapendo di attingere ad una fonte ricca e documentatissima, o fosse il giovane studente intimidito, che
iniziava il suo percorso di studi e che chiedeva un consiglio per redigere il piano di studi.
Ma questa disponibilità non era solo espressione delle sua grande e generosa «bontà», era un modo essenziale del suo stare nel mondo, era legato a quella costante
e sempre vigile disposizione percettiva che caratterizzava il suo radicale empirismo. Empirismo che non solo lo portava ad essere un acutissimo osservatore senza pregiudizi del reale (ricordo come divertito e ironico scherzava affettuosamente con alcuni di noi sul fatto
che Massimo Cacciari, allora sindaco di Venezia, avesse
definito i piccioni degli uccelli neri, per lui erano al contrario variopinti e differenti uno dall’altro, come di fatto lo erano), come anche lo faceva essere quello straordinario pensatore e studioso che, ovunque indirizzasse
le sue indagini e i suoi interessi di ricerca (dall’opera veneziana del Seicento alle avanguardie musicali del secondo Novecento, da Metastasio a Gertrude Stein, dal melodramma verdiano alla musica di Nino Rota, dal teatro
musicale di Cimarosa al cinema degli Straub-Huillet o
di Istvan Gaal), sempre sapeva offrire geniali ipotesi interpretative e nuovi apporti conoscitivi.
In questo senso sono convinto che il suo magistero non
possa essere assolutamente limitato, e mi rendo conto del
paradosso nell’usare questo participio passato aggettivato per Morelli, a quello del grande musicologo di livello internazionale.
Morelli è uno dei veri e grandi pensatori del nostro tempo, che ha lasciato una vastissima, e apparentemente dispersa, mole di lavori di ricerca e di pubblicazioni; la musica è certamente presente come una sorta di centro dei
suoi interessi, ma lo è anche in quanto modalità espressiva privilegiata per intendendere quel «sensismo fenomenologico», di ispirazione illuminista e nutrito di una
profonda competenza medico-farmacologica, che caratterizza il pensiero morelliano.
L’aver scritto prevalentemente di teatro e sul teatro non
limita lo spessore filosofico di Diderot, anzi il suo teatro
è un modo della nuova e ardita ricerca filosofica del promotore dell’Encyclopédie. Così è anche in Morelli, la sua
indagine musicologica non è fine a se stessa, non è autoreferenziale, ma è sempre un’occasione che gli consente di intraprendere dei percorsi di ricerca nei differenti e
specialistici terreni della comprensione dei meccanismi
percettivi del nostro essere al mondo, percorsi che comunque non sono mai estranei a una profonda coscienza storico-politica.
La metafora musicale, ricorrente in Diderot, del «clavecin sensible et animé» (Denis Diderot, Le Rêve de d’Alambert. «Entretien entre d’Alambert et Diderot»), metafora attraverso cui il filosofo combatte ogni forma di distinzione cartesiana tra materia e sensibilità, come anche ogni forma di inibizione all’osare del pensiero – «Voyez-vous cet œuf? C’est avec cela qu’on renverse toutes
les écoles de théologie et tous les temples de la terre» –,
ha fortemente influenzato la geniale ricerca morelliana.
Ad ulteriore rinforzo della vicinanza di Morelli a Diderot, mi piace ricordare che se Morelli aveva compiuto in
gioventù seri studi di medicina ed era un profondo co-
noscitore della semeiotica e della farmacologia, Diderot
aveva iniziato la sua carriera di pubbicista, traducendo il
celebre dizionario medico dell’inglese Robert James (Robert James, Dictionnaire universel de médecine... traduit de l’anglais par Mrs Diderot, Eidous et Toussaint. T. iii, Paris, Briasson, David l’aîné, Durand, 1747).
In questo materialismo empirico radicale, che sapeva
evitare i rischi di quei presupposti inconsapevoli di cui
si nutre un ingenuo «sensismo», Morelli era come il dr.
Boerhaave di Leyden, uno dei molti personaggi che la
sua fertile scrittura e immaginazione hanno inventato:
La sua regola scientifica era la ricerca sul malato e non sulla
malattia. Vagamente correva voce che sostenesse che non esistevano le malattie ma solo condizioni individuali di sopravvivenza, dolore, spasmo, paralisi, ecc., tutte differenti, oltre
le similitudini di alcuni quadri sintomatici, caso per caso. Dai
suoi testi scomparvero le argomentazioni e il suo magistero
fu un magistero di osservazioni ‘innocenti’ (spesso amava dire che il medico migliore del mondo avrebbe potuto essere un
‘bambino’ – ovviamente – ‘intelligente’ cui fosse stata messa
a disposizione, da guardare, una galleria di malati) (Il morbo di
Rameau, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 211).
Questa sua prospettiva di pensiero, che attraverso la
musica e con la musica parlava del nostro essere al mondo, era comunque sempre attenta e aggiornata ai risultati più recenti degli studi specialistici dalla psicoanalisi al
cognitivismo sino alle neuroscienze e, come ho già osservato, era sempre sensibile ai temi di una insospettabile dimensione politica e libertaria.
Nei confronti dell’estrema specializzazione teorica che
caratterizza i saperi contemporanei, Morelli da un lato
aveva la capacità di assumerli, le sue conoscenze erano
sempre aggiornate e competentissime, e dall’altro lato
l’analisi musicologica si arricchiva di questi saperi o offriva agli stessi nuove prospettive.
Fra i molti suoi lavori mi piace ricordare il Paradosso del
farmacista. Metastasio nella morsa del tranquillante, pubblicato
presso Marsilio nel 1998, testo su cui credo si debba tornare come ad un testo importante della nostra modernità. Qui densità di pensiero, qualità della scrittura, sapiente erudizione, profonde conoscenze mediche, invenzione letteraria degna dei suoi modelli (Diderot, Rousseau
e Sterne in primis), analisi musicale si fondono in un saggio che vuole e sa essere la ripresa attenta e innovativa
dei grande temi dell’illuminismo francese, dal radicale
interrogarsi sul perché del male se esiste Dio, all’interpretazione della «sensibilité, propriété generale de la matière», quelle sensibilità che Morelli sapeva indagare e approfondire attraverso le musiche che amava.
In un suo recente intervento pubblico all’Università
(2.x.2009), ancora inedito, Morelli scriveva:
Nel corso della spedizione ricognitiva sulla letteratura orale groenlandese, Knud Rasmussen, che era inuit (groenlandese), nativo, si sentì interrogare da Ludvig Mylius Erichsen, suo
professore di comparatistica a Copenhagen, su come e a che
cosa credessero gli Inuit.
E Rasmussen pare che abbia risposto: «Noi Inuit non crediamo, noi abbiamo paura».
Mi sono chiesto io, oggi, 107 anni dopo quello scambio di
battute: cosa significa ‘avere paura’ in una dimensione culturale come quella del Grande Nord, essenzialmente fonda-
ta sulla oralità, segnata dalla prepotente riduzione del tempo presente alla notte lunghissima ovvero al futuro incerto
del ritorno indefinitamente solo probabile del sole, e così via.
Ho finito per ricorrere alla tardiva nozione di ansia sviluppata dall’ultimo Freud delle ultime lezioni (1933). Una nozione basata su una definizione essenzialmente semiotica nella sua
enunciazione: l’ansia è un segnale. Un segno indicatore, ad libitum: o (1) di presenze pericolose oppure di (2) un deficit della vitalità, di tracollo del business, o perlomeno del forte rischio di perdita della continuità del business.
E proprio la riflessione sui meccanismi di gestione, controllo, rimozione, superamento etc. di quest’ansia immotivata è uno dei temi cardine de Il paradosso del farmacista,
dove, nelle prime pagine, Morelli osserva, con notevole
acume e sensibiltà politiche, come
nell’ora/oggi, infatti, ed è un dato di fatto, insisto nel dirlo
tale, «banale», il Farmaco [il sacrificio rituale su cui si era dilungato nelle pagine precedenti] viene ripotenziato, come tale; ri-potenziato, non per altro, ma perché Farmaco o in-quanto-Farmaco, dalle tecniche innovative della persuasione delle masse e dalle enfiagioni dell’one time circoscritto sentimento della tribù che s’ingrassa grazie al lievito di sentimenti cospicui, sconosciuti agli antichi, e dilaganti nell’amplitudo delle
genericità: come quei sentimenti che van trasudando al labbro quando si parla con la dovuta convinzione di gente, di patria, di popolo, di impero, di nazione e simli altre nozioni. (Il paradosso del farmacista, p. 16)
Morelli ci ha lasciato ma restano il suo lavoro, le sue ricerche, i suoi studi, vivace testimonianza di una acuta
passione che vedeva nelle musiche, che ci ha fatto conoscere e ci ha aiutato a capire, una terapia per vivere con
meno ansia.
Alberto Caprioli
A Giovanni Morelli, voce del pensiero Fuggente
Nel nostro tempo arido e agnostico, pochi osano riconoscere la profezia con un atto di fede. Ad essa non rimane altro che venir salutata dai posteri filistei, abili sciacalli dell’altrui memoria incoronati di tombacco; e altrettanto pochi sono coloro che sanno interpretarne le fulminee epifanie. Talvolta la profezia si nasconde tra le parole
quotidiane, talvolta tra le pagine dei libri o nella musica o
nelle immagini che si perdono nell’aria, annunciata più e
meno consapevolmente da uomini che non sono necessariamente dei profeti.
Con Giovanni Morelli, conosciuto durante la grande
stagione bolognese di Tito Gotti e delle Feste Musicali e frequentato a più riprese durante i soggiorni veneziani, mi piace rimettermi in cammino riascoltando il
silenzio: un silenzio che non è il nulla, né il vuoto delle
acque appena mormoranti della città di Venezia addormentata sotto le brume, ma un silenzio che si può ascoltare: quello di cui scrive Barbey d’Aurevilly, vate del giovane Maurice de Guérin: «Je viens d’ouvrir ma fenêtre
et d’écouter le silence.– écouter est le mot; il n’y a pas de
musique plus intimement poignante»: la stessa Stille che
aprirà dopo due generazioni la camera notturna di In Venedig di Georg Trakl.
Giovanni Morelli, con la sua ermeneutica cinematica
intessuta su multipli frammenti, pensiero diagonale, polifonico e polifunzionale nato dall’umile e al tempo stesso ardita coscienza che, con Jean Starobinski, «tout choix
éveille une culpabilité», è stato sublime interprete e insieme personaggio-attore – deuteragonista per scelta – del
secolo che si era aperto con il primo viaggio veneziano
di Proust in compagnia di Reynaldo Hahn.
E, in opposizione agli averni simbolisti delle Toteninseln
di Böcklin incarnati delle pulsioni di morte della Lugubre
gondola, la sua inimitabile lezione si inserisce come un filo dorato nel damasco veneziano, alla ricerca di un percorso nuovo, a partire dalle trame lasciate incompiute
dall’accorato messaggio di Simone Weil fino alle lucide
intuizioni di Philippe Sollers: trasfigurazioni – più spesso dinamiche che estatiche – alla ricerca di un presente–
vivente in grado di contrastare l’atemporalità della Venezia «perduta» di John Ruskin evocata da Proust ne La
Prisonnière: «le temps propre de la musique qui m’aidait
à descendre en moi-même, à y découvrir du nouveau».
Ripercorrendo a ritroso le tappe delle passeggiate sottobraccio nei chiostri della Cini, i nostri dialoghi sempre
interrotti e sempre ripresi, fino ai tempi dell’ultima fatica
Prima la musica, poi il cinema, dopo il coraggioso varo delle
riviste «aaa/tac, Acustical Arts and Artifacts, Technology, Aesthetics, Communication» e «aam/tac Art and
Artifacts, in Movie. Technology, Aesthetics, Communication»; e, prima ancora, all’epoca della pubblicazione
del saggio Scenari della lontananza, di cui mi aveva donato il primo esemplare cosegnatogli da Marsilio (rispondendo alle mie proteste: «tanto a me non serve, l’ho scritto io») con la dedica schizzata a biro, frettolosamente:
«Copia n. 1. / Ad Alberto Caprioli / G. Morelli»; e, logico epilogo della lezione sans titre su Berlioz dei tempi di
Vittore Branca, la fine del viaggio si era compiuta, come
la fine del secolo, rivivendo la musica dell’ultimo Nono:
quando aveva sorriso in maniera sorniona, aggiungendo le sue indimenticabili chiose a mezza voce, sentendomi dire in una tavola rotonda a Ca’ Foscari che ancora una volta Proust, ne Le temps retrouvé, aveva preconizzato gli esiti della musica più alta del nostro tempo («cet
art si compliqué est justement le seul art vivant. ...c’est la
marche en sens contraire, le retour aux profondeurs où
ce qui a existé réellement gît inconnu de nous»): Fragmente–Stille. An Diotima; A Carlo Scarpa architetto, ai suoi infiniti
possibili; Prometeo. Tragedia dell’ascolto; e quella, solo sognata, per Giordano Bruno.
«Bologna, 20 giugno 2011. Caro Giovanni, come stai?
Spero che tu stia bene, e che tutti gli inconvenienti siano
risolti. Ti mando un bacio e intanto ti scrivo per dirti che
il mio pezzo Fuggente, per voci e strumenti / a Giovanni Morelli, voce del pensiero sarà eseguito in autunno da Monica Bacelli e dall’Ex Novo Ensemble alle Sale Apollinee della
Fenice. Ci saranno alcune modifiche alla prima versione di in canto che doveva essere eseguita l’anno scorso –
sto lavorando alla partitura. Il testo parte da frammenti di fonemi, dai quali si materializza poco a poco la prima parte de Il tramonto della luna, fino a “oscura / Resta
la vita.” Sono le cose che ci siamo detti tante volte, solo
appena accennate, quelle che ti assalgono dalla Hälfte des
Lebens in poi – interrotte perché l’ellissi generi una speranza: anche se lontana, come i suoni che provengono
dalla laguna dove ti sei rifugiato tu, da tempo – “l’estremo albor della fuggente luce” – spero di vederti presto
/ un abbraccio affettuoso dal tuo / Alberto Caprioli».
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 45
46 — per Giovanni Morelli
Orfano, con il respiro di Oscar Wilde – «it can help us
to leave the age in which we were born, and to pass into
other ages, and find ourselves not exiled from their air»
– resta ora il pezzo che canterà Monica Bacelli il 26 ottobre, Fuggente, per voce e strumenti. A Giovanni Morelli, voce del pensiero, sull’incipit de Il tramonto della luna (Wilde:
«the pain of Leopardi crying out against life becomes our
pain»): «Quale in notte solinga, / Sovra campagne inargentate ed
acque,/ Là ‘ve zefiro aleggia, / E mille vaghi aspetti / E ingannevoli obbietti / Fingon l’ombre lontane / Infra l’onde tranquille / E rami e siepi e collinette e ville; / Giunta al confin del cielo,
/ Dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno / Nell’infinito seno /
Scende la luna; e si scolora il mondo; / Spariscon l’ombre, ed una
/ Oscurità la valle e il monte imbruna; / Orba la notte resta, /
E cantando, con mesta melodia, / L’estremo albor della fuggente
luce, / Che dianzi gli fu duce, / Saluta il carrettier dalla sua via;
// Tal si dilegua, e tale / Lascia l’età mortale / La giovinezza.»,
dedicato a colui che scriveva, pochi giorni prima di lasciarci: «Venezia, 21 giugno 2011. Carissimo, grazie della tua lettera dolcissima e delle notizie. Spero che venga
presto l’autunno».
pensare a lungo, e mi ci è voluto tanto tempo per superare i miei limiti. Tu non ne avevi: volavi col pensiero,
perché la sapienza, che regalavi con un bellissimo sorriso a fior di labbra, veniva da lontano e andava lontano.
Sempre una spanna sopra le miserie del mondo con distacco ammaliante, sempre a caccia del paradosso – una
volta sei quasi riuscito a convincermi che esistesse un cabernet frizzante...
Dal giorno in cui sei volato via sono tornato un paio di
volte a Venezia, restando a zonzo per calli e canali più
del solito. Quando passavo per i luoghi in cui ero abituato a incontrarti, rivedevo la tua faccia e sentivo la tua
mancanza. Da campo Santa Maria Mater Domini fino
a San Pantalon, passando per San Stin e i Frari, ma anche a San Basilio, dove comperavi il cibo per la tua colonia di mici, o a Palazzo Cini in campo San Vio: Venezia
era davvero il tuo regno, e non mi sarà facile tornare nei
chiostri della Fondazione a San Giorgio, dove galleggiano troppi ricordi belli.
Specialmente in queste passeggiate ti ho pensato tanto, e mentre il dolore acuto evolveva in rassegnazione e
malinconia, fischiavo una melodia dolcissima
per Giovanni Morelli
Michele Girardi
Un angelo che insegnava la libertà
Cremona, 14 agosto 2011
Giovanni amatissimo,
eri un angelo che spargeva il bene a piene mani, donandolo a chiunque ne avesse bisogno. Mi hai regalato affetto, gioia, arguzia e scienza a piene mani fino a quando,
poco più d’un mese fa, non te ne sei andato per sempre,
in punta dei piedi com’era nel tuo stile. Da tanto, ormai,
il declino fisico era il Leitmotiv dei tuoi discorsi, ma anche
di recente avevi sconfitto la malattia e speravo con tutte le
mie forze che ce l’avresti fatta pure stavolta. Quando ho
saputo, prima di disperarmi sono rimasto incredulo, poi
il mio cuore ha cominciato a tornare indietro nel tempo.
Non dimenticherò mai il nostro incontro nella tua casa di gatti alla Giudecca: era il giugno del 1980, mi stavo laureando in Storia della musica e tu avevi il ruolo di
correlatore – da poco ti eri insediato a Ca’ Foscari, futuro Doge di tutti noi veneziani che si occupavano di musicologia. Quel pomeriggio parlammo per ore, poi abbiamo continuato a discutere in seduta di laurea, e poi
ancora durante tutti questi anni, da quando ho lasciato
la laguna per seguire le mie vocazioni. Eri una presenza
immanente e discreta, capace di placare con un motto o
un vezzo la più profonda delle inquietudini.
Tra le mille cose che mi hai insegnato in tre decenni,
una mi è cara sopra tutte, ed è norma della mia vita di
docente: ogni maestro non è davvero tale se non aiuta
i suoi allievi a diventare anzitutto persone libere. Libere di pensare, di scegliere e valutare... certo, è più difficile avere successo nel mondo accademico, che predilige
l’adulazione e l’imitazione peggiorativa, ma solo così la
cultura insemina la società, e può contribuire a migliorarla – e poi, a dirla tutta, sei sempre stato inimitabile!
Ti confesso che se, come uomo, eri un libro che s’apriva subito (suscitando emozioni per ogni pagina di un tomo insolitamente ponderoso), come studioso ho imparato a capirti nel corso del tempo. Ammetto inoltre che
all’inizio la ritenevo un’impresa utopica. Ogni tua risposta a un quesito, ogni consiglio, ogni saggio, mi faceva
e l’associavo a te, forse perché questo genere di danza,
che viene idealmente dai tuoi secoli prediletti come studioso, trova nuova vita tra Otto e Novecento e, in qualche modo, traccia un arco temporale che corrisponde ai
tuoi interessi speculativi, estesi sino all’ultima novità. La
pavane di Ravel è metafora sonora di un passato che torna indossando un abito moderno e prezioso ma non alla
moda, un abito che non gli impedisce di esibire fra le sue
pieghe il suo esprit d’antan. Come te, questa musica vive di
contraddizioni felicemente risolte, è antica perché nuova e viceversa, conosce le vanità del mondo e le guarda
dall’alto, senza un briciolo di superbia.
Addio Giovanni, i tuoi occhietti brillanti mi seguiranno ovunque finché campo, come quelli del piccolo Leonardo Pesaro che s’affaccia verso di noi dalla pala di Tiziano ai Frari. Ma non potrò più cogliere nel tuo volto
quella gamma infinita di espressioni che mi aiutavano a
capire la vita e a sopportarla, strappandomi sempre un
istante di buon umore insieme a una riflessione profonda.
Con affetto e gratitudine infiniti,
Michele
Anna Maria Morazzoni
La cassetta degli attrezzi
Carissimo Giovanni,
l’espressione del titolo è tua, viene dalla tua Introduzione al volume di Massimo Mila sulle sinfonie di Mozart,
un libro dello scorso anno sul quale sono riuscita a farmi scrivere una dedica, che ora suona ancora più intensa
e mi brucia nel cuore: «per ricordarci dell’uomo falena»
sono le parole che hai voluto tracciarvi e il cui senso, sia
straordinario sia notturno, assume il colore del commiato.
Ero abituata, come tutti, a sentirmi rispondere «Male»
alla domanda di rito «Come stai?», sia di persona sia per
telefono: una volta era la difficoltà del respiro, un’altra
il dolore alle gambe o qualche altro disturbo desunto
dalla tua maestria nella «classica vecchia semiologia dei
medici: scienza del rilievo del dettaglio sintomatologico»
(ti cito dalla stessa Introduzione), oppure qualche motivo di preoccupazione, anche verso amici e collaboratori. Così, impreparata a cogliere qualcosa di dirimente,
ho sottovalutato la tua ennesima allerta, quella purtroppo vera sulle condizioni del tuo cuore: impossibile immaginare che dopo la lunga sessione di tesi per la laurea
magistrale egart nel giugno scorso non ti avrei più incontrato in questo mondo. Seduti fianco a fianco, si era
ricreata immediatamente la complicità del nostro dialogo, un po’ stravagante come tutto quello che ti riguarda.
Ti avevo sentito reticente nel parlare dell’estate, ma vacanze e compleanni non ti sono mai andati a genio; poi
mi avevi sorriso come sempre, avviandoti verso il ricevimento studenti dall’uscita secondaria di Ca’ Dolfin.
La tua meta per quel pomeriggio, senza concederti una
tregua, riflette la tua generosità: in questo caso verso gli
studenti, come avevi appena dimostrato nella valutazione delle tesi, ma in generale verso ogni istanza. Mi piace indicare la generosità come utensile privilegiato nella cassetta degli attrezzi del tuo essere poiché l’ho sperimentata in tante occasioni, nei trent’anni che abbiamo
trascorso insieme, a distanza più o meno ravvicinata, tra
momenti di silenzio e periodi di stretta collaborazione;
negli ultimi cinque i miei incarichi presso la Fondazione
Cini ci hanno fatti incontrare regolarmente, instaurando continuità in un dialogo antico.
Non hai mai voluto risparmiarti, rallentare i ritmi di
quell’attività che ogni mattina ti portava a San Giorgio,
a Ca’ Foscari («a scuola», come dicevi tu), magari di nuovo a casa e poi da capo, con l’aggiunta di incontri in qualche altra istituzione veneziana oppure viaggi per lavoro.
Nel 1983, quando lessi per la prima volta una relazione
a un convegno della Cini, la tua era una presenza sommessa, eppure registravi tutto, non ti sfuggiva alcuna sfumatura, come ho avuto modo di osservare recentemente, quando il nome e l’orientamento di Vittore Branca, il
Segretario Generale di quei tempi, sono stati evocati intensamente e fattualmente in Isola.
Incontrarti in Cini di prima mattina mi metteva di buon
umore per l’intera giornata: nel chiostro o nel corridoio degli uffici oppure nell’ufficio angusto che ti eri scelto, un abbraccio, un aggiornamento reciproco sui gatti
e una conversazione dolce su argomenti disparati – avvenimenti riservati o pubblici, spettacoli, progetti, idee
– con accostamenti surreali e divagazioni di assoluto divertimento nei quali i tuoi occhi brillavano di gioia nel
lanciare la sfida a seguire l’agilità della tua intelligenza
fulgida e fulminea attraverso una rete imprevedibile di
associazioni.
La generosità era il tuo segno peculiare nel mettere in
contatto persone e istituzioni, nell’ideazione di iniziative (ricerche, pubblicazioni, convegni, concerti, cicli cinematografici), come pure nella valorizzazione dei Fondi musicali della Cini, che curavi personalmente con una
dedizione assoluta nel conservarli così come erano pervenuti dai rispettivi intestatari, e dai quali fornivi materiali di studio accompagnati da consigli, bonari nel tono
ma decisivi nella sostanza. La tua conoscenza di questi
documenti, nella loro varietà e ricchezza, è stata determinante per i miei studi come per i tanti contributi scientifici che vi hanno fatto riferimento. Basta l’esordio della tua descrizione del Fondo Boito a illuminare sia la tua
logica archivistica sia il tuo stile: «Fondo piccolo ma “caleidoscopico”, un archivio “trillato”, fatto di molte carte
allitteratamente sparse ma pervase da un’aura di segreta
coerenza nella incoerenza…».
La tua scrittura crea reazioni estreme: amore e odio. Personalmente, l’ho sempre amata, nei libri e nei saggi (quanti
estratti mi hai donato chiedendo conto della mia lettura
alla prima occasione), forse soprattutto per l’andamento
digressivo che la connota e che propone costantemente altro, attraverso suggestioni gravide di suggerimenti.
Confermo a distanza di anni quanto scrissi recensendo
il tuo libro del 2003 Scenari della lontananza. La musica del
Novecento fuori di sé: «La scrittura di Morelli è un antidoto alle trappole del pensiero, è una vaccinazione contro
le (comode e rassicuranti) scorciatoie su strade tracciate
(cosiddette maestre), è una sfida ai luoghi comuni vicini
a tanta letteratura accademica, insomma è l’espressione
di un pensiero libero, vivace, senza pregiudizi e senza limiti. Non c’è soltanto la musica in questo volume: ci sono
la storia, la politica (fino all’attualità), la filosofia, la poesia (ricorre Auden), le arti visive, la scienza e la medicina; non c’è soltanto il Novecento, anzi si può apprendere molto sul Medioevo. La sensibilità di Morelli mette in
atto sinergie tra esperienze conoscitive, scientifiche ed
estetiche, di ogni campo e il girovagare del suo pensiero
è quello di un Wanderer per il quale “no hay camino” e al
quale si aprono continuamente scenari altri con tutta la
loro suggestione, anche per il lettore».
Hai partecipato alla Festschrift per i compleanni di tanti amici e ti sei sottratto al 14 maggio 2012, ai tuoi settant’anni, lasciando incolmabile e indimenticabile il debito che sento verso di te, con tanto affetto.
Luca Zoppelli
Non si impara a sciare sul tappeto del salotto. Si va sulle
piste, si prova, si cade – si impara. Quando ancora mi capitava di fare qualche discesa sulla neve, tentando di riaggiustare l’equilibrio dopo lunghi periodi di inattività, mi
inseguiva questa metafora di Giovanni Morelli – elargitami, una volta, per calmare l’ansia dell’aspirante studioso che non ha il coraggio di buttarsi a far qualcosa di suo
senza prima esser sicuro di aver assimilato tutto quello
che bisogna. Non so se Giovanni avesse mai messo gli sci
ai piedi – tenderei a dubitarne – ma l’asserzione è preziosa, sia presa alla lettera, sia come metafora. Come, d’altra
parte, tutte le sue fulminanti associazioni d’idee: la cadenza improvvisata alla fine del primo tempo di concerto che
è un po’ come la «giunta» del macellaio, la ricostruzione
di strumenti antichi dall’iconografia che è come far della
zoologia sul rinoceronte corazzato di Dürer…
Certo, il disagio fu poi nel conciliare la metafora con
la realtà dell’insegnare, man mano che quel ruolo – nei
Conservatori, nelle Università – diventava il mio. Calibrare i programmi, dosare i piani di studio, preparare gli
studenti, metterli in guardia contro gli shocks metodologici cui andranno incontro fuori dalle aule universitarie. Poi, dopo tanti dosaggi, la domanda mi girava per la
testa: sto insegnando loro a sciare sul tappeto del salotto? Giovanni, con noi, aveva forse fatto così? Sbagliavo?
Erano cambiate le condizioni?
Certo in lui si annidava la convinzione che l’insegnamento non è la costruzione formale di protocolli e ca-
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 47
per Giovanni Morelli
48 — per Giovanni Morelli
noni, ma una tempesta di stimoli intellettuali, il piacere di perdere e ritrovare il senso dell’oggetto studiato attraverso le dinamiche più disparate della cultura. Ricordo soprattutto inviti a guardare ad altro, oltre i confini
di una disciplina di cui pure, in quel momento, molti di
noi (io senz’altro) erano ancora ben lungi dal controllare i «fondamentali». Una visione certo aristocratica della formazione intellettuale, forse anche uno scetticismo
di fondo sulla possibilità di trasmettere veramente, in
pillole, i suoi percorsi ermeneutici in quello che chiamò
(recensendo il New Grove) il «mondo-nuvola» – e sull’inutilità di trasmettere formule e canoni, tanto abbondano in ogni manuale.
Eppure (sta qui, penso, il cuore dell’esperienza che facevamo con lui), lo scetticismo intellettuale sui protocolli dell’insegnamento non diventava né distacco personale né disimpegno istituzionale. La generosità in idee, materiali, documenti, bibliografie, verso chiunque gli chiedesse un aiuto o un parere: fuori scala rispetto a quanti,
maestri o colleghi, ho incrociato in tanti anni. Il pragmatismo e la reattività nel quotidiano organizzativo, come
fosse un altro piano (non problematico, o da trattare in
modo non problematico) rispetto all’ermeneutica vertiginosa del dato storico o testuale. La voglia di dare una
mano a qualunque iniziativa potesse far circolare musiche, idee e domande, senza distinguerne rango e prestigio. La curiosità per ogni oggetto di ricerca, anche apparentemente umile, bislacco, insignificante: per diffidenza verso le gerarchizzazioni, per convinzione che ogni
atomo di questo sistema gassoso meriti di essere messo
al centro dell’attenzione. Da un lato, capivi che ciò che
conta davvero è la qualità dell’interrogazione intellettuale. Dall’altro, sentivi che l’interrogazione non si fa se non
sugli oggetti: non su di un oggetto, ma su molti, moltissimi
– sulle serie, sulle liste (la sua passione per le liste tradiva
l’insofferenza verso la violenza intellettuale delle messe
in forma). Che nulla è comprensibile se non a partire da
qualcos’altro. Capivi che la totalità enciclopedica del sapere – impressionante, in lui – era un modo per meglio
afferrarne la natura metamorfica e renitente ai sistemi.
Lo spaesamento intellettuale sarebbe bastato per spaventare chiunque; ma humour, dolcezza e understatement
permettevano di reggere allo straniamento e alla vertigine. Non credo che quella pedagogia sia imitabile, se non
da qualcuno che possieda la stessa, improbabile combinazione di qualità. Difficile restituire quello che Giovanni Morelli ci ha lasciato: proveremo, almeno, a pagarne
gli interessi con la stessa dedizione intellettuale e umana.
Sandro Cappelletto
C’è un termine, bisogna consegnare il ricordo di te all’indirizzo mail di «Venezia Musica e dintorni» entro oggi, altrimenti tipografo e stampatore non riusciranno a rispettare i tempi e questo numero non potrà uscire. Naturalmente, c’è sempre un termine.
Tu non te lo ponevi, pensando – con l’incoscienza che
hanno i medici quando si tratta di curare se stessi – di poter tenere sotto controllo ogni cosa. Con qualche fatalismo,
vissuto con ironia, con quella bonomia, così gentile di tratto, di voce, che è stata un tuo segno riconoscibile. Come
prassi scaramantica, avevi stilato una graduatoria, spesso
aggiornata, dei «sommi ipocondriaci» nazionali. Non ti eri
messo in gara.
Della vita musicale sei stato un termine, un punto d’arrivo
imprescindibile. Nei modi noti a tutti: alla Fondazione Cini, dove la tua indiscussa autorità ha permesso di raggiungere esiti che devono essere considerati definitivi, in futuro
non cedibili; nella collaborazione con Marsilio: nella collana da te diretta, fino a quando le è stato concesso di esistere, non un titolo è superfluo; a Ca’ Foscari, dove hai semplicemente aperto la strada, unendo la tua acutezza di studioso ad una generosità mai stanca verso gli studenti. Poi, c’erano le attitudini più private, fatte di consigli, riletture, indicazioni bibliografiche, in un territorio temporale e stilistico
che impressionava per la sua vastità.
All’avvio della nuova facoltà chiamata egart, a San Sebastiano, mi hai donato un’indicazione fondamentale per
mantenere la rotta: non spaventarsi mai di fronte a certi
vuoti inattesi, a certe nubi che attraversano i volti degli studenti durante le lezioni. «Sono plastici, vedrai».
In tre parole hai fatto giustizia dei luoghi comuni sulla pigrizia, l’insipienza, la modestia intellettuale degli universitari di oggi. Come fossero, loro, responsabili delle mancanze
di altri, come non avessero desiderio vorace di conoscere,
appassionarsi, cercare di trovare un bandolo nella complessità del presente, mentre le regole del lavoro, delle sicurezze sociali e professionali, le certezze sul futuro sono sempre
più sfavorevoli a chi inizia.
Non amavi la scrittura giornalistica, tanto meno la critica
esercitata a caldo, sui quotidiani. Non ti era congeniale l’esibizione mondana che accompagna uno spettacolo, e non
riusciva a darti soddisfazione quell’esercizio di stile sempre
semplificatorio, anche vanitoso, talvolta dannoso, raramente rivelatore. Quella prosa spiccia non fa per te.
La tua scrittura seguiva altre traiettorie, assumeva l’aspetto di esercizio divinatorio. Una tenace resistenza alla prevalente semplificazione del lessico, del periodo, della costruzione stessa del pensiero. Una prosa sommamente «barocca», si diceva. Esoterica piuttosto, riservata, non preoccupata di piacere, destinata a chi avesse voglia di varcare la soglia. Non necessariamente destinata alla pubblicazione. Come le ultime opere di Bach.
A proposito di Bach. L’ultima volta, alla Cini, avevi preparato il dvd di Cronaca di Anna Magdalena Bach, il film della coppia Huillet-Straub (i ragazzi non hanno fiatato per
due ore, durante la proiezione, rapiti dalla discrezione di
quel racconto, dalla devozione della figura di lei). Eri molto occupato e non ti ho chiesto quale fosse la tua risposta ad
una questione alla quale non trovo soluzione: perché, nelle Goldberg, Bach scrive soltanto tre variazioni in minore e le
colloca ai numeri 15, 21, 25? Non te l’ho chiesto perché era
impossibile pensare ci fosse un termine, immaginare che
una persona come te potesse un giorno lasciarti solo, che
non capitasse una prossima occasione.
Per chi ti ha conosciuto da adulto, non sei diventato Giovanni Morelli: già lo eri e lo sei sempre rimasto. Un uomo
mite e potente, che ti tranquillizzava con la certezza della
sua disponibilità. Che ti incitava a raggiungere il livello più
alto possibile per te. Un seminatore di qualità, di serietà.
Ora questo «termine» è mancato. Nessuno possiede la tua
supremazia, fatta anche della capacità che hai avuto, veramente plastica, da stratega, di tenere assieme le esigenze del
quotidiano e la previsione di quanto poteva accadere.
La tua assenza è sensibile.
per Giovanni Morelli — 49
Il modo in cui Giovanni avrebbe voluto essere ricordato sarebbe stato quello di non farlo; e chi avesse avuto la
fortuna di percorrere un tratto di strada con lui, conservasse i propri ricordi. Ma evidentemente non può essere
così, per mille motivi, uno fra tutti: chi lo ha conosciuto
oltre a piangerne la scomparsa, non potrà coprire facilmente il vuoto della sua assenza e, in parte, lo potrà fare
solo ricordandolo.
Questa giustificazione Giovanni non l’avrebbe accettata,
ma, nella sua generosità, l’avrebbe compresa e tollerata.
Ho incontrato Giovanni, per l’ultima volta, naturalmente alla Giudecca, due giorni prima che venisse operato. «Ho sentito che vuoi fare un programma di farse
musicali al Malibran, non ci sono solo quelle di Rossini,
te ne posso suggerire tante di molte belle». «Ok, aspetto
che tu ritorni e poi ci vediamo». Purtroppo quelle farse,
questa volta, da Giovanni non le potrò avere. Andavamo avanti così ormai da alcuni decenni, da quando ho
cominciato l’attività di organizzatore musicale: il confronto con lui era diventato per me indispensabile ed era
una via di mezzo, se possibile, tra un punto di partenza e un punto di arrivo. Tanto sterminata era la sua conoscenza, quanto la prontezza nell’individuare quello di
cui uno aveva bisogno per raddrizzare una stagione, sistemare una pubblicazione, sviluppare un festival. Per
quanto mi riguarda, avessi avuto più o meno responsabilità dirette, ho sempre passato al vaglio con Giovanni
le stagioni della Fenice, per imparare, per cercare, laddove fosse possibile, di risolvere meglio alcune situazioni. Non svelo particolari segreti dicendo che in concomitanza con i migliori risultati musicali ed artistici della
Fenice vi era molto di Morelli. Erano anche esercizi teorici perché, poi, non sempre si
realizzavano le condizioni per cambiare qualche scelta
opaca; ma lui continuava a dare consigli e ne sorrideva
se non venivano seguiti. A volte anticipava, solo lui sapeva come, le tue problematiche e dal suo inseparabile
carrettino, magari tra una fermata e l’altra del vaporetto,
ti tirava fuori una tesi di laurea, un articolo, un libro che
era quello che ti serviva, guai se lo ringraziavi, non te ne
lasciava il tempo. Difficile, fuori dell’aula, intavolare un
lungo discorso, per comunicare veramente con lui, per
riuscire ad entrare in sintonia, dovevi usare linguaggi diversi, sapere capire e rispondere con gli sguardi, pronto
all’ironia ma senza cattiveria. Elencare ricordi sarebbe
un po’ come ridurre un rapporto, duraturo ed intenso, a
qualcosa di poco significante rispetto l’esperienza vissuta.
Desidero, però, ricordare almeno due aspetti di Giovanni: la sua bontà e il rapporto con i giovani. Era un buono
e generoso, ma non sottomesso, le sue idee erano chiare e la sua etica senza discussioni, su questo non transigeva e non usava mezzi termini nei confronti di chi non
aveva la stessa considerazione; era capace di una durezza che non ti saresti aspettato: uno degli aspetti della sua
coerenza che gli piaceva trasmettere anche agli altri. Instancabile nel lavoro, aveva particolare cura dei suoi studenti e di altri giovani promettenti, a tanti si affezionava
e li seguiva anche nel difficile passaggio dallo studio alla
ricerca di una collocazione nel mondo del lavoro. Giovanni ha fatto molto per tanti e in futuro ci mancherà,
certo saremo privi delle sue battute, del suo ironico sorriso, della sua rassicurante presenza, dei suoi consigli e
delle sue provocazioni, ma ci rimarrà, da poter seguire,
la sua profonda lezione di studio e di vita.
Il Teatro La Fenice dedicherà a breve una giornata a Giovanni Morelli. La data, non ancora definitivamente stabilita quando questa
rivista va in stampa, è l’1 ottobre (ndc).
Paolo Cattelan
Penso ora di aver accettato sventatamente la proposta
della rivista «Venezia Musica e dintorni» e di non poter in
effetti testimoniare nulla di importante e speciale su Giovanni Morelli. E soprattutto di non poter far finta di aver
già elaborato e consegnato al passato il mio rapporto con
lui. Inoltre ultimamente ci vedevamo meno, dopo tanti
anni di assidue frequentazioni all’università e alla Fondazione Cini, ed esiste quindi probabilmente un mio certo
qual modo di rapportarmi a lui, anche mentalmente, che
non è aggiornato e non può aggiungere nulla a quanto potranno dire altri molto meglio di me. Comunque, dopo
molte prove e pentimenti, ho pensato che forse due piccoli
episodi piuttosto recenti possono essere raccontati almeno per alludere a quanto la sua presenza significa per me.
Anche se tutti conoscono oggi in Giovanni l’eminente
contemporaneista, non guasta ricordare che da una sua
incursione nel Settecento italiano è nata con l’ottimo Elvidio Surian l’edizione degli Orazi e Curiazi di Cimarosa,
edizione che restituisce un testo di fondamentale importanza dell’era prerossiniana. Così, quando l’anno scorso ho ritrovato due Oratori che Cimarosa ha scritto per
l’Ospedaletto qui a Venezia, tra cui una bella Judith 1782,
sono andato a trovarlo all’università e l’ho invitato all’esecuzione degli estratti, arie e sinfonia, che avevo preparato per la chiesa della Pietà. Mi ha promesso che sarebbe venuto e poi, mentre gli parlavo dei soprani acrobatici dell’Ospedaletto, Lucia Bianchi e Teresa Ortolani, contraccambiando le notizie alla sua maniera, gradualmente divergente, dapprima mi ha ricordato che alla Cini c’è la riproduzione di Artemisia, l’ultima opera di
Cimarosa, scritta per Venezia e lasciata incompiuta, poi
della Giuseppina Grassini, il contralto dell’ultima stagione del musicista partenopeo, quindi di vocalità in vocalità, mi ha parlato di un recente cd pubblicato a San Giorgio con le Liriche di Ottorino Respighi (che mi invitava
prontamente a ritirare presso la segreteria del suo Istituto
in Fondazione). Infine mi ha offerto il suo ultimo scritto, un profilo di Luciano Berio, rendendomi a suo modo
specularmente la provocazione sul piano degli interessi musicologici. Infatti, nonostante la mia gran passione
per il Classicismo europeo e veneto anch’io ho lavorato
un poco sul Novecento e la Contemporaneità e per circa quindici anni insieme a lui con pochissime risorse, ma
molte idee, abbiamo cercato di animare l’attività di quella fondazione che porta il nome del povero Gian Francesco Malipiero (un ente che oggi a detta di Giovanni «non
si occupa più di musica», ma di cosa si occupa allora?)
Non è poi venuto alla Pietà, ma mi ha fatto recapitare
un messaggio da un amico comune. E a dire il vero nemmeno io sono passato a ritirare il cd alla Cini, ma gli ho
telefonato, qualche tempo dopo, indirettamente spronato da una richiesta di Paolo Pinamonti, che ogni tanto, quando ne ha l’occasione, fa eseguire musica di questo enigmatico compositore veneziano del Settecen-
per Giovanni Morelli
Cristiano Chiarot
per Giovanni Morelli
50 — per Giovanni Morelli
to, che si chiama Giovanni Domenico Ferrandini, che
ho riscoperto nel 1987 a Padova. Oggi Ferrandini è eseguito un po’ dappertutto nel mondo anche grazie al fatto che è il vero autore di una celebre cantata, falsamente attribuita a Haendel, dedicata al pianto di Maria sotto
la Croce. Anche se so che Giovanni non ama i ritorni, e
Ferrandini appartiene un poco agli inizi della mia personale storia musicologica, questa volta, comunicandogli una piccola novità di ricerca, in cui sono quasi incappato, mi pareva di potergli strappare un sorriso: «Lo sai
che il Ferrandini, nel 1749, si è presentato di fronte al tribunale dell’inquisizione per discolparsi e far abiura di certe proposizioni eretiche che pronunciava contro l’autorità della Chiesa: sparlava dei preti e, come si dice negli atti, sosteneva l’impossibilità della verginità di Maria post
partu?» Una risatina a questo punto dall’altra parte della cornetta c’è stata. Ma, a parte tutto, siccome di questo
musicista si sa ancora pochissimo, perfino tra i musicologi oggi in cattedra nel Veneto, abbiamo discusso e infine
Giovanni ha approvato il progetto di un’agile biografia
per gli «Studi di Musica Veneta» della Fondazione Cini.
Quando parliamo, Giovanni può permettersi ogni sorta di spericolatezza e di far valere il privilegio della sua
inarrivabile cultura e capacità di speculazione, io sono
molto più limitato e impacciato e solo quanto si sprigiona
dall’approccio materiale alle fonti illumina per me il passaggio dalla ricerca all’interpretazione, per questo, forse,
sono particolarmente, ed anche idealmente, legato alla
teorizzazione del progetto della restituzione di una storia della musica «vivente» che Morelli ha formulato, qualche anno fa, sulle pagine della rivista «Musica e Storia»:
un incontro tra metodo storico, psicologia della percezione e musicologia critica. So poi che Giovanni apprezza particolarmente le verità eversive e quindi le sorprese basate sulla ricerca, l’osservazione e l’interpretazione
diretta delle fonti e delle tracce della realtà storica. Questa sua disponibilità alla sorpresa non solo rivela in lui
l’attenzione dello storico vero, ma anche una posizione
intellettuale sempre viva e perfino una concezione demitizzante e un po’ ludica del lavoro musicologico: sorprenderlo è pertanto per me una delle soddisfazioni più
grandi da quando ho cominciato a fare questo mestiere.
E non c’è caso che resista a comunicare con lui quando
ne ho qualcuna di nuova. Sono fortunato: diverse volte
l’ho sentito dire «Questa volta l’abbiamo fatta grossa».
Infine non mi si darà dell’ingrato se proprio oggi provocatoriamente dico che Giovanni Morelli non è stato
il mio maestro, spero anzi che anche altri si ricordino di
certe frasi pronunciate da lui simili a questa: «Nessuno è
il maestro di nessun altro»: l’autonomia, l’autodisciplina
sono il carattere fondante, autentico, di ogni attività di
studio, di ricerca, di produzione di cultura.
Gianni De Luigi
Il primo incontro con Giovanni fu nell’ormai lontano
1979, quando insieme a Bepi Mazzariol e Mario Baratto
sempre vivi! lo invitai a tenere un corso sulla musica nel
Surrealismo. Già allora sembrava uno Hobbit, in perfetta sintonia con la «Antologia surrealista», e incantandoci
con la sua voce fina, quasi stridula, ci condusse per meandri sconosciuti. Eravamo vicini di casa e ci incontravamo
in fondamenta: la sua disponibilità al dialogo ti costringe-
va ad usare l’intelligenza. Trascinava sempre un gran carretto di cui non indovinavo mai il contenuto, un giorno
era cibo per gatti un altro libri, e con il suo sguardo sornione accennava quel sorriso che ti faceva sentire stupido. All’improvviso mi donava un suo saggio, per poi nel
tempo sondarmi. A qualsiasi studio dei miei allievi era un
testimone critico. Non mi ha mai negato la sua presenza, con generosità e disponibilità. Devo ricordare un altro suo intervento magistrale nella nostra Giudecca, «La
musica tra Pace e Guerra», anche in quella occasione aprì
orizzonti sconosciuti ai più. Ancora in uno dei nostri incontri nel famigerato vaporetto mi sorprese esordendo:
«Lo sai che gli Hinuit usano sessanta concetti per definire
cielo, ghiaccio, neve?» Io sorpreso dovetti sforzare la mia
memoria per ricordare che gli Hinuit erano gli Eschimesi. Credo che come il grande poeta Majakovskij, detestasse gli epitaffi. Voglio pensarlo così: «In te c’è più di quanto tu non sappia, figlio dell’Occidente cortese. Coraggio
e saggezza, in giusta misura mischiati. Se un maggior numero di noi stimasse cibo, musica e opere al di sopra dei
tesori d’oro, questo sarebbe un mondo più lieto» (Thorin
sul letto di morte a Bilbo Baggins, in Lo Hobbit di John
Ronald Reuel Tolkien).
Tito Gotti
La sapienza si donò alla pratica
Parlare di Giovanni Morelli vuol dire innanzi tutto
sceglierne la chiave in uno strabocchevole numero. Uno
sconcerto che mi ha investito dal 1976: nelle Feste Musicali che ho per trent’anni programmato e curato a Bologna, si inseriva una serata di musiche massoniche. Occorrevano le note illustrative per il programma. Con Morelli
ci si conosceva, in biblioteca, di vista e di mormorati saluti. Il programma del concerto era fuori routine per l’illustratore: alcuni pezzi stranoti con altri estorti a uno specialista musicale del Grand Orient di Parigi, e altri ancora
che avevo dovuto stanare dall’ignoto. Ma a che mai poteva valere l’istanza saputella di fronte ai perduti sguardi
del bizzarro personaggio che ad ogni mossa garantiva insieme l’evento e l’impensata evidenza? L’assenso fu consapevole (rassegnato?), l’azione fulminea: al primo giro del
suo pendolariato didattico litigavo coi perfidi, celebri caratterini della sua dattilografica, esplodeva, spesso da inseguire inafferrabile, il crepitare universale e strabiliante
dei suoi riferimenti, i frutti sempre impensati del suo forcipe nel costume, nella storia, nelle genetiche sorprendenti, indiscutibili, solitarie, bozzetti di vita dilatabili alla caricatura o alla verità più recondita.
Quattro pagine, forse destinate al vicolo cieco e alla
esasperazione del lettore capriccioso della chiarezza. Le
custodisco fra la folla di consimili morelliane gemme.
Le Feste Musicali ne trassero il complice più acceso e
flemmatico. Nei contatti spesso quotidiani si degustava
il paradosso, l’accostamento insieme affettuoso e spericolato (mai irriverente!) fra gli adorati oggetti di una scoperta, di un parto associato o divaricante.
Linfe nuove, esilaranti. E qui arrivo: il parlar di Giovanni è lavoro di gran virtuoso, a me si addice la casamatta del fatto compiuto, l’arroccamento nell’evocazione di
qualche operato comune, il resoconto stupefatto di un
ricorrente associarsi, convinto e fatalmente errabondo.
Il fatto, dunque. Forzatamente, uno fra i tanti, e an-
per Giovanni Morelli — 51
di ogni filologia delle fonti originali.
Estraiamo qui i titoli dal programma bolognese:
due versioni storiche da concerto per
Gli Orazi e i Curiazi
di Antonio Simone Sografi
Musica di Domenico Cimarosa
27 giugno 1984 - Chiostro di San Martino
Gli Orazi e i Curiazi
Soirée per il Primo Console
Fontainebleau, 1802
28 giugno 1984 - Chiostro di San Martino
Gran Concerto di Madama Grassini
Ristretto degli Orazi e Curiazi con l’aggiunta di arie di Marco Portugal
Padova, 1820
Agli astanti non sfuggì la impressiva divaricazione inferita da quasi un ventennio alle due «aure», alle due stesse concezioni della medesima storia. Tanto per dire: nella prima dominava il feroce (piaggiatorio?) patriottismo
giacobino con l’esaltazione del fraterno omicidio. Nell’altra la dolente malasorte di due quasi Romeo-Giulietta divisi dalla fatalità e dall’odio delle fazioni.
per Giovanni Morelli
che preferito per certi contorni più descrivibili.
Era il 1984. Da circa sette anni, assecondato dal devoto Elvidio Surian, Morelli si occupava de Gli Orazi e i
Curiazi di Cimarosa (e Antonio Simone Sografi librettista!). Il lavoro attinse pochi anni dopo a una programmata vetta: la versione dell’Editore, per i tipi della Suvini
e Zerboni. In essa l’«Editor» Morelli ammanniva il prodigio nel prodigio: dopo le tante d’epoca da lui indagate,
una versione dell’opera propria e perciò inventivamente
super-autentica, voce del quotidiano d’antan come pure lettura di esso nel tempo della storia, un’associazione
infallibile di verità e fantasia. Io me la godei all’Opera di
Roma nel 1989. Non ne conosco tutte le fortune in giro
per il mondo, secondo il dubbio capriccio degli eventi.
Ma nel 1984 le Feste Musicali già da un paio d’anni guatavano in corso d’opera la Grande Ricerca, fiutando in
essa un’occasione irripetibile, la tematizzazione (insieme
ad altra, berlioziana) della divaricanza e dell’evoluzione
per forze combinate: un cartellone metamorfico. I due
ricercatori avevano ricostruito un caso esemplare nella
storia, nell’estetica, nella sociologia del teatro in musica.
Dal suo esordio (Venezia, 1796) un successo e una diffusione enormi, una quasi cinquantennale presenza sui
cartelloni, rara in quell’epoca di veloci avvicendamenti e
continue novità sulle scene. Degli Orazi, i teatri di ogni dove presentarono una variopinta
serie di nuove versioni differenziate, in un vivace flusso del gusto, operate mediante tagli,
aggiunte, inversioni del percorso drammaturgico, qualche azzeccata sostituzione... L’autore
era morto nel 1801 senza più toccare la sua opera, salvo furti d’arie per un suo estremo lavoro. I manomissori degli Orazi? Evidentemente da cercarsi fra impresari, direttori, cantanti (perfino qualche predilezione nota di certi
illustri committenti), all’evidente progressiva
ricerca della maggior consumabilità.
Entro quel 1984 la coppia Morelli-Surian aveva già identificato e limpidamente ricostruito
(certo dalle fonti bibliograficamente meno praticabili!) più di quaranta versioni. A chi le scorresse con giusto fervore offrivano un’occasione magica e presumibilmente senza confronti
per cogliere i rapporti di interazione fra produzione e pubblico sull’appassionante tracciato
del gusto evolventesi, di una civiltà drammatica che, da una partenza già post-metastasiana, irresistibilmente s’addentrava nell’universo romantico.
Il fervido utente di quei documenti proiettava la fantasia su una sognata produzione multipla: audace e devota alle ragioni più intime, alle più interne anime del teatro da conquistare, da far conquistare, avrebbe offerto in
successive rappresentazioni una distillata, abbagliante,
leggibile serie di esempi della metamorfosi oraziana, facendo conquistare alla curiosità del melomane l’inedito
avvitamento di un originario germe musicale sulla creatività dei posteri, sui capricci del costume, sulle strategie del virtuoso narcisismo, sull’ingordigia dei mercati.
Le Feste Musicali 1984 riuscirono ad avviare un siffatto laboratorio, attente a non esorbitare dalle loro risorse.
Per benignità della sorte, la serie delle ricostruzioni storiche annoverava due versioni da concerto. Nessun sacrificio quindi di una originale completezza esecutiva.
Piuttosto, la più canina fedeltà ai testi, l’infallibile cura
L’affiancamento di Morelli all’operazione fu larghissimo. Fra l’altro, fu concesso al programma di sala il suo
monumentale saggio La rinascita della tragedia oggi a tutti leggibile come introduzione all’edizione Suvini e Zerboni: una voce di spicco nel catalogo morelliano, da conoscere a parte.
Qui vi spigoliamo, per arrotondare di una più carnosa verità i semplificati cenni di poco sopra sulla conflittualità fra 1802 e 1820. Nella marea indaginosa e interpretativa del saggio, Morelli accarezza anche l’umbratile intreccio fra le vicende della partitura e quelle, personali, di Giuseppina Grassini, somma e tenace protagonista nei decenni del monumento cimarosiano. Con impalpabile sottigliezza il saggio coniuga l’evoluzione dei
tempi con quella del canto di Giuseppina. Ricorda e soavemente liquida ogni grossolana malizia sugli adattamenti all’usura vocale nella marcia verso i più sommessi accenti del patetico, per chiamare in causa la genia-
52 — per Giovanni Morelli
le sensibilità dell’artista nell’aggiornare la sua iconografia culturale. Di ciò indicatore indiscutibile resta la sempre più ostinata inserzione delle due splendide, abbandonate, arie di Portugal al posto dei classicistici, un tantino pietrosi originali cimarosiani.
Tutti fatti segnalati con successo a Julia Hamari, sottile
e potente interprete delle esecuzioni bolognesi del 1984.
La grassiniana implicanza va letta nel suo tortuosissimo intero, ma qui viene ricordata in quanto frutto tipico di ogni affratellamento con Morelli sul lavoro, della
condivisa sostituzione dell’astrazione storicistica con la
realtà del professionale, dell’umano, della materialità fattuale. Con Giovanni, l’uomo dei vissuti avvicinamenti,
il gioco esplodeva con nettezza e allegria.
per Giovanni Morelli
Vitale Fano
Fleur impérissable
L’aspetto mite, il tono di voce pacato e l’atteggiamento
informale celavano in Giovanni Morelli una personalità
esuberante, fantasiosa e piena di brio. Uomo di sconfinata
e profonda cultura, generoso nel far partecipi gli altri delle sue conoscenze, amava esprimersi con verve ilare e spiritosa, trovando parole eleganti e poetiche e trasformando i pensieri in immagini vivide, con lo straordinario effetto di rendere incantevole la comunicazione.
Le mie poche righe intendono soffermarsi proprio sul fascino del suo linguaggio, che ho voglia di ritrovare aprendo un suo libro, Il morbo di Rameau. Il volume, che porta
come sottotitolo La nascita della critica musicale, è un’acuta
analisi dell’opera Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau presentata sotto forma di dialogo fra Jean-François
Rameau e Pierre-Louis Fuzelier, stravaganti nipoti del
compositore e del librettista dell’opera. «Un dialogo che
non è dialogo, ma monologo bifronte» – dice Morelli – in
cui i due sostengono, in successione di capitoli denominati «scandali» («come può fare miracoli un prete impostore», «come può essere un amore né fedel né incostante», ecc.), tesi contrapposte, non di rado poco plausibili,
sul significato intrinseco de Le Indie galanti. Un esercizio
intellettuale di sublime erudizione e raffinatezza che riflette la vastità delle conoscenze musicali, storiche, letterarie e filosofiche che tutti gli riconosciamo. Ma il tono enfatico e visionario delle enunciazioni dei due interlocutori, assieme alla ricercata e pittoresca ambientazione in una saletta dello storico Café de la Régence a Parigi, fra partite di scacchi, piatti succulenti e strani personaggi, lo rendono un avvincente romanzo critico in cui
balzano continuamente all’occhio la trovata geniale, l’espressione esilarante, il gusto per la descrizione minuta
e la tendenza all’iperbole, il tutto in uno stile narrativo
prezioso ed elegante.
Ecco la descrizione del momento in cui uno dei due nipoti viene interrotto bruscamente dal frastuono provocato da un giocatore che prende matto in poche mosse
niente meno che da Kermuy de Légal, figura nota nella
storia degli scacchi proprio grazie a questa partita.
Sul fondo della saletta, in quel preciso momento, al tavolo
che stava incuneato fra il giro largo della scaletta col corrimano d’ottone e il muretto con la mensola su cui troneggiavano
sporgenti e sempre in attesa di cadere, i tre vasi da farmacia,
i tre grandi orci panciuti di ceramica di Rennes, in cui le pa-
drone tenevano stipate due partite di spugne nuove, per i bagni del primo piano, ovvero al tavolo di Légal, accadde un fatto notevole, a dir poco «storico».
Légal, che da mesi giocava a pagamento (vendendo «vantaggi») aveva dato matto in sette mosse al giovane Jean-Léonor
de Saint-Brie (cui aveva fatto pagare salato il vantaggio della
torre): 1. e4, e5; 2. Ac4, d6; 3. Cf3, Cc6; 4. Cc3, Ag4; 5. C:e5,
A:d1; 6. A:f7+, Re7; 7. Cd5 matto.
Il cavaliere, congestionato nel viso, si era levato allora tanto
di scatto dallo sgabello, che aveva fatto cadere, non uno, non
due, ma tutti e tre i grandi orci, pieni di spugne secche, che
stavano sulla mensola che gli aveva fatto da tettoia durante la
malaugurata e fulminante partita.
Due si ruppero subito, senza troppo fragore, rovesciando
sulla sinistra della saletta una impressionante quantità di spugnette gialle e verde-limone, che presero a saltellare un po’
dovunque a scatti. A prima vista il pavimento prese l’aspetto
di un campo di battaglia di rane e pannocchie di granoturco.
Poi fu ben presto, pressoché immediatamente, la volta del
terzo vaso che aveva stranamente un po’ esitato in aria, aveva quindi saltato il corrimano e raggiunto il settimo gradino
della scala da cui era sceso a balzelloni, via via schiantandosi
e vomitando un centinaio di piccole spugne della Martinica,
di color marrone, quasi nere, somigliantissime a topi.
Furono queste ultime e non le prime, le giallo canarine, ad
attirare l’attenzione della gatta di Mme Poleni, una delle tre
padrone, l’italiana, e dei cinque giovanissimi frutti della sua
ultima covata.
Questa situazione fantasmagorica (potrebbe essere un
cartone animato!), in cui significativamente compare anche una gatta con i suoi cuccioli, è esempio di uno humour
che permea tutto il testo e lo arricchisce di immagini finemente scolpite: lo spiantato Rameau è descritto come
«meraviglioso cacciatore di prestiti» e le sue argomentazioni divengono «la traccia, nel bosco, delle bricioline di
un Petit Poucet che cerca di “tornare alla modernità”»;
la mente di Fuzelier è invece abitata da «ossi del pensiero» con cui l’uomo è in grado di «edificare scheletri di
idee assolutamente originali». Fra le altre innumerevoli
immagini suggestive ci sono poi il «rosario di ossimori»,
le «rifrazioni caleidoscopiche della noia», «sotto la doccia di argomentazioni fredde», «un quadro dipinto che
aspetta ancora la tela», Rameau che temeva un dibattito sul metodo storico «come gli spruzzi dello sternuto di
un raffreddato». Per non dire delle metafore mediche: «il
mezzo di contrasto rivelatore di smaglianti visioni critiche»; la fable che «soffre da tutte le parti di emorragie
della pertinenza»; la «filosofia della vaccinazione»; fino
a descrizioni acustico-anatomiche come le «vocali tutte
appoggiate sui denti e continua semi-tensione dei muscoli mandibolari, con sibilamento esplosivo delle nasali». E così via, in un prodigioso equilibrio fra profondità e originalità della critica musicale e varietà delle divagazioni immaginifiche. «Ma è tutto vero», mi disse Morelli durante una delle nostre chiacchierate. Mi regalò il
libro sfidandomi a scovare un’inesattezza, non ricordo
bene se sul diagramma di una posizione o nella notazione di una partita di scacchi. Lo lessi avidamente e vi riconobbi, come in una sorta di autoritratto, il suo caratteristico modo di esprimersi che non cessava mai di stupirmi, anche nella comunicazione abituale.
Riuscì a definire il percorso universitario di uno studente adulto e già diplomato in Conservatorio «un omag-
gio alle istituzioni» e a iniziare un esame dicendo al candidato: «Mi faccia lei delle domande!», dimostrando così considerazione e rispetto assoluti, che tutto il popolo
degli studenti ha sempre da lui ricevuto.
Ricordo un suo colorito suggerimento sulla metodologia della ricerca con cui metteva in guardia dallo studio
meccanico e acritico: «Non è setacciando l’acquedotto
di Treviso che si trova l’oro, ma piuttosto andando a verificare le intuizioni»; nel contempo, di fronte all’ammirazione per la sua enorme conoscenza dei repertori musicali, anche dei meno noti, disse candidamente: «Bisogna sporcarsi le orecchie», suggerendo così di ascoltare
di tutto senza atteggiamenti di superiorità.
Rivolgendosi a lui si riceveva sempre qualcosa di speciale: quando gli chiesi un buon soggetto per partecipare a un convegno su Toscanini tirò fuori dalla sua collezione un film-documentario del 1943 in cui il direttore
d’orchestra, esule in America, è protagonista di una sceneggiatura propagandistica ideata all’indomani della caduta del fascismo: «Questo è uno scoop!», mi disse, e me
ne fece dono. Si trattava di una rarità assoluta, di straordinario interesse storico, misteriosamente sparita dalla
circolazione da più di sessant’anni.
Di Giovanni conservo gelosamente un buon numero
di e-mail confidenziali e di lavoro. Mi piace concludere con le sue parole, trascrivendo un significativo commento relativo alla mia trasposizione informatica di un
brano sinfonico:
Sentita l’Ouverture.
Decisamente un bel pezzo.
Decisamente un bel lavoro anche il tuo, eroico.
Uno strano effetto – da verificare nell’esecuzione reale –: si avverte come percezione particolare che cresce
nel tempo uno strabiliante colorismo decolorato; non è
solo una questione timbrica (condizionata dallo specimen elettronico), sembra esserci nel testo una dichiarata esposizione coloristica (piùchewagneriana) abbassata
ad un effettivo bianco e nero.
Certamente una amplificazione, non trascrittiva, di un
pensiero essenzialmente pianistico.
Qualche anno fa, per un’edizione postuma di due saggi musicologici ripescati negli archivi della Fondazione
Cini, Morelli pensò al titolo Fleurs impérissables. Viene oggi naturale rivolgere a lui lo stesso suggestivo pensiero.
Mario Messinis
Qualche mese fa Giovanni Morelli mi donò con allegria
l’ultimo volume (il trentottesimo) della Drammaturgia musicale veneta, la monumentale collana ideata dall’Istituto per
la Musica della Fondazione Cini da lui diretto. Il facsimile del manoscritto napoletano dell’Incoronazione di Poppea
di Monteverdi è preceduto da saggi storici e musicologici.
Sembra quasi che il grande studioso, mentre approfondiva
le ultime tendenze delle tecnologie informatiche e audiovisuali – che lo avevano particolarmente impegnato negli
ultimi anni con seminari ed esecuzioni di opere nuove –
volesse ritornare anche agli studi della giovinezza, quando indagava e scopriva manoscritti ed autografi sei-settecenteschi e innumeri fonti del teatro musicale veneziano.
Riuscì a convincere il riluttante amico storico Gino Ben-
zoni, di cui apprezzava la scrittura frondosa ed antiaccademica, ad occuparsi dell’opera marciana non soltanto
dal punto di vista storico, ma anche letterario. Morelli era
un maestro della «musicologia satirica», di cui parla Vinay, ma anche uno stimolatore di energie: il suo Istituto
era un formidabile polo di attrazione per i più forti ingegni musicologici a livello internazionale. Non dava nulla
per scontato, e si richiamava a Benjamin con una citazione che chiariva il suo stesso metodo critico: la Storia che
dovrebbe svelarci «come sono andate veramente le cose è
uno dei potenti narcotici del nostro secolo». Gli chiesi se
metteva ancora in dubbio l’autenticità dell’Incoronazione: è un «pasticcio», mi rispose, cioè un’opera a più mani.
Morelli è stato uno straordinario coordinatore di fondi documentari dei maggiori musicisti italiani del Novecento, in gran parte da lui raccolti alla Fondazione Cini. Divennero il corpo vivo della sua ricerca: non si contano i contributi e le pubblicazioni, le ricostruzioni biografiche e filologiche, sorrette anche con un fiuto poliziesco da «agente di Scotland Yard» (ricostruì il viatico
oltreoceano della partitura del Requiem di Maderna, che
si riteneva perduta). Non credeva ad una concezione rettilinea della storia: le sue predilezioni erano deliberatamente contraddittorie, l’astratta gioielleria dodecafonica
di Togni valendo quanto la «candida» leggerezza di Rota.
Amava l’utopia, i progetti conoscitivi temerari. Memorabile la ricostruzione dell’incompiuto concerto per pianoforte e orchestra di Togni da lui sollecitata nella convinzione che si potessero sonorizzare le «particelle» manoscritte dell’autore. Fu un’ipotesi ardita che rivela la sua
profonda conoscenza anche dei meccanismi seriali della nuova musica.
Talento interdisciplinare, di vastissime letture, prediligeva soprattutto un’area culturale tra Francia, certo Est
europeo e Stati Uniti. Come pedale sotterraneo attraversano la sua opera ascendenze speculative, tra Illuminismo, sociologia e il pensiero materialistico di Marx. Le
intuizioni psicanalitiche rivelano, sotto un linguaggio allusivo e frammentato, le più nascoste verità.
Tra i numerosi libri, Il morbo di Rameau, con cui Morelli
ha creato il romanzo musicologico, chiarisce la sua idea
narrativa. Attraverso Diderot splende la verità documentaria e insieme la immaginaria fantasmagoria creativa,
sorretta da una irresistibile vena ironico-giocosa: «Non
c’era più neanche un passerotto sul parapetto; […] solo
due merli bischeri erano ancora lì, neri, nerissimi, freddi». D’altronde basta leggere i titoli estrosi dei suoi saggi
e dei suoi libri per cogliere i capricci di una scrittura limpida, ma talora deliberatamente quasi indecifrabile. L’articolazione sintattica alterna la semplicità alla complessità nella vertigine labirintica delle immagini e nei grovigli di incisi e subordinate. Il suo volatile ermetismo esigeva la partecipazione intellettuale del lettore. L’incontro tra rigore filologico e invenzione letteraria ricorda il
pensiero di Gianfranco Contini.
Giovanni Morelli era un intellettuale di statura europea. Ma i suoi innumerevoli contributi storici erano noti soltanto ad una ristretta cerchia di specialisti e letterati soprattutto stranieri (godeva della stima di Jean Starobinski, lo studioso tra l’altro di Rousseau e Diderot).
Non ha mai scritto per i giornali, non ha mai parlato alla radio: la sua era una presenza silenziosa. Prediligeva
l’anonimato, amava donare le sue conoscenze. Generoso nell’amicizia, come nei rapporti con gli esperti. A
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 53
per Giovanni Morelli
54 — per Giovanni Morelli
Ca’ Foscari si era assunto il compito di insegnare per un
quinquennio anche Storia del cinema perché la cattedra
non venisse soppressa. Amava lo spettacolo, anche se
non frequentava teatri, né sale di proiezione. Ma i suoi
archivi privati sono sterminati. Mi accadde di chiedergli
alcune informazioni su film sovietici di Kozintsev per
la musica di Šostakovič. Mi descrisse subito varie colonne sonore ricostruendo dettagliatamente a memoria anche la narrazione cinematografica. Il suo ultimo libro,
Prima la musica, poi il cinema, pubblicato da Marsilio, l’editore fedele, conferma l’interesse per il suono e per l’immagine. Due esempi: la lettura dell’atto sacrificale e della «rincorsa verso la morte» di Offret di Tarkovskij, attraverso il suono del Nono estremo; la riflessione su Barry
Lindon di Kubrick che traduce l’ambientazione musicale settecentesca «in una stele, in un cippo nero di pietra»
con una didascalia antinarrativa da «film muto».
La curiosità di Morelli era illimitata. Non aveva pregiudizi nella sua sublime stravaganza; credeva in una informazione aperta, che arricchiva giorno dopo giorno. Era
inquieto, ostile all’ortodossia, interessato ad ogni aspetto del mondo dei suoni, dal Rinascimento alle culture
tradizionali, da Verdi ai contemporanei. Contestò anche
metodologicamente l’accademia musicologica, forse sollecitato dalla larghissima conoscenza delle ultime avanguardie, con una saggistica acuminata su Kurtág, Nono, Berio, la musica elettronica, Cage, di cui era in grado di ricostruire persino gli happenings. Conosceva analiticamente l’intera produzione del «divino» Stockhausen.
C’è stata una particolare consonanza tra Morelli e Margot Galante Garrone, ideatrice del Teatrino «La Fede
delle Femmine». Negli affascinanti spettacoli di marionette dal miniaturismo ramificato – ironici, crudeli, ambigui, erotici, enigmatici – si scoprivano affinità con la
sottigliezza ludica e pungente, con le diramazioni della
scrittura e con il gusto antiquariale del Morelli editore.
La sua presenza era non soltanto culturale, ma anche affettiva: «Morelli è un santo», mi disse un giorno Luciano Berio. Dalla privazione di Giovanni c’è in me un’inguaribile solitudine.
Veniero Rizzardi
Perché fosse tanto schivo, oltre il «ragionevole» (se posso dire così), non saprei – e comincio da qui, da uno dei
tratti suoi più appariscenti, quello che ha fatto sì che non
ci siano state cerimonie o riti funebri, pubblici. Si è sottratto così anche a un principio di elaborazione collettiva del lutto che però, più opportunamente, ciascuno sta
facendo per sé, in incontri e parole a quattro, massimo
sei occhi (aveva ragione lui, naturalmente, come ci avesse costretto a fare proprio in questo modo), in una specie
di collettivo e continuato bisbiglio in cui ciascuno di noi
che l’abbiamo conosciuto, e che dobbiamo imparare a fare i conti con questo vuoto, si trova a raccontare qualcosa che lo ha toccato da vicino, a scambiare altre storie, un
episodio sconosciuto, e spesso sorprendente, che completa e arricchisce di sfaccettature un’immagine che crediamo di conoscere già bene. Questo vale anche per la sua
biografia intellettuale, che conosco solo in modo approssimativo, che mi ha sempre incuriosito, ma che mi è sempre piaciuto più che altro immaginare: straordinariamente fitta di esperienze, figure, motivi, letture, idee, attività,
anche semisegrete, molte abbandonate, appartenenti ad
altre stagioni sue, a me sconosciute; ma tutt’altro che «dispersiva», anzi, totalmente inclusiva, e per questo produttiva quant’altre mai, in modo unico.
Credo che la ritrosia sia stato soprattutto il suo modo
di fare i conti in modo radicale con l’ingombro della genialità, con la coscienza acuta di un’obiettiva superiorità intellettuale, un modo di rovesciare nel suo contrario
quello che in altri sarebbe divenuta anche veste esteriore, convenzionale, di autorevolezza. Con questo – insieme a una totale, disarmante assenza di un qualsiasi atteggiamento o moto che denotasse un sia pur minimo tasso
di fisiologica aggressività – si definiva il carattere, singolare, della sua vera, concreta autorità, e quindi della sua
azione di intellettuale; oltre che, inscindibilmente, delle
sue qualità umane, di cui poi occorrerà ben dire qualcosa.
In quanto musicologo è stato l’opposto, la negazione
felicemente funzionante dello specialista, e lo è stato più
di chiunque altro studioso contemporaneo che io abbia conosciuto, anche indirettamente. Ma questa è ancora un’approssimazione, perché se alcune sue competenze specifiche potevano permettergli di giocare temporaneamente il ruolo dello specialista, e ai massimi livelli – basta pensare a come ha potuto ordire e organizzare, singolarmente e complessivamente, i volumi della Drammaturgia musicale veneta, trenta opere del Sei-Settecento – il significato di queste operazioni si amplificava
per effetto di «tutto il resto», di tutto quello di cui era in
grado di occuparsi con uguale disinvoltura, competenza, perspicacia, capacità di creare rivelazioni: teatro musicale di ogni epoca, musiche etniche, rock femminile,
composizione contemporanea, jazz, musica elettronica,
e poi via via allargando i cerchi, cinema, teatro, poesia,
lettere, filosofia, psicologia, e altre scienze umane conosciute, e se non ben conosciute, magnificamente intuite.
Tutto questo in realtà lo sto dicendo a chi non l’ha conosciuto, perché se ne faccia un’idea approssimativa, in
realtà sto ripetendo, per automatismo consolatorio, coordinate ben note a tutti coloro che hanno avuto un qualche rapporto con lui, e che hanno fatto esperienza della sua abilità e della sua naturalezza nel collegare nozioni e pensieri e soprattutto ambiti del sapere in apparenza lontani. Anche nella chiacchiera. Più che erudito, dava l’impressione di essere onnisciente.
Mi dispiace molto di essere arrivato troppo tardi per
avere l’opportunità di averlo come docente, l’esperienza delle sue lezioni e delle esercitazioni (altri suoi discorsi in pubblico erano un’altra cosa) mi era ormai preclusa.
La invidiavo a quegli studenti miei che frequentavano i
suoi corsi, ai quali ogni tanto cercavo di carpire, senza
darlo a vedere, qualche informazione fresca. Non ne ricavavo quasi niente, salvo la sorpresa dell’uniformità delle opinioni: erano tutti indistintamente affascinati, e stimolati da un’esperienza che ammettevano di non riuscire ad afferrare («non si capisce niente, è meraviglioso»),
e non uno solo che se ne sentisse magari un po’ irritato,
nemmeno quando, dopo la riforma, l’università aveva
cominciato a richiedere modi e tempi di apprendimento
adatti più che altro a una scuola guida. La stessa impressione me l’hanno sempre riferita amici e colleghi che lo
avevano avuto come docente anni addietro, e che nella
distanza ricordano come la sua lezione fosse sedimentata in uno strato di fermenti tuttora attivissimi. Va bene,
questo lo si dice sempre di un buon insegnante, ma in
per Giovanni Morelli — 55
Con Vitale Fano
nello Studio Respighi della Fondazione Cini (2008).
lora tutta questa oscurità?): ci parla cioè del desiderio di
incontrare la verità, «imprendibile», attraverso i continui
scarti del pensiero che scrive, e il cui esito può essere se
mai la temporanea sedazione (ecco spuntare anche qui la
sua inclinazione per i farmaci) di quella fondamentale disposizione ansiosa in cui prendeva forma la sua passione.
Osservate poi quell’aggettivo, «impreparato». Come a
dire che la scrittura (sempre: il pensiero che scrive) si fa
sorprendendosi da se stessa; l’umorismo, che al suo pensiero è necessario, coglie di sorpresa anche il soggetto che
scrive, così come le «sparizioni» del significato, approssimato per mezzo di «ritorni variati e repentini». Il proliferare di informazioni che concrescono, in tutte le direzioni, alla sua prosa corrispondono così (e dico: ovviamente) su altra scala, alla molteplicità degli interessi che
esercitava, metteva a «lavorare» insieme – il tutto detto
nella solita sua indefinibile emulsione di modestia, autentica, e di autocompiacimento:
«La fantasia che spesso mi si attribuisce come carattere
espressivo personale è solo e soltanto una forma di abreazione al numero incalcolabile di influenze cui mi sono volontariamente esposto, come in una sorta di esercizio di esposizione alle infezioni (il mio sogno potrebbe essere una villeggiatura a Ebola) quasi a tentare di realizzare, in modo perentoriamente anomalo, quel martirio cui di fatto aspiro e che mi è negato invece come at-
per Giovanni Morelli
questo caso il dato di partenza era sempre quella sua leggendaria, ormai scontata «incomprensibilità».
Non si comportava, dunque, con gli studenti, in modo diverso da come la sua scrittura provoca il lettore. Io
per la verità non l’ho mai trovata veramente «difficile» –
voglio dire, non mi pare abbia niente di strutturalmente
ostico. Intricata, sì, per effetto più che altro dell’impulso irrefrenabile, goloso, a includere, ramificare, moltiplicare, non rinunciare ad arricchire ogni enunciato di sfumature, risonanze, allusioni, potenziali rinvii (per non
parlare dell’ipertrofia delle note a piè pagina) come se l’esattezza così sorvegliata della sua prosa non possa essere
tale senza tutti questi complementi, ivi comprese eventuali traduzioni in scrittura di quello che a una conversazione potrebbero aggiungere gli sguardi, la gestualità, la
mimica facciale. In questo senso, una paradossale soluzione, tutta sua, a quella tara che spesso gli ho sentito lamentare a proposito della lingua italiana scritta, che non
ha appunto sviluppato (a differenza del francese, per es.)
uno stile di conversazione.
Parlava poco di sé, ma non si tirava indietro quando
provocato. Ho sottomano nientemeno che un’intervista, raccolta cinque anni fa in occasione del conferimento di un premio e pubblicata su una rivista che circola
quasi esclusivamente nei Conservatori di musica.1 Credo
sia passata inosservata (anche questa cosa sembra architettata, e va benissimo d’accordo con il
personaggio), dunque vale la pena che
ne riproduca qui qualche sostanzioso
pezzo. Sicuramente non raccolta a voce, ma scritta (immagino di getto), produce rivelazioni che assomigliano tanto a conferme di ciò che si sospettava.
«Circa il linguaggio “musicologico”
da me praticato, continuo a praticarlo
senza prestar mai orecchio alle rampogne di chi lo definisce “arduo”, in quanto ritengo che “arduo” non sia, quanto
“necessariamente sordo” ai canti delle sirene della semplificazione. In posizione di destinatario di comunicazione ho sempre nutrito sospetto nei
confronti di messaggi troppo “chiari”
e mi sono avvicinato, invece, mit innigster Empfindung alle trasmissioni di sapere chiaroscurate e, possibilmente, oscure».
Eloquente. Ma attenzione a quello che segue, perché
si produce in un catalogo (parziale, per esempi, ma per
noi più che sufficiente), come un piccolo saggio di autoanalisi, o magari di «poetica»:
«In quelle oscurità, nell’incedere preoccupante delle
discrasie tra contenuto e forma, negli abissi ellittici, negli “imbottigliamenti” paratattici, nelle eruzioni impreparate di umorismo, nei ritorni variati e repentini del significato e nelle sue sparizioni ancor più impreparate,
nell’arcana bi-logicità del discorso dei poeti che han saputo prescindere sia dall’io che dal tu-lirico, ho sempre trovato il conforto, anche sedativo, dell’incontro imprendibile con la verità».
C’è tutto il suo stile, ma sta parlando di sé, lo sta applicando a un pezzo importante di confessione (e dov’è al-
tributo dall’essenziale mia esclusione dal novero dei santi cattolici, storici o potenziali».
Le «influenze». C’è da crederci, che siano state incalcolabili. Negli anni in cui l’ho frequentato (non tantissimi,
direi dal 1994, e comunque è con lui che mi sono riscoperto a mia volta esposto a un potente contagio) ho potuto vederne in azione diverse, di queste «influenze», nel
loro emergere e qualche volta nel dilagare, nell’imprimere svolte se non altro alle sue priorità scientifiche (ma come suona riduttivo dire «scientifiche», nel suo caso). E
spesso non erano nemmeno troppo (direttamente) musicali. Il cinema aveva giocato un ruolo più importante,
in particolare quello di Otar Ioseliani, con cui si era forse
anche in parte umanamente identificato, e recentemente
di Istvan Gaál. Memorabile un articolo sul Rocky Horror
Picture Show, se non altro per l’umorismo (tutt’altro che
unprepared, stavolta) della sintesi contenuta nel titolo: La
spinta pelvica del ‘cult’. Negli ultimissimi tempi aveva apertamente dichiarato entusiasmo per un compositore,
per Giovanni Morelli
56 — per Giovanni Morelli
Robert Ashley, specie dopo avere scoperto un suo lavoro del 1974 basato su di un testo follemente proliferante
concepito dall’enigmatico John Barton Wolgamot. Uno
dei suoi ultimi scritti, credo proprio l’ultimo, è dedicato agli sviluppi contemporanei della musica elettronica,
affrontati giustamente dal lato della pratica sociale, ed è
un’apertura di campo veramente molto, molto significativa e utile, a pratiche musicali irriducibili al testo (feticcio dei musicologi).
Ancora, a completare l’argomento dell’esposizione a influenze plurime: «Ho sviluppato un certo sesto senso e
delle perfezionate antenne per riuscire a trovare sempre
una situazione in cui posso inespressivamente esprimere al meglio la mia disposizione acquisita a sottomettermi totalmente al caso».
Un occasionalismo dichiarato. E, volendo, anche orgogliosamente spudorato che, dopo un po’, mi è stato
abbastanza evidente come caratteristica del suo pensiero. Spesso le cose gli giungevano incontro appunto per
caso, e divenivano centro del suo lavoro di scavo. Come i fondi musicali che si trovava ad amministrare alla Fondazione Cini. Non so se altrimenti si sarebbe occupato, per dirne una, di Camillo Togni. Forse nemmeno di Nino Rota. Così era nata anche la rivista aaa/tac,
da una proposta che gli avevo timidamente accennato, e
che andava nel senso di preoccupazioni che sapevo avevamo in comune, proprio in rapporto all’istituzione di
qualcosa che trattasse l’arte acustica, la storia del suono, le intersezioni tecnica/suono/musica. «Forse abbiamo la possibilità di farci una rivista», ma non mi pareva
che ne avesse una gran voglia, poi però poco dopo la rivista è nata. E ci si è ingolosito subito, così le riviste sono diventate due, con aam/tac per il cinema – a ulteriore conferma della centralità che aveva preso questo linguaggio per lui – manco a dirlo due nuovi, bei carichi di
lavoro, figurarsi se delegati a qualcuno. Si occupava lui
della redazione finale degli articoli – questa non gliel’avrebbe tolta nessuno – di intitolare creativamente i raggruppamenti degli articoli in sezioni, e sapeva recuperare qualche collaborazione prestigiosa (come la firma di
Michel Serres), chissà come. E i numeri si sono sempre
chiusi puntualmente.
Adesso tornate su e riprendete nota dell’«aspirazione
al martirio», con dentro tutta la disposizione all’iperbole «malcontenta» (alla Malipiero, altro autore molto amato, scavato e commentato) e dunque umoristica, che però
corrispondeva bene al tenore, all’intensità, ripeto, spesso interiormente ansiosa, del suo fare. Digressione: c’era
stato un periodo, qualche anno fa, che aveva preso l’abitudine di andarsene in giro, oltre che con l’inseparabile
carrello della spesa –pieno di libri e carte, tranne qualche pomeriggio, quando lo era di scatolette per i gatti –
con qualche borsa di tela a tracolla. Tre o quattro. Mi
spiegava che ogni borsa era dedicata a un singolo lavoro
in corso d’opera. Al che gli chiedevo, borse o non borse, quante cose stesse portando avanti contemporaneamente in quel momento. Lui rimane in silenzio un attimo, si vede che sta enumerando, poi, senza nessuna enfasi, mi risponde: «quaranta», e mi fidavo, non esagerava. In un suo profiletto biografico, non so dove sul web,
aveva detto che la sua produttività era il frutto di un’autocostrizione a lavorare «un po’ per spirito di servizio e
un po’ per nervosismo».
La sua capacità di lavoro, la sua velocità esecutiva, an-
che, non correvano mai il rischio di «tirare via». E quando, per ragioni di tempo, di circostanze, si metteva nelle
condizioni in cui chiunque altro avrebbe rischiato una
prestazione meno che brillante, riusciva sempre a pescare dal suo magazzino qualcosa che non avevi mai visto o sentito. Ricordo di averlo quasi trascinato, almeno
tre volte, in performance oratorie che aveva sicuramente cominciato ad affrontare controvoglia, due di queste,
alla fine, del tutto improvvisate: l’esito risultava comunque perfettamente strutturato nella ricchezza e nell’ordine dell’argomentazione, buono per le stampe, volendo,
e, va da sé, originale. Alla fine si era naturalmente divertito. La stessa capacità di sbrigare velocemente un enorme volume di lavoro era applicata a una quantità incalcolabile di incombenze minori e strumentali, in cui riusciva sempre a trovare un motivo di interesse, come magari la stesura di una lettera di presentazione: ne ricordo
una per una pianista che proponeva un repertorio originale, era finita per essere una cosa simile a un gustoso e
raffinato programma di sala. Ma chissà quante ne avrà
scritte di queste cosette (sempre in grafia minutissima,
corpo 8 almeno; perché così, immagino, aveva trovato il
modo, passando alla videoscrittura, almeno di alludere ai
caratteri di scarsissima decifrabilità della sua grafia manoscritta, dove qualche volta gli era capitato di rinchiudersi dentro, da solo: una volta mi disse che, cercando di
riprendere appunti di molti anni prima, non era riuscito
a capirci più niente), chissà quanti gesti, pensati e accuratamente eseguiti, nel più totale disinteresse.
E qui comincio a lasciare da parte, ma solo per modo
di dire, il cosiddetto ritratto intellettuale, per metter giù
altre cose: intanto che questa fisionomia anomala, eccezionale, che per un limite forse di ritrosia, forse di qualcosa d’altro, forse di semplice felicità nel vivere e operare in questa città-isola singolare, che non ci fa venire
gran voglia di uscire e andarcene – tanto poi il mondo ci
fa visita e lo incontriamo qui – questa figura non è stata
ancora conosciuta, non ha avuto le risonanze che meriterebbe al di fuori della cultura italiana. In futuro chissà; per le fortune postume, purtroppo, c’è sempre tempo.
Poi, «naturalmente», e questo fa comunque ancora parte del suo costume intellettuale, gli aspetti umani, anche
questi di eccezione. Perché è stato sempre buono, generoso, paterno con chiunque gli si rivolgesse. Immagino
di leggere, qui intorno, tante lievi varianti di questa cosa
che sto scrivendo, tante storie e storielle a dimostrazione di un carattere, anche in quest’ambito, fuori, ma tanto fuori dal comune. Quando incontrava qualcuno di cui
avesse un qualche grado di stima trovava sempre il modo di favorirlo, spontaneamente, di promuoverlo, quasi sempre in modo inavvertito. Capitava di ricevere un
invito per un’occasione di studio, di lavoro, un articolo,
una conferenza, o di altro di maggior peso ecc. e toccava soltanto sospettare che ci fosse dietro lui, ma ben nascosto, perché la sua tattica andava sempre nel senso di
evitare manifestazioni esplicite di gratitudine, che peraltro gli facevano piacere (e meno male). Ma si comportava
allo stesso modo anche con chi andava a bussare alla sua
porta. In questo senso, pur in possesso di un prestigio
oggettivo che gli avrebbe consentito di istituire una solidissima baronia, non ha esercitato alcun potere nell’accademia, di cui aveva in odio le strutture, pur sapendole
usare alla perfezione. So che non amava le scuole di dottorato perché le riteneva palestre di lotta fratricida. La
per Giovanni Morelli — 57
Gli sono grato per un’infinità di cose, che naturalmente non starò qui a dire. Ho avuto la fortuna di avere qualche maestro per amico (e viceversa), ma con lui è stata un’amicizia ancora differente. Ben prima che potessi immaginare di non averlo più, avevo già elaborato ricordi che si erano fissati come lezioni, anche istantanee,
magari davanti al bancone di un’osteria. Una volta, sollecitato da una domanda che non ricordo, mi ha detto
perentoriamente: «io non ho opinioni». Questo è rimasto, una lezione di metodo in quattro parole. Poi il privilegio di aver fatto di tanto in tanto qualcosa a quattro
mani con lui, e svariati episodi estemporanei di complicità, alcuni di grandissima soddisfazione. Riguardo l’archivio delle email, tra le più informali e dirette che abbia mai scambiato con chiunque, prive di formule, saluti e spesso anche di ringraziamenti, spesso corredate da
immagini, poemetti umoristici in stile metastasiano, foto, mp3, di cui ti chiedevi sempre quale messaggio arcano potessero contenere.
«...un libro, abbastanza visionario, che non mi decido
a terminare (forse sperando di lasciarlo incompiuto, come forse si converrebbe) in cui tento di raffigurare, nella vicenda del più dotato, a dire dei professionali fratelli, dei figli di Bach (Gottfried Heinrich Bach, 1724-1761)
ma anche il meno dotato alla vita di relazione (gravemente autistico, infatti, straordinario improvvisatore creativo al cembalo e al clavicordo, sopravvissuto al padre in
casa del cognato Altnickol, il marito di Elisabeth Bach,
senza aver imparato a parlare una lingua qualsiasi), l’acme, precocissima e profetica, della crisi della modernità. Ciò a dimostrare/dichiarare che l’apparente giocosità e la densità talora fastidiosa del mio standard espressivo sono, l’una, una maschera civile, e, l’altra, il frutto
indesiderato di una profonda paura nei confronti degli
orrori della cultura».
Gli orrori della cultura.
Antonio Castronuovo, Incontro con Giovanni Morelli, «Musica e
scuola», xx , n. 21, 15 dicembre 2006, pp. 27-28. In quell’anno
aveva ricevuto il Premio Imola «Una vita per la critica».
1
Paolo Cecchi
Una noterella sull’«écriture» di Giovanni Morelli
Solo un tentativo del tutto parziale, forse meno di una
traccia di diagramma o di un cartello indicatore, su un
aspetto assai importante della ricerca e dell’esercizio critico di Giovanni Morelli: la trama, lo spessore, i labirinti, la
cartografia dei registri e del lessico della sua scrittura. Non
il semplice stile del suo scrivere saggistico, il «piglio» di tale scrivere, ma – aspetto ben più importante, direi decisivo della sua strategia interpretativa – la funzione che tale écriture acquista nel complesso progetto critico che l’autore realizzò incessantemente, progetto in cui l’indagine
musicologica veniva pensata come parte di una più generale indagine della cultura dell’età moderna e contemporanea e delle sue pratiche discorsive da esercitarsi sub specie antropologica (ma con riferimento ad un’antropologia
storico-medico-esegetica assai personale, fruttuosamente intricata quanto a riferimenti occultati, esibiti o rifiutati, a modelli e paradigmi fatti solo balenare, e ad «antimodelli» presi in considerazione onde dissolverli o, ribaltandoli, ricavarne nuove raffigurazioni critiche di tutt’altro segno). Morelli ha installato i propri cantieri critici in
luoghi di frontiera e di giuntura tra le discipline, non certo per un anti-accademismo spicciolo, quanto per una necessità, ritenuta impellente, di dissodare problemi e questioni con strumenti costruiti ad hoc (beninteso tenendo
ben presenti alcuni armamentari critici d’alto lignaggio a
lui consentanei) e seguendo itinerari trascurati o nemmeno esplorati, laddove egli riteneva che i pur indispensabili,
ma spesso burocraticamente applicati, paradigmi basati
sulle diadi opera/contesto, storico/sistematico, struttura/
sovrastruttura, andassero ampliati e reinventati costantemente, superando le anchilosanti procedure investigative indotte da categorie interpretative e storiografiche da
molti assunte come certamente efficaci quasi per automatismo. A tal fine Morelli è ricorso ad una mise en place assai
mobile di modalità esegetiche e di strumenti critici tra i
più disparati, apparentemente tendenti al limite dell’accumulo e dell’eterogeneità esoterica, ma che invece, pur nella loro variabilità, vengono attentamente controllati nella
scrittura da strutture concettuali ed interpretative di riferimento che orientano la direzionalità (sia pur plurima)
del congegno argomentativo in modo perlopiù sorprendentemente efficace (se per efficace si intende anche ciò
che raggiunge risultati e risultanze significative scegliendo vie metodologicamente impervie, anche a scapito della clarté del percorso critico).
Nella complessa macchina critico-esegetica che Giovanni Morelli metteva in moto ad ogni nuovo saggio, costantemente rinnovandola nei congegni e negli obbiettivi, la scrittura ha un ruolo fondamentale come costellazione di scelte linguistiche che si modellano sull’oggetto dell’indagine in modo polimorfo, puntigliosamente
mobile ed anticonvenzionale, tracciando i propri percorsi retorici ed argomentativi in una prosa cangiante,
plurima, stratificata, a tratti inafferrabile e quasi fantasmatica. Quella scrittura è sempre funzionale a costruire una tela, una rete, un rizoma, in grado di avvolgere
gli oggetti dell’indagine nella loro complessità e nella loro difficile (non di rado impossibile) ricostruzione storica e comprensibilità critica, in un corpo a corpo esegetico e storiografico messo in atto attraverso e dentro
una prosa che diviene essa stessa protagonista dell’in-
per Giovanni Morelli
sua intima, radicale mitezza lo portava a ingigantire il
problema; tuttavia, per lo stile di ricerca che amava, e per
lo stile di lavoro che praticava – aperto, non competitivo, persino giocoso – era perfettamente nel giusto. Certo, è anche per quest’ordine di ragioni che non ha ‘fatto
scuola’. Oggi il vuoto che si avverte è anche fatto di questo. D’altronde, come potrebbe darsi una continuità di
‘scuola’, di ispirazione, a prescindere della sua personalità singolarissima? È una certezza, non un’impressione,
che sia stato, e sarà, insostituibile nelle varie posizioni di
responsabilità che deteneva. Come già ci sta mancando
quella sua capacità unica di relazione, di mettere virtuosamente in comunicazione persone, interessi, attività. Ci
manca soggettivamente, a ciascuno di noi – e al di là degli affetti, anche come parte di una comunità studiosa.
Praticamente, ci accorgeremo presto di quanto mancherà, enormemente, al sistema della cultura di questa città.
per Giovanni Morelli
58 — per Giovanni Morelli
cessante sforzo ricostruttivo ed ermeneutico perseguito dall’autore. La scrittura di Giovanni Morelli coniuga
molto spesso le figure del dedalo labirintico e dell’accumulo, ricorrendo ad una sintassi «metricamente» instabile e spiraliforme, ma nel contempo costellata sagacemente da alcuni punti di riferimento che provvedono a
«tenere in forma» la struttura argomentativa. Quanto alle scelte lessicali, esse meriterebbero un’analisi stilistica
(alla Spitzer) che desse conto del costante uso della stratificazione «concentrica» delle immagini/concetti/asserzioni, con uso assai vario di ritmi instabili, poi regolari
e poi nuovamente pericolanti, di sincopi, di reiterazioni
variate, di una dispositio lessicale ricca nel suo sperimentare, capace di cambi improvvisi di registro e di ambito linguistico, quanto mai idiosincratica, eppure attentamente vagliata. Un solo esempio, dall’incipit del Paradosso del farmacista, uno dei saggi più complessi e criticamente fruttuosi di Morelli, incipit ove viene enunciato il
tema – poi indagato in tutta la prima parte del volume –
di come in molti costrutti estetici (drammatici, narrativi, operistici ecc.) dell’età moderna venga declinato il topos mitologico dell’espulsione dal gruppo, e poi del «sacrificio tragico», del «singolo che diviene eroe», e di come tale sacrificio (compiuto o sventato nel «lieto fine»),
assolva la funzione di pharmakós in grado di sedare talune angosce, correlate ad identità smarrite, che minano il
corpo sociale: «Molte sono le storie, dunque, tutte troppo simili, di un allontanamento di un Singolo disbrigato in nome o in pro della salvezza di un «Soggetto Impersonale» che va a prendere la forma di un «Soggetto
Collettivo» […] i fatti accadono [id est l’allontanamento
e poi il sacrificio del “Singolo”] comunque nel nome o a
pro di un vero e proprio salvataggio di un collettivo […]
a pro di una sospirata riduzione della pressione dell’ansia
che sta opprimendo, o va ad opprimere a momenti un
gruppo di persone – in specie un gruppo unitario, perlopiù di cittadini – che non riescono bene a identificarsi, uniti o unitari, in una qualsivoglia cognizione di sé».
Sempre all’inizio del Paradosso del farmacista (pag. 3) Morelli si rivolge al «buon lettore interattivo» (da non confondersi con un «lettore ideale» o «idealtipico»): tale apostrofe è spia di un aspetto importante della scrittura dell’autore: essa postula un lettore che abbia la voglia e la curiosità intellettuale di districare la tela fittissima di quella
prosa, ma nel contempo sappia/voglia ritessere una propria tela parallela alla prima, almeno per quel che riguarda alcuni punti nodali dell’indagine critica che va leggendo. Al fine di riuscire ad approntare la propria rete di riferimenti derivata dal suo «colloquio» interattivo con la
scrittura, egli deve rimanere costantemente all’erta onde
non smarrirsi nel congegno linguistico del testo, attento a cogliere quei segnali orientativi e quei points de repère
che l’autore disloca in luoghi strategici della propria narrazione/argomentazione: segnali assai più chiarificatori del senso complessivo e delle tesi implicite che guidano la trama discorsiva di quanto la lettura di primo acchito riesca ad individuare. Evocato, e direi quasi necessario, è dunque per Morelli un lettore partecipe, ma alla maniera di uno sparring partner o di un cane da punta:
la scrittura critica che a lui rivolge l’autore non va solo
«meditata», ma implica una partecipazione intellettuale che accetti quanto di criptico e di labirintico anima il
discorso e le risultanze scrittorie, uno sforzo teso a decifrare costantemente – dietro l’«oscurità» di molti seg-
menti del percorso argomentativo – la presenza (come
detto, per segnali e punti di riferimento) di strutture discorsive «forti» che rendono alla fine evidente il senso
complessivo degli enunciati. Sono strutture che Morelli
– in pectore dialettico occulto anche quando appare puntigliosamente «decostruttivo» – tesse in guisa di impalcatura assai profilata e «cartesiana», attorno alla quale si
attorcono i fili dell’aggrovigliato – necessariamente aggrovigliato secondo l’autore – percorso scrittorio: il groviglio cela in parte al lettore tale impalcatura «chiarificatrice», la quale mantiene tuttavia intatta – una volta che
la si individui nel suo essere costantemente attiva «dentro» la macrostruttura del testo – la sua funzione coesiva
ed esplicativa. Groviglio e struttura appaiono come due
poli entro i quali la prosa di Giovanni Morelli può ad un
tempo far proliferare in modo controllato la propria labirintica, debordante vis interpretativa, ed indicare nuovi orizzonti e nuove modalità d’indagine rispetto ad una
testualità specialistica sin troppo codificata, che rischia
sovente di essere criticamente inerte. L’écriture di Morelli
agisce (dialetticamente) su un doppio piano: è realizzazione della singolarità del pensiero dell’autore, pensiero
interpretativo e storico ad un tempo, diretto a dirimere singole questioni, e nel contempo – in modo sotterraneo, ma sistematico – si costituisce, nella particolarità di
ogni indagine, anche come costante critica dell’ideologia (nelle sue diverse e spesso labirintiche declinazioni),
intesa come vera e propria macchina mitica in costante, sotterranea attività, che opera come un narcotico nei
confronti del corpo sociale e la sua vivificante «instabilità» antropologica e culturale.
Post scriptum: ora d’istinto mi appare indispensabile –
sia per gli specialisti, sia, più in generale, per chi è interessato alla ricostruzione della storia della cultura in età
moderna attraverso l’indagine dei suoi costrutti estetici – pubblicare un’edizione, almeno antologica, dei numerosissimi kleine Schriften di Morelli. Sono testi disseminati non solo in periodici e volumi musicologici, ma
anche in riviste, volumi miscellanei, atti di convegni riguardanti altre discipline e di altri saperi: riunire almeno in parte tali scritti sparsi costituirebbe uno strumento utilissimo per meglio comprendere la continuità e la
varietas di una produzione critica vastissima, onnivora e
ora più che mai necessaria.
Cesare De Michelis
Non era facile conquistare l’intimità di Giovanni Morelli e certo a me non è riuscito, tanto almeno quanto l’avrei desiderato, ma al contempo nessun altro territorio di
incontro con lui era praticabile se non quello appunto di
una complicità intellettuale che rinunciava a qualsiasi definizione nel tempo e nello spazio per resistere nella segreta dimensione che altrimenti non saprei dire che intima, interiore, dunque, e privata, nel senso proprio di non
pubblica e da altri immediatamente condivisibile.
Si poteva talvolta arrischiarsi oltre la reciprocità del dialogo, coinvolgendo tre, sin quattro interlocutori nello
stesso momento, ma poi ciascuno doveva camminargli
accanto per quel tratto che gli toccava, senza illusioni o
pretese esclusive.
Persino nei percorsi di lettura dei suoi testi non c’era
verso di correre diritti da un punto all’altro, perché
per Giovanni Morelli — 59
Con Italo Zannier (alla sua destra) fotografo e storico della fotografia, e il
preside della Facoltà di Lettere Filippo Carigi in occasione del convegno di
studi su Giuseppe Mazzariol , il 9 ottobre 2009 (foto di Nico Stringa).
cari e finalmente i suoi, fino all’ultimo – Prima la musica,
poi il cinema –, uscito ad aprile di quest’anno.
Se ne parlava incontrandosi quasi per caso, ogni volta
riscoprendo pensieri e sentimenti assai prossimi, come
se ciascuno proseguendo il proprio cammino non perdesse il filo di un discorso condiviso.
Non c’era solo la storia delle arti e delle culture a occupare le nostre chiacchiere, ma l’esperienza dell’insegnamento, l’attenzione per la produzione e l’organizzazione
degli eventi e persino le sempre più coinvolgenti riflessioni sui malanni di una salute traballante, di una vecchiaia inevitabilmente incipiente.
Ci accomunava la fatica di respirare, ma lamentandosene negli occhi di Giovanni brillava, più forte di qualsiasi malinconia, la gioia di fare e la curiosità per quanto intanto accadeva.
Poi, quando le strade ci dividevano, lui se ne andava trascinando il suo carretto senza fare rumore, perché, perennemente senza cappotto, calzava felpate babbucce che
strisciavano silenziose sulle pietre del selciato veneziano.
Ci manca ora Giovanni, ci manca quella che Messinis ha
descritto come la sua «sublime stravaganza», la sprezzatura che impediva qualsiasi superbia, il sorriso e la generosità con cui regalava informazioni e consigli, ma il patrimonio di quanto ha fatto e scritto in una vita eccezionalmente operosa lo incroceremo mille volte ancora e sempre vi troveremo il segno inequivocabile del suo ingegno.
per Giovanni Morelli
la sua stessa scrittura costringeva a deviare lungo i bordi per ritrovarsi al centro senza capire da dove vi si era
giunti. Sembrano note, letteralmente postille, tutti i suoi
scritti, frutti di un saggismo esemplarmente novecentesco, sempre oscillante tra la forma raziocinante della comunicazione scientifica e l’imprevedibile immaginazione che raggiunge il vero improvvisamente per virtù di
stile e di scrittura.
È una sfida subito perduta tentare il riassunto dei suoi
scritti composti, si direbbe, per accumulazione e giustapposizioni o accostamenti, attingendo, ben al di là di una
specifica competenza musicale, alle più varie tradizioni
artistiche e culturali, con una disarmante leggerezza che
azzera qualsiasi tentazione erudita.
Non c’è un traguardo, una conclusione e neppure una
tesi nei suoi libri, c’è invece la pienezza appagante dell’esperienza, del viaggio, del passaggio, c’è la varietà inesauribile del vissuto.
Prendere o lasciare: al catechismo dottrinario nelle sue
pagine subentra la ricchezza molteplice delle storie e ogni
volta si rinnova l’incanto di un senso, un significato, che
sgorga squillante da dove meno te lo aspettavi.
Giovanni lo incontravi davvero quasi sempre per strada e gli restavi accanto in vaporetto, lungo un corridoio,
ai margini di un’aula; lui d’altronde trascinava i suoi passi lenti e il carrello della spesa, che come il cilindro del
prestigiatore conteneva tutto quello che serviva in uno
sconcertante disordine che si opponeva caparbiamente a qualsiasi disciplina,
perché, come nella vita di ogni giorno,
le cose devono stare insieme in una sequenza senza soluzione di continuità.
Quando lo conobbi, ormai più di
trent’anni fa, sembrava che ben poco
ci fosse che potevamo condividere, tanto le strade che avevamo percorso sinallora erano diverse, eppure lui subito scoprì, e non senza il gusto sornione
di attribuire importanza alle cose per
poi subito negargliela quasi irridente,
che avevamo qualche comune interesse,
seppure con tanta diversa competenza.
Correggeva e integrava il mio giovanile
commento alle Convenienze del Sografi
svelando un sapere inesauribile e una
grazia nell’esporlo che incantava piuttosto che intimidire.
Fu Mario Messinis che mi presentò Giovanni alla fine
degli anni settanta, quando arrivò a Venezia per insegnare a Ca’ Foscari, e quasi subito – nel ’79 – pubblicammo
in Marsilio il volume che aveva curato per il Festival internazionale di musica contemporanea della Biennale,
Mitologie. Convivenze di musica e mitologia, poi immaginammo e progettammo la collana «Musica critica», diretta
appunto da Messinis e Morelli, della quale i primi titoli – I drammi musicali di R. Wagner di Carl Dahlhaus e L’opera napoletana di Michael Robinson – apparvero nell’84.
Da allora il dialogo con Giovanni non si è più interrotto, anzi, anno dopo anno, si è arricchito perché ai libri
degli altri studiosi si aggiunsero quelli degli allievi più
Marina Pellanda
L e lezioni del professor Giovanni Morelli sono partiture che
non smetti mai di udire, sono musica che ti vive dentro e non ti abbandona. Ognuno possiede un modo speciale attraverso il quale continuare a sentirle, e ripensarle spesso significa trovare la loro verità
anche a distanza di anni. Ho capito da qualche mese cosa avrebbe
voluto sentirsi dire quando alla mia discussione di laurea nel 1998
(esponevo una tesi su Sacrificio di Andrej Tarkovskij e Morelli
era mio correlatore) mi chiese del rapporto tra Luigi Nono e il regista russo. Ora credo di sapere che in quella domanda nella quale lui
raccontava alcune sequenze del film del cineasta di cui mi occupavo,
seguendo con la voce una melodia interna tutta propria in cui la durata dei suoni era diventata discorso, le parole avevano l’andamento straordinario della musica. Per rispondere avrei dovuto inseri-
60 — per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli
re una pausa lungo la frase, una pausa musicale che, da zitto a pausa di semibreve o di semiminima, sarebbe diventata il mio racconto
tarkovskiano e dunque la mia risposta. Provare a descrivere quello che negli anni è rimasto il nostro rapporto (fu Morelli a presentare il primo libro che ho scritto) mi mette davanti a parole che sbuffano insofferenza, perché non vogliono essere «scenari della lontananza». E perciò, proprio perché per me incontrare Morelli (ho seguito
tra l’altro molti dei suoi incontri musicali a Palazzo Cini sui quali poi ci scambiavamo mail) ha sempre voluto dire ricordarsi che come scrisse Nono per Tarkovskij No hay caminos hay que caminar, ho scelto di ricordarlo recensendo forse l’ultima occasione di
camminare che ci ha lasciato.
Prima la musica, poi il cinema di Giovanni Morelli, il suo
libro novissimo – ahimé anche nel senso latino di ultimo –
uscito per i tipi di Marsilio lo scorso aprile, fa coincidere
la scrittura con la «forma-sonata» (Quasi una sonata: Bresson, Kubrick, Fellini, Gaál, certamente non a caso, è il suo
sottotitolo). Per il cinema si usa la macchina da presa, si
può fare benissimo a meno della carta. Così, a nostro avviso, ha fatto anche Morelli, che all’atto della creazione
di questo testo ha composto la propria opera quasi fosse
seduto al pianoforte anziché alla scrivania, innalzando
suono e immagine a pari dignità di racconto.
Ci sono oggetti che dovrebbero essere uguali in tutto ad
altri oggetti e che invece, per qualche motivo, diventano
magici, oggetti che se accuditi e amati diventano perfetti, privi di difetti. Ed è proprio un pianoforte senza imperfezioni – ricorda il cd 318, lo Steinway gran concerto
di Glenn Gould così come lo racconta Katie Hafner nel
suo libro sul celebre musicista (Glenn Gould e la ricerca del
pianoforte perfetto) – la scrivania usata da Giovanni Morelli per comporre il suo libro. Per ogni pianista esiste un
concetto aureo del proprio strumento, qualcosa che ogni
artista ode nella propria immaginazione: il profilo tonale unico della scrittura di Morelli dà vita, su un pianoforte dalla meccanica leggera i cui tasti sembrano muoversi quasi senza sforzo, a una sonata che invece di volume
ha sfumature, invece di forza incisività, e che come tale
si articola in tre movimenti più una coda. I primi due, l’esposizione e lo sviluppo, sono «alla breve»: seguendo un impulso due volte più veloce del normale (da 4/4 a 2/2, dalla semibreve alla breve, appunto), fanno di Cronos il postiglione di una pluralità di fondazioni che, dai fratelli
Lumière a Diderot e al Barry Lyndon di Kubrick, dissolve nel Settecento il 1895 della nascita del cinema. Il rapporto tra Fellini e Zanzotto, secondo l’equazione ottocentesca che fa del virtuosismo un veicolo di preziosità
spirituale, è la ripresa, il terzo movimento di questa «forma-sonata», che va a chiudersi in una coda che racconta
l’esperienza estetica dell’Orfeo e Euridice di István Gaál.
doti ogni volta che il cammino della conoscenza è ancora
lungo, e che t’invogliano a mettere tutto te stesso nel lavoro che stai facendo. Quella volta mi fece sentire totalmente disarmato: mentre gli stavo spiegando che l’opera
di cui trattava il mio studio non era stata mai più eseguita
dal 1809, lui me ne porse una registrazione che aveva tratto da una trasmissione radiofonica di qualche anno prima. Cogliendo il mio imbarazzo mi rincuorò: «Eh... non
preoccuparti... capita...», bisbigliò.
La percezione di un’innata ironia era alimentata dal timbro flebile della sua voce, che non perse mai la calata romagnola delle origini. Ricordo numerosi scambi avvenuti
in vaporetto. Una volta, appoggiato al carretto della spesa giallo pieno di libri, senza nemmeno salutare, sorride
e m’interroga: «Di sprezzo degno se stesso rende chi pur
nell’ira la donna offende»; replico: «Traviata...», e lui: «Sì,
vabbé [asino ndr]... ma da dove viene?». Resto senza parole, e lui: «Pensaci pure, tanto ci si vede. Ciao!», e scende alla fermata. Mi lasciò soffrire per qualche giorno e
finalmente, impietositosi, mi rivelò l’identità tra la frase
verdiana e un preciso recitativo beethoveniano.
In tanti anni non ho mai smesso di sentirmi lo studente
del primo incontro, nonostante la sua crescente cordialità, e così mi sono rivolto a lui tante volte quando non
riuscivo ad afferrare il bandolo di una matassa, trovandolo sempre disponibile. A lui il Teatro La Fenice deve
la paternità di scelte artistiche importanti. Cito solo l’ultima: non riuscivo a risolvere una serata dedicata a Bruno Maderna, che avrebbe dovuto concludersi con Dido and Aeneas di Pourcell. Intendevo aprirla con un pezzo del compositore veneziano che si prestasse a un’interpretazione coreografica: non feci a tempo a esporre
del tutto il mio problema che Morelli aveva già la risposta pronta: Le rire per nastro magnetico, un titolo offertomi con passione e partecipazione. Fu, a detta di molti, un grande spettacolo, con una particolare forza che
veniva proprio dall’accostamento fra due brani diversissimi e lontanissimi, sì, ma accomunati dall’essere frutto
ciascuno di un’età pionieristica in cui i rispettivi compositori, in epoche diverse, affrontavano un mondo nuovo. Prima ancora di suggerirmi un brano che non conoscevo, Morelli mi illuminò la strada per risolvere il mio
problema, che non era solo estetico o formale, ma anche
storico e umano: la strada era fatalmente quella dell’uomo nella tensione verso il nuovo. In questi casi si sprecano sempre espressioni del tipo una perdita incolmabile; sì è proprio incolmabile… L’unica cosa che possiamo
e che dobbiamo fare è ricordarlo ogni giorno mettendoci al lavoro. Ci aiuterà a servire sempre meglio le istituzioni in cui militiamo.
Fortunato Ortombina
Jacopo Pellegrini
Le ciocie
Ho conosciuto Giovanni Morelli sul finire degli anni ottanta. M’incoraggiò a trarre un articolo dalla tesi di
laurea per una rivista che curava allora, così andai a San
Giorgio, dove mettevo piede per la prima volta. Mi è subito parso un uomo di una generosità straordinaria, aperto,
curioso, privo di pregiudizi e coltissimo, e insieme discretissimo. Non solo un docente o uno studioso, insomma,
ma un maestro di quelli rari, che ti insegnano ad affinare
il metodo, che ti fanno crescere nel confronto mostran-
Avanzava alternando passi brevi e strascicati a improvvise accelerazioni, quasi un rotolio rapido, ma sempre dato dalla somma di movimenti corti e secchi. Si fermava,
si guardava intorno, ripartiva. In precedenza l’avevo incontrato sì e no un paio di volte, di sfuggita. Eravamo in
S. Marco per il concerto natalizio della Fenice. Quell’anno Mario Messinis (allora sovrintendente del Teatro veneziano) ci aveva preparato una bellissima sorpresa, l’Enfance du Christ, il raro e non men che sublime oratorio di
per Giovanni Morelli — 61
Al Premio Venezia 2010
(foto di Michele Crosera – cortesia degli Amici della Fenice).
tovalutare), non gli davano tregua. Quest’ansia di pianificare e seguire passo passo ogni circostanza in cui fosse coinvolto può aver urtato la suscettibilità di qualcuno, ma non era forse essa anche alla base di quella sua
generosità dilapidatrice, che si manifestava nell’elargire
idee, dritte, indirizzi di studio, nel confezionare progetti (ad uso altrui, s’intende), nel procurare documenti, testi, musiche, dischi cd e video (ne possedeva un’infinità: tesoro preziosissimo, da preservare), persino nel fare
fotocopie su richiesta (le ultime ancora a fine giugno…)?
Tutto ciò, troppo confusamente, me ne rendo conto,
ma con tutta la schiettezza possibile a chi soffra la perdita d’una persona molto cara (benché non gli sia concesso chiamarlo maestro o amico), per dire che occorre quanto prima raccogliere in volume una scelta la più
ampia possibile dei suoi saggi, disseminati in riviste, atti
di convegno, Festschriften (sono oltre 250). Magari corredandoli di chiose e glosse, laddove il senso risulti troppo
oscuro (Paolo Pinamonti ed Emilio Sala potranno atten-
dere degnamente all’impresa). Affinché la diffusione di
questo immane tesoro critico non resti limitata ai soli uomini di buona volontà, che poi, così va il mondo, sono in
numero assai inferiore rispetto a quelli di volontà cattiva.
Nico Stringa
giovanni enarmonico,
giovanni ipotattico-parentetico,
ante-post-contemporaneo,
intuscostruttivo,
giovanni ceramologo,
antimusicologo,
filomusico,
musico,
antispettacolare,
giovanni inventore,
inventivo,
inveniente,
giovanni paziente,
partoriente,
generoso,
amico,
pulsante,
giovanni astraente,
aggettivante,
caminante,
giovanni parolibero,
per Giovanni Morelli
Berlioz. Faceva un freddo cane, l’umidità allegramente
spietata trapassava carne e ossa, eppure quel signore con
stampato sul volto tondeggiante un sorriso dolce e ironico
a un tempo indossava appena una giacca, direi una delle
sue a quadri, o comunque con qualche disegno sul tessuto.
Sotto, la camicia era ovviamente colorata e in tinta unita;
la cravatta, stretta: un modo per distinguersi dall’andazzo corrente, con dissimulata quanto ricercata eleganza. Ai
piedi, le ciocie. Sì, lo so, non erano propriamente ciocie,
erano quelle calzature di tela con sotto la para di gomma
in uso negli ospedali, ma a me piace chiamarle così, ciocie.
Era solo. Sedemmo vicini, non per una bizzarria del destino, ma per sovrana decisione di Mario. Aveva con sé
la partiturina da studio; io ne estrassi un’altra dalla tasca
del cappotto. Di questo fatto sembrò sorprendersi un poco, forse, chissà, compiacersi anche. Seguimmo la musica insieme, dalla mia copia. Alla fine era contento come una Pasqua. L’avreste potuto scambiare per un bimbo, di quelli stanchi ma felici dopo essersi a lungo trastullati con un balocco appena ricevuto in dono. Fu davvero un regalo,
per lui, quell’Enfance, un regalo personale e graditissimo, l’ennesimo frutto
del dialogo intimo tenace ininterrotto coll’amatissimo Messinis.
All’uscita, il freddo nel frattempo era
diventato birbone, chiacchiere stringate, qualche risata sommessa ma schietta, saluti rapidi. Mentre noi lietamente
si andava a cena, egli lentamente s’avviò
verso l’imbarcadero perdendosi nella
fioca luce lattiginosa della piazza. Prima che il buio l’inghiottisse lo vidi alzarsi il bavero della giacca, sempre strisciando a terra i piedi nelle ciocie.
Sull’Enfance ha poi scritto un saggio concepito dal punto
di vista dell’«infante», lo stesso da cui si era posto – direi
– Berlioz, quantomeno nei pannelli della fuga in Egitto e
dell’arrivo a Saïs. Non l’ho letto quel saggio, me ne parlò
lui una volta per strada, dalle parti della Fondazione Levi.
La stessa gioia ardente, fisica che traeva dallo studio e
dall’ascolto (leggeva e sentiva molta musica, specie riprodotta), lo stesso gusto matto provato nello smontare
il «giocattolo» delle idee ricevute, riversava nelle lezioni, sulla pagina scritta. Inutile soffermarsi sulle strategie di comunicazione orale e scritta da lui adottate, quel
continuo alternare dispersione (una forma mentis affinata sui prediletti romanzi del Settecento) e specificazione (l’accumulo di genitivi, anche cinque di seguito, alle volte); o insistere sul fatto che proprio per questa ragione era difficile stargli dietro, all’ascolto come alla lettura. Tutti ben sappiamo quanto lo sforzo di attenzione necessario fosse infine ripagato dal profluvio di intuizioni notazioni riflessioni conclusioni (quasi mai imperiose, definitive, più volentieri suggerite tra le righe, alluse). Alle volte le oscurità del dettato erano indotte dalla velocità di stesura, da una mancata rilettura del testo,
da una punteggiatura difettosa: la nevrosi inesausta del
fare, la necessità di esserci e testimoniare (l’angoscia del
tempo che scivola via? non facevamo quasi più caso agli
annunci allarmanti, tendevamo a ridimensionare, a sot-
62 — per Giovanni Morelli
giovanni barocco,
scrittore, poeta,
atleta dei suoni,
giovanni professore,
giovanni ascoltatore,
ascoltante,
pensatore,
vivo,
diverso,
giovanni innovatore,
semplice-difficilissimo,
facile,
passatore,
giovanni scopritore,
giovanni sofferente,
silente,
offerente,
giovanni parlatore,
timido,
incantatore,
giovanni…
per Giovanni Morelli
Lorenzo Bianconi e Giuseppina La Face
Primavera-estate 1974. Risale a quel periodo il sodalizio
sentimentale di chi firma queste righe. Negli stessi mesi si
strinse l’amicizia con Giovanni Morelli. Ci eravamo arrivati attraverso un amico comune, l’indimenticabile Tom
Walker. Mediazione necessaria, perché Giovanni non si
era ancora manifestato sul versante della musicologia, la
coltivava per così dire in semiclandestinità: non l’avremmo dunque incrociato tanto facilmente. Insegnava Disegno anatomico (la disciplina di suo padre Angelo) all’Accademia di Bologna. Lì – dopo averlo incontrato nei primissimi convegni Folena-Muraro della Cini – lo vedeva
in trattoria uno di noi (l.b.), ben presto commensale frequente anche alle Zitelle. Al generoso desco di Giovanni e Margot fu cooptata al volo anche l’altra metà del cielo (g.l.f.), di passaggio in Laguna: tra i tanti ricordi che di
quel torrido agosto le son rimasti negli occhi e nell’animo
c’è il sentimento di gloriosa serenità, di frizzante libertà
che si respirava dalle finestre di casa Morelli, la luce dorata sul canale della Giudecca e la raccolta penombra nel
salotto colmo di libri e d’arguzia (e di gatti).
Sempre nel 1974, fresco redattore della «Rivista italiana di Musicologia», l.b. carpì a Morelli il primo, memorabilissimo articolo d’argomento musicale, gli Éloges rendus
à un singulier mélange de philosophie, d’orgueil, de chimie, d’opéra
&c.: un osso duro da redigere e da leggere, ma l’indagine
sulle ascendenze melodrammatiche nell’antropologia di
Rousseau sprizzava intelligenza mercuriale, scintillante
acume, funambolismo interdisciplinare; fra i musicologi fece colpo. Tra tante cose, mostrava loro – e non solo
a loro – quanto avesse inciso, sulle correnti intellettuali nell’età dei Lumi, la poesia del Metastasio (non c’erano ancora stati i cento convegni che in occasione dei due
centenari hanno poi tirato a lucido l’immagine, allora impolverata, del sommo drammaturgo).
Sempre nel 1974, l.b. lavorava con t.w. a un saggio sulla
diffusione dell’opera veneziana, quelle Storie di Febiarmonici che qualcuno legge ancor oggi. Ebbene, la posa d’uno dei pilastri del nostro racconto storico la dovemmo
a Morelli: oggi tutti sanno che il libertinismo filosofico
coltivato dagli Accademici Incogniti fertilizzò le origini
del teatro d’opera a Venezia; ma senza l’intuito, l’erudizione e la generosità di Giovanni quel chiodo, poi battuto e ribattuto da tanti studiosi angloamericani, non l’avremmo conficcato.
Nel 1979-80, g.l.f. e t.w. portarono in giro per l’Italia
una conferenza-concerto che, prendendolo alla lettera,
metteva in discussione il concetto dell’esecuzione «autentica»: il programma constava infatti di sonate per violino del sec. xviii trascritte tra Otto e Novecento secondo un gusto démodé, magari gozzanianamente «pessimo»,
ma in sé coerente. In qualche circostanza – a Bologna,
Venezia, Firenze – la conferenza-concerto fu corredata
da una ghiribizzosa serie di proiezioni di diapositive, immagini allusive ed extravaganti, firmata da Richard Di
Gennaro. Sotto tale pseudonimo, risultante dalla somma del secondo nome di battesimo di t.w. e di l.b., si nascondeva Giovanni, che se la rideva sornione nel saggiare le reazioni degli spettatori, ignari di chi avesse congegnato quell’allegra randonnée figurativa, quel vellicante
contrappunto iconico.
Nel 1981, Morelli e l.b., su sprone dell’on. Carlo Galante Garrone, stilarono il testo della proposta di legge che, firmata da tutto l’arco costituzionale, disponeva
il trasferimento delle biblioteche storiche dei Conservatori dal Ministero della Pubblica istruzione al Ministero per i Beni culturali; in un unico articolo quella legge
avrebbe sanato l’anomalia che, classificandole come biblioteche scolastiche, continua tuttora ad affliggere questi scrigni del patrimonio musicale italiano. La proposta
sollevò un putiferio (non certo in Parlamento), poi cadde la legislatura e non se ne fece nulla: ma vedeva giusto
e vedeva lontano.
Nella seconda metà degli anni ottanta Morelli, con Claudio Annibaldi, Fabrizio Della Seta e g.l.f., diresse la «Rivista italiana di Musicologia»: fu un lavoro di squadra
tanto vivificante e produttivo quanto varia era l’indole e
la visione dei quattro compagni di strada. Prova provata
che la diversità è una risorsa, a farla fruttare.
Potremmo continuare. La curiosità culturale, l’inventiva intellettuale, l’umana generosità, la formidabile capacità di lavoro del valetudinario Giovanni Morelli rimarranno come il ricordo d’un dono che, nella mestizia
del lutto, consola chi ne è stato beneficato.
Giampaolo Vianello
Per anni ho avuto occasione d’incontrarlo nei Consigli
Direttivi delle istituzioni musicali veneziane, buon ultimo nel Comitato dei Garanti di questa Rivista. Ho perciò
ben presente nella memoria la sua figura sapientemente
paziente e buona. Ricordo i suoi interventi, a me e a molti
non sempre immediatamente comprensibili, che avevano
la capacità di richiamare l’attenzione di tutti. Dopo un po’
capivamo che erano assolutamente pertinenti in quanto
portavano all’interno della discussione argomenti di grande rilevanza, ingiustamente dimenticati.
I suoi contributi erano inoltre sempre dettati dalla volontà di raggiungere il massimo di concretezza. Si intuiva infatti una sua leggera frustrazione quando coglieva
nell’atteggiamento dei suoi interlocutori una eccessiva
intellettualità. Ma un aspetto di Giovanni Morelli mi ha
sempre affascinato: la sua curiosità per i gusti musicali,
per Giovanni Morelli — 63
Giorgio Busetto
Come nacque la cattedra
di Storia della musica contemporanea
Giovanni Morelli era un uomo di intelligenza acutissima e, cosa rara in generale e rarissima negli uomini molto intelligenti, era buono.
Ho conosciuto Giovanni nel 1972. Partecipavamo al
corso biennale di Archivistica Paleografia e Diplomatica tenuto all’Archivio di Stato di Venezia da Luigi Lanfranchi, Maria Francesca Tiepolo, Bianca Lanfranchi Strina e Paolo Selmi. Aveva sempre un’aria molto trascurata, non portava cappotto neanche col freddo sottozero,
stava sempre coi sandali e i piedi nudi, d’inverno aggiungeva alla camicia un maglione, i suoi capelli erano sempre arruffati. Questa sua figura così caratteristica la vedevo poi molto spesso aggirarsi la sera tra gli scaffali delle sale riservate della Biblioteca della Fondazione Querini Stampalia, dove io ero volontario aiuto bibliotecario,
intento alle più disparate consultazioni. Mi sarei accorto
in futuro che era uomo di cultura vastissima e raffinata,
di formazione dapprima scientifica: quante volte poi mi
avrebbe detto che la sua laurea in medicina rendeva più
pesanti e più difficili da affrontare i suoi malanni, di cui
parlava in termini così leggeri e autoironici da impedirti
di coglierne la fondatezza e gravità, fino all’ultimo, quando mi descrisse l’operazione al cuore che avrebbe dovuto
subire di lì a pochi giorni, e che temeva non avrebbe più
superato. Eravamo sulla soglia dell’Archivio Luigi Nono, di cui fu promotore e strenuo sostenitore, ottenendo
anche che Ca’ Foscari riconoscesse con la laurea honoris
causa Nuria Schoenberg Nono per l’immane sua opera
di costituzione, dotazione e gestione di tale Fondazione.
Passarono gli anni, senza che io mi accorgessi più veramente di lui, tanto lo avevo integrato nell’anima della città. Venezia è veramente città nobilissima e singolare, ma
se lo sono le sue pietre, l’urbs, non lo sono certo i suoi cittadini: la civitas appare immemore, pavida, egoista, avida e avara, spesso ignobile, caricatura plebea dell’urbs di
cui è del tutto immeritevole. Se questa è la generalità, esistono ovviamente belle eccezioni, e Giovanni era una di
queste, bianca pietra angolare e non vile materia fittile.
Giovanni c’era sempre quando ne avevi bisogno, quando
ti rivolgevi a lui. Era sempre presente e possedeva un’immensa capacità di dare. Questa era una delle sue caratteristiche fondamentali, da un incontro con lui non uscivi
mai a mani vuote e mai e poi mai ti avrebbe fatto pesare
il suo contributo, né nel modo di porgere, né successivamente. Sapeva essere lievemente lievito del tuo fare, con
valutazioni, indicazioni, successiva partecipazione a riunioni, a organi, a iniziative, a collegamenti.
Non solo pareva saper di tutto e di più, aver visto e sentito di tutto e di più, ma ogni volta riusciva a proporti un
punto di vista nuovo, di sottile intelligenza e sorprendente conoscenza. Ogni volta dunque il contributo era
singolare, manifestava un’attenzione precisa per te, per
quello che facevi, per il tema che proponevi e per il contesto in cui andava ad inserirsi e che lui sapeva inquadrare con uno sguardo sempre molto ampio, con una visione strategica delle questioni: ciò che ne faceva non solo
un professore privo di ubbìe accademiche, a differenza
della maggior parte dei suoi colleghi, ma anche un amministratore capace, silenzioso e attento nelle riunioni
degli organi finché non toccasse a lui intervenire, e allora lo faceva con profonda saggezza. Nell’arco di oltre
vent’anni è stato quasi continuativamente alla Fondazione Ugo e Olga Levi membro autorevole del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato scientifico e della Direzione della rivista «Musica e Storia».
Rammento le indicazioni che diede nel luglio del 2003,
in preparazione di una riunione del Consiglio di Amministrazione, sulla strategia culturale della Fondazione Levi,
tuttora valide e progressivamente via via quasi tutte attuate, grazie al tandem con Giulio Cattin e poi con Antonio Lovato, presidenti del Comitato scientifico; indicazioni che univano la sicurezza del giudizio, per cui una
proposta poteva apparirgli «ammuffita», alla perspicuità
culturale; e insieme alle proposte giungeva la disponibilità a spendersi di suo per l’individuazione delle iniziative, e per l’eventuale loro conduzione. Non a caso in quella stessa circostanza un commento di Cattin a un’ipotesi di presentazione di rarità recitava «Evviva Giovanni
Morelli e la sua acutezza e disponibilità!»
Anche alla Querini Stampalia Giovanni riusciva ad essere presente, in prima persona o suggerendo i referenti del caso, ogni qual volta ne fosse richiesto, si trattasse
di un seminario sui riflessi culturali della guerra di conquista veneziana della Morea piuttosto che della presenza della musica nella vita di quella famiglia nel Settecento, dell’illustrazione di A Carlo Scarpa architetto ai suoi infiniti possibili di Luigi Nono o della rievocazione del ruolo
di Giuseppe Mazzariol.
Di quest’ultimo organizzammo alla Querini Stampalia
un ampio ricordo nel 1992, a tre anni dalla morte. Giovanni stese per il catalogo un saggio: «Se l’uomo dovesse sopravvivere, questo è un modello». Mazzariol e l’idea di Università. Vi profuse la propria vasta cultura, utilizzando citazioni disparate e ricordi di vita vissuta per un’ermeneutica dell’espressività di Mazzariol creatore di organizzazioni culturali, con un approccio filosofico in cui il succitato testo di Nono, grazie alla apparentemente pretestuosa coincidenza dell’anno di composizione, il 1984,
con quello di nascita del «Dipartimento delle arti (le visive e le altre)» veniva con rapidi tocchi sinteticamente
quanto profondamente analizzato; per essere poi usato
da un lato a richiamare la presenza di Scarpa come sigillo
della «re-invenzione della gestione della Querini» operata da Mazzariol, dall’altro a cifra della contemporaneità,
in un sapientissimo e saporosissimo gioco di specchi, in
cui continuamente il linguaggio viene forzato e temprato grazie ad una «squisita sensibilità semantica» attri-
per Giovanni Morelli
nessuno escluso, dei giovani. Cercava sempre di richiamare la nostra attenzione sull’opportunità di analizzarli, attribuendo, con l’autorevolezza indiscussa del grande
studioso, dignità culturale al loro approfondimento. In
questo era probabilmente unico, e tra le altre questa sarà certamente una grave mancanza che la sua prematura
scomparsa porterà al mondo degli studi musicali. Mi auguro che questa Rivista voglia dare, come Lui suggeriva,
spazio a questo aspetto della contemporaneità.
64 — per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli
buita al protagonista oggetto della narrazione, ma in realtà ancor più compiutamente operata dall’autore del testo, che finisce per rivelare una propria identificazione e
sovrapponibilità col personaggio ricordato nella traditio
del magistero. Val la pena di rileggere per intero la chiusa del saggio, non tanto e non solo perché atto di nascita della cattedra di Storia della musica contemporanea,
ma soprattutto perché questo è Giovanni Morelli, impasto di intelligenza, cultura, modestia sincera e pragmatismo positivo:
Devo ricorrere alla mia limitata e ingenua esperienza personale. Ricordo che si era seduti stretti su due sedie affiancate, le braccia appoggiate sullo stesso tavolo, in Consiglio di
Facoltà. Sorse, impreparato, il problema del rimpiazzo di una
cattedra esuberante di una storia artistica del profondo passato. Mazzariol mi disse sottovoce: «La mettiamo a Storia della musica contemporanea?». «Sarebbe la prima, l’unica e l’ultima in Italia», risposi. «Meglio». E fece subito ad alta voce la
proposta che passò senza discussioni. «E adesso?» gli chiesi.
«Adesso vedi tu». Da quel momento, smettendo di occuparmi
di quel che mi occupava (che so? Seicento, Cimarosa, Verdi,
Vivaldi ecc.), mi sono trasferito alla contemporanea e ho cercato di farmi da solo un modello di quel che avrei potuto fare perché fosse possibile farlo. Ci sto ancora provando; tratto
ancora materiali informi e sfuggenti; poco trasmetto agli studenti oltre il sentimento di questo cercare il possibile fra testi che ancora testi non sono, fra momenti dell’oggi che ti diventano ieri sotto le mani, oscurandosi, fra orme che si cancellano e ombre di improvvisi e inverosimili ritorni di un passato ancora non-finito che cerca di conoscere il suo domani.
Che un’esperienza del genere potesse essere un modello l’ho
appreso da Mazzariol in pochi istanti fra le pieghe di una reale, sonnacchiosa situazione di routine procedurale accademica, laddove ho appreso anche quanto un gesto, un’idea, una
breve decisione possa essere un’opera. Tanto più bella quanto più serenamente incompiuta.
Alvise Vidolin
Colmare il vuoto lasciato da Giovanni Morelli è impossibile e non trovo le parole che ci possano aiutare a rendere meno grave la sua assenza. Mi limito pertanto a elencare una serie di fatti per evidenziare un aspetto che forse è stato meno trattato da altri, cioè l’interesse che Giovanni ha sempre coltivato nei confronti della musica contemporanea e delle moderne tecnologie legate alla ricerca musicale. Questo interesse risale ancora agli inizi degli anni ottanta quando La Biennale di Venezia promuoveva Festival come «Numero e Suono» e il «Laboratorio
per l’informatica musicale». Ricordo che già nel 1981 tramite un allievo in comune, Giovanni propose una tesi di
laurea sull’acustica e sulla psicoacustica musicale, partendo dalla traduzione di un testo americano che utilizzavo
per le mie lezioni in Conservatorio, che l’allievo allargò
sviluppando un ampio glossario per i termini allora poco conosciuti in ambito umanistico. E a questa prima tesi
di laurea ne sono seguite molte altre di carattere musicologico su opere incentrate sulla tecnologia, come quella
sulle Risonanze erranti di Luigi Nono o sul restauro audio.
Qualche tempo più tardi, nell’86, quando realizzai con
Roberto Doati, sempre per la Biennale, un’ampia mostra
storica sulla musica elettronica, fu proprio Giovanni a
chiederci un articolo in merito per la pubblicazione nel
Bollettino del Dipartimento di storia e critica delle arti
di Ca’ Foscari. E pochissimo tempo dopo fu altrettanto felice di pubblicare, nel medesimo Bollettino, un altro mio testo dedicato alla musica elettronica nel veneto
e fu proprio lui ad idearne il titolo. Per restare sempre in
ambito universitario, ricordo la positiva sorpresa quando
negli anni novanta appresi che Giovanni stava tenendo
un corso monografico che prendeva spunto da una pubblicazione dell’ircam sul timbro, come metafora della composizione: una raccolta di saggi di compositori e scienziati
sulla ricerca musicale in ambito tecnologico-scientifico.
Gli stessi interessi nei confronti della musica elettronica furono coltivati anche all’interno della Fondazione
Cini. Un esempio significativo è la partecipazione attiva
della Fondazione alla realizzazione di tutti i corsi di interpretazione musicale sulle prassi esecutive nella musica di Luigi Nono con elettronica (promossi a partire dagli anni 2000 dall’Archivio Nono, spesso in collaborazione con il Conservatorio «Benedetto Marcello»). Il fascino in lui suscitato dall’interazione tra voci, strumenti e live electronics l’ha portato, nel 2006, a dotare la Sala
degli Arazzi di San Giorgio di un ottimo impianto audio ottofonico con mixer e strumentazioni varie, adatto
all’esecuzione dal vivo di musica elettronica. Acquistato in occasione del corso sulla Lontananza nostalgica utopica futura di Nono, questo impianto è stato la base anche di molte altre attività successive, tra cui diversi concerti con live electronics dell’Ex Novo Ensemble ed ha favorito la nascita dell’Arazzi Laptop Ensemble animato
da Paolo Zavagna, cui hanno aderito molti miei ex allievi. L’aver dato vita al Laptop Ensemble e aver fatto in
modo che il Laboratorio Arazzi sviluppasse una serie di
incontri a carattere laboratoriale all’interno dell’Istituto
per la Musica della Fondazione Cini, sono altre due testimonianze della vicinanza di Giovanni al mondo della tecnologia. Infine non si può non accennare alla collaborazione tra la Fondazione Scuola di San Giorgio e il
Consiglio Nazionale Delle Ricerche, grazie alla quale si
è sviluppato a San Giorgio un centro di ricerca destinato alla Fisica Acustica, dotato di una bella sala anecoica con varie attività di studio, fra cui la spazializzazione
dei suoni in ambito cinematografico, l’acustica delle sale musicali del Veneto e il restauro audio.
Personalmente, sono riconoscente a Giovanni di tanti
insegnamenti, consigli, esperienze, coinvolgimenti, riservatezze, stimoli, intuizioni, ascolti e la lista potrebbe
continuare all’infinito, ma non posso non aggiungere la
riconoscenza per aver promosso la pubblicazione del libro di Paolo Zavagna 60 dB dedicato alla scuola veneziana di musica elettronica. Un omaggio nei miei confronti
che mi è stato consegnato a sorpresa in occasione della
festa del mio sessantesimo compleanno, da lui promossa
alla Fondazione Cini, in coincidenza con il mio pensionamento dal Conservatorio: un momento della mia vita
dove l’ho sentito particolarmente vicino. ◼
All’Auditorium di Santa Margherita il 6 dicembre 2010, nella pausa
dell’esecuzione integrale dei Quartetti di Mozart (foto di Nico Stringa).
• Maurizio Agamennone • Università di
Firenze
• Carmelo Alberti • Università Ca’ Foscari di
Venezia
• Gianni De Luigi • Regista
• Giorgio Pestelli • Musicologo
• Cesare De Michelis • Università di Padova
– Editore
• Pierluigi Petrobelli • Musicologo
• Gino Benzoni • Fondazione Giorgio Cini
• Barbara di Valmarana • Fondazione Amici
della Fenice (Presidente)
• Luigi Berlinguer • Comitato nazionale
per l’apprendimento pratico della musica
(Presidente)
• Vitale Fano • Archivio Musicale Guido
Alberto Fano (Presidente)
• Lorenzo Bianconi • Università di Bologna
• Pasquale Gagliardi • Fondazione Giorgio
Cini (Segretario Generale)
• Fabrizio Borin • Università Ca’ Foscari di
Venezia
• Michele Girardi • Università di Pavia
• Giorgio Busetto • Fondazione Ugo e Olga
Levi (Direttore)
• Massimo Cacciari • Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano
• Roberto Calabretto • Università di Udine
• Daniela Goldin Folena • Università di
Padova
• Tito Gotti • Direttore d’orchestra – Direttore
delle Feste musicali di Bologna
• Giuseppina La Face Bianconi • Università
di Bologna
• Marzio Pieri • già docente di Letteratura
italiana all’Università di Parma
• Giuseppe Maria Pilo • Storico dell’arte
• Paolo Pinamonti • Università Ca’ Foscari di
Venezia
• Paolo Puppa • Università Ca’ Foscari di
Venezia
• Enzo Restagno • Musicologo
• Veniero Rizzardi • Musicologo
• Ellen Rosand • Yale University
• Emilio Sala • Università Statale di Milano
• Nuria Schoenberg Nono • Fondazione
Archivio Luigi Nono (Presidente)
• Giampiero Cane • Musicologo – Scrittore
• Francesco Lombardi • Segretario e
Conservatore del Fondo Nino Rota presso la
Fondazione Giorgio Cini
• Sandro Cappelletto • Critico musicale
• Mario Messinis • Critico musicale
• Nico Stringa • Università Ca’ Foscari di
Venezia
• Alberto Caprioli • Compositore
• Gian Paolo Minardi • Musicologo
• Elvidio Surian • Musicologo
• Carlo Carraro • Università Ca’ Foscari di
Venezia (Rettore)
• Giordano Montecchi • Critico musicale
• Mercedes Viale Ferrero • Studiosa di
scenografia
• Teresa Camellini • Musicista
• Paolo Cattelan • Università Ca’ Foscari di
Venezia
• Paolo Cecchi • Università di Bologna
• Cristiano Chiarot • Fondazione Teatro La
Fenice (Sovrintendente)
• Marcello Conati • Musicologo
• Alan Curtis • Direttore d’orchestra
• Anna Maria Morazzoni • Università di
Milano-Bicocca
• Fiamma Nicolodi • Università di Firenze
• Fortunato Ortombina • Fondazione Teatro
La Fenice (Direttore artistico)
• Alessandro Spina • Romanziere e saggista
• Giampaolo Vianello • Già Sovrintendente
della Fondazione Teatro La Fenice
• Alvise Vidolin • Regista del suono
• Gianfranco Vinay • Université Paris 8
• Marina Pellanda • Università iuav
• Andrea Zanzotto • Poeta
• Jacopo Pellegrini • Critico musicale
• Luca Zoppelli • Università di Friburgo
per Giovanni Morelli
per Giovanni Morelli — 65