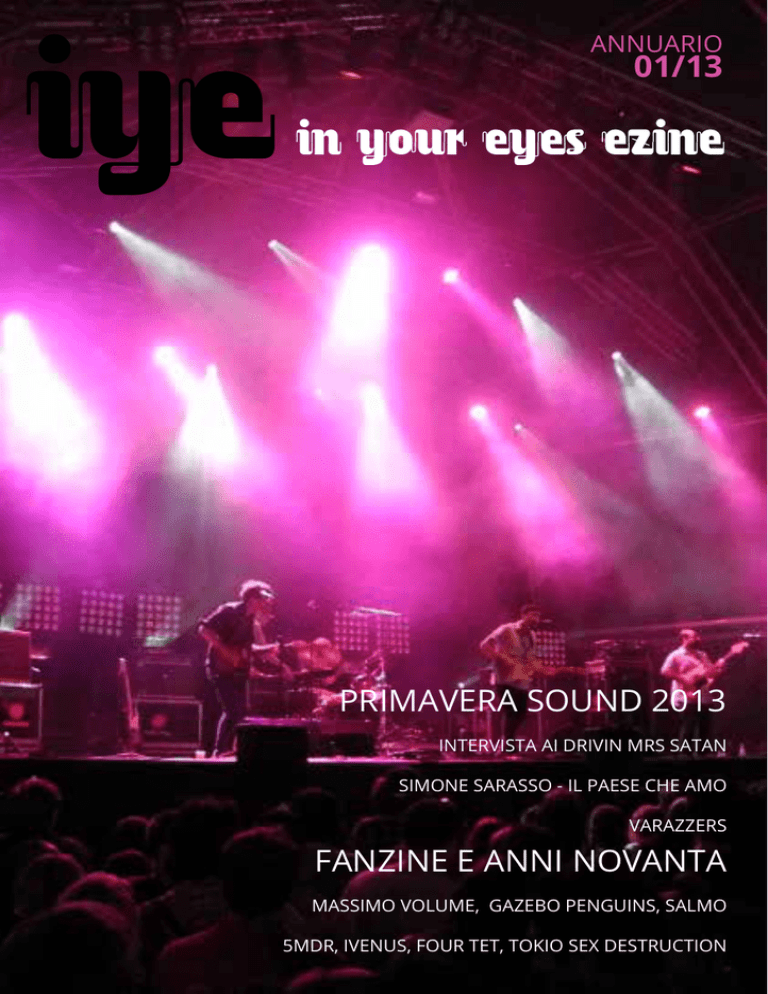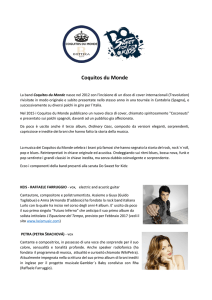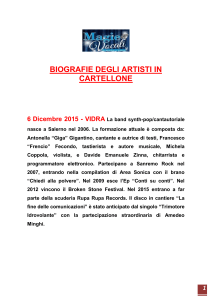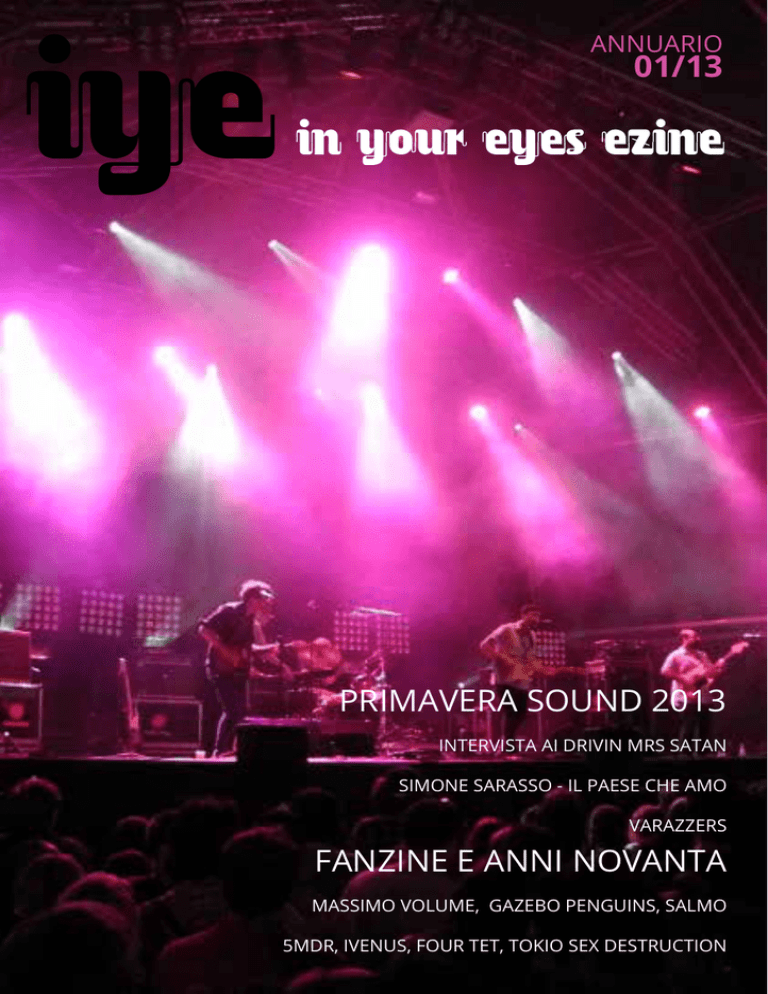
iye
ANNUARIO
01/13
in your eyes ezine
PRIMAVERA SOUND 2013
INTERVISTA AI DRIVIN MRS SATAN
SIMONE SARASSO - IL PAESE CHE AMO
VARAZZERS
FANZINE E ANNI NOVANTA
MASSIMO VOLUME, GAZEBO PENGUINS, SALMO
5MDR, IVENUS, FOUR TET, TOKIO SEX DESTRUCTION
1
Directed by:
Simone Benerecetti
N. 1/2013
Web: http://www.iyezine.com
E-mail: [email protected]
Collaboratori:
Massimo Argo, Il Santo, Francesco Cerisola, Stefano Cavanna, Nicolas Gasco, Marco
Appioli, Davide Siri, Ilaria Maietta, Gianluca Perata, Gianluca Camogli, Giovanni Sciuto,
Kaosleo, Marco Repetto, Pietro Caviglia, Luca Fazio, Alessandro Bonetti, Alberto Centenari, Freddi Koratella, Mauro Francioni, Francesco Orazzini, Marini Yolima.
Dal 2006 abbiamo avuto da 124.216 persone sul sito con 372.875 pagine viste.Grazie.
2
Editoriale
In Your Eyes è nata nel 1999 e io
stavo per finire le scuole medie. Escluse le band più note e commerciali
del periodo conoscevo ben poco di
musica. Sicuramente non conoscevo
In Your Eyes (nonostante fosse fatta
da gente che dista da casa mia solo
20 Kilometri). Questo è quello che
solitamente succede in provincia, in
piccole città come Savona, chiuse su
sé stesse e, spesso, prive di curiosità
e voglia di scoperta. Nessuno si
preoccupa di quello che succede a
un palmo dal proprio naso, nessuno
fa attenzione al fatto che chi ci sta
di fronte potrebbe avere le nostre
stesse idee, i nostri stessi gusti e che,
insieme si potrebbe fare qualcosa di
molto più grosso del solito far niente.
Nessuno si accorge che città come
Genova, Torino, Milano sono lontane,
ma non così lontane da essere concepite come irraggiungibili. Nessuno
fa caso al fatto che dietro al progetto
più grande che si possa immaginare
ci saranno sempre persone in carne
ed ossa, uguali a noi in ogni più piccola parte. Nessuno ha mai voglia di
provare a fare un passo in più rispetto al dovuto.
Io stesso facevo parte di questa categoria di persone.
Può capitare, però, che un qualcosa,
un momento, una situazione, un’idea,
in maniera improvvisa, ti prenda e ti
rivolti come un calzino, piantandoti
dentro al petto una voglia irrefrenabile di fare quello che credevi fosse
impossibile fare. Per me è stato il
parlare, dopo molte birre, con un mio
amico, il quale, a un certo punto, con
tono incazzato mi ha semplicemente
chiesto “Ma perché porti quel paio
di scarpe?”. Sembra stupido, ma non
sapevo rispondere.
Ci ho pensato giorni interi a quella
domanda e alla fine ho deciso di
cambiare (non solo le scarpe) e mettermi a fare cose che sentivo veramente mie, a cui avrei potuto dare
sempre e comunque una spiegazione nel caso qualcuno me l’avesse
chiesto. Ho costruito un’etichetta che
fa dischi e ho cominciato a scrivere
recensioni.
Ho guardato lontanissimo non badando mai a quel che avevo vicino
(la cultura della provincia è dura da
eliminare) e, solo dopo 10 anni, ho
scoperto che dietro l’angolo c’era
quello che più mi interessava, uno
spazio dove parlare liberamente della
musica che più mi prendeva, senza
aver pressioni, scadenze e ansie.
In Your Eyes è questo, una piccola
webzine, dura e pura, che fregandosene di tutto e tutti, parla di quel
che gli pare, quando gli pare. Pochi
ragazzi (con ormai quarant’anni sulle
spalle) che, con una passione infinita,
portano avanti un progetto che non
ha altro obiettivo se non quello di
diffondere (soprattutto a chi gli sta
vicino, ma anche a chi è lontanissimo)
musica, idee e contenuti.
Una sorta di monolite che ha superato indenne tutti gli anni ‘00 e che,
invece di sprofondare nella stagnazione, ha preferito costruire un lento e
costante sviluppo, fatto di piccole ma
importanti cose.
3
Ora, a quasi quindici anni di distanza
dal primo click, In Your Eyes vuole
provare a fare un ulteriore piccolo
passo, fare qualcosa che la ricolleghi
al suo passato, a quando, prima del
1999 e con altro nome, girava di
mano in mano sotto forma di fanzine
cartacea autoprodotta: ritornare, per
una volta, oggetto fisico, concreto
e tangibile. Abbiamo voluto creare
queste 50 pagine (circa) per raccontarvi quali sono stati per noi i dischi,
le band, i libri e i concerti più interessanti di questo 2013, ma non solo.
L’altro obiettivo che ci siamo posti
è stato quello di fornirvi una prova
incontrovertibile del fatto che le
cose, se si vuole, si possono fare, che
anche nel posto più arido possono
nascere iniziative che valga la pena
supportare, che non si è soli, che
c o m u n ic a z io n
4
e
dietro a ogni lavoro ci sono sempre
delle persone e che, interagendo
con questi lavori, è un po’ come
comunicare con queste persone, che
costruirsi da soli è molto meglio che
adeguarsi ad uno standard o a uno
stereotipo, che la crisi è monetaria,
ma che i progetti, prima di tutto,
sono fatti di idee.
Francesco Cerisola.
PRIMAVERA FESTIVAL
Memorabile in termini di numeri, con
oltre 170 mila presenze in tre giorni.
In termini di cambio di sponsor
principale (il passaggio da San Miguel
ad Heineken, con evidente vantaggio
per le casse del festival). Ma in particolare nel fatto che sia il gran Galà
di presentazione in streaming live
mondiale che la campagna di marketing successiva abbiano creato una
aspettativa a dir poco virale intorno
all’evento. Più degli anni scorsi, se
possibile, il Primavera Sound era “il
festival in cui bisognava andare”.
Per noi, per fortuna, il Primavera
Sound rimane ancora una benefica
esplosione di suoni distillata in
cinque giorni e 230 concerti. Poco
ci importa della ruota panoramica
plagiata dal Coachella, su cui non
saliremo mai. Delle inconsuete temperature autunnali, brillantemente
combattute saltando sempre in zona
transenna. Delle voci basse dei My
Bloody Valentine, che devono essere
basse, e se non sapete il perché peggio per voi.
GIOVEDI 23 MAGGIO
Il pop east-coast dei Wild Nothing
apre le danze quando ancora il sole
è alto. E’ un bell’ascoltare, sebbene
i brani eseguiti troppo pedissequamente rispetto ai due album non
destino particolari sussulti.
Sul palco ATP invece compare la vera
sorpresa del giorno: i White Fence.
Il progetto solista di Tim Presley,
intriso di cavalcate psichedeliche
dall’incedere garage, si spinge su
territori già esplorati dai conterranei
Oh Sees, e grazie ad un songwriting
intenso quanto spigoloso riesce ad
ammaliare e convincere.
I Tame Impala non lasciano spazio
all’immaginazione: un muro di suoni
anni ’60 si abbatte sul palco principale, tappeti di synth fanno volare una sezione ritmica a dir poco
scioccante: rullate dimezzate aprono
come dighe delle cavalcate di delay
chitarristici in cui è impossibile non
perdersi. Il bassista dei Pond è alla
sua prima uscita dopo l’abbandono
di Nick Allbrook, ma poco cambia: i
brani funzionano molto meglio che
da studio, sono più incisivi e i fuzz
dilatati delle Rickenbacker la fanno
da padrona. Un concerto capolavoro,
il migliore del giovedì.
I Dinosaur Jr., anche con Kyle Spence
alla batteria, regalano sempre grandi
gioie: “Feel the Pain”, “Out There”, e
“Freakscene” autorizzano J Mascis a
comparire nei dizionari musicali alla
voce “Wah-Wah”.
Poco dopo i Deerhunter presentano live il capolavoro lo-fi dell’anno,
l’acclamato “Monomania”. Bradford
Cox distilla in musica la spirale di
disperazione, ossessioni, desideri
e conquiste di una creatura di due
metri, filiforme al punto di spezzarsi.
E’ un pugno allo stomaco, e il coinvolgimento del pubblico è sentito.
I due artisti successivi, Grizzly Bear e
Phoenix, non rappresentano alcuna
novità per chi già ha avuto la fortuna
di apprezzarli. I primi, meravigliosamente soporiferi, ormai suonano
5
6
più come un’orchestra che come
una band, perfettamente inseriti
in uno scenario di calde lanterne
ondeggianti in sottofondo. Le
armonizzazioni di voce che cullano
l’intero show sono magistralmente
sorrette da un basso “acquoso” e
dei timidi quanto efficaci contrappunti di tastiere.
Pare che la band di Brooklyn tenda
quasi a nascondere propria smisurata classe, senza proporre leader
né cadere in ostentazioni, ponendo
al centro della scena solo la delicatezza delle proprie composizioni.
I Phoenix, d’altro canto, reduci
da un album appena sufficiente,
riescono a non deludere grazie
soprattutto allo sporco lavoro di
frontman di Thomas Mars. Il concerto non è certo fallimentare, ma
la loro sfortuna è proprio quella di
suonare dopo i Grizzly Bear: non
si possono decisamente azzardare
paragoni.
La serata termina con la pessima
performance degli Animal Collective, che due anni fa proprio al
Primavera Sound avevano fatto “il
concerto”. Oggi invece sono mosci,
svogliati, a tratti perfino fastidiosi.
Un gran peccato.
VENERDI 24 MAGGIO
E’ inutile negarlo, per buona parte
del pubblico il venerdì è il giorno
dei Blur. Il concerto che tutti aspettano, gli headliner degli headliners,
il live che a Barcellona manca da
dieci anni. Nel frattempo, fino alle
01:30, sono tanti gli artisti che deliziano le nostre orecchie. Esclusi gli
iniziali Merchandise, i quali presentano brani copiati male dai Killers
e di una banalità imbarazzante. Il
contorno di voci alla Morrissey e
il repertorio di faccette proposte
dal cantante chiudono il cerchio di
questa superflua esibizione. Kurt
Vile invece propone un piacevole
set incentrato su “Wakin on a Pretty
Daze”, la sua ultima fatica.
L’unica pecca è il dover suonare con
la luce ancora alta e in uno spazio
ancora troppo grande (Heineken
stage). Se i Django Django, di bianco vestiti, mostrano una ottima
affinità dal vivo presentando il loro
acclamato album d’esordio, gli onnipresenti Shellac di Steve Albini
appaiono sempre più violenti ed
affiatati, con dei suoni al limite della
perfezione.
E’ l’ora dei Jesus and Mary Chain
che, a sentire i rumors, non fanno
nulla per coinvolgere il pubblico
(gli hipster della zona vip, almeno).
In compenso si limitano a suonare pezzi di storia come “Just Like
Honey” con Blinda Butcher dei
My Bloody Valentine, “Head On” e
“Happy When it Rains”. E a me basta
e avanza per trattenere a stento
l’emozione. Cosa che non succede
poco più tardi, coi Blur, sullo stesso
palco.
Damon Albarn, indicando il cielo,
saluta il pubblico con un “So Hola to
la luna”. Non guardo il dito, e Graham Coxon attacca con “Girls and
7
Boys” quello che sarà il concerto
più emozionante dell’ intero festival, per i tanti che hanno passato
un’adolescenza legata a doppio filo
col britpop.
La band londinese alterna sapientemente momenti più movimentati
come “Country House” e “Parklife”
(purtroppo orfana di Phil Daniels)
alle melanconiche “Out of time”,
“Tender” e “This is a Low”, in cui momenti di estasi collettiva uniscono
il pubblico in un lungo singalong
con il quartetto di coristi di colore
presente sul palco. “Coffe and TV”
esalta la grazia chitarristica e la
flebile voce di Graham Coxon, mentre Albarn si tuffa sulle prime file
8
guardandoci in faccia uno per uno.
“Under the Westway” sembra ormai
un classico, seppur uscita da non
più di un anno, “The Universal” è
maestosa e catartica, e nel suo “it
really really really happened” fa
ridestare dal torpore e realizzare
quello che è appena trascorso. I
Blur danno tutto ciò che hanno, e
in termini di sintonia col pubblico,
di presenza scenica, di rilevanza
storica dei brani non esiste paragone con alcuna band di questo
festival.
Purtroppo perdo i The Knife, che
a quanto pare inscenano uno dei
migliori spettacoli della serata, e mi
dirigo verso i Titus Andronicus. La
loro brillante miscela di folk punk, a
cavallo tra Pogues, Dropkick Murphys e The Clash, scuote la folla che
canta a squarciagola ogni brano
fino alla conclusiva, lacerante “No
Future part three”, in cui ci si perde
in un lungo “You will always be a
loser”.
SABATO 25 MAGGIO
L’ultimo atto del Primavera Sound
2013 si apre con i Melody’s Echo
Chamber, band indiepop che suona
meno abbottonata che dal cd,
convincendo nei momenti più dissonanti e dilatati piuttosto che nelle
strofe più prettamente melodiche.
Sullo stesso palco l’innamoratissimo
canadese Mac Demarco delizia il
pubblico con un delicato pop di
piena fattura Pavement, salva un
ragazzo esagitato dagli spintoni
della security, e improvvisa un
crowdsurfing su “Togehter” per
raggiungere la sua amata Karen in
mezzo al pubblico. Fantastico.
Gli Oh sees e i Liars sono i protagonisti del sabato. I californiani,
reinventando il garage rock in
chiave psichedelica, propongono
un altro grandissimo set “fisico”
con cori infiniti, sepolcrali, dilatati
fino allo spasmo, che li consacrano
come una delle migliori rock ‘n’ roll
band in circolazione.
I Liars, completamente avvolti
nell’oscurità, reinventano il loro
ultimo album WIXIW, realizzato per
lo più in chiave elettronica, in una
sorta di contemplazione minimale
del suono, creando il loro spazio in
cui far vivere crescere e sviluppare
una musica che è e può essere solo
loro. L’effetto è oltremodo ipnotico,
in particolare in “Flood to Flood”,
“N°1 Against the rush”, e nella
conclusiva “Broken Witch”, in cui il
cantante urla “blood blood blood”
per un tempo interminabile.
Concludo la serata con i My Bloody
Valentine, sul quale live si è detto
tutto e il contrario di tutto. Semplicemente i MBV hanno un muro di
suoni impressionante, una poesia
rumoristica fantastica, che non
tutte le orecchie possono accettare come tale. Citando Picasso,
riguardo chi contestava il cubismo:
“io non capisco i libri in inglese,
ma non per questo affermo che
essi non significhino nulla”. Se non
capite lo shoegaze c’è sempre il
cantautorato, dopotutto.
Mentre cammino per l’ultima volta
attraverso il Parc del Fòrum, ormai
popolato di soli bicchieri di plastica
che riflettono l’alba, capisco che
questo Primavera Sound è ormai
diventato uno dei migliori festival al
mondo.
Se veramente amate la musica più
delle instagrammate, le transenne
più delle ruote panoramiche, le dissonanze indie rock più delle zone
vip, vi consiglio di farci un salto.
Yes, it really, really really happened. .
Marco Appioli
9
10
Driving
Mrs. Satan
Sono una delle novità più stimolanti
emerse nel panorama musicale
italiano negli ultimi tempi.
L’idea di coverizzare dei brani metal
sfrondandoli della strumentazione
elettrica, di per sé non sarebbe
una novità, ma è il modo in cui
viene trasformato e rimodellato un
genere musicale che è, per antonomasia, il più rumoroso e il meno
rassicurante, a rendere speciale
un’operazione del genere.
Dietro al bizzarro monicker ci sono
tre musicisti napoletani di estrazione pop-folk-jazz (Ernesto Nobili,
Giacomo Pedicini e Claudia Sorvillo)
ai quali abbiamo posto una serie
di domande sfruttando anche lo
spiccato senso dell’humour che li
contraddistingue.
In Your Eyes: La prima domanda
é normalmente la più ovvia e
non farò nulla per distinguermi
dalla massa: come nascono e chi
sono i Driving Mrs.Satan ?
Giacomo Pedicini - I Driving Mrs.
Satan nascono in una notte passata
sul ponte di una nave per la Corsica
con un’IPod pieno di musica.
Claudia Sorvillo - Siamo tre musicisti, ci stiamo divertendo a riarrangiare la storia dell’heavy metal.
Ernesto Nobili - Per me, nascono
da una spiccata sete di sangue che
avevo dopo aver portato mia figlia
all’asilo.
In Your Eyes: Nella tracklist di
“Popscotch” si passa dalla melodia dei brani di matrice power/
nwobhm all’oscurità tipica del
thrash; come sono distribuite le
preferenze musicali all’interno
del trio ?
G.P. - Molto varie e non solo legate
al Metal.
E.N. - Volendo rimanere nel metallo, io ho amato molto tutte le divagazioni metalliche possibile. Quello
che non mi è mai piaciuto, salvo
casi rari è stato il death, il black
nordico … Per dire, passavo con
molta disinvoltura dai Def Leppard
agli Slayer senza troppi problemi
morali …
C.S. - Rock di ogni tipo, e cantautori.
In effetti le mie preferenze variano
di settimana in settimana. Questa
settimana nel mio player ci sono
Alt-j, Ark, Tunngs, Epo, The Roots,
So Percussion, Villagers, Art Brut,
Woodkid e Thony.
In Your Eyes: Ad esclusione di
“Never Say Die”, che risale addirittura al 1978, tutti gli altri brani
sono stati pubblicati nella loro
versione originale negli anni ‘80 e
il più recente tra questi è “From
Out Of Nowhere”, datato 1989;
la scelta di attingere esclusivamente a quel periodo musicale è
stata voluta o è semplicemente
una casualità ?
11
G.P. - I dischi migliori o diciamo
quelli che io ritengo significativi
sono usciti in quel decennio. Gli
anni 80 sono gli anni dell’Heavy
Metal. Il periodo in cui sia io che Ernesto abbiamo imbracciato gli strumenti e deciso che avremmo fatto
i musicisti. Mi sembrava logico partire da qui per un progetto legato
a questo genere musicale. Claudia
forse doveva ancora nascere...
E.N. - Concordo in pieno con
Giacomo. Dopo, almeno per me,
la musica ha preso le strade più
disparate. La curiosità porta ad allontanarsi per scoprire, e a desiderare altra musica. Quindi, sarebbe
stato anche emotivamente difficile
entrare per esempio in un certo nu
metal.
In Your Eyes: Non è che, per caso,
siate tra chi ritiene la musica
prodotta negli ultimi 20 anni non
sia all’altezza di quella del passato (teoria trasversale espressa
da ascoltatori di qualsiasi genere
musicale) ?
Oltre che di metal sono un
grande appassionato di progressive e ho sempre contestato quelli che definivo “tolemaici”, fieri
assertori della piattezza della
Terra nonché della fine del prog
coincidente con l’uscita di Gabriel
dai Genesis; onestamente non
penso che possa accadere qualcosa di analogo anche a musicisti
di ampie vedute come voi. C’è
quindi qualche band o sottogenere in ambito metal in grado
di destare il vostro interesse ai
giorni nostri ?
12
G.P. - Provo a seguire la scena
metal attuale. Cerco di ascoltare i
nuovi gruppi ma non ce ne sono
molti che mi entusiasmano. Le cose
più’ oneste continuano ad arrivare
dai gruppi storici, quelli che lavorano sulla formula vincente del loro
successo. Penso ai Motorhead, Iron
Maiden, Ac/Dc. Pero’ il ritorno di
Michael Kiske con gli Unisonic mi ha
fatto veramente piacere.
E.N. - Altroché, la musica c’è. Non
seguo molto metal di oggi, ma basta che pensi ai Radiohead, esplosi
dopo il ‘98, oppure se approfondisci
il panorama alternativo, indie, free,
post country, trovi dei geni assoluti .
Penso a Sufjan Stevens, Anna Calvi,
o “grandi vecchi” che non finiscono
mai di stupire, tipo David Byrne …
i nostri tempi non sono tempi di
musica di massa, questo si.
In Your Eyes: Per i benpensanti
l’iconografia classica del “metallaro” è quella di un personaggio
come quello di Lorenzo, interpretato da Corrado Guzzanti,
ovvero un tizio quasi incapace
di proferire due parole di fila
in un italiano comprensibile,
dall’igiene personale sommaria
e fornito da madre natura di un
solo neurone che, spesso, finisce
pure per smarrirsi.
Detto che in effetti ai concerti
mi è capitato di vedere più d’uno
corrispondere a questo modello,
pensate che un’operazione come
quella portata avanti dai Driving Mrs.Satan possa contribuire
a migliorare questa immagine,
visto che, almeno apparentemente, sembrereste delle persone “perbene” … ?
G.P. - Dov’e’ il mio neurone?..Ridatemi il mio neurone!!!!..
E.N. - ghgrmdspjvòsldktsv-…
scherzi a parte, invece eravamo ,
almeno nel nostro piccolo, metallari
colti. Ideologi del metallo, in estasi
quando trovavamo riferimenti alla
mitologia greca nei Maiden o in
quei pirla dei Manowar … Ci ho
trovato spunti letterari nel metal.
Non solo le donnine allegre (molto
gradite) dei Motley Crue … E alla
fine anche la scena più street glam
della Los Angeles di fine anni ottanta ha un suo fascino decadente
che gruppi come i Red Hot hanno
descritto bene.
C.S. - Ma certo. La cosa che mi ha
sempre affascinato dei metallari è
la contraddizione, solo apparente,
tra un look sciatto e associato alla
violenza, e il fatto che in effetti
siano spesso persone meglio istruite, più sensibili e consapevoli della
media.
In Your Eyes: Tornando seri per
un attimo, mi ha sempre incuriosito, fin da quando mi sono
imbattuto nei vostri primi brani,
sapere in che modo avviene il
lavoro di arrangiamento. Soprattutto l’operazione di de-metallizzazione di un brano come South
Of Heaven, per uno che non fa
il musicista, appare quasi prodigiosa.
G.P. - Non c’e’ stato un lavoro di
arrangiamento pensato a tavolino.
Ogni brano di Popscotch e’ partito
soprattutto da una fotografia che
avevo nella mente e si e’ sviluppata
in corso d’opera con l’aiuto di Er-
13
nesto e Claudia. Ho tenuto sempre
presente le linee vocali che sono
rimaste quasi inalterate rispetto
agli originali. I riff portanti delle
chitarre le puoi trovare nei brani
sotto forme diverse, nascosti o delegati ad altri strumenti o addirittura
stravolti. Ma la parte decisiva e’
stata quella di Claudia. Non conoscendo gli originali ha interpretato i
testi che noi conoscevamo perfettamente rispettando la sua visione.
E.N. - Comunque è stata la voce di
Claudia poi ad aprire varchi insospettabili.
C.S. - Il metal non e’ la mia influenza principale, e anzi, in molti
casi ero assolutamente all’oscuro
della forma originale di quello che
stavo cantando. E’ probabilmente
questo il motivo per cui i brani sono
interpretati cosi diversamente, e
incuriosiscono.
In Your Eyes: Secondo voi, quindi,
è più facile trasformare in un
brano pop/folk “Raining Blood”
degli Slayer oppure effettuare
l’operazione inversa, rendendo
un massacro thrash metal una
canzone tipo “Granada” di Claudio Villa ?
G.P. - Non e’ solo una questione di
facilita’, e’ una questione di riuscita.
Ci vuole sincerità’ e rispetto.
E.N. - Da piccolo facevo il contrario.
Metallizzavo il non metallo.
C.S. - Immagino che entrambe le
operazioni possono essere più o
meno semplici, e più o meno efficaci, a seconda dell’interesse e
della storia musicale personale di
14
chi le affronta. Qualche tempo fa mi
aveva divertito molto una versione
metal di “All The Things She Said”
delle Tattoo per esempio.
In Your Eyes: Personalmente ho
sempre ritenuto le classiche versioni unplugged piuttosto noiose
e quelle orchestrali ridondanti e,
alla lunga, stucchevoli; credo che
la strada che state battendo sia
quella giusta affinché la coverizzazione di un brano non sia solo
aggiungere o togliere qualche
strumento, bensì quello di trasformarlo e manipolarlo attraverso un reale processo creativo.
Che si sappia voi siete sicuramente tra i pochi a farlo in questi
termini: riuscite a percepire un
incremento dell’interesse nei
vostri confronti dopo l’uscita di
“Popscotch”, rispetto a quanto
accaduto all’epoca del primo Ep ?
E.N. - Personalmente non amo neanche io le versioni orchestrali. Gli
unplugged hanno il difetto, se lo è,
di essere suonati dai gruppi stessi
che hanno creato i pezzi, e quindi
per loro è più difficile distaccarsi
dagli originali. Invece il bello per
noi è stato vedere cosa succedeva
mano mano. Ci siamo fatti anche
grasse risate, pensando alla vocetta
di Claudia che cantava Tom Araya. E
comunque mi fa impazzire il risultato sensuale e “ambiguo” che ha
creato il suo modo di cantare.
In Your Eyes: Navigando sul web
ho letto diverse recensioni del
vostro lavoro e ho notato un ap-
perché mi ha fatto ridere nella sua
semplicità: “Publicity because Vagina”. E’ un punto di vista. Per fortuna
la risposta che stiamo ricevendo da
parte del pubblico è estremamente
positiva nella grande maggioranza
dei casi. Il nostro progetto è apprezzato sia dagli ascoltatori del
genere che da quelli che non lo sono.
Ieri una ragazza mi ha detto “Mi è
piaciuta un sacco I Want Out. Devo
dirti che non avevo mai ascoltato la
G.P. - Le risposte sono state quasi
tutte positive … ed e’ stata una cosa versione originale. Ho scoperto che
mi piace moltissimo anche quella!”.
sorprendente...I Want Out ne e’ la
Mi ha fatto ridere pensare che i Drivprova. E’ stato il segnale che ci ha
ing Mrs. Satan abbiano passato un
aiutato a capire che la strada era
quella giusta. In più’ Michael Weikath nuovo ascoltatore agli Helloween e
(chitarrista degli Helloween) quando non il contrario.
l’ha ascoltata ci ha fatto molti compliIn Your Eyes: Spesso chi ascolta
menti.
musica non ha un’idea precisa di
E.N. - C’è ancora tempo per essere
parecchi aspetti, anche di carcrocifissi a testa in giù durante un
attere burocratico, che stanno
concerto dei Morbid Angel.
C.S. - Nessuna mail minacciosa, ma dietro la realizzazione di un disco.
In realtà, come funzionano le
qualche commento esilarante c’è
stato. Uno di questi mi sono sentita cose nel momento in cui qualcuno
di riprenderlo nel blog e su facebook decide di utilizzare un brano altrui
? Per esempio, si chiama Lemmy e
prezzamento pressoché unanime,
anche quando a scrivere erano
collaboratori di webzine dal nome
minaccioso tipo “MetalSucks” et
similia … C’è stato invece qualcuno
che si è arrabbiato, inviandovi
e-mail poco lusinghiere dopo aver
ascoltato le vostre versioni di brani che, per alcuni, sono ammantati
quasi da un’aura di sacralità ?
15
gli si chiede: “Hey vecchia lenza,
come va ? Male ? Eh già, gli anni
passano per tutti ...
Senti, ti dispiacerebbe molto se
facessimo diventare “Killed By
Death” un pezzo folk ?”, oppure,
molto più realisticamente, ci
si mette in contatto con chi ne
detiene i diritti e si paga un tot
per ottenere l’autorizzazione ?
In quest’ultimo caso fatecelo sapere, magari ci possiamo impegnare a comprare il cd se non altro
per farvi rientrare delle spese
sostenute ...
G.P. - Lemmy ha sempre il telefono
di casa fuori posto…
E.N. - Invece Ozzy mi aspetta sotto
casa con un bastone in mano. In
realtà è questione che riguarda gli
editori.
C.S. - Qualcuno sostiene che il
nostro disco sia un suicidio discografico. Io non la penso cosi. L’altro
giorno fantasticavo sulla destinazione dei soldi dei diritti d’autore.
Tipo: James Hetfield che compra
un biglietto del concerto degli One
Direction a sua figlia adolescente.
In Your Eyes: Tre domande per
ciascuno di voi :
1) Qual è stato il primo disco
metal che avete ascoltato ?
G.P. - Seventh son of a Seventh son
- 1988
E.N. - 1987, registrati su cassette
Maxwell lo stesso giorno : “Piece Of
Mind” (Iron Maiden), “Seventh Star”
(Black Sabbath) e “Hysterya” (Def
Leppard). Ma se ci ripenso avevo
16
già comprato “Slippery When Wet”
di Bon Jovi, un discone.
C.S. – “Awake” dei Dream Theater.
In Your Eyes: 2) Qual’è invece
quello preferito in assoluto ?
G.P. - Che difficoltà’ immane … direi
“The Keepers Of The Seven Keys
pt.2” degli Helloween … ma la scelta
e’ difficilissima!!!
E.N. - Variabile. “Rage For Order”
dei Queensryche, o “Piece Of Mind”
degli Iron, hanno occupato il podio
per più tempo.
C.S. – “Remedy Lane” dei Pain of
Salvation.
In Your Eyes: 3) Qual è il brano
che via ha maggiormente soddisfatto per la sua riuscita in Popscotch?
G.P. - I Want Out sicuramente ...
seguito da Battery … e tutti gli altri
... ah ah!!! …
E.N. - Posso dirne 11?
C.S. - La nostra versione di Killed By
Death dei Motorhead. E pensare
che altri non volevano neanche
includerla nel disco!
Sperando che ci sia qualche promoter lungimirante che ci consenta di vedere i Driving Mrs.Satan
all’opera nella (non sempre) ridente
Liguria; in tal caso noi di In Your
Eyes saremo i primi a supportarli.
Stefano Cavanna
VARAZZERS.
© Varazzers
Varazzers. nasce nel 2013 come pagina pubblica di Facebook per aggiornare il pubblico
giovane su cosa succede in Riviera, tramite
post fotografici e PRaggio di eventi locali.
Panorama dal Santuario Madonna della Guardia
La nostra presenza sul web si sta allargando
con un sito web (ancora in allestimento) su cui
trovare info su eventi, locali ecc.
Varazze Bici Festival - maggio 2013
Seguici su Facebook & Instagram
17
Foto dall’evento skate OTW 2013 che si tiene a Varazze ogni primavera.
18
Fanzine,Anni
Novanta
Vi inoltro questo scritto pubblicato su
Cagnara, fanzine nata negli anni 90 e
che ora vive su Facebook.
Mi hanno chiesto di scrivere un pezzo
su Non Ce N'é, la fanzine che facevo
negli anni 90 assieme a Luca. é un po
come fare mente locale sul passato,
su tante avventure ed l'abc della mia
formazione...
buona lettura.
MEMORIA DI CARTA......
Cagnara (Facebook), oggi ha incontrato Fabio Battistetti che a noi
fanzinari di lunga data suscita un bel
po' di ricordi legati al periodo cosiddetto cartaceo... quello per intenderci
che va dagli anni ottanta ai novanta...
quello dove il postino portava le
buste con le fanzine, quello dove si
facevano gli stand ai concerti in qualche locale sperduto in luoghi non ben
precisati, quello della macchina da
scrivere, della coccoina... insomma
un mondo molto meno tecnologico
di adesso ma forse più sincero....
Questo è quanto ci ha raccontato
il buon Fabio sul suo periodo fanzinaro.....
A pensarci ora vi vien da sorridere…
Per tanti motivi, fare una fanzine è
stata per me un'esperienza formativa, sociale, comunicativa oltre che
musicale. Era il 1993, frequentavo
il liceo ed al secondo anno mi ritrovai un nuovo compagno di banco
(Luca) col quale iniziammo a scoprire
musiche diverse dalle solite propinate da radio e riviste musicali (che
principalmente erano heavy metal e
simili). Il nostro percorso di scoperta
fu molto rapido, il punk rock ci rapì
per l'immediatezza e l'urgenza (di
comunicare): quello fu il primo input.
Fummo aiutati dal fatto che in città,
a Torino, trasmetteva l'emittente
libera, Radio Blackout che di punk e
musiche alternative ne era un po' la
voce ed essendo una radio autoprodotta il contatto con essa poteva essere semplice. C'era una trasmissione
che oltre a far ascoltare le ultime
novità del punk/hardcore ed i “classici” del genere raccontava di fanzine
straniere e non, il conduttore era
Andrea Pomini, fanzinaro anch'esso
con Abbestia.
Lo contattammo per ordinare proprio delle fanzine (incuriositi dai suoi
racconti radiofonici) ed andammo direttamente in radio a ritirare l'ordine
scoprendo un piccolo grande mondo
che da lì a qualche anno sarebbe
stato un punto centrale per noi (in
radio ci arrivammo con una nostra
trasmissione l’anno successivo). E’
così che iniziammo a divorare pagine
fotocopiate di fanzine nostrane e
straniere (Maximum Rocknroll e
Flipside). Quelle letture ci entusiasmarono e facemmo presto due più
due e ci dicemmo: “ora tocca a noi !”.
Volevamo anche noi dire la nostra,
scrivere di musica ci affascinava e
per di più potevamo fare tutto da noi
19
perchè uno dei primi insegnamenti
avuti dal punk, è l'autoprodursi,
far da se, senza chiedere ad altri o
delegare e nel caso di una fanzine
non ci voleva poi così tanto per
farla. In parallelo, in quegli anni,
grazie a Luca iniziai a frequentare
intensamente l'annuale Fiera del
Libro per la passione della lettura
e per scorgere un po' del mondo
dell'editoria che in un modo del
tutto rudimentale noi prendemmo
a modello per il nostro piccolo
progetto cartaceo. Non avevamo
i mezzi dell’editoria, ma in fondo
non servivano ed interessavano
per il nostro scopo: il punk ed il do
it yourself ci offriva il contesto ed
i mezzi di produzione. Il taglia ed
incolla non è stato inventato con
il sistema operativo dei computer,
era ed è qualcosa di fisico da farsi
con forbici e colla, ed era forse una
delle ultime azioni nella produzione di una fanza, prima occorreva
20
scrivere ! Il nome Non Ce N’è lo
decidemmo dopo alcuni tentativi
prendendo spunto dal titolo di un
brano di un gruppo locale, i Church
Of Violence.
I contenuti nascevano dall’urgenza
di dire la nostra, raccontare e far
conoscere, musiche, gruppi, situazioni e compagnie bella. Le sorgenti su cui scrivere arrivavano un
po’ dai nostri ascolti musicali che in
quel periodo erano in piena esplorazione / scoperta e dagli amici
di penna (fanzinari, appassionati
come noi, etc.), tanto che una caratteristica di Non Ce N’è è sempre
stata quella di avere contributi da
persone esterne. Ad esempio, nel
primo numero un ragazzo di Saluzzo scrisse un articolo sui Germs (lui
stesso di lì a poco iniziò la fanzine
Bestial Devotion). Usavamo un
software di scrittura per computer
(DOS) che girava su un floppy disk
(di cui conservo ancora una copia
con i testi prodotti) ed una volta che
avevamo pronti gli scritti li stampavamo per poi passare alla fase
calda della produzione: con forbici
e colla alla mano assemblavamo
le pagine. I primi numeri furono
stampati in ciclostile grazie al padre
di Luca, ed il ciclostile era un buon
metodo (per velocità e qualità) e ci
permise anche di avere la copertina
stampata in azzurro mentre il resto
delle pagine erano in nero.
In quel momento storico, avere
fuori un numero di una fanzine,
significava aprire la porta su un
mondo di contatti, nuovi amici di
penna e difatti fu proprio così. I
primi due numeri furono il frutto
dell’urgenza a livello di contenuti
forse non erano il massimo, seppur
rappresentino parecchio il nostro
intento, dal terzo in poi iniziammo a
lavorare in maniera più definita rispetto alla composizione ed alla re-
dazione, dandogli una caratteristica
precisa, dando importanza primaria
alle recensioni di dischi e fanzine
ed alle opinioni personali (columns,
qui era chiara l’influenza dalle fanzine americane). In parallelo avevamo anche dato vita all’etichetta
discografica Non Ce N’è Records
producendo il 7” (il fantomatico 45
giri) diviso a metà tra i torinesi Boyz
Nex’ Door e gli spezzini Manges.
All’epoca del quarto numero della
fanzine, pubblicammo la fanza in
500 copie allegando la seconda
uscita dell’etichetta, il 7” dei torinesi
Killer Klown. Se la mente non mi
tradisce, quello fu anche l’ultimo
numero firmato da me e Luca
assieme, perché dopo questo lui
decise di dedicarsi maggiormente
all’etichetta ed in seguito partì con
un nuova fanzine, Gabba Gabba
Hey (più orientata sul garage ed
il punk rock come temi musicali),
mentre io volevo orientare la fanza
verso uno sguardo più amplio sul
21
mondo musicale underground
(chiaramente in base ai miei gusti).
Non Ce N’è Records sotto la guida
di Luca è andata avanti per un bel
po’ producendo altri dischi per
Killer Klown, Manges ed altri gruppi,
prima di cambiare nome in Mad
Driver, arrivando a produrre anche
gruppi stranieri (Spider Babies,
Coyote Men…). Io ho dedicato maggiori sforzi alla fanzine curandone
la relativa distribuzione di fanze e
dischi che era nata come conseguenza dello scambio di NCN con
altro materiale. All’interno della
scena DIY, lo scambio è sempre
stato il modo migliore per far veicolare il materiale, era una specie di
rete internazionale di supporto che
andava anche oltre, organizzando
concerti.
Anche noi ne facevano parte e ci siamo anche dedicati ad organizzare
concerti a Torino per un po’ di anni,
già dai tempi della fondazione della
fanza, il primo fu nel novembre
del 1994 ad El Paso per i Soundblast di Ravenna ed gli Slowo dalla
Polonia, i primi si erano da poco
autoprodotti il primo 7” che ci aveva
entusiasmato tanto da decidere di
dargli una mano per un concerto in
città. In molte di queste situazioni
si creavano amicizie e situazioni di
scambio “umano” ed in fondo era
quello il succo di tutto: condividere
umanità.
Il tema della condivisione, l’ho
imparato lì ed è una cosa che ho
ritrovato su altre vie a proposito
di copyright e software e tuttora è
un leit motiv per quanto riguarda il
22
mio agire in ogni campo. La conseguenza di avere una distribuzione ed
il condividere le esperienze di cui
sopra mi portò a creare una piccola
etichetta discografica, Neghenè
(non ce n’è in dialetto ligure-spezzino, suggeritami dai Manges) con la
quale co-produssi (assieme ad altre
etichette) dischi di gruppi ai quali
sentivo di voler dare il mio supporto, ricordo il 7” dei Rudimenti,
quello degli Arsenico, quello dei
Bombardini, una cassetta dal vivo
dei Manges, il cd dei Panico ed altri.
NCN come fanzine ha proseguito
le pubblicazioni sino al 2000/1
assumendo un layout sempre più
curato ed arrivando al numero 9 in
un’uscita split con la fanzine: La Piccola Meraviglia.
Nove numeri in 7 anni erano forse
pochi, ma i tempi di produzione
e distribuzione erano abbastanza
lunghi, avevo la volontà di dare
maggiore continuità per fornire
informazioni fresche, ma non ci
riuscivo più di tanto. Dopo aver
esaurito le risorse per quel progetto, ne misi subito in cantiere uno
nuovo: una fanzine dal formato più
piccolo (non più l’A5 di Non Ce N’è,
ma bensì uno che era la metà), una
sorta di diario tascabile, impostato
sulle opinioni e con temi musicali
più freschi (anche qui frutto dei
miei gusti diversificati del periodo).
Il nuovo progetto si chiamava La
Mini e ne feci 4 numeri stampati
per poi passare al web/blog; la
frequenza di uscita era più rapida
rispetto a NCN e si basava su una
redazione a più voci e con contributi esterni anche per l’impaginazione,
i primi tre numeri furono curati
in parte o in todo da Alessandro
Baronciani. In base a questa linea,
l’evoluzione quasi naturale visti
i mezzi in ballo fu quella di trasformarla in un blog (che è ancora
online) con l’intento di proseguire il
tema della scrittura condivisa, andando avanti sino al 2004/5 quando
lentamente il tutto iniziò a sfumare
via. Da quel momento partono
altre storie di vita che non hanno
apparentemente nulla in comune
con una fanzine, se non le esperienze umane condotte, che hanno
avuto influenze su di me ancora per
parecchio.
Sul web c’è (ma non più è aggiornata) una pagina dedicata alla Mini
e con rimandi a Non Ce N’è.
23
Francesco
Orazzini,artista
visivo, perde la
maggior parte del
suo tempo a perdere capelli per colpa delle burocrazie.
Produce di continuo roba oscura, ed e’ diviso in due
parti:una e’ persuasa che siamo una completa massa
di imbecilli, l’altra ci vede come meravigliose creature.
sito: www.Francesco-Orazzini.com
email: [email protected]
24
25
26
27
28
29
30
Tame Impala LIVE
IYEzine è stata al Mojotic festival
di Sestri Levante (località della
nostra beneamata riviera ligure
di levante, per chi non lo sapesse,
spero nessuno), per seguire il concerto dei Tame Impala, il 13 Agosto,
grande appuntamento per questa
edizione 2013, dopo gli eventi che
hanno visto protagonisti i Baustelle, Daughter, Willy Mason,
Adam Green, e la Shhh! Silent
Disco.
Vorrei innanzitutto spendere due
parole per il festival nel suo complesso, che ha ormai raggiunto una
certa dimensione e una sua stabilità
nel panorama rivierasco, ed è ormai una delle migliori iniziative che
contribuiscono a rendere davvero
viva e giovane la riviera, iniziative di
cui purtroppo a mia memoria essa
è sempre stata abbastanza povera,
vuoi ad esempio per il mancato
appoggio dei comuni o sponsor, le
proteste di una popolazione avanti
negli anni, la mentalità di chiusura
ligure e la volontà di limitare al
meno possibile le “grane”, perchè
tanto i turisti in riviera ci vengono lo
stesso, e siccome non sono perlopiù giovani non interessa promuovere certe iniziative.
Presentatavi la situazione, ecco
dunque che il nostro Mojotic si erge
e splende come una luce di speranza, che possa continuare e magari
anche ingrandirsi sempre di più
in futuro. Perchè l’organizzazione
è buona, c’è gente che ha voglia
di fare bene e far divertire il pubblico, mettendo tutti d’accordo ed
evitando i contrasti e le polemiche
che altri eventi come la storica e
tanto chiacchierata “hanoa hanoa”
hanno generato negli ultimi anni,
perché le location scelte si prestano
molto bene, il pubblico è educato e
la proposta vincente. Questa quinta
edizione segna inoltre una netta
crescita, un salto di qualità, rispetto
alle precedenti edizioni, per le
dimensioni e la portata degli eventi
proposti.
Ancora un piccolo commento
sulla location, perché è davvero
incantevole...ci sono stato non so
quante volte, ma ad ogni nuova occasione in cui mi trovo lì non posso
fare a meno di provare la stessa
emozione...sto parlando della Baia
del Silenzio, in fondo alla quale si
trova l’ex convento dell’Annunziata.
Una location perfetta per eventi di
medio-piccola grandezza, nel cui
cortile interno con terrazza rialzata
sul mare, è stato allestito il palco.
È impossibile a mio giudizio arrivare lì e non innamorarsi del posto,
come ha più o meno detto lo stesso
frontman della giovane band australiana, affermando sicuramente
con un po’ di adulazione, ma anche
con un po’ di sincerità a parer mio,
che per loro è uno dei posti più belli
al mondo, e che è stato bellissimo
poter trascorrere la giornata al
mare e suonare lì accanto la sera...
31
Ma veniamo al concerto, scusate
se mi sono dilungato, ma ci tenevo
a parlarvi di queste sensazioni che
quella zona mi evoca, dovute ai
tanti ricordi dei mesi estivi trascorsi
da quelle parti...
Per non sembrare un po’ ipercritico
ad alcuni strenui difensori della
band, ci tengo a dire che i dischi
dei Tame Impala mi sono piaciuti
molto molto, sia “InnerSpeaker” che
“Lonerism”, inseriti anche nella mia
toplist dei dischi del 2010 e 2012.
Secondo me gli australiani sono
davvero meritevoli, perchè riescono
bene a coniugare tutto il filone
dell’hypnagogic pop e gli appetiti
indie del giovane pubblico, con una
ricerca sonora molto radicata nel
rock psichedelico (tant’è vero che
prima dei Tame Impala, o meglio
32
prima di “InnerSpeaker”, Parker &
soci erano cresciuti nella lontana
Australia a pane e psichedelia seventies).
Però a seguito della loro esibizione
non posso certo dire che la giovane
band si collochi nella mia toplist dei
concerti dal vivo...
Direi che i Tame Impala si prendono una piena e meritata sufficienza,
ma non troppo di più: è innegabile
che hanno dei suoni davvero particolari e fanno un tipo di musica che
a me piace molto, così affondata
nella psichedelia e costituita da un
muro sonoro di synth e chitarre,
contaminata da un’influenza pop
sempre più marcata. Purtroppo
nel complesso la performance ha
avuto, secondo me, alcune carenze,
un pochino troppo evidenti per
una band che ormai stà passando
dallo status di gruppo emergente
a quello di gruppo di prima fascia,
riassumibili se vogliamo in tre “pecche”, che hanno un po’ macchiato
una altrimenti grande performance.
Innanzitutto, eccetto vari momenti
davvero molto buoni e coinvolgenti,
ad un timido Kevin Parker e alla sua
band è mancata secondo me un
pochino di presenza scenica; nella
mia aspettativa (ma forse questa
cosa è legata alla mia personale
aspettativa che mi ha un po’ fregato) una band del genere avrebbe
potuto avere un maggiore impatto
espressivo: il pubblico era caldo
e la performance ottimamente
accompagnata da splendidi visuals psichedelici, e mentre in alcuni
pezzi i ragazzi ci hanno davvero
messo del loro, creando un suono
avvolgente, prolungando e variando il brano, in altri è sembrato
quasi che i brani venissero riprodotti in maniera un po’ più “impersonale”.
Inoltre, la legge dice che dal vivo
non si scappa, cari miei, si vedono
sia l’estro e le doti dei musicisti ma
anche vengono fuori i punti deboli...
così emerge purtroppo che la voce
di Kevin Parker è troppo carente, a
volte è sembrato quasi non farcela,
in particolar modo in Feels Like
We Only Go Backwards, una delle
tracce più attese e rivelatasi la peggiore della scaletta.
Però la cosa mi lascia alquanto
perplesso, perché riascoltando la
discografia, le prime ottime prove
(i demos e il loro primo EP) erano
caratterizzate da un suono e una
voce più potente, con una psichedelia più vicina al rock e meno al
pop, rispetto ai recenti sviluppi,
dove all’ammorbidirsi del suono,
più colorato e con più attenzione
alla narrativa, si è ammorbidita
anche la voce, divenuta quasi femminile, che dal vivo è risultata in
affanno e comunque non all’altezza
dell’espressività della musica.
In ultimo, per riassumere e chiudere un po’ queste considerazioni,
che per inciso nulla vogliono
togliere al valore della band australiana, mi trovo costretto ad
affermare che i Tame Impala
rendono meglio su disco, dove il
“labor limae” di produzione riesce a
rendere il suono più pulito e avvolgente, mentre per loro c’è ancora
da lavorare per rendere le esibizioni
dal vivo all’altezza delle loro ottime
e particolari produzioni.
I Tame Impala hanno scelto per
l’esibizione una continua alternanza
tra i brani di Lonerism e InnerSpeaker, saltando di qua e di là tra
l’album di debutto, di passaggio da
rock psichedelico a pop ipnagogico,
dove queste caratteristiche convivono in maniera molto interessante, e
Lonerism, che segna una svolta più
netta in direzione pop. Il concerto
si apre sulle note di Why Won’t You
Make Your Mind, da “InnerSpeaker”,
seguita immediatamente da Music
To Walk Home By.
Un buon inizio, e l’alternanza procede con Mind Mischief – Solitude Is
33
Bliss, la prima più leggera e colorata, la seconda più potente con
le sue scariche di chitarre distorte,
e in seguito troviamo una buona
Keep On Lying.
La sensazione è che con il binomio Half Glass Full Of Wine e
Elephant, in successione, avvicinandoci alla metà del concerto, la band da Perth si spari le
proprie cartucce migliori. Questo
binomio costituisce il momento più
coinvolgente della serata, dove si
vedeva tutto il pubblico davvero
trascinato dai ritmi più veloci, distorsioni potenti e cascate di synth,
soprattutto nella lunga e bellissima
Half Glass Full Of Wine, il pezzo
più roccioso della serata, in cui la
progressione in climax culmina in
estatiche cascate di synth.
Questo pezzo, un vero e proprio
cavallo di battaglia, addirittura risale al self-titled EP d’esordio di cui
abbiamo parlato poco fa, ed è stato
quasi sempre inserito nei concerti,
perchè è una vera bomba. Quanto a
Elephant invece, è un coinvolgente
ed incalzante concentrato d’energia
che entra nella testa e non può non
far muovere il pubblico.
Con la successiva Be Above It viene
fuori anche un po’ di elettronica,
in un ottimo connubio con la
psichedelia pop, un viaggione, dove
su un ritmo incalzante si innestano
tappeti di synth e successive piccole
esplosioni. In seguito i Tame Impala
vogliono decomprimere un po’
l’ambiente, con un lungo interludio
34
strumentale in cui vengono fuori gli
Air ed altre influenze più propriamente dream pop.
Della deludente Feels Like We Only
Go Backwards abbiamo già parlato,
perciò saltiamo a Desire Be Desire
Go, altro pezzo ormai storico e
sempre bello della band.
Ci avviamo verso la conclusione, e
troviamo ancora l’accoppiata formata dalle coloratissime Alter Ego
e Apocalypse Dreams.
Come da ormai inscalzabile abitudine, la band esce sapendo già che
verrà presto richiamata sul palco,
perchè il pubblico è assetato e
francamente una performance da
un’ora e un quarto sembra pochino
agli occhi di tutti, perciò si prosegue
per un’altra ventina di minuti con
due brani riservati alla chiusura
ancora estratti da InnerSpeaker, ovvero It Is Not Meant To Be e Nothing That Has Happened Has Been
Anything We Could Control.
In conclusione, mi sento di fare i
miei complimenti ai Tame Impala
perchè sono un gruppo promettente e con delle ottime idee, e di
fare un plauso e un incitamento a
continuare così agli organizzatori,
perché non è così frequente dalle
nostre parti vedere eventi del genere, perciò un arrivederci a presto
al Mojotic Festival!
Davide Siri
Adriano VII
Frederick
Rolfe
Di Gianluca Camogli
Letterariamente parlando, mi ero
innamorato del pretino Julien Sorel
, così come mi ero appassionato
della vicissitudini di Narciso e Boccadoro.
Non poteva quindi non entusiasmarmi questo affresco storico di
Frederick Rolfe, ambientato nei
primi del ‘900 in un Europa in
piena trasformazione geopolitica e
culturale, che racconta la bizzarra
storia di George Arthur Rose.
Da prete esiliato a Papa, quasi
per scherzo. Dai ai margini della
scena ad attore principale, con in
più la capacità intellettuale per rivoluzionare il sistema dall’interno.
Gli oppositori vengono ribaltati
all’angolo secondo uno schema che
ricorda una partita a scacchi.
Le azioni dell’avversario sono
state previste tutte: ignaro di essere manovrato e condizionato
nella scelte delle mosse, pensa
che queste siano opera e volontà
propria, e non si accorge che sono
il risultato di un ragionamento
fine e astuto, che limita gli spazi
di manovra secondo uno schema
predefinito.
Solo possedendo acume si riesce
ad insultare e a criticare con eleganza chi ti rivolge accuse infondate,
e allora “la voce del serpente e la
voce dell’oca sono una sola e unica
voce”.
Ma questa intelligenza genera
anche sofferenza nell’animo, alienazione, inquietudine nell’essere
emarginato a causa di una condizione di superiorità che eleva
rispetto agli “innumerevoli branchi
di cuccioli mal leccati e di mediocri
ignoranti” ma isola.
La mediocrità infatti accomuna i
molti, che nella loro condizione non
si pongono domande e nella loro
ignoranza temono chi sa di più: la
paura si trasforma in cattiveria, a
tal punto da far chiedere a George
di voler “essere onesto e semplice
invece di sottile e complicato” per
poter sfuggire alle pene che gli altri
gli arrecano.
Adriano VII è un libro che consiglio a chi a voglia di essere
stimolato nelle riflessioni e che
non vuole solo lasciarsi coinvolgere
da una storia, dato che sono diversi
i temi trattati.
Primo su tutti la rivoluzione ideologica della Chiesa e del pensiero
collettivo verso di questa.
In periodo di rivoluzione, ad un cardinale che si lamenta della scarsa
sicurezza nell’uscire per le strade
Adriano VII, che ha già cominciato il
35
processo di trasformazione, semplicemente risponde che “la Chiesa
ha grande bisogno di un martire”, e
che si tratta sempre di inviti e mai
di imposizioni. La Chiesa è troppo
distante dalle persone.
Il nuovo Papa decide inoltre di vendere i beni della Chiesa per rifondarne la spiritualità e l’immagine,
ma allo stesso tempo distogliere le
attenzioni mediatiche da vicissitudini personali precedenti alla sua
nomina.
di un secolo, per questi e altri aspetti risulta estremamente attuale,
con riferimenti che possono aprire
parentesi nel mondo moderno.
Sembra una conferma del la “teoria dei corsi e dei ricorsi storici” di
Giambattista Vico.
Quante analogie con la situazione attuale, con lo IOR, con
l’abdicazione di Benedetto XVI e alla
elezione di Francesco I.
Altro tema che accompagna il libro
è quello del giornalismo commerciale: non mancano velate critiche
al sistema di diffusione delle notizie, che troppo spesso sceglie solo
in base alla pessima morale del
numero di copie vendute.
La veridicità delle notizie non è più
così importante, perché “l’appetito
del pubblico è capriccioso” e “bisogna tentarlo con esche variate”,
“se le trote sono stanche di zanzare,
bisogna provare con le mosche”.
Anche in questo caso quante analogie con la disinformazione odierna,
con l’abilità di modificare la comunicazione di certe notizie, con il
conflitto di interessi per eccellenza,
col problema di un giornalismo
scarsamente indipendente.
Nonostante questo libro abbia più
36
Un libro avvincente, imperniato su
un personaggio che si potrebbe
definire rivoluzionario, intrigante,
parzialmente scorretto per un fine
superiore e in grado di catturare la
nostra simpatia.
Quando arriverete alla fine di
questa storia, Adriano VII e la sua
stravagante personalità vi saranno stati talmente di compagnia
che vi mancheranno.
Simone Sarasso
Il Paese Che Amo
di Massimo Argo
Terzo volume della trilogia di
Simone Sarasso, cominciata
con “Confine di Stato” del 2007,
proseguita con “Settanta” ed infine
compiuta con questo libro. Sarasso in questa trilogia tratta dei
peggiori 40 anni di storia italiana,
dall’omicidio di Wilma Montesi
del 1953 fino al 1994, anche se
la cronologia non è strettamente
aderente.
L’autore sviluppa un proprio universo di personaggi che potrebbero
essere riconosciuti come persone
reali, ma gli sviluppi narrativi di
queste opere non sono rintracciabili nella realtà. Seguendo
l’esempio di Ellroy nella sua trilogia
su Kennedy, Simone costruisce
un universo altamente verosimile
e probabile, ma che non è quello
che conosciamo noi. Certamente,
e purtroppo mi viene da dire, un
personaggio come Andrea Sterling
è esistito in Italia, e si potrebbero paragonare i personaggi della
saga a quelli reali, ma questo non
è l’obiettivo dell’autore. Lo scopo
di Sarasso, e potrei venire clamorosamente smentito, è quello di far
capire attraverso romanzi narrati e
sceneggiati come dei film, i meccanismi nascosti dietro 40 anni di storia
tricolore.
L’autore ha studiato a fondo la
materia, e vuole portare a galla le
congiunture, i piccoli fatti, le storie
personali che stanno dietro a questi
avvenimenti. In tutti i libri ci sono
elementi di noir, di giallo e di storia,
ma soprattutto una grande sapienza nel trattare i caratteri umani,
tratteggiando nel migliore dei modi
possibili le parabole esistenziali
dei protagonisti e facendoci capire
che la storia l’hanno vinta e scritta i
peggiori. In questo terzo ed ultimo
libro della trilogia si può osservare
la crescita di Sarasso in termini di
scrittura, mentre tratteggia le pennellate finali di un grande affresco,
fosco e cattivo.
L’Italia ivi descritta è la nostra
patria, stuprata in più maniere
da tanti bruttimbusti, ma sempre per gli stessi motivi, primi fra
tutti l’anticomunismo, come è ben
testimoniato dall’accendino Zippo
del Mago, oggetto che sarà molto
importante in qeusta vicenda. Ne
Il Paese Che Amo già dal titolo
dovreste aver capito dove vuole
condurvi l’autore, anche perché
l’arco di tempo trattato è molto
prossimo ai giorni nostri, anzi
è ancora la maggiore influenza
di questi nostri miseri tempi. In
quest’occasione capirete come
tutte le cose che avvengono in Italia
non siano affatto un caso, ma c’è
sempre un disegno, una ragione
occulta, poiché questo paese è il
paese della nebbia per eccellenza.
Se pensate che questa nostra Italia
possa anche aver avuto una seppur remota innocenza leggendo
Sarasso vi accorgerete che le cose
37
vanno molto peggio di quanto possiate aver mai creduto. La trilogia è
costruita molto bene, praticamente
sono tre film, l’ultimo dei quali è
sicuramente il più maturo, e dentro
al Il Paese Che Amo potete trovare
una grande rabbia, una delusione
ed un impegno a non scordare chi
ha lasciato sull’asfalto la propria
vita e i propri sogni, Piazza Fontana, Piazza Della Loggia, Bologna,
Ustica...
Sarasso si rivela un grande scrittore storico, come possono dimostrare i suoi romanzi “Invictus.
Costantino Imperatore Guerriero” e
“Colosseum. Arena Di Sangue”.
Qui il romanzo riprende la sua
valenza civile, di scrittura come
responsabilità e memoria, per far sì
che in Italia ci siano meno smemorati, in un paese dove dimenticare è
il primo valore.
Lettura altamente consigliata, la
trilogia crea dipendenza ma sono
tre acquisti di cui non vi pentirete,
preparando però il fegato al nervoso. Consiglio caldamente anche
dell’autore la graphic novel “United
We Stand” che traccia un possibile
tragico futuro per l’Italia.
Sarasso inquieta e fa ricordare, affermandosi come uno dei migliori
scrittori italiani apparsi negli ultimi
anni.
INTERVISTA
Dopo aver recensito Il Paese Che
Amo, opera ultima di Simone
Sarasso, ecco l’intervista che va
ad aggiungersi a un graditissimo
38
regalo che Simone ha fatto ai nostri
lettori : in esclusiva, siamo molto
onorati di poter pubblicare, nella
sezione “articoli” la postfazione del
libro, che è una vera e propria confessione dello scrittore . Solo per i
vostri occhi.
iye: Raccontaci la genesi della
Trilogia.
La Trilogia Sporca dell’Italia nasce
da un’amalgama di urgenza civile
e bisogno di frugare, attraverso
la narrativa, nel ventre molle del
Paese, nei suoi meandri oscuri.
La Trilogia accende la luce nella
polverosa Stanza dei Bottoni, fa
scappare i bacherozzi dal tappeto
della Storia.
iye Quali sono stati i tuoi scrittori
di riferimento per questi libri?
De Cataldo, Carlotto, Evangelisti,
Genna, Wu Ming, Bertante e Lucarelli sul fronte italiano. Winslow,
Duncan e James Ellroy su quello
statunitense.
iye: Hai timore che il senso di
questi libri non venga compreso?
Uno scrittore non è uno storico,
non pretende di raccontare la
verità. Si limita, quando si occupa
di narrazione civile, a tenere in vita
la fiammella della memoria, così
debole nel Paese che amo.
iye:Chi sceglieresti come regista
di eventuali film per questi libri?
Robert Rodriguez. Senza alcun dubbio.
iye: L’Italia che tu descrivi è stata
la peggiore, o stiamo grattando
ora il fondo del barile?
Ho motivo di credere che sotto il
fondo del barile ci sia altra melma.
iye: Dato che siamo una webzine
musicale, devo farti questa
domanda: quali sono i tuoi ascolti preferiti?
Sono visceralmente legato al punk
degli anni Novanta. E alle sue
derivazioni più o meno contemporanee. Ascolto ossessivamente
Less Than Jake, Rancid, Green Day e
Dropkick Murphys.
iye : Tornerai in campo fumettis-
tico dopo l’incredibile “United We
Stand”?
Al momento non c’è nulla in programma a breve termine, ma in
futuro chissà. Io e Daniele Rudoni
lavoriamo da parecchi anni a un
progetto top secret in lingua inglese
che prima o poi, ne sono convinto,
approderà sugli scaffali.
Grazie mille Simone per la tua
disponibilità e per portarci là
dove l’ Italia non può essere
lavata.
POSTAFAZIONE IN
ESCLUSIVA PER IYEZINE
È stata una lunga cavalcata: quasi
dieci anni di lavoro forsennato.
Quando ho iniziato a scrivere la
Trilogia Sporca dell’Italia, non avevo
idea che sarebbe stata una trilogia.
Immaginavo, mettendo in fila le
false piste, i fatti loschi e buchi neri
della Storia, un grande romanzo
sulla prima Repubblica, sull’Italia
peggiore, dal dopoguerra a Tangentopoli. Presto mi sono reso conto
che un romanzo solo non sarebbe
bastato, neppure per descrivere il
marcio d’un paio di decenni.
Così mi sono messo in cammino, ho
pigiato sui tasti, trascorso ore nelle
emeroteche e nelle biblioteche, intervistato testimoni oculari, tessuto
trame, dato vita a personaggi.
Dell’intero trittico, IL PAESE CHE
AMO è stato il libro più difficile da
scrivere. Perché, degli avvenimenti
che narro, ho memoria cruda e viva.
39
È l’Italia in cui sono cresciuto, in cui,
bambino, ho imparato a leggere
e scrivere, far di conto e sognare.
L’Italia che mi ha deluso, l’Italia che
non riesco a smettere di amare.
Quando è venuto il momento di
raccontarla, ancora una volta, mi
sono trovato di fronte a un bivio:
dire la verità era impossibile, ma
trasfigurarla senza criterio sarebbe
stato ingiusto.
Ho fatto delle scelte, ho corso dei
rischi.
Ho fatto quello per cui sono venuto
al mondo e per cui mi pagano: ho
mentito.
Sperando di raccontare almeno un
frammento, una scaglia lucente di
verità.
Come già mi trovai a scrivere,
riguardo a Settanta: quella che
avete appena finito di leggere è una
storia di finzione.
Niente, in questa storia, è reale.
Verosimile, forse, ma reale no. Non
sono reali i personaggi, né le cose
che accadono. Molti avvenimenti
ricordano la storia mondiale degli
anni Ottanta e Novanta. Nessuno di
essi ha la benché minima credibilità
storiografica. Semplicemente perché l’Italia, l’Europa e l’America che
descrivo in questo romanzo non
coincidono del tutto con il mondo
in cui sono diventato grande.
Il Paese Che Amo è, sotto molti
aspetti, un Paese fittizio.
In un certo senso, un non-luogo.
Valerio Evangelisti alcuni anni fa
mise in coda al suo romanzo più
bello, Noi saremo tutto, una nota
40
bibliografica che iniziava così:
Sebbene questo romanzo non abbia pretese storiografiche, il contesto della vicenda è frutto di ricerche
piuttosto accurate.
Le sue parole, come valevano per
Settanta e Confine di Stato, valgono
anche per questo lavoro.
Il Paese Che Amo è, prima di tutto,
fiction.
Non c’è la Storia “pura”, qua dentro:
piuttosto un’inestricabile mescolanza di Storia e finzione.
Nessuno dei miei protagonisti è
reale. Anche se molti di loro assomigliano a personaggi storici,
nessuno di loro è identificabile con
il proprio corrispettivo.
Tanto per essere chiari: Tito
Cobra non è Bettino Craxi, Ljuba
Marekovna non è Ilona Staller
né Moana Pozzi, Carlo Ciaccia
non è Giovanni Falcone né Paolo
Borsellino, l’Omino non è Giulio
Andreotti e Domenico Incatenato, l’avrete capito, non è Antonio
Di Pietro.
La non identificazione è valida
per molti altri protagonisti minori.
Praticamente per tutti i personaggi
del libro.
Esplicitare questa differenza, questa non identità tra Storia e fiction,
tra personaggio storico e character,
non significa semplicemente pararsi il culo da eventuali querele per
diffamazione.
Questo testo non è un disclaimer.
Un’implicita deresponsabilizzazione del mio testo. Questo scritto è
qualcos’altro. Un tentativo concreto
di dar conto del modo in cui lavoro.
Quando ho scelto di far morire il
papa nell’attentato in Piazza San
Pietro, o di mettere John Wayne alla
Casa Bianca, non volevo soltanto
scioccare il lettore con una narrazione ucronica à la Robert Harris. Mi
interessava proporre un punto di
vista altro sulla Storia. In particolare, sulla storia del nostro Paese
martoriato.
Cambiare prospettiva, lasciarsi
sorprendere dall’immaginazione, è
un tentativo di stravolgere il noto
per tentare di leggere in profondità
le questioni che la storiografia e la
giurisprudenza lasciano spalancate.
Non è compito di scrive romanzi
raccontare la verità. Ma è compito
di chi sceglie di prendersi cura della
memoria non lasciarla appassire.
Stimolare, con l’invenzione, la riflessione periodica sul Paese deteriore,
sul suo lato oscuro.
Per fare ciò, per non lasciare che il
passato si sfaldi, occorre studiarlo
a fondo.
Durante la stesura del romanzo,
sono moltissimi i libri che mi hanno
influenzato, ma ve ne sono alcuni,
senza i quali questa storia non
avrebbe lo stesso sapore.
Surf
ers
of
Varazze
®
www.surfvarazze.it
41
RECENSIONI
FOUR TET
“0181”
Text
Four Tet torna a sorpresa, con
un bel regalo: una compilation in
free download di rarità composte
da parte del genio Kieran Hebden
tra 1997 e 2001, gli inizi della sua
carriera, ma il sound è già maturo,
ed è un mix di elettronica cerebrale
e downtempo.
Lo avevamo lasciato non molti
mesi fa con il suo ultimo album
Pink, seguito dagli immancabili EP
di remix e compagnia bella. Così,
a sorpresa, ora il geniaccio Kieran
Hebden in arte Four Tet, se ne
esce a metà Gennaio sul suo sito e
sul suo soundcloud con una bella
novità.
Il ragazzo dal faccione sorridente
e i capelloni ha deciso di regalarci
una bellissima compilation, e noi
ringraziamo!
Posta il set, unicamente chiamato
0181, un’immagine copertina, mette
un link con download gratuito, e
nulla più. Non ci sono informazioni
sulle tracce contenute in esso, né
altro. Sappiamo solo che si tratta di
musica prodotta da Four Tet in un
arco di tempo compreso tra il 1997
e il 2001, ed assemblata nel 2012
per formare 0181.
Una compilation di rarità risalenti
ad un periodo vicino agli inizi della
42
carriera di Four Tet, e anche prima:
nel 1997 Hebden aveva solo 19
anni e il suo esordio con questo
pseudonimo, destinato a recitare
un ruolo fondamentale nella
musica elettronica “intelligente”
negli anni a venire, risale all’anno
successivo, il ‘98, con l’EP
“Thirtysixtwentyfive” a cui seguirà
l’album “Dialogue” nel ‘99. Siamo
dunque proprio agli albori della
sua carriera, e il sound di questa
compilation possiamo definirlo
tranquillamente già maturo e di
stampo marcatamente “Hebdiano”,
perchè sono già riconoscibili le
strutture e le sonorità che hanno
fatto grande la sua musica.
Il Four Tet delle origini non può
che essere già votato all’elettronica
cerebrale e a strutture che saranno
sviluppate appieno nel proseguo
della sua carriera (soprattutto
tra i minuti 8 e 13), ma le rarità di
0181 evidenziano come questo
orientamento si manifesti solo in
maniera marginale, mostrandoci
invece un Hebden che guarda
maggiormente alla musica più
tradizionalmente downtempo,
caratterizzata da ritmi-atmosferebattute più rallentate, delicate,
cadenzate, con spunti jazzistici
(minuto 20) o chitarristici. Nel
complesso siamo già su alti livelli,
non pensiate che si tratti di scarti o
di materiale di poco conto!
Potete trovare il set, che si estende
per 38 minuti e spiccioli, sul suo
Soundcloud o su iTunes, nell’attesa
anche della già annunciata uscita su
vinile che farà felici gli appassionati.
Sarà stata la solita operazione di
marketing monta-hype? A dire
il vero non mi interessa, qui c’è
dell’ottima musica che possiamo
goderci liberamente, quindi enjoy!
Davide Siri
GLI ALTRI
“Fondamenta Strutture Argine”
Taxi Driver/Dreamin Gorilla/
QSQDR/Savona Sotterranea/Rude/
Bus Stop
Per chi negli anni novanta ha
sudato, pogato sotto il palco e
gridato in cameretta ascoltando
Frammenti, By Any Means,
Sottopressione e tanti altri gruppi
italiani di hardcore, avete tra le
mani il lavoro definitivo, un disco
che avreste voluto sentire in
quell’epoca.
Gli Altri sono un giovane gruppo
di Savona, molto talentuoso e
picchiano come fabbri. La loro
musica è un ponte fra punk ed
hardcore, con un gusto fortemente
anni novanta. Eppure questi
ragazzi ci sono nati nei novanta
o giù di lì, non dovrebbero aver
sentito certi dischi. Ed invece
Gli Altri chiamano a cantare nel
loro disco Roberto Ceruti, storico
cantante degli Affranti, che a
Savona hanno portato avanti per
anni l’hardcore, totemici. Questo è
l’hardcore, una musica che sfoga
la rabbia, che rompe muri, e non
ha età, né confini. I testi de Gli
Altri sono surreali, grida silenziose
su astronavi d’asfalto e merda,
poiché l’hardcore racconta la
43
realtà in maniera sfumata, ma può
anche essere un macigno. Ci sono
gruppi come gli Indigesti, come gli
Affanti appunto, che descrivono
il nostro mondo in maniera iper
reale, accumulando sensazioni ed
emozioni in una maniera catartica.
Fondamenta Strutture Argine
è un disco che crea immagini e
fotografie di vita notevoli, ribellioni
biologiche, impotenza e disagio
quotidiano, perché chi sente male
deve gridare. E questo cd gronda
di vita e di grida, di voglia di uscire
dalla gabbia. A Savona ci sono le
gabbie,si chiamano strade, e io
devo rendere omaggio a questa
città, almeno per quanto riguarda
la musica, perché gruppi come
Gli Altri, come i Dsa Commando,
come gli Uguaglianza (non proprio
di Savona), Affranti e Risonanze
hanno creato non una scena ma
un’urgenza di comunicare, di dire
la propria. Questo è un disco
fantastico, commovente per come
riesce a forgiare un passaggio tra
epoche diverse, ma stessa rabbia.
Lo senti dall’inizio alla fine, e ci vedi
tante facce, tante situazioni, tante
lotte. Perché se dei ragazzi fanno
dischi come questo, lo mettono
in free download, e soprattutto
portano avanti una logica DIY e
libertà di pensiero, allora l’hardcore
non morirà mai. Al di là delle pose
e della violenza di certe scene. Gli
Altri sono una scelta, che fa chi non
vuole rimanere passivo, chi vuol
piangere ma anche ridere di fronte
ad una pozzanghera nell’ennesima
giornata di merda e asfalto. Perché
a noi il culo ci rode ancora.
44
Massimo Argo
TOKYO SEX DESTRUCTION
“Sagittarius”
Bcore Disc
Dopo tre anni in tour, e dopo
diversi cambi di formazione
tornano i fantastici Tokyo Sex
Destruction, sublimi fautori del
Soul Rock. Sagittarius è il disco
della loro conferma per chi era
ancora scettico.
È un’opera che non ti fa mai
stare fermo e penso che sia il
loro miglior disco di gran lunga.
La loro consueta energia qui si
sublima, arrivando ad apici mai
raggiunti. Sagittarius è la perfetta
combinazione tra il soul di Detroit
e il latin soul di New York sponda
Fania. In tutti gli 11 pezzi i Tokyo
sprigionano energia e passione
sporca, insomma vera soul music.
Chi li ha visti dal vivo sa che sono
una macchina da festa, e qui sotto
la guida di Fernando Pardo tirano
fuori il meglio. Un disco fresco,
potente ed additivo. Davvero
additivo. Alla sesta prova su lunga
distanza, i Tokyo Sex Destruction
si confermano nell’olimpo dei
gruppi che fanno muovere il culo a
signorine e signorini. Mani in alto e
via con la festa, il red soul continua
!!!
Massimo Argo
ERIC FUENTES
“Copper And Gold”
“Dasvidanija”
Bcore Disc
DreaminGorilla Rec
Pianoforte e voce. E a volte una
chitarra. Attitudine hardcore e
voglia di dimostrare che anche in
tempi più o meno moderni si può
fare un disco come ai tempi dei
crooners.
Scrivere una recensione è già più
difficile di quel che possa sembrare,
tutto si complica poi se nel mirino
finisce un gruppo con cui condividi
la stessa città d’origine. Voci, note e
rumori diventano volti, caratteri e
sagome che hai visto calpestare le
tue stesse strade per anni. Separare
il livello di giudizio dell’ascoltatore
nativo dall’ottica in scala nazionale
non è semplice, soprattutto se si
parla di un gruppo, come iVenus,
con cui è difficile condividere spazio
vitale senza creare un rapporto
emotivo di qualsiasi sorta.
Tutto ciò ce lo propone Eric
Fuentes, ex dei The Unfinished
Sympathy, che dal 1997 ha
intrapreso una fruttuosa carriera
solista, accompagnato al piano da
Bernat Sanchez. Ed è apertamente
magia, il feeling di questo album
è incredibile, è qualcosa che
appare in controluce, un sogno
probabilmente. Ascoltando fra le
righe, si può ben capire che è un
disco fortemente pop, con intrecci
sonori e canori alla Prefab Sprout.
Altra caratteristica di questo
fenomenale disco è la possanza
quasi fisica della musica di Eric e
Bernat. Il piano è pestato, la voce
è calda e vibrante, per un insieme
davvero inedito e magnifico. Dal
vivo si avranno anche altri musicisti
sul palco, come Joan Thelorious
dei nostri tanto amati Tokyo Sex
Destruction.
Passione e ricercatezza, per uno dei
dischi più belli della Bcore, che ha
un catalogo eccezionale.
Massimo Argo
IVENUS
Attivi sul territorio ligure dall’età
della pietra, il loro debutto di
un paio di anni fa, Tanz!, sapeva
ancora molto di ‘fatto in casa’,
ma conteneva già una quantità
notevole di singoli irresistibili, che
li aveva sbalzati in un tour biennale
in cui si sono trovati a condividere
il palco con alcuni dei nomi più
altisonanti della scena italica.
Piacioni, spettinatori ammiccanti
e volutamente poco raffinati (anzi,
piuttosto tendenti al trash) volano
intorno a quel pop più teatrale e
rumoroso, supportato però, più di
quanto lascino intendere, da un
ABC implicito di quanto successo
in Italia negli ultimi anni in ambito
musicale, dal baby building al che
cos’hai tu da brillare tanto e l’occhio
nero con la matita blu.
Per chi già li conosce, Dasvidanija
45
non cambia troppo le carte
in tavola rispetto al passato:
si parla sempre di un assetto
strumentale dei più classicamente
rock, arricchito da una tastiera
effettata, pestata con foga, che
prende spesso il sopravvento su
tutto, lasciandosi piegare solo dai
capricci vocali del frontman Cash
nella Pelliccia. Tanti riverberi, tanti
synth, tanto pop, tanto casino: il
rischio di suonare come un vecchio
incubo anni ‘80 è sempre dietro
l’angolo, ma tutto sembra fatto per
far muovere e ballare o quanto
meno battere un po’ il piedino. I
testi, sorprendentemente arguti,
abbozzano ritratti agrodolci di
gioie passate o auspicate, disagi
e disastri emotivi con picchi di
menefottismo notevoli, misantropia
e amore globale condividono lo
stesso letto.
Se un elemento di costanza
c’è, è sicuramente la ricerca
dell’orecchiabilità più immediata e
coinvolgente (una sola eccezione:
la title-track, ballata lenta e docile
nei suoni, ma non nel testo). Ci
sono dei momenti in cui il gruppo
ci riesce discretamente bene (la
blasfema The great capitombolo, il
tripudio di synth di scuola i Cani
Settembre, il Fiumani & Dylan Dog
di Mangianastri), altri in cui qualche
perplessità può essere più che
lecita (C’est la vie mon amie, in cui la
musica leggera tende a diventare
troppo leggera, e Ventricoli,
mancante quel qualcosa in più
che mantenga viva l’attenzione).
Spicca sul resto, scandendo il ritmo
46
generale del disco, l’irresistibile
trittico P.O.P, Grazielle e Rembrandt:
giocate su ritmi martellanti e ciclici,
tutte e tre si scagliano in faccia
all’ascoltatore, avvinghiandolo in
una presa ermetica da cui è difficile
sottrarsi.
Per capire del tutto iVenus,
probabilmente, bisogna andarli
a cercare in qualche concerto,
quando ci si trova davanti a orde
in delirio, crowd-surfing ad ogni
ritornello, bassisti che si contorcono
a piedi nudi e caramelle gettate a
grappoli contro gli aficionados in
prima fila. Questo, però, si rivela
sempre un’arma a doppio taglio,
raramente impugnata dalla parte
del manico in un mondo in cui la
carta che canta resta pur sempre
il disco. Se immerso nel contesto
nazionale e spogliato di tutte le
associazioni visive e sonore raccolte
nei live, Dasvidanija rischia di fare
la figura del Davide: ha ancora le
spalle strette e le gambe deboli,
avrebbe forse bisogno di un po’ di
esercizio mirato per rinforzarsi qua
e là, ma potrebbe lo stesso battere
il suo Golia se decidesse di giocare
d’astuzia.
Nicolas Gasco
THE BARBACANS
No Hits For The Kids
Boss Hoss Records
A qualcuno può interessare qual’è
l’album che gira in ultra heavy
rotation sul mio stereo di casa ed in
quello del negozio in cui lavoro?
Lo so, lo so, non ve ne può fregare
di meno ma, che ci volete fare, la
recensione la faccio io e quindi vi
tocca saperlo lo stesso, l’album in
oggetto (dei miei ascolti e della mia
recensione) è questo splendido No
Hits For The Kids, secondo album di
una band in crescita esponenziale
come i Barbacans.
Ebbi la fortuna, sempre per questa
mirabile e-zine di recensire anche
il precedente God Save The Fuzz
(potreste immaginare titolo più
bello per un album di garage?!?) e
dissi che in quel caso il disco era
molto bello ma che gli mancava un
pezzo forte che lo stagliasse dalle
altre produzioni di genere; ebbene
dissi una delle mie proverbiali
minchiate perché da quel giorno
“Kick The Children” e “Turn Away”
entreranno di forza nelle mie scelte
di negletto dj di provincia.
A distanza di ben 4 anni (era
proprio necessario farci attendere
tanto?) i nostri tornano alla carica
con una raccolta di canzoni ancor
più bella della precedente e
costringendomi a rimodellare la
mia playlist annuale; sono conscio
che al lettore non potrà importar
molto neppure di questo ma io alla
47
mia playlist dedico ragionamenti
approfonditi e se, poi, a dicembre
inoltrato i tipi della Boss Hoss mi
mandano un album così bello, mi
costringono a violentare le mie
convinzioni più radicate, e che si fa
così tra persone per bene?
Partendo dall’inciso che tutti, e
dico tutti, i pezzi di questo disco
sono molto belli vi citerò quelli
che hanno riscontrato la mia
sperticata preferenza; si parte
con 10000 promises che, sorretta
da un grandissimo lavoro di voxx,
esplode in un fragoroso pezzo di
garage-punk eighties style degno
dei migliori Miracle Workers,
Kind Of The Blue Beat è un breve
strumentale molto psych e
molto veloce nel quale sembra di
ascoltare i Plasticland con una tigre
nel motore, Fatiscenza Violenta è
un brano adatto a chi pensa che
il garage non renda se cantato in
italiano, pensate, basta soltanto
rivisitare la lezione del nostro
sixties-beat più degenere (semplice
no?), Istato Itagliano è mettere in
musica uno stato di ubriachezza
molesta.
Breve sosta, biretta fresca, e si
ricomincia: He’s Gone è il mio pezzo
preferito, è la tipica canzone in cui
tutto funziona alla perfezione dagli
intarsi fra gli strumenti al ritornello,
qui il garage si fa quasi epico, senza
tralasciare una vena di psichedelica
malinconia, in poche parole una
BOMBA, Hug Hug è molto wild o
molto punk e quando compare
un’armonica killer fa letteralmente
sognare, chiude il cerchio la breve
suite oppiacea di Tahiti With You.
48
Concludendo No Hits For The
Kids dura poco meno di mezz’ora
(nessun album di vero rock’n’roll
dovrebbe durare di più) ed è come
fare un giro nell’orgasmatron
che compare nel film dell’ancora
giovane e non ancora tedioso
Woody Allen intitolato “Il
Dormiglione”; se non lo avete
ancora visto (il fim) fate in modo di
vederlo e se non lo avete ancora
ascoltato (l’album) vedete di
ascoltarlo da qui a breve perché
cambierà le vostre vite in (molto)
meglio.
Per quanto riguarda il giro
nell’orgasmatron, vedete di
organizzarvi...
Il Santo
WOODEN SHJIPS
“Back To Land”
Thrill Jockey Records
Ripley Johnson e Omar Ahsanuddin
si sono trasferiti nell’Oregon,
lasciando San Francisco, patria,
teatro e habitat naturale di tutte
le produzioni targate Wooden
Shjips, nel pieno stile di una neopsichedelia californiana che più di
così non si può.
L’album West aveva molti simboli
che legavano indissolubilmente la
musica all’ambientazione, dal nome
alla copertina del disco (mi sembra
di ricordare un ponte...); anche
nella cover art di Back To Land
ci sono dei richiami, ma stavolta
alla storia del genere, perchè la
copertina ricorda un po’ quella della
pietra miliare “The Psychedelic
Sounds Of The 13th Floor
Elevators” e richiama in generale il
rock psichedelico 60s-70s da cui la
band attinge la propria ispirazione
e attualizza al presente in forma
più fruibile per un’audience sempre
maggiore.
Si parlava del trasferimento,
ebbene questo è il primo
album di Ripley e soci che ha
un’ambientazione diversa da
S.Francisco, e la sensazione da
parte della band stessa è che la
componente ambientale abbia
giocato un ruolo e un’influenza
nella stesura di queste nuove otto
tracce.
Senza abbandonare l’immediatezza
e l’energia della loro matrice
psichedelica, caratteristiche
principali di West, i Wooden Shjips
cercano in alcune tracce di ampliare
i propri orizzonti ed arricchire la
loro musica ponendo maggior
attenzione anche alla narrazione
e alla componente melodica.
A conferma di ciò, accanto alle
usuali caratteristiche distintive
del suono della band, incentrato
sull’accoppiata chitarra-tastiere,
in alcuni tratti compare anche la
chitarra acustica.
Ma ci sono anche varie tracce con
il loro forte marchio di fabbrica,
con riff distorti e un ritmo vivace
come base, su cui chitarre e tastiere
ricamano e ondeggiano tra primo e
secondo piano, in alternanza.
In definitiva, “Back To Land” è un
album dalle due facce: da una parte
abbiamo la continuazione di “West”
e la confidenza nell’espressione
di tratti distintivi già consolidati
(soprattutto nella prima parte);
dall’altra abbiamo qualche novità,
costituita da tratti più melodici
e una maggiore ricerca della
componente emozionale.
Questa prima tendenza, trova
subito espressione partendo
dall’iniziale title-track, perchè
la prima impressione è quella
di avere tra le mani un lato C di
West, costituendo una diretta
connessione tra i due lavori. A
seguire troviamo l’incalzante
ritmo di Ruins, e dopo 30 secondi
sei già ad ondeggiare e ripetere
parabarabara-parabarabara (sì,
lo so cosa pensate, ma IYEzine
purtroppo non prende un assegno
mensile per farmi da assistenza
sociale).
Sempre parlando di brani di forte
impatto, troviamo la potenza di
Ghouls e Other Stars e la velocità di
In The Roses.
D’altra parte, riguardo al secondo
aspetto evidenziato poco sopra,
troviamo anche tracce più lente
e introspettive. Secondo me la
traccia più significativa è These
Shadows, è quella che emerge
maggiormente nel lotto perchè
esula dal tradizionale stampo
Shjips, con chitarra acustica, una
maggiore tendenza narrativa, un
suono avvolgente e curato, inserti
chitarristici un po’ più dilatati
rispetto al sempre più usuale
riffetto-ritornello, un ritmo più
rallentato ma che riesce sempre a
49
coinvolgere trasmettendo nuove
sensazioni ed emozioni.
L’altro brano in cui è maggiormente
evidente questa novità è la traccia
che chiude ottimamente la raccolta,
Everybody Knows, che conosce una
nota malinconica praticamente
senza precedenti in casa Shjips,
un po’ come se un rampante Roky
Erickson invitasse a un party i
Codeine e li facesse gonfiare come
canotti cercando anche di farli
prendere bene (va beh, è un falso
storico, traslate mentalmente lo
slowcore un paio di decenni prima
per ritrovarvi a tale party).
Servants è un altro ottimo
pezzo, che costituisce un po’
un compromesso tra le due
componenti e amalgama queste
due tendenze per rendere il
risultato complessivo un po’ più
fluido.
particolarità.
Per cui, sebbene ammetto che il
primo ascolto abbia generato in me
un moderato entusiasmo, (forse
hanno avuto un certo ruolo anche
le aspettative per questo nuovo
lavoro), soprattutto nel sentire
le somiglianze con il precedente,
in seguito ripercorrendo e
analizzando meglio “Back To
Land”, mi sono accorto anche delle
differenze e delle migliorie, perchè
la band californiana ha ampliato il
proprio campionario acquisendo
nuovi tratti distintivi.
Perciò mi viene da dire che anche
questa prova sia stata superata
con successo dai Wooden Shjips,
confermandoli tra le punte di
diamante del nuovo decennio
psichedelico.
In alcuni tratti ti viene quasi il
dubbio che la premiata ditta Ripley
Johnson & soci si limiti quasi a
svolgere il proprio compito per
consolidare la posizione di ascesa
raggiunta col precedente album,
senza variare troppo il copione o
cercare novità particolari, poi però
pensi anche che in fondo questo è il
loro marchio di fabbrica, questo è il
suono degli Shjips, e se la formula
funziona, i pezzi sono coinvolgenti
ed energici, per carità va bene
così, perchè poi ci si affeziona
al suono caratteristico di una
band. Ma questo sarebbe molto
limitativo per descrivere “Back To
Land”, un album certamente ricco
di spunti interessanti e delle sue
GAZEBO PENGUINS
“Raudo”
50
Davide Siri
To Lose La Track
Dopo “Legna” del 2011 e lo split
con I Cani del 2012, i tre Gazebo
Penguins (Capra, Sollo, Piter)
ritornano, insieme all’ormai
collaudata e sempre più attenta To
Lose La Track, con Raudo, ovvero
il loro terzo lavoro lungo. L’album,
composto da dieci brani, continua
nel solco del precedente, regalando
nuove chitarre esplosive, una
maggiore maturità dal punto di
vista compositivo e, ovviamente,
una nuova palata di emozioni.
E’ Finito Il Caffè, tra chitarre
scalpitanti, melodie accattivanti e
un testo agrodolce, apre il disco
travolgendo con la sua forza
emotiva, mentre Casa Dei Miei,
schiacciando sull’acceleratore,
disorienta con il suo raccontare. Le
tempeste di chitarra di Difetto e il
nervosismo di Domani E’ Gennaio
(dissolto solo da quell’amaro “le
rate di una libertà che dura un
anno, ti prego non mi dire più
domani è un altro giorno, i lunedì
di maggio sono così da otto anni”)
cedono spazio all’altrettanto
rabbiosa e disillusa Ogni Scelta E’
In Perdita (“non solo ogni lasciata
è persa, è strano ma vedrai, che
ogni scelta è in perdita”) e alla
malinconica tranquillità (per modo
di dire) della breve Correggio.
L’energico sfrecciare di Trasloco,
infine, seguita da una veloce e
graffiante Mio Nonno, apre alla
granitica Non Morirò, al suo “se
avessi avuto un’ora di più o anche
solo un minuto, non avrei fatto
nulla di diverso” e al catartico
gridare “oggi mi sento piuttosto
bene, uo uo uo” della conclusiva
Piuttosto Bene.
Questo terzo album dei Gazebo
Penguins pare avere tutte le carte
in regola per bissare il successo del
precedente “Legna”. Forse i testi
sono più scarni e semplici, ma le
emozioni continuano ad essere
trasmesse con intensità, le melodie
danno l’impressione che ci sia stato
un ottimo lavoro alle spalle e i
suoni esplodono nell’aria. Un disco
sincero e fatto a regola d’arte: non
potrà che conquistarvi.
Francesco Cerisola
ARTISTI VARI
“Saoco! - Bomba, Plena And The
Roots Of Salsa In Puerto Rico”
Vampisoul
Il saoco era una bevanda usata
come tonico dagli schiavi a
Cuba, un mix di cocco e rum,
rinfrescante e rinvigorente.
Proprio come questa compilation
di salsa, secondo episodio di
un’esplorazione cominciata l’anno
scorso.
Le coordinate sono intorno agli
anni ‘50 e ‘60 del 1900, luogo
Puerto Rico, sorella minore di Cuba
per quanto riguarda la salsa e i
suoi progenitori. Nel primo volume
ci si è maggiormente focalizzati
sulla bomba e sulla plena, due
antenate della salsa, mentre
qui andiamo maggiormente nei
51
territori della guaracha, rumba,
mambo, merengue e della musica
tradizionale contadina. Puerto Rico
ha sempre avuto un’ottima scena
musicale, essendo stata influenzata
dai gruppi cubani che suonavano a
Puerto Rico.
Un’altra particolarità di questa
musica è che, principalmente,
veniva registrata a New York, dove
molti emigravano; uno dei generi
che possiamo ascoltare in questo
cd è la guaracha, una musica molto
radicata a Puerto Rico, poiché arrivò
insieme alle compagnie teatrali
cubane dal 1910. La guaracha è
considerata un’asse portante della
salsa, ma il repertorio di questi
gruppi antesignani era composto
da molti stili. Dopo la liberazione
di Cuba da parte di Fidel Castro e il
conseguente embargo, Cuba perde
la sua dominazione musicale nei
Caraibi, a vantaggio di Puerto Rico
e New York. I gruppi della metà
degli anni sessanta fusero rumba,
charanga, pachanga e rock and
roll secondo il gusto dell’epoca,
e in ¡Saoco! ne abbiamo diverse
dimostrazioni. Si sente molto quindi
l’influenza di stili eterogenei, ma
la salsa di Puerto Rico mantiene
sempre una forte impronta,
tanto da diventare facilmente
riconoscibile, almeno ai più esperti.
Quest’epoca è stata il siglo de oro
della musica puertoricana e ha
partorito autentiche gemme, come
questi 28 pezzi d’argenteria. Qui si
può godere di un’autentica musica
latina, ancora non sottomessa al
gusto europeo o nordamericano. El
son è forte e potente, si snoda in un
52
amalgama di gioia e fisicità. Sudore
e sederi che ballano frenetici.
Massimo Argo
MUM
“Smilewound”
Morr Music
Morr Music è ormai da molto
tempo un marchio di fabbrica.
L’etichetta berlinese si è infatti
distinta da molti anni per un genere
di elettronica minimale e delle sue
sfumature da diventarne quasi un
sinonimo.
Non stupisce allora che i Mum
gravitino intorno a questa scena,
dato che l’elettronica è alla base
di questo gruppo islandese che
mescola beat, strumenti classici,
sintetizzatori, tastiere giocattolo per
suoni Arcade (in When Girls Collide
sembra di giocare ad un gioco in un
vecchio computer), con un risultato
finale incredibilmente melodico,
equilibrato, dolce e raffinato.
Il tutto è condito da una voce
eterea, cullante, elfica, sentimentale
e ipnotica: Slow Down è una
canzone d’amore che vi farà venire
la voglia di essere innamorati.
One Smmmmile vi farà passare
dalle atmosfere rade e dilatate, dai
paesaggi minimali e da una natura
quasi immobile caratteristica della
prima parte dell’album al ritmo dei
mercati d’oriente, alla frenesia dei
suk e dei mille bazar.
La voce lieve delle gemelle Gyða
and Kristín Valtýsdóttir vi cullerà
comunque per tutto il disco e, come
per un Ulisse contemporaneo, sarà
estremamente difficile resistere
all’attrazione magnetica e inconscia
di questo canto (Underwater Snow e
Time To Scream And Shout su tutte).
Ciliegina pop sulla squisita torta,
la presenza di Kylie Minogue in
Whistle.
Gianluca Camogli
OLIVER SCHORIES
“Exit”
Der Turnbeutel
Oliver Schories, chiamato alla
riconferma col suo sophomore
album Exit continua sullo stesso
asse del suo ottimo esordio. Col
suo crossover di House e Techno,
riesce a creare elettronica ipnotica
ed evocativa dalla sensibilità
pop. “Rising star” dell’elettronica
tedesca?
Il producer tedesco Oliver
Schories è una piacevole vecchia
(non più di tanto) conoscenza
di IYEzine, poiché lo ritroviamo,
andando indietro di un anno, con
il suo album di esordio dal titolo
complicatissimo http://www.
iyezine.com/recensioni/1699-oliverschories-herzensangelegenheit.
htm Herzensangelegenheit. Ora
Schories, divenuto ormai dj e
producer affermato, è chiamato
alla consacrazione tra i grandi con
questa seconda prova su lunga
distanza, dal titolo Exit.
Dico ciò riguardo ad una possibile
consacrazione anche perchè si era
generata in me grande aspettativa
per questo album, giacchè la
precedente prova aveva messo in
luce grandi potenzialità da parte
del tedesco...e un po’ l’aspettativa ti
fotte.
Ad essere sincero non riesco così
bene a capire se questa “prova di
maturità”, come spesso si dice,
sia stata centrata in pieno o sia da
rimandare ai giorni che verranno,
anche perchè, eccezioni a parte,
di solito sono tre indizi a fare una
prova...ad ogni modo, so benissimo
che questo qui non è il punto
cruciale, sono fondamentalmente
chiacchiere, il punto è il disco, e la
discussione la palleggio a voi che lo
ascolterete.
Schories si pone in
logica continuazione di
“Herzensangelegenheit” (e non
fatemelo dire di nuovo!), ne
riprende gli schemi e ne amplia
l’influenza pop, cerca di pulire
maggiormente il suono ricercando
l’equilibrio più per sottrazione
che per addizione. L’idea di base
è, inoltre, a mio parere diversa
tra i due album: questo nuovo
lavoro è meno intenso dal punto
di vista ritmico, qui si va a cercare
di muovere più la mente che
il corpo (60% contro 40% ?),
mentre l’esordio forse ribaltava le
proporzioni, e infine Exit compie
un leggero passo verso la “hit” di
sensibilità maggiormente pop, nel
senso più generale del termine.
Le sonorità e di conseguenza le
sensazioni che riescono a creare
questi brani sono l’uscita di
53
sicurezza che ci offre il tedesco,
una piccola oasi nel quotidiano.
Questo è Exit, una porta che se
appena socchiusa mostra già i caldi
raggi del sole di un luogo dove è
sempre estate. Nell’idea del suo
autore, Exit ha la funzione di creare
un’atmosfera evocativa, un locus
amoenus in musica, per il piacere
dell’ascoltatore più che per il club.
Col suo particolare crossover di
House e Techno, fatto di suoni
caldi e delicati, un ritmo sempre
misurato e mai portato a spingere
troppo, brani orecchiabili ma
non scontati, Schories ricerca
efficacemente il bilanciamento e la
quadratura del cerchio nel creare
elettronica ipnotica.
Mi piace molto pensare a Schories
come colui che può realizzare
quelle potenzialità che uno come
Kalkbrenner (Paul) non è riuscito
a realizzare pienamente (per
quanto ne abbia mostrato alcuni
abbaglianti sprazzi qua e là),
un po’ offuscato dal suo stesso
successo. Perchè per un certo verso
l’elettronica di Oliver si avvicina
abbastanza a quella di mr. Berlin
Calling, ma secondo me ci mette
più anima e più sfaccettature, per
quanto sia forse meno attenta
al ritmo. Il suono del nostro non
è ancora così ben confezionato
come quello di altri suoi colleghi
più esperti come il buon Paul, e
non ha ancora la raffinatezza nel
suono di un modello di riferimento
come può essere Pantha Du Prince,
per quanto facciano anche musica
diversa; però le idee e la capacità di
54
metterle in musica ci sono tutte, e
Schories ha tutte le carte in regola
per entrare tra i grandi.
Perciò sì, si può creare musica
elettronica che sia insieme
ricercata e orecchiabile, che sia
fruibile ma non risulti scontata
né “commerciale”, come insegna
questo ragazzo.
Dopo l’introduzione, ci troviamo
subito con l’orecchiabilità di Sunset,
una traccia di atmosfera molto
estiva, e quindi But Maybe che
parte ruvida ma presto diventa
dolcemente ammaliante. In seguito
le ipnotiche Get Me e Circles ci
ghermiscono, Go ha una struttura
simile a quella della precedente
But Maybe, e Another Day è una
delle tracce che ricordano forse
maggiormente il precedente album.
Il disco è molto lungo, abbiamo
appena superato la metà, in totale
Exit contiene più di un’ora e un
quarto di ottimi brani, tutti sempre
sui 6 minuti, ma l’ascolto non pesa
perchè Oliver ha questa capacità di
farci entrare presto in uno stato di
piacevole trasporto, ci fa muovere
interiormente con le stesse
frequenze e la stessa forma d’onda
della sua musica.
Non mi dilungo oltre a descrivere i
singoli brani, ma sappiate che sono
tutti da ascoltare dall’inizio alla fine,
e tutti hanno le loro sfaccettature
che li rendono interessanti e
gradevoli. Il tutto è riassumibile
con la frase che ci siamo detti
contemporaneamente io e
Massimo di IYE parlando del disco:
“ma senti che suoni!”.
Direi perciò che bisogna mettere
bene in chiaro che Oliver si
conferma un grande producer,
ed ora abbiamo le prove per
poterne parlare come “rising star”
dell’elettronica tedesca.
Buon ascolto!
Davide Siri
FINE BEFORE YOU CAME
“Come Fare A Non Tornare”
La Tempesta Dischi / Legno
Quando pochi giorni fa ho visto che
i Fine Before You Came avevano
pubblicato il loro nuovo disco ho
pensato “Olè, questa è la volta
buona che sbagliano”. Invece poi
l’ho messo su e l’ho ascoltato per
tre volte consecutive, rimanendo
totalmente spiazzato. Come Fare
A Non Tornare questo il nome
del lavoro, si compone di cinque
tracce cupissime dove, se i testi
continuano ad essere evocativi
e affascinanti come in passato,
alla voce gridata si sostituisce un
cantato lucidamente disilluso e alla
vena post hardcore/emo un post
rock/slow core soffocante.
“Battiamo i lividi per mantenerli
sempre viola, per ricordarci che san
fare ancora male” è così che si apre
Discutibile, la quale, avvolgendo
con le sue delicate chitarre che
lentamente crescono, ci sbatte
poi in faccia quell’amaro “noi
non sappiamo come fare a non
tornare”. Alcune Certezze, altrettanto
sofferta, ma accompagnata da
melodie più leggere e meno
soffocanti, ci tiene legati a sé con
con quel “la soluzione ai miei
problemi sembra sempre la causa
dei tuoi”, mentre Il Pranzo Che Verrà,
affondando in una scura voragine
di chitarre e sentimenti infranti,
viene rischiarata solo a metà da
un breve e pacato scorrere di note
malinconiche. Una Provocazione, più
decisa e tesa, corre veloce su quel
“come i bambini vorrei correggere
i disegni, finché non fan schifo, il
foglio si buca, e poi si convincon
che va bene così” per poi spegnersi
lentamente, lasciando in balia del
dolore più forte, quello causato
dalla conclusiva Dura: “niente di
tutto questo mi piace davvero, ma
so che la mia fortuna è averlo, cosa
vuoi che ti dica, vado avanti così
finché dura, passo dalle vittorie
alle sconfitte senza combattere
battaglia alcuna”.
Con questo nuovo lavoro i Fine
Before You Came, giunti ormai
a quasi quindici anni di attività,
aggiungono un’ulteriore tassello
al lungo processo di evoluzione
sonora che li ha contraddistinti.
Dall’emo/post hardcore al
post rock/slow core più scuro,
dall’inglese all’italiano, dalla voce
gridata a un cantato cupo e senza
più forze. Come Fare A Non Tornare
è un lavoro profondo, di quelli da
ascoltare tutto d’un fiato, in cui
perdersi insieme a tutti i propri
malesseri. Un disco importante,
di sicuro più del precedente, forse
anche dell’eccezionale “Sfortuna”.
Francesco Cerisola
55
THE ASSYRIANS
“The Assyrians”
Bored Youth Records
Chi ha la pazienza e la, non sempre,
buona sorte di leggere le mie
recensioni avrà, ormai da qualche
tempo, compreso quanto sia solito
aprire le mie righe con tediose
premesse.
Anche in questo caso, mie care
anime pie, la premessa è doverosa
in quanto la band in oggetto sta per
uscire con un nuovo album (la data
dovrebbe essere il 15 novembre
e l’etichetta la prestigiosa Foolica
Records) mentre il mini di cui sto
per parlarvi ha sulle spalle già
alcuni mesi.
Ma, il caso vuole, che gli Assyrians
abbiano suonato in agosto nella
nostra ridente cittadina e che, dopo
la loro più che lodevole esibizione,
si siano intrattenuti con lo “staff”
della nostra fanzine.
Durante il corso di questo
piacevolissimo incontro i
componenti del gruppo si sono
dimostrati persone molto socievoli
e disponibili ed inoltre hanno
gentilmente concesso questo
mini album alla nostra attenzione
dicendosi interessati ad un nostro
sindacabilissimo giudizio.
Ed eccomi qui, con una quarantina
di giorni di colpevole ritardo, a
parlarvi della quattro canzoni
d’esordio di questo mirabile
quartetto.
L’inizio è davvero stupefacente,
56
Moon happy monkeys and hope
maniac ape è un pezzo davvero
notevole tanto che il sottoscritto
lo giudica in modo inappellabile la
più bella pop song del 2013; avete
presente quando Alex in Arancia
meccanica, abbigliato in perfetto
stile ottocentesco, tenta, con
successo, di circuire due fanciulle
con tanto di gelato?
Dice loro di seguirlo nella sua
abitazione perché nel suo
stereo sentiranno un suono che
difficilmente potranno dimenticare
(abbiate pietà di me ma ora su
due piedi non ricordo l’esatta
descrizione).
Ebbene voi inserite questo
dischetto nel vostro lettore e
potrete provar le medesime
sensazioni, se poi come nel film
riuscirete anche a fare dell’ottimo
sesso a tre tanto di guadagnato,
vi dico solo che si è sui livelli dei
migliori Xtc,e gli Xtc sono fra i miei
gruppi preferiti di sempre.
Proseguendo si ascoltano altresì
la dolcissima My garden with
statues of Em che tanto ricorda
i pezzi magici che produceva
alcuni anni orsono la Sarah
Records, e non ditemi che non
conoscete la Sarah Records e che
nonostante ciò siete sopravvissuti
a questo triste mondo; Farewell
scarlet pimpernel dall’andamento
leggermente psychedelico e
dall’incidere beatlesiano o, dato
che si parlava di Xtc, in odor di
Dukes of Stratosphear, se non
conoscete neanche loro mi spiace
dirvelo ma questo triste mondo
vi ha definitivamente sconfitti,
per chiudere con Htrowyah atir
che oscilla tra i Beach Boys di “Pet
Sounds” e le ballate dei Kinks;
riuscite a immaginare qualcosa di
altrettanto allettante?
Inutile dirvi che la mia attesa
per l’album di cui parlavo ad
inizio recensione sia a dir poco
febbrile perché, se tanto mi da
tanto,entrerà di prepotenza nel
novero dei miei dischi preferiti di
questa annata.
Il Santo
THE MORLOCKS
“Submerged Alive”
Epitaph Records
Ho visto piuttosto recentemente
Leighton Koizumi, era impegnato
(in verità piuttosto brillantemente)
nel perpetrare la leggenda di
due gruppi nei quali ha militato: i
Morlocks , oggetto di queste righe,
e i Gravedigger V.
L’ho visto molto bene, persino
rubicondo, con quel po’ di pancetta
che fa tanto salute e ciò ha riempito
di gioia il mio cuoricino di garagemaniac. Lo stesso non poteva
certo dirsi nell’anno d’uscita di
questo fantasmagorico live, il 1987,
il nostro infatti, era impegnato
in un impari tenzone con un
mostro fottutamente potente
come l’eroina, tanto che da lì a
poco la stampa specializzata lo
diede definitivamente per perso
intonando un, fortunatamente
prematuro, de profundis.
Ma torniamo a Submerged Alive,
che a 26 anni dalla sua uscita (lo
licenziò la Epitaph di Brett Gurewitz,
per quanto possa sembrare
retrospettivamente impossibile)
torna a disposizione di tutte le
genti di buon gusto grazie alla
lungimiranza dei tipi di Area Pirata,
che non smettono mai di stupire i
loro, spero sempre più numerosi,
adepti.
Le danze vengono aperte dal blues
strascicato e psichedelico di Get
Out Of My Life Woman, cover di un
classico di Al Touissant; si prosegue
con il garage criptico e ultracompresso di She’s My Fix, suono
che è un vero e proprio marchio
di fabbrica della band; spiccano
inoltre altre due brillanti riprosizioni
quella di Leavin’ Home dei Birds
e quella di Body Not Your Soul di
Cuby & the Blizzards nelle quali
emerge un suono garage-punk più
“classico”, inteso ovviamente nella
sua accezione più virtuosa.
Un capitolo a parte lo meritano
anche l’inquietudine esistenziale
della quale è intrisa Different World
nella quale sembra di ascoltare
una versione ancor più malata e
viziosa di Mick Jagger e, soprattutto,
la lenta e struggente My Friend
The Bird ammantata di magica
melanconia stoogesiana.
Come ben si evince da queste mie
righe con questo disco siamo di
fronte ad un’incisione che, senza
dubbio alcuno, può definirsi
epocale tanto che mi sento in
diritto di buttar lì un paragone:
dirsi appassionati di garage e non
conoscere questo album è come
affermare di essere tifosi del
57
Boca Juniors e non saper chi sia
Diego Armando Maradona, una
contraddizione ed allo stesso tempo
un peccato imperdonabile.
Se ai tempi in cui questo live uscì
foste nella risicata schiera di chi lo
acquistò oggi avete fra le mani un
oggetto di grande valore, non solo
intrinseco ma anche economico,
per tutti quelli che, vuoi per ragioni
anagrafiche vuoi per qualsivoglia
altro motivo, non lo fecero ecco
una splendida occasione per
colmare una preoccupante lacuna,
non tutti i giorni capita di poter
mettere le mani si di un capolavoro
e Submerged Alive è uno dei non
moltissimi dischi per i quali il
termine capolavoro può essere
usato senza temere di essere
smentiti.
P.S.: Questa ristampa è disponibile
nella versione cd digipack ed
anche in quella, strepitosa, in vinile
colorato e numerato a mano. Fossi
in voi non avrei dubbi su quale dei
due formati preferire.
Il Santo
5MDR
“La Prospettiva Del Conflitto”
Varie etichette
Un disco di punk rock incazzato,
fatto da ragazzi appassionati per
ragazzi poganti sotto al palco.
Tornano i savonesi 5MDR, dopo
il full length “Via Di Qua” del 2010
e l’ep “Stato Di Allerta” del 2008. Il
loro punk rock è molto carico, fatto
di scorribande in territorio hc, con
58
una forte base oi ! . I 5MDR sono
tra i migliori esponenti italiani di
quella forte ed impetuosa corrente
sotterranea che parte dall’ oi! Punk
inglese, infatti in questo disco vi è la
cover di Riot Squad dei Cock Sparrer,
passa per la Savona dei Klasse
Kriminale e dei Cervelli Stanki, e
sfocia in gruppi come Uguaglianza,
5MDR, e tanti altri. Il minimo
comune denominatore è la rabbia,
quel rodere il culo che fa gridare
in mezzo a questa indifferenza
da scaffale. La Prospettiva Del
Conflitto ha dei gran testi ed una
grande potenza, con una carica
inesauribile. Sinceramente sono
davvero contento che dei ragazzi
continuino a fare questa musica,
che fuori moda non ci andrà mai,
poiché non è mai stata fashion.
Sarò di parte ma i 5MDR sono
davvero molto ma molto bravi. Il
disco è scaricabile gratuitamente,
poiché una importante prospettiva
del conflitto è quella di liberare la
musica, almeno quella onesta e di
qualità.
Massimo Argo
MASSIMO VOLUME
“Aspettando I Barbari “
La Tempesta Dischi
A tre anni di distanza dall’ottimo
“Cattive Abitudini” e a due dallo
split con i Bachi Da Pietra, i
Massimo Volume (Emidio Clementi,
Vittoria Burattini, Stefano Pilia,
Egle Sommacal), formazione tra
le più influenti all’interno della
scena musicale indipendente
italiana, mettono su disco dieci
nuovi pezzi. Il nuovo lavoro,
Aspettando I Barbari, abbandona
quasi completamente il carattere
relativamente morbido del
precedente disco, preferendo
solcare mari decisamente più
nervosi, elettrici e scuri.
La nera spina dorsale su cui si
struttura Dio Delle Zecche, apre
l’album crescendo e ferendo,
affondando il colpo di grazia solo
quando la voce si fa urlo e le parole
si inchiodano in testa, mentre La
Cena, a seguire, tra velocità e ritmi
incalzanti, si rivela travolgente con
le sue melodie venate di malessere.
Aspettando I Barbari, sprofondando
nelle tenebre, disegna ombre
arrese su echi di chitarra e dense
note di basso, lasciando che a
proseguire siano l’ossessivo monito
angosciante “ricordati di Chesnutt”
di Vic Chesnutt e il “vi piaccia o
no” estremamente determinato
di Dymaxion Song (brano ispirato
alla vita di Buckminster Fuller). La
notte, tesa e graffiante, si concentra
sul contrapporre le storie (in
evoluzione) di molte persone con lo
statico aspettare del protagonista,
disintegrandosi di fronte al tellurico
e violento vibrare dell’allucinata
Compound e all’intensità su più
strati della malinconica Silvia
Camagni.
Il Nemico Avanza, infine, tra affilate
parole che riportano a scenari di
profonda violenza, introduce l’addio
(che permette di sciogliere tutte le
tensioni) della conclusiva Da Dove
Sono Stato.
Con questo nuovo disco i Massimo
Volume mescolano molto bene le
carte, riorganizzando tutto il loro
mondo sonoro e riproponendolo
in forma differente, ripescando
l’energia elettrica degli anni ‘90 e
aggiungendo inaspettati inserti
di elettronica, raccontando
(ovviamente) storie nuove, ma
non abbandonando gli umori
che li caratterizzano da sempre.
Aspettando I Barbari è un disco
cupo e oppressivo, energico e
rabbioso, denso e affascinante.
A vent’anni dal loro esordio,
dimostrano di essere ancora sul
pezzo. Un album di qualità.
Francesco Cerisola
.
SALMO
“Midnite”
Tanta Roba
Lasciate perdere etichette, generi e
cazzate testosteroniche da rapper
adolescenti. Aprite le casse a palla,
lasciate che questo meteorite di
apocalisse entri nelle vostre stanze,
corrompa il vostro cervello ed
ascoltate il racconto della vostra
morte. Salmo ha rabbia ed urgenza
in stile hardcore punk, viene dal
metal rap ed ha inventato un
qualcosa di nuovo, un modo di
rappare che va oltre il genere.
Noi lo seguiamo fin dagli inizi di
The Island Chainsaw Massacre, e lo
abbiamo anche intervistato (www.
iyezine.com/interviste/1275-salmo.
59
WWW.GREENFOGSTUDIO.COM
60
htm).
Il suo stile è farvi male, le rime sono
pugni in faccia, ma sono anche
qualcosa che può darvi la forza di
continuare a sbracciare in questo
mare di merda. Salmo vende
tante copie, certe strumentali
sono più commerciali rispetto
alle precedenti, ma ciò non conta
molto. Se cercate un rifugio questo
non è il posto giusto, questa è la
colonna sonora dell’apocalisse,
della morte che stiamo vivendo
ogni giorno. Sentire Weishaupt è
qualcosa di davvero illuminante, ci
fa capire che presto saremo terra
per i vermi. Un disco mostruoso, di
un livello incestuoso, con un solo
brano sbagliato : Faraway.
Le collaborazioni sono tutte
azzeccate, specialmente quella
con i Cyberpunks in Russel Crowe.
Guardatevi le spalle.
Ma il resto è storia.
Massimo Argo
THEE BOMB’O’NYRICS
“Thee Bomb’o’nyrics”
Autoprodotto
Qualcuno fra voi, e sottolineo
il forse, potrebbe pensare, con
una notevole dose di malizia e
prevenzione, che io possa avere un
debole per le Thee Bomb’o’nyrics.
Si potrebbe giungere a tale
affrettata quanto erronea
conclusione considerando che,fra
le mie ultime tre recensioni, due
riguardano questa all-female band,
ma si tratta null’altro che di un
caso, io neanche le conosco e poi,
chissà,magari se le conoscessi mi
starebbero pure antipatiche.
Ma abbandoniamo queste puerile
ed inutili considerazioni e valutiamo
il contenuto di questo 7” dalla
copertina celeste cielo.
Sul lato A è incisa Into The
Woodche, al rituale garage-punk
scombicchierato marchio di
fabbrica del gruppo, aggiunge, a
parer mio, un tocco di quello che
un tempo fu il sound delle riot
grrrls, direi un pizzico di prime Hole
pre-ubriacatura da superstar di
Courtney Love.
Lo trovate un riferimento così
balzano?
Agli ascoltatori, ed alle autrici,
rimpallo l’ardua sentenza.
Il lato B è invece occupato da
She Was Puking della quale ebbi
a parlare nelle mia recente
recensione della loro ultima fatica
su musicassetta, per i più distratti,o
per i lettori saltuari di questa
e-zine, ricorderò che si tratta di un
pezzo roots-rock,se per roots-rock
intendete quello che suonavano i
Cramps.
Dopo aver ascoltato quanto
prodotto sino ad oggi da questo
quartetto di esagitate direi proprio
che la ciliegina che farebbe da
completamento alla loro torta
allucinogena sarebbe un bel lp,
vinyl only of course.
Magari se ci conoscessimo e
ci trovassimo reciprocamente
simpatici potrei produrglielo io ...
Il Santo
THREELAKES AND THE FLATLAND
61
EAGLES
“War Tales”
Upupa Produzioni
Luca Righi, in arte Threelakes,
debutta sulla lunga distanza con i
suoi fidi compari Flatland Eagles
(Andrea Sologni, Raffaele Marchetti,
Lorenzo Cattalani, Marco Chiussi,
Paolo Polacchini). Il disco, War
Tales, esce dopo una serie di ep
che ben hanno fatto parlare di lui,
proponendo dieci intensi brani
indie folk pieni zeppi di emotività
ed ospiti di riguardo (Emanuele
Reverberi, Francesca Amati, Capra
dei Gazebo Penguins, Luciano
Ermondi).
Wild Water, con il suo muoversi
delicato su note di chitarra e
il viscerale abbandonarsi alla
melodia, apre il disco, trovando
anche il tempo per introdurre
l’energico travolgere dell’immediata
The Walk e il più pacifico (ma non
meno accattivante) ondeggiare
della malinconica The Lonesome
Death Of Mr. Hank Williams.
To Do, con il suo lento galleggiare su
chitarre e ritmiche composte, lascia
spazio all’iniziale armonica di The
Day My Father Cried e al suo delicato
e fragile svilupparsi, mentre By My
Side, più elettrica e ruvida, apre al
movimento in crescendo di D-Day
(molto coinvolgente nel finale) e al
morbido incedere di March.
Horses Slowly Ride, infine, tra banjo
e rapidi colpi di batteria, trotta
veloce fino alle note dell’avvolgente
e conclusiva Rose (tempi lenti,
intense note di tromba, chitarre
62
lente e molto altro).
Con questo primo album i
Threelakes And The Flatland
Eagles mettono a segno un buon
colpo. I dieci pezzi proposti, infatti,
scorrendo uno dopo l’altro tra
ottime melodie e testi curati (tutto
il disco ruota attorno al concetto di
guerra, come suggerito dal titolo),
istigano all’ascolto compulsivo. Un
disco che non vi lascerà delusi.
Francesco Cerisola
GAZEBO PENGUINS
“Raudo”
To Lose La Track
Dopo “Legna” del 2011 e lo split
con I Cani del 2012, i tre Gazebo
Penguins (Capra, Sollo, Piter)
ritornano, insieme all’ormai
collaudata e sempre più attenta To
Lose La Track, con Raudo, ovvero
il loro terzo lavoro lungo. L’album,
composto da dieci brani, continua
nel solco del precedente, regalando
nuove chitarre esplosive, una
maggiore maturità dal punto di
vista compositivo e, ovviamente,
una nuova palata di emozioni.
E’ Finito Il Caffè, tra chitarre
scalpitanti, melodie accattivanti e
un testo agrodolce, apre il disco
travolgendo con la sua forza
emotiva, mentre Casa Dei Miei,
schiacciando sull’acceleratore,
disorienta con il suo raccontare. Le
tempeste di chitarra di Difetto e il
nervosismo di Domani E’ Gennaio
(dissolto solo da quell’amaro “le
rate di una libertà che dura un
anno, ti prego non mi dire più
domani è un altro giorno, i lunedì
di maggio sono così da otto anni”)
cedono spazio all’altrettanto
rabbiosa e disillusa Ogni Scelta E’
In Perdita (“non solo ogni lasciata
è persa, è strano ma vedrai, che
ogni scelta è in perdita”) e alla
malinconica tranquillità (per modo
di dire) della breve Correggio.
L’energico sfrecciare di Trasloco,
infine, seguita da una veloce e
graffiante Mio Nonno, apre alla
granitica Non Morirò, al suo “se
avessi avuto un’ora di più o anche
solo un minuto, non avrei fatto
nulla di diverso” e al catartico
gridare “oggi mi sento piuttosto
bene, uo uo uo” della conclusiva
Piuttosto Bene.
Questo terzo album deiGazebo
Penguins pare avere tutte le carte
in regola per bissare il successo del
precedente “Legna”. Forse i testi
sono più scarni e semplici, ma le
emozioni continuano ad essere
trasmesse con intensità, le melodie
danno l’impressione che ci sia stato
un ottimo lavoro alle spalle e i
suoni esplodono nell’aria. Un disco
sincero e fatto a regola d’arte: non
potrà che conquistarvi.
PIERRE DEUTSCHMANN
“Betroit”
BluFin
Pierre Deutschmann ci presenta
Betroit, il suo techno-capolavoro,
una raccolta che costituisce la
summa del suo credo musicale.
Pierre Deutschmann, classe
1974, è un pezzo importante
della scena techno berlinese e,
di recente, il dj e producer (con
quel cognome, più tedesco di
così!) si è messo in testa un’idea
molto ambiziosa, complicata,
ma certamente anche molto
stimolante. L’idea è quella di creare
un album vab>sto ma corposo
e compatto, che rappresenti
il suono che lo ha influenzato
negli ultimi vent’anni (quando un
giovane Pierre si avvicinava alla
musica elettronica). Un disco che
lo rappresenti, che racconti le
sue influenze rielaborandole in
ciò che è diventato il suo canone
della techno; l’intento è quello di
andare oltre una sorta di “back to
mine”, e plasmare questi metalli
fusi, queste influenze, nella forma
che sintetizzi al meglio tutto
ciò, forgiando un suono che sia
contemporaneamente qualcosa
di originale, personale e attuale,
che esprima ciò che Pierre è ora,
ma anche qualcosa di riferibile alla
storia e all’evoluzione di un genere
e un percorso musicale.
E da che parte, da dove si possono
ricevere influenze di questo genere,
se non dai luoghi per eccellenza
in cui la techno si è sviluppata e
ha tratto linfa vitale? Luoghi che
rappresentino le cellule germinali
da cui questo movimento si è
propagato con le sue potenti
vibrazioni...Quali luoghi se non
Detroit e Berlino? Due città che
hanno fatto, soprattutto per quanto
63
64
riguarda la motor city, e stanno
tuttora facendo, soprattutto per
quanto riguarda la capitale tedesca,
la storia di questo movimento. Le
capitali mondiali del genere, quella
del nuovo e quella del vecchio
continente, le due ampolle da cui
Pierre attinge i suoi ingredienti, da
buon alchimista della techno, per
creare una miscela potentissima.
L’una, la città dalla quale proviene
e nella quale opera per dare il suo
contributo a questa storia, l’altra,
la cui scena qualunque persona
minimamente interessata al genere
dovrebbe conoscere.
Ecco dunque che questo disco
assume altri significati e valenze:
oltre a dare la più completa
visione del suo marchio di fabbrica
musicale, la sintesi di queste
materie prime con la produzione
di colate di stampo Deutschmann,
questa raccolta diventa anche per
il tedesco una sorta di celebrazione
di tutto il genere musicale, della sua
storia e delle sue caratteristiche.
Unendo le due visioni
complementari della materia, egli
realizza un’opera di grande impatto
e di grande ambizione, un potente
inno celebrativo al techno sound.
Il risultato finale, perciò, possiede
quella caratteristica particolare che
è molto più della somma delle sue
parti.
In sei mesi nasce così Betroit,
album da tredici tracce più intro e
outro, per un totale di quindici, il cui
titolo è già abbastanza evocativo e
rappresentativo di questo concetto.
Si crea questa connessione BerlinoDetroit, le due città non sono
mai state così vicine! L’intro della
raccolta si chiama Detroit, l’outro
si chiama Berlino, come a dire “da
qui si parte, e qui si arriva, tenetevi
forte, questo è il percorso”; ed è
un percorso che unisce, mescola,
miscela, fa reagire, le due matrici di
partenza, contaminando l’una con
l’altra.
Da quanto accennato, si tratta di
un disco lungo, che però non cade
mai nel rischio che si corre quando
si ascolta un album techno fuori
dai clubs (quello di essere troppo
pesante), perchè nonostante il
buon Pierre ci vada giù piuttosto
forte, dopotutto è un picchiatore,
le tracce non sono caratterizzate
da un suono dritto, egli riesce
a creare quest’ambientazione
avvolgente, scura come la notte,
un battito pulsante come il cuore
dell’underground di queste due
città e che trasmette grande
energia e vigore.
Tolte intro e outro, il volume del
materiale di Betroit è veramente
imponente, sono 13 tracce
veramente massicce, con una
qualità media molto elevata e una
certa unità di visione.
Un lavoro impressionante,
estremamente coeso e compatto
anche nella sua lunga durata, che
segue un unico fil rouge senza
cadere nell’eccessiva uniformità
e piatta ripetitività, riuscendo a
trovare quell’elemento vincente che
rende le tracce sempre espressive,
e ne fa emergere una manciata
65
come dei capolavori. Parameter
Lock, col suo incedere cadenzato, i
soundscapes di Area1507, e ancora
Looking Backwards e Cryptalk, sono
alcuni tra i pezzi più notevoli; ma
soprattutto, il cuore del disco, il
momento più alto, arriva poco
dopo la metà, ed è un terzetto di
brani composto da Hunch & Guess,
Emphasis (uscito anche come primo
singolo estratto dall’album), e il
misto acido-ansiogeno di One True
Zero.
In definitiva penso di poter dire
senza troppi rischi di dover
ritrattare la faccenda, di trovarmi
davanti il disco techno dell’anno,
difficilmente qualche altra uscita
potrà farmi cambiare idea.
Davide Siri
VÀLI
“Skogslandskap”
Auerbach Tonträger / Prophecy
Productions
Dimenticate l’inconcludente
ripetitività di certo ambient o la
spiritualità a buon mercato di
gran parte della musica new age;
se volete provare ad ascoltare
composizioni strumentali in
grado di accarezzare il vostro
udito facendovi riappacificare con
l’universo intero, anche se farete
un pò di fatica nel pronunciarlo,
Skogslandskap fa al caso vostro.
Risulta senza dubbio più semplice
memorizzare il nome dell’artista
che si cela dietro l’omonimo
66
progetto, il norvegese Vàli che, con
la sua chitarra acustica supportata
di volta in volta da altri quattro
magnifici musicisti, ci regala tre
quarti d’ora di musica delicata
quanto emozionante.
Skogslandskap è suddiviso
in quindici brevi tracce che si
susseguono senza che affiori
nemmeno per un attimo il senso di
noia o di assuefazione ad un tipo
di sound normalmente a rischio
da questo punto di vista; basta
ascoltare l’opener Nordavindens
Klagesang , un gioiello che dà il
via a questo viaggio all’interno
delle foreste norvegesi nell’arco di
tempo compreso tra il tramonto
e l’alba successiva, per percepire
quanto la musica prodotta da
Vàli rifugga stucchevoli tecnicismi
rivelandosi, invece, una magica
successione di suoni capaci di
muoversi all’unisono con la natura
circostante. Il cammino per il quale
Vàli ci conduce, si snoda armonioso
tra i mormorii delle piante, lo
zampettare frenetico degli animali
notturni, l’effluvio inebriante
della terra bagnata dall’umidità
notturna per concludersi con i
quattro minuti finali di Morgenry, un
concentrato di pura magnificenza
e di commovente poesia che
rende ineluttabile la necessità
di riascoltare dalla prima traccia
questo capolavoro.
Skogslandskap riprende il
discorso laddove si era interrotto
ben nove anni fa con “Forlatt”,
facendo apparire breve come un
soffio di vento un lasso di tempo
oggettivamente piuttosto lungo.
67
Riscoprire quel disco è pertanto
doveroso, come pure lo è ascoltare
questa musica senza tempo, capace
di ricondurci al nostro naturale
status di ospiti del pianeta, che
più ci si addice rispetto a quello di
usurpatori di un regno che non ci
appartiene.
Stefano Cavanna
DGM
“Momentum”
Scarlet Records
Dopo uno, cinque, dieci ascolti di
Momentum, alla fine non si può
evitare di chiedersi cosa possano
avere i DGM in meno di Dream
Theater, Symphony X, Vanden Plas
e compagnia: oggettivamente nulla,
si direbbe, se non un monicker
senza dubbio molto meno
“pesante”.
Considerate le prove non sempre
esaltanti messe in scena negli ultimi
anni da alcune delle band citate,
non sarebbe male che, almeno gli
appassionati italiani, volgessero con
maggiore attenzione lo sguardo alla
più vicina “città eterna” invece che
oltreoceano o verso le fredde lande
nordeuropee.
Se è vero che il suono della band
laziale è oggettivamente accostabile
ai Symphony X , va anche rimarcato
il fatto che qui non si sta parlando
di epigoni dell’ultima ora dato che
entrambi i gruppi si sono formati
attorno alla metà degli anni
novanta.
La presenza di Russell Allen nella
68
traccia d’apertura Reason è una
dimostrazione della comunione
d’intenti tra le due band e, nel caso
specifico, il contributo dell’illustre
ospite è senz’altro pregevole, ma
il fatto stesso che non spicchi
più di tanto dimostra anche
l’enorme qualità della prestazione
vocale offerta da Mark Basile in
quest’album.
In Momentum viene messo in scena
il repertorio ideale di una band che
suona prog metal: un caleidoscopio
di fughe tastieristiche e delicati
passaggi pianistici (Emanuele
Casali), riff rocciosi e assoli dal
grande impatto melodico (Simone
Mularoni, noto ai più anche come
rinomato producer), con il valore
aggiunto di una base ritmica
perfetta (Andrea Arcangeli e Fabio
Costantino) e, come detto, un
cantante che non mostra un solo
attimo di cedimento.
Non resta che godersi senza alcuna
remora questo magnifico disco, che
si snoda tra accelerazioni irreali (per
la tecnica esibita) e passaggi più
orecchiabili che, solo in occasione
di Repay sfociano in un formato
simil-ballad; forzando un pò la
mano con i paragoni, si potrebbe
affermare che i DGM si collocano
in perfetto equilibrio, a metà strada
tra le spigolosità metalliche dei
Symphony X ed il gusto melodico
della prima prova solista di Allen
in coppia con l’altro “mostro” Jorn
Lande (“The Battle”), insediandosi
in un territorio nel quale la band
romana mostra d’avere ben pochi
rivali.
Considerando che l’uscita di
Momentum coincide con un
altro eccellente esempio di prog
metal, come l’album degli Odd
Dimension, la Scarlet esibisce
in un colpo solo un’invidiabile
coppia d’assi; speriamo solo che
la crisi economica che continua a
mortificare i nostri portafogli non
costringa qualcuno a dover fare
una scelta dolorosa, sacrificando
in ogni caso dei lavori che, per
la qualità esibita, non meritano
davvero d’essere accantonati, fosse
anche solo momentaneamente.
LE CAROGNE
“Secondo Le Carogne”
Autoprodotto
Quando hai un’attività e sulla
tua porta si staglia la minacciosa
figura del postino le più fosche
previsioni si addensano nella
tua mente: una cartella pazza di
Equitalia? L’ennesima estorsione
bancaria? Pessime notizie dal tuo
commercialista di fiducia?
E’ con tutta questa serie di timori
che pochi giorni or sono ho accolto
la figura invero simpatica del
portalettere di zona ma, per una
volta, non si trattava di pessime
notizie bensì dell’invio del nuovo
lavoro delle mie carogne preferite
(hanno un nome da cattivi ma
vedendo la loro fotografia si capisce
subito che sono bravi ragazzi).
Per chi aveva avuto la ben
poca gradevole ventura di aver
letto la mia recensione del loro
primo album ben ricorderà che
il mio apprezzamento nei loro
confronti era molto alto, ed era un
apprezzamento condiviso con nomi
di grande rilievo del giornalismo
musicale italiano.
Ed è quindi con grande piacere e
con notevole curiosità che ho subito
estratto il cd dalla sua pregevole
confezione e l’ho posizionato sul
portatile che ho in negozio.
Da quel momento ho ascoltato
almeno una decina di volte le
nove canzoni che compongono
questo disco e l’ho fatto per
due motivi precisi: il primo è
stato indubbiamente quello
di metabolizzare gli indubbi
cambiamenti avvenuti nel
suono della band ed il secondo,
consequenziale al primo, è stato
quello di riuscire a dare il mio
modesto, ma pur sempre obiettivo,
giudizio.
Ecco quindi cos’è scaturito dai miei
ascolti: il pezzo che apre l’album,
Fermami, potrebbe ricordare uno
dei brani più rock di quel folle
di Mgz, Di Poche Parole è un surf
sporcato di elettronica “povera” che
fa tanto Man Or Astro-man? post
svolta Devo, Pittore, che poi è la mia
canzone preferita del lotto, mi ha
rimembrato addirittura una band
mirabile come gli Avvoltoi con il suo
suono volutamente retro-futurista
(?!?) ed il suo testo (finalmente)
ingenuo.
Proseguendo nell’ascolto il mio
interesse è stato destato dai ritmi
grintosamente punk di Via XXV
Aprile 67, dalle atmosfere garage
screziate di synth di Atmosfera
protetta e dall’epitaffio finale di
Tkngrg nella quale i ritmi si rialzano
69
sopra i livelli di guardia.
Nel descrivere i considerevoli
mutamenti avvenuti nel sound
de Le Carogne si potrebbero
scomodare discendenze più
o meno nobili, ma è soltanto
ascoltando con attenzione questo
album che potrete farvi un’idea
di una raccolta che, passato un
primo momento di comprensibile
spaesamento, potrebbe riservarvi
notevoli e piacevoli sorprese.
Le Carogne sono tornate, sono
cambiate ma sempre e comunque
viva Le Carogne.
Il Santo
ABYSMAL GRIEF
“Feretri”
Terror From Hell Records
Arrivando un pò in ritardo
sull’uscita di questo disco, si
rischia inevitabilmente di essere
ripetitivi o, ancor peggio, di fare un
bignamino di tutte le recensioni già
uscite.
Ciò che mi resta, a questo punto,
è provare a parlare, da genovese,
di una band della mia città che
perpetua un filone musicale che,
all’ombra della Lanterna, trae
ispirazione da un immaginario
agli antipodi della modernità,
fatto com’è di riferimenti ai mitici
sceneggiati tv in bianco e nero
e all’horror all’italiana, più FulciBava che Argento, e lo dimostra
scegliendo come copertina
un’immagine tratta da uno dei
rivalutati B-movies dei primi anni
70
’70.
In una città che si sta
decomponendo seppellita dalla
crisi, prima ancora morale che
economica, avvilita dall’ignavia dei
governanti e aggrappata alle sorti
di un porto che fatica a reggere
l’accresciuta competitività della
concorrenza, gli Abysmal Grief
come sfondo per le loro (rare) foto
promozionali non scelgono, come
parrebbe logico, i monumenti
funebri di Staglieno, simbolo
decadente della nobiltà di una
Superba che ha cessato di esistere
da decenni, bensì i piccoli cimiteri
di periferia o di campagna, nei quali
anonimi resti contrassegnati da una
semplice croce faticano a ritagliarsi
spazio tra le erbacce e l’incuria
volte a simboleggiare, anch’esse, un
degrado che appare irreversibile.
Seguendo la strada tracciata,
perlomeno a livello di immaginario
retrospettivo, dai Malombra prima
e da Il Segno Del Comando poi,
gli Abysmal Grief esorcizzano il
terrore della morte nel miglior
modo possibile, ovvero con un
doom malsano e dai tratti antichi,
nel quale è un magnifico hammond
a condurre le macabre danze
contrappuntato da un basso
pulsante e, talvolta, dominante
anche su una chitarra che, quando
si ritaglia spazio in versione
solista, lascia sempre il segno; a
piantare gli ultimi chiodi sulla bara
è, idealmente, la voce di Labes
C. Necrothytus che ricorda in
senso lato quella del grande Carl
McCoy, almeno nell’impostazione,
passando da tonalità baritonali
ad un growl profondo ma sempre
comprensibile, e nella capacità di
comunicare il funesto contenuto
lirico dei brani.
Questo disco mostra un volto
diverso, più orrorifico e morboso,
del doom, che in tutte le sue
versioni mantiene le proprie
caratteristiche di musica per pochi,
e pazienza se la sua visibilità
a livello di media è nulla e se,
conseguentemente, chi organizza
i concerti fatica a riempire locali
anche piccoli; il doom è un
modus vivendi (e non “moriendi”
come potrebbe erroneamente
pensare qualcuno) e per suonarlo
ed ascoltarlo è necessaria una
sensibilità diversa che consente di
godere di sensazioni e vibrazioni
psichiche precluse alla maggioranza
delle persone.
Feretri in definitiva, corrisponde
per filo e per segno a ciò che ogni
appassionato avrebbe voluto
ascoltare dagli Abysmal Grief;
l’insinuante e malefica tastiera che
pervade questi tre quarti d’ora di
grande musica si è incuneata nel
mio cervello e non ha nessuna
intenzione di abbandonarlo in
tempi brevi.
Lungi da tentazioni sciovinistiche,
si può tranquillamente affermare
che un disco con tali caratteristiche
poteva estrarlo dal cilindro solo una
band italiana.
Letteralmente imperdibile.
Stefano Cavanna
MOURNING BELOVETH
“Formless”
Grau Records
Gli Irlandesi Mourning Beloveth
sono una della band europee più
longeve in ambito death-doom,
potendo vantare un’esperienza
ormai ventennale costellata di
lavori di indubbio valore (citerei
tra tutti il secondo album “The
Sullen Sulcus”), ma evidentemente
insufficienti fino ad oggi a farli
assurgere ad uno status superiore
a quello (peraltro invidiabile) di cultband.
Sicuramente i nostri se
ne infischiano di queste
considerazioni, a giudicare dalla
musica contenuta nella loro
ultima fatica Formless (che arriva
a ben cinque anni di distanza da
“A Disease For The Ages”), oltre
che per la durata, vicina all’ora e
mezza, spalmata su 2 cd, che certo
non favorisce ascolti distratti od
occasionali: la verità inconfutabile
che emerge da questo lavoro è
che i Mourning Beloveth sono
stati capaci di imprimere un loro
marchio indelebile in questo
lungo e straziante percorso che
si conclude con l’ultima nota di
Transmission.
Se è vero che il solco compositivo
entro il quale si muove la band
irlandese è evidentemente quello
tracciato dai consueti My Dying
Bride e primi Anathema, non si
può fare a meno di notare quanto
influisca sul sound la diversa
71
provenienza geografica e la
conseguente tradizione musicale
rispetto alle omologhe band
albioniche.
Infatti, grazie anche al magnifico
contributo vocale di Frank
Brennan alle clean vocals, spesso
pare di ascoltare una versione
iper-rallentata dei conterranei
Primordial (emblematica in tal
senso la magnifica Nothing Has A
Centre), ma sarebbe ingeneroso
ridurre l’operato dei Mourning
Beloveth a una semplice fusione di
queste due influenze.
Basta ascoltare una perla come
Dead Channel per rendersi
conto delle veridicità di questa
affermazione, in particolare quando
nella sua parte centrale il brano
si apre in un crescendo velato di
un’epica mestizia; come pure non
si può tacere della maestosità
dell’opener Theories Of Old Bones
e della successiva Ethics On The
Precipice, tracce dalla lunghezza
considerevole eppure prive di
momenti di stanca.
Se vogliamo, la sola Old Rope si
rivela come un episodio nella
norma, senza particolari slanci e
ossequioso dei dettami del deathdoom più classico, ma per certi
versi la sua collocazione si rivela
funzionale inserendosi come una
sorta di breve intermezzo tra le
due coppie d’assi presenti nella
tracklist del primo cd, che viene
concluso dalla già citata Nothing
Has A Centre: prendete Alan Averill
e soci, spogliateli della componente
più rabbiosa sostituendola con le
cupe trame del doom più evocativo
72
e otterrete un formidabile risultato.
L’alternanza tra il cantato pulito di
Frank e il feroce growl di Darren
Moore funziona sempre alla
perfezione (cosa tutt’altro che
scontata) nel corso del disco ma in
questo brano raggiunge livelli molto
vicini alla perfezione.
Un discorso a parte merita
Transmission, brano che occupa per
intero il secondo cd pur avendo
una durata “limitata” a circa un
quarto d’ora; in effetti le differenze
rispetto alle sonorità mostrate in
precedenza sono notevoli, tanto da
rendere apprezzabile la scelta di
farlo apparire una sorta di bonustrack, isolandolo dal resto del
lavoro.
In effetti, una traccia così
particolare, interamente acustica e
per certi versi definibile come una
sorta di doom-blues, per essere
apprezzata appieno necessita
d’essere ascoltata come un’opera a
sé stante: esperimento sicuramente
affascinante che dimostra il valore
della band irlandese e soprattutto
la sua volontà di non appiattirsi
troppo sui consueti modelli di
riferimento.
I Mourning Beloveth dopo anni
costellati di produzioni encomiabili
ma rimaste confinate in un
immeritato limbo, con Formless
sfornano il disco che li potrebbe
consacrare tra i nomi più influenti
della scena death-doom europea.
Stefano Cavanna
73
THE MEN
“New Moon”
Sacred Bones
Della loro infatuazione per la
tradizione americana ce ne
eravamo già accorti su Open Your
Heart, capolavoro che ci aveva
regalato, immerse in un pantano
di suoni noise indie, quei due
momenti di meraviglioso relax
intriso di tradizione sudista di
Country Song e Oscillation.
Ma qui la cosa inizia a farsi seria.
O a rompere le palle, fate vobis.
La nuova luna dei The Men,
purtroppo per noi poveri insaziabili
consumatori di rock’n’roll-noise, ha
portato in dote una dose aggiuntiva
di slide guitars vogliose di blues,
ballate, armoniche e chitarre
acustiche a disegnare melodie
americane da cantare tutti in coro
davanti al caminetto. Detta così fa
impressione eh? Ma dopo l’iniziale
spaesamento (“dai The Men mi
aspettavo tutt’altro” e stronzate del
genere) bisogna pure ammettere
che i quattro ragazzi newyorkesi ci
hanno saputo fare anche stavolta.
Che a parte la dose massiccia di
country e folk, c’è ancora un’anima
indie noise bene in vista capace di
abbattere qualsiasi concorrente.
E che in fondo, ‘sta roba qui non è
che la naturale evoluzione del loro
sound.
Le vette di Open Your Heart sono
lontane, ma di pane da mettere
sotto i denti i Nostri continuano a
fornirne in quantità industriale. Se
74
le ballate country Open The Door e
High and Lonesome lasciano un po’
interdetti, il resto del disco, invece,
cresce di continuo con gli ascolti e
finirà per rapirvi l’anima così come
aveva fatto il precedente. Half
Angel, Half Light e Without A Face
sono due bellissime ballate folk
sporcate di rifiuti noise e rock’n’roll,
dove le linee armoniche disegnate
da chitarra acustica e armonica si
sposano con wah-wah (la prima) e
sferragliate noise-core (la seconda).
The Seeds è una bellissima ballata
country-blues arricchita da una
linea di basso distorta posta in
sovrimpressione e da un bel solo
di mandolino (eh già). Neil Young
fa capolino da I Saw Her Face,
ispirando un folk rock chitarristico
che deraglia sul finale causa
accelerazione punk.
Arrivati circa alla metà del disco,
i rapporti di forza sembrano
cambiare. Il folk e il country
rimangono sottotraccia, salvo
qualche colpo di coda (Bird
Song), e riaffiorano prepotenti le
escrescenze noise. E allora ecco in
rapida successione la bellissima
cavalcata noise’n’roll di The Brass,
lo splendido ruggito indie del primo
singolo Electric, le ballate folk-rock
stuprate da chitarre noise di I See
No One (uno dei pezzi migliori del
lotto) e Freaky, o le sferragliate
noise di Supermoon.New Moon
conferma: i The Men sono la miglior
indie rock band in circolazione!
Kaosleo