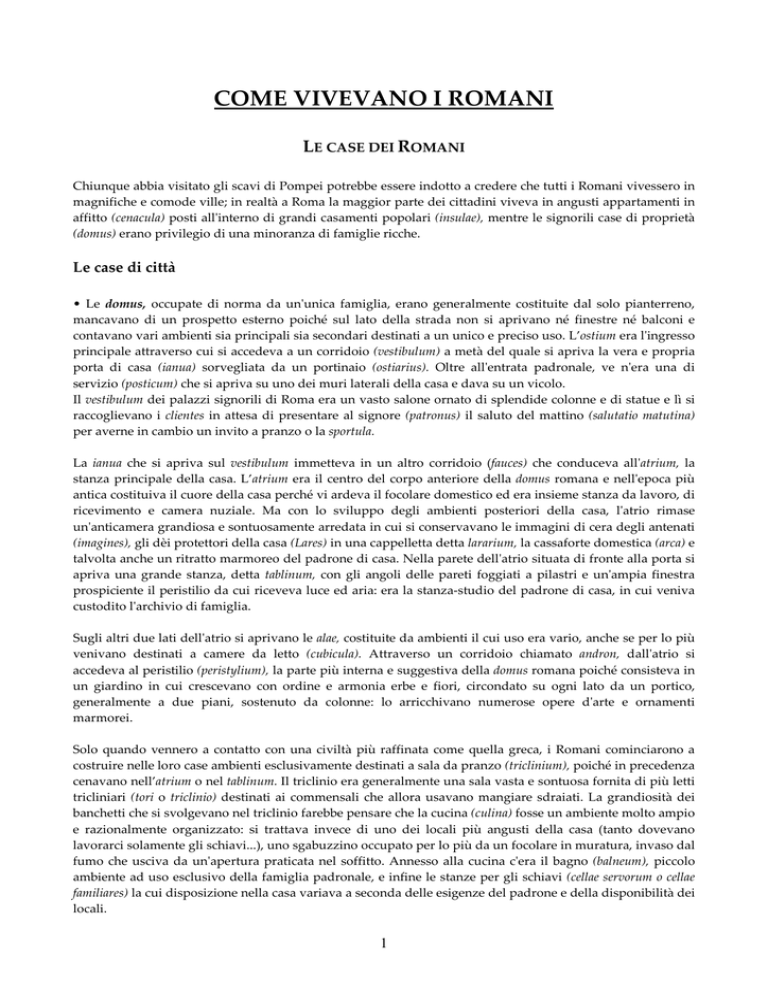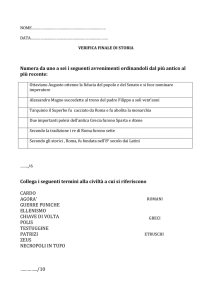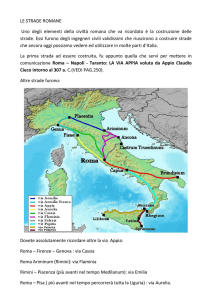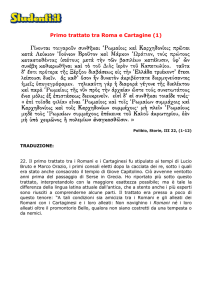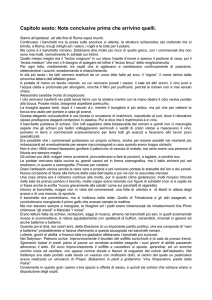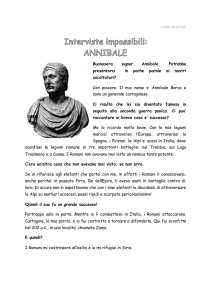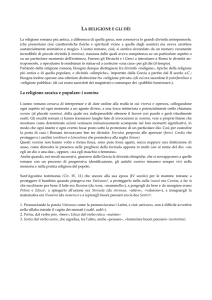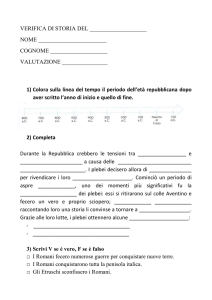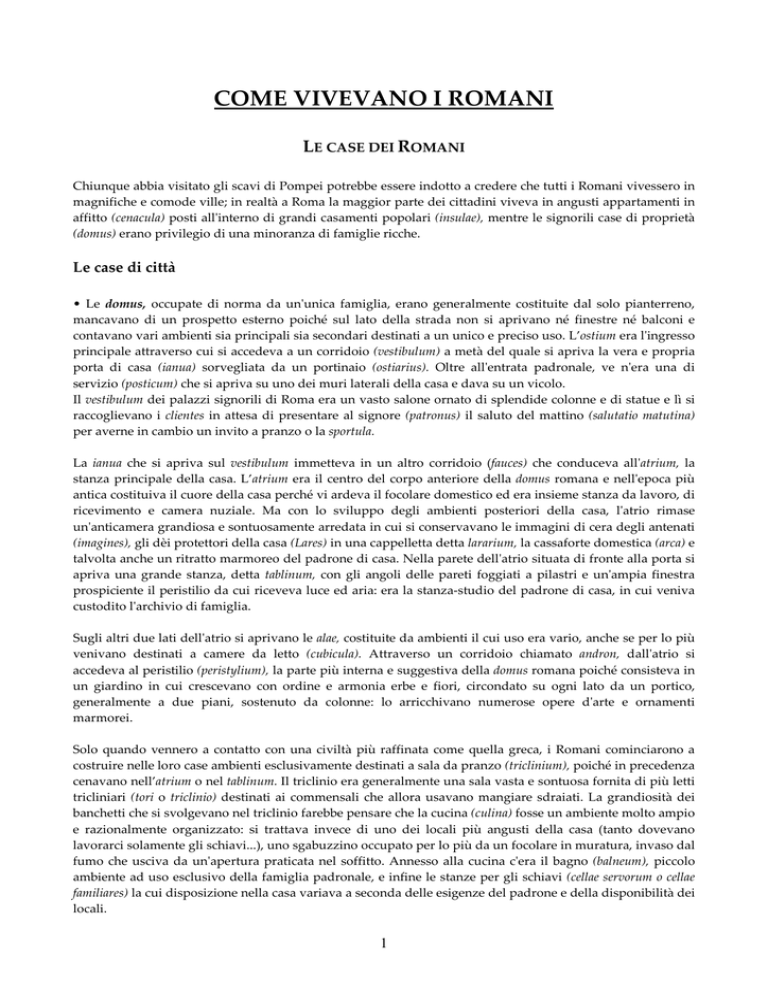
COME VIVEVANO I ROMANI
LE CASE DEI ROMANI
Chiunque abbia visitato gli scavi di Pompei potrebbe essere indotto a credere che tutti i Romani vivessero in
magnifiche e comode ville; in realtà a Roma la maggior parte dei cittadini viveva in angusti appartamenti in
affitto (cenacula) posti all'interno di grandi casamenti popolari (insulae), mentre le signorili case di proprietà
(domus) erano privilegio di una minoranza di famiglie ricche.
Le case di città
• Le domus, occupate di norma da un'unica famiglia, erano generalmente costituite dal solo pianterreno,
mancavano di un prospetto esterno poiché sul lato della strada non si aprivano né finestre né balconi e
contavano vari ambienti sia principali sia secondari destinati a un unico e preciso uso. L’ostium era l'ingresso
principale attraverso cui si accedeva a un corridoio (vestibulum) a metà del quale si apriva la vera e propria
porta di casa (ianua) sorvegliata da un portinaio (ostiarius). Oltre all'entrata padronale, ve n'era una di
servizio (posticum) che si apriva su uno dei muri laterali della casa e dava su un vicolo.
Il vestibulum dei palazzi signorili di Roma era un vasto salone ornato di splendide colonne e di statue e lì si
raccoglievano i clientes in attesa di presentare al signore (patronus) il saluto del mattino (salutatio matutina)
per averne in cambio un invito a pranzo o la sportula.
La ianua che si apriva sul vestibulum immetteva in un altro corridoio (fauces) che conduceva all'atrium, la
stanza principale della casa. L’atrium era il centro del corpo anteriore della domus romana e nell'epoca più
antica costituiva il cuore della casa perché vi ardeva il focolare domestico ed era insieme stanza da lavoro, di
ricevimento e camera nuziale. Ma con lo sviluppo degli ambienti posteriori della casa, l'atrio rimase
un'anticamera grandiosa e sontuosamente arredata in cui si conservavano le immagini di cera degli antenati
(imagines), gli dèi protettori della casa (Lares) in una cappelletta detta lararium, la cassaforte domestica (arca) e
talvolta anche un ritratto marmoreo del padrone di casa. Nella parete dell'atrio situata di fronte alla porta si
apriva una grande stanza, detta tablinum, con gli angoli delle pareti foggiati a pilastri e un'ampia finestra
prospiciente il peristilio da cui riceveva luce ed aria: era la stanza-studio del padrone di casa, in cui veniva
custodito l'archivio di famiglia.
Sugli altri due lati dell'atrio si aprivano le alae, costituite da ambienti il cui uso era vario, anche se per lo più
venivano destinati a camere da letto (cubicula). Attraverso un corridoio chiamato andron, dall'atrio si
accedeva al peristilio (peristylium), la parte più interna e suggestiva della domus romana poiché consisteva in
un giardino in cui crescevano con ordine e armonia erbe e fiori, circondato su ogni lato da un portico,
generalmente a due piani, sostenuto da colonne: lo arricchivano numerose opere d'arte e ornamenti
marmorei.
Solo quando vennero a contatto con una civiltà più raffinata come quella greca, i Romani cominciarono a
costruire nelle loro case ambienti esclusivamente destinati a sala da pranzo (triclinium), poiché in precedenza
cenavano nell’atrium o nel tablinum. Il triclinio era generalmente una sala vasta e sontuosa fornita di più letti
tricliniari (tori o triclinio) destinati ai commensali che allora usavano mangiare sdraiati. La grandiosità dei
banchetti che si svolgevano nel triclinio farebbe pensare che la cucina (culina) fosse un ambiente molto ampio
e razionalmente organizzato: si trattava invece di uno dei locali più angusti della casa (tanto dovevano
lavorarci solamente gli schiavi...), uno sgabuzzino occupato per lo più da un focolare in muratura, invaso dal
fumo che usciva da un'apertura praticata nel soffitto. Annesso alla cucina c'era il bagno (balneum), piccolo
ambiente ad uso esclusivo della famiglia padronale, e infine le stanze per gli schiavi (cellae servorum o cellae
familiares) la cui disposizione nella casa variava a seconda delle esigenze del padrone e della disponibilità dei
locali.
1
Schema di domus.
L'atrium della casa dei Cei a Pompei. Questo ambiente era per lo più di forma quadrangolare: al centro vi si trovava una larga vasca
rettangolare detta impluvium perché destinata a ricevere l'acqua piovana che proveniva da un'ampia apertura (compluvium) praticata
nel tetto inclinato verso l'interno. L'acqua veniva poi convogliata in una cisterna nel sottosuolo attraverso un'apertura praticata ai
margini della vasca e circondata da un puteal («pozzo») cilindrico.
• Le insulae, in stridente contrasto con le abitazioni signorili ora descritte, sorgevano nei quartieri popolari
di Roma. Si trattava di costruzioni d'affitto a più piani che, sorte nel IV secolo a.C. dall'esigenza di offrire un
alloggio entro il ristretto territorio dell' Urbs a una popolazione in continuo aumento, si erano sviluppate in
senso verticale. Già nel III secolo a.C. numerose erano in città le insulae a tre piani, ma alla fine della
repubblica e in periodo imperiale parecchi edifici superavano il sesto piano, come la famosa insula Felicles
che si elevava su Roma come un grattacielo.
2
Costruite spesso da imprenditori privi di scrupoli che impiegavano materiali fragili e scadenti, amministrate
da proprietari che miravano solo ad ottenere il massimo profitto da affitti esagerati, le insulae erano frequentemente preda di incendi e i continui crolli che minacciavano la sicurezza dei cittadini spinsero
l'imperatore Augusto a proibire ai privati di elevare costruzioni al di sopra dei 70 piedi (21 m circa). L'insula
comprendeva diversi appartamenti (cenacula), i più economici dei quali erano costituiti da pochi locali molto
angusti e scarsamente areati che fungevano contemporaneamente da soggiorno, sala da pranzo e camera da
letto.
Anche le insulae però si dividevano in due categorie: nei palazzi più prestigiosi il pianterreno costituiva
un'unità abitativa a disposizione di un unico locatario e assumeva quindi l'aspettò e i vantaggi di una casa
signorile alla base dell'insula; nei palazzi popolari il pianterreno era invece occupato da botteghe o magazzini
(tabernae) in cui gli inquilini non solo lavoravano ma vivevano e dormivano, poiché una scala di legno univa
la bottega a un soppalco che costituiva anche l'abitazione dei bottegai (tabernarii). Particolarmente grave era
il problema igienico perché tutti gli appartamenti mancavano di condutture d'acqua e di bagni: a Roma
infatti le reti idriche e fognarie erano esclusivamente riservate all'uso pubblico e solo le domus e le case
signorili al pianterreno delle insulae potevano usufruire, dietro pagamento di un canone molto alto, di un
allacciamento privato.
Veduta dell'atrium, del tablinum e del peristylium della Casa della Caccia a Pompei, del I secolo d.C; in primo piano è visibile una
bocca di cisterna.
3
Particolare delle pitture di giardino del triclinium della Villa di Livia presso Roma, di età augustea (Livia era la moglie
dell'imperatore Augusto). Questo genere di pittura, derivato dalle scenografie di età ellenistica raffiguranti i cosiddetti paradeisoi
(«giardini») orientali e molto diffuso nelle case romane, riflette l'amore dei Romani per la natura ma è anche carico di significati
simbolici.
Le villae di campagna
• Nell'epoca più antica villa è «la fattoria», cioè un complesso di edifici simile alle «cascine» o ai «casali»
delle nostre campagne, che comprendeva gli alloggi della intera familia (padroni e lavoranti sia liberi sia
schiavi), le stalle per gli animali, i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli (formaggi, olio, vino ecc.), i
magazzini (horrea) per lo stoccaggio e la conservazione del grano, della frutta, del vino ecc. Essa era
l'abitazione principale del patrizio romano, che si occupava personalmente del podere organizzando e
controllando il lavoro della servitù; in città si recava soltanto per sbrigare i suoi affari e per adempiere ai suoi
doveri di civis. A questo proposito venne tramandato come esemplare il comportamento del patrizio Lucio
Quinzio Cincinnato che, nel corso della guerra contro gli Equi (metà del V secolo a.C.), ricevette l'annuncio
della sua nomina a dittatore mentre era intento ad arare personalmente i suoi campi: corse a Roma, sconfisse
gli Equi e ritornò immediatamente al suo lavoro nei campi.
• A partire dal II secolo a.C, questo modello di vita ispirato a ideali di frugalità e austerità venne
abbandonato a favore di un modello «cittadino»: i nobili eressero a loro abitazione principale le grandi domus
in città pur continuando a trarre la loro ricchezza dalle proprietà terriere, affidate a uomini di fiducia detti
vilici, (propriamente «amministratori della villa»): il padrone e la sua famiglia andavano nella villa solo
d'estate per sfuggire alla calura di Roma.
• In età imperiale, infine, la villa diventa soprattutto la «casa vacanze» immersa nel verde di curatissimi
parchi e giardini, situata in una amena località di mare o di campagna: i romani molto ricchi ne possedevano
più d'una, e facevano a gara per costruirla sempre più spaziosa e dotata di ogni comfort: oltre a numerose
stanze (camere da letto, saloni per conversare e ascoltare musica, sale da pranzo, biblioteche ecc.), non
mancavano mai un'ampia loggia con vetrate che permettesse di prendere il sole senza essere disturbati dal
vento, lunghi e ampi porticati al piano terra nei quali fosse possibile non solo passeggiare stando «al
coperto», ma anche andare a cavallo o in lettiga, e, infine, un vero e proprio complesso termale completo di
piscine di acqua calda (calidarium), tiepida (tepidarium) e fredda (frigidarium). Parte integrante della villa
signorile era, come si è detto, il parco con aiuole di fiori, piante rare, fontane capaci di produrre giochi
d'acqua, viali ombrosi abbelliti da statue.
Le infrastrutture
4
• Il riscaldamento. Scarsi erano presso i Romani i mezzi di riscaldamento, poiché anche il focolare non era
in genere sormontato da un camino e quindi il fumo rendeva spesso l'aria irrespirabile. Per riscaldare i locali
venivano usati bracieri o fornelli di varia forma e materiale. Solo nelle case più ricche, in età imperiale, fu
installato un sistema di riscaldamento simile a quello in uso nelle terme, che consisteva nel far circolare aria
calda nelle pareti attraverso un'intercapedine formata da mattoni forati all'interno.
Grande tenuta agricola, mosaico cartaginese detto del dominus Julius (fine del IV secolo d.C,
• L'illuminazione. Le case romane erano piuttosto buie anche di giorno per il ridotto numero di finestre e
l'assenza del vetro trasparente. Di notte venivano illuminate con lampade ad olio (lucernae) o candelae diverse
dalle nostre, formate da cordicelle ricoperte di sostanze grasse o cera, che venivano intrecciate come funi e
fissate a candelabri detti lychni.
Per spostarsi da un luogo all'altro si faceva luce con la lanterna a mano (lanterna), retta da uno schiavo
adibito a questa mansione (lanternarius), e formata da un lume a olio protetto da sottili pareti di mica. Le
fiaccole di legno resinoso dette taedae venivano invece usate in occasioni importanti come i matrimoni o i
funerali.
• L'arredamento. Nelle case romane l'arredamento era ridotto al minimo poiché le stanze, eccetto l’atrium e il
triclinium, erano molto piccole. Con un unico sostantivo collettivo supellex («suppellettile») i Romani
definivano tutto ciò che serviva all'arredamento e che si riduceva in genere ai letti, ai sedili, alle tavole e agli
armadi, oltre naturalmente a tutto ciò che veniva usato per ornare la casa: quadri, baldacchini, tende (velario)
e altro.
Numerosi e di vario tipo erano i lecti; si badi, tuttavia, che i Romani usavano il termine lectus, i per indicare
non solo i nostri «letti», ma anche «poltrone» e «divani», e con un aggettivo ne precisavano l'uso: ad
esempio, il lectus cubicularis era il letto singolo, mentre il lectus iugalis o genialis era il letto matrimoniale;
lectus lucubratorius era chiamata una comoda poltrona per leggere e studiare, lectus triclinialis era il divanetto
su cui i commensali si sdraiavano per pranzare. I vari lecti erano poi ornati da cuscini detti pulvinari o, se
destinati all'appoggio del capo, cervicalia. Per sedersi si usavano vari tipi di sedie, dal semplice scamnum o
subsellium, uno sgabello a 4 gambe, alla sella, senza spalliera ma con i braccioli, alla comoda cathedra con una
spalliera lunga e arcuata. Non esisteva una «tavola da pranzo», ma tavolini (mensae) di legno o di prezioso
avorio posti presso il letto tricliniale ove i commensali potessero appoggiare le stoviglie.
5
Lungo le pareti dei vari locali c'erano poi cassapanche (arca, ae) e armadi (armarium, ii) di fattura più o meno
pregiata, ora appoggiati a terra ora appesi al muro, come i nostri pensili. Fra le arcae ce n'era una
particolarmente importante e preziosa, la cassaforte, fatta di materiali robusti e corredata di grosse borchie.
Braciere in bronzo di età imperiale proveniente da Pompei (Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
Tavola con esposizione di vasellame d'argento (affresco della tomba di Vestorio Prisco, Pompei).
6
LA SCUOLA
Nella Roma antica non esisteva una scuola di stato che gratuitamente impartisse una cultura di base a tutti i
cittadini. Si riteneva infatti che il compito di educare e istruire i figli appartenesse unicamente alla famiglia,
che vi provvedeva in base alle sue condizioni economiche e sociali. È una conquista moderna, figlia
dell'Illuminismo settecentesco, il principio secondo cui tutti i cittadini, a qualunque ceto appartengano, sono
titolari di un «diritto all'istruzione» e che, di conseguenza, lo stato ha il dovere di istituire una scuola di base
obbligatoria e gratuita.
I corsi di studio
Il più antico modello educativo della società romana prevedeva che della educazione dei figli si occupasse
nella prima infanzia la madre e in seguito, soprattutto per i maschi, il padre, che aveva il compito di inserire
il ragazzo nella vita economica e politica, trasmettendogli quindi anche i valori religiosi, sociali e civili che lo
educassero a essere un buon cittadino. In genere tuttavia, soprattutto nelle città, la famiglia provvedeva alla
istruzione dei propri figli affidandoli, a seconda delle proprie possibilità, a un pedagogo privato (si trattava
per lo più di uno schiavo) o mandandoli in una scuola, ove un maestro radunava diversi bambini e ragazzi e
impartiva un insegnamento collettivo. Quando pensiamo alla scuola romana tuttavia non dobbiamo pensare
a grandi edifici suddivisi in aule con palestre e laboratori, ma, specie per la scuola elementare, dobbiamo
immaginare locali angusti, talvolta «a cielo aperto», lungo le strade principali, spesso separati dal vociare
della gente solo da una semplice tenda; l'arredamento era povero e scomodo: una sedia a braccioli per il
maestro (cathedra) e sgabelli per i ragazzi che dovevano tenere le tavolette cerate (i quaderni di allora) sulle
ginocchia.
L'ambiente decisamente squallido e poco invitante rispecchiava la scarsa considerazione che nella società
romana aveva il servizio scolastico e il bassissimo prestigio sociale ed economico di maestri e professori. Lo
stipendio di un maestro elementare fissato dall’Edictum de pretiis di Diocleziano (301 d.C.) era di 50 denari
per alunno al mese, il che significava che, per raggiungere il guadagno mensile di un operaio specializzato o
di un artigiano, il maestro doveva radunare almeno 30 alunni; al grado scolare successivo il professore
(grammaticus) stava decisamente meglio, il suo stipendio era infatti di 200 denari al mese per allievo; di poco
più elevato (250 denari) era infine lo stipendio del docente di livello superiore (rhetor).
L'anno scolastico incominciava a marzo, dopo i 5 giorni di festa (Quinquatrus) dedicati a Minerva, dea della
cultura e quindi protettrice anche degli studenti, e prevedeva un periodo di vacanze estive. Si andava a
scuola mattino e pomeriggio tutti i giorni, ad eccezione di quelli festivi e delle Nundinae, un giorno ogni
nove, dedicato al mercato. Il corso di studi completo comprendeva tre gradi di istruzione corrispondenti,
grosso modo, alla nostra scuola elementare, media e superiore.
7
Cippo funerario con scena di scuola. Gli scolari, disposti su due file, scrivono su tavolette; un altro scolaro sembra dettare, da un
rotolo di papiro, sotto la guida del maestro (Roma, Museo Nazionale Romano).
Affresco proveniente da Pompei raffigurante la fustigazione di uno scolaro nel Fòro. Lo scolaro viene appoggiato sulle spalle di un
compagno, mentre un altro gli immobilizza le gambe. Nella scuola romana le punizioni corporali facevano parte del programma
educativo e lo strumento usato era generalmente la ferula, una bacchetta così chiamata dal nome della pianta da cui spesso veniva
ricavata (I secolo d.C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
• Scuola primaria (ludus litterarius): l'insegnamento era impartito dal litterator che con metodi lenti e
decisamente faticosi, fra i quali erano molto importanti le percosse, insegnava ai bambini a leggere, scrivere e
far di conto.
• Scuola media: l'insegnamento veniva impartito dal grammaticus ed era basato sullo studio della lingua e
della letteratura greca e latina. Venivano letti e analizzati con uno studio pedante e minuzioso i più famosi
testi poetici di cui si imparavano anche a memoria ampie parti. Dei Greci il più letto era Omero; fra i Latini,
almeno fino al I secolo a.C., erano «in programma» soprattutto i poeti dell'età arcaica come Livio Andronico,
Ennio, Plauto e Terenzio, ai quali successivamente si aggiunse Virgilio. La matematica e le «materie
scientifiche» venivano studiate solo in quanto fornivano elementi necessari per la comprensione dei testi
letterari.
• Scuola superiore: il completamento dell'istruzione (e solo pochi potevano permetterselo) era affidato al
rhetor, cioè al professore di" eloquenza che aveva il compito di preparare i giovani all'esercizio dell'oratoria,
indispensabile per emergere nella vita politica e per esercitare l'avvocatura. Gli allievi studiavano le tecniche
fondamentali dell'«arte del ben parlare» (rhetorica), analizzavano le opere in prosa più famose e si
esercitavano a comporre e a declamare discorsi su argomenti fittizi, spesso di carattere mitologico. Tipiche
esercitazioni delle scuole di retorica, specie in età imperiale, erano le controversiae e le suasoriae: le prime
consistevano in discorsi nei quali si dibattevano due tesi opposte, nelle seconde si doveva invece cercare di
persuadere qualcuno a fare o a non fare qualche cosa, portando le argomentazioni più opportune e
svolgendole nel modo più efficace (ad esempio «Agamennone delibera se sacrificare o no Ifigenia», oppure
«Silla delibera se abdicare o no»). A coronamento del ciclo completo di studi, i Romani ricchi mandavano i
figli a perfezionarsi ad Atene, ove si trovavano le più famose scuole di filosofia e di retorica.
8
Piccolo abaco, risalente all'età imperiale: era utilizzato nella scuola primaria per imparare a contare (Roma, Museo Nazionale Romano).
Frammento di sarcofago con un istitutore e i suoi allievi. Nelle famiglie romane abbienti i figli venivano spesso affidati a istitutori
che li aiutavano nelle lezioni e nei compiti (ll-lll d.C, Città del Vaticano, Museo Gregoriano Profano).
Libri e quaderni
Noi siamo abituati ad associare la scuola e la cultura alla carta, anzi sarebbe addirittura impensabile
immaginare il nostro mondo (e non solo la scuola) senza la carta (cioè senza libri, quaderni, giornali, riviste
ecc.). Ma nel mondo romano la carta non esisteva, anche se esisteva la parola: charta era infatti chiamato il
foglio di papiro che, assieme a quello di pergamena e alle tavolette cerate, costituiva uno dei più comuni (e
costosi) materiali scrittori.
• Il papiro era una pianta molto diffusa in Egitto, usata per fabbricare fogli su cui scrivere sin dal 3000 a.C. Il
midollo della pianta (detto liber) veniva ridotto in sottili strisce, disposte l'una accanto all'altra in senso
verticale; su di esse ne venivano stese e incollate altre disposte però in senso orizzontale, così da ottenere un
foglio (charta) abbastanza compatto e consistente, opportunamente levigato con un tornio o a colpi di
9
martello. Si scriveva in genere su una sola facciata; i fogli venivano quindi uniti fra di loro e arrotolati
intorno a un bastoncino (umbilicus) a formare un volumen (dal verbo volvo che significa appunto
«avvolgere»). Il «libro» si presentava dunque sotto forma di rotolo, più o meno grosso, costituito da una
lunga striscia di «pagine» e si leggeva srotolandolo: devolvere ad umbilicum significava propriamente
«srotolare un volumen fino in fondo» quindi, in senso figurato, «leggere un libro sino alla fine».
Tavoletta cerata rinvenuta a Pompei in scrittura capitale corsiva
Affresco da Pompei che ritrae una donna con penna e rotolo. In passato e' stato considerato un ritratto della poetessa Saffo. (Napoli,
Museo Archeologico Nazionale)
10
La grafìa corsiva era molto diversa dalle familiari lettere maiuscole che si vedono nelle iscrizioni. Questo è un frammento di una
lettera scritta con l'inchiostro su una tavoletta di legno e ritrovata in Britannia. La lettera è indirizzata a un decurione di nome Lucio
al quale si porgono i ringraziamenti per un dono di ostriche (I secolo d.C, Londra, British Museum).
• La pergamena altro non era che pelle di capra o più spesso di pecora opportunamente conciata e derivava
il suo nome dalla città di Pergamo (in Asia Minore) che nel II secolo a.C. ne fu il più famoso centro di
produzione. I fogli di pergamena potevano dare origine a due diversi tipi di libro: a un volumen del tutto
simile a quello fatto con chartae di papiro o a un codex costituito da fogli piegati e tagliati in quattro (quaternio,
da cui il nostro «quaderno») uniti fra loro, come avviene nei libri di oggi.
• Per scrivere si usavano inchiostri di diverso colore, fra i quali il più comune era quello nero (atramentum), e
ci si serviva di cannucce appuntite (calamus) o di penne d'oca (penna).
• Volumina e codices avevano evidentemente un costo molto elevato, di conseguenza per documenti di
minore importanza («brutte copie», appunti, esercizi scolastici ecc.) si usavano tavolette di legno con i bordi
rialzati su cui veniva spalmato uno strato consistente di cera di colore scuro (venivano chiamate cerae,
codicilli o anche pugillares). Per scrivere si usava un bastoncino (stilus o graphium) con una estremità a punta e
l'altra a spatola: con la prima si incideva la cera {arare, exarare), con l'altra si cancellava (stilum vertere
significava letteralmente «girare lo stilo», quindi, in senso figurato, «cancellare», «correggere»).
• Solo persone molto ricche potevano permettersi una biblioteca personale ben fornita ed essere quindi
buoni clienti dei vari librai che, nelle loro botteghe, servendosi di copisti, riproducevano i libri che venivano
loro richiesti. Fra i librai, che erano in genere anche editori, uno dei più famosi fu Tito Pomponio Attico,
destinatario di molte lettere di Cicerone di cui fu forse l'amico più fidato.
11
Strumenti di scrittura ritrovati a Pompei: teche per inchiostro, uno stilo metallico, una penna metallica e un raschietto per eradere
scrittura ad inchiostro (Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
In questo famoso affresco pompeiano un panettiere e la moglie esibiscono orgogliosamente i simboli della ricchezza acquisita, tra i
quali gli strumenti per scrivere; infatti nella ritrattistica romana i rotoli di papiro e le tavolette rivelano non tanto un interesse
culturale quanto uno status sociale (Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
12
GIOCHI E SPETTACOLI
Sui giochi sia dei bambini sia degli adulti abbiamo poche notizie frammentarie: nessuno degli autori latini ne
parla diffusamente e dobbiamo quindi accontentarci dei rari accenni presenti qua e là nelle opere letterarie e
figurative (pittura vascolare, bassorilievi ecc.). Qualche cosa di più sappiamo degli spettacoli «di massa»
come le gare dei cavalli e i cruenti ludi gladiatori che attiravano grandi folle, scatenavano risse fra tifosi e
alimentavano vorticosi giri di scommesse.
Giochi e divertimenti dei bambini
I giochi dei bambini romani non erano molto diversi da quelli dei bimbi di oggi: si divertivano con la trottola
(turbo), con la corda, con il cerchio (orbis, trochus), ornato talvolta di piccoli campanelli, che veniva fatto
girare con un bastoncino (clavis). Le bambine amavano giocare con le bambole, che potevano essere rozzi
pupazzi di legno o di terracotta, o raffinate opere d'artigianato in legno o in avorio costruite in modo che la
testa, le braccia e le gambe fossero perfettamente snodabili. Esistevano poi anche i «corredini» per le
bambole che comprendevano, né più né meno di oggi, pettini, anelli, vestiti ecc. Anche i bambini romani
amavano i giochi con la palla: si trattava di un pallone leggero gonfio d'aria (follis), diverso da quello, più
pesante e duro, usato dai grandi.
Molto praticati erano poi i giochi collettivi di abilità e destrezza: il più noto era quello delle noci, che
consisteva nel far crollare da una distanza prestabilita un mucchietto di noci oppure nel centrare con un
lancio perfettamente calibrato la bocca di un recipiente. I giochi con le noci dovevano essere molto diffusi,
tant'è vero che per dire che la fanciullezza era finita si usava l'espressione «abbandonare le noci» (nuces
relinquere). Diffusissimi erano poi i giochi di costruzione o di fantasia, come quelli ricordati dal poeta Orazio
che fra le più comuni attività dei bambini cita «costruire cassette, attaccare topi a un carrettino, giocare "a
pari e dispari", andare a cavallo di una canna». Con qualche variante insomma i bambini romani giocavano
proprio come i nostri: non è infatti difficile riconoscere, dietro gli accenni degli scrittori o esaminando le
figure di qualche bassorilievo, giochi come guardia e ladri, l'altalena, il nascondino, la mosca cieca (che nel
mondo antico si chiamava «mosca di rame») e tanti altri ancora, nati dalla fantasia dei piccoli che, ieri come
oggi, imitano le attività degli adulti, giocando «ai soldati», «ai giudici», «ai cavalli», oppure facendo i giochi
d'azzardo, come la morra.
Giochi di ragazzi raffigurati nelle pitture murali provenienti dalla tomba di via Portuense (Roma, Museo Nazionale).
13
Bambola di Crepereia Thriphaena, 150 - 160 d. C. Roma, Museo Nazionale Romano.
Giochi e divertimenti dei grandi
Molto diffusi erano i giochi d'azzardo, ufficialmente proibiti, come la morra (digitis micare) o i dadi nella
varietà degli astragali (in latino tali, bastoncini con quattro facce numerate) e delle tesserae, del tutto simili ai
nostri dadi. Esistevano poi giochi di società «intelligenti» simili alla nostra dama e ai nostri scacchi,
consistenti nel muovere su una scacchiera (tabula lusoria) dei pezzi (calculi) secondo regole ben precise. Molto
praticati, specie fra i giovani, erano alcuni giochi «di movimento» come quelli con la palla, fra i quali particolarmente popolari erano il trigon e soprattutto l’harpastum, un gioco di squadra piuttosto violento che
prevedeva anche durissime mischie. Per tutte le attività all'aperto il punto di riferimento era il Campo
Marzio, per la ginnastica le Terme e le palestre private. Del tutto sconosciuti erano gli sport della montagna
quali lo sci, l'alpinismo o anche il semplice escursionismo alpino. Comunque nel mondo romano l'attività
sportiva non rientrava fra gli hobby e i divertimenti, e men che meno aveva l'importanza che i Greci le
attribuivano per un'armonica formazione dell'uomo (si pensi al significato che nel mondo ellenico avevano
le Olimpiadi!): a Roma veniva praticata solo «per mantenersi in forma», per il resto i Romani amavano più lo
sport-spettacolo che lo sport praticato direttamente, ed erano quindi più «tifosi» che «sportivi»; insomma
allo stadio ci andavano non per giocare o per gareggiare ma soltanto per assistere alle gare e agli spettacoli
gladiatori.
Fra i divertimenti di massa, specie dei giovani, oggi ai primi posti bisognerebbe porre la discoteca o i
concerti dei cantanti e dei complessi alla moda, nulla del genere esisteva invece in Roma antica. Per il
costume romano (ed anche greco) la musica, la danza e il canto sono sempre legati a manifestazioni rituali
(molti riti comportavano danze sacre) o comunque a forme di spettacolo consistenti in una esibizione di
abilità e di grazia, riservate dunque a danzatori professionisti. La danza, inoltre, rientrava anche nella
educazione delle fanciulle perché contribuiva a rendere aggraziati e armonici
I movimenti del corpo, ma, per lo meno a Roma, era ritenuto sconveniente che una signorina di buona
famiglia si appassionasse troppo e amasse esibirsi in pubblico. Non parliamo poi dei maschi, ai quali il ballo
era severamente interdetto: dare del ballerino (saltator) a un uomo romano significava rivolgergli uno degli
insulti più gravi. Danze (decisamente poco serie) e canzoni (tutt'altro che rituali) costituivano comunque il
contenuto delle due forme di spettacolo teatrale che appassionavano maggiormente i Romani: il mimo
(spettacolo di musica e danza) e il pantomimo (simile alla nostra commedia musicale).
14
Il gioco dei dadi (tesserae) raffigurato in un affresco di età imperiale nella taverna di Mercurio a Pompei.
Questo mosaico di età imperiale raffigura una donna con delle nacchere che danza seguendo la musica di un doppio flauto suonato
da un compagno; gruppi di artisti si esibivano scritturati per apparire a cene importanti (Città del Vaticano, Museo Pio Clementino).
Spettacoli del circo e ludi gladiatori
In Grecia, e soprattutto ad Atene, lo spettacolo che attirava grandi masse era quello teatrale (tragedia e
commedia), i Romani invece preferivano decisamente assistere a gare sportive (soprattutto corse di cavalli) e
ai combattimenti fra gladiatori.
• La passione per gli spettacoli del circo (ludi circenses) era fortissima e coinvolgeva tutti i ceti sociali: il poeta
Giovenale (II secolo d.C.) osservava amaramente che ai suoi tempi il popolo romano desiderava soltanto due
cose, panem et circenses, cioè «avere la pancia piena e godersi gli spettacoli del circo».
Nella Roma imperiale c'erano ben quattro circhi (oggi diremmo stadi o ippodromi) di cui il più grande e il
più imponente era il circo Massimo, capace di contenere 250 000 spettatori. Vi si svolgevano corse di cavalli
montati da fantini o di cocchi tirati da un numero variabile di cavalli: si andava dalla veloce biga con due soli
cavalli al pesante carro con tiro a dieci (decemiugis). Il «tifo» per i colori delle varie scuderie era altissimo e
provocava manifestazioni incredibili e spesso violente, anche perché attorno alle gare c'era un vorticoso giro
di scommesse.
15
• Alla passione per il circo si associava quella per gli spettacoli violenti e sanguinosi dell'arena, ludi
gladiatorii e venationes.
I ludi gladiatorii, che in epoca imperiale si svolgevano nell'anfiteatro Flavio (il Colosseo), consistevano in
combattimenti fra gladiatori reclutati in genere fra schiavi, prigionieri di guerra e condannati a morte,
organizzati da impresari (lanìstae) che avevano istituito vere e proprie scuole in cui gli uomini venivano
allenati a combattere e a morire bene. Il combattimento, infatti, si svolgeva all'insegna della morte-spettacolo
e seguiva un preciso rituale: dopo una sontuosa cena (che per molti sarebbe stata l'ultima), i gladiatori con
un abito scarlatto fregiato d'oro facevano il loro ingresso nell'arena e ne percorrevano tre volte il perimetro
quindi sostavano davanti al podio delle autorità e rivolgevano all'imperatore il tradizionale saluto: Ave
Caesar, morituri te salutant. Dopo il controllo delle armi e il sorteggio delle coppie, aveva inizio la serie dei
combattimenti che il pubblico seguiva avidamente (anche perché sulla vita e sulla morte dei gladiatori si
facevano scommesse), pronto a protestare e a invocare l'intervento dei lorarii («staffilatoli») se i gladiatori davano l'impressione di non impegnarsi a fondo. La lotta terminava b con la morte o con la resa di uno dei due:
in quest'ultimo caso il gladiatore sconfìtto alzava la mano a chiedere grazia; mentre nei tempi più antichi
questa veniva concessa o rifiutata dallo stesso avversario, in età imperiale era lasciata all'arbitrio
dell'imperatore che, in genere, si atteneva agli umori del pubblico: se era favorevole alla grazia sventolava i
fazzoletti e sollevava il pollice gridando Mitte! («Lascialo andare!»), se invece ne voleva la morte, abbassava
il pollice (pollice verso) e gridava iugula! («Sgozzalo!»). Il vincitore riceveva premi e, dopo diverse vittorie, il
definitivo congedo.
• Molto amato era anche un altro tipo di spettacolo non meno feroce e cruento, il combattimento fra fiere
(elefanti, bufali, orsi, leoni, tigri ecc.) o tra un gladiatore specializzato (bestiarius) e una o più fiere. In molti
casi l'esposizione alle fiere (ad bestias) veniva scelta come modalità spettacolare per eseguire una condanna a
morte, tale fu ad esempio la sorte di molti Cristiani.
Ma altre atrocità si consumarono negli anfiteatri di Roma quali la rappresentazione realistica di battaglie
navali, o di vicende storiche e mitologiche nelle quali la morte del protagonista non era una finzione scenica:
Icaro veniva realmente fatto precipitare dall'alto!
La folla assisteva entusiasta e avida di sangue, alla ricerca di sensazioni sempre più forti; imperatori e
impresari cercavano di accontentarla inventando spettacoli sempre più atroci, in un crescendo di orrore che,
forse più di ogni altra cosa, rivela il distacco che ci separa dalla civiltà romana. Essa non conosceva il
concetto della sacralità della persona umana in quanto tale, portatrice di per sé di diritti inviolabili, ma
distingueva fra «uomini liberi» titolari di dignità e garantiti dalla legge, e «gli altri», privi di diritti, in balia
del loro proprietario (un privato o lo stato stesso) che poteva usarli a suo piacimento. Fu il Cristianesimo a
porre fine a tale prospettiva proponendo la dottrina della sostanziale pari dignità di tutti gli uomini, tutti
creati da Dio a sua immagine e somiglianza; con i primi imperatori cristiani vennero aboliti, fra il IV e il V secolo, sia i ludi gladiatorii sia l'abitudine di gettare ad bestias i condannati a morte.
16
Quattro pannelli pavimentali (emblemata), ciascuno raffigurante un auriga delle quattro fazioni del circo (l'azzurra o veneta, la
verde o prasina, la rossa o russata e la bianca o albata), con il rispettivo cavallo (III secolo d.C, Roma, Palazzo Massimo alle Terme).
Mosaico con scena di gladiatori (IV secolo d.C. Madrid, Museo Archeologico).
17
Una rissa tra tifoserie in un affresco pompeiano di epoca imperiale. La rissa sanguinosa tra Pompeiani e Nocerini è in corso, sia all'interno sia all'esterno dell'anfiteatro di Pompei.
18
I ROMANI A TAVOLA
La frugalità era una delle virtù tipiche del mos maiorum e di conseguenza la cucina romana più antica era
impronta a grande sobrietà e basata su pochi e semplici alimenti. E tale continuò sostanzialmente ad essere
per la gran maggioranza della popolazione, anche quando giunsero a Roma prelibatezze e specialità
alimentari da ogni parte dell'impero e i ricchi gareggiavano nell'allestire banchetti sontuosi, citati dagli
scrittori satirici come esempi di pacchianeria e di cattivo gusto.
I pasti quotidiani
I pasti quotidiani dei Romani erano normalmente tre: lo ientaculum o prima colazione (del mattino), il
prandium o seconda colazione (di mezzogiorno) e la cena, il pranzo della sera che costituiva il pasto
fondamentale della giornata. I Romani in genere si svegliavano col sorgere del sole e verso le nove del
mattino (ora terza) facevano una rapida e leggera colazione (ientaculum) a base di uova, latte e formaggio per
ritemprare le energie. Era detta ientaculum anche la merenda che i fanciulli portavano a scuola. Verso
mezzogiorno (ora sesta) veniva consumato, per lo più in piedi, un frettoloso spuntino (prandium) a base di
cibi caldi o freddi che erano spesso avanzi della cena della sera precedente. Alle tre del pomeriggio (ora
nona), e d'estate anche più tardi, cominciava la cena (o coena), il pasto più importante della giornata.
In questo affresco pompeiano si vede una bottega di panettiere con vari tipi di pane e focacce disposti sul banco. Il pane dei Romani
si distingueva in pane nero (panis plebeius o rusticus) fatto con farina contenente molta crusca, pane bianco ma non finissimo (panis
secundarius) e pane bianco di lusso (panis candidus) impastato con farina raffinata e priva di crusca (I secolo d.C, Napoli, Museo
Archeologico Nazionale).
La cena
Presso la gente più povera la cena era a base di polenta (puls) di farro (farratum), di miglio (fitilla) o di semola
(alica). I cereali, ridotti in farina o lasciati in grani interi, venivano cotti in acqua o latte e la polenta, tenuta
piuttosto morbida, poteva essere accompagnata, a seconda delle disponibilità, da uova, formaggio, interiora
di animali o miele (puls punica). Dal II secolo a.C. si diffuse, accanto alla polenta, l'uso del pane che poteva
essere d'orzo, di miglio, di spelta o di altri cereali. La cena dei ricchi invece constava di tre momenti distinti:
il gustus (o gustatio o promulsis), la cena vera e propria e le secundae mensae. Il gustus consisteva in un
antipasto durante il quale venivano serviti crostacei, uova preparate in vari modi, olive verdi e nere, ortaggi
crudi e cotti (i Romani amavano particolarmente i funghi, i porri, la lattuga e gli asparagi) e crostacei. Il
gustus era accompagnato dal mulsum, bevanda a base di vino leggero mescolato a miele. La cena vera e
19
propria era costituita da diverse portate (fercula o cenae) a base di carne, pollame, selvaggina o pesce delle più
varie qualità: erano ritenute preli bate le carni di ghiro (glis), che veniva appositamente allevato nei gliraria,
di pavone e di fenicottero. Nel corso della cena si beveva vino, solitamente caldo, puro (merum) o allungato
con acqua. Durante i banchetti importanti, tra la cena vera e propria e il dessert (secundae mensae) venivano
offerte libagioni alle statuette dei Lares domestici. Le secundae mensae infine comprendevano dolci di vario
tipo, come focacce al miele (placentae), e frutti: mele, pere, pesche, noci, ciliegie, introdotte a Roma dopo le
guerre mitridatiche, albicocche, originarie dell'Armenia, e datteri, importati dall'Africa. Quando il banchetto
si protraeva per tutta la notte, dopo il dessert aveva inizio la comissatio, cioè una serie di brindisi
beneauguranti che i commensali, inghirlandati, indirizzavano ai presenti su proposta di uno di loro, eletto a
sorte rex convivii o arbiter bibendi.
Questa «natura morta» fa parte di un affresco della Casa di Giulia Felice a Pompei. Sul ripiano sono disposti un mortaio con un
grande cucchiaio, un vassoio ricolmo di uova e una brocca per il vino (oinochoe); alla parete sono appesi quattro tordi e un
asciugamano frangiato. Una piccola anfora, anch'essa per il vino, è appoggiata all'angolo del ripiano.
L'ambiente del banchetto
I Romani del periodo arcaico e del primo periodo repubblicano erano soliti consumare la cena con molta
semplicità nell’atrium, vicino al focolare. Quando la struttura della domus si ampliò, alla cena venne riservato
un locale apposito detto, con una parola di origine greca, triclinium, dal nome dei tre divani su cui si
stendevano i commensali per pranzare.
In età imperiale, l'esigenza di ospitare a banchetto più di nove persone fece aumentare le dimensioni del
triclinio e il lectus tricliniaris venne sostituito
con un letto arcuato detto sigma, perché aveva la forma del sigma lunato greco (C), e poteva ospitare da 6 a
12 persone.
Le stoviglie
Il vasellame era costituito da piatti piani (patinae), fondi (catini) e da portata (lances); vi erano inoltre
l'ampolla per l'aceto (acetabulum) e la saliera (salinum). Le coppe per le bevande (pocula) erano di varie forme
(larghe senza piede né manici le paterae, alti con piede e manici ad ansa i calices...) e potevano essere di
semplice coccio senza ornamenti (pocula pura) o di metalli preziosi (argento e oro) finemente cesellati (pocula
gemmata). Il vino, posto in un grosso vaso (crater o cratera) in cui veniva mescolato con acqua calda prima di
essere servito, era attinto per mezzo di un mestolo (cyathus) e versato nei pocula da uno schiavo addetto a tale
compito {puer ad cyathum). Il cibo, prima di essere servito, veniva suddiviso in piccole porzioni (pulmenta) da
uno schiavo detto scissor o carptor e i commensali lo portavano alla bocca con le mani, essendo sconosciuto
20
l'uso della forchetta. Poco usato era anche il coltello (culter), mentre era necessario il cucchiaio (cochlear) per
sorbire i cibi liquidi come le minestre di verdura. L'uso della tovaglia (mantele) si affermò solo nel I secolo
d.C. mentre il tovagliolo (mappa) era fornito dall'ospite o portato da casa da ciascun commensale che alla fine
del pranzo vi avvolgeva gli avanzi da portar via.
L'affresco pompeiano mostra una scena di banchetto. Solitamente il triclinio ospitava tre letti posti lungo le pareti: su ciascuno di
essi prendevano posto tre persone e nello spazio tra i tre letti era posta la mensa o tavolo d'appoggio. I! letto tricliniare (lectus
triclinaris) era simile a una larga panca coperta con un materasso su cui i commensali si sdraiavano di sbieco col gomito sinistro
appoggiato al cuscino (I sec. d.C, Casa dei casti amanti, Pompei).
21
LE ISTITUZIONI POLITICHE
L'ordinamento politico romano si può definire una «costituzione mista» che si articolava in un complesso
meccanismo di poteri contrapposti ma complementari, con la finalità di stornare il pericolo dell'affermazione
di una tirannide e di garantire stabilità e continuità allo stato. Si fondava su una struttura formata da un
organismo direttivo (il senato), da sei magistrature ordinarie (consolato, pretura, censura, edilità, questura e
tribunato della plebe) e da tre assemblee popolari (i comizi curiati, centuriati e tributi): vi erano poi
numerose cariche collegiali inferiori e una magistratura straordinaria, la dittatura, alla quale si faceva ricorso
nei momenti di particolare necessità per lo stato.
Il senato
Il senato (senatus) era l'organo direttivo della vita politica romana, di cui tracciava le fondamentali linee
programmatiche per garantire continuità di indirizzo e stabilità di governo allo stato. Durante la monarchia i
senatori (patres), il cui numero era salito a trecento dai cento dell'epoca di Romolo, venivano scelti dal re solo
tra le gentes patrizie e svolgevano una semplice funzione consultiva.
Con l'avvento della repubblica il loro numero fu accresciuto con l'ammissione di nuovi membri (conscripti,
«aggiunti»), scelti tra le più ricche famiglie plebee; i senatori vennero così chiamati patres et conscripti poi la
congiunzione et cadde e l'espressione patres conscripti assunse valore formulare, venne usata cioè nel
linguaggio ufficiale per indicare l'insieme dei senatori riuniti per deliberare. I senatori erano nominati a vita
e l'ammissione al senato, affidata in un primo tempo ai consoli e ai censori, dal I secolo a.C. divenne
automatica per tutti quanti avessero ricoperto la questura, cioè la prima delle magistrature del cursus
honorum.
Il primo della lista dei senatori, detto princeps senatus, era solitamente il più anziano e il suo giudizio era
tenuto in gran conto; in età imperiale invece il princeps senatus fu sempre l'imperatore. Segni distintivi
dell'ordine senatorio erano la larga lista di porpora (latus clavus) intessuta nella tunica dall'alto fino al lembo
inferiore, l'anello d'oro (anulus aureus) e i calzari rossi (calcei senatorii).
Le competenze del senato si estendevano a tutti i campi della vita dello stato. In ambito legislativo discuteva
e approvava in forma preventiva i progetti di legge da presentare ai comizi. In ambito esecutivo era suo
compito dichiarare, in situazioni di emergenza, lo stato d'assedio con la nomina del dittatore o, con una
speciale delibera (senatus consultum ultimum) proclamare lo stato di emergenza affidando i pieni poteri ai
consoli con la formula solenne Videant consules ne quid res publica detrimenti capiat, «provvedano i consoli a
che lo stato non riceva alcun danno».
In campo militare il senato stabiliva il reclutamento o lo scioglimento dell'esercito, ne fissava il bilancio,
divideva le province e i contingenti tra i comandanti, decretava il trionfo per i generali vittoriosi
(imperatores).
Dirigeva inoltre la politica estera poiché aveva il diritto di dichiarare guerra, di concludere trattati di pace o
di alleanza e di stringere rapporti diplomatici coi paesi stranieri. In campo finanziario controllava l'erario e i
beni dello stato, redigeva il bilancio, stabiliva il gettito tributario e dirigeva la zecca. In ambito religioso
svolgeva un'attenta azione di sorveglianza: dopo aver consultato i competenti collegi sacerdotali, stabiliva le
cerimonie e i sacrifici, disponeva la consultazione dei Libri Sibillini e prendeva provvedimenti contro i culti
stranieri in difesa della religione di stato.
Il senato si riuniva normalmente nella Curia, ma anche i templi (in particolare quello della Concordia e di
Giove Statore) potevano costituire luoghi di riunione: tutte le sue deliberazioni (senatus consulta) avevano
valore di leggi.
L'opinione di Polibio
Per lo storico greco Polibio (202-120 circa a.C.) la costituzione della repubblica romana presenta un aspetto
che la differenzia da tutte le forme di governo in vigore presso gli altri popoli: essa riesce, infatti, a riunire il
22
meglio del regime monarchico (i consoli esercitano poteri simili a quello di un re), aristocratico (il senato è
costituito dai nobili) e democratico (l'intero popolo è chiamato a deliberare nei Comizi).
Le componenti dunque che nello stato romano gestivano il potere, erano quelle tre [consoli, senato e popolo]
di cui ho parlato in precedenza. Tutti i settori dell'amministrazione, considerati singolarmente, erano così
equamente ed opportunamente ordinati e regolati attraverso l'azione di queste componenti, che nessuno
avrebbe potuto dire con sicurezza se questo sistema politico fosse, nel suo complesso, aristocratico o democratico o monarchico. Ed era ovvio che fosse così. Se infatti si fissava lo sguardo sul potere dei consoli, la
costituzione appariva completamente monarchica e regia; se invece si guardava al potere del senato, essa
dava l'impressione di essere aristocratica; se uno infine considerava il potere del popolo, questa gli
sembrava chiaramente democratica. Ciascuna di queste componenti aveva, nell'ambito della costituzione,
proprie competenze.
(Storie VI, 11, 11-13; trad. A. Vimercati)
Le assemblee del popolo
Nella repubblica romana la «sovranità» (maiestas atque imperium) apparteneva, almeno per principio, al
popolo che non la esercitava però direttamente ma la trasmetteva e conferiva ai magistrati. Pertanto per
eleggerli e per accettare o rifiutare una legge, il popolo si riuniva in tre forme di pubbliche assemblee
(comitia): i comizi curiati, centuriati e tributi, a seconda che i cittadini fossero convocati per curie, per centurie
o per tribù.
• Comizi curiati (comitia curiata): i comizi curiati, la cui istituzione risaliva all'età regia, costituivano la più
antica forma di assemblea a cui partecipavano solo i membri delle gentes patrizie atti alle armi, suddivisi in
30 curie risalenti alla ripartizione del popolo romano - operata da Romolo - in tre tribù (Ramnes, Tities e
Luceres), ognuna delle quali era divisa in 10 curie. Mentre in età regia questi comizi, pur avendo carattere
consultivo, si esprimevano sulle più importanti questioni dello stato, in età repubblicana persero
d'importanza e si mantennero solo per esplicare tradizionali atti formali quali il conferimento dell'imperium
ai magistrati eletti dai comizi centuriati.
Ricostruzione dell'edificio della Curia Giulia (I secolo a.C.-lll secolo d.C), situata nel Foro Romano e sede del senato. L'edificio, iniziato da Cesare e terminato da Augusto, fu poi ricostruito da Diocleziano, all'epoca del quale appartiene l'edificio in mattoni oggi
visibile, ripristinato nel 1930-36.
23
• Comizi centuriati (comitia centuriata): i comizi centuriati erano l'assemblea di tutti i cittadini che avessero
compiuto diciassette anni, militarmente ordinati in centurie, sulla base della riforma che la tradizione
attribuiva a Servio Tullio ma che storicamente si fa risalire al primo periodo della repubblica. Il permanente
stato di guerra della città in espansione aveva infatti reso necessario ampliare la base del reclutamento, cui
aveva provveduto Servio Tullio suddividendo, in base al censo, tutto il popolo romano in 5 classi, ripartite a
loro volta in centurie, cosi chiamate perché dovevano fornire ciascuna cento uomini all'esercito.
La prima classe, che era anche la più ricca dal momento che vi appartenevano coloro che possedevano un
capitale non inferiore a 100000 assi (monete di rame), era divisa in 98 centurie, la seconda, la terza e la quarta
erano formate da 20 centurie ciascuna, la quinta da 30, mentre i nullatenenti (capite censi, «censiti solo come
individui») e i proletari (ricchi solo di prole) erano considerati al di sotto delle classi (infra classem) e
costituivano le ultime 5 centurie.
Poiché nei comizi il popolo votava per centurie, risultava che la prima classe, costituita da ben 98 centurie
sulle complessive 193, aveva da sola oltre la metà dei voti, così che le deliberazioni più importanti venivano
di fatto prese dai cittadini più ricchi anche se costituivano una minoranza nella città. In compenso essi
contribuivano in modo massiccio alle finanze pubbliche e fornivano il maggior numero di uomini
all'esercito. I comizi centuriati, proprio per la loro struttura militare, si riunivano nel Campo Marzio, fuori
dal pomerium, ed erano presieduti dai magistrati cum imperio, cioè con potere militare (consoli, pretori,
dittatori). Spettava loro l'elezione dei magistrati superiori, l'approvazione delle leggi, la decisione in ultima
istanza sulle dichiarazioni di guerra o sulle trattative di pace; avevano infine potere decisionale in tutte le
cause penali che prevedevano per il cittadino la perdita dei diritti civili (de capite civis Romani). Per tali motivi
i comizi centuriati assunsero un potere sempre maggiore e le loro deliberazioni ebbero forza di leggi (leges
centuriatae).
Particolare del fregio dell'ara di Lucio Domizio Enobarbo, che illustra la cerimonia della registrazione dei cittadini nelle liste
elettorali: un cittadino togato si presenta al pubblico funzionario per dichiarare il proprio censo, tenendo in mano i documenti che
lo attestano.
• Comizi tributi (comitia tributa): i comizi tributi rappresentavano la forma più completa di assemblea
popolare poiché ad essi intervenivano tutte le categorie di cittadini suddivisi in tribù territoriali (4 urbane e
31 rustiche) in base al luogo di abitazione.
Nei primi tempi della repubblica vi partecipavano solo i plebei e venivano quindi chiamati concilia plebis
(«adunanze della plebe»), ma dopo la conquista dei diritti civili e politici da parte della plebe, tali assemblee
24
acquistarono una sempre maggiore importanza perché vi partecipava tutto il popolo, compresi i patrizi, e le
loro deliberazioni (plebiscito) assunsero vigore di leggi per tutti i cittadini.
I comizi tributi, inoltre, eleggevano i tribuni della plebe e i magistrati inferiori (edili, questori ecc.) ed
esercitavano anche il potere giudiziario nel caso in cui un cittadino, condannato ad una pena capitale, avesse
fatto ricorso all'assemblea popolare (provocatio adpopulum). Si radunavano per lo più nel Foro ed erano
presieduti dai tribuni della plebe, poi sempre più spesso da magistrati superiori (come i consoli), a conferma
della loro importanza.
Le magistrature
Con il termine magistratus si indicavano sia la carica sia la persona alla quale era stato legittimamente
conferito un pubblico potere: i magistrati dunque detenevano il potere esecutivo. Si dividevano in magistrati
«ordinari» e «straordinari», a seconda delle circostanze della loro nomina, e in magistrati cum imperio, o sine
imperio in base al tipo di potere che detenevano.
L’imperium, di cui erano investiti i magistrati superiori (pretori, consoli e dittatore), comportava il comando
dell'esercito in guerra, l'interpretazione e l'applicazione della legge (compresa la condanna a morte) e il
controllo amministrativo dello stato.
Tutte le cariche repubblicane avevano caratteristiche comuni: erano elettive perché tutti i magistrati, tranne
quelli straordinari come il dittatore, erano eletti dai comizi curiati o tributi; erano temporanee perché tutti i
magistrati duravano in carica un anno (il dittatore però veniva eletto per sei mesi e i censori per diciotto);
erano collegiali perché tutte le deliberazioni dovevano essere prese all'unanimità e il veto (intercessio) di un
solo membro arrestava qualunque procedura. Tutti i magistrati inoltre erano responsabili dei loro atti e al
termine del mandato dovevano render conto ai censori della loro gestione.
Sarcofago con processus consularis, cioè la processione per l'entrata in carica di un console, che avveniva a Roma all'inizio
dell'anno secondo un cerimoniale ben preciso (III secolo d.C, Roma, Palazzo Massimo alle Terme).
Le cariche politiche (honores), proprio perché considerate «onori», venivano ricoperte gratuitamente dal
cittadino che doveva quindi possedere un patrimonio che potesse garantire a lui e alla sua famiglia un tenore
di vita confacente al rango; è questo uno dei motivi per cui il cursus honorum, cioè la carriera politica che
procedeva per gradi prestabiliti dalla questura al consolato, era generalmente riservato a un ristretto gruppo
25
di famiglie nobili o ricche (nobilitas). L'aspirante ad una carica pubblica svolgeva la propria propaganda
elettorale (ambitus) aggirandosi per la città vestito di una toga candida (per questo era detto candidatus, da
cui l'italiano «candidato») e accompagnato da uno schiavo (nomenclator) che gli ricordava i nomi delle
persone incontrate affinché egli potesse assicurarsi il loro voto. L'accesso alle magistrature era però
consentito solo ai cittadini liberi optimo iure, che godessero cioè della pienezza dei diritti civili e politici,
mentre ne erano esclusi quelli minuto iure come i liberti e gli stranieri residenti a Roma (peregrini).
Magistrature ordinarie
• Consoli (consules): i due consoli, la cui nomina aveva luogo nei comizi centuriati, erano i supremi
magistrati dello stato e rimanevano in carica per un anno. Detenevano l’imperium loro conferito con atto
formale dai comizi curiati e pertanto amministravano tutti gli affari interni ed esterni della repubblica,
comandavano gli eserciti, curavano l'applicazione delle leggi, convocavano e presiedevano il senato. Qualora
un console in carica morisse, veniva nominato un sostituto detto consul suffectus. In tempo di pace i consoli
indossavano come segno distintivo la toga praetexta bordata di porpora, mentre in guerra vestivano il manto
rosso detto paludamentum. A riprova della importanza del consolato si tenga presente che i Romani per
designare gli anni usavano per lo più i nomi dei consoli in carica: di fondamentale importanza erano dunque
i «fasti consolari», cioè gli elenchi dei consoli che venivano custoditi e aggiornati dai Pontefici. Allo scadere
dell'anno i consoli diventavano consulares («ex consoli») e in qualità di proconsoli (proconsules) venivano
inviati a governare una provincia.
• Censori (censores): istituita nel 443 a.C. la censura era, rispetto alla dignità, la carica più elevata tra le
magistrature romane. I censori, in numero di due, venivano eletti ogni cinque anni, scelti generalmente tra
gli ex consoli (viri consulares) di provata moralità, e rimanevano in carica diciotto mesi. Redigevano le tabulae
censoriae, liste dei cittadini divisi in base al censo (census) ai fini degli obblighi tributari e militari,
amministravano l’ager publicus controllavano le entrate e le spese dello stato, vigilavano sulla moralità dei
senatori e dei cittadini infliggendo la nota censoria a chi non si comportava degnamente. Soli tra i magistrati
non erano sindacabili e il loro operato non era sottoposto al veto (intercessio) dei tribuni o di altri magistrati.
Propaganda elettorale sui muri di Pompei: «Votate per Marco Samellio Modesto, degno della res publica»; alla terza riga inizia un
altro testo che definisce il candidato «iuvenem probum», giovane onesto (copia di una scritta murale di Pompei, Roma, Musei
Capitolini).
• Pretori (praetores): i pretori detenevano ed esercitavano il potere giudiziario. Nel 336 a.C, anno di
istituzione di tale magistratura, vi era un solo pretore, poi dal 242 a.C. ne furono eletti due, il praetor urbanus,
giudice delle contese tra cittadini romani, e il praetor peregrinus, per dirimere le cause fra forestieri. Con
l'incremento della popolazione e il moltiplicarsi dei processi il numero dei pretori crebbe fino a sedici.
Duravano in carica un anno e la loro funzione consisteva nel presiedere le commissioni giudiziarie nelle
cause penali e nel nominare i giudici e convocare le parti nelle cause civili. Detenevano la più alta carica a
Roma in assenza dei consoli e per tale motivo poteva esser loro conferito l’imperium compreso il comando
dell'esercito. Allo scadere del loro mandato ai pretori veniva generalmente assegnato il governo di una
provincia in funzione di propretori (propraetores).
26
• Edili (aediles): gli edili (due patrizi, detti «curùli», e due plebei) svolgevano funzioni di polizia urbana,
sorvegliavano l'ordine pubblico, la pulizia delle strade e delle Terme, si occupavano degli
approvvigionamenti, esercitavano un particolare controllo sul mercato del grano e allestivano giochi e
spettacoli pubblici.
• Questori (quaestores): istituiti all'origine della repubblica con funzioni inquisitorie (da quaero, «indagare»),
assunsero poi la funzione di tesorieri dello stato. Eletti inizialmente in numero di due, il loro numero
aumentò fino a quaranta. Duravano in carica un anno e amministravano il pubblico erario, riscuotevano le
imposte e i tributi, provvedevano alle spese dell'esercito. I quaestores urbani risiedevano a Roma mentre i
quaestores militares seguivano i generali in guerra con funzione di tesorieri.
Tribuni della plebe
I tribuni della plebe {tribuni plebis), istituiti dopo la secessione della plebe sul Monte Sacro o sull'Aventino nel
494 a.C, passarono nel corso dei secoli da due a dieci; erano scelti tra i plebei nati liberi, ma successivamente
furono eletti anche dei patrizi. Convocavano e presiedevano le assemblee della plebe (concilia plebis) e i
comizi tributi (comitia tributa). La loro persona era sacra e inviolabile (sacrosancta) e difendevano i diritti della
plebe esercitando il diritto di veto (ius intercessionis) sulle deliberazioni degli altri magistrati ritenute lesive
degli interessi dei plebei oppure chiamando a discolparsi, una volta usciti di carica, quei magistrati che
avevano agito contro la plebe.
Magistrature straordinarie
• Dittatore (dictator): veniva eletto dal senato in circostanze eccezionali, in casi di grave pericolo esterno o
interno per lo stato, godeva di poteri straordinari e assoluti, compreso il comando dell'esercito (imperium).
Durava in carica sei mesi.
• Comandante della cavalleria (magister equitum): era il luogotenente del dittatore da cui veniva scelto e
nominato e, come il dittatore, durava in carica sei mesi.
Cariche collegiali minori
Oltre alle magistrature del cursus honorum e a quelle straordinarie, esistevano a Roma alcuni collegi
permanenti o provvisori di funzionari statali detti «minori» poiché il loro ufficio non comportava
l'ammissione di diritto in senato, ma costituiva il primo gradino per giungere alla questura (primus gradus
honoris). Questi pubblici ufficiali dapprima erano solo aiutanti dei magistrati poi, quando anch'essi furono
eletti nei comizi tributi e ottennero una loro potestas, furono riconosciuti come funzionari dello stato. Fra le
cariche più importanti ricordiamo i tresviri capitales, che avevano il compito di procedere all'arresto di cittadini, sorvegliare le carceri, eseguire le condanne a morte; i tresviri aere argento auro flando feriundo, con il
compito di dirigere la produzione delle monete. C'erano poi funzionari addetti alla pulizia e alla
manutenzione delle strade, alla vigilanza notturna, all'approvigionamento, agli acquedotti ecc.
Amministrazione della giustizia
L'amministrazione della giustizia o giurisdizione (iurisdictio) a Roma non era stabile ed esclusivo ufficio di
magistrati specificamente istituiti, ma era piuttosto un'emanazione deìl'imperium. Mentre durante il periodo
regio il compito di giudicare spettava al re, assistito dal consiglio dei senatori, in periodo repubblicano tale
compito rientrava nelle competenze di diversi magistrati che godevano del diritto di infliggere punizioni (ius
cöercitionis), che potevano andare dalle semplici multe alla condanna capitale, contro cui il cittadino poteva
ricorrere al giudizio del popolo riunito nei comizi tributi (provocatio adpopulum). Le cause civili e penali erano
affidate a giudici scelti tra gli appartenenti all’ordo senatorius o equestris che, eletti per un anno, operavano
secondo le direttive dei pretori.
27
• Per i procedimenti civili il pretore, urbanus o peregrinus a seconda che si trattasse di cause tra cittadini
romani o forestieri, sceglieva fra coloro che ne avevano i requisiti un giudice unico per il caso in questione,
previo accordo delle parti in causa.
• Per i procedimenti penali invece, che in ultima istanza spettavano ai comizi curiati, furono costituite col
tempo commissioni permanenti di giudici (quaestiones perpetuae) presiedute da un pretore o da un suo
delegato detto quaesitor. Ogni commissione, corrispondente più a meno alle nostre «sezioni» del Tribunale,
era specializzata nel giudizio di determinati tipi di crimini: concussione (de repetundis), alto tradimento
(maiesta-tis), peculato (peculatus), assassinio (inter sica-rios), avvelenamento {de venefìcio), violenza (de vi), falsa
testimonianza (de falso), illegalità negli atti pubblici (de ambitu).
Fuori Roma e nelle province amministrava la giustizia il governatore (proconsole o propretore) coadiuvato
da magistrati (praefecti iure dicundo) istituiti a tale scopo. In caso di processi intentati contro gli ex governatori
delle province per malgoverno, il giudizio spettava al senato che istituiva apposite commissioni d'indagine.
Verso di moneta coniata nel 55 a.C. A da Quinto Cassio Longino in memoria del suo antenato Lucio Cassio che nel 137 aveva
introdotto il voto segreto nelle assemblee giudiziarie: al centro il tempio di Vesta, fra le colonne una sedia curule, a sinistra l'urna
per il voto, a destra una tavoletta con le lettere AC (absolvo/condemno). (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana).
28
L'ESERCITO
L'esercito sino alla fine del II secolo a.C. era formato esclusivamente da cittadini delle prime classi censitane
(quindi in grado di provvedere al proprio armamento) che, abbandonate temporaneamente le loro attività,
accorrevano alla chiamata del console o del dittatore a difendere in armi una causa che sentivano come
propria, a combattere, come si diceva, pro aris et focis, propriamente «per gli altari e i focolari», cioè a difesa
di quanto avevano di più sacro. Con la riforma di Mario, avvenuta gradualmente alla fine del II secolo a.C.,
l'arruolamento fu esteso anche ai proletari, cioè ai cittadini nullatenenti, che venivano quindi mantenuti e
equipaggiati dallo stato e che proprio dalla loro condizione di soldati traevano la loro fonte di
sostentamento: era la premessa di un esercito «di mestiere», composto di professionisti fedeli, più che allo
stato, alla concreta figura del loro comandante, dal cui successo dipendeva anche la loro paga e soprattutto
dipendevano gli «extra» (bottino, prede di guerra ecc.). L'esercito assunse di conseguenza un peso politico
sempre maggiore e in età imperiale furono numerosi gli imperatori che raggiunsero il potere supremo solo
grazie alle truppe che li sostenevano: l'esempio lo diedero Cesare e Augusto, che uscirono vittoriosi dalle
guerre civili proprio grazie alle legioni che preferirono essere fedeli ai loro comandanti che al senato di
Roma.
La legione
La legione (legio) dopo la riforma attuata da Mario (fine II secolo a.C.) comprendeva, nella sua struttura
ideale, 6000 uomini, suddivisi in 10 coorti (cohortes) di 600 uomini, ciascuna delle quali era formata da 3
manipoli (200 uomini ciascuno) comprendenti 2 centurie (100 uomini). Il comandante in capo (dux) era il
console o un altro magistrato cum imperio, cioè con i poteri propri di un comandante supremo (pretore,
proconsole, propretore ecc.), affiancato da uno staff di collaboratori di cui facevano parte i legati (i
«luogotenenti», oggi diremmo gli ufficiali di Stato Maggiore), i tribuni militum («ufficiali superiori»), in parte
di elezione popolare in parte di nomina del comandante, il praefectus equitum («comandante della
cavalleria»), un questore (con compiti amministrativi e logistici), il praefectus fabrum («comandante del
genio») ecc. L'ossatura della legione era costituita dai centurioni (centuriones), corrispondenti ai nostri
sottufficiali o agli ufficiali inferiori che avevano il comando delle centuriae, le unità operative più piccole di
100 uomini ciascuna; essi vivevano a contatto con la truppa, condividevano rischi, disagi e paure dei soldati
e, con il loro comportamento, erano in grado di determinare il «tono» di un reparto.
Non mancavano poi reparti speciali, formati dagli addetti a servizi particolari, come i fabri (oggi diremmo i
genieri), o i suonatori di strumenti quali i cornicines («suonatori di corno») o i tibicines («suonatori di
tromba»), o come gli addetti ai bagagli ed agli animali da soma (calones) ecc. Accanto alle truppe regolari
c'erano quelle ausiliarie (auxilia), fornite dalle province o dagli alleati e ripartite in cohortes di 400-500 uomini,
in genere indicate con il nome della popolazione di origine.
Tipiche truppe ausiliarie erano gli squadroni di cavalleria, in genere 10 per legione, per un complesso di 300
uomini.
29
Cammeo con l'aquila romana, emblema militare divenuto poi simbolo del potere imperiale (Vienna, Kunsthistorisches Museum).
Bassorilievo che raffigura un combattimento tra romani e barbari (Il secolo d.C, Roma, Museo Nazionale Romano).
Le coorti pretorie, composte da soldati scelti. Bassorilievo del I secolo a.C.
30
Stele del centurione bolognese Marco Cellio, appartenente alla XXII legio e ucciso dai Germani nella foresta di Teutoburgo nel 9
d.C. La corona di quercia significa che Marco aveva salvato in battaglia un cittadino romano; i medaglioni sulla corazza, disposti
secondo un ordine e con un significato preciso sono decorazioni militari corrispondenti alle moderne medaglie. Ai lati del
centurione le effigi di due liberti periti insieme a lui (Bonn, Rheinsches Landesmuseum).
L'armamento individuale
Armamento difensivo (arma)
• Elmo: era di due tipi, la galea di cuoio rinforzato da anelli metallici e la cassis interamente metallica.
Sull'elmo degli ufficiali c'era un pennacchio formato da piume o da crini di cavallo (crista o iuba).
• Scudo: il più comune era lo scutum ovale lungo m 1,20, convesso, formato da assi di legno ricoperte di
cuoio e con i bordi metallici; era caratteristica, al centro, una protuberanza chiamata umbo e che serviva a
deviare le frecce. Più leggeri erano il clypeus e la parma, un piccolo scudo rotondo in dotazione alla cavalleria
ed ai reparti d'assalto.
• Corazza (lorica): si andava dalla semplice placca metallica per proteggere il petto, al giubbetto di maglie
(lorica hamata) o di lamine metalliche (lorica squamata), al corsetto costituito da tre pezzi snodabili (lorica
segmentata), che divenne il modello più diffuso in età imperiale.
• Schinieri o gambali: si chiamavano ocreae ed erano in metallo o in cuoio.
Armamento offensivo (tela)
• Spada: il modello più importante e più diffuso era il micidiale gladius, di origine iberica, lungo 70 cm e con
lama a doppio taglio. Veniva conservato in un fodero di legno appeso ad una bandoliera di cuoio (balteus),
portata a tracolla e pendente dal lato destro. C'era poi l’ensis, più lunga e più sottile e, a partire dalla fine del
III secolo, la spatha (da cui l'italiano «spada») a lama piatta e lunga un metro,
• Giavellotto: ogni soldato aveva in dotazione un pilum, pesante giavellotto di origine sannitica che poteva
superare i due metri e pesare più di due chili, formato da un manico di legno e da una punta metallica. Esso
veniva scagliato contro il nemico all'inizio della battaglia, da una distanza di 30-35 metri. Simile al pilum era
l’hasta che si differenziava per la minor lunghezza della parte in ferro.
• Proiettili vari: erano di moltissimi tipi, si andava dalle sagittae (frecce da scagliare con l'arco), ai glandes,
proiettili di pietra o di metallo che venivano lanciati con le fionde dai frombolieri (funditores), fra i quali
erano particolarmente famosi quelli delle isole Baleari.
31
Le macchine da guerra
Con il termine generico di tormenta si indicavano gli strumenti e le macchine sia di difesa sia di offesa, che
venivano impiegate in battaglia e negli assedi.
Macchine da offesa
• Ariete (aries): si trattava di una lunga trave con ad una estremità un pesante blocco metallico spesso
sagomato a forma di ariete; veniva usato per sfondare le porte della città assediata o per aprire brecce nelle
mura.
• Macchine da lancio: le più semplici erano le ballistae («balestre»), foggiate ad arco, e gli scorpiones
(«scorpioni») che servivano per lanciare frecce o pietre; le più complesse erano le pesanti catapultae, con le
quali si potevano scagliare a notevole distanza grossi proiettili e che costituivano quindi l'artiglieria pesante
dell'epoca.
• Torri (turres): erano le tipiche macchine da assedio in legno, alte quanto le mura della città assediata.
Accostate alle mura consentivano di «spiare» i movimenti dei nemici e di portare gli uomini direttamente
sugli spalti.
Macchine difensive
• Plutei: erano paraventi di legno rivestiti di pelle e montati su ruote che servivano a proteggere i soldati
assedianti dai proiettili durante l'avanzata.
• Musculi (propriamente «topolini»): erano delle gallerie mobili, ove stavano e lavoravano i soldati
assedianti.
• Vineae (propriamente, «vigne», «pergolati»): erano delle macchine con tetto a forma di pergolato, sotto cui
gli assedianti trovavano riparo dai proiettili dei nemici nella loro avanzata.
Particolare di un rilievo proveniente dal tempio della Fortuna Primigenia a Preneste, con nave da guerra romana; vi sono raffigurati
alcuni soldati con le loro armature (ll-l secolo a.C. Musei Vaticani)
L'accampamento
32
L'accampamento (castra, castrorum) era sempre di forma quadrata o rettangolare, percorso da due vie
.principali (il cardo e il decumanus) al cui incontro sorgeva il «reparto comando» (praetorium) con la tenda del
comandante (tabernaculum ducis) e, attorno, quelle dei legati e dei tribuni; alle spalle del praetorium c'erano,
disposte secondo un preciso allineamento e raggruppate per reparto, le tende dei soldati {contubernio),
ciascuna delle quali ospitava sino a dieci uomini.
Predisporre l'accampamento esigeva la precisione e l'esperienza di diverse squadre di specialisti: dapprima
toccava agli agrimensores o gromatici (oggi diremmo ai geometri) stabilire con esattezza il tracciato (castra
metari) con l'aiuto dei metatores (dal verbo metior, «misurare»), che per determinare gli angoli si servivano di
uno strumento che si chiamava groma (donde il termine gromatici); subentravano quindi sterratori e muratori
che, sotto la guida di centurioni esperti, scavavano tutto intorno all'area prescelta un ampio fossato (fossa) e,
con l’agger, cioè con la terra dello scavo unita ad altri materiali (pietre, legname ecc.) costruivano un
terrapieno sormontato da una palizzata (valium).
Le opere di difesa e di protezione (munitiones) erano completate da una serie di fortini (castella) in grado di
ospitare le sentinelle (excubiae, custodes, vigiles) ed eventuali piccoli reparti di pronto intervento (praesidia). Le
porte, ben sorvegliate, erano quattro: sui due lati principali si aprivano la decumana e la praeto-ria, poste ai
due estremi del decumanus; sugli altri due lati c'erano invece la principalis dextera e la principalis sinistra, in
corrispondenza alla via principalis, coincidente in genere con il cardo. Lo schema geometrico
dell'accampamento romano è alla base della pianta di molte città europee (uno degli esempi più famosi è
Torino), caratterizzate da un reticolo di strade che si incrociano ad angolo retto. Soprattutto gli
accampamenti stanziali (stativa castra), in cui l'esercito trascorreva i lunghi mesi durante i quali erano sospese
le operazioni militari (autunno-inverno), erano vere e proprie piccole città completamente autonome dal
punto di vista logistico e con una vita economica e commerciale piuttosto animata: al seguito dell'esercito,
c'era infatti una nutrita schiera di personaggi (vivandieri, osti, commercianti, avventurieri ecc.) che viveva
vendendo beni e servizi ai soldati, in genere acquartierata fuori dall'accampamento, ma in continuo rapporto
con i militari.
I legionari costruivano l'accampamento producendo da soli i materiali necessari, come questa antefissa (tegola frontale di un tetto);
vi sono impressi il nome e l'emblema della XX legione, un cinghiale alla carica (I secolo d.C, Londra, British Museum).
33
Accampamento militare (castrum). Esso veniva costruito, se possibile, su un terreno rialzato, nei pressi di un corso d'acqua o di una
sorgente, e con intorno prati per il foraggio.
34
LA RELIGIONE E GLI DÈI
La religione romana più antica, a differenza di quella greca, non conosceva le grandi divinità antropomorfe,
(che presentano cioè caratteristiche fìsiche e spirituali vicine a quelle degli uomini) ma aveva carattere
sostanzialmente animistico e magico. L'uomo romano, cioè, si sentiva circondato da un numero veramente
incredibile di piccole divinità (i numina), ciascuna delle quali aveva competenza su un particolare aspetto o
su un particolare momento dell'esistenza. Furono gli Etruschi e i Greci a introdurre a Roma le divinità antropomorfe, a riprodurne le sembianze in statue ed a costruire «una casa» per gli dèi (il tempio).
Parlando della religione romana, bisogna dunque distinguere fra divinità «indigene», tipiche della religione
più antica e di quella popolare, e divinità «olimpiche», importate dalla Grecia a partire dal II secolo a.C.;
bisogna inoltre operare una ulteriore distinzione fra «religione privata» (di cui era sacerdote il paterfamilias) e
«religione pubblica» (di cui erano sacerdoti dei magistrati o comunque dei «pubblici funzionari»).
La religione arcaica e popolare: i numina
L'uomo romano cercava di interpretare e di dare ordine alla realtà in cui viveva e operava, collegandone
ogni aspetto ed ogni momento a un agente divino, a una forza misteriosa e potenzialmente ostile chiamata
numen (al plurale numina), della quale era indispensabile ottenere il favore con parole e gesti ritualmente
esatti. Gli eruditi romani ci hanno trasmesso lunghe liste di invocazioni ai numina, vere e proprie litanie che
mostrano come determinate azioni venissero minuziosamente scomposte nei loro momenti significativi, in
modo che ogni istante e ogni evento fosse posto sotto la protezione di un particolare dio. Così per custodire
la porta di casa i Romani invocavano ben tre divinità: Forculus preposto alle aperture (fores), Cardia che
proteggeva i cardini (cardines) e Limentinus che presiedeva alla soglia (limen).
Questi numina non hanno volto e forma fisica, sono pure forze agenti, senza neppure una distinzione di
sesso, come dimostra la presenza nelle preghiere della formula apposta in molti casi al nome del dio: «sia
egli un dio o una dea», oppure, «sia egli maschio o femmina».
Anche quando, nei secoli successivi, giunsero dalla Grecia le divinità olimpiche, che si sovrapposero a quelle
romane con un processo di progressiva identificazione, gli antichi numina rimasero sempre vivi nella
memoria e nella pratica religiosa del popolo.
Sant'Agostino testimonia (Civ. IV, 11) che ancora alla sua epoca (IV secolo) per le mamme romane a
proteggere il bambino quando piangeva era Vaticanus1, a proteggerlo nella culla (cuna) era Cunina, a far sì
che succhiasse per bene il latte era Rumina (da ruma, «mammella»), a porgergli da bere e da mangiare erano
Potina e Educa2, a spingerlo all'azione era Strenula (da strenuus, «attivo», «valoroso»), a insegnargli la
matematica era Numeria (da numerus) e a ispirargli buoni pensieri era la dea Sentiri3.
1. Pronunciando la parola Vaticanus come la pronunciavano i Latini, e cioè uaticanus, non è difficile avvertire
nella sillaba iniziale il vagito dei neonati («uah!, uah!»).
2. Potina, dal verbo poto, «bere»; Educa dal verbo educo, «nutrire»
3. Sentia dal verbo sentio, che significa, tra l'altro, anche «pensare», «formulare buoni pensieri» (sententiae).
35
I templi romani di età arcaica erano del tutto simili a quelli etruschi: così doveva presen-tarsi il tempio di Giove Capitolino sul
Campidoglio, costruito nel 509 a.C. (ricostruzione del tempio di Giove Capitolino).
Alla religione familiare apparteneva anche il culto dei morti che venivano seppelliti insieme ad oggetti che furono loro cari, nella
convinzione che la vita proseguisse dopo la morte in un luogo tenebroso e sotterraneo (gli Inferi o l'Orco). Si pensava che esistesse
anche un collegamento fra il regno dei morti e quello dei vivi: per questo, secondo un uso etrusco, in un punto sacro della città
esisteva una fossa detta mundus normalmente coperta da una lastra di pietra. Nei giorni prescritti dedicati ai defunti il mundus
veniva aperto e vi veniva versato il sangue delle vittime, poiché si riteneva che i morti, bevendo quel sangue, ricevessero nuova
forza e nuovo vigore.
Urna cineraria con allusione al viaggio agli Inferi per mare (ll-l secolo a.C. Volterra, Museo Guarnacci).
Rimase comunque sempre vivo nella cultura romana il principio di assegnare forza di divinità ad ogni
aspetto del reale che fosse in qualche modo produttore di effetti positivi o negativi nella vita dell'uomo. Per
questo venivano divinizzate ed avevano un tempio la Fides (cioè «la lealtà»), la Concordia, la Libertà, la
Vittoria, la Pudicizia, ma anche la Febbre e persino Robigo («la ruggine» che distrugge e corrode), Pavor («il
terrore») e Pallor («la paura che fa impallidire»), poiché ciascuna di queste entità, come osserva Cicerone «ha
una forza troppo grande per essere governata senza un dio».
La religione familiare
36
Accanto ai numina, che accompagnavano ogni atto e ogni gesto dell'esistenza, c'erano poi divinità comuni a
gruppi di individui (la famiglia, lo stato, l'esercito, le corporazioni professionali ecc.) e il culto ad esse
praticato aveva carattere comunitario, aveva cioè la funzione di rinsaldare il legame di appartenenza, ed
assumeva di conseguenza grande importanza sul piano sociale e politico: onorare gli dèi della propria
famiglia e della propria gens significava ribadire l'appartenenza ad un «clan» ed accettare gli obblighi che
questo comportava; onorare gli dèi «comuni» di Roma significava riconoscersi cittadino romano ed impegnarsi ad assolvere gli obblighi e i doveri verso lo stato.
Ogni famiglia onorava Vesta, dea protettrice del focolare domestico, i Lari, i Penati, protettori della casa e
della famiglia, e i Mani, cioè le anime degli antenati.
Sacerdote della religione familiare era il paterfamilias che presiedeva personalmente i riti prescritti sia in
onore degli dèi della famiglia sia di quelli che proteggevano le proprietà e le attività economiche (il campo,
la semina, il raccolto ecc.).
Gli dèi olimpici e la religione pubblica
Oltre alle divinità protettrici della propria casa, erano oggetto di culto anche gli dèi protettori dello stato, alla
cui tutela era preposta una gerarchia celeste con a capo Giove (Iuppiter), signore del cielo, garante della
grandezza e della potenza di Roma. Addetti alla religione pubblica erano appositi sacerdoti che facevano
parte di alcuni collegi sacerdotali a capo dei quali c'era il «Pontefice massimo» (Pontifex maximus).
Va comunque precisato che nell'antica Roma non esisteva una casta di sacerdoti «professionisti», depositari
di un sapere misterioso e di potere divini, come nell'antico Egitto o nel mondo ebraico: sacerdote della
religione familiare era, infatti, il paterfamilias e sacerdoti della religione di stato erano magistrati che avevano
percorso una normale carriera politica, ai quali veniva affidato il compito di eseguire puntualmente i riti
prescritti per assicurare alla comunità la benevolenza degli dèi. Fra collegi sacerdotali e istituzioni politiche
c'era dunque un legame molto stretto.
In ogni casa esisteva, accanto al focolare un piccolo tabernacolo (il larario) con dipinti, spesso sotto forma di piccole figure danzanti,
i Lari, ai quali ogni giorno venivano offerti fiori. Erano queste le divinità protettrici della casa e di chi in quel momento la abitava.
Ogni famiglia aveva poi gli dèi protettori della propria stirpe, i Penati, raffigurati in statuette di legno. A differenza dei Lari, i
Penati seguivano la famiglia nei suoi spostamenti. Anche la città aveva i suoi Penati: quelli di Roma, secondo il mito, furono trasportati da Troia nel Lazio da Enea e venivano custoditi a Lavinio, cioè nella città fondata, secondo la tradizione, dall'eroe (63-79
d.C).
La ricerca delta pax deorum: preghiere e sacrifici
La religiosità per l'uomo romano non consisteva nell'essere fedele ad un rapporto personale ed esclusivo con
un dio ritenuto «unico e vero» (si pensi alle grandi religioni monoteistiche), ma nel cercare in ogni
37
circostanza la benevolenza del dio tutelare dell'azione che stava per intraprendere. I Latini, per designare la
benevolenza degli dèi, usavano l'espressione pax deorum, che propriamente significa «pace degli dèi» e il
modo per ottenerla, sia nell'ambito della religione privata, sia in quello della religione pubblica, era la
esecuzione di un rito che doveva svolgersi con assoluta esattezza e precisione, con le formule e i gesti
previsti dalla tradizione.
Agli dèi venivano rivolte in primo luogo «invocazioni» e «preghiere» che potevano essere accompagnate
dalla supplicano, durante la quale il richiedente, prostrato davanti alla statua, abbracciava le ginocchia del
dio. La preghiera, sia nel culto pubblico che in quello privato, era talvolta accompagnata da offerte di corone
di fiori, di focacce, di prodotti agricoli (frutta, latte, vino) o di profumi (venivano ad esempio bruciati grani
d'incenso).
La forma più impegnativa di offerta era costituita dal sacrificio di animali, che erano diversi a seconda della
divinità da onorare: ad esempio a Giove veniva offerto un toro bianco, a Cerere una scrofa, alle divinità
sotterranee animali di colore scuro). Le vittime, maschi per gli dèi e femmine per le dee, dovevano essere
fisicamente perfette e dopo l'uccisione le loro carni venivano mangiate: solo le interiora, infatti, dopo che
erano state esaminate per ricavare presagi, venivano bruciate e offerte integralmente agli dèi. Il sacrifìcio di
animali era dunque un vero e proprio banchetto rituale.
Un tipico sacrificio, fatto dal paterfamilias ogni primavera per propiziare un buon raccolto, era quello di un
maiale, un montone e un toro, detto suovetaurilia dalle prime lettere delle tre parole latine che designano gli
animali sacrificati: sus (il «maiale»), ovis (il «montone»), taurus (il «toro»). Una delle cerimonie pubbliche più
solenni era il «lettisternio», un grande banchetto al quale, venivano «invitati» gli dèi, le cui statue,
opportunamente vestite, erano collocate a mensa accanto ai sacerdoti che celebravano il rito. In onore degli
dèi, sul modello etrusco e greco, venivano poi organizzati, a cura degli edili, pubblici spettacoli teatrali,
giochi e gare sportive.
Le divinità maggiori
Ecco, in ordine alfabetico, le divinità più importanti della religione pubblica romana: tutte sono state
assimilate a una divinità olimpica greca, ad eccezione di Giano, unico dio totalmente italico.
• Apollo (Apollo): introdotto a Roma e in Italia sia attraverso l’Etruria (si pensi all'Apollo di Veio) sia
direttamente dalle colonie greche, mantenne i caratteri propri del dio greco Apollo e non fu mai
completamente assimilato a divinità italiche. Come dio del sole, dispensatore di calore e di vita, era
protettore della salute degli uomini e delle greggi; come dio della poesia e della musica presiedeva il coro
delle nove Muse; a Roma però era soprattutto considerato il dio della divinazione e il suo oracolo a Delfi in
Grecia, dove la Pizia proferiva le sue oscure sentenze, era conosciuto in tutto il mondo antico.
• Cerere (Ceres): antica divinità italica della terra, era spesso associata nel culto alla Tellus Mater («Madre
Terra») in quanto datrice dei frutti dell'agricoltura, in particolare dei cereali, e come tale assimilata alla greca
Demètra. Come dea dell’agricoltura era considerata anche protettrice dell'annona (approvigionamenti) e
della pace.
• Diana (Diana): divinità italica della luce lunare assimilata poi alla greca Artemide, veniva considerata
protettrice dei boschi e della caccia. Il suo culto venne poi legato ai riti propiziatori per la fecondità non solo
della natura, ma anche degli uomini.
• Giano (Ianus): divinità italica che non ha corrispondente nel mondo greco. Protettore della porta (ianua) e
dell'arco, mezzi di accesso alla casa e alla città, veniva considerato dio degli inizi (da lui infatti prende il
nome Ianuarius, il primo mese dell'anno) e difensore della pace. Era rappresentato bifronte e le porte del suo
tempio nel Foro romano venivano chiuse in tempo di pace e aperte in tempo di guerra.
• Giove (Iuppiter): dio italico del cielo, di sicura origine indeuropea, presiedeva ai fenomeni atmosferici ed
era onorato con gli appellativi di Tonans («Tonante»), Pluvius («Pluvio») e Fulgurator («Folgoratore»).
Assimilato al greco Zeus, era capo e padre degli dèi e degli uomini, dispensatore dei beni e dei mali ai
38
mortali, simbolo della giustizia, protettore dello stato e garante delle promesse e dei giuramenti; per tutte
queste competenze era invocato come Optimus Maximus («Ottimo Massimo») e come tale presiedeva la
«Triade capitolina» (Giove, Giunone e Minerva), che dal tempio sul Campidoglio reggeva e guidava le sorti
di Roma.
• Giunone (Iuno): antica dea italica poi assimilata alla greca Era; sposa di Giove, era simbolo della
femminilità e protettrice delle donne in ogni fase della loro vita; infatti come Pronuba presiedeva alle nozze,
come Interduca conduceva là sposa alla nuova casa e come Lucina proteggeva le partorienti. Divenne poi
un'importante dea dello stato e con l'appellativo di Regina costituiva con Giove e Minerva la Triade venerata
nel tempio sul Campidoglio (v. Giove).
• Marte (Mars): principale dio italico dopo Giove; era in origine una divinità agreste (da lui infatti prende
nome Martius il primo mese della primavera), espressione di un popolo dipendente dall'agricoltura per le
risorse alimentari, ma spesso impegnato nella guerra; assunse quindi anche gli attributi di divinità guerriera
e, assimilato al greco Ares, divenne il dio della guerra. A Roma godeva di onori particolari in quanto
simbolo della potenza della città e padre di Romolo. Per il suo culto il re Numa aveva istituito il collegio dei
sacerdoti Salii.
• Mercurio (Mercurius): dio dei mercati e del commercio. Non c'è traccia a Roma o in Italia di un suo culto
primitivo, si deve quindi dedurre che fosse lo stesso dio greco Ermes introdotto a Roma con il nome che
ricordava le sue attività mercantili (mercari, «commerciare»).
• Minerva (Minerva): dea italica protettrice della città e dei mestieri, aveva originariamente attributi più
domestici che guerrieri. Quando fu assimilata alla greca Atena divenne, oltre che protettrice delle arti e delle
scienze, anche dea della guerra, intesa come perizia e capacità strategica contrapposta alla forza e alla
violenza di Marte. Il suo culto si affermò a Roma dopo l'introduzione della Triade capitolina di cui Minerva
faceva parte.
• Nettuno (Neptunus): dio italico delle acque ma non del mare; solo la successiva identificazione con il greco
Poseidone, dio del mare, estese il suo culto anche in tal senso. A Roma era soprattutto onorato come
Neptunus Equester, protettore dei cavalli e delle corse nel circo.
• Plutone (Pluto): sovrano del regno dell'oltretomba, era anche il dio sotterraneo che alimentava la
vegetazione e donava o celava agli uomini le ricchezze minerali nascoste nel sottosuolo. Assimilato al dio
greco Ade, era onorato a Roma anche col nome di Dite (cfr. dives, «ricco») personificazione della ricchezza.
• Quirino (Quirinus): dio di origine sabina, era venerato fin dai tempi più antichi sul Quirinale. Era collegato
agli aspetti più civili (attività economiche) della Roma arcaica e faceva parte dell'antica triade posta a difesa
dello stato insieme a Giove e a Marte. Quirinus era l'epiteto di Romolo divinizzato e Quirites erano chiamati i
cittadini romani.
• Saturno (Saturnus): antica divinità italica della semina (cfr. sero, «seminare»; satus, «seminagione») fu più
tardi assimilato con il greco Cronos e gli furono quindi attribuiti i caratteri di quest'ultimo: era padre di
Giove, Giunone, Cerere, Plutone e Nettuno e veniva ritenuto il re dell'antico Lazio durante la mitica Età
dell'Oro. In memoria dell'aureo regno di Saturno (Saturnia regna) a Roma, dal 17 al 19 dicembre, si
celebravano i Saturnali (Saturnalia) durante la quale tutti si scambiavano doni, gli schiavi erano serviti a
tavola dai padroni e ognuno si divertiva mangiando e bevendo in allegria.
• Venere (Venus): dea italica originariamente legata al culto della rinascita primaverile della natura e quindi
della fertilità. In seguito all'assimilazione con la greca Afrodite divenne dea della bellezza e dell'amore. A
Roma era venerata anche come datrice di vittoria, protettrice della concordia civile e come genitrice (Venus
Genetrix) della stirpe del troiano Enea e della gens Iulia.
• Vesta (Vesta): dea del focolare, dell'economia e della vita domestica, equivalente alla greca Hestìa. Il sacro
fuoco che ardeva nel suo tempio e che era simbolo del focolare dello stato non doveva mai spegnersi ed era
custodito dalle Vestali.
• Vulcano (Vulcanus): antico dio italico del fuoco, in particolare quello vulcanico. Era venerato a Roma fin
dai tempi più antichi con l'epiteto di Mulciber («colui che ammollisce, che fonde [il ferro]»). Assimilato poi al
greco Efesto, aveva la sua officina nelle viscere dell'Etna dove, come fabbro degli dèi, eseguiva mirabili opere
in metallo con l'aiuto dei Ciclopi; per tale motivo era ritenuto dio della lavorazione dei metalli.
39
Rilievo dell'ara dei Vicomagistri, raffigurante un corteo sacrificale con tre tori, vittimari, musici, littori. I Vicomagistri erano i capi
dei vici o quartieri della città, a cui Augusto affida dal 18 a.C. i Lari della sua casa, che diventano così protettori di tutta la città (30-40
d.C, Città del Vaticano, Museo Gregoriano Pagano).
Una preghiera privata...
Ecco il testo di un'antichissima preghiera rivolta a Marte (in origine, come abbiamo già detto, dio agricolo)
dal padrone di un campo nel corso di una ceri-monta che culminava con il suovetaurilia Si osservi la
minuziosa e pedante specificazione di tutto quanto viene offerto e di tutto quanto viene richiesto in cambio:
par di leggere le clausole di un contratto, e in effetti, il rapporto con gli dèi si pone nella Roma antica in
termini strettamente «contrattualistici». Il testo ci è tramandato da Catone in un trattato sull'agricoltura
composto nel II secolo a.C.
Padre Marte, ti prego e ti chiedo di essere benevolo e propizio a me, alla mia casa e alla mia famiglia. Per
questo dunque ho fatto condurre
attorno al campo, alla terra e al mio fondo, un porco, un montone e un toro perché tu tenga lontano,
respinga e storni le malattie visibili e invisibili, la sterilità del suolo e la devastazione, le calamità e le
intemperie e perché tu permetta la crescita e la buona riuscita delle messi, del frumento e delle giovani
piante e conservi sani e salvi i pastori e il bestiame e dia buona salute e prosperità a me, alla mia casa e alla
mia famiglia.
... e una pubblica Ed ecco il testo di una «preghiera ufficiale», il Carmen saeculare, un inno agli dèi
protettori di Roma, composto dal poeta Quinto Orazio Flacco in occasione dei «Ludi secolari», una grande
celebrazione politica e religiosa insieme, voluta da Augusto nel 17 a.C. per celebrare l'inizio di una nuova era
di pace e di prosperità. Di questa celebrazione noi possediamo il «verbale», pervenutoci grazie a un'epigrafe,
in cui vengono accuratamente descritte tutte le cerimonie compiute nei tre giorni dei Ludi, dalla notte del 31
maggio sino al 3 giugno, cerimonie che culminarono con il canto del Carmen da parte di un coro di
ventisette ragazzi e ventisette ragazze, dapprima sul Palatino e successivamente sul Campidoglio. Del
Carmen saeculare, un componimento molto lungo e complesso, proponiamo le prime strofe in traduzione.
Febo1 e signora delle selve Diana,
chiare gemme del cielo; venerandi
e venerati sempre: udite il canto
di scelte vergini
e di fanciulli puri che prescrisse
la Sibilla2 di volgere agli dèi,
cui furon cari i sette colli, al compiersi
del tempo sacro.
Almo Sole, che sul brillante carro
porti e ci togli il giorno e vario e uguale
40
nasci, di Roma nulla mai il tuo raggio
veda più grande.
(Trad. E. Centrangolo)
1. «Febo» è epiteto di Apollo, divinità solare, e significa propriamente «il Luminoso».
2. La celebrazione dei Ludi saeculares era dunque prescritta da un oracolo dei libri Sibillini e doveva contrassegnare il passaggio a
un nuovo ciclo di anni, a una nuova era.
41