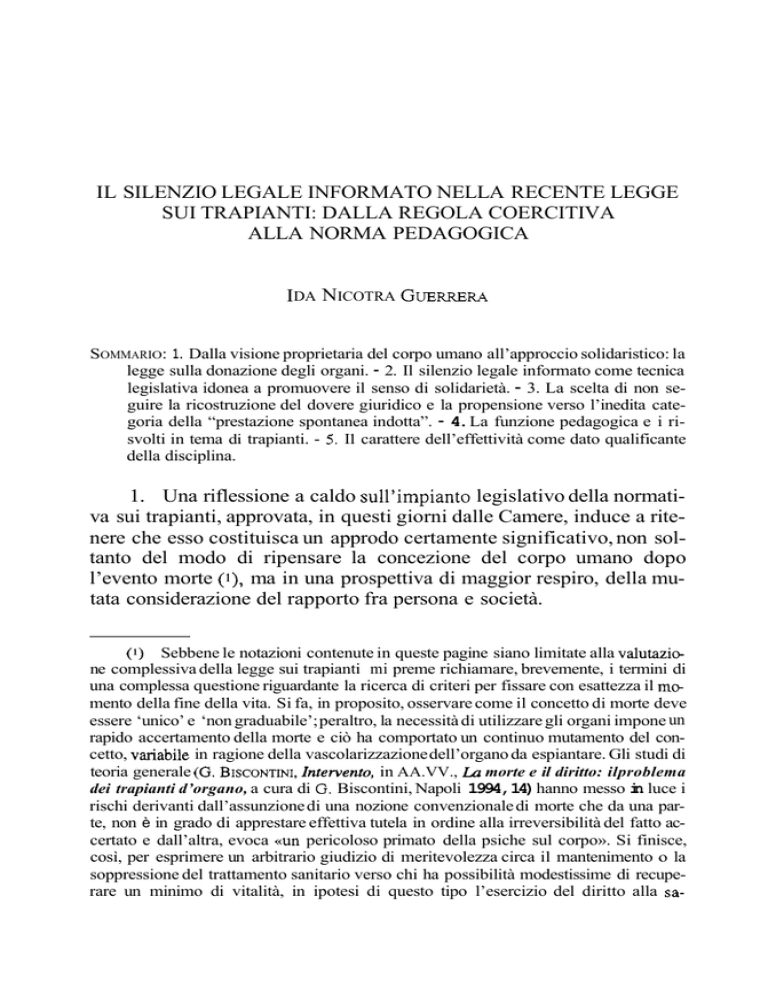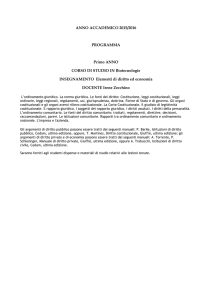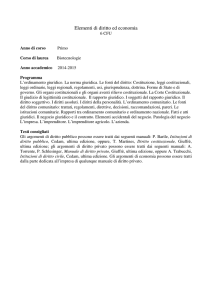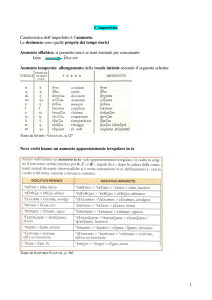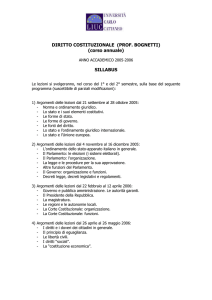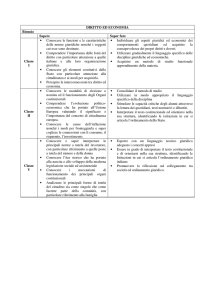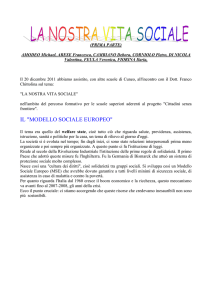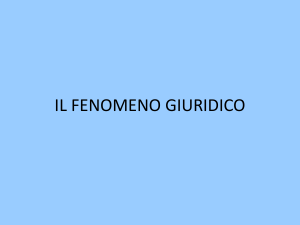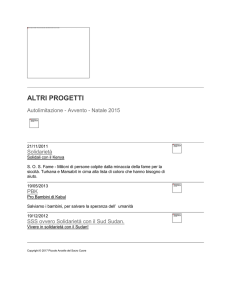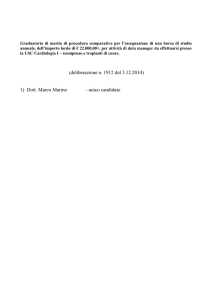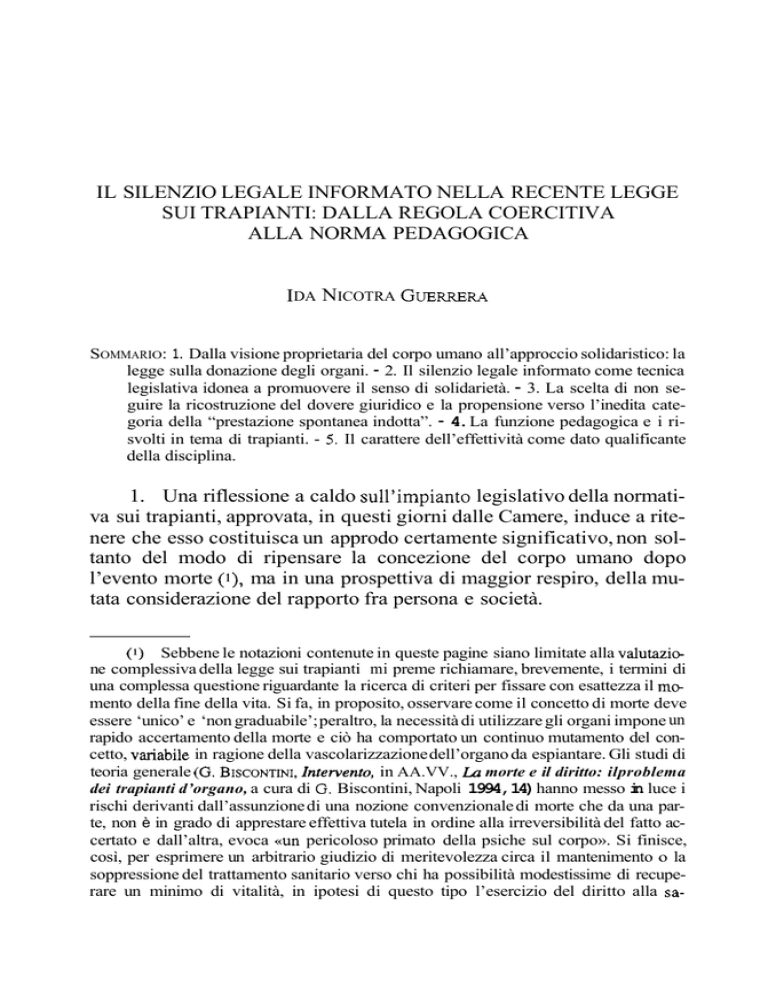
IL SILENZIO LEGALE INFORMATO NELLA RECENTE LEGGE
SUI TRAPIANTI: DALLA REGOLA COERCITIVA
ALLA NORMA PEDAGOGICA
IDA NICOTRA GUERRERA
SOMMARIO: 1. Dalla visione proprietaria del corpo umano all’approccio solidaristico: la
legge sulla donazione degli organi. - 2. Il silenzio legale informato come tecnica
legislativa idonea a promuovere il senso di solidarietà. - 3. La scelta di non seguire la ricostruzione del dovere giuridico e la propensione verso l’inedita categoria della “prestazione spontanea indotta”. - 4. La funzione pedagogica e i risvolti in tema di trapianti. - 5. I1 carattere dell’effettività come dato qualificante
della disciplina.
1. Una riflessione a caldo sull’impianto legislativo della normativa sui trapianti, approvata, in questi giorni dalle Camere, induce a ritenere che esso costituisca un approdo certamente significativo, non soltanto del modo di ripensare la concezione del corpo umano dopo
l’evento morte (I), ma in una prospettiva di maggior respiro, della mutata considerazione del rapporto fra persona e società.
(1)
Sebbene le notazioni contenute in queste pagine siano limitate alla valutazie
ne complessiva della legge sui trapianti mi preme richiamare, brevemente, i termini di
una complessa questione riguardante la ricerca di criteri per fissare con esattezza il m e
mento della fine della vita. Si fa, in proposito, osservare come il concetto di morte deve
essere ‘unico’ e ‘non graduabile’; peraltro, la necessità di utilizzare gli organi impone un
rapido accertamento della morte e ciò ha comportato un continuo mutamento del concetto, vanabile in ragione della vascolarizzazione dell’organo da espiantare. Gli studi di
Intervento, in AA.VV., La morte e il diritto: ilproblema
teoria generale (G. BISCONTINI,
dei trapianti d’organo, a cura di G. Biscontini, Napoli 1994,14) hanno messo in luce i
rischi derivanti dall’assunzione di una nozione convenzionale di morte che da una parte, non è in grado di apprestare effettiva tutela in ordine alla irreversibilità del fatto accertato e dall’altra, evoca «un pericoloso primato della psiche sul corpo». Si finisce,
così, per esprimere un arbitrario giudizio di meritevolezza circa il mantenimento o la
soppressione del trattamento sanitario verso chi ha possibilità modestissime di recuperare un minimo di vitalità, in ipotesi di questo tipo l’esercizio del diritto alla sa-
830
IDA NICOTRA GUERRERA
L’orientamento, rimasto per lungo tempo dominante, era imperniato sull’idea squisitamente individual-proprietaria (2) alla cui stregua il
corpo umano nella sua interezza, al momento del decesso, rimane di assoluta pertinenza del de cuius (3) e dei congiunti (4). La scissione fra
l’elemento corporeo e quello immateriale che si verifica dopo la morte,
non cancellando del tutto l’immedesimazione tra persona e corpo, giustifica il fatto che l’ordinamento abbia dato rilevanza alla determinazione del soggetto circa la sorte del proprio cadavere.
Sulla scorta di tale indirizzo si è, gioco forza, ritenuto che la facoltà
dispositiva sul cadavere fosse di pertinenza del soggetto che, in vita, ha
espresso una precisa volontà circa la sua destinazione post rnortern (5).
lute non potrebbe, comunque, essere condizionato da rinunce preventive operate da terzi. Soltanto dinanzi ad un accertamento che attesti in maniera irreversibile la morte si p e
trà procedere al prelievo. Una forte resistenza sul piano etico viene espressa in riferimento alla concezione secondo cui la persona da poco morta possa essere ritenuta alla
stregua di una risorsa. Si prende in considerazione la condizione di un soggetto da poco
deceduto ma con qualcuna delle qualità associate alla vita, che viene mantenuto in quello stato per il tempo occorrente al prelievo. W. GAYLIN, (Harvesting the dead, in Harper, 23 settembre 1974, 23 ss. richiamato da D. LAMB, Il confine della vita, Bologna,
1987, 165) parla di ‘neomorti’, «mantenuti in uno stato di vitalità cellulare ai fini di trapianto» e giudica questo fenomeno come una forma di corruzione morale. In definitiva,
si giunge ad una logica che differenzia le situazioni, lasciando al personale medico la decisione di ‘staccare la spina’ se non ci sono richieste immediate di organi da trapiantare
o di mantenere la respirazione artificiale soltanto qualora si debba procedere all’asportazione. La questione - come si comprende bene - finisce per intersecarsi con le delicatissime tematiche relative alla eutanasia, su cui sia consentito rinviare a, I. NICOTRA
GUERRERA, ‘Vita’ e sistema dei valori nella Costituzione, Milano, 1997, 140 ss.
(2)
L’abolizione della schiavitù dovuta al Cristianesimo ha escluso dall’ambito della logica proprietaria un altro soggetto ma non il proprio corpo, il quale è la prima ‘res’
del diritto di proprietà, sebbene ad esso si applichi una differente disciplina da quella delle cose commerciabili; cfr. F. CARNELUTTI,
Come nasce il diritto, Torino, 1958, 26.
(3)
La dottrina prevalente preferisce inquadrare il diritto sul proprio cadavere
nella categoria dei diritti su cose future extra commerciurn; rientrante, altresì, fra i diritti della personalità, cfr., P. PERLINGIERI, La personalità umana nel1 ’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, 319; G. CIAN - A. TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, Padova, 1992, 92; G. ALPA - A. ANSALDO,
Le personefisiche, Milano, 1996, 266;
C. RUPERTO - V. SGROI, Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile, Milano,
1994, 366; Commentario al codice civile, diretto da P. Cendon, I, Torino, 128.
(4)
G.A. BELLONI, I morti per la salvezza dei vivi, in Giust. pen., 1951, I, 408; J.
SAVATIER,
Le problème des greffes d’organes prèleves sur un cadavre, in Foro it.,
1968, V, 69; G. GEMMA, Questioni in tema di trapianti: profili di illegittimità costituzionale, in Riv. dir proc. civ., 1970, 1000 ss.
(5)
P.M. VECCHI, Trapianti e trasfusioni (dir. civ.), in Enc. giur., XXXI, Roma
1994, 9; L. MEZZANOTTE, Trapianti e trasfusioni, (diritto comparato e straniero), ivi, 1.
IL SILENZIO LEGALE INFORMATO
83 1
Così, nel rispetto di una consolidata e risalente regola sociale, il
primo intervento del legislatore stabilì la liceità del prelievo di parti del
cadavere a scopo terapeutico soltanto nell’ipotesi in cui la volontà individuale attesti, in maniera inequivocabile, l’intenzione di consentire
( 6 ) . I1 significato da attribuire ad un comportamento silenzioso era obbligato nel senso di una precisa volontà di vietare a chiunque una utilizzazione diversa dalla normale sepoltura, con la sola eccezione del
consenso espresso da parte del coniuge o dei parenti più prossimi (7).
L’affermarsi della consapevolezza di dover far fronte ad interessi di
elevato valore sociale ha gradualmente affievolito l’assolutezza del
principio della piena facoltà dispositiva, consentendo l’emersione del
profilo di utilità, funzionale alla promozione della vita e della salute (*),
attraverso l’espianto di organi.
Allora, il costume ha lentamente cominciato a modificarsi, modellandosi sul principio solidaristico, retto dalla necessità di attuare, anche
nel campo del diritto alla salute, una disciplina fondata sulla eguaglianza sostanziale al fine di rimuovere, mediante gesti di fratellanza da parte della collettività, gli ostacoli al pieno godimento dell’esistenza umana. Tuttavia, l’erosione di un modo di pensare radicato da tempo immenorabile nelle coscienze individuali - incentrato sul valore preminente della pietus (9) verso il defunto e della decisione manifestata
‘sull’oggetto’ che aveva costituito la sua stessa persona - richiedeva un
periodo di maturazione collettiva.
(6)
Cfr. art. 1 1. 3 aprile 1957, n. 235; nonché art. 5, d.P.R. 20 gennaio 1961, n.
300.
(7)
In mancanza di una dichiarazione scritta attestante la volontà di donazione
degli organi, la legge riconosceva ai figli maggiori di età, ai coniuge o ai genitori la
possibilità di opporsi al prelievo sul corpo del congiunto, eccezion fatta in cui il cadavere veniva sottoposto a riscontro diagnostico o ad autopsia per superiori esigenze di
giustizia (art. 6, comma 2, 1. 2 dicembre 1975, n. 644;art. 1 1. 12 agosto 1993, n. 30).
Sulle ragioni che hanno indotto parte della dottrina ad esprimersi criticamente sulla ammissibilità dei parenti di opporsi al prelievo, per tutti, G.GIACOBBE, Trapianti, in Enc.
dir., XLIV, Milano, 1992, 897.
R. LANZILLO, Trapianti di organi e diritti sul proprio corpo, in Corr. giur.,
(8)
1989, 119; P. PICOZZA,
Trapianti e trasfusioni, (diritto canonico), in Enc. giur., XXXI,
Roma, 1994, 9.
(9)
Il senso di rispetto verso il cadavere era già fortemente sentito nel diritto romano ed ha portato non soltanto alla disciplina giuridica del cadavere ma anche alla
enucleazione dello ius eligendi sepulchrum, cfr., in proposito, C. SANFILIPPO, Zstituzioni di diritto romano, Catania, 1982, 67; G. ALPA - A. ANSALDO, Le personefisiche, cit.,
266.
832
IDA NICOTRA GUERRERA
È probabilmente questa la ragione, assai condivisibile (IO), della
scelta legislativa odierna che non ha osato porre in discussione la regola secondo cui non si possa prescindere del tutto dalla volontà del soggetto, ma, che, tuttavia, ha modificato la prospettiva tradizionale, conferendo valore unicamente alla manifestazione di volontà personale,
escludendo che i parenti possano opporsi al prelievo sul corpo del congiunto.
La rilevanza data al consenso esprime il contemperamento tra approccio individualista e visione sociale, secondo la nota configurazione
(11) della libertà, intesa non come garanzia di isolamento egoistico ma
come stimolo di responsabilità verso l’interesse collettivo. Insomma,
l’agevolazione del sentimento di adesione alla scelta solidaristica è avvenuta senza traumi, scartando l’ipotesi, peraltro paventata, di giungere
alla positivizzazione della cd. funzione pubblica del cadavere (12).
L’aver individuato, sull’esempio della legislazione francese e belga ( 1 9 , nell’accettazione presunta, la condizione minima indispensabile
per permettere la donazione costituisce una risposta conforme al rispetto costituzionale della dignità di cui il soggetto, anche dopo la vita, rimane ancora partecipe. In una società basata sulla centralità della persona non può, coerentemente, residuare spazio per discipline che ridu-
(10)
Infatti, il principio di una costruttiva gradualità i?
tipica di un sistema democratico in cui già la prospettazione di totali e repentine trasformazioni equivale a porsi
fuori dal gioco democratico «esaltato allora soltanto come cortina fumogena dietro la
quale si celano le intenzioni di un simile massimalismo, che ben sappiamo quanto sia
causa di involuzioni e reazioni ritardatrici di ogni progresso», R. BAUER,Un progetto
di democrazia, Bologna, 1996, 224.
(11)
V. ATRIPALDI, Il catalogo delle libertà civili nel dibattito, in Assemblea Costituente, Napoli, 1979, 21.
(12)
P. PERLINGIERI,
La Personalità umana nell ’ordinamento giuridico, Napoli,
1972, 318; G. GEMMA, Questioni in tema di trapianti, cit., 1000.
(13)
Nell’ordinamento d’oltralpe la nomativa sui trapianti autorizza il prelievo
qualora il soggetto in vita non ha espressamente dichiarato il suo rifiuto, in Belgio una
legge del 1986 prescrive che la volontà del donatore venga inserita in appositi registri
predisposti dalla amministrazione, e trasmessi in una Banca dati del Ministero, sicchè
prima di procedere all’espianto su persona deceduta vi è l’obbligo di verificare l’esistenza di una opposizione espressa; v. L. MEZZANOTTE, Trapianti, cit., 2. La disposizione contenuta nell’art. 671-7 della legge francese n. 94-654 del 29 luglio 1994 stabilisce che il prelievo di organi «può essere effettuato dal momento che la persona interessata non ha fatto conoscere, mentre era in vita, i1 suo rifiuto ad un tale prelievo». Per
un commento alla disciplina cfr., G. FERRANDO, Appunti sulle leggifrancesi relative al
rispetto del corpo umano, in Pol. dir., 1995, 315 ss.
IL SILENZIO LEGALE INFORMATO
833
cono il singolo a mera ‘cosa’ ( 1 9 , conferendo allo Stato la pretesa di decidere circa la destinazione del cadavere, neanche facendo appello alla
enucleazione della categoria dei c.d. diritti ‘transociali’ ( 1 5 ) . L’elevazione della dignità umana a valore non declinabile in via assoluta (16)
impone l’adozione di una disciplina che rifiuta la tesi della illimitata
soggezione del cittadino alle esigenze del gruppo presente nelle società
a vocazione collettivista e che ha condotto talune Costituzioni a sancire il diritto dello Stato sulla salma del cittadino (17), affermando la pretesa ad una vera e propria ‘espropriazione per pubblica utilità’ (18).
2. Merita, in particolare, qualche notazione la previsione contenuta nell’art. 1 della legge varata da recente ove si afferma che <<icittadini sono tenuti a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione» (19). L’interesse suscitato dalla norma dipende, in particolare, dalla tecnica adottata ai fini dell’interpreta-
Cfr., G. BISCONTINI, intervento, cit., 9 ss.
F. MASTROPAOLO, Il diritto alla vita e alla integrità tra biotecnica e bioetica, in Scritti in onore di A. Falzea, 11, 2, Milano, 1991, 555; G. GIACOBBE, Trapianti,
in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 892; L. MEZZANOTTE, Trapianti, cit., 1.
(16) Sul valore oggettivo e indisponibile della dignità umana che non tollera né
la libertà del singolo di autodegradarsi, né una tutela da parte dello Stato a favore di chi
rinuncia spontaneamente ai diritti fondamentali, F. BARTOLOMEI, La dignità umana come concetto e valore costituzionale, Torino, 1987, in part. 89, ma passim; A. RUGGERI
- A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in
Pol. dir., 1991, 237.
(17)
P. PICOZZA,
Trapianti e trasfusioni, cit., 8.
(18)
L‘espressione - come è noto - appartiene a F. CARNELU-ITI,Problema
giuridico della trasfusione di sangue, in Foro it., 1938, IV, 89.
(19) La disposizione contenuta al c o m a 4 dell’art. 4 del medesimo testo stabilisce, altresì, che il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di
morte è consentito: a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti, ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto
stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole al prelievo, nonché b)
qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti risulti che il soggetto sia
stato informato ai sensi del decreto del Ministro della sanità e non abbia espresso alcuna volontà. L‘unica eccezione alla disciplina è costituita dall’ipotesi in cui «entro il termine comspondente al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte (... )
sia presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del soggetto
di cui si è accertata la morte».
(‘4)
(15)
834
IDA NICOTRA GUERRERA
zione del volere della persona circa l’effettuazionepost rnorrern del trapianto di organi; si è preferito, in questa occasione, utilizzare il meccanismo del valore legalmente predetenninato della condotta omissiva.
A prima vista, l’interpretazione normativa del silenzio potrebbe apparire un congegno come un altro per imprimere un profilo di certezza
ad una volontà inespressa. Con parole diverse, la valenza ‘avalutativa’
(20) di un simile modo di procedere starebbe insieme con l’esigenza di
semplificare il procedimento, accertando la decisione con una sorta di
presunzione assoluta, qualora il soggetto in vita non abbia esplicitamente negato il proprio assenso.
Credo che la previsione sul silenzio assenso contenuta nella legge
soddisfi una esigenza, solo in apparenza avulsa dal contesto nel quale
si trova inserita. Infatti, la circostanza che il silenzio sia legalmente valutato in senso positivo sortisce, in sostanza, l’effetto di trasformare una
modalità di conoscenza del pensiero in strumento di adesione del singolo alla linea prescelta dal legislatore: «se taci aderisci all’orientamento della legge».
È innegabile che la casistica del silenzio tipizzato non è estranea al
nostro legislatore, che esprime, con esso, uno dei molteplici risvolti del
suo agire discrezionale; è altrettanto vero, tuttavia, che nella generalità
dei casi, il significato attribuito al comportamento omissivo costituisce
il risultato dello sforzo di ricercare l’interesse di chi tace, ragionevolmente desumibile dal volere rimasto non estemato (21).
Dalla indagine sulla volontà presunta nasce, talvolta, il silenzio assenso, talaltra, quello attestante un atteggiamento dissenziente: la richiesta di un consenso manifesto corrisponde - come è ovvio - ad
una accezione negativa del contegno omissivo.
L’aspetto singolare della vicenda presa in esame consiste nella difficoltà oggettiva di attribuire alla mancata esternazione un preciso significato secondo il criterio del comportamento dell’uomo medio (22),
non essendo individuabile, alla stregua di normali canoni presuntivi, il
(*O)
Per un analisi del linguaggio politico legislativo e le sue implicazioni si può
leggere lo scritto di A. PASSERIN DENTREVES,
La jìlosojìa della politica, in Storia delle idee politiche economiche e sociali, VI, a cura di L. Firpo, Torino, 1972, in particolare, 593.
(2’)
A. LA TORRE, Silenzio (dir. priv.), in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 554,
ove, appunto, si sottolinea come una valutazione normativa della condotta omissiva come assenso appare adeguata alle ipotesi in cui è presumibile una siffatta volontà anziché quella contraria.
G.CASTIGLIA, Silenzio (dir. priv), in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, 1.
(22)
IL SILENZIO LEGALE INFORMATO
835
volere individuale. È facile comprendere le difficoltà insite nella ricostruzione dell’ intentio: così come, secondo una prospettiva di segno
marcatamente individualista, il senso di affezione o di attaccamento
della persona alla sua fisicità potrebbe far propendere per il diniego e
per una sepoltura che conservi, nella sua integrità, il corpo umano; parimenti, una visione più incline a valorizzare l’aspetto sociale della condivisione e dell’altruismo indurrebbe al differente convincimento circa
l’elevato senso della donazione.
Sembra, in tal modo, profilarsi una scelta, in un certo senso, indipendente dal presunto discernimento personale ed agganciata, piuttosto,
a principi di rilievo costituzionale. I1 contemperamento dei valori in
gioco costituisce il dato qualificante del]’attività legislativa, ove i molteplici interessi coinvolti possiedono, ciascuno, una copertura nel Testo
fondamentale.
Accanto al diritto alla salute, alla vita, alla solidarietà viene giustapposto dal Costituente il rispetto per la libertà di autodeterminarsi,
nonché quello per la disponibilità del proprio corpo, secondo il disposto dell’art. 13, e ribadito, in via ordinaria, nell’art. 5 C.C.(23).
L’esistenza, nella norma appena ricordata, di un aggancio costituzionale al principio personalistico sembra includervi la facoltà dispositiva del singolo con riguardo al proprio corpo, anche dopo la morte. La
garanzia della libertà personale stabilita nell’art. 13, nei confronti di chi
è in vita deve trovare, invero, applicazione estensiva imposta da altro
valore supremo. I1 fondamento del dato espansivo va rintracciato nella
tutela riservata alla dignità che non viene dismessa, anche da chi non è
più in vita, esprimentesi, nel rispetto della salma e costitutiva del ‘bene’ protetto nelle figure di reato sanzionatone di comportamenti contrari al sentimento di rispetto verso i defunti (24).
La critica a tale ricostruzione potrebbe trovare un qualche appiglio
(23)
In un precedente studio (I. NICOTRA GUERRERA, Vita e sistema, cit., part. 33
ss., ma passim) si è avuto modo di dimostrare l’approssimazione concettuale che sta
dietro alla nozione di indisponibilità, elemento qualificante dei c.d. diritti personalissimi.La disposizione contenuta nell’art. 5 c.c., in realtà, sancisce la regola della relatività sugli atti dispositivi del proprio corpo, ammettendo - come è noto - che il limite di disporre possa essere superato con il consenso dell’avente diritto, anche per atti
che comportano lesioni permanenti dell’integrità fisica, compiuti in vista della soddisfazione di un superiore dovere morale.
A. DE CUPIS, Cadavere (diritto sul), in Dig. disc. privatistiche, 11, Torino,
(24)
1988, 191; G. FIANDACA - E. MUSCO,Diritto penale, parte speciale, I, Bologna, 1997,
336.
836
IDA NICOTRA GUERRERA
nella previsione contenuta nell’art. 42, in cui il Costituente lambisce la
questione relativa alla facoltà di disposizione del de cuius, affermando
la nota regola secondo cui la legge stabilisce i limiti alla successione e
dispone norme sui diritti dello Stato sulla eredità (25).
Dalla facoltà del legislatore di imporre limitazioni ad un atto dispositivo del de cuius si potrebbe, forse, trarre il più generale principio
che ammette la possibilità di circoscrivere le ultime volontà per le questioni non patrimoniali, escludendo la possibilità di far dipendere
l’espianto dalla sua decisione. Peraltro, il carattere imprescrittibile della dignità impone una lettura restrittiva del principio appena richiamato, che va applicato alle sole vicende del de cuius, comunque suscettibili di valutazione economica.
La ragionevolezza della opzione legislativa non va, perciò, soltanto commisurata alla reazione della opinione pubblica per l’effetto che
avrebbe potuto sortire, contravvenendo ad un sentimento diffuso di osservanza della volontà personale, (in segno di attaccamento alla proiezione di sé anche dopo il passaggio alla vita ultraterrena), ma va, soprattutto, stimata per l’aderenza al dettato costituzionale circa la valenza prioritaria della questione antropologica (26).
Nondimeno, anche ove prevalesse la differente impostazione volta
a privilegiare la promozione costituzionale della vita umana e della salute, concependo i doveri come modalità di rispetto dei diritti inviolabili (29, la conseguenza più preoccupante di una disciplina che imponesse l’espianto di organi non sarebbe tanto quella che su di essa venisse proposto ed approvato un referendum (28) abrogativo, quanto l’atteggiamento di rifiuto dei cittadini nei confronti di un gesto di solidarietà imposto per legge. Alla luce della visione solidaristica accolta nella Carta (29) bisognava, dunque, comporre in una armonica sintesi, l’antinomia individualismo-collettivismo.
(25)
Sul significato di tale disposizione si può leggere il mio Contributo alla condizione di ex cittadino (da un “caso” di disposizione della quota di legittim), in Dir.
SOC., 1995, 262.
(26)
Cfr. F. WALHNER, Autocoscienza e società umana sotto l’aspetto antropologico, in Individuo, collettività e Stato, I, Palermo, 1983, 69 ss.
(27)
L’impostazione è seguita, fra gli altri, da A. CERRI, Doveri pubblici, in Enc.
giur, XII, Roma, 1989, 2.
(28)
R. ROMBOLI, Commento sub art. 5, in Commentario del codice civile, Libro
I, Persone efamiglia, Roma-Bologna, 1988, 369.
(29)
La problematica è affrontata specificamente da N. OCCHIOCUPO,
Liberazione e promozione umana nella Costituzione, Milano, 1988, passim.
IL SILENZIO LEGALE INFORMATO
837
Se così è, il silenzio assenso rappresenta la soluzione congeniale
per accostare il cittadino al valore solidaristico; l’osservazione (30) convincente che sia da considerare assai improbabile che una persona si dia
cura in vita di dichiarare esplicitamente il proprio dissenso all’espianto
di organi avvalora l’opinione esposta circa il motivo primario della determinazione legislativa.
L’accettazione silenziosa risulta una tecnica, anche raffinata, di comunicazione per promuovere nel cittadino un sentimento solidale, per
orientare le scelte individuali lungo la direttrice costituzionale degli
adempimenti di solidarietà sociale. La posizione non è neutrale al cospetto di una duplice alternativa comunque costituzionalmente legittima; per molti aspetti, l’ordinamento sceglie nel modo di porsi nei confronti dei consociati un atteggiamento di favore verso la socialità, a detrimento di un individualismo, forse anche, esasperato (31). Lo sforzo
del legislatore si è mosso nella direzione di dar maggior rilievo alla formazione sociale, alla comunità dei vivi (32), realizzando nell’altruismo
la cooperazione per offrire, a tutti - secondo il precetto dell’art. 3, 2
c o m a - migliori chances anche rispetto alla salute come bene fondamentale della collettività (33). Si delinea una cornice chiara in cui la
legge rappresenta un ulteriore tassello per configurare una concezione
A. LA TORRE, Silenzio (dir. priv.), cit., 558, nt. 33.
Al riguardo si rinvia alle mirabili riflessioni di F. D’AGOSTINO,
Accoglienza
della vita in un ’epoca di secolariuazione, in Orientamento scolastico e professionale,
1976, 6539; ID., Irrinunciabilitù e irrealiuazione dei diritti dell’uomo, in Studi in onore di L. Spinelli, IV, Modena, 1989, 1348 ss. Da altra angolatura la trasformazione
dell’agire sociale verso un modello che abbandona l’approccio individualista, per preferire il gruppo come strumento per l’affermazione delle proprie esigenze è posta in luce da C. ROSSANO,La finzione del partito nelle democrazie occidentali, in Individuo,
collettività, cit., 181, ove si sostiene che il «passaggio dall’uomo individualmente considerato» al socius, come soggetto ‘situato’ è reso possibile solo quando si determina
tra i componenti il rapporto di solidarietà.
(32)
Senza aderire alla antica impostazione della funzionalizzazione dei diritti
non si può, comunque tacere, che il modello prescelto dal Costituente sia incentrato
sull’idea che l’esercizio delle libertà risulti in armonia con gli obiettivi perseguiti
dall’ordinamento; V. ATRIPALDI, Il Catalogo delle libertù, cit., 35, laddove si legge la
previsione contenuta nell’art 6 dell’articolato che accompagnava la relazione La Pira in
cui si dice che la libertà «deve servire per elezione al bene supremo e personale di ciascuno ed a quello comune, solidale e fraterno di tutti».
(33)
Per tutti, in proposito, M. LUCIANI,
Il diritto costituzionale alla salute, in
Dir. SOC., 1980, 779 ss.
(30)
(31)
838
IDA NICOTRA GUERRERA
dell’uomo incentrata sul momento relazionale con la società, attraverso
una composizione della dialettica benefici-sacrifici (34).
Si cerca una consonanza di vedute che - lasciando in ogni caso a
ciascuno, conformemente al principio autodeterministico, la possibilità
di pensarla diversamente, di non omologarsi - allontani l’affermazione di modelli a sfondo collettivista (35).
3. Una conseguenza di non trascurabile rilievo scaturisce dalle
notazioni fin qui svolte, connessa alla opportunità di interpretare correttamente il dato costituzionale. In modo appropriato si è, infatti, evitato di decodificare l’atto di solidarietà in tema di trapianti alla stregua
di un ‘dovere’, facendo, per così dire, passare la richiesta di prestazioni solidaristiche attraverso il filtro di una qualche forma negoziale. Sicché, l’ordine giuridico costruisce una prestazione soggettiva non caratterizzata dalla bilateralità del rapporto, in virtù della quale, tradizionalmente, si pone una correlazione necessaria con il diritto altrui, ovvero
con poteri destinati ad assicurare l’osservanza di un obbligo sia per via
di surrogazione, sia ricollegando all’inadempienza una sanzione (36).
Questo pare il punto cruciale: la caratterizzazione di un comportamento di altruismo non viene creato all’insegna del dovere, ma rimane
nell’ambito di disponibilità della persona; non si segue, cioè, la strada,
del comando giuridico. A mio avviso ciò dipende dalla consapevolezza
del ‘politico’ che il diritto si trova a gestire, in tale evenienza, un dato
prima che giuridico, etico e sociologico (37). Se il principio solidaristico risponde, anzitutto, all’esigenza di orientare verso l’altruismo e il reciproco sostegno tra gli appartenenti al gruppo, esso si coniuga con il
(34)
Sull’equivoco di fondo che lo Stato sociale sia nato dail’esigenza di dispensare soltanto benefici, si veda A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 142.
(35)
Sullo sforzo compiuto dallo Stato contemporaneo di giungere ad una soluzione che, superando le opposte teorie fondate rispettivamente su individualismo e organicismo, approdasse al più equilibrato modello personalista, sia permesso richiamare, I. NICOTRA
GUERRERA. ‘Vita’ e sistema, cit., in part. 68 ss.
( 3 6 ) Sui caratteri del dovere giuridico, S . ROMANO, Doveri. Obblighi, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1983, 106. Per alcune notazioni critiche circa
la concezione del diritto come organizzazione della forza, alla cui stregua si arriva a
sostenere che il carattere di norma giuridica va riservato solo alle norme che comminano sanzioni, R. GLJASTINI,
Dovere giuridico, in Enc. giur., XIi, cit., 3.
(37)
Così, per tutti, voce Solidarietà in Dizionario enciclopedico italiano, Roma
1970,429.
IL SILENZIO LEGALE INFORMATO
L
i
l
839
carattere spontaneo della prestazione, e mal tollera, invece, una imposizione drastica da parte dei pubblici poteri (38).
Con parole diverse, lo spirito di solidarietà che spinge l’uomo a
proiettarsi in modo non egoistico nel sociale si raggiunge prima nel costume sociale, nella mentalità del gruppo e nelle coscienze individuali,
con la sollecitazione all’osservanza di un obbligo morale e, soltanto
eventualmente, in un momento successivo, il fallimento di un tale processo può portare alla positivizzazione di una vera e propria pretesa
giuridicamente fondata. I1 tentativo è quello di modificare lo stato di
crisi ‘della spontaneità individuale’ (39) nel campo del beneficio affidato alla liberalità, spingendo i singoli ad un rapporto di collaborazione
con la società, in modo che quest’ultima «provveda a sé medesima, prevedendo i bisogni di tutti e quindi facendo, di tutti in blocco, i beneficiati della società e al tempo stesso i benefattori» (a).
In questo caso il legislatore mira a sottolineare, particolarmente, il
profilo morale (41) del dovere, lasciando sullo sfondo la sua pregnanza
giuridica, promuovendo l’aspetto, per così dire, indipendente, della solidarietà ricavabile dall’enunciato contenuto nell’art. 2 della Costituzione.
Sul punto, l’intuizione del Costituente va colta proprio nella correlazione tra esercizio di diritti fondamentali e rispetto del dovere di solidarietà, che, come è stato suggerito, si scorge «come richiamo allo
spontaneo adempimento dell’uomo» (42) di spendere la propria autono-
Diversa è la soluzione cui giunge P. PERLINGIERI,
La personalità, cit., 321,
(38)
il quale richiamandosi al principio di solidarietà ritiene che, anche ove si accogliesse la
lettura del diritto di proprietà sul proprio cadavere, si deve concludere nel senso di dover sottrarre ‘definitivamente’ all’autonomia privata le questioni relative al trapianto di
organi.
(39)
E. BETTI,Dovere giuridico (teoria gen.), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965,
55.
G. Guzzo, Fenomenologia dell’obbligo e del dono, in Filosofia, 1963, 416.
In questa prospettiva anche A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 1990, 16, il quale ricorda in proposito la posizione del Mazzini che ammoniva come in un consorzio civile i cittadini sono tenuti innanzitutto moralmente e
politicamente all’osservanza dei doveri.
Così, L. ARCIDIACONO, La persona nella Costituzione, in L. ARCIDIACONO,
(42)
A. CARULLO, G. RIZZA, Istituzioni di diritto pubblico, Bologna, 1997, 256; il quale lascia intendere chiaramente la duplice valenza della previsione costituzionale che, in ossequio alla clausola di solidarietà, suggerisce ai cittadini comportamenti ad essa conformi cui si giustappone la richiesta di una vera e propria condotta doverosa da parte di
ciascuno.
(40)
(4’)
I
c
840
IDA NICOTRA GUERRERA
mia, esternando il senso di partecipazione alle difficoltà altrui, per favorire la realizzazione di loro diritti.
In linea con tale indirizzo interpretativo anche la giurisprudenza
costituzionale, che in diverse decisioni ha ancor meglio esplicitato la
complessità della norma contenuta nell’art. 2, affermando che il principio solidaristico va posto alla base della convivenza sociale «al di là dei
vincoli derivanti da doveri pubblici o da comandi dell’autorità» (43) e
che per tale ragione la finalità del legislatore deve essere quella di «favorire la donazione (...) caratterizzata da apprezzabili ed elevati contenuti di solidarietà umana e di utilità sociale» (44).
4. E proprio a tale esigenza di incentivazione, cui il diritto deve
dare risposta, si ispira, in maniera esplicita, la nuova disciplina nella disposizione contenuta al Capo I (art. 2, lett. c) in cui la promozione
dell’informazione sull’educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di trapianti vengono assunti come obiettivi prioritari. Risulta agevole comprendere, dall’enunciato legislativo come, più in generale, il tema della solidarietà sociale rappresenti un terreno d’elezione, ma non il
solo, in cui il diritto e in particolare le Costituzioni, possono svolgere
anche una funzione ‘pedagogica’ (45) nei confronti dei cittadini. L’idea
non è certamente nuova, già nell’antichità Platone veniva annoverato fra
i fautori del valore educativo, come quello di gran lunga prevalente, degli ordinamenti politici. il problema della formazione e dell’assetto di
questi, secondo siffatta idea, poteva trovare adeguata soluzione soltanto
dopo aver affrontato il tema dell’educazione attraverso una funzione
orientativa da parte del diritto, sicché è «la Costituzione politica che forma gli uomini, uomini buoni se buona, cattivi, se cattiva» (46). Del resto,
(43)
Corte cost. sent. n. 75/1992, in Giur cost., 1992, 418; annotata da E. ROSSI,
Principio di solidarietà e legge quadro sul volontariato, ivi, 2348.
(4) Così, Corte cost. sent. n. 52 del 1992, in Giur. cost., 1992, 302.
(45)
La funzione orientativa del diritto trova, in alcuni ambiti dell’ordinamento,
sede privilegiata di svolgimento; in materia ambientale, ad esempio diverse discipline
pongono espressamente tra le proprie finalità quella educativa, così il c o m a 3 dell’art
1 e la lett. e) dell’art. 4 della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette
in cui si precisano che la sottoposizione ad uno speciale regime di tutela e di gestione
ha lo scopo di perseguire anche la promozione di attività di educazione al rispetto del
patrimonio naturale e che il programma triennale per queste zone determina gli indinzzi ai quali gli enti territoriali devono uniformarsi per i compiti relativi alla ueducazione ambientale delle popolazioni interessate».
(46) PLATONE, Repubblica, a cura di F. Sartori e G. Pisani, Baxi, 1995, 260; F.
MERCADANTE, Dovere giuridico Ifilosofia), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 72, nt. 32.
iL. SILENZIO LEGALE INFORMATO
84 1
la spiegazione del diritto in chiave pedagogica è stata ripresa da autori
contemporanei che hanno focalizzato l’attenzione sul compito primario
del processo politico-legislativo consistente nel consigliare linee di condotta ai cittadini, per cui l’ammonimento e la persuasione costituiscono
la premessa della stabilità di una data organizzazione politica (47). Le riflessioni su questo fondamentale tema sono legate al convincimento che
i governanti assumono l’impegno di non tralasciare l’aspetto educativo
( 4 9 , «essenziale per ogni organizzazione politica che voglia sinceramente rifarsi ai principi della democrazia» (49). A ben vedere siffatta impostazione riconduce alia teoria della Costituzione per valori e alla funzie
ne della normazione attuativa, nei singoli settori dell’ordinamento, delle
scelte di rango supremo. Già in sede di lavori preparatori era stata sentita l’esigenza di collocare prima delle singole libertà una sorta di preambolo nel preciso intento di orientare il corpo sociale circa la significazione dei diritti come fonte di responsabilità per la realizzazione «del
bene comune e l’incremento di esso nella solidarietà sociale» (50).
Ora, se non pare convicente un approccio che, in via assoluta (51)’
neghi la facoltà del legislatore di imporre, ex novo, in attuazione della
(47) R. BAUER, Un progetto di democrazia, Presentazione di A. Colombo, Bologna, 1996, 39, in cui espressamente si evidenza l’esigenza da parte dei pubblici poteri
di ‘educare’ i cittadini alla democrazia e alle libertà, W. BAGEHOT, La Costituzione inglese, Bologna, 1995, 141 ss.; nella stessa prospettiva si colloca, per l’ipotesi consideTrapianti e trasfusioni, cit., 9, il quale auspica che il legislarata nel testo, P. PICOZZA,
tore promuova una attività di informazione per sensibilizzare l’opinione pubblica circa
la necessità della donazione di organi, incoraggiando verso il compimento di un atto
umanitario e di riaffermazione della dignità umana, nella collaborazione ad un proprio
simile minacciato daiia morte.
(48)
Un significativo indice di questa tendenza è offerto dalle moderne Costituzioni che espressamente contemplano il profilo pedagogico come funzione fondamentale dell’ordinamento. Così, al esempio, la previsione contenuta nell’art.91 della Costituzione portoghese che affida allo Stato il compito di coordinare la politica economica
con le politiche sociali, educative e culturali al fine di preservare la qualità di vita dei
cittadini.
(49) R. BAUER, Un progetto, cit., 226.
(50)
Cfr. la Relazione di la Pira contenuta in parte in V. ATRIPALDI,
Il Catalogo
delle libertà, cit., 35.
(51)
L’orientamento che concorda nel ritenere ammissibile un intervento legislativo impositivo di ulteriori doveri in ossequio ai principio costituzionale di solidarietà
è di C. CARBONE, I doveri pubblici individuali nella Costituzione, Milano, 1968, 91; per
una posizione più sfumata A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 15,
il quale rintraccia il limite aila discrezionalità della legge in materia al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti costituzionalmente sanciti.
842
D A NICOTRA GUERRERA
scelta solidaristica sancita nell’art. 2, doveri non individuati nel Testo
in vista dall’alta funzione sociale, è degna di nota la soluzione legislativa di non richiedere l’impegno individuale in termini di obbligatorietà. Essa va stimata anche alla luce dell’interpretazionerestrittiva ( 5 2 )
che, tracciando una profonda distinzione tra diritti inviolabili e doveri
inderogabili, riserva alla legge soltanto una limitata discrezionalità nella creazione di doveri ‘non enumerati’. Tale filone di pensiero nega in
particolare, con riguardo alla clausola di solidarietà, che essa possa fornire fondamento e giustificazione ad una nuova tipologia di doveri, al
fine di salvare quella sfera inviolabile di libertà individuali consacrate
che rappresentano l’aspetto saliente dell’impianto costituzionale (53).
Condividendo la preoccupazione che all’intemo della disposizione
costituzionale in oggetto possa annidarsi «un bacillo che può uccidere
ogni libertà» (54), nel campo della solidarietà, risulta prevalente la tendenza ad abbandonare il profilo della doverosità per lasciare il posto ad
una inedita categoria di situazioni giuridiche che sembra collocarsi a
metà strada tra diritto e dovere ( 5 9 , definibile come «prestazione di solidarietà indotta», che trattiene in sé una quota di spontaneismo. Quasi
che l’ordinamento abbia previsto uno spazio sul terreno della solidarietà
per l’emersione di una condotta, quanto mai auspicata, ma non obbligatoria, ripercorrendo l’intuizione kantiana secondo cui il comportamento positivo dell’uomo può dirigersi verso una duplice direzione:
(52)
P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 68; M.
LUCIANI,
Diritto costituzionale alla salute, in Dir. SOC., 1980, 781.
(53)
P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., 68; nonché G.LOMBARDI, Contributo allo
studio dei doveri costituzionali, Milano, 1967, 29, ove viene sostenuto che i doveri inderogabili richiamati nel secondo articolo della Costituzione altro non sono che quelli
esplicitamente menzionati in ulteriori previsioni del Testo.
(54)
P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953,
148; G. TREVES, La difesa della libertà individuale, in Scritti giuridici, Milano 1982,
182.
(55)
La questione, sia pure in un differente ambito di indagine, è stata posta proprio al fine specifico di mettere in discussione l’esattezza della tradizionale dicotomia
delle situazioni giuridiche soggettive nel binomio diritto-dovere. L‘emersione di nuove
istanze sociali impone, infatti, una verifica sulla tenuta delle antiche categorie. È parso,
seguendo tale itinerario, di poter individuare a proposito di taluni valori come l’ambiente, la pace, la sicurezza, la cultura e la vita una nuova categoria di beni extra soggettivi, comprendente interessi incondizionatamente protetti, la cui salvaguardia, vale a
dire, da parte dei pubblici poteri agisca indipendentemente dalla volontà del singolo e
da qualsivoglia finalità che a questi si possa in qualche modo ricollegare (I. NICOTRA
GUERRERA, ‘Vita’ e sistema, cit., 1-28).
IL SILENZIO LEGALE INFORMATO
843
quella riconducibile all’adempimento del dovere morale «in cui l’uomo
non fa se non ciò che è doveroso per legge (azione dovuta)», ovvero «fa
più di quanto può essere costretto a fare secondo la legge» (azione meritoria) (56). Lungo questo binomio autorità-libertà il ruolo dell’ordinamento sembra consistere proprio nella equilibrata ricerca di mezzi per
invogliare o, addirittura, per persuadere il cittadino verso una più completa adesione a siffatto valore. Non più, dunque, ‘il rapporto di obbedienza’ (57)’ al centro della complessa intelaiatura di rapporti tra Stato
e singolo, giustificativo di una serie di doveri costituzionali. Si fa strada con maggior vigore la differente prospettiva, basata sul principio
della autoresponsabilità ( 5 9 , secondo cui la condivisione di ideali solidaristici si raggiunge, non adottando una logica autoritaria, bensì con
l’intervento attivo (59) del singolo componente il gruppo sociale sulla
scia del modello che mira al mutamento delle situazioni soggettive da
diritti alla ‘dissociazione’ in diritti ‘alla partecipazione’ (60). Sicché,
l’ideale relazione di solidarietà reciproca - che anche, dopo la morte
permane, tra il singolo e il gruppo come continuità di quella instauratasi nel corso della esistenza di ciascuno - difficilmente può coesistere
con un modello individualizzante, in cui «non si deve nulla agli altri
(...) e ad essi nulla possa essere richiesto» (61).
(56)
I. KANT, Introduzione alla metafisica dei costumi, in Scritti politici, Tonno,
1956,404.
P. BARILE, Il soggetto privato, cit., 148.
All’idea, messa a punto dalla giurisprudenza tedesca, che dal vincolo solidaristico scaturisca il principio di responsabilità dei singoli verso la società e lo Stato
aderisce, E. CASTORINA, Introduzione allo studio della cittadinanza, profili ricostruttivi
di un diritto, Milano, 1997, 131.
(59)
Sul fondamentale apporto della partecipazione per una completa consapevolezza della persona umana nella società contemporanea si vedano le considerazioni di
Una società nuova: quella partecipativa, in Individuo, collettività, cit.,
P.L. ZAMPETTI,
541, in particolare nella parte in cui si sottolinea come la partecipazione alle scelte fondamentali della società incentivi nel singolo la volontà a porre al servizio della collettività le sue energie migliori.
(60) V. A TRIPALDI, Il catalogo delle libertà, cit., 37. Per un particolare approccio
che ravvisa nella partecipazione dei cittadini alle decisioni giuridiche dei pubblici poteri una fonte di legittimazione delle norme, si rinvia a N. LUHMANN,
Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, a cura di A. Febbraio, Milano, 1995, XIV, in cui l’obiettivo fondamentale che l’a. si prefigge è quello di dimostrare come una società sia capace di legittimare il proprio diritto «non più con I’ausilio di verità invariabili ritrovate come tali, bensì soltanto, o principalmente, mediante la partecipazione ai procedimenti».
(61)
La questione viene impostata in termini analoghi da E. LECALDANO, La que(57)
(58)
844
IDA NICOTRA GUERRERA
In conclusione, il risultato cercato con l’approvazione della norma
sul silenzio assenso è che la prestazione di solidarietà non viene percepita né come gesto di liberalità, nobile e isolato (62), come per lungo
tempo è avvenuto, né come dovere, la cui intrinseca natura, rappresenta la negazione di un atto autenticamente solidale.
5. La questione può essere riletta al cospetto dell’effettività come
carattere qualificante l’ordinamento (63): l’osservanza e l’applicazione
del sistema normativo dipendono, in buona sostanza, secondo lo schema concettuale considerato, non soltanto dal carattere sanzionatorio,
quanto, almeno in eguale misura, dalla condivisione del sottofondo culturale delle scelte fondamentali, la cui mancanza sarebbe, alla lunga,
causa dell’esaurimento di un dato assetto politico. Questo differente approccio poggia sulla necessaria accettazione da parte del corpo sociale
di un contesto storico sociale espressivo di valori. I1 conferimento dj efficacia all’ordine giuridico sulla base di tale presupposto si pone in sintonia con la richiesta di prestazioni improntate sull’alternativa della
scelta, che in ultima analisi non sono assimilabili agli schemi logici sintetizzati nella situazione dovere-obbligo. In questo contesto, l’elemento
coercitivo (64) va, lentamente, sgretolandosi e cessa di costituire l’unico criterio distintivo dell’ordinamento (65). Esso, piuttosto, si raccorda
stione della disciplina del prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Il contributo della riflessione sulla morale con linee argomentative, in La bioetica, Questioni morali e politiche per il futuro dell’uomo, Roma, 1990, 41.
(62)
A. LA TORRE, Silenzio (dir. priv.), cit., 558.
(63)
Utili, al riguardo, le notazioni di M. BERTOLISSI - R. MENEGHELLI, Lezioni di
diritto pubblico generale, Torino, 1993, 46; G. RIZZA, Diritto, ordinamento giuridico e
stato, in L. ARCIDIACONO, A. CARULLO, G. RIZZA, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 6.
(64) I1 carattere necessario e vincolante della legge, espresso nel momento coercitivo, rappresenta il profilo più allarmante di un legislatore che con l’uso della forza
supera acriticamente il rapporto tra Stato e società, tra apparato autoritario e cittadini.
I1 risultato è che l’ordine giuridico si risolve, quasi per intero, nella sanzione, degradando l’obbligo «al rango di bassa operazione tecnica, di corvée di conio legale cui
soggiace la gente minuta, tuttavia affetta dal timore dell’autorità, che poi non è altro che
il variabile predominio degli uni sugli altri», così, F. MERCADANTE, Dovere giuridico
filosofia), cit., 76.
(65)
Illuminanti, sul punto, le notazioni di H. HART, Il concetto di diritto, Torino, 1965, 60, ove si avverte come il modello dell’ordine sostenuto da minacce «rende
oscure più parti del diritto di quante non né illumini», invero il tentativo di ridurre la
coercibilità a fattore caratterizzante ogni norma giuridica finisce per imporre ad esse
una falsa uniformità. È stato, altresì, sostenuto che quando si discute di sanzioni organizzate come elemento costitutivo del diritto ci si riferisce non alle singole norme, ma
IL SILENZIO LEGALE INFORMATO
845
significativamente sul piano strutturale con una concezione consensuale e meno autoritaria delle prestazioni individuali, fondate sull’adempimento spontaneo di ciascuno. I1 discorso si riannoda a questioni di
maggior respiro che interessano, più in generale, le conseguenze del
passaggio dallo Stato di diritto liberale allo Stato sociale (66): infatti, il
radicale mutamento di prospettiva di un tipo di struttura ordinamentale
intesa a garantire l’ordinata convivenza civile, attraverso attività in prevalenza di mera repressione di comportamenti vietati, rispetto ad un
modello interventista che non si limita a vigilare ma svolge compiti di
direzione sociale ha comportato la nascita di strumenti di incentivazione, incoraggiamento delle prestazioni soggettive (67).
Talché, la progressiva perdita di importanza delle teorie imperativistiche (68) connesse alla funzione repressiva delle norme lascia il posto all’aspetto promozionale del diritto, preoccupato di favorire comportamenti della persona vantaggiosi per la collettività (69).
A siffatto stato di cose può essere ricondotto lo sfaldamento del ca<d’ordinamento giuridico preso nel suo complesso», talché il carattere coattivo del diritto non è più l’unico criterio distintivo della norma giuridica, ma uno dei suoi elementi
Teoria della norma giuridica, Torino 1958, 207 che, afcaratteristici; cfr. N. BOBBIO,
ferma, inoltre, come il carattere sanzionatorio non garantisce l’osservanza della condotta e diversamente una legge c.d. imperfecta può essere efficacia sul piano motivazionale.
(66) Sulla funzione promozionale del diritto utilizzata come tecnica di controllo
sociale dal moderno ordinamento interventista, messa a punto attraverso ‘un’attenta calibratura di pene e di premi’, di sanzioni positive e negative, F. DAGOSTINO,
Sanzione,
(teoria gen.), cit., 322.
(67) G.R. CARRIO, Sul concetto di obbligo giuridico, in Riv. fil., 1966, 57; N.
BOBBIO,
Dalla struttura allafunzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano 1977; R.
GUASTINI, Dovere giuridico, cit., 6.
Come nasce il diritto, cit., 17 l’elemento della for( 6 8 ) Secondo F. CARNELUPI,
za costituisce la vera differenza del diritto dalla morale e, con ciò, la naturalità del diritto in confronto con la soprannaturaiità della morale (...) la sanzione introduce la forza nella nozione del diritto» perché, questo possa essere messo in atto. Siffatta teoria
identifica, notoriamente, la norma giuridica con un imperativo di comando o di astensione che poggia su un fondamento di obbligazione, la cui trasgressione comporta l’inflizione di una sanzione. L’obiezione più ricorrente si basa sulla necessità di spiegare
alla luce dell’imperativismo la presenza di norme meramente permissive e facoltizzanti che pure compongono l’ordinamento giuridico e che non sono riconducibili alle figure dell’obbligo e del diritto; sul punto F. MODUGNO, Norma (teoria gen.), in Enc. dir.,
XXVIII, Milano, 1978, 332.
N. BOBBIO,
Teoria della norma giuridica, cit., 48; ID., Studi per una teoria
(69)
generale del diritto, Torino, 1970; K. OLIVECRONA, La struttura del1 ’ordinamentogiuridico, a cura di E. Pattaro, Milano, 1972.
846
IDA NICOTRA GUERRERA
rattere coattivo della legge e il contemporaneo sviluppo di una concezione del diritto incline a orientare verso quei doveri definibili, secondo la terminologia kantiana, di ‘beneficenza o di virtù’ ( 7 9 , sicché la regola giuridica diviene il veicolo per l’affermazione di principi etici che,
anche in mancanza di una costrizione esterna, suggeriscono la condotta
da tenere in ossequio ai dettami della coscienza. Nella scelta ordinamentale odierna pare materializzarsi la suggestiva edificazione (71) che
fa scaturire il diritto dall’esigenza di gettare un ponte tra economia e
morale. Invero, giuridicizzando il principio di solidarietà senza legarlo
al comportamento personale obbligatorio, l’ordinamento ha enucleato,
tra il regno dell’egoismo e quello dell’altruismo, una sorta di surrogato
che rappresentasse una mediazione tra le due opposte visioni, spingendo il singolo verso la spontanea irnmedesimazione con il gruppo.
Appare, così, sbiadito, alla luce di un simile assetto normativo, il
tradizionale assunto secondo cui la coercibilità della norma costituirebbe il prius dell’ordinamento giuridico, laddove il diritto si identifica, sic
et simpliciter, con l’idea di coercibilità (72). Si percepisce dal principio
in tema di trapianti una spiccata propensione del legislatore al profilo
‘speculativo’ (73) del diritto al fine di realizzare attraverso i processi
parlamentari un costante collegamento con la realtà sociale, rispecchiando quanto più fedelmente le inclinazioni della consociazione staQuesti ultimi, afferma I. KANT, Principi metafisici della dottrina del diritto,
(70)
in Scritti politici, cit., 419, 420, «non possono essere soggetti a nessuna legislazione
esterna, perché essi sono diretti ad un fine che è nello stesso tempo un dovere (o che è
nostro dovere di raggiungere), ma si propongono uno scopo, che non può essere realizzato da nessuna legislazione esterna, perché è un atto interno dell’animo».
(71)
Sul punto, notoriamente, F. CARNELUTTI,
Come nasce il diritto, cit., 15.
(72)
Assai pregevoli risultano le riflessioni di P. BARILE, Istituzioni di diritto
pubblico, Padova, 1978,4 il quale all’interrogativo su quale sia il fondamento delle norme giuridiche risponde affermando che esso risiede nella «convinzione collettiva della
necessità che queste regole siano osservate perché indispensabili al funzionamento della società (...) le reazioni della società possono perfino giungere a reazioni di forza, ma
solo quando violate siano norme effettivamente vigenti, non norme esistenti ma non osservate, prive cioè del requisito dell’effettivitb. Una differente prospettiva, peraltro da
me non condivisa nella sua assertorietà, esclude in modo radicale dal concetto di legge
il carattere della coazione, così, B. CROCE, Filosofia della pratica$ Bari, 1963, 319, a
suo giudizio, infatti, nessuna azione può essere può essere costretta, «la pena trova sempre di fronte a sé la libertà dell’individuo», per evitare la pena il soggetto potrà liberamente osservare la legge.
(73)
Sul carattere speculativo del diritto, con riferimento all’ordinamento americano, si può leggere, M. MARCHESIELLO,
Presentazione al volume, L.M. FRIEDMAN, Storia del diritto americano, Milano, 1995, XII.
IL SILENZIO LEGALE INFORMATO
847
tale, permutandole in precetti normativi. A ben guardare, questa funzione di ‘rispecchiare’ la società costituisce l’altra faccia del tratto peculiare di un sistema giuridico, ossia l’effettività (74). Attraverso tale
cammino circolare l’ordinamento realizza la sua finalità primaria
dell’osservanza ‘diffusa’ (75) nei confronti delle regole sufficientemente condivise dal consorzio civile, in applicazione della logica democratica sottesa nell’art. 1 della nostra Costituzione. In particolare, nell’ambito della solidarietà sociale sembra prendere consistenza la lungimirante costruzione di Costantino Mortati che mise in guardia dall’errore
di prospettiva commesso da chi considerasse la normatività come «elemento primigenio dell’esperienza giuridica» (76). L’effettivo valore giuridico delle regole è condizionato dalla capacità delle medesime «ad
essere concretamente osservate da coloro cui si dirigono (...) se un’obbedienza totale non è necessaria, né sarebbe raggiungibile, viceversa
una disubbidienza diffusa verrebbe a togliere alle medesime il requisito della vigenza» ( 7 9 , necessario affinché assumano la funzione pratica
ordinatrice loro congeniale.
(74) Siffatta opinione sembra trovare conforto nella teoria di SANTI ROMANO,
(Diritto finzione del), in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1983, 86) a
proposito della funzione del diritto, laddove assegnando alla norma giuridica il compito di “stabilizzare, normalizzare, fissare taluni momenti e movimenti della vita sociale,
avverte espressamente che non si intende far riferimento a tendenze conservatrici che
pongono il diritto in una sfera avulsa dai mutamenti della società. Al contrario, l’illustre studioso sostiene che l’ordinamento per essere un organismo vitale deve rinnovarsi per far posto anche a modificazioni radicali e profonde ed adeguarsi costantemente
alle differenti esigenze dell’istituzione.
(75) Alle teorie realistiche o sociologiche del diritto sembrano ispirarsi le pregevoli riflessioni di C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1975, 6. Secondo la nota concezione aristotelica del diritto come «dimensione propria di quell’essere intermedio, ‘sintetico’, né angelo, né bestia, che è l’uomo: proprio perché non è ragione pura o libertà assoluta, proprio perché non è totale assenza di ragione e di libertà,
l’uomo percepisce se stesso come libertà finita, percepisce cioè la normatività, la doverosità (...)», così, F. D’AGOSTINO,
Sanzione (teoria generale), in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 305.
(76) Ancora, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 7, analogamente, P.
BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 4, laddove sostiene che la coazione «accompagna sempre spontaneamente la norma dotata di effettività, cioè osservata, mentre
quando accompagna una norma non osservata, anche se è una norma che esiste formalmente, si dimostra inefficace».
(77) «...dato che la ‘validità’ conferita alla norma dal fatto del suo discendere dal
comando di un’autorità dà vita solo ad un’aspettativa (...) mentre solo la corrispondente conformità ad essa riesce a conferirle quella effettività che la rende veramente giuridica ...»; F. BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 31 1. L’idea è presente, seppur
848
IDA NICOTRA GUEFSERA
In linea con tale percorso, il processo politico si va attestando su
posizioni che prediligono la creazione di strumenti maggiormente democratici coi quali sostituire le categorie giuridiche esistenti. Per l’appunto, i disegni di legge per la riforma del servizio di leva - in cui si
abbandona l’idea del periodo di leva come dovere e si propone l’alternativa con il reclutamento di volontari, attraverso l’incentivazione di un
esercito specializzato che offre la sua professionalità al servizio dello
Stato - costituiscono un indice significativo di tale nuova tendenza.
nel particolare ambito relativo alle tematiche ambientali, in S. GRASSI, Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, Firenze, 1998, 22, il quale mette in evidenza lo scopo delle Costituzioni moderne di individuare al loro interno valori che ispirano l’azione dei pubblici poteri e nel contempo costituiscono «punto di riferimento e di consenso>>per i cittadini; analogamente N. GRECO, La Costituzione dell’ambiente, Bologna,
1996, 63, che individua il compito della scienza del diritto costituzionale nella capacità
di entrare in sintonia con i caratteri spirituali generali della sua epoca.