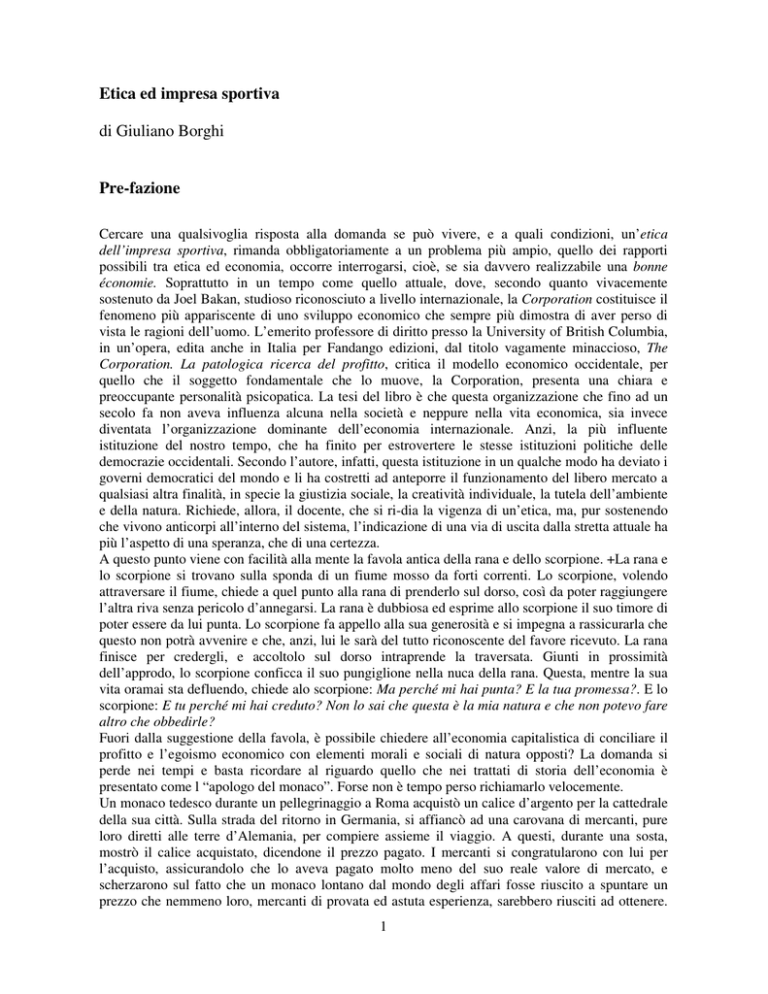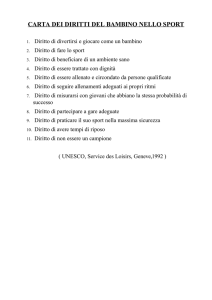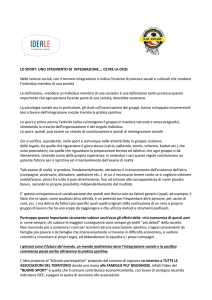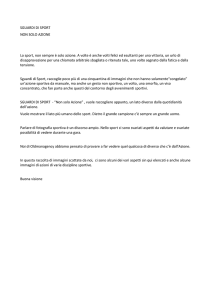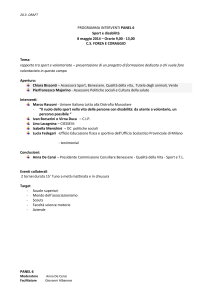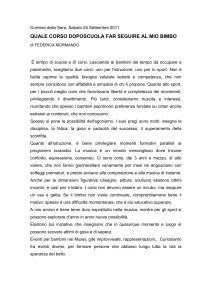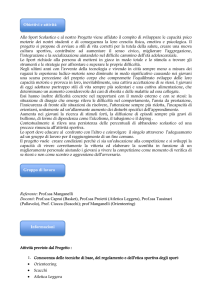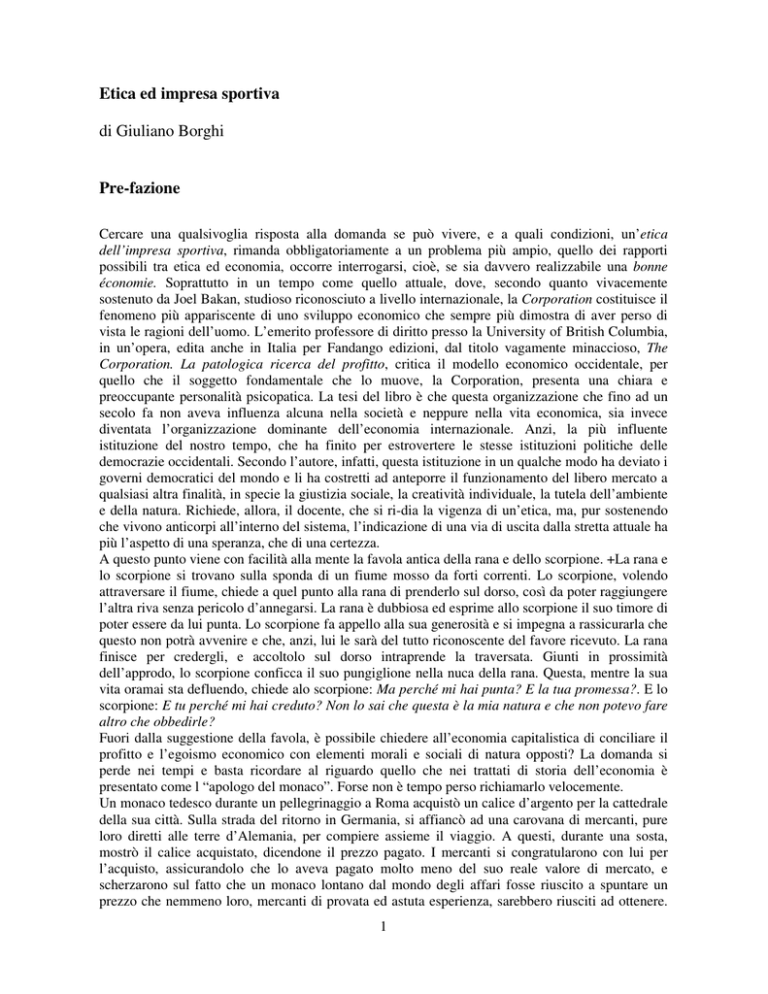
Etica ed impresa sportiva
di Giuliano Borghi
Pre-fazione
Cercare una qualsivoglia risposta alla domanda se può vivere, e a quali condizioni, un’etica
dell’impresa sportiva, rimanda obbligatoriamente a un problema più ampio, quello dei rapporti
possibili tra etica ed economia, occorre interrogarsi, cioè, se sia davvero realizzabile una bonne
économie. Soprattutto in un tempo come quello attuale, dove, secondo quanto vivacemente
sostenuto da Joel Bakan, studioso riconosciuto a livello internazionale, la Corporation costituisce il
fenomeno più appariscente di uno sviluppo economico che sempre più dimostra di aver perso di
vista le ragioni dell’uomo. L’emerito professore di diritto presso la University of British Columbia,
in un’opera, edita anche in Italia per Fandango edizioni, dal titolo vagamente minaccioso, The
Corporation. La patologica ricerca del profitto, critica il modello economico occidentale, per
quello che il soggetto fondamentale che lo muove, la Corporation, presenta una chiara e
preoccupante personalità psicopatica. La tesi del libro è che questa organizzazione che fino ad un
secolo fa non aveva influenza alcuna nella società e neppure nella vita economica, sia invece
diventata l’organizzazione dominante dell’economia internazionale. Anzi, la più influente
istituzione del nostro tempo, che ha finito per estrovertere le stesse istituzioni politiche delle
democrazie occidentali. Secondo l’autore, infatti, questa istituzione in un qualche modo ha deviato i
governi democratici del mondo e li ha costretti ad anteporre il funzionamento del libero mercato a
qualsiasi altra finalità, in specie la giustizia sociale, la creatività individuale, la tutela dell’ambiente
e della natura. Richiede, allora, il docente, che si ri-dia la vigenza di un’etica, ma, pur sostenendo
che vivono anticorpi all’interno del sistema, l’indicazione di una via di uscita dalla stretta attuale ha
più l’aspetto di una speranza, che di una certezza.
A questo punto viene con facilità alla mente la favola antica della rana e dello scorpione. +La rana e
lo scorpione si trovano sulla sponda di un fiume mosso da forti correnti. Lo scorpione, volendo
attraversare il fiume, chiede a quel punto alla rana di prenderlo sul dorso, così da poter raggiungere
l’altra riva senza pericolo d’annegarsi. La rana è dubbiosa ed esprime allo scorpione il suo timore di
poter essere da lui punta. Lo scorpione fa appello alla sua generosità e si impegna a rassicurarla che
questo non potrà avvenire e che, anzi, lui le sarà del tutto riconoscente del favore ricevuto. La rana
finisce per credergli, e accoltolo sul dorso intraprende la traversata. Giunti in prossimità
dell’approdo, lo scorpione conficca il suo pungiglione nella nuca della rana. Questa, mentre la sua
vita oramai sta defluendo, chiede alo scorpione: Ma perché mi hai punta? E la tua promessa?. E lo
scorpione: E tu perché mi hai creduto? Non lo sai che questa è la mia natura e che non potevo fare
altro che obbedirle?
Fuori dalla suggestione della favola, è possibile chiedere all’economia capitalistica di conciliare il
profitto e l’egoismo economico con elementi morali e sociali di natura opposti? La domanda si
perde nei tempi e basta ricordare al riguardo quello che nei trattati di storia dell’economia è
presentato come l “apologo del monaco”. Forse non è tempo perso richiamarlo velocemente.
Un monaco tedesco durante un pellegrinaggio a Roma acquistò un calice d’argento per la cattedrale
della sua città. Sulla strada del ritorno in Germania, si affiancò ad una carovana di mercanti, pure
loro diretti alle terre d’Alemania, per compiere assieme il viaggio. A questi, durante una sosta,
mostrò il calice acquistato, dicendone il prezzo pagato. I mercanti si congratularono con lui per
l’acquisto, assicurandolo che lo aveva pagato molto meno del suo reale valore di mercato, e
scherzarono sul fatto che un monaco lontano dal mondo degli affari fosse riuscito a spuntare un
prezzo che nemmeno loro, mercanti di provata ed astuta esperienza, sarebbero riusciti ad ottenere.
1
A sentire questo il monaco cadde nello sconforto, salutò immediatamente i mercanti e riprese la
strada per Roma, desideroso di ritornare dal venditore del calice, per versargli la differenza tra il
prezzo pagato e quello che aveva saputo essere, invece, equo. Così volle fare e così fece, poiché
sapeva che era la scelta che la sua coscienza gli aveva imposto. Certamente siamo in un tempo nel
quale si vivevano tutti i rapporti, compresi quelli economici, tenendo sempre presente la legge di
Dio e non quella di Mammona. E in una dimensione economica già densa di traffici e mercanti,
dove, però, l’economia ancora si fondava su un sistema sociale di diritti e obbligazioni, e non sull’
“acquisizione” registrata sulla compravendita, sul prestito ad interesse e rivolta principalmente al
profitto. Il dilemma che l’aneddoto del monaco pone è quello tra una morale religiosa, che afferma
che tutti gli uomini sono fratelli- e che pertanto ognuno è responsabile anche per l’altro e non gli è
permesso di godere di un suo eventuale errore- e l’altro corno, il successo, il profittare degli altri,
per garantirsi un guadagno, trovando nell’arricchimento conseguito la ragione giustificativa, per
quello che nel libero mercato vale la regola del caveat emptor. Un siffatto conflitto tra un principio
etico e un principio legale, con il quale viene giustificata la rivalità concorrenziale dell’economia di
mercato, ha tenuta occupata la mente dei teologi e dei filosofi da allora fino ad oggi, ma non ha
ancora trovata soluzione definitiva. A meno che non si voglia ritenere, e accettare, che la risposta
decisiova sia quella che già ci ha cantato Mandeville nella sua Favola delle api?
In una recente opera, a titolo The market of virtue, David Vogel, docente a Berkeley di Business
Ethics, afferma che sarebbe auspicabile che le industrie si adeguassero alla responsabilità sociale,
ma, allo stesso tempo, sostiene che una siffatta operazione comporterebbe costi più elevati, che i
consumatori non sarebbero, però, disposti a pagare, neppure per avere un prodotto che incorpori un
valore etico. L’operazione è anche spesso inefficace, perché non può obbligare tutte le aziende e
sovente gli obiettivi sono del tutto vaghi. Nelle scelte di responsabilità sociale delle aziende la
“razionalità economica”, in effetti, è assente e sono tenui le ragioni della eventuale scelta verso la
responsabilità sociale Per Vogel, comunque, il “mercato delle virtù” si starebbe, nonostante tutto,
consolidando, ma occorrerebbe l’intervento dei governi per stabilire standards e strumenti di
controllo delle imprese “cattive”. Una risposta certa, tuttavia, non è stata ancora trovata, cosicché la
questione continua a presentarsi con tutta la sua urgenza, per quello che si richiama ad una
condizione vitale, e sicuramente non ad una astratta ipotesi intellettuale. Tale situazione riveste una
speciale importanza per quello che riguarda una possibile definizione di un’etica dell’impresa
sportiva, perché risalta chiaramente che questa può prendere senso solamente dalla soluzione
trovata per quella.
Etica dell’impresa sportiva
Ci troviamo di fronte a tre ben precisi e distinti concetti: Etica, Impresa, Sport, la relazione tra i
quali non è così immediata e, a dire il vero, nemmeno tanto scontata. Se il primo concetto, infatti,
possiede una natura morale, che implica l’apertura e la solidarietà verso gli altri e presuppone la
vigenza di un principio normativo, religioso o laico che sia, il secondo, da parte sua, si caratterizza
per esclusivi attribuiti estetici e non-economicistici, quali la gratuità, la prodigalità, il tempo di
festa. La pietra di volta sulla quale si regge l’Impresa, invece, come ben si sa, è scolpita da una
razionalità economica, che ha la sua decisiva giustificazione unicamente nel profitto individuale,
nell’utilitarismo e nel tempo del lavoro.
Conviene, allora, prendere in esame il termine impresa, tentare di delinearne le caratteristiche
intime e da qui considerare la possibilità di un suo rapporto dotato veramente di senso con gli altri
due termini, insomma, verificare se l’evidente ossimoro può comportare una applicazione pratica.
Per questo potrà esser utile prestar orecchio attento a quanto hanno detto nelle loro famose opere
alcuni tra i più interessanti studiosi contemporanei.
2
L’Imprenditore
In Storia dell’analisi economica Schumpeter tratta il ruolo dell’imprenditorialità e indica la sua
funzione come l’elemento chiave dello sviluppo. La definisce come innovazione, perché
l’imprenditore modifica le condizioni dell’approvvigionamento, combina le risorse esistenziali in
modo nuovo e le innalza ad un nuovo livello. In tal modo Schumpeter sottolinea la natura
rivoluzionaria dell’imprenditore, che considera comunque sempre come una funzione, seppure
chiaramente separata, in senso dinamico, dalle attività del normale uomo d’affari. Per lui
l’imprenditore è un capo che sa osare, è disposto ad infrangere i vincoli ordinari, in questo
distinguendosi dal dirigente di routine. Inoltre, la sua natura di capo implica la capacità di pensare il
nuovo, di afferrare l’essenziale, di agire prontamente e di comprendere in maniera intuitiva le cose.
Agisce basandosi sulla propria volontà e autorità personale ed è pronto ad affrontare le critiche che
sempre si manifestano quando un comportamento innovativo è considerato deviante e pericoloso.
Anche se in modo meno eroico, ha qualcosa in comune con i capi militari e religiosi del passato. E’
un capo che agisce in una società razionale, utilitaristica e antieroica e di conseguenza non suscita
sentimenti carismatici o entusiasmi collettivi come coloro che creano o difendono intere civiltà.
Opera in una sfera più limitata e il posto che occupa nella società è più precario.
Schumpeter sa bene che l’imprenditorialità, come fenomeno storico specifico, si basa sulla
premessa della differenziazione della sfera economica dalle altre nelle quali l’individuo agisce. In
epoche passate la funzione imprenditoriale si confondeva, nell’azione dei capi religiosi, politici e
sociali, con altre funzioni. L’imprenditore, l’imprenditorialità, nel tempo moderno, invece, si
automatizzano, e finiscono per essere la forma, l’ideal typus si potrebbe dire, di leadership che
compare storicamente e specificamente nel capitalismo e di questo costituisce un fenomeno
particolarmente adeguato, anzi essenziale, al suo dinamismo. Schumpeter si occupa anche della
psicologia dell’imprenditore e del suo comportamento, che implica una miscela di elementi
razionali ed emotivi. Da una parte, in effetti, è razionale perché richiede, in alta misura, previsione e
pianificazione, dall’altra si muove su un impulso autonomo alla realizzazione e creazione, ricercate
per loro stesse, e anche sul sogno di fondare, a coronamento della propria carriera, una qual sorta di
dinastia familiare. L’imprenditore, per tutto questo, sfrutta tutte quelle componenti del suo
ambiente, quali il denaro, la scienza, la libertà personale, che hanno una base razionale, e nella sua
condotta si fa guidare da valori utilitaristici. In lui, tuttavia, c’è altro ancora. Di fondo,
l’innovazione imprenditoriale è un atto creativo, che in un qualche modo va contro la cultura
economicistica, che definisce la razionalità dal punto di vista ristretto del calcolo del proprio
vantaggio a breve termine. La “razionalità” dell’imprenditore contiene certamente un elemento di
profitto e di guadagno, e non potrebbe essere altrimenti, ma segue anche il desiderio e la capacità di
pensare il nuovo, l’originale e di agire seguendo questa spinta. Appare evidente come questa
posizione di pensiero di Schumpeter, diverga da quella di studiosi come Weber, Pareto, Sombart e
Tonnies, per i quali, invece, la razionalità utilitaristica si identifica totalmente con il capitalismo,
costituendone l’unica e vera anima.
3
La razionalità strumentale
Vediamo, almeno per quanto riguarda Weber e Sombart, come stanno le cose. Degli scritti di Weber
il filone più importante è rappresentato dal collegamento posto tra etica religiosa, mentalità
economica e azione economica, essenziale per capire il razionalismo e il capitalismo
dell’Occidente. Per Weber, il capitalismo moderno è un grande complesso di istituzioni
interconnesse, come l’economia di mercato, le imprese con fini di lucro, il lavoro libero e
volontario, il credito pubblico, la borsa valori, e altro ancora. Ognuna di queste istituzioni ha una
sua storia e sue relazioni con le altre. Tuttavia, questo complesso di istituzioni è tenuto assieme da
una mentalità comune: lo spirito del capitalismo, legato a sua volta all’etica ascetica del calvinismo
e del puritanesimo.
Per riassumere velocemente i punti essenziali dell’argomentazione weberiana, si può dire che tanto
l’imprenditore quanto, in una certa misura, il lavoratore salariato, si distinguono dai loro
predecessori storici nelle economie tradizionali, per il perseguimento razionale e sistematico del
guadagno economico, per il ricorso ad un calcolo, la misura del quale si lega a questo criterio
economico, per l’estensione delle fiducia attraverso il credito e la subordinazione dei consumi agli
interessi dell’accumulazione. Sono questi gli elementi di quello “scopo della razionalità”, di quella
“razionalità strumentale”, che permette all’attore razionale di istituire un rapporto sistematico tra i
fini economici preferiti e i mezzi migliori per raggiungerla. Fin qui Weber.
La struttura psicologica
Di Sombart è nota la descrizione che esso, ne Il Borghese, ha dato della struttura psicologica
dell’imprenditore moderno, per lo meno quello che vedeva muoversi sugli scenari dei primi del
Novecento. Scrive il sociologo tedesco: Mi sembra che la struttura psichica dell’imprenditore
moderno, come quella dell’uomo moderno, sempre più contagiata dal suo spirito, divenga più
facilmente comprensibile se ci trasportiamo nel mondo delle rappresentazioni e dei valori
fanciulleschi. In sostanza gli ideali di questi uomini rappresentano una completa riduzione di ogni
procedimento psichico ai suoi primi elementi, una specie di ricaduta dunque nelle semplici
condizioni dell’anima infantile. Ma voglio giustificare questa concezione. Il bambino ha quattro
complessi elementari di valori; la sua vita è dominata da quattro ideali: 1. la grandezza materiale
2. la rapidità del movimento 3. la novità 4. il senso della potenza.
Questo è quanto afferma Sombart, per il quale la forma che il processo economico ha assunto nel
periodo dell’alto capitalismo può essere significata dal motto Fiat productio et pereat homo, per
dire la direzione altra, il senso e il fondamento diverso che la vita economica ha subìto, quando a
muovere il suo corpo, cioè le forme di produzione, distribuzione ed organizzazione, è sopraggiunto
lo spirito economico ed utilitaristico, tipico dell’anima moderna. Per Schumpeter, invece, non
sarebbe possibile sostenere questa totale identificazione, perché la coscienza imprenditoriale
continuerebbe a conservare elementi autonomi di carattere non utilitaristico. Se così davvero
dovessero stare le cose, pur tenendo in debito conto quello che lo stesso Schumpeter scrive: Il
capitalismo genera una forma mentis critica, che dopo aver distrutto l’autorità morale di tante
altre istituzioni, si rivolge da ultimo contro le proprie, si aprirebbe una prospettiva non del tutto
opposta a quella che dà significato all’azione sportiva.
Stiamo parlando di “impresa”, di un qualcosa che per sua natura si muove nell’ambito di quel
sistema capitalistico che costituisce comunque il quadro generale nel quale attualmente viviamo
tutti i nostri rapporti, tanto privati, quanto pubblici. Il punto sintetico che lo raffigura è
indubbiamente il profitto, una affettività, chiamiamola così, che è altra da quella nella quale si
esprime l’azione sportiva, la natura della quale non è economica. La domanda che dobbiamo porci,
allora, è se vi sia per caso un tipo di capitalismo, capace di ispirare una impresa che tenga conto non
solo del profitto, ma che sappia anche di altro. Si può chiedere questo al capitalismo, oppure una
tale pretesa significherebbe per esso un cambiamento così radicale della sua essenza che, dopo, non
sarebbe più capitalismo, e l’impresa ben altra faccenda?
4
Per il filosofo Emanuele Severino, che qualche tempo fa è intervenuto su questo quesito, un siffatto
compromesso, tra logica del profitto ed esigenze sociali, destinerebbe il capitalismo ad un
inarrestabile tramonto. La posizione di Severino è forse troppo rigorosa: in effetti, nella storia non si
è mai presentato, in termini assoluti, un libero mercato e neppure una società totalmente dominata
dalla sola legge del profitto. Così come non è mai esistita una società retta unicamente da una
corretta e piena adesione a principi e regole non economicistiche o utilitaristiche. E’ pur vero,
d’altra parte, che tra le forme possibili nelle quali il sociale, intendo la vita della società non
modulata su ragioni economicistiche, si mescola, e resiste, con il profitto, vi sono quelle nelle quali
è preponderante la tensione verso il sociale, e altre nelle quali prevale l’esaltazione del profitto
individuale, assai spesso giustificato dalla affermazione che esso abbia la proprietà naturale e
positiva di produrre effetti trainanti e di irradiazione del benessere sull’intera società.
Le due forme di Capitalismo
Questi due diversi esiti delle possibili combinazioni tra profitto e socialità, che possono distinguere
due diverse formulazioni con le quali si può oggi pensare il capitalismo, sono stati oggetto di un
interessante e vasto studio, edito alcuni anni fa in Italia per i tipi del Mulino, dell’economista
francese Michel Albert, allievo di François Perroux, dal significativo titolo Capitalismo contro
capitalismo. In esso si trovavano analizzati due precisi tipi di capitalismo, quello angloamericano,
iperindividualista e chiuso nel calcolo delle convenienze, vettorialmente espresso dalla politica
economica di Reagan, di Bush e della Thatcher e quello, più aperto a motivi solidaristici e
comunitari, teorizzato nel modello di economia sociale di mercato, il cosiddetto “modello renano”,
applicato in Europa dalla Germania e in Asia dal Giappone.
Anche se a distanza di circa dieci anni dall’uscita di quello studio, la situazione economica
europea, e quella tedesca, non gode più di quelle condizioni positive, la distinzione posta da Albert
su due modi relativamente diversi di pensare il capitalismo, continua a mantenere una sua utilità per
le linee di tendenza che offre, sulle quali può essere possibile riflettere anche per il nostro tema. Il
punto allora sostenuto dall’economista francese, nel tempo, cioè, nel quale le economie più
dinamiche del mondo erano quella tedesca e quella giapponese, era che la socialità non costituiva
un costo passivo, bensì un investimento destinato a rendere, e che la saldatura tra socialità e
competitività poteva realizzarsi con grande profitto delle Nazioni che l’avevano perseguita, come
appunto stava lì a testimoniare il successo dell’economia tedesca e giapponese.
Va detto che indubbiamente il fascino che il modello di economia sociale di mercato, pur se talvolta
segnato da una certa arroganza del potere, aveva finito per esercitare era in stretta relazione con il
successo pratico che la riuscita fusione di elementi di socialità aveva conseguito nella competizione
sul mercato mondiale. Senza un tale successo, la suggestione sarebbe stata relativa, visto che né il
capitalismo tedesco, né quello giapponese avevano comunque creato il “paese delle meraviglie”.
Rimane pur sempre da tenere in preziosa attenzione il fatto che già si è resa possibile una efficace
coniugazione della competitività, e della ricerca del profitto che la innerva, con la socialità, e con le
forme di vita che la hanno presa come registro.
La fallaccia economicistica
Posta questa prospettiva, e per quella validità che essa può pretendere, vale ora la pena di riferirsi ad
un autore, meno noto e citato degli autori prima richiamati, il contributo del quale sulla riflessione
critica del paradigma dell’economia politica non è meno decisiva, intendo Karl Polanyi. La sua tesi
centrale è che l’economia è “annidata” nel contesto sociale generale. Da un punto di vista storico
l’economia è immersa nelle relazioni sociali e gli agenti economici agiscono non tanto per
massimizzare i propri interessi materiali, quanto per garantirsi posizioni, ambizioni e vantaggi
sociali. Il mercato e il capitalismo, pertanto, sono il risultato di un processo attraverso il quale
l’economia si è liberata dal controllo della società e ha subordinato alle proprie necessità tutti gli
altri aspetti della vita sociale. Questo processo è stato capillare a tal punto che gli studiosi tendono a
5
dimenticare la sua eccezionalità, cioè la sua unicità nella storia dell’uomo, e a concepirlo,
sbagliando, come una manifestazione di leggi universali e generali.
Ne La grande trasformazione, che è la opera fondamentale di Polanyi, la tesi centrale è che il
mercato autoregolativo costituisce il grande meccanismo istituzionale di regolazione economica del
capitalismo, ma che questo non può sopravvivere a lungo senza annullare la sostanza naturale e
umana della società. L’economia, infatti, una volta strutturata sulla base del mercato autoregolativo,
si trova destinata a separarsi radicalmente dalle altre istituzioni sociali e a costringere il resto della
società a funzionare secondo le sue leggi, trasformando terra e lavoro in “merci fittizie”, e
l’ambiente in un deserto. Al centro della “Grande trasformazione” è il capovolgimento dell’idea che
la società di mercato costituisca un punto di approdo naturale nella vicenda delle società umane e
dunque la relativizzazione delle categorie che in essa hanno la loro validità. Polanyi distingue due
aspetti della vita economica, quello “sostanziale”, che definisce le relazioni istituzionalizzate fra gli
uomini e il loro ambiente naturale e sociale e mira al soddisfacimento dei bisogni, e quello
“formale”, fondato sulle nozioni di scelta tra alternative e scarsità di mezzi, oltre che sull’idea di
relazione logica tra mezzi e fini.
La “fallacia economicista”, come la definisce Polanyi, consiste nello scambiare il secondo aspetto
per l’intera vita economica. Tale fallacia è nata, a partire dal diciottesimo secolo, assieme alle
economie di mercato formalizzate con le loro relazioni tra domanda e offerta, che gli economisti
avevano considerato, sbagliando però, come naturali e universali. Non più naturale, dunque,
semmai meno delle altre, la “ società di mercato” è come un caso patologico che è destinato a
chiudersi con una crisi violenta, a causa dell’estrema artificiosità di un sistema nel quale l’economia
si è sottratta al controllo sociale, celata dalle giustificazioni dell’economia classica. Per Polanyi
l’economia è immersa in altre istituzioni e si chiede allora quale mai possa essere il genere di realtà
istituzionali nel quale si annida quel processo dell’attività economica, che è un costante
spostamento di uomini, mezzi materiali e conoscenze tecniche entro la società. Che tipo di principi,
insomma, governa, di conseguenza, il flusso dei beni economici dentro la società? A contraltare del
modello mercato-denaro-scambio degli economisti formalisti, Polanyi formula una tipologia che
distingue tre principi di integrazione economica: reciprocità, ridistribuzione e scambio. Ognuno di
questi tipi implica forme di distribuzione spaziale diverse.
La reciprocità comporta transazioni correlate tra gruppi simmetrici, per esempio gli scambi di doni,
la ridistribuzione comporta transazioni appropriative da e verso un centro, quali per esempio
possono essere distribuzioni di viveri organizzate amministrativamente, oppure la filantropia, infine
lo scambio, che si riferisce a transazioni in un sistema di mercato, vedi compra-vendita. Corollario
di tale classificazione è che il modo di trasferimento economico avrà la forma corrispondente al
quel tipo di raggruppamento strutturale che possiede la società. Quale che possano essere i limiti, o
le carenze, di questa tipologia, la critica generale di Polanyi appare valida e utile per quello che
fornisce alcuni criteri orientativi che possono permettere il pensiero di una economia che prenda
esplicitamente in considerazione il contesto istituzionale. Cosa, infatti, ci ricorda Polanyi? Nelle
società capitalistiche i fatti economici si muovono all’interno di forme sociali , politiche e religiose.
L’economia, quindi, non domina, ma si trova vincolata a finalità e a leggi di carattere extraeconomico. L’economia, insomma, come discorso specifico e come spazio autonomo non è un
predicato necessario dell’essere sociale, ma ha avuto una sua recente, ben datata, genesi. A partire
da un certo momento storico, attorno al “300 circa, la società incontra l’economia, la costruisce e in
un vischioso rimando tra se stessa e gli oggetti trovati – capitale, mercato, consumo, profitto-,
inventa un processo storico e culturale, che finisce per offrirsi come la teoria e la prassi
fondamentale della modernità.
6
Il dono perduto e da ritrovare
Un grande studioso francese contemporaneo può essere richiamato al riguardo, intendo François
Perroux, perché la sua ampia ricerca costituisce un tentativo interessante, all’interno di una
disciplina teoricamente dominata dal mitema dell homo oeconomicus, di ricondurre i vari problemi
dello sviluppo economico nel solco di una concezione creativa ed antiutilitaristica dell’agire
economico. Soprattutto in Economia e società. Contratto, scambio, dono, Perroux dimostra che le
idee e le prassi economiche devono aprirsi al mondo della vita e dei principi, per occuparsi, ben
diversamente da quanto prescrive il gretto calcolo crematistico, della soddisfazione dei bisogni
fondamentali di tutti e del massimo di libertà concreta, vissuta in modo da raggiungere la
rivelazione di tutte le capacità umane e potenziali presenti in ogni uomo. La risorsa uomo, di
conseguenza, assume nella sua opera una dimensione superiore che conferisce alla riflessione un
grande equilibrio. Per confrontarsi con i problemi reali della solidarietà umana, necessita una
posizione realistica, che non pensi di trovare la soluzione affidandola al libero dispiegamento
dialettico delle forze istintuali. Le ricorrenti tensioni socio-economiche possono essere ridotte in
maniera vantaggiosa per la società, se si riconduce l’economia alle sue finalità originarie etiche e
sociali. Crescita, sviluppo e progresso propriamente detto, costituiscono livelli ascendenti di
organicità. Il progresso include armonicamente gli altri due concetti e può essere l’esito sia di
processi coercitivi, pilotati dalle classi dominanti, come avvenuto finora, sia dell’agire di estesi
movimenti sociali, fondati sulla partecipazione e sulla adesione degli esecutori alla creazione
collettiva. Gli economisti che designano nell’avarizia delle nazioni un naturale e metastorico
strumento di progresso, pretendono di ignorare che il mercato non è un meccanismo che può essere
separato dalla società, entro la quale nasce e si sviluppa, e che l’uomo non è affatto caratterizzato
dal mercato, perché non si può sostenere davvero che l’economicismo sia un apriori, insito nella
natura umana.
La domanda che sorge dalla lettura delle pagine di Perroux è se sia possibile mai una visione
dell’economia, dove gli unici atti razionali non siano solamente la compravendita e il prestito,
secondo quanto impone la scienza ufficiale, ma dove si riaffermi la preminenza della persona
umana. Insomma, si tratta di ri-trovare quel perduto principio di reciprocità positiva, che si trova
sempre legato ad un alto grado di coesione dei gruppi sociali e che costituisce una forma di
interazione organica non economica, dove le relazioni di reciprocità, pur venendo prima della
ricerca del profitto, sono in grado, allo stesso tempo, di rispondere alle necessità poste dalle attività
veniali.
Si tratta, più chiaramente, di quella precisa forma di reciprocità positiva, che è in primo luogo un
ciclo animato dalla triplice obbligazione del dare, ricevere,restituire, che costituisce, secondo
quanto ampiamente dimostrato da etnologi, quali Marcel Mauss e da economisti, quali appunto
François Perroux, il vero e proprio nucleo basale di ogni forma di socialità, capace di dettare un
altro modo di pensare e fare l’economia. Persino per Alfred Marshall, uno dei sommi padri della
teoria neoclassica, il Dono, che è il nome che si appella per la richiamata reciprocità positiva, come
trasferimento di beni privo di contraccambio immediato o certo, è un atto di “cavalleria economica.
Infatti, per l’autore dei famosi Principles of Economics, la condotta degli affari dovrebbe
uniformarsi a quei criteri di nobiltà d’animo che informarono la cavalleria medioevale. L’uomo
d’affari, così, con il disinteresse verso l’utile personale mostrato dagli antichi cavalieri, dovrebbe
orientare le proprie attività verso il bene comune. Secondo la tradizione cavalleresca, in effetti,
l’uomo ricco deve restituire alla comunità quello che in precedenza ha conquistato grazie ad essa.
Così facendo, colui che dona acquista prestigio sociale, suscitando tra i beneficati reazioni
emulative, segnate dalla volontà di restituire, secondo le diverse capacità, quanto si è ricevuto. In tal
modo, contro il predominio dello spirito mercantile, potrebbe diffondersi ovunque l’aspirazione” a
fare cose nobili e difficili, solo perché sono nobili e difficili.
7
Aristotele ha definito come autonome tutte quelle attività che sono fine a se stesse, praticando le
quali l’uomo fa esperienza della propria sovranità e si realizza come persona. Le attività mercificate
sono escluse per essenza, poiché il loro fine è quello scambio monetizzato che sminuisce e
contamina il senso intrinseco, non misurabile, dell’azione o dell’opera. Il pittore, ad esempio, non
dipinge i suoi quadri per venderli, e quando li mette in vendita è per mostrarli e poter continuare a
dipingere. Per l’attività artistica, infatti, al pari di quella sportiva, e come per quelle che riprendono i
giochi, il turismo, gli spettacoli, il denaro non fonda affatto la ragione che le muove, ma rappresenta
solo un mezzo necessario. Questo non vieta evidentemente che ci possa essere uno scambio, ma
esclude che questo possa avere un carattere meramente mercantile, per quello che la sfera delle
attività autonome può sopportare ed accettare come forma dello scambio unicamente la reciprocità
del dono. Io ti faccio dono senza chiedere una contropartita, tu accetti il dono con gioia e ti impegni
a contraccambiare. Non si tratta, però, di rendere un equivalente di ciò che si è ricevuto, ma di
restituire nell’occasione propizia e a chi capiterà, di rimettere, insomma, oggettivamente in circolo
il dono avuto. Si tratta, pertanto, di instaurare un rapporto di generosità, di “amicizia”, nel quale
ciascuno considera l’altro incondizionatamente come fine assoluto.
L’attività sportiva appartiene per essenza a quest’ordine d’azioni, accanto a quelle religiose,
filosofiche, scientifiche e artistiche. Non sono, queste, pratiche strumentali per guadagnarsi da
vivere, implicano, al contrario, un dono di sé incondizionato e questo dono continua ad essere
riconosciuto nel suo valore incommensurabile anche quando gli dovesse accadere di essere
“onorato” con un pagamento, perché questo non potrebbe mai avere il senso di un acquisto, vale a
dire di un controvalore di scambio. Sono attività, inoltre, libere da necessità, perché quello che
coscientemente le motiva è il desiderio di far nascere, o di manifestare, il Vero, il Bello e il Giusto.
Si deve alla fatica di ricercatore di Marcel Mauss la scoperta in seno al mondo arcaico
dell’universalità dell’obbligo di dare, ricevere, restituire. Un siffatto obbligo, che Mauss
mirabilmente descrive nel suo Saggio sul dono, è governato da una duplice condizione: non esiste
dono non spontaneo, ma questa spontaneità è soggetta ad obbligo, quello che lo muove è il puro
piacere, ma in esso è presente un certo interesse, il soddisfacimento del quale passa per la sua
negazione. Il dono, in buona sostanza, come ogni tipo di azione, conosce il momento dell’interesse,
ma non si appiattisce su di esso, ruota, invece, su altri centri altrettanto reali come quelli del piacere,
dell’obbligo e della spontaneità. Non è, dunque, una “ragione utilitaria” quella che lo giustifica,
piuttosto quell’affettività che Aristotele per il mondo greco e Cicerone per il mondo romano, hanno
significato con i nomi di philia e d’amicizia. Nell’antica Roma, poi, i munera, secondo quanto
testimonia Festo, avevano un chiaro riferimento allo scambio e al dono, donum quod officii datur.
Riguardavano, infatti, quelle nomine dei magistrati che obbligavano il cittadino eletto ha restituire,
a contraccambiare, gli onori e i vantaggi che l’elezione a tale carica comportava, con offerte a
proprie spese di spettacoli, in questa reciprocità propriamente trovandosi giustificato il senso di
munus, tanto come “carica ufficiale”, quanto come “scambio”.
Il dono esplorato da Mauss, non riguarda soltanto i popoli arcaici, ma resta il momento costitutivo
di quella che è stata definita la socialità primaria della modernità, di quella sfera sociale, vale a
dire, fuori dalla socialità secondaria del mercato e dello Stato, dove si vive l’unione e la parentela,
l’amicizia e il cameratismo e si struttura concretamente la vita associativa. In essa, infatti, le
relazioni tra persona e persona funzionano sempre in base all’obbligo di dare, ricevere e restituire,
ed è proprio attraverso questa reciprocità circolare che si formano le identità personali e si
intrecciano le comunità, secondo quanto testimoniano, proprio ispirandosi agli studi di M.Mauss, i
sociologi francesi J. Godbout e A. Caillé nella abbastanza recente opera L’esprit du don. La
struttura intima dell’azione sportiva, il “mondo” che essa costruisce per la sua natura, potrebbe
allora porsi veramente come riferimento generale, come immagine di guida per l’insieme delle varie
attività che intrecciano la vita della società civile. Il triplice obbligo sul quale si modula l’azione del
dono, infatti, è, sotto una speciale angolatura, lo stesso dinamismo che fa scorrere, e la tiene in
giusta armonia, l’azione sportiva, tanto per quello che riguarda l’atleta nei confronti di se stesso,
quanto per quello che, in gara, deve vivere in relazione con gli altri.
8
L’atleta che, nella competizione, dà tutto se stesso, ha diritto per questo al rispetto degli avversari,
ma a sua volta è obbligato a restituire, a rimettere in circolo, il dono della lealtà ricevuto, nella
coscienza che l’occasionale hostis è, allo stesso tempo, il suo hospes. L’agonalità, in tal modo, se da
un verso costringe l’agonista a conoscere e ad accettare se stesso, dall’altro lo pungola a riconoscere
gli altri come figure necessarie, in un rapporto dialettico d’implicazione-esclusione, per poter essere
quello che è e realizzare la pratica che lo specifica. La pratica dello sport, infine, può rendere
evidente che se è pur vero che nell’uomo, e quindi anche nello sportivo, i momenti del prendere, del
conservare, dell’appropriarsi sono fondamentali, perché è un soggetto di passioni, di desideri, di
egoismi, è altrettanto vero che gli uomini provano piacere anche, e soprattutto, nel dare, nel creare,
nell’intraprendere. Per di più, l’essenza stessa dell’azione sportiva può offrire un ulteriore punto di
riflessione vitale. Se la promessa di una società “opulenta” per tutti appare oramai solamente un
miraggio, se la “società dei consumi” ha finito per assumere una singolare forma a clessidra, con
una base di posti al margine di essa che va sempre più allargandosi, mentre si restringe
progressivamente la sua parte alta, diventa allora necessario pensare ad una società altra, vivibile
per i “ più”, ancor prima che per i “meno”.
Lo spirito che anima le varie forme dello Sport è opposto a quello dell’opulenza, si richiama per la
sua natura, ad una necessaria idea di frugalità, che potrebbe offrirsi quale nuova “regola” per la
società degli uomini. Non sfugge, comunque, a chi scrive che il rapporto sociale che regola la
macrosocietà non si riduce affatto alla socialità primaria e che, di conseguenza, la regola di
quest’ultima, così com’è, non può valere per il mercato e per lo Stato. Quella che si ha in mente,
però, in questa discussione sullo Sport, è la società civile, e se non è troppo azzardato prevedere per
un futuro prossimo un’organizzata convivenza tra gli uomini connotata da una minore presenza
dello Stato e da una maggiore occupazione della società, allora il compito di pensare a relazioni
fondate sul dono, riprendenti tutta la società civile, appare non solo fattibile, ma addirittura vitale.
Post-fazione
Lo Sport nel Novecento
Nei primi decenni del Novecento, precisamente nel 1927, il filosofo e sociologo tedesco Max
Scheler scriveva: Forse nessun fenomeno collettivo sopranazionale merita oggi una analisi
sociologica e psicologica quanto lo sport, enormemente cresciuto in dimensione e valore. E
invitava gli studiosi ad interpretare con attenzione quel fenomeno che a lui appariva poderoso.
Sempre attento a tutto quanto la società moderna andava manifestando di se stessa. Scheler, infatti,
aveva bene inteso il peso e l’influenza che lo sport era destinato ad esercitare e anche come le forme
moderne con le quali le emergenti pratiche sportive venivano vissute, potessero essere rivelatrici del
sentire tipico dell’anima moderna. Nella seconda metà del Novecento, a far data dagli anni
Cinquanta, nell’Europa occidentale, nonostante le difficoltà poste dalla ricostruzione post-bellica, lo
sport cresce ovunque e aumenta vistosamente il numero dei praticanti, fino a coinvolgere settori
sempre più consistenti della popolazione giovanile. Si moltiplicano anche gli impianti sportivi che
accompagnano e sostengono la diffusione delle pratiche sportive e lo sport ben presto diviene una
delle occupazioni più ricorrenti delle nuove generazioni, una sorta di rito laico della società di
massa. Gli sport tradizionali, tanto individuali, quanto di squadra si ingigantiscono e si radicano
sempre più nel costume sociale. Si popolarizzano, allo stesso tempo, sports prima praticati da
minoranze, al punto che tennis, sci, canottaggio pallavolo, nuoto ed atletica, tra altri, finiscono
spesso per far concorrenza agli sports più antichi. Le ragioni di questa esplosione, si potrebbe dire
di questa pandemia sportiva, di riferiscono a due fattori fondamentali: il primo riguarda la
9
diffusione negli strati e nei tempi sociali del tempo libero, il secondo riguarda la maggiore
disponibilità economica e la crescita delle risorse individuali da poter impiegare nel tempo libero.
Una spinta all’ulteriore sportivizzazione del tempo libero è stata data anche da certe politiche sociali
che il Welfare state trionfante nelle società occidentali ha messo in campo, con la costruzione di
impianti e con la promozione e la organizzazione delle attività sportive quali veicolo di
socializzazione. Ai vecchi e ai nuovi sports, inoltre, negli ultimi tempi si sono aggiunti quelli di
phisical fitness, quelli ecologi di provenienza californiana, centrati su una concezione salutistica
dell’attività psicocorporea e sull’esaltazione del corpo e infine quelli sentiti e vissuti come
“estremi”. Al monismo “spiritualista”, sprezzante verso le attività corporee, ancora diffuso nella
società nei primi del Novecento, ha finito così per opporsi il monismo “materialista” di oggi, una
specie di “umanesimo del corpo”, che tende a rivalutare quest’ultimo sul piano esistenziale nella
pienezza della sua espressività e delle sue potenzialità, al punto che “le tecniche del corpo” sono
diventati temi dominanti nella psicologia, nella pedagogia, nella psicanalisi e nella antropologia. Il
corpo è diventato il totem dell’epoca moderna e lo sport è considerato come un’azione che vive
sull’idea di progresso che anima il corpo, su quella ottocentesca tesi scientifica di stampo
evoluzionista che postula che ad ogni miglioramento di performance possa seguirne un altro che si
va a registrare su di una linea verso l’avanti della quale non si conoscono i limiti. Una tale
persuasione nell’ambito più specificatamente competitivo ha dato vita ad una singolare ossessione
del record, in accordo certamente con quello che è il sentire moderno, come assai bene detto da il
massimo esponente dell’antropologia filosofica Arnold Ghelen: la continua ricerca del record
corrisponde alla razionalizzazione che affiora sempre più nettamente nella nostra vita...e che
astrae dal qualitativo ed estrae unicamente il misurabile e il quantitativo. Il record, che è una
astrazione, permette una dilatazione psicologica della competizione che può avvenire non soltanto
con recordman viventi, ma anche con quelli già defunti. Come tale è un congegno psicologico
polifunzionale, perché funge da stimolo al conseguimento di una data prestazione e allo stesso
tempo da barriera psichica che si oppone agli sforzi umani e in ogni caso simboleggia la civiltà
occidentale che rincorre il primato e l’individuo moderno affascinato dalla potenza, suggestionato
dalla grandezza e attratto dalla velocità. Il record certamente ci dice di questa attitudine a
primeggiare attraverso la testimonianza e il contributo all’evoluzione della “macchina-uomo” e a
celebrarsi narcisisticamente con la quantificazione delle “gesta” sportive. Ma, di converso, ci
ammonisce anche che l’atleta è un uomo che non può essere ridotto a metri, a secondi, a
chilogrammi, e neppure ad un prodotto da allevamento animale, così come l’azione sportiva, che è
espressione dell’uomo, non può risolversi unicamente in una serie schematizzata di gesti meccanici.
Tralasciando per ora questo aspetto, si può concludere che in una società di massa che interiorizza
una parte sempre più crescente di attività sportive, lo sport acquisisce una decisa rilevanza sociale e
che coinvolge di continuo nuovi soggetti sociali. Questo coinvolgimento, però non è solamente
sportivo, ma è antropologico e culturale in senso lato ed economico in particolare.
Deideologizzazione dello sport e sua economicizzazione
1. Nella seconda metà del Novecento, per una serie di processi prevalentemente economici, la sfera
politica della società ha cominciato a perdere il controllo esercitato per anni sullo sport, sui suoi
contenuti culturali ed ideologici e conseguentemente sulla sua funzionalizzazione sociale. Non si
vuol dire che lo sport abbia rotto tutti i ponti con la politica e non si abbia più una osmosi tra sport e
politica, assieme ai loro reciproci condizionamenti. Si può però sostenere che la politica non
egemonizzi più lo sport, come ancora avveniva negli immediati anni del secondo dopo guerra, vedi
la vittoria di Bartali al tour di Francia del 1948, oppure la rivalità tra Bartali, il “ciclista di Dio”,
simbolo dell’Italia cattolica e dei comitati civici e Coppi, l’“adultero”, icona dell’Italia laica e
progressista. È pur vero che esempi di efficace interattività tra sport e politica si ritrovano ancora
negli anni settanta al tempo degli Olimpiadi del Messico e di Germania e a seguire nei boicottaggi
olimpici di statunitensi e di sovietici. Si può aggiungere a questo il costume invalso da parte di
10
politici e di imprenditori di usare strumentalmente la ribalta dello sport per crearsi riserve elettorali,
utilizzabili per affermazioni personali. Nonostante tutto questo, lo sport ha finito per affrancarsi da
ogni ideologia fino a costituirsi a ideologia di se stesso, fuori da ogni subordinazione e da rapporti
preferenziali con questo o quello settore sociale. La deideologizzazione politica dello sport non ha
prodotto però uno stravolgimento della natura funzionale dello sport. In questi ultimi anni, infatti, lo
sport si è costruito una sua ideologia di se stesso, ma ha mantenuto talune delle sue funzioni
strutturali, la più importante delle quali, assieme a quelle salutistiche, è sicuramente quella di dare
identità ad una moltitudine sparsa di soggetti sociali, di fornire ad essi i luoghi di approvazione e di
riconoscimento culturale e psicologico. Lo sport, anzi, ha assimilato molte delle caratteristiche che
prima gli erano imposte dall’esterno dai “grandi racconti” dell’ideologia e li raccoglie, li promuove
e li caratterizza secondo modalità che riflettono i suoi propri interessi. In tal modo lo sport
ideologicamente autoreferente può essere totalizzante al pari dello sport eteroriferito, cioè in grado
di attivare meccanismi sociali e psicologici, individuali e collettivi altrettanto totalizzanti e al pari
dello sport visto quale “teatro di massa”, funzionale alla fabbricazione del consenso politico, ma
dove ora si recita un altro copione,sempre efficace, però, a produrre altrettanti condizionamenti
psicologici.
2. La deideologizzazione dello sport ha preso avvio negli ultimi decenni a seguito della costante
attenzione e del crescente impegno economico del sistema industriale nel dominio sportivo. In un
primo momento, un determinato settore economico promuove e alimenta le manifestazioni sportive
e il loro sviluppo nella società. È questo il tempo durante il quale lo sport, bipolarizzato tra
dilettantismo e professionismo, è assistito economicamente: team automobilistici, squadre di calcio,
squadre di ciclismo, di pallacanestro, pugili sono sostenuti e mantenuti da grandi industrie, che
attraverso loro fanno conoscere e diffondono il loro marchio. Un tale sostegno ripete antiche forme
di mecenatismo sportivo da un lato e di filantropismo sportivo dall’altro e in queste forme di
sostegno dello sport si evidenzia assai presto l’utilità dell’investimento pubblicitario, con una decisa
ricaduta positiva nella vendita dei prodotti dell’azienda sponsorizzatrice. Con il passare degli anni,
poi, lo sport diviene una sede privilegiata dell’investimento pubblicitario e cambia il suo ruolo,
passando da beneficato a benefattore. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, infatti, attraendo
l’attenzione e gli interessi delle masse, risulta essere il palcoscenico migliore per il lancio e la
propaganda dei prodotti. Negli anni cinquanta la società europea vede il trionfo delle televisioni
nazionali, poi dell’Eurovisione e infine della Mondovisione, assiste insomma alla consacrazione
della televisione quale mezzo primario della comunicazione sociale e di massa, e alla definitiva
affermazione, nell’ambito delle comunicazioni, dell’immagine dinamica su quella statica offerta dai
tradizionali sistemi di stampa. Gli avvenimenti sportivi hanno sempre, rispetto ad altri eventi o a
spettacoli di rilassamento, una altissima visione e godono così di un pubblico televisivo di milioni
di spettatori. E’ evidente allora che l’associazione comunque di un marchio commerciale ad un
fatto, anzi ad uno spettacolo sportivo, è vista da un pubblico grandissimo, buona parte del quale può
essere indotta allora, proprio in grazia di quella associazione sport-prodotto commerciale, a
trasformarsi in acquirente. La lunga esposizione di un vasto pubblico all’immagine sportiva finirà
per configurare il luogo di una specie di rivoluzione economica. Gli agenti pubblicitari, infatti,
proprio nell’esposizione più lunga e più seguita dell’immagine sportiva, individua per le imprese il
luogo dove esibire marchi e scritte che potranno avere una più ampia risonanza e godere di un
credito commerciale molto più intenso rispetto alle tradizionali tecniche pubblicitarie. Prende avvio
l’era della sponsorizzazione, dove l’industria, indipendentemente dal suo prodotto specifico,
finanzia società ed atleti e li utilizza quali veicoli del suo marchio e compra spazi pubblicitari
all’interno delle manifestazioni sportive. In tal modo, l’industria sportiva, oltre che lanciare
messaggi promozionali, orienta e caratterizza tanto il mercato, e i suoi consumi, quanto la
produzione di materiali, di attrezzature sportive, di abbigliamento sportivo. Con la
sponsorizzazione, l’avvenimento sportivo si trasforma in un ambito “fattore di produzione” che le
organizzazioni e le società sportive offrono e vendono al miglior offerente ricavando profitti
sempre maggiori. Lo sport, di conseguenza, da luogo di un impegno promozionale e pubblicitario si
11
fa lui stesso economia, con questa trasformazione, però, ponendo un problema grave, per quello che
la natura della sport non è affatto economica, ma estetica. Non è difficile vedere che nelle società
tardo-industriali lo sport è diventato un ambito di produzione economica, un luogo ove si produce
una merce, ma dove si è dimenticato che lo sport non è merce. L’economicizzazione dello sport lo
ha sicuramente sottratto alla subordinazione politica e a una collocazione sociale legittimata solo
dalla sua utilità politica, lo ha svuotato dall’ideologia, e ricondotto a se stesso, ma a un se stesso
necessitato dalla sola economia. Quello che ne consegue è che divenuto un prodotto economico, lo
sport diviene a sua volta merce che ha un suo spettacolo, un suo pubblico, i suoi consumatori. Gli
stessi rapporti sportivi, le relazioni tra i soggetti che operano nel “mondo dello sport”, sono divenuti
rapporti economici, relazioni tra soggetti economici, all’interno di luoghi di produzione e di
commercializzazione di prodotti. L’etica che dovrebbe regolare questo insieme di rapporti e
relazioni è a sua volta un etica economica, mercantile, dove però non vive più il “mercante”, che è
pur sempre un individuo, seppure ridotto alla sola dimensione sensistica , ma la “produzione” che si
impone, superandolo, allo stesso individuo, rendendo vera e attuale l’affermazione fatta a suo tempo
da Sombart, riguardo il sistema di produzione e di vita del capitalismo: Fiat productio et pereat
homo. Il nuovo modo di consumare lo sport è reso possibile da una offerta di prodotti industriali
pubblicizzata nei media e nelle manifestazioni sportive, che lo riproducono e lo moltiplicano, da
una industria, indotta dallo sport stesso, fatta di tecnologie sofisticate, di attrezzature ricercate, di
abbigliamento griffato, di materiali propagandistici e pubblicitari, che servono ad educare e
spingere al consumo un soggetto sociale che consuma sport non solo nell’esercizio specifico o nella
partecipazione passiva all’evento, ma che consuma lo sport fuori dai suoi tempi tradizionali,
investendo economicamente, psicologicamente e culturalmente quote non indifferenti delle sue
risorse complessive non immediatamente riferibili all’esercizio e alla partecipazione all’evento
sportivo.
12