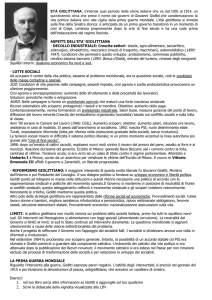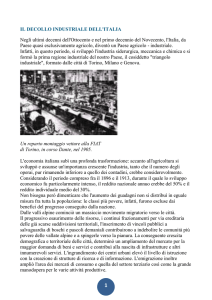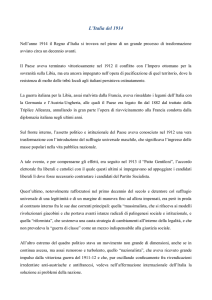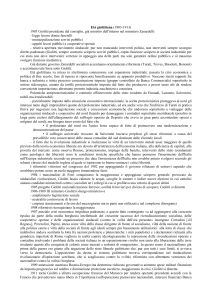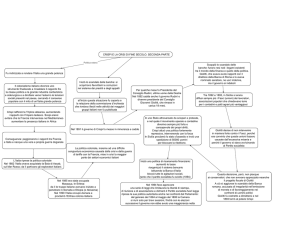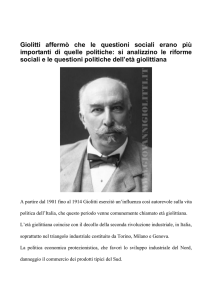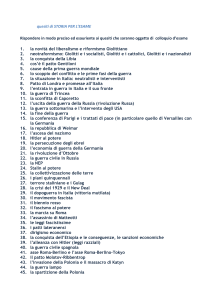Il potere alla volontà della
nazione: eredità di Giovanni
Giolitti
di Aldo A. Mola
IL POTERE ALLA VOLONTÀ DELLA NAZIONE: EREDITÀ DI GIOVANNI GIOLITTI
−
Gli ultimi anni della vita di Giolitti, 1920-1928, furono intensi e segnati dai profondi
rivolgimenti vissuti dall’Italia tra inquieto dopoguerra, crisi agonica del sistema liberale,
avvento del governo Mussolini, deriva verso il regime di partito unico, estrema difesa delle
libertà statutarie. Benché ormai anziano, per unanime riconoscimento Giolitti rimase a lungo
il punto di riferimento del sovrano, di larga parte del Paese di quanto rimase della tradizione
liberale.
−
Sia pure a grandi pennellate, la ricostruzione di quegli anni conferma la sua misura di statista.
Nel 1920 le condizioni dell’Italia erano per molti aspetti drammatiche. Vinta la guerra, sempre
più essa stava perdendo la pace. La lotta politica e gli scioperi a getto continuo, anzitutto nei
pubblici servizi, la precipitavano nel caos. Sfuggivano di mano a quanti promuovevano e
generavano una guerra civile strisciante, che ormai si alimentava da sé: di vendetta in
vendetta. Stava accadendo quanto Giolitti aveva sempre cercato di scongiurare: gl’italiani si
divisero all’interno sulla base della loro adesione a interessi stranieri. Nel gennaio 1921 al
congresso di Livorno si verificò l’ennesima scissione del partito socialista. Nacque il Partito
comunista “d’Italia”, sezione “locale” della Terza Internazionale fondata da Lenin nell’Unione
delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla base di 21 punti che obbligavano le sezioni
aderenti ad anteporre gl’interessi dell’URSS a quelli del loro Paese giacché essa era la “madre
della rivoluzione” in corso nel mondo e per poterla poi esportare occorreva intanto difenderla
dove si era affermata. Senza confluire nel Pcd’I, che puntava all’”ordine nuovo”, l’ala
massimalistica del partito socialista mirò a “scavalcarla a sinistra”, mobilitando i militanti
contro le istituzioni (Corona, Parlamento, …) oltre che contro il “dominio di classe” della
borghesia.
−
Giolitti non aveva avuto parte nel varo della proporzionale che nel 1918 sostituì i collegi
uninominali. Si trovò nondimeno a fare i conti con le conseguenze delle elezioni del 16
novembre 1919, che avevano affossato la maggioranza liberale e ridotto al lumicino i seggi per
i democratici nella sua stessa provincia: tre su 12. Quando Nitti risultò incapace di risolvere la
crisi di Fiume, di avviare il risanamento del debito pubblico e tenere insieme al governo
popolari (cattolici), socialriformisti ed ex radicali (anticlericali e massoni), il re incaricò
Giolitti di formare il governo. Questi aveva 78 anni. Consapevole dei giganteschi problemi
incombenti, Nitti (Melfi, Potenza, 1868 – Roma, 1953) – che stava nell’ufficio di presidente del
consiglio dalle cinque o sei del mattino alle undici di sera – profetizzò che entro un mese, per
la fatica, lo statista piemontese avrebbe mostrato novant’anni e cento entro due mesi. Sarebbe
stato triturato dall’emergenza e il governo sarebbe tornato a lui, appena cinquantenne. Invece
“a Palazzo” Giolitti andò, come sempre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sei ore gli bastavano,
perché aveva idee chiare sulle cose da fare e si circondò di ministri competenti e volitivi, tutti
decisi a far valere l’autorità dello Stato e a usarne la macchina senza risparmio, a cominciare
dalla forza pubblica. I capisaldi del programma di governo erano già stati enunziati nel
discorso del 12 ottobre 1919, col quale aveva affrontato le elezioni del novembre successivo e
che suscitò un ampio dibattito nel paese. Ora si trattava di metterli in pratica. In primo luogo
occorreva restituire credito internazionale all’Italia: contrattare la restituzione dei giganteschi
debiti di guerra, in specie con gli USA, e risolvere le potenziali contese con gli Stati confinanti
sorti dalla dissoluzione dell’Impero austro-ungarico: la repubblica austriaca e quella
jugoslava. I rapporti con l’Austria vennero regolati dalla pace di Saint-Germain (foriera di
tensioni e conflitti che verranno forse risolti nel XXI secolo, con l’ampliamento dell’Unione
Europea). Con la Jugoslavia Giolitti stipulò il Trattato di Rapallo (12 novembre), che riconobbe
il confine del regno a Monte Nevoso (molto oltre quello previsto dal patto di Londra del 1915)
e il conferimento a Fiume dello status di Corpus separatum, un’autonomia che avrebbe
lasciato libero campo alla sua progressiva pacifica “italianizzazione” in una visione ispirata
PAGINA 1
alla collaborazione internazionale anziché all’espansione imperialistica. Quale necessaria
conseguenza, a fine anno Giolitti intimò a d’Annunzio di lasciare Fiume, e poiché il “reggente”
non si decideva, usò le forze armate: reparti dell’esercito occuparono Zara e marciarono sulla
città, mentre l’”Andrea Doria” cannoneggiò il Palazzo della Reggenza e colpì un locale attiguo
all’ufficio del “vate”, che si decise ad andarsene. Altrettanta fermezza il presidente chiese ai
ministri chiamati a restaurare la finanza pubblica, tagliando tutte le spese pubbliche non
strettamente necessarie, e con l’abolizione del prezzo politico del pane: operazione affidata a
Marcello Soleri, in veste di Commissario straordinario. Altri obiettivi immediatamente avviati
a soluzione con appositi disegni di legge furono la nominatività dei titoli, di qualsiasi genere,
per poterli sottoporre con certezza a tassazione. Conscio che si trattava di innovazione
sgradita alla Santa Sede, offrì in cambio l’istituzione dell’esame di stato quale traguardo finale
degli studi superiori, sì da restituire dignità alla scuola e, al tempo stesso, da rimuovere ogni
ostacolo alla proliferazione delle scuole private (cattoliche) a patto che, appunto, preparassero
i loro allievi ai livelli richiesti in quella pubblica. Nessuno dei due disegni andò in porto, ma
il secondo rimase cardine della riforma scolastica attuata nel 1923 da Giovanni Gentile, che
operò nel solco di Benedetto Croce.
−
Il terzo nodo da sciogliere fu il trasferimento del potere di dichiarare guerra e trattare la pace
dal re al Parlamento. Espressione di una borghesia che arrivava dalla dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789 e che non si sentiva intimidita dall’ascesa delle masse e dalle
loro ragionevoli richieste, Giolitti non esitò a mettere in evidenza le ambiguità e le
contraddizioni tra lo Statuto albertino, che affondava un piede nell’assolutismo
predemocratico, e la realtà della Nuova Italia, in forza della quale il sovrano tale era sulla base
dei plebisciti e quindi “per volontà della nazione”. Secondo Giolitti non si sarebbe dovuta
ripetere mai più la situazione dell’aprile-maggio 1915, quando una manciata di persone –
talune neppure al governo – aveva deciso le sorti dell’intero Paese, impegnandone il futuro
con trattative segrete, all’insaputa del potere, Parlamento, opinione pubblica. A che cosa
serviva il diritto di voto se poi le decisioni supreme – che gl’Italiani dovevano scontare con la
vita in trincea e con la perdita di valore dei loro risparmi e beni – venivano assunte in “piccolo
comitato”, al di fuori del quadro istituzionale? Per Giolitti la sovranità era nel Parlamento e
nei consessi elettivi: province e comuni. La guerra aveva aperto gli occhi: ciò che sino ad allora
era stato tollerabile (guerre coloniali a Camere chiuse, com’egli stesso aveva fatto con lo
sbarco di Tripoli e prima di lui Depretis, Crispi e Pelloux con l’impresa in Cina…) ora risultava
francamente inammissibile.
−
Nel settembre 1920 l’estrema sinistra politico-sindacale decise l’occupazione delle fabbriche
nell’illusione di “fare come in Russia”. Confuse il luogo di produzione con quello del potere:
istituzioni e mercato, interno e internazionale. Le violenze, non solo verbali, di quei giorni
spinsero i conservatori a contrattaccare. Giolitti non accolse la richiesta padronale di usare la
forza contro un movimento di quasi mezzo milione di persone. Come già nel 1904, lasciò che
l’agitazione, priva di prospettive realistiche, si esaurisse da sé: anche sulla base di un patto che
prevedeva la compartecipazione degli operai agli utili, messo a punto da massoni torinesi e
milanesi di entrambe le parti in conflitto (era il caso di Gino Olivetti per gl’industriali) e che
faceva capo al ministro del Lavoro, Arturo Labriola, massone a sua volta. Anziché in piazza i
massimalisti andavano affrontati alle urne. In vista della rielezione dei consigli provinciali e
comunali, in carica dal 1914, Giolitti puntò alla formazione di blocchi moderati per battere
comunque la sinistra. Don Luigi Sturzo si oppose però alla convergenza del PPI in tali blocchi,
suscitando perplessità e reazioni negative anche in ambienti della Santa Sede, come ha
documentato padre Giovanni Sale S.J. (“La Civiltà Cattolica”, 19 luglio 2003, a. 154, n. 3674). I
blocchi risultarono pertanto sbilanciati a destra. Compresero liberali di vario orientamento,
nazionalisti, agrari, interventisti, ex combattenti, fiumani e fascisti. Risposero all’intento.
Poiché molti sindaci socialisti, appena insediati, si premurarono di levare dal loro ufficio il
PAGINA 2
ritratto del re, risultò ancor più chiaro che per salvare lo Stato occorreva utilizzare i blocchi
anche in sede politica. Contro il parere dell’amico Alfredo Frassati (che riteneva occorresse
passare attraverso una seria riforma elettorale), Giolitti ottenne lo scioglimento della Camera
e nuove elezioni (15 maggio 1921). Esse produssero quattordici gruppi parlamentari, con lieve
incremento dei popolari, una flessione dei socialisti, bilanciata dall’affermazione di comunisti
e socialisti indipendenti. Accanto a nazionalisti e liberalconservatori, vennero eletti 35 fascisti:
due in liste dichiaratamente tali e 33 nei blocchi (tra questi anche Mussolini e il ras di
Cremona Roberto Farinacci). Dinnanzi all’irriducibile ostilità di PPI e socialisti a un’intesa coi
liberali – una specie di “unione sacra” per la salvezza dell’Italia – Giolitti si dimise. Si
susseguirono in breve tre governi in poco più di un anno, sempre più deboli e incapaci di
contenere il dilagare delle violenze. Lo statista invitò ripetutamente cattolici e socialisti
moderati a mettere la sordina, almeno in via transitoria, su ciò che divideva per varare un
governo di ampia coalizione. Invano. Sturzo fece sapere che avrebbe preferito un accordo
diretto coi socialisti piuttosto che favorire il suo ritorno al governo. Giolitti osservò che non
ci si poteva attendere nulla di buono da un’intesa tra Sturzo e Turati, espressione di forze
originariamente avverse all’unificazione nazionale. Presto vanificato il patto di pacificazione
tra socialisti e fascisti (Zaniboni-Acerbo) del luglio 1921, nell’estate 1922 tutti i principali
esponenti costituzionali (Salandra, Orlando, Nitti, Bonomi e Giolitti stesso) si dichiararono
convinti che, per svuotare l’aggressività extralegale del fascismo – da movimento divenuto
Partito nazionale fascista: PNF – occorreva inserirlo nel governo, con una rappresentanza
proporzionale alla sua forza parlamentare. Giolitti però, fu l’unico a dichiararsi pronto a
formare un governo anche senza (e quindi contro) di essi. Dal canto suo Mussolini trattò con
tutti i predetti – Giolitti incluso – per dar vita a una nuova coalizione, proprio per impedire
che il re conferisse l’incarico a Giolitti. In quest’ultimo caso – egli disse al suo capo ufficio
stampa, Cesare Rossi – i fascisti sarebbero stati “fottuti”, perché, come aveva fatto sparare su
d’Annunzio, ancor meno avrebbe esitato ad affrontare in armi le “squadre” dei
manganellatori.
−
Altrettanto lineare di quella giolittiana fu la condotta di Vittorio Emanuele III. Sollecitò
ripetutamente Facta, cui spettava, a convocare il Parlamento in modo da mettere ciascuno
dinanzi alle sue responsabilità. Il presidente lo rassicurò sino all’ultimo che non v’era alcun
timore di “marcia su Roma”. Il 27-28 ottobre la crisi precipitò ma Facta si guardò dal chiedere
al re di convocare Giolitti a Roma. Infine lo fece, ma solo su sollecitazione di Vittorio
Emanuele III e quand’ormai la situazione era compromessa. Infatti, per evitare una guerra
civile a vantaggio dell’estrema sinistra e che nessuna persona di buon senso voleva, la mattina
del 28 ottobre il sovrano negò la firma alla proclamazione dello stato d’assedio e incaricò
dapprima Salandra, poi lo stesso Mussolini che il 30 giunse a Roma e presentò una lista di
ministri comprendente tre fascisti, liberali, esponenti del partito popolare (tra i quali il futuro
presidente della repubblica, Giovanni Gronchi), demosociali. Solo all’ultimo ne venne
depennato il socialista Gino Baldesi, disponibile alla collaborazione. Quel governo non
conteneva in sé necessariamente il futuro regime, né, meno ancora, quanto avvenne nel
ventennio seguente, l’alleanza con la Germania di Hitler, le leggi razziali, …: tutti eventi che
si verificarono in circostanze all’epoca niente affatto immaginabili. Se si vuole esprimere un
giudizio storiograficamente corretto, senza scadere in polemiche e propaganda strumentale
quanto avvenne nel triennio 1922-25 va valutato sulla base dei fatti di allora, non di quelli del
decennio successivo. Giolitti (come Benedetto Croce, Enrico De Nicola, Vittorio Emanuele
Orlando, Alcide De Gasperi, …) approvò la nuova coalizione, giacché essa puntò a risanare la
finanza pubblica e a ripristinare l’ordine, accelerando la ripresa economica. Fu anche
favorevole all’abolizione della “maledetta proporzionale” e all’introduzione del sistema
maggioritario (legge Giacomo Acerbo, 1923) che assicurò due terzi dei seggi della Camera alla
lista che avesse ottenuto almeno il 25% dei voti. Dichiarò: “il Paese ha il governo che si merita”
e rinfacciò ai socialisti di non aver mai avuto il coraggio di entrare al governo per mantenere
PAGINA 3
inutilmente immacolato il mito di una loro rivoluzione ormai tramontata. Poco dopo
Mussolini intavolò trattative per accordi economici con l’URSS, il cui governo non li
subordinò certo al benestare dei socialcomunisti italiani.
−
In vista delle elezioni del 6 aprile 1924 il gran consiglio del fascismo, istituito nel gennaio 1923,
formò un “listone” comprendente fascisti e fiancheggiatori, anche democratici, cattolici,
riformisti. Dal canto suo Giolitti capitanò un “listino” che in Piemonte ottenne tre seggi: tutti
per candidati del Cuneese (egli stesso, Soleri ed Egidio Fazio). Dopo il rapimento e l’assassinio
del socialista Giacomo Matteotti, una parte delle opposizioni (popolari, socialisti,
repubblicani, e il liberaldemocratico Giovanni Amendola) abbandonarono la Camera
(“Aventino”). In Aula rimasero i comunisti e i giolittiani. A fine 1924 Giolitti si schierò
nettamente contro le limitazioni della libertà di stampa, garantita dallo Statuto. Il re – al quale
indirettamente si rivolgeva – finse di non sentire. Del resto, una parte dei partiti e dei giornali
d’opposizione si batteva per l’eliminazione della monarchia, sicché il sovrano non aveva
speciali motivi per difenderli. Nel corso del 1925, dinnanzi alle prime leggi “fascistissime” (il
divieto di iscrizione dei pubblici impiegati ad associazioni non approvate dal governo, quali
la massoneria: per la quale Giolitti non nutriva simpatia, ma i cui meriti storici riconosceva e
riteneva comunque compatibile con lo Stato) e la perdurante violenza contro gli avversari, lo
statista dichiarò la sua opposizione alla politica interna del governo, mentre ne approvava
quella estera. Umiliando i consiglieri provinciali di Cuneo (inclusi parte dei liberali e popolari)
Mussolini pose Giolitti al bivio: fascistizzazione o dimissioni da presidente. A fronte di quella
“lurida congiura” (quale venne definita da uno dei suoi autori) “per elementare dignità” –
come egli scrisse agli elettori di San Damiano e Prazzo, che rappresentava dal 1920 – Giolitti
si dimise anche da consigliere provinciale. Col fascismo ormai era rottura completa. Ma
questo non gli fece perdere né l’ottimismo né la capacità di combattimento e persino di
sorridere. Al nipote Curio Chiaraviglio nel 1927 descrisse con sarcasmo l’eclissi dello Stato:
“Dopo la guerra il governo Nitti lasciò insultare l’esercito, disorganizzò i servizi pubblici, abdicò
ogni potere in mano dei socialisti”. E deplorò “la condotta bestiale dei socialisti che, venuti alla
Camera in 157, il primo giorno insultarono il Re…, lavorarono a rendere impossibile ogni
governo, rifiutando di assumere essi qualsiasi responsabilità, e tentando di condurre la finanza
in fallimento col prezzo politico del pane. La condotta non meno bestiale dei popolari, (che)
venuti alla Camera in 107 si misero sotto gli ordini di un prete, non uomo politico ma intrigante,
piuttosto vano che superbo, senza programma proprio… Fra le altre cose ora i sindacati
sopprimono il cittadino: la legge riconosce il falegname, il filosofo il ciabattino, l’avvocato, il
cavadenti, il beccamorti, ma il cittadino no. Il civis Romanus sum è un’anticaglia. La libertà?
Chi se ne ricorda? Ma il giorno in cui il popolo se ne ricordasse e la reclamasse!?… Che cosa fare?
Pensare alla salute”.
−
Viaggiò, lesse, scrisse e il 16 marzo 1928 andò alla Camera per votare contro la riforma
elettorale voluta da Mussolini. L’abolizione delle libere elezioni e la predisposizione da parte
del gran consiglio del fascismo della lista dei 400 membri destinati a formare la Camera
segnava il “decisivo distacco” del fascismo “dal regime retto dallo Statuto”. Ancora una volta il
re tacque e firmò. Così aveva voluto il Parlamento, così fosse. Tornato a Cavour, Giolitti morì
il 17 luglio 1928. Da cattolico, com’era vissuto. Fu il più strenuo e coerente assertore del
principio autenticamente democratico, secondo il quale lo Stato è espressione, in ogni sua
istituzione, della “volontà nazionale” e che questa si manifesta non in piazzate né in scioperi
ma in libere elezioni e attraverso le assemblee elettive. Sotto questo profilo egli fu il massimo
statista italiano dall’Unità nazionale.
−
Dopo il rovesciamento di Mussolini dal governo, il giolittiano avvocato Pietro Allemandi
venne nominato commissario al comune di Dronero, di cui era stato sindaco prima del
regime. Nel gennaio 1944 venne arrestato con il tipografo del “Progresso”, democratico della
PAGINA 4
Valle Maira, e deportato a Mauthausen. Entrambi vi morirono. Fu la dimostrazione della
coerenza ideale di cui Giolitti fu maestro: senza chiasso, senza esibizioni di formule sonanti.
Tra quanti avevano a lungo irriso Giolitti con caricature velenose, parecchi finirono invece a
vele spiegate nelle file del fascismo. Bastino, tra i tanti, i nomi di Guido Podrecca, ex socialista
(come Mussolini, d’altronde) e di Alberto Giannini, già direttore del “Becco Giallo”, poi autore
delle Memorie di un fesso, in cui narrò la sua “conversione”: due volte spergiuro (era anche
massone). A fronte di quell’Italia si erse e rimase gigantesca la figura di Giolitti, del quale si
può bene sorridere: senza però dimenticare che fu l’ultimo a insegnare davvero il “senso dello
Stato”, subordinato non a partiti, chiese, ideologie bensì solo alla legge: espressione compiuta
della “volontà della nazione”.
−
Aldo A. Mola
−
Giovanni Giolitti nella satira politica: la nascita dell’Italia odierna, Catalogo della mostra,
Torino, edizioni il Pennino, 2004, pp. 101-103.
PAGINA 5