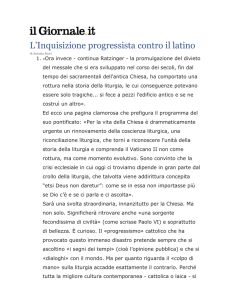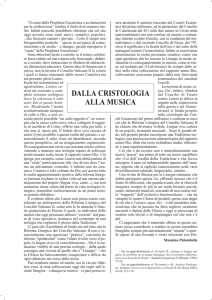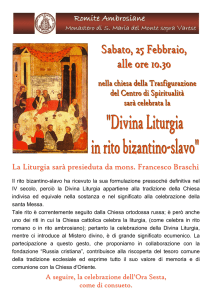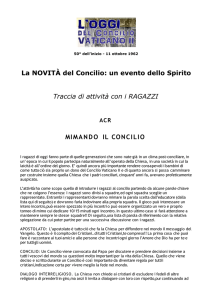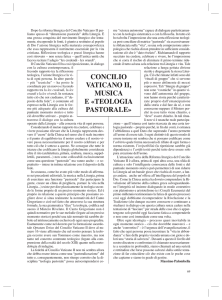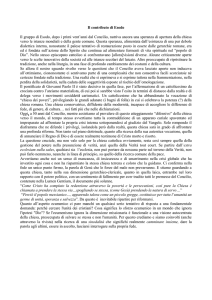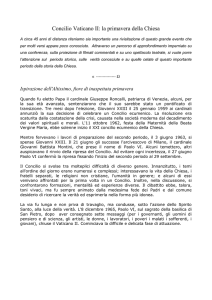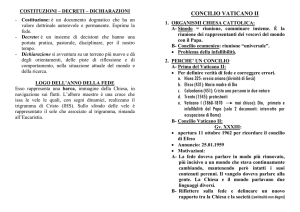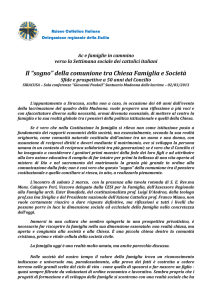Juan José Silvestre, Selezione di testi di Benedetto XVI sulla Sacra Liturgia VI, Liturgia - Tradizione - Progresso, in
www.collationes.org, gennaio 2013.
Liturgia – Tradizione - Progresso
[42] Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2005.
(...) L'ultimo evento di quest’anno su cui vorrei soffermarmi in questa occasione è la
celebrazione della conclusione del Concilio Vaticano II quarant'anni fa. Tale memoria suscita la
domanda: Qual è stato il risultato del Concilio? È stato recepito nel modo giusto? Che cosa, nella
recezione del Concilio, è stato buono, che cosa insufficiente o sbagliato? Che cosa resta ancora da
fare? Nessuno può negare che, in vaste parti della Chiesa, la recezione del Concilio si è svolta in
modo piuttosto difficile, anche non volendo applicare a quanto è avvenuto in questi anni la
descrizione che il grande dottore della Chiesa, san Basilio, fa della situazione della Chiesa dopo il
Concilio di Nicea: egli la paragona ad una battaglia navale nel buio della tempesta, dicendo fra
l'altro: «Il grido rauco di coloro che per la discordia si ergono l’uno contro l’altro, le chiacchiere
incomprensibili, il rumore confuso dei clamori ininterrotti ha riempito ormai quasi tutta la Chiesa
falsando, per eccesso o per difetto, la retta dottrina della fede ...» (De Spiritu Sancto, XXX, 77; PG
32, 213 A; SCh 17bis, pag. 524).
Emerge la domanda: Perché la recezione del Concilio, in grandi parti della Chiesa, finora si
è svolta in modo così difficile? Ebbene, tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio o –
come diremmo oggi– dalla sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e di applicazione. I
problemi della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovate a
confronto e hanno litigato tra loro. L'una ha causato confusione, l'altra, silenziosamente ma sempre
più visibilmente, ha portato frutti.
Da una parte esiste un'interpretazione che vorrei chiamare “ermeneutica della discontinuità e
della rottura”; essa non di rado si è potuta avvalere della simpatia dei mass-media, e anche di una
parte della teologia moderna. Dall'altra parte c’è l'“ermeneutica della riforma”, del rinnovamento
nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è un soggetto che cresce nel
tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in
cammino.
L'ermeneutica della discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e
Chiesa postconciliare. Essa asserisce che i testi del Concilio come tali non sarebbero ancora la vera
espressione dello spirito del Concilio. Sarebbero il risultato di compromessi nei quali, per
raggiungere l'unanimità, si è dovuto ancora trascinarsi dietro e riconfermare molte cose vecchie
ormai inutili. Non in questi compromessi, però, si rivelerebbe il vero spirito del Concilio, ma invece
negli slanci verso il nuovo che sono sottesi ai testi: solo essi rappresenterebbero il vero spirito del
Concilio, e partendo da essi e in conformità con essi bisognerebbe andare avanti. Proprio perché i
1
testi rispecchierebbero solo in modo imperfetto il vero spirito del Concilio e la sua novità, sarebbe
necessario andare coraggiosamente al di là dei testi, facendo spazio alla novità nella quale si
esprimerebbe l’intenzione più profonda, sebbene ancora indistinta, del Concilio. In una parola:
occorrerebbe seguire non i testi del Concilio, ma il suo spirito. In tal modo, ovviamente, rimane un
vasto margine per la domanda su come allora si definisca questo spirito e, di conseguenza, si
concede spazio ad ogni estrosità.
Con ciò, però, si fraintende in radice la natura di un Concilio come tale. In questo modo,
esso viene considerato come una specie di Costituente, che elimina una costituzione vecchia e ne
crea una nuova. Ma la Costituente ha bisogno di un mandante e poi di una conferma da parte del
mandante, cioè del popolo al quale la costituzione deve servire. I Padri non avevano un tale
mandato e nessuno lo aveva mai dato loro; nessuno, del resto, poteva darlo, perché la costituzione
essenziale della Chiesa viene dal Signore e ci è stata data affinché noi possiamo raggiungere la vita
eterna e, partendo da questa prospettiva, siamo in grado di illuminare anche la vita nel tempo e il
tempo stesso. I Vescovi, mediante il Sacramento che hanno ricevuto, sono fiduciari del dono del
Signore. Sono «amministratori dei misteri di Dio» (1 Cor 4,1); come tali devono essere trovati
«fedeli e saggi» (cfr Lc 12,41-48). Ciò significa che devono amministrare il dono del Signore in
modo giusto, affinché non resti occultato in qualche nascondiglio, ma porti frutto e il Signore, alla
fine, possa dire all'amministratore: «Poiché sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto» (cfr
Mt 25,14-30; Lc 19,11-27). In queste parabole evangeliche si esprime la dinamica della fedeltà, che
interessa nel servizio del Signore, e in esse si rende anche evidente, come in un Concilio dinamica e
fedeltà debbano diventare una cosa sola.
All'ermeneutica della discontinuità si oppone l'ermeneutica della riforma, come l'hanno
presentata dapprima Papa Giovanni XXIII nel suo discorso d'apertura del Concilio l'11 ottobre 1962
e poi Papa Paolo VI nel discorso di conclusione del 7 dicembre 1965. Vorrei qui citare soltanto le
parole ben note di Giovanni XXIII, in cui questa ermeneutica viene espressa inequivocabilmente
quando dice che il Concilio «vuole trasmettere pura ed integra la dottrina, senza attenuazioni o
travisamenti», e continua: «Il nostro dovere non è soltanto di custodire questo tesoro prezioso, come
se ci preoccupassimo unicamente dell'antichità, ma di dedicarci con alacre volontà e senza timore a
quell'opera, che la nostra età esige... È necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve
essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del
nostro tempo. Una cosa è infatti il deposito della fede, cioè le verità contenute nella nostra
veneranda dottrina, e altra cosa è il modo col quale esse sono enunciate, conservando ad esse
tuttavia lo stesso senso e la stessa portata» (S. Oec. Conc. Vat. II Constitutiones Decreta
Declarationes, 1974, pp. 863-865).
È chiaro che questo impegno di esprimere in modo nuovo una determinata verità esige una
nuova riflessione su di essa e un nuovo rapporto vitale con essa; è chiaro pure che la nuova parola
può maturare soltanto se nasce da una comprensione consapevole della verità espressa e che, d’altra
parte, la riflessione sulla fede esige anche che si viva questa fede. In questo senso il programma
proposto da Papa Giovanni XXIII era estremamente esigente, come appunto è esigente la sintesi di
2
fedeltà e dinamica. Ma ovunque questa interpretazione è stata l’orientamento che ha guidato la
recezione del Concilio, è cresciuta una nuova vita e sono maturati frutti nuovi. Quarant’anni dopo il
Concilio possiamo rilevare che il positivo è più grande e più vivo di quanto non potesse apparire
nell’agitazione degli anni intorno al 1968. Oggi vediamo che il seme buono, pur sviluppandosi
lentamente, tuttavia cresce, e cresce così anche la nostra profonda gratitudine per l’opera svolta dal
Concilio.
(... ) Sono tutti temi di grande portata su cui non è possibile soffermarsi più ampiamente in
questo contesto. È chiaro che in tutti questi settori, che nel loro insieme formano un unico
problema, poteva emergere una qualche forma di discontinuità e che, in un certo senso, si era
manifestata di fatto una discontinuità, nella quale tuttavia, fatte le diverse distinzioni tra le concrete
situazioni storiche e le loro esigenze, risultava non abbandonata la continuità nei principi -fatto
questo che facilmente sfugge alla prima percezione. È proprio in questo insieme di continuità e
discontinuità a livelli diversi che consiste la natura della vera riforma. In questo processo di novità
nella continuità dovevamo imparare a capire più concretamente di prima che le decisioni della
Chiesa riguardanti cose contingenti –per esempio, certe forme concrete di liberalismo o di
interpretazione liberale della Bibbia– dovevano necessariamente essere esse stesse contingenti,
appunto perché riferite a una determinata realtà in se stessa mutevole. Bisognava imparare a
riconoscere che, in tali decisioni, solo i principi esprimono l’aspetto duraturo, rimanendo nel
sottofondo e motivando la decisione dal di dentro. Non sono invece ugualmente permanenti le
forme concrete, che dipendono dalla situazione storica e possono quindi essere sottoposte a
mutamenti. Così le decisioni di fondo possono restare valide, mentre le forme della loro
applicazione a contesti nuovi possono cambiare.
3
Liturgia – Tradizione - Progresso
[43] Benedetto XVI, Incontro con il clero della diocesi di Roma, Aula della Benedizione, 2
marzo 2006.
Dopo gli interventi di cinque presbiteri, il Santo Padre ha aggiunto:
L'altro punto era incentrato sul fatto che la formazione sacerdotale tra generazioni, anche
vicine, sembra essere per molti un po’ diversa, e questo complica il comune impegno per la
trasmissione della fede. Ho notato questo quando ero Arcivescovo di Monaco. Quando noi siamo
entrati in seminario, abbiamo avuto tutti una comune spiritualità cattolica, più o meno matura.
Diciamo che il fondamento spirituale era comune. Adesso vengono da esperienze spirituali molto
diverse. Ho constatato nel mio seminario che vivevano in diverse "isole" di spiritualità che
comunicavano difficilmente. Tanto più ringraziamo il Signore perché ha dato tanti nuovi impulsi
alla Chiesa e tante nuove forme anche di vita spirituale, di scoperta della ricchezza della fede.
Bisogna soprattutto non trascurare la comune spiritualità cattolica, che si esprime nella Liturgia e
nella grande Tradizione della fede. Questo mi sembra molto importante.
Questo punto è importante anche riguardo al Concilio. Non bisogna vivere –come ho detto
prima di Natale alla Curia Romana– l'ermeneutica della discontinuità, ma vivere l'ermeneutica del
rinnovamento, che è spiritualità della continuità, dell'andare avanti in continuità. Questo mi sembra
molto importante anche riguardo alla Liturgia. Prendo un esempio concreto che mi è venuto proprio
oggi con la breve meditazione di questo giorno. La Statio di questo giorno, giovedì dopo il
Mercoledì delle Ceneri, è san Giorgio. Corrispondenti a questo santo soldato, una volta vi erano due
letture su due santi soldati. La prima parla del re Ezechia, che, malato, è condannato a morte e prega
il Signore piangendo: dammi ancora un po' di vita! E il Signore è buono e gli concede ancora 17
anni di vita. Quindi una bella guarigione e un soldato che può riprendere di nuovo in mano la sua
attività. La seconda è il Vangelo che narra dell'ufficiale di Cafarnao con il suo servo malato.
Abbiamo così due motivi: quello della guarigione e quello della "milizia" di Cristo, della grande
lotta. Adesso, nella Liturgia attuale, abbiamo due letture totalmente diverse. Abbiamo quella del
Deuteronomio: "Scegli la vita", e il Vangelo: "Seguire Cristo e prendere la croce su di sé", che vuol
dire non cercare la propria vita ma donare la vita, ed è una interpretazione di cosa vuol dire "scegli
la vita".
Devo dire che io ho sempre molto amato la Liturgia. Ero proprio innamorato del cammino
quaresimale della Chiesa, con queste "chiese stazionali" e le letture collegate a queste chiese: una
geografia di fede che diventa una geografia spirituale del pellegrinaggio col Signore. Ed ero rimasto
un po' male per il fatto che ci avessero tolto questo nesso tra la "stazione" e le letture. Oggi vedo
che proprio queste letture sono molto belle ed esprimono il programma della Quaresima: scegliere
la vita, cioè rinnovare il "Sì" del Battesimo, che è proprio scelta della vita. In questo senso, c'è
un'intima continuità e mi sembra che dobbiamo impararlo da questo che è solo un piccolissimo
esempio tra discontinuità e continuità. Dobbiamo accettare le novità ma anche amare la continuità e
4
vedere il Concilio in questa ottica della continuità. Questo ci aiuterà anche nel mediare tra le
generazioni nel loro modo di comunicare la fede.
5
Liturgia – Tradizione - Progresso
[44]
Benedetto XVI, Es. apost. post. Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, nn. 3.11.
3. Guardando alla storia bimillenaria della Chiesa di Dio, guidata dalla sapiente azione dello
Spirito Santo, ammiriamo, pieni di gratitudine, lo sviluppo, ordinato nel tempo, delle forme rituali
in cui facciamo memoria dell'evento della nostra salvezza. Dalle molteplici forme dei primi secoli,
che ancora splendono nei riti delle antiche Chiese di Oriente, fino alla diffusione del rito romano;
dalle chiare indicazioni del Concilio di Trento e del Messale di san Pio V fino al rinnovamento
liturgico voluto dal Concilio Vaticano II: in ogni tappa della storia della Chiesa la Celebrazione
eucaristica, quale fonte e culmine della sua vita e missione, risplende nel rito liturgico in tutta la sua
multiforme ricchezza. La XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, svoltasi dal 2
al 23 ottobre 2005 in Vaticano, ha espresso nei confronti di questa storia un profondo
ringraziamento a Dio, riconoscendo operante in essa la guida dello Spirito Santo. In particolare, i
Padri sinodali hanno constatato e ribadito il benefico influsso che la riforma liturgica attuata a
partire dal Concilio ecumenico Vaticano II ha avuto per la vita della Chiesa 5. Il Sinodo dei Vescovi
ha avuto la possibilità di valutare la sua ricezione dopo l'Assise conciliare. Moltissimi sono stati gli
apprezzamenti. Le difficoltà ed anche taluni abusi rilevati, è stato affermato, non possono oscurare
la bontà e la validità del rinnovamento liturgico, che contiene ancora ricchezze non pienamente
esplorate. Si tratta in concreto di leggere i cambiamenti voluti dal Concilio all'interno dell'unità che
caratterizza lo sviluppo storico del rito stesso, senza introdurre artificiose rotture 6.
11. (...) Con il comando « Fate questo in memoria di me » (Lc 22,19; 1 Cor 11,25), Egli ci
chiede di corrispondere al suo dono e di rappresentarlo sacramentalmente. Con queste parole,
pertanto, il Signore esprime, per così dire, l'attesa che la sua Chiesa, nata dal suo sacrificio, accolga
questo dono, sviluppando sotto la guida dello Spirito Santo la forma liturgica del Sacramento. Il
memoriale del suo dono perfetto, infatti, non consiste nella semplice ripetizione dell'Ultima Cena,
ma propriamente nell'Eucaristia, ossia nella novità radicale del culto cristiano.
5
Cfr. Propositio 2.
6
Mi riferisco qui alla necessità di una ermeneutica della continuità anche in riferimento ad una corretta lettura dello
sviluppo liturgico dopo il Concilio Vaticano II: cfr Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana (22 dicembre 2005):
AAS 98 (2006), 44-45.
6
Liturgia – Tradizione - Progresso
[45] Benedetto XVI, Lettera apostolica “Motu Proprio data” Summorum Pontificum,
sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, 7 luglio 2007.
I Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura che la Chiesa di Cristo
offrisse alla Divina Maestà un culto degno, “a lode e gloria del Suo nome” ed “ad utilità di tutta la
sua Santa Chiesa”. Da tempo immemorabile, come anche per l'avvenire, è necessario mantenere il
principio secondo il quale «ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non
solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente
accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare
errori, ma anche per trasmettere l'integrità della fede, perché la legge della preghiera della Chiesa
corrisponde alla sua legge di fede» 7.
Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di San Gregorio Magno, il
quale si adoperò perché ai nuovi popoli dell’Europa si trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori
del culto e della cultura accumulati dai Romani nei secoli precedenti. Egli comandò che fosse
definita e conservata la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il Sacrificio della Messa sia
l’Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava nell'Urbe. Promosse con massima cura la diffusione
dei monaci e delle monache, che operando sotto la regola di San Benedetto, dovunque unitamente
all’annuncio del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della Regola: «Nulla
venga preposto all’opera di Dio» (cap. 43). In tal modo la sacra Liturgia celebrata secondo l’uso
romano arricchì non solo la fede e la pietà, ma anche la cultura di molte popolazioni. Consta infatti
che la liturgia latina della Chiesa nelle varie sue forme, in ogni secolo dell’età cristiana, ha spronato
nella vita spirituale numerosi Santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtù di religione e ha fecondato
la loro pietà.
Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono particolare sollecitudine a che
la sacra Liturgia espletasse in modo più efficace questo compito: tra essi spicca S. Pio V, il quale
sorretto da grande zelo pastorale, a seguito dell'esortazione del Concilio di Trento, rinnovò tutto il
culto della Chiesa, curò l'edizione dei libri liturgici, emendati e “rinnovati secondo la norma dei
Padri” e li diede in uso alla Chiesa latina. Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il Messale
Romano, che si sviluppò nella città di Roma, e col passare dei secoli a poco a poco prese forme che
hanno grande somiglianza con quella vigente nei tempi più recenti. «Fu questo il medesimo
obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici nel corso dei secoli seguenti assicurando
l'aggiornamento o definendo i riti e i libri liturgici, e poi, all'inizio di questo secolo, intraprendendo
una riforma generale» 8. Così agirono i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, San Pio X 9,
Benedetto XV, Pio XII e il Beato Giovanni XXIII.
7
Institutio generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397.
8
GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Vicesimus quintus annus (4 dicembre 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
7
Nei tempi più recenti, il Concilio Vaticano II espresse il desiderio che la dovuta rispettosa
riverenza nei confronti del culto divino venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessità della
nostra età. Mosso da questo desiderio, il nostro Predecessore, il Sommo Pontefice Paolo VI, nel
1970 per la Chiesa latina approvò i libri liturgici riformati e in parte rinnovati. Essi, tradotti nelle
varie lingue del mondo, di buon grado furono accolti da Vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo
II rivide la terza edizione tipica del Messale Romano. Così i Romani Pontefici hanno operato
«perché questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse nuovamente splendido per dignità e
armonia»10.
Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con tanto amore ed
affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano imbevuto così profondamente la loro
cultura e il loro spirito, che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, mosso dalla cura pastorale nei
confronti di questi fedeli, nell’anno 1984 con lo speciale indulto Quattuor abhinc annos, emesso
dalla Congregazione per il Culto Divino, concesse la facoltà di usare il Messale Romano edito dal
Beato Giovanni XXIII nell’anno 1962; nell’anno 1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la
Lettera Apostolica Ecclesia Dei, data in forma di Motu proprio, esortò i Vescovi ad usare
largamente e generosamente tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedessero.
A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate già dal Nostro
Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali nel Concistoro
tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo
aver invocato lo Spirito Santo e contando sull’aiuto di Dio, con la presente Lettera Apostolica
stabiliamo quanto segue:
Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria della lex
orandi (“legge della preghiera”) della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano
promulgato da San Pio V e nuovamente edito dal Beato Giovanni XXIII deve venir considerato
come espressione straordinaria della stessa lex orandi e deve essere tenuto nel debito onore per il
suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della lex orandi della Chiesa non porteranno in
alcun modo a una divisione nella lex credendi (“legge della fede”) della Chiesa; sono infatti due usi
dell’unico rito romano. Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione tipica
del Messale Romano promulgato dal Beato Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma
straordinaria della Liturgia della Chiesa.
9
Ibid.
10
PIO X, Lett. Ap. Motu proprio datae Abhinc duos annos (23 ottobre 1913): AAS 5 (1913), 449-450; cfr GIOVANNI
PAOLO II, Lett. ap. Vicesimus quintus annus (4 decembre 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
8
Liturgia – Tradizione - Progresso
[46] Benedetto XVI, Lettera ai vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera
apostolica “Motu Proprio data” Summorum Pontificum, sull’uso della liturgia romana
anteriore alla riforma del 1970, 7 luglio 2007.
A questo documento si opponevano più direttamente due timori, che vorrei affrontare un po’
più da vicino in questa lettera.
In primo luogo, c’è il timore che qui venga intaccata l’Autorità del Concilio Vaticano II e
che una delle sue decisioni essenziali –la riforma liturgica– venga messa in dubbio. Tale timore è
infondato. Al riguardo bisogna innanzitutto dire che il Messale, pubblicato in duplice edizione da
Paolo VI e poi riedito una terza volta con l'approvazione di Giovanni Paolo II, ovviamente è e
rimane la forma normale –la forma ordinaria– della Liturgia Eucaristica. L’ultima stesura del
Missale Romanum, anteriore al Concilio, che è stata pubblicata con l’autorità di Papa Giovanni
XXIII nel 1962 e utilizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere usata come forma
extraordinaria della Celebrazione liturgica. Non è appropriato parlare di queste due stesure del
Messale Romano come se fossero “due Riti”. Si tratta, piuttosto, di un uso duplice dell’unico e
medesimo Rito. Quanto all’uso del Messale del 1962, come forma extraordinaria della Liturgia
della Messa, vorrei attirare l’attenzione sul fatto che questo Messale non fu mai giuridicamente
abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre permesso. Al momento
dell’introduzione del nuovo Messale, non è sembrato necessario di emanare norme proprie per l’uso
possibile del Messale anteriore. Probabilmente si è supposto che si sarebbe trattato di pochi casi
singoli che si sarebbero risolti, caso per caso, sul posto. Dopo, però, si è presto dimostrato che non
pochi rimanevano fortemente legati a questo uso del Rito romano che, fin dall’infanzia, era per loro
diventato familiare. Ciò avvenne, innanzitutto, nei Paesi in cui il movimento liturgico aveva donato
a molte persone una cospicua formazione liturgica e una profonda, intima familiarità con la forma
anteriore della Celebrazione liturgica. Tutti sappiamo che, nel movimento guidato dall’Arcivescovo
Lefebvre, la fedeltà al Messale antico divenne un contrassegno esterno; le ragioni di questa
spaccatura, che qui nasceva, si trovavano però più in profondità. Molte persone, che accettavano
chiaramente il carattere vincolante del Concilio Vaticano II e che erano fedeli al Papa e ai Vescovi,
desideravano tuttavia anche ritrovare la forma, a loro cara, della sacra Liturgia; questo avvenne
anzitutto perché in molti luoghi non si celebrava in modo fedele alle prescrizioni del nuovo
Messale, ma esso addirittura veniva inteso come un’autorizzazione o perfino come un obbligo alla
creatività, la quale portò spesso a deformazioni della Liturgia al limite del sopportabile. Parlo per
esperienza, perché ho vissuto anch’io quel periodo con tutte le sue attese e confusioni. E ho visto
quanto profondamente siano state ferite, dalle deformazioni arbitrarie della Liturgia, persone che
erano totalmente radicate nella fede della Chiesa.
Papa Giovanni Paolo II si vide, perciò, obbligato a dare, con il Motu Proprio Ecclesia Dei
del 2 luglio 1988, un quadro normativo per l’uso del Messale del 1962, che però non conteneva
9
prescrizioni dettagliate, ma faceva appello, in modo più generale, alla generosità dei Vescovi verso
le “giuste aspirazioni” di quei fedeli che richiedevano quest’uso del Rito romano. In quel momento
il Papa voleva, così, aiutare soprattutto la Fraternità San Pio X a ritrovare la piena unità con il
Successore di Pietro, cercando di guarire una ferita sentita sempre più dolorosamente. Purtroppo
questa riconciliazione finora non è riuscita; tuttavia una serie di comunità hanno utilizzato con
gratitudine le possibilità di questo Motu Proprio. Difficile è rimasta, invece, la questione dell’uso
del Messale del 1962 al di fuori di questi gruppi, per i quali mancavano precise norme giuridiche,
anzitutto perché spesso i Vescovi, in questi casi, temevano che l’autorità del Concilio fosse messa
in dubbio. Subito dopo il Concilio Vaticano II si poteva supporre che la richiesta dell’uso del
Messale del 1962 si limitasse alla generazione più anziana che era cresciuta con esso, ma nel
frattempo è emerso chiaramente che anche giovani persone scoprono questa forma liturgica, si
sentono attirate da essa e vi trovano una forma, particolarmente appropriata per loro, di incontro con
il Mistero della Santissima Eucaristia. Così è sorto un bisogno di un regolamento giuridico più
chiaro che, al tempo del Motu Proprio del 1988, non era prevedibile; queste Norme intendono anche
liberare i Vescovi dal dover sempre di nuovo valutare come sia da rispondere alle diverse situazioni.
L’ultima stesura del Missale Romanum, anteriore al Concilio, che è stata pubblicata con
l’autorità di Papa Giovanni XXIII nel 1962 e utilizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere
usata come forma extraordinaria della Celebrazione liturgica. Non è appropriato parlare di queste
due stesure del Messale Romano come se fossero “due Riti”. Si tratta, piuttosto, di un uso duplice
dell’unico e medesimo Rito. Quanto all’uso del Messale del 1962, come forma extraordinaria della
Liturgia della Messa, vorrei attirare l’attenzione sul fatto che questo Messale non fu mai
giuridicamente abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre permesso.
Al momento dell’introduzione del nuovo Messale, non è sembrato necessario di emanare
norme proprie per l’uso possibile del Messale anteriore. Probabilmente si è supposto che si sarebbe
trattato di pochi casi singoli che si sarebbero risolti, caso per caso, sul posto. Dopo, però, si è presto
dimostrato che non pochi rimanevano fortemente legati a questo uso del Rito romano che, fin
dall’infanzia, era per loro diventato familiare. Ciò avvenne, innanzitutto, nei Paesi in cui il
movimento liturgico aveva donato a molte persone una cospicua formazione liturgica e una
profonda, intima familiarità con la forma anteriore della Celebrazione liturgica.
Tutti sappiamo che, nel movimento guidato dall’Arcivescovo Lefebvre, la fedeltà al Messale
antico divenne un contrassegno esterno; le ragioni di questa spaccatura, che qui nasceva, si
trovavano però più in profondità. Molte persone, che accettavano chiaramente il carattere vincolante
del Concilio Vaticano II e che erano fedeli al Papa e ai Vescovi, desideravano tuttavia anche
ritrovare la forma, a loro cara, della sacra Liturgia; questo avvenne anzitutto perché in molti luoghi
non si celebrava in modo fedele alle prescrizioni del nuovo Messale, ma esso addirittura veniva
inteso come un’autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale portò spesso a
deformazioni della Liturgia al limite del sopportabile. Parlo per esperienza, perché ho vissuto
anch’io quel periodo con tutte le sue attese e confusioni. E ho visto quanto profondamente siano
10
state ferite, dalle deformazioni arbitrarie della Liturgia, persone che erano totalmente radicate nella
fede della Chiesa.
Papa Giovanni Paolo II si vide, perciò, obbligato a dare, con il Motu Proprio Ecclesia Dei
del 2 luglio 1988, un quadro normativo per l’uso del Messale del 1962, che però non conteneva
prescrizioni dettagliate, ma faceva appello, in modo più generale, alla generosità dei Vescovi verso
le “giuste aspirazioni” di quei fedeli che richiedevano quest’uso del Rito romano. In quel momento
il Papa voleva, così, aiutare soprattutto la Fraternità San Pio X a ritrovare la piena unità con il
Successore di Pietro, cercando di guarire una ferita sentita sempre più dolorosamente. Purtroppo
questa riconciliazione finora non è riuscita; tuttavia una serie di comunità hanno utilizzato con
gratitudine le possibilità di questo Motu Proprio. Difficile è rimasta, invece, la questione dell’uso
del Messale del 1962 al di fuori di questi gruppi, per i quali mancavano precise norme giuridiche,
anzitutto perché spesso i Vescovi, in questi casi, temevano che l’autorità del Concilio fosse messa
in dubbio. Subito dopo il Concilio Vaticano II si poteva supporre che la richiesta dell’uso del
Messale del 1962 si limitasse alla generazione più anziana che era cresciuta con esso, ma nel
frattempo è emerso chiaramente che anche giovani persone scoprono questa forma liturgica, si
sentono attirate da essa e vi trovano una forma, particolarmente appropriata per loro, di incontro con
il Mistero della Santissima Eucaristia. Così è sorto un bisogno di un regolamento giuridico più
chiaro che, al tempo del Motu Proprio del 1988, non era prevedibile; queste Norme intendono anche
liberare i Vescovi dal dover sempre di nuovo valutare come sia da rispondere alle diverse situazioni.
In secondo luogo, nelle discussioni sull’atteso Motu Proprio, venne espresso il timore che
una più ampia possibilità dell’uso del Messale del 1962 avrebbe portato a disordini o addirittura a
spaccature nelle comunità parrocchiali. Anche questo timore non mi sembra realmente fondato.
L’uso del Messale antico presuppone una certa misura di formazione liturgica e un accesso alla
lingua latina; sia l’una che l’altra non si trovano tanto di frequente. Già da questi presupposti
concreti si vede chiaramente che il nuovo Messale rimarrà, certamente, la forma ordinaria del Rito
Romano, non soltanto a causa della normativa giuridica, ma anche della reale situazione in cui si
trovano le comunità di fedeli.
E’vero che non mancano esagerazioni e qualche volta aspetti sociali indebitamente vincolati
all’attitudine di fedeli legati all’antica tradizione liturgica latina. La vostra carità e prudenza
pastorale sarà stimolo e guida per un perfezionamento. Del resto le due forme dell’uso del Rito
Romano possono arricchirsi a vicenda: nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti
nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi. La Commissione “Ecclesia Dei” in contatto con i diversi enti
dedicati all’usus antiquior studierà le possibilità pratiche. Nella celebrazione della Messa secondo il
Messale di Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è spesso finora, quella
sacralità che attrae molti all’antico uso. La garanzia più sicura che il Messale di Paolo VI possa
unire le comunità parrocchiali e venga da loro amato consiste nel celebrare con grande riverenza in
conformità alle prescrizioni; ciò rende visibile la ricchezza spirituale e la profondità teologica di
questo Messale
11
Sono giunto, così, a quella ragione positiva che mi ha motivato ad aggiornare mediante
questo Motu Proprio quello del 1988. Si tratta di giungere ad una riconciliazione interna nel seno
della Chiesa. Guardando al passato, alle divisioni che nel corso dei secoli hanno lacerato il Corpo di
Cristo, si ha continuamente l’impressione che, in momenti critici in cui la divisione stava nascendo,
non è stato fatto il sufficiente da parte dei responsabili della Chiesa per conservare o conquistare la
riconciliazione e l’unità; si ha l’impressione che le omissioni nella Chiesa abbiano avuto una loro
parte di colpa nel fatto che queste divisioni si siano potute consolidare. Questo sguardo al passato
oggi ci impone un obbligo: fare tutti gli sforzi, affinché a tutti quelli che hanno veramente il
desiderio dell’unità, sia reso possibile di restare in quest’unità o di ritrovarla nuovamente. Mi viene
in mente una frase della Seconda Lettera ai Corinzi, dove Paolo scrive: «La nostra bocca vi ha
parlato francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto aperto per voi. Non siete davvero allo
stretto in noi; è nei vostri cuori invece che siete allo stretto... Rendeteci il contraccambio, aprite
anche voi il vostro cuore!» (2 Cor 6,11-13). Paolo lo dice certo in un altro contesto, ma il suo invito
può e deve toccare anche noi, proprio in questo tema. Apriamo generosamente il nostro cuore e
lasciamo entrare tutto ciò a cui la fede stessa offre spazio.
Non c’è nessuna contraddizione tra l’una e l’altra edizione del Missale Romanum. Nella
storia della Liturgia c’è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni
anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto
proibito o, addirittura, giudicato dannoso. Ci fa bene a tutti conservare le ricchezze che sono
cresciute nella fede e nella preghiera della Chiesa, e di dar loro il giusto posto. Ovviamente per
vivere la piena comunione anche i sacerdoti delle Comunità aderenti all’uso antico non possono, in
linea di principio, escludere la celebrazione secondo i libri nuovi. Non sarebbe infatti coerente con
il riconoscimento del valore e della santità del nuovo rito l’esclusione totale dello stesso
12
Liturgia – Tradizione - Progresso
[47] Benedetto XVI, Intervista concessa ai giornalisti durante il volo verso Francia, 12
settembre 2008.
DOMANDA: Che cosa dice a coloro che in Francia temono che il Motu proprio
"Summorum pontificum" segni un ritorno indietro rispetto alle grandi intuizioni del Concilio
Vaticano II? In che modo può rassicurarli?
BENEDETTO XVI: È una paura infondata perché questo Motu proprio è semplicemente un
atto di tolleranza, ai fini pastorali, per persone che sono state formate in quella liturgia, la amano, la
conoscono, e vogliono vivere con quella liturgia. È un gruppo ridotto poiché presuppone una
formazione in latino, una formazione in una cultura certa. Ma per queste persone avere l'amore e la
tolleranza di permettere di vivere con questa liturgia, sembra un'esigenza normale della fede e della
pastorale di un vescovo della nostra Chiesa. Non c'è alcuna opposizione tra la liturgia rinnovata del
Concilio Vaticano II e questa liturgia.
Ogni giorno (del Concilio, n.d.r.) i padri conciliari hanno celebrato la messa secondo l'antico
rito e, al contempo, hanno concepito uno sviluppo naturale per la liturgia in tutto questo secolo,
poiché la liturgia è una realtà viva che si sviluppa e conserva nel suo sviluppo, nella sua identità. Ci
sono dunque sicuramente accenti diversi, ma comunque un'identità fondamentale che esclude una
contraddizione, un'opposizione tra la liturgia rinnovata e la liturgia precedente. Credo in ogni caso
che vi sia una possibilità di arricchimento da ambedue le parti. Da un lato gli amici dell'antica
liturgia possono e devono conoscere i nuovi santi, le nuove prefazioni della liturgia, ecc.... dall'altra,
la liturgia nuova sottolinea maggiormente la partecipazione comune ma sempre... non è
semplicemente un'assemblea di una certa comunità, ma sempre un atto della Chiesa universale, in
comunione con tutti i credenti di tutti i tempi, e un atto di adorazione. In tal senso mi sembra che vi
sia un mutuo arricchimento, ed è chiaro che la liturgia rinnovata è la liturgia ordinaria del nostro
tempo.
13
Liturgia – Tradizione - Progresso
[48] Benedetto XVI, Discorso alla Conferenza Episcopale Francese, Lourdes, 14 settembre
2008.
Il culto liturgico è l’espressione più alta della vita sacerdotale ed episcopale, come anche
dell’insegnamento catechetico. Il vostro compito di santificazione del popolo dei fedeli, cari
Fratelli, è indispensabile alla crescita della Chiesa. Nel Motu proprio Summorum Pontificum sono
stato portato a precisare le condizioni di esercizio di tale compito, in ciò che concerne la possibilità
di usare tanto il Messale del Beato Giovanni XXIII (1962) quanto quello del Papa Paolo VI (1970).
Alcuni frutti di queste nuove disposizioni si sono già manifestati, e io spero che l’indispensabile
pacificazione degli spiriti sia, per grazia di Dio, in via di realizzarsi. Misuro le difficoltà che voi
incontrate, ma non dubito che potrete giungere, in tempi ragionevoli, a soluzioni soddisfacenti per
tutti, così che la tunica senza cuciture del Cristo non si strappi ulteriormente. Nessuno è di troppo
nella Chiesa. Ciascuno, senza eccezioni, in essa deve potersi sentire “a casa sua”, e mai rifiutato.
Dio, che ama tutti gli uomini e non vuole che alcuno perisca, ci affida questa missione facendo di
noi i Pastori delle sue pecore. Non possiamo che rendergli grazie per l’onore e la fiducia che Egli ci
riserva. Sforziamoci pertanto di essere sempre servitori dell’unità!
14
Liturgia – Tradizione - Progresso
[49] Benedetto XVI, Luce del mondo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010,
pp. 153-154.
“Per quel che riguarda la questione concreta [il MP Summorum Pontificum], la liturgia
rinnovata del Concilio Vaticano II è la forma valida in cui la Chiesa celebra la liturgia. Ho voluto
rendere più facilmente accessibile la forma antica in modo tale da preservare il profondo ed
ininterrotto legame che sussiste nella storia della Chiesa. Non possiamo dire: prima era tutto
sbagliato, ora invece è tutto giusto. In una comunità infatti nella quale la preghiera e l’Eucaristia
sono le cose più importanti, non può considerarsi del tutto errato quello che prima era ritenuta la
cosa più sacra. Si è trattato della riconciliazione con il proprio passato, della continuità interna della
fede e della preghiera nella Chiesa”.
15
Liturgia – Tradizione - Progresso
[50] Benedetto XVI, Messaggio al Cardinale Angelo Bagnasco in occasione della LXII
Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 4 novembre 2010.
2. L’autentico credente, in ogni tempo, sperimenta nella liturgia la presenza, il primato e
l’opera di Dio. Essa è veritatis splendor (Sacramentum caritatis, 35), avvenimento nuziale,
pregustazione della città nuova e definitiva e partecipazione ad essa; è legame di creazione e di
redenzione, cielo aperto sulla terra degli uomini, passaggio dal mondo a Dio; è Pasqua, nella Croce
e nella Risurrezione di Gesù Cristo; è l’anima della vita cristiana, chiamata alla sequela,
riconciliazione che muove a carità fraterna.
Cari Fratelli nell’Episcopato, il vostro convenire pone al centro dei lavori assembleari
l’esame della traduzione italiana della terza edizione tipica del Messale Romano. La corrispondenza
della preghiera della Chiesa (lex orandi) con la regola della fede (lex credendi) plasma il pensiero e
i sentimenti della comunità cristiana, dando forma alla Chiesa, corpo di Cristo e tempio dello
Spirito. Ogni parola umana non può prescindere dal tempo, anche quando, come nel caso della
liturgia, costituisce una finestra che si apre oltre il tempo. Dare voce a una realtà perennemente
valida esige pertanto il sapiente equilibrio di continuità e novità, di tradizione e attualizzazione.
Il Messale stesso si pone all’interno di questo processo. Ogni vero riformatore, infatti, è un
obbediente della fede: non si muove in maniera arbitraria, né si arroga alcuna discrezionalità sul
rito; non è il padrone, ma il custode del tesoro istituito dal Signore e a noi affidato. La Chiesa intera
è presente in ogni liturgia: aderire alla sua forma è condizione di autenticità di ciò che si celebra.
(...)
Come Chiesa che vive in Italia, attenta a interpretare ciò che avviene in profondità nel
mondo di oggi e, quindi, a cogliere le domande e i desideri dell’uomo, voi rinnovate l’impegno a
operare con disponibilità all’ascolto e al dialogo, mettendo a disposizione di tutti la buona notizia
dell’amore paterno di Dio. Vi anima la certezza che «Gesù Cristo è la via, che conduce ciascuno
alla piena realizzazione di sé secondo il disegno di Dio. È la verità, che rivela l’uomo a se stesso e
ne guida il cammino di crescita nella libertà. È la vita, perché in lui ogni uomo trova il senso ultimo
del suo esistere e del suo operare: la piena comunione di amore con Dio nell’eternità» (Educare alla
vita buona del Vangelo, n. 19).
4. In questo cammino, vi esorto a valorizzare la liturgia quale fonte perenne di educazione
alla vita buona del Vangelo. Essa introduce all’incontro con Gesù Cristo, che con parole e opere
costantemente edifica la Chiesa, formandola alle profondità dell’ascolto, della fraternità e della
missione. I riti parlano in forza della loro intrinseca ragionevolezza e comunicabilità ed educano a
una partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa (cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 11).
16
Liturgia – Tradizione - Progresso
[51] Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dal Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo, nel 50º anniversario di fondazione, Sala Clementina, 6 maggio 2011.
Appartiene alla “memoria” la vita stessa del Pontificio Istituto Liturgico, che ha offerto il
suo contributo alla Chiesa impegnata nella recezione del Vaticano II, attraverso un cinquantennio di
formazione liturgica accademica. Formazione offerta alla luce della celebrazione dei santi misteri,
della liturgia comparata, della Parola di Dio, delle fonti liturgiche, del magistero, della storia delle
istanze ecumeniche e di una solida antropologia. Grazie a questo importante lavoro formativo, un
elevato numero di laureati e licenziati prestano ora il loro servizio alla Chiesa in varie parti del
mondo, aiutando il Popolo santo di Dio a vivere la Liturgia come espressione della Chiesa in
preghiera, come presenza di Cristo in mezzo agli uomini e come attualità costitutiva della storia
della salvezza. Infatti, il Documento conciliare pone in viva luce il duplice carattere teologico ed
ecclesiologico della Liturgia. La celebrazione realizza contemporaneamente un'epifania del Signore
e un'epifania della Chiesa, due dimensioni che si coniugano in unità nell'assemblea liturgica, ove il
Cristo attualizza il Mistero pasquale di morte e di risurrezione e il popolo dei battezzati attinge più
abbondantemente alle fonti della salvezza. Nell'azione liturgica della Chiesa sussiste la presenza
attiva di Cristo: ciò che ha compiuto nel suo passaggio in mezzo agli uomini, Egli continua a
renderlo operante attraverso la sua personale azione sacramentale, il cui centro è costituito
dall’Eucaristia.
Con il termine “profezia”, lo sguardo si apre su nuovi orizzonti. La Liturgia della Chiesa va
al di là della stessa “riforma conciliare” (cfr. Sacrosanctum Concilium, 1), il cui scopo, infatti, non
era principalmente quello di cambiare i riti e i testi, quanto invece quello di rinnovare la mentalità e
porre al centro della vita cristiana e della pastorale la celebrazione del Mistero Pasquale di Cristo.
Purtroppo, forse, anche da noi Pastori ed esperti, la Liturgia è stata colta più come un oggetto da
riformare che non come soggetto capace di rinnovare la vita cristiana, dal momento in cui "esiste un
legame strettissimo e organico tra il rinnovamento della Liturgia e il rinnovamento di tutta la vita
della Chiesa. La Chiesa dalla Liturgia attinge la forza per la vita". A ricordarcelo è il Beato
Giovanni Paolo II nella Vicesimus quintus annus, dove la liturgia è vista come il cuore pulsante di
ogni attività ecclesiale. E il Servo di Dio Paolo VI, riferendosi al culto della Chiesa, con
un’espressione sintetica affermava: «Dalla lex credendi passiamo alla lex orandi, e questa ci
conduce alla lux operandi et vivendi» (Discorso nella cerimonia dell’offerta dei ceri, 2 febbraio
1970).
Culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme fonte da cui promana la sua virtù
(cfr. Sacrosanctum Concilium, 10), la Liturgia con il suo universo celebrativo diventa così la grande
educatrice al primato della fede e della grazia. La Liturgia, teste privilegiato della Tradizione
vivente della Chiesa, fedele al suo nativo compito di rivelare e rendere presente nell’hodie delle
vicende umane l’opus Redemptionis, vive di un corretto e costante rapporto tra sana traditio e
17
legitima progressio, lucidamente esplicitato dalla Costituzione conciliare al n. 23. Con questi due
termini, i Padri conciliari hanno voluto consegnare il loro programma di riforma, in equilibrio con
la grande tradizione liturgica del passato e il futuro. Non poche volte si contrappone in modo
maldestro tradizione e progresso. In realtà, i due concetti si integrano: la tradizione è una realtà
viva, include perciò in se stessa il principio dello sviluppo, del progresso. Come a dire che il fiume
della tradizione porta in sé sempre la sua sorgente e tende verso la foce.
18
Liturgia – Tradizione - Progresso
[52] Benedetto XVI, Lettera al Gran Cancelliere del Pontificio Istituto di Musica Sacra in
occasione del 100º anniversario di fondazione dell’Istituto, 13 maggio 2011.
Un aspetto fondamentale, a me particolarmente caro, desidero mettere in rilievo a tale
proposito: come, cioè, da san Pio X fino ad oggi si riscontri, pur nella naturale evoluzione, la
sostanziale continuità del Magistero sulla musica sacra nella Liturgia. In particolare, i Pontefici
Paolo VI e Giovanni Paolo II, alla luce della Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium,
hanno voluto ribadire il fine della musica sacra, cioè «la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli»
(n. 112), e i criteri fondamentali della tradizione, che mi limito a richiamare: il senso della
preghiera, della dignità e della bellezza; la piena aderenza ai testi e ai gesti liturgici; il
coinvolgimento dell’assemblea e, quindi, il legittimo adattamento alla cultura locale, conservando,
al tempo stesso, l’universalità del linguaggio; il primato del canto gregoriano, quale supremo
modello di musica sacra, e la sapiente valorizzazione delle altre forme espressive, che fanno parte
del patrimonio storico-liturgico della Chiesa, specialmente, ma non solo, la polifonia; l’importanza
della schola cantorum, in particolare nelle chiese cattedrali. Sono criteri importanti, da considerare
attentamente anche oggi. A volte, infatti, tali elementi, che si ritrovano nella Sacrosanctum
Concilium, quali, appunto, il valore del grande patrimonio ecclesiale della musica sacra o
l’universalità che è caratteristica del canto gregoriano, sono stati ritenuti espressione di una
concezione rispondente ad un passato da superare e da trascurare, perché limitativo della libertà e
della creatività del singolo e delle comunità. Ma dobbiamo sempre chiederci nuovamente: chi è
l’autentico soggetto della Liturgia? La risposta è semplice: la Chiesa. Non è il singolo o il gruppo
che celebra la Liturgia, ma essa è primariamente azione di Dio attraverso la Chiesa, che ha la sua
storia, la sua ricca tradizione e la sua creatività. La Liturgia, e di conseguenza la musica sacra, «vive
di un corretto e costante rapporto tra sana traditio e legitima progressio», tenendo sempre ben
presente che questi due concetti –che i Padri conciliari chiaramente sottolineavano– si integrano a
vicenda perché «la tradizione è una realtà viva, include perciò in se stessa il principio dello
sviluppo, del progresso» (Discorso al Pontificio Istituto Liturgico, 6 maggio 2011).
19
Liturgia – Tradizione - Progresso
[53]
Benedetto XVI, Motu proprio Porta fidei, 11 ottobre 2011, n. 5.
5. Per alcuni aspetti, il mio venerato Predecessore vide questo Anno come una «conseguenza
ed esigenza postconciliare»8, ben cosciente delle gravi difficoltà del tempo, soprattutto riguardo alla
professione della vera fede e alla sua retta interpretazione. Ho ritenuto che far iniziare l’Anno della
fede in coincidenza con il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II possa
essere un’occasione propizia per comprendere che i testi lasciati in eredità dai Padri conciliari,
secondo le parole del beato Giovanni Paolo II, «non perdono il loro valore né il loro smalto. È
necessario che essi vengano letti in maniera appropriata, che vengano conosciuti e assimilati come
testi qualificati e normativi del Magistero, all'interno della Tradizione della Chiesa... Sento più che
mai il dovere di additare il Concilio, come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel
secolo XX: in esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre»
9
. Io pure intendo ribadire con forza quanto ebbi ad affermare a proposito del Concilio pochi mesi
dopo la mia elezione a Successore di Pietro: «se lo leggiamo e recepiamo guidati da una giusta
ermeneutica, esso può essere e diventare sempre di più una grande forza per il sempre necessario
rinnovamento della Chiesa»10.
8
PAOLO VI, Udienza Generale (14 giugno 1967): Insegnamenti V(1967), 801.
9
GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Novo millennio ineunte (6 gennaio 2001), 57: AAS 93(2001), 308
10
BENEDETTO XVI, Discorso alla Curia Romana (22 dicembre 2005): AAS 98(2006), 52.
20
Liturgia – Tradizione - Progresso
[54] Benedetto XVI, Messaggio per la chiusura del 50 Congresso Eucaristico
Internazionale, Dublino 17 giugno 2012.
Il Congresso inoltre si svolge in un periodo in cui la Chiesa in tutto il mondo si prepara a
celebrare l’Anno della Fede, per commemorare il 50° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano
II, un evento che lanciò il più ampio rinnovamento del Rito Romano mai visto prima. Basato su un
apprezzamento sempre più profondo delle fonti della liturgia, il Concilio ha promosso la piena ed
attiva partecipazione dei fedeli al Sacrificio eucaristico. Oggi, a distanza di tempo dai desideri
espressi dai Padri Conciliari circa il rinnovamento liturgico, e alla luce dell’esperienza universale
della Chiesa nel periodo seguente, è chiaro che il risultato è stato molto grande; ma è ugualmente
chiaro che vi sono state molte incomprensioni ed irregolarità. Il rinnovamento delle forme esterne,
desiderato dai Padri Conciliari, era proteso a rendere più facile l’entrare nell’intima profondità del
mistero. Il suo vero scopo era di condurre la gente ad un incontro personale con il Signore, presente
nell’Eucaristia, e così al Dio vivente, in modo che, mediante questo contatto con l’amore di Cristo,
l’amore reciproco dei suoi fratelli e delle sue sorelle potesse anch’esso crescere. Tuttavia, non
raramente, la revisione delle forme liturgiche è rimasta ad un livello esteriore, e la "partecipazione
attiva" è stata confusa con l’agire esterno. Pertanto, rimane ancora molto da fare sulla via del vero
rinnovamento liturgico. In un mondo cambiato, sempre più fisso sulle cose materiali, dobbiamo
imparare a riconoscere di nuovo la presenza misteriosa del Signore Risorto, il solo che può dar
respiro e profondità alla nostra vita.
(…) Inoltre, l’Eucaristia è il memoriale del sacrificio di Cristo sulla croce, il suo corpo e il
suo sangue offerto nella nuova ed eterna alleanza per la remissione dei peccati e la trasformazione
del mondo. L’Irlanda è stata plasmata per secoli dalla Messa al livello più profondo e, dalla sua
potenza e grazia, generazioni di monaci, di martiri e di missionari hanno vissuto eroicamente la fede
nella propria terra e diffuso la Buona Novella dell’amore e del perdono di Dio ben al di là dei vostri
lidi. Siete gli eredi di una Chiesa che è stata una potente forza di bene nel mondo, e che ha offerto a
moltissimi altri un amore profondo e duraturo per Cristo e per la sua Santa Madre. I vostri antenati
nella Chiesa in Irlanda seppero come impegnarsi per la santità e la coerenza nella vita personale,
come predicare la gioia che viene dal Vangelo, come promuovere l’importanza di appartenere alla
Chiesa universale in comunione con la Sede di Pietro, e come trasmettere alle generazioni future
amore per la fede e le virtù cristiane. La nostra fede cattolica, imbevuta di un senso profondo della
presenza di Dio, rapita dalla bellezza della creazione che ci circonda, e purificata mediante la
penitenza personale e la consapevolezza del perdono di Dio, è una eredità che sicuramente è
perfezionata e nutrita quando è deposta con regolarità sull’altare del Signore nel Sacrificio della
Messa. Ringraziamento e gioia per una così grande storia di fede e di amore sono stati di recente
scossi in maniera orribile dalla rivelazione di peccati commessi da sacerdoti e persone consacrate
nei confronti di persone affidate alle loro cure. Al posto di mostrare ad essi la strada verso Cristo,
verso Dio, al posto di dar testimonianza della sua bontà, hanno compiuto abusi su di loro e minato
21
la credibilità del messaggio della Chiesa. Come possiamo spiegare il fatto che persone le quali
hanno ricevuto regolarmente il corpo del Signore e confessato i propri peccati nel sacramento della
Penitenza abbiano offeso in tale maniera? Rimane un mistero. Eppure evidentemente il loro
cristianesimo non veniva più nutrito dall’incontro gioioso con Gesù Cristo: era divenuto
semplicemente un’abitudine. L’opera del Concilio aveva in realtà l’intento di superare questa forma
di cristianesimo e di riscoprire la fede come una relazione personale profonda con la bontà di Gesù
Cristo. Il Congresso Eucaristico ha un simile scopo. Qui desideriamo incontrare il Signore Risorto.
Chiediamo a Lui di toccarci nel profondo. Possa Colui che ha alitato sugli Apostoli a Pasqua,
comunicando loro il suo Spirito, donare alla stessa maniera anche a noi il suo soffio, la potenza
dello Spirito Santo, aiutandoci così a divenire veri testimoni del suo amore, testimoni della sua
verità. La sua verità è amore. L’amore di Cristo è verità.
22
Liturgia – Tradizione - Progresso
[55] Benedetto XVI, Omelia Santa Messa per l’apertura dell’Anno della fede, 11 ottobre
2012.
Ma dobbiamo ora risalire a colui che convocò il Concilio Vaticano II e che lo inaugurò: il
Beato Giovanni XXIII. Nel Discorso di apertura, egli presentò il fine principale del Concilio in
questi termini: «Questo massimamente riguarda il Concilio Ecumenico: che il sacro deposito della
dottrina cristiana sia custodito ed insegnato in forma più efficace. (…) Lo scopo principale di questo
Concilio non è, quindi, la discussione di questo o quel tema della dottrina... Per questo non
occorreva un Concilio... E’ necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve essere
fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro
tempo» (AAS 54 [1962], 790.791-792). Così Papa Giovanni nell'inaugurazione del Concilio.
Alla luce di queste parole, si comprende quello che io stesso allora ho avuto modo di
sperimentare: durante il Concilio vi era una tensione commovente nei confronti del comune
compito di far risplendere la verità e la bellezza della fede nell’oggi del nostro tempo, senza
sacrificarla alle esigenze del presente né tenerla legata al passato: nella fede risuona l’eterno
presente di Dio, che trascende il tempo e tuttavia può essere accolto da noi solamente nel nostro
irripetibile oggi. Perciò ritengo che la cosa più importante, specialmente in una ricorrenza
significativa come l’attuale, sia ravvivare in tutta la Chiesa quella positiva tensione, quell’anelito a
riannunciare Cristo all’uomo contemporaneo. Ma affinché questa spinta interiore alla nuova
evangelizzazione non rimanga soltanto ideale e non pecchi di confusione, occorre che essa si
appoggi ad una base concreta e precisa, e questa base sono i documenti del Concilio Vaticano II, nei
quali essa ha trovato espressione. Per questo ho più volte insistito sulla necessità di ritornare, per
così dire, alla «lettera» del Concilio –cioè ai suoi testi– per trovarne l’autentico spirito, e ho ripetuto
che la vera eredità del Vaticano II si trova in essi. Il riferimento ai documenti mette al riparo dagli
estremi di nostalgie anacronistiche e di corse in avanti, e consente di cogliere la novità nella
continuità. Il Concilio non ha escogitato nulla di nuovo come materia di fede, né ha voluto sostituire
quanto è antico. Piuttosto si è preoccupato di far sì che la medesima fede continui ad essere vissuta
nell’oggi, continui ad essere una fede viva in un mondo in cambiamento.
Se ci poniamo in sintonia con l’impostazione autentica, che il Beato Giovanni XXIII volle
dare al Vaticano II, noi potremo attualizzarla lungo questo Anno della fede, all’interno dell’unico
cammino della Chiesa che continuamente vuole approfondire il bagaglio della fede che Cristo le ha
affidato. I Padri conciliari volevano ripresentare la fede in modo efficace; e se si aprirono con
fiducia al dialogo con il mondo moderno è proprio perché erano sicuri della loro fede, della salda
roccia su cui poggiavano. Invece, negli anni seguenti, molti hanno accolto senza discernimento la
mentalità dominante, mettendo in discussione le basi stesse del depositum fidei, che purtroppo non
sentivano più come proprie nella loro verità.
23
Liturgia – Tradizione - Progresso
[56] Benedetto XVI, Discorso nell´incontro con i vescovi che hanno partecipato al Concilio
ecumenico Vaticano II, 12 ottobre 2012.
Sono tanti i ricordi che affiorano alla nostra mente e che ognuno ha ben impressi nel cuore
di quel periodo così vivace, ricco e fecondo che è stato il Concilio; non voglio, però, dilungarmi
troppo, ma –riprendendo alcuni elementi della mia omelia di ieri– vorrei ricordare solamente come
una parola, lanciata dal Beato Giovanni XXIII quasi in modo programmatico, ritornava
continuamente nei lavori conciliari: la parola «aggiornamento».
A cinquant’anni di distanza dall’apertura di quella solenne Assise della Chiesa qualcuno si
domanderà se quell’espressione non sia stata, forse fin dall’inizio, non del tutto felice. Penso che
sulla scelta delle parole si potrebbe discutere per ore e si troverebbero pareri continuamente
discordanti, ma sono convinto che l’intuizione che il Beato Giovanni XXIII compendiò con questa
parola sia stata e sia tuttora esatta. Il Cristianesimo non deve essere considerato come «qualcosa del
passato», né deve essere vissuto con lo sguardo perennemente rivolto «all’indietro», perché Gesù
Cristo è ieri, oggi e per l’eternità (cfr Eb 13,8). Il Cristianesimo è segnato dalla presenza del Dio
eterno, che è entrato nel tempo ed è presente ad ogni tempo, perché ogni tempo sgorga dalla sua
potenza creatrice, dal suo eterno «oggi».
Per questo il Cristianesimo è sempre nuovo. Non lo dobbiamo mai vedere come un albero
pienamente sviluppatosi dal granello di senape evangelico, che è cresciuto, ha donato i suoi frutti, e
un bel giorno invecchia e arriva al tramonto la sua energia vitale. Il Cristianesimo è un albero che è,
per così dire, in perenne «aurora», è sempre giovane. E questa attualità, questo «aggiornamento»
non significa rottura con la tradizione, ma ne esprime la continua vitalità; non significa ridurre la
fede, abbassandola alla moda dei tempi, al metro di ciò che ci piace, a ciò che piace all’opinione
pubblica, ma è il contrario: esattamente come fecero i Padri conciliari, dobbiamo portare l’«oggi»
che viviamo alla misura dell’evento cristiano, dobbiamo portare l’«oggi» del nostro tempo
nell’«oggi» di Dio.
Il Concilio è stato un tempo di grazia in cui lo Spirito Santo ci ha insegnato che la Chiesa,
nel suo cammino nella storia, deve sempre parlare all’uomo contemporaneo, ma questo può
avvenire solo per la forza di coloro che hanno radici profonde in Dio, si lasciano guidare da Lui e
vivono con purezza la propria fede; non viene da chi si adegua al momento che passa, da chi sceglie
il cammino più comodo. Il Concilio l’aveva ben chiaro, quando nella Costituzione dogmatica sulla
Chiesa Lumen Gentium, al numero 49, ha affermato che tutti nella Chiesa sono chiamati alla santità
secondo il detto dell’Apostolo Paolo «Questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione» (1
Ts 4,3): la santità mostra il vero volto della Chiesa, fa entrare l’«oggi» eterno di Dio nell’«oggi»
della nostra vita, nell’«oggi» dell’uomo della nostra epoca.
24
Cari Fratelli nell’episcopato, la memoria del passato è preziosa, ma non è mai fine a se
stessa. L’Anno della fede che abbiamo iniziato ieri ci suggerisce il modo migliore di ricordare e
commemorare il Concilio: concentrarci sul cuore del suo messaggio, che del resto non è altro che il
messaggio della fede in Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, proclamata all’uomo del nostro
tempo. Anche oggi quello che è importante ed essenziale è portare il raggio dell’amore di Dio nel
cuore e nella vita di ogni uomo e di ogni donna, e portare gli uomini e le donne di ogni luogo e di
ogni epoca a Dio. Auspico vivamente che tutte le Chiese particolari trovino, nella celebrazione di
questo Anno, l’occasione per il sempre necessario ritorno alla sorgente viva del Vangelo,
all’incontro trasformante con la persona di Gesù Cristo. Grazie.
25