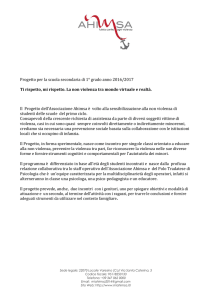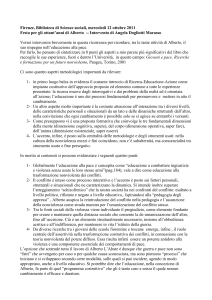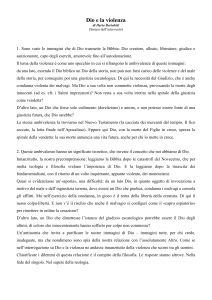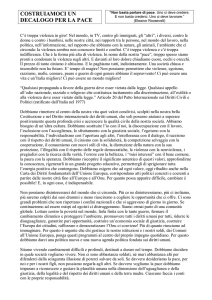LA DOMENICA DELLA NONVIOLENZA
"La nonviolenza è in cammino" Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara
9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: [email protected] Numero 23 del 29 maggio 2005 In
questo numero:
"Vivere la nonviolenza. La filosofia di Aldo Capitini" di Federica Curzi
Enrico Peyretti commenta il libro
1. Nel titolo di questo libro (Federica Curzi, Vivere la nonviolenza. La filosofia di Aldo Capitini,
Cittadella editrice, Assisi 2004, pp. 201, euro 16), prima ancora che la parola nonviolenza vedo
risaltare altre due parole: vivere, filosofia. Sono indicative del circolo prassi-teoria-prassi, opzionepensiero-opzione. Si legge in qualche parte del Talmud: "Lo studio ha il primato perché conduce
alla pratica". Allora, chi ha il primato? Bellissima domanda, perché impedisce un primato, giacché
lo distribuisce equamente. Non si sa da dove comincia la vita: dall'agire, certamente; e anche dal
pensare in quale modo si debba agire. L'agire nutre il pensiero, e il pensiero guida l'agire. Sono due
fratelli, che camminano tenendosi per mano.
*
2. La nonviolenza è una forza per attraversare il dolore del mondo (p. 9).
Non è un ottimismo facile, ignaro del male; non è rassegnazione astensionista. È indignazione,
dolore, amarezza per la tanta violenza, che fa cercare altrove dalla violenza l'origine, il senso, la
direzione. "Come può la coscienza umana non rivoltarsi al ricordo di tutte queste violenze e di tutte
le persone il cui volto attraverso il corso dei secoli è stato sfigurato dal ferro e dal fuoco? È lo
scandalo di questa violenza esercitata da uomini su altri uomini che mette in movimento il pensiero
filosofico; è la certezza che questo male non-deve-essere, che provoca la riflessione. Noi vogliamo
sostenere che la rivolta del pensiero, davanti alla violenza che fa soffrire gli uomini, è l'atto
fondatore della filosofia. Noi vogliamo affermare che il rifiuto di ogni legittimazione di questa
violenza fonda il principio di nonviolenza". Così scrive Jean-Marie Muller (1).
Egli chiede: "Come può la coscienza umana non rivoltarsi?". Ma può anche non rivoltarsi. C'è
questo problema. Non solo: può farsi complice, serva e autrice di violenza. Questo accade. Ma è
coscienza vigile o coscienza smarrita? Coscienza (sapere di sè; conoscere se stessi) e pensiero non
si limitano a osservare e registrare, ma valutano, scelgono, agiscono.
Richiedono un criterio.
In effetti, la violenza si fa ripudiare, se vigiliamo, perché è negazione della realtà, offesa di cip' che
è e che vive. È contro di noi, se è contro qualcuno e qualcosa. Ripudiarla è cercare altro, scoprire e
difendere un bene negato. La violenza ci fa scattare (azione-pensiero) in difesa delle cose e delle
vite offese. Difendendo le cose, difendiamo la nostra ragion d'essere, e viceversa. Ripudiando la
violenza, scopriamo la nostra ragion d'essere.
*
3. Ascoltiamo parole alte. Capitini: "Quando il mare rende sulla spiaggia / il cadavere di un
fanciullo / tutti si sentono madre" (citato a p. 10).
Mencio, l'antico sapiente: "Tutti gli uomini hanno un animo sensibile all'altrui sofferenza... La
ragione per cui affermo che tutti gli uomini hanno un animo sensibile all'altrui sofferenza è la
seguente: supponi che vi siano delle persone che all'improvviso vedono un bimbo mentre sta per
cadere in un pozzo. Ebbene, tutte proveranno in cuor loro un senso di apprensione e di sgomento, di
partecipazione e di compassione. Questa reazione non dipende certo dall'esigenza di mantenere
buoni rapporti con i genitori del bambino, nè dal desiderio di essere elogiati da vicini ed amici, e
neppure perché disturbino le grida del bambino. Da tutto questo si può arguire che non sono uomini
quanti sono privi di un animo sensibile ai sentimenti della partecipazione e della compassione, della
vergogna e dell'indignazione, della deferenza e dell'acquiescenza, e del senso di ciò che è giusto e di
ciò che non è giusto" (2).
"Tutti gli uomini hanno un animo sensibile all'altrui sofferenza" perché "il sentimento dell'umanità,
ren zhi xin, si esprime nel bu ren, 'non sopportare le sofferenze altruì" (3). Ecco, il principio della
nonviolenza è in questo scatto di in/tolleranza, che, contrariamente al senso solito, non è contro
l'altro diverso, ma a favore dell'altro offeso o bisognoso, nell'incapacità di rassegnarsi all'esistenza
dell'offesa.
*
4. Quale sguardo e lettura dell'essere umano porta al ripudio della violenza? La religione della
compresenza, la filosofia dell'alterità.
Religione della compresenza. Ho sempre presente una parola di Aulo Gellio, nelle Noctes Atticae:
"Religiosus esse nefas, religentes oportet" (poiché non è inglese, oggi obbligatorio, lo traduco: è
nefasto essere religiosi; bisogna essere colleganti). La religione cattiva è quella che lega. La
religione buona è quella che collega, unisce senza assorbire, fonda relazioni nel visibile e
nell'invisibile. La relazione è costitutiva della persona: ferita o distrutta la relazione, è ferita o
distrutta la persona.
Tutto ciò che salva, che cura, che arricchisce la relazione, salva, cura, apre, arricchisce la persona.
Vista così, vissuta così, la persona ripudia la violenza che ferisce o distrugge la relazione.
Filosofia dell'alterità. La nostra esistenza interpretata essenzialmente come relazione con l'altro (il
Tu-Tutti), fondata su una relazione originaria. Così Federica Curzi spiega il pensiero di Capitini e lo
confronta con alcune filosofie relazionali del Novecento (Buber, Levinas, Marcel), e gli può dare il
nome di "metafisica dell'amore". Se il nostro essere è essere-con-l'altro, allora la violenza con cui
colpiamo l'altro colpisce il senso stesso del nostro essere, perciò va ripudiata, per poter vivere, non
solo sopravvivere. Sopravvive anche chi vive sopra la vita dell'altro, dominato o soppresso, ma non
vive davvero se si riduce a vivere senza giusta relazione con l'altro.
*
5. Della nonviolenza di può parlare in tanti modi: la teoria, i maestri, i testimoni, le esperienze, la
storia, gli itinerari. In questo periodo io amo vederla soprattutto come un itinerario. Qui lo espongo
in forma sintetica, abbreviata.
Dunque, la nonviolenza è: 1) ahimsa, lotta alla propria violenza, conversione personale dalla
durezza alla mitezza; 2) indipendenza, libertà dall'idolo (4) della violenza; 3) satyagraha, lotta alla
violenza di altri e dei sistemi, con una forza che non fa violenza; 4) testimonianza, confidenza in
forze così profonde e reali della verità umana e del bene, che non sono veramente sconfitte da
nessuna sconfitta, ma testimoniano in ogni caso una possibilità migliore. La nonviolenza è un
impegno e una lotta libera dall'ossessione e dall'ideologia della vittoria (5). La quale è
consustanziale all'ideologia della violenza, perché dovere e volere vincere ad ogni costo trascina a
fare violenza.
Questo far conto sulla efficacia della nonviolenza, che sempre testimonia la pace, anche quando è
sconfitta (ma ha pure i suoi successi, e più di quanti sono comunemente noti (6)), non è
"fondamentalismo pacifista", non è "esaltazione a basso costo del martirio", nè "l'esporsi
masochisticamente al danno della guerra" da parte di "esaltatori del martirio" (7).
Il significato originario di martire è testimone. Testimone è colui che porta notizia di un fatto finora
ignoto. La lotta per una maggiore giustizia coi soli mezzi giusti introduce la visione di un obiettivo
e di un metodo che, anche se non si stabiliscono oggi nella realtà effettiva, si annunciano davanti ad
essa come possibili, desiderabili, necessari, validi.
La u-topia è il non-ancora-reale. Persino quando il lottatore nonviolento è ucciso, egli resta nel
tempo più presente e operante di chi lo elimina: Gesù è più presente e operante di Pilato e di Caifa,
Martin Luther King è oggi più attivo del suo assassino, Gandhi guida ancora un movimento
mondiale mentre il fanatico che lo uccise è immobile e dimenticato. Non si tratta certamente di
autosacrificarsi per avere successo, ma di avere fiducia nel successo perché il sacrificio nel
testimoniare ciò che è giusto è una forza. Si tratta della forza - il satyagraha gandhiano - che viene
dallo stare attaccati alla verità, senza ingannare l'avversario, una forza data dal sapere che la via
della giustizia come mezzo per la giustizia, la pace come via alla pace, può venire ostruita
temporaneamente, ma non cancellata. La giustizia, anche quando è colpita, testimonia il permanente
valore della giustizia. Come la scintilla sprizza dalla pietra sotto lo scalpello, così il diritto risalta
sotto l'offesa, non è cancellato ma evidenziato. Il diritto della persona è inviolabile perché non deve
essere violato, ma anche perché non può essere distrutto. È immortale, invulnerabile. In ogni essere
umano c'è "una parte imprendibile" (8). L'opera della pace e della giustizia, perciò, rimane intatta,
ed è affidata alla sapienza del tempo: "Uno semina, un altro miete" (9), ma il seme non è mai
perduto.
Questi quattro passaggi possono essere detti in altre poche parole: 1) a-himsa: la violenza patita,
trasmessa, epidemica, viene qui interrotta, assorbita e spenta in me. Proprio perché "mi fa male"
(crea male, aggiunge male) è da escludere dai miei atti. Non aggiungerò violenza, non "farò"
soffrire. Non conta per quale motivo, non conta se chi faccio soffrire è colpevole o innocente: conta
soltanto che così c'è più dolore e male nel mondo. Etty Hillesum, su questo, ha detto parole
luminose.
2) In-dipendenza; non-rassegnazione al male; resistenza e non resa.
3) lotta; è l'effetto del punto 2.
4) "martirio" come testimonianza: è la decisione radicale; ha un effetto certo, grazie alla "forza della
verità", inoffensiva, liberante.
Come, secondo l'universale "regola d'oro", si tratta di non fare (ciò che dispiace all'altro) e di fare
all'altro (ciò che vorremmo fosse fatto a noi), così nella nonviolenza si tratta di non fare (violenza) e
di fare (giustizia coi soli mezzi giusti).
*
6. Ma torno allo stimolante libro di Federica Curzi, per fissare per me ciò che ne ho colto e ciò che
mi suggerisce ancora.
Nel primo capitolo Curzi descrive l'itinerario, le fonti, che conducono Capitini all'originalità del suo
pensiero: ogni essere non si riduce a parte di un Tutto, ma ogni esistenza è finitezza e insieme
ulteriorità.
Capitini chiama questa realtà presenza: un finito e una eccedenza; una possibilità da liberare.
*
7. Nel secondo capitolo (L'esperienza della relazione come prassi d'amore) si entra nella filosofia
della compresenza: l'origine dell'essere è un darsi, un amore che si dà; la realtà si costituisce e si
articola come maieutica della moltiplicazione (far nascere se stessi e gli altri, per tutti); la realtà è
"realtà di tutti"; la si conosce e la si impara imparando l'alterità dell'altro, di tutti gli altri.
Il primum è l'esperienza dell'altro (p. 99). Viene in mente l'anagramma riferito da Luigi Pintor sulla
domanda di Pilato: "Quid est veritas? Est vir qui adest" (Che cos'è la verità? È l'uomo che hai di
fronte) (10).
Annoto a p. 71: il principio è inteso non tanto come fondamento o causa, quanto come moto (p. 10),
atto iniziale che apre l'esperienza del limite alla possibilità di liberazione. Parafrasando il libro
biblico (11), si può dire con Capitini: principio della sapienza è la tensione alla liberazione del
finito, possibilità intimamente contenuta nel limite (dolore, violenza) del finito.
Si conosce, ci si apre (che è nascere, rinascere) alla realtà, procedendo per aggiunta (dialettica
dell'aggiunta, non della sintesi; p. 87), ci si apre ad ogni Tu: "La mia nascita è quando dico un tu"
(p. 88, che cita Colloquio corale, p. 13). Riconoscendo l'altro come un Tu, interiorizzo la sua
esistenza, che diventa presenza (p. 99), e ciò per tutti, dunque compresenza. Per questo, aggiungo
io, dare del tu è molto più rispettoso e onorifico che dare del lei (non dico il voi, pluralis majestatis),
col quale ci si rivolge all'altro in terza persona, come laterale, distante, non presente, quasi che
scartarlo sia maggiore rispetto.
Dall'Uno-Tutto delle filosofie totalizzanti Capitini passa all'Uno-Tutti (p.
90), attraverso il Tu-Tutti, il Tu riconosciuto in tutti gli esseri, che valgono come presenze, non
oggetti. Allora, se ogni Tu è presenza e vicinanza, ne seguono nonmenzogna e nonuccisione (pp.
100-104), quindi la nonviolenza, che è anzitutto rispetto e cura materna.
Riconoscere è più che lasciar essere (non violare), è far esistere, fare presenti, accogliere come
presenti; è un accettare ma anche un creare.
Roger Garaudy, scrivendo da qualche parte su Marx, diceva: "Noi siamo creati creatori". Il creare di
Dio è renderci creatori, crea libertà e liberazione, una dipendenza libera e attiva. Ogni incontro con
l'altro, ogni essere incontrati dall'altro, è un simile creare ed essere creati, è un essere toccati e
modificati, perciò un dipendere che nulla ci toglie e molto ci dà, ci chiede, ci attiva.
L'amore che fa essere è amore materno, aggiunta di vita: maternità di Dio e maternità dell'amore
che riconosce e cura. Amare è fare come Dio, Dio è nell'atto di amare.
La nonviolenza è all'origine (unità-amore) del reale, non è un rimedio al reale come male (p. 115).
È la radice (cfr Gandhi: "antica come le montagne") del reale e dell'umano, da liberare. La
nonviolenza è il principio essenziale, il logos, la natura buona dell'essere (p. 116). Se l'origine, il
cuore di verità dell'essere, non fosse bene, il male non sarebbe urto e scandalo (male), ma normale.
Ma poiché noi di fatto ne soffriamo, se l'essere fosse male, noi saremmo il puro bene, perché al
male ci opponiamo. Il male grida reclamando e chiamando il bene. Essendo male, dimostra che c'è
il bene, almeno come criterio per poter dire che il male è male.
Ho creduto di poter dire: c'è più bene che male (12), sulla scorta, tra altri, di Gandhi: "La storia
comunemente conosciuta è la registrazione delle guerre del mondo... Se nel mondo fosse avvenuto
soltanto questo l'umanità avrebbe cessato di esistere da lungo tempo... Il fatto che vi sono ancora
tanti uomini vivi nel mondo dimostra che questo non è fondato sulla forza delle armi, ma sulla forza
della verità o dell'amore" (13).
*
8. Ma qui ci si imbatte nel problema del male. La nostra Autrice scrive che: "Il male non ha una
chiara spiegazione all'interno della filosofia capitiniana" (p. 117); "Il dolore del mondo viene
attraversato senza essere razionalizzato" (p. 9); in Capitini "non è presente una chiara teoria del
male" (p. 158). Per Capitini la presenza del male rivela "l'impossibilità di accettare che l'evidenza
con cui esso si manifesta costituisca un principio della realtà" (p. 158).
Chiediamo: ma è proprio impossibile questo accettare il male come principio della realtà?
L'ideologia della violenza accetta come principio e senso della realtà polemos, il conflitto
eliminatorio, il mors tua vita mea, male tuo bene mio, perdita tua guadagno mio (dell'economia
competitiva e possessiva), perciò la necessità del male e del farne uso.
Capitini, nella "fretta teoretica" di "abbracciare i tutti attraverso il principio dell'amore lascia aperto
l'abisso insondato del male" (p. 118). Il suo pensiero culmina nell'esito etico-metafisico facendo "un
salto rispetto all'analisi del male" (ivi). Se così il male "non trova alcuna ragione che lo giustifichi",
d'altra parte "l'assenza di una interpretazione specifica della violenza e del male rischia di presentare
la filosofia della nonviolenza come un ottimismo che dà per scontata la vittoria del bene sul male, ...
la quale risulta contraddetta dall'evidenza, fornita dalla storia, di una permanenza della potenza
distruttrice della violenza" (p. 119).
Non si capisce, continua Curzi, come Capitini possa rivalutare nella compresenza anche l'attività del
malvagio, definita essa pure "cooperante" (p. 119, citando Bertin), e ricondotta dall'amore-perdono
originario all'interno dell'incremento della compresenza (p. 120). L'azione cattiva "non ha alcuna
collocazione all'interno della filosofia capitiniana", semplicemente è attestata (p. 119).
Perciò sorge la domanda non piccola: "Se la compresenza è lo statuto intimo della realtà, perché la
storia non ne segue lo sviluppo?". Se c'è la continua assurda esperienza della violenza, "come può la
nonviolenza essere la logica interna all'essere? Capitini non si pone queste domande", ma il suo
sguardo è teso consapevolmente ad abbracciare già una realtà liberata (p. 122). Quindi profetizza,
non analizza.
Però non è un utopista, ma un profeta attivo, come chiarisce bene Bobbio: "Mentre l'utopista
disegna una stupenda struttura di società ideale ma ne rinvia l'attuazione a tempi migliori, il profeta
comincia subito, qui e ora" (14). E Bobbio cita qui quelle righe tanto espressive dell'atteggiamento
di Capitini davanti alle ambiguità, ai limiti, ai ritardi del tempo: "Io non dico: fra poco o molto
tempo avremo una società perfettamente nonviolenta... A me importa fondamentalmente l'impiego
di questa mia modestissima vita, di queste ore o di questi pochi giorni; e mettere sulla bilancia
intima della storia il peso della mia persuasione" (15).
*
9. Il terribile interrogativo del male non blocca Capitini, non lo incanta.
Ma possiamo chiederci: forse perché non lo guarda abbastanza? Poiché il male è constatato ma non
pensabile, poiché non trova posto sensato, proprio per questo fa reagire a respingerlo ponendo il suo
contrario, il bene, l'unità-amore. Se il male è assurdo, senza ragione, anti-ragione, allora la ragione
reagisce, si orienta, decide, muove l'intimo verso ciò che è diverso dal male.
Sarebbe bella la vita senza la morte: come reagire alla morte? La vita senza morte comincia col
non-uccidere (16). Davanti al male c'è il primato della ragion pratica: un pensare-altrimenti che
costituisce già una "conversione della realtà" (p. 124), attraverso la conversione pratica di chi agisce
nell'"incontro con l'alterità" (ivi). L'altro è il nuovo a cui darsi, la continua aggiunta, che non si
arresta nella contabilità del male e dei suoi danni, ma sempre dà e aggiunge e apre, e così chi si apre
può venire persuaso da questo agire che, oltre il pesante ingombro del male, della violenza, c'è una
sorgente continua di natività (aggiunta) di bene: in ciò che incontra e scopre nell'altro, e nel suo
stesso agire aperto.
La risposta di Capitini al male starebbe dunque: 1) nel constatare come verità della vita l'amoredarsi; illuminato e persuaso da questa verità più profonda del fatto del male, Capitini non ha
bisogno di soffermarsi sul tormentoso interrogativo riguardo al male: meglio agire, porre,
aggiungere; 2) nel porre attivamente amore-bene (con l'azione etica) dove c'è il male, confidando
nella forza sostitutiva, innovativa, creativa, del bene.
Questo atteggiamento ha un presupposto necessario: il discernimento qualitativo tra bene e male, e
la conseguente opzione. Chi vede solo lo scontro di forze e valuta solo ciò che prevale (ideologia
della vittoria; "pre-valere" dei fatti sui valori), senza discernere bene e male, costui "non ha occhi
per vedere e orecchi per intendere". Ma allora, se qualcuno è fuori da quel presupposto
discernimento, chiedo di nuovo, la realtà è ancora "di tutti"? Oppure, come lo è? *
10. Capitini però dovrebbe porsi anche il problema non solo del male che scandalizza e offende, il
male degli atti cattivi, ma del male che paralizza e trattiene anche l'animo buono e l'azione buona, il
male che è in noi e inficia proprio il discernimento e l'azione: "Non capisco quello che faccio: non
eseguo ciò che voglio, ma faccio quello che odio" (Paolo ai Romani 7, 15). Forse per reagire al
pessimismo antropologico della pedagogia religiosa (cattolica e protestante), che vede l'uomo tutto
corrotto e incapace, per esaltare la grazia di Dio; o forse per il candore dei puri di cuore come lui,
Capitini non pare osservare il male interiore all'uomo. Invece, la nonviolenza, la filosofia e politica
dell'amore, non può non fare i conti, pur nello stesso atteggiamento moralmente dinamico e attivo,
lungi da fatalismi e rassegnazioni, con questa dimensione più profonda del male.
Ma il pensiero di Capitini sull'abisso del male e sull'amore che lo ricolma, non è superficiale e
sbrigativo. Egli scrive: "Il vero amore continua dall'alto di una croce" (17). "La nonviolenza fa
bene a non promettere nulla del mondo, tranne la croce" (18). Strani, questi cenni in Capitini, forte
critico della religione sacrificale. Ma egli ha imparato, anche personalmente, dalla sofferenza,
quella della malattia e debolezza personale, quella della povertà, quella dell'emarginazione e
solitudine sociale. La croce è sofferenza attiva d'amore perché è affrontamento del male. Gesù, non
sottraendosi, innocente, al sacrificio impostogli dal potere religioso e politico, condanna con la
massima forza e sancisce la fine della giustificabilità di ogni sacrificio sacralizzato (cfr Renè
Girard). Così la sofferenza ha valore (Gandhi), non in quanto male, ma in quanto opposizione forte
al male, col coraggio di pagare il prezzo della lotta.
Il dolore-male, infatti, ha due volti: 1) inflitto, come violenza, offende, ferisce, può abbattere, è
forza di morte, sottrae e tende ad annullare; è l'opposto dell'aggiunta creativa; 2) patito con forza
(non subito), è resistenza, lotta, che umanizza e dilata l'interiorità di chi soffre, è "arma umana"
(Gandhi) che può vincere/con-vincere il violento che infligge sofferenza, del quale può toccare il
cuore, e intanto nobilita, sottrae al disprezzo e avvia ad una speranza più forte della morte ogni
vittima che il potere si è illuso di distruggere e cancellare.
Il male del primo tipo è il male-violenza, che abbassa il mondo. Chi infligge male per colpire e
punire il male, non esce dal male, non toglie male, ma aggiunge male.
Il male del secondo tipo è il dolore-resistenza, che afferma la vita-darsi sulla morte-togliere, perciò
redime il mondo. Lo redime per magnanimità, che significa avere un'anima più grande, essere un
bene e una bellezza che abbraccia il male, come il mollusco si difende dal corpo estraneo penetrato
nella conchiglia formandovi attorno la bellezza imperitura della perla.
Il problema non è tanto la presenza del male, la sua profondità ed estensione, ma la nostra
possibilità e capacità di opporgli il bene.
*
11. Il terzo capitolo (La metafisica dell'amore) suggerisce alcuni altri appunti e riflessioni.
Alle pp. 136 e 137, Curzi vede in Capitini una nuova comprensione del divino "con la necessità di
porre un rapporto religioso tra Dio e mondo, che abbia origine dall'esperienza dell'amore". Va bene
l'esperienza dell'amore. Ma...
e l'esperienza del male? E quando questa è l'esperienza preponderante, tale da oscurare il bene? Può
sorgere una reazione di bene. Ma può aversi anche la ripetizione del male, in un orizzonte di solo
male. Capitini non resta "perplesso" (come Bobbio), sospeso, o disperato, ma si lascia "persuadere"
ad agire per colmare il vuoto del male.
"L'essenza di Dio è il suo darsi nell'atto originario d'amore che comprende ogni essere all'interno
della realtà in quanto compresenza irriducibile alla morte" (p. 137). Quindi, l'origine dell'amore è un
sorgere dal nulla, e dunque sempre risorgere, essersi liberato dal nulla, anche come destino.
Come origine positiva dal nulla, come un porsi sopra il nulla, l'amore non è solo "forte come la
morte" (Cantico dei cantici 8, 6) ma è più forte della morte. Ma... di nuovo: che accade per coloro la
cui esperienza non è di amore, ma di morte che opprime la vita? Forse una risposta di Capitini
potrebbe essere ancora questa: non potendo cambiare queste esperienze di vita, tutto ciò che
possiamo fare, e non è poco, è immettere atti di amore nella compresenza di tutte le vite, e questi
toccheranno in qualche lontano modo chi finora non ne ha fatto esperienza.
"In ogni vita si rinnova l'atto creativo in cui Dio riconosce - amandole - tutte le creature, in un atto
che le comprende e le salva da qui all'eternità" (p. 138). Perciò, nella compresenza, ogni creatura è
immortale. "La costituzione della realtà come eccedenza del valore sull'essere [eccedenza data da
Dio nel suo "darsi" a ciascuno] scongiura la possibilità del nulla, dando valore di presenza eterna a
tutto ciò che esiste" (p. 140, vedi anche 142, 144, 145, 146).
Leggiamo di due amori, o due facce della realtà-amore: 1) Dio che si dà ad ogni vita e ogni essere,
costituendolo come valore sopra il fatto; 2) nell'amore verso ogni prossimo si ha esperienza di Dio,
non onnipotente e trascendente ma in quanto "infinita iniziativa di amore fra tutti" (p. 139).
Dio non è tutto trascendente nè tutto immanente; la terza via è il ripensamento della trascendenza
attraverso l'immanenza. L'infinito di Dio costituisce il valore del finito, in esso si presenta, non vi si
esaurisce, ma lo apre all'infinito: ulteriorità nel finito, del finito (p. 140).
*
12. Da qui, dall'amore che dà valore, viene il tema del nascere (pp. 141, 143, 145, 147). Nasciamo e
rinasciamo perché siamo amati; amando facciamo nascere; c'è natalità e non solo mortalità
dell'essere umano; chi non è amato non nasce; chi non ama non fa nascere e resta nella mortalità
senza nascita. Viene alla mente Giovanni apostolo: "Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla
vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte" (1 Giovanni 3, 14).
Dio, che si dà come unità-amore di tutti (p. 142), configura una realtà basata sulla relazione
(abbiamo già ascoltato Aulo Gellio: "... religentes oportet"), una con-realtà, che non giudica e non
esclude. Perciò primato della teologia pratica, teologia etica, della relazione altruistica sulla teologia
speculativa.
"Dio è amando" (p. 142, al fondo). Così anche noi: amo ergo sum. Come camminare è squilibrarsi
in avanti, così esistere è darsi, amare. Se qualcuno non amasse, neppure un poco, il suo tentativo di
esistere finirebbe nel nulla statico, da cui non sarebbe uscito, e ciò non per una condanna divina, ma
per l'inconsistenza di quell'esistere. Ma allora, come per il male, così Capitini dovrebbe far posto
nel pensiero all'ipotesi possibile dell'esistenza fallita, non salva, invece di abbracciare tutto, anche
l'eventuale malvagio pervicace, in un amore originale senza giudizio, sì, ma a rischio di essere
anche senza la drammatica libertà umana di fallire.
Forse il suo sorvolare su di ciò può dipendere dalla sua sana reazione al pesante, ribadito in quegli
anni, dogma cattolico dell'inferno.
Amare è dare di più, e dare per sempre (p. 144). È eccedenza rispetto alla parità, alla giustizia ("Se
la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e farisei, non entrerete nel Regno dei cieli",
Matteo 5, 20).
È eccedenza e tensione che preme sul limite della temporalità, per superare la morte.
L'esperienza dell'ulteriorità di valore, presente in ogni altro, è per Capitini un'evidenza esistenziale;
l'evento dell'incontro quotidiano (suo testo semplice e luminoso a p. 144) è un atto di "amore
religioso moltiplicabile per tutti" (Curzi). Cioè: l'altro è di più. Incontrando l'altro, persino se
avverso a me, ricevo un di più, un'aggiunta, sono amato e creato, arricchito, indipendentemente
dalla sua volontà, e indipendentemente da quanto è chiara la mia consapevolezza. Ricevo un di più,
rispetto a ciò che sono, e mi è chiesto il di più dell'amore, che non ricambia soltanto, ma aggiunge.
*
13. Si ripresenta (a p. 145) l'esperienza del male, incontrato nell'incontrare il nemico, il malvagio, il
peccatore; provoca dolore, sdegno, compassione; è un appello a sentirci responsabili per l'altro,
specialmente per chi è stato soggetto o oggetto del male. Nel testo qui citato, Capitini chiama
"dimezzati" quelli che Nietzsche chiama "malriusciti": per Nietzsche sono da buttare, per Capitini
da promuovere, da far nascere.
Ma affinché l'altro, il di più, sia realmente incontrato e ricevuto, occorre accoglierlo, fargli uno
spazio in noi, ridurre qualcosa di noi, non avere un sè completo, pieno ("pieni di sè"), restringersi e
tacersi, sapersi bisognosi, per poter contenere il dono che ci accrescerà e arricchirà (p. 146).
Alle pp. 158, 159 ritorna il tema del "principio": l'ideologia della violenza, ben presente, accetta la
violenza come principio; interrompere la catena che risponde al male col male, è porre la
nonviolenza come principio.
Riconoscere che l'amore per l'altro è il primo movimento e il senso dell'essere nel mondo, è traccia
di una presenza ulteriore al mero essere, "che conduce a individuare come origine un fondamento
vivo dell'esistenza" (p. 166), cioè a credere in colui che chiamiamo Dio. Sì, ma noi cominciamo
come essere-amati (passivo), non come amore per l'altro. Questa precisazione semmai rafforza
l'argomento, mostrando che un amore ci precede, all'origine, ed è un amore che ama l'altro, e l'altro
siamo originariamente noi, in quanto amati. Ma chi non fa l'esperienza di essere-amato? Non potrà
mai amare? Nè avvertire la natura dell'origine, la "metafisica dell'amore"? Illustrando, a p. 168, tra
le filosofie dell'alterità del Novecento, il pensiero di Martin Buber, Federica Curzi registra la sua
"ontologia delllo zwischen (tra)", per la quale il "tra" della relazione ontologica fonda l'essere di
tutti gli elementi del reale. Forse si può aggiungere qui che questa relazione costitutiva sussiste
anche sotto le nubi dell'incomprensione, anche dell'incomunicazione, e sotto la grandine del
conflitto e persino dell'avversione. Lo zwischen permane, costitutivo, anche sotto e nonostante il
gegen (contro). Una delle due: o costituente è il gegen, e lo zwischen accessorio, casuale, caduco,
oppure viceversa. Dunque: o ontologia della guerra, oppure della pace. La prima è priorità dell'Io, la
seconda del Tu e della relazione. Il centro nell'Io configura la casa, la piccola patria, e il prossimo
delimitato. Il centro nel Tu e nella relazione configura la patria mondo, il prossimo intero. Il centro
nell'Io è l'economico, il privato, il possesso. Il centro nel Tu e nella relazione è il politico, il
pubblico, la condivisione, e culmina nel religioso.
*
14. Conclusione: Una politica della nonviolenza La critica capitiniana della politica e della società
(testo alle pp.
178-179, da Elementi di una esperienza religiosa, 1937, p. 12) coincide con la critica della
razionalità occidentale (p. 180). Raimon Panikkar ha scritto: "Il compito della filosofia nel
momento attuale... consisterebbe, a mio parere, nel disarmare la ragione armata" (19), e questo la
filosofia non lo fa da sola, nè ad opera di una ragione più potente, perché la filosofia "non è
esclusivamente razionale nè meramente teoretica".
La violenza non è naturale, non è la legge della realtà, ma la negazione della vita e della natura,
perciò anche della politica (p. 181). Quindi Capitini rifiuta ogni rassegnazione. L'antropologia (di
Machiavelli, di Hobbes) che naturalizza la violenza è la profezia del peggio, che si autoadempie
ponendo la violenza come regola, come unico orizzonte e strumento decisivo, e relegando la
nonviolenza a fortunata eccezione; mentre è vero il contrario. La violenza è la cecità, che non vede
nell'altro la "radice intima" a tutti comune, amorosa, creativa, che vieta di distruggere e offendere
alcunchà. L'esperienza e la filosofia della comunione ontologica, della "apertura ai tutti" si traduce
naturalmente in politica, in una tramutazione della politica.
Una nuova teoria del potere è "la chiave di accesso ad un nuovo senso della politica" (p. 182). Ma è
veramente nuova? Già Aristotele, Etienne de la Boetie, Gandhi, e, dopo Capitini, Gene Sharp (20),
hanno mostrato che il potere speciale di uno sta nelle mani di tutti, che nessun potere si regge senza
qualche consenso, che il potere non è posseduto, ma è dato dal consenso. La verità della
compresenza degli esseri tutti, per Capitini, ispira la politica. La politica è la costruzione della
possibilità della convivenza fra tutti, è "la capacità di comprendere in essa tutte le presenze e di
preservare il loro futuro". La politica coincide col servizio alla vita, che è unità dei tutti.
*
15. Che cosa significa il potere per Capitini? (p. 183). Potere è diverso da potenza, e questa vuol
dire dominio sull'altro, privato del suo potere, invaso e occupato nella sua libertà. L'essenza del
potere non è questa violenza, ma la sua condivisione tra tutti, appunto il "potere di tutti" liberato,
l'onnicrazia.
Se la compresenza è l'unità tra tutti (non unità di tutti; non tutti una cosa sola) essa esclude un
potere su tutti, ma vuole il potere di tutti (p.
184). Questa uguaglianza non è solo formale, giuridica, detta nella legge; non è materialeeconomica-quantitativa, ma è anzitutto uguaglianza nel valore, il quale è dato dall'infinito a cui ogni
finito è aperto, è dunque equi-valenza (Pat Patfoort) più che l'ambigua eguaglianza.
Non è solo, questa uguaglianza, la "pari opportunità", il non-impedimento, la non-discriminazione
(viene in mente: "Tutti possono arricchirsi, salvo i poveri!"), ma è il potere come reale possibilità di
tutti, quindi di partecipazione effettiva, organizzata e garantita, di espressione da parte di ciascuno
del proprio dono a tutti gli altri, di democrazia dal basso, di potere ascendente dagli ultimi e umili
fatti primi, fino ai capaci e forti, questi non esclusi ma fatti ultimi. Questo non è un potere che fa
violenza imponendosi, ma è il "potere della nonviolenza".
Politica falsa, non genuina, ma adulterata, fallita, come cibo che non nutre ma danneggia, è la
politica che fa conto su violenza e guerra, che usa il potere-imposizione. Guerra e violenza non sono
affatto mezzi e continuazione della politica, ma la sua fine: "Nel momento in cui si prepara una
guerra non si ha la prosecuzione della politica, ma il suo fallimento" (21).
Come nella triste serie dei Disastri della guerra di Goya, un testo di Capitini elenca sei enormi mali
della guerra: "la sottrazione di enormi mezzi allo sviluppo civile, la strage di innocenti e di estranei,
l'involuzione dell'educazione democratica e aperta, la riduzione della libertà e il soffocamento di
ogni proposta di miglioramento della società e delle abitudini civili, la sostituzione totale
dell'efficienza distruttiva al controllo dal basso" (p. 185, da Il potere di tutti, p. 67).
In questo testo, Capitini indica poi "l'antitesi della natura come forza e la compresenza come unitàamore". Qui c'è l'idea capitiniana della pura natura, del "vitalismo", come una dimensione cieca, che
si afferma anche con la violenza, e che solo la consapevolezza della compresenza può criticare e
superare, correggere e addolcire con la mitezza del vivere insieme, non del solo vivere istintivo.
Aveva detto che la violenza non è la legge della realtà e della natura. Ma solo la religione attiva
della compresenza riporta anche la natura alla sua verità.
*
16. La nuova politica scaturisce dalla forza della nonviolenza, capace di riconoscere il valore di
ogni alterità. L'espressione suggerisce chiaramente la differenza e opposizione tra forza e violenza,
a cui tengo molto. C'è una confusione corrente, anche voluta, tra i due termini, per nobilitare la
violenza. Ma la forza costruisce, la violenza distrugge (22).
C'è un enorme equivoco da risolvere. La forza è vita, è diritto-dignità, è politica; la violenza è
morte, offesa e sopraffazione. La forza è resistenza; la violenza è aggressione.
Capitini non aderisce a partiti, ma sceglie la politicità quotidiana di base. Non mi pare che elabori la
critica forte dello strumento partito, fatta da Moisei Ostrogorski, da Simone Weil e da Vaclav Havel
(23). Nei partiti egli vede la vecchia concezione del potere, concentrato, che si impone sui cittadini
dall'alto di una fortezza che i partiti mirano a conquistare, in lotta tra loro.
Il potere di tutti, annunciato e cercato da Capitini, ha i caratteri del decentramento, della
permanenza (è continuo, quotidiano, non sporadico, nel momento della delega elettorale),
dell'accessibilità a tutti. Ma (p. 188), mentre vale molto come educazione all'incontro e confronto
civico e umano, perché "per le persone, la cosa peggiore è non incontrarsi, non ascoltarsi
reciprocamente" (p. 186, tratto da Nuova socialità e riforma religiosa, p.
240), non pare che possa essere funzionale al momento della delibera, della decisione, nelle grandi
società. La "parte mancante" sarebbe il raccordo tra le strutture dal basso e gli altri organi della
democrazia, fino a poter "rappresentare la voce di tutti all'interno dello spazio della decisione".
Rimane il grande valore dell'indicazione di Capitini per "rifondare una politica a partire
dall'incontro, dalla cura della relazione con altri, con tutti" (pp. 187-188).
Dunque, politica come incontro paritario di tutti (p. 189): ma la politica è anche conflitto, proprio
perché libertà di tutti i singoli, potere di tutti, differenze tra i singoli.
Allora, ordinerei le idee in questo schema (tra parentesi il segno positivo o negativo) [per esigenze
grafiche non possiamo qui riprodurre lo schema in modo adeguato; riportiamo comunque i termini
di esso - ndr -]: 1. politica: 2. incontro dalla base, dalla periferia-centro, nel decentramento (+) 3.
conflitto 4. violento: scontro eliminatorio (-) 5. moderato: criterio della maggioranza: = 6. semplice
forza del numero (-) = 7. relativa nonviolenza democratica (+) = 8. rischio: dittatura della
maggioranza (- -) 9. ricerca del consenso nonviolento nel dialogo razionale comunitario: 10. con
persuasione comune (+) 11. muro contro muro (-) 12. delibera a maggioranza (minor danno - +) 13.
ripresa del dialogo educativo continuo (n. 2) (+) Le procedure democratiche classiche per decidere,
nella differenza, se non raggiungono 9 e 10, ricadono in 11. A questa impasse si rimedia con la
imperfetta nonviolenza ("meglio contare le teste che tagliarle") della democrazia della maggioranza,
n. 12, e si deve ricominciare (n. 13 che riporta al n. 2).
La libertà non è individuale, ab-soluta, ma con-divisa (p. 190). È libertà di partecipare con tutti gli
altri alla polis. Il programma politico di Capitini si può sintetizzare: "Liberalsocialismo inteso come
massima libertà sul piano giuridico e culturale e massimo socialismo sul piano economico" (24).
"Soltanto il potere della nonviolenza come capacità di vivere con-altri [tutti gli altri] può restituire
alla politica la sua identità propria" (p. 191). La politica è pace nonviolenta, relazione di pace non
imposta, ma trovata nel co-orientamento. Il problema è passare da questo concetto di politica
all'attuazione... Ma intanto si pone salda un'alternativa alla prassi violenta, da cui nasce il concetto
violento della politica, che genera sempre altra violenza pratica. L'obiettivo politico nonviolento fa
cercare e costruire i mezzi omogenei nonviolenti.
La prassi politica nonviolenta libera le potenzialità più originarie dell'uomo: la sua dignità, i suoi
diritti umani, e specialmente restituisce i diritti umani a coloro ai quali sono negati. L'esercizio dei
diritti si completa in armonia con l'esercizio dei doveri, perché la politica è etica, ed è "cura per
l'altro": è questo, in Capitini, "il nuovo nome della politica", il perfetto opposto del nome oggi (ma
quante altre volte nella storia e nello spazio umano) corrente e dominante: politica come "gara
contro l'altro". La politica capitiniana è l'opposto assoluto della politica che intende usare la morte
data ad altri, invece della cura della vita.
*
17. Il criterio è chiaro: "Preservare la vita ed il futuro di tutti è il primo criterio necessario per vivere
all'interno di una percezione mondiale". Qualunque criterio escludente, in nome di qualunque valore
- libertà, progresso, civiltà, democrazia - sarebbe dimenticare le radici della politica, che è spazio
della comunità, di tutti e di ciascuno (p.
191).
Questo è l'imperativo categorico di Jonas: "Un imperativo adeguato al nuovo tipo di agire umano e
orientato al nuovo tipo di soggetto agente, suonerebbe press'a poco così: 'Agisci in modo che le
conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla
terrà, oppure, tradotto in negativo: 'Agisci in modo che le conseguenze della tua azione non
distruggano la possibilità futura di tale vità, oppure, semplicemente: 'Non mettere in pericolo le
condizioni della sopravvivenza indefinita dell'umanità sulla terrà, o ancora, tradotto nuovamente in
positivo: 'Includi nella tua scelta attuale l'integrità futura dell'uomo come oggetto della tua volontà'"
(25).
La partecipazione nel potere di tutti, in quanto produce uguaglianza, produce pace. Ecco un altro
nome vero della politica: la politica è pace.
La cura per l'altro è il mezzo, il metodo, la via; la pace è il risultato.
Il quale è possibile se il metodo è quello detto. Che non è eludere il conflitto, ma gestirlo senza
violenza, con metodi costruttivi, della vita, non distruttivi, della morte e del dominio (p. 192).
La pace è il fine della politica. Non ne è "la fine", nel senso che possa porsi solo al di là della
politica, essendo questa identificata con la non-pace, o non-ancora-pace, ma sempre legata a mezzi
di conflittualità permanente, compromessa con la violenza, non pacificata (26).
La polis di giustizia, di pace, di unione e partecipazione, di nonviolenza, del potere di tutti, del
confronto senza violenza, non è limitata ai forti, capaci di lottare e competere, ma è comunità - cosa
e casa comune, res publica, di tutti, non divisa e non lacerata fra possessi parziali e contrapposti,
non privatizzata, non consegnata all'etica del profitto particolare, ma alla legge del bene comune e
del servizio ad esso.
Di questa comunità, dunque, sono membri non i forti privilegiati e capaci: "ne fanno parte non
soltanto i cittadini sani e attivi e producenti, ma anche i malati, gli inerti, i disfatti, i morti" (27). È
una "politica della responsabilità", della cura per tutti, quindi certamente anche delle generazioni
future. Capitini anticipa una sensibilità che ha avuto sviluppi dopo di lui, nel pensiero morale e in
tutta la cultura ecologica: la responsabilità verso i posteri (28). Si tratta di una "aggiunta" preziosa
all'etica interpersonale e politica: non è vero che non abbiamo doveri verso chi ancora non è nato,
verso i posteri. Poiché noi poniamo continuamente le condizioni, positive o negative, della loro vita,
rendendola più o meno umana; poiché il loro modo d'essere e di vivere è nelle nostre mani; dal
momento che siamo responsabili di tutte le conseguenze, anche lontane ma prevedibili, delle nostre
azioni, siamo tanto più responsabili quando quegli effetti toccheranno vite umane, sebbene ora
sconosciute.
Ecco, la comunità così intesa è una proiezione al massimo possibile della democrazia partecipata, il
suffragio più universale che ci sia (scritto in tempi di dittatura imposta e subita dall'Italia). Anche i
morti partecipano con la loro presenza nella costruzione attraverso tempi e spazi della "coralità dei
valori". Davvero, non una politica del calcolo e confronto delle forze, ma della convergenza
differente e costruttiva di tutte le forze ed energie spirituali. Un'immagine massima e compiuta della
città umana, modello trainante delle realizzazioni storiche condizionate. Ma non un modello
estrinseco al reale: piuttosto un'animazione e fermento intimo della convivenza umana storica, che
cerca e persegue la sua verità sempre maggiore.
*
Note 1. Jean-Marie Muller, Il principio nonviolenza. Una filosofia della pace, Plus - Pisa University
Press, Pisa 2004, p. 22.
2. Mencio (Mengzi), filosofo cinese, 372-289 a. C., citato in Pier Cesare Bori, Saverio Marchignoli,
Per un percorso etico tra culture. Testi antichi di tradizione scritta, seconda edizione, Carocci, Roma
1998, p. 59. Si potrebbe usare questo ragionamento, e lo si fa, contro la nostra argomentazione:
"non sono uomini...", dunque vanno eliminati dalla società umana. Ma fa parte dell'umano
l'evoluzione sia in peggio sia in meglio, e nessuno può escludere il ricupero di un essere umano
all'umanità che lui ha negato in se stesso. Sopprimerlo sarebbe un disumano fissarlo nella
contraddizione con la sua natura. Credo, infatti, che questo "non sono uomini..." sia da intendere
non nel senso definitorio, ma descrittivo, come se dicesse: non vivono all'altezza umana,
contraddicono la loro natura umana.
3. Cfr nota 34 alla stessa p. 59, di Pier Cesare Bori, citando Scarpari, La concezione della natura
umana in Confucio e Mencio, Cafoscarina, Venezia 1991, p. 40.
4. Alberto Melloni, Chiesa madre, chiesa matrigna, Einaudi, Torino 2004, p.
134.
5. Cfr il mio Dov'è la vittoria? Piccola antologia aperta sulla miseria e fallacia del vincere, Il Segno
dei Gabrielli editori, S. Pietro in Cariano (Verona) 2005.
6. Si può vedere la mia bibliografia dei casi storici di lotte nonviolente Difesa senza guerra,
pubblicata
più
volte
in
successivi
aggiornamenti,
reperibile
in
internet:
http://italy.peacelink.org/pace/articles/art_2668.html
;
http://db.peacelink.org/tools/author.php?l=peyretti 7. Secondo il giudizio di un autore (citato da
Melloni nell'opera citata, pp. 135-136), che può forse avere ragione in qualche caso di pacifismo
estremo, di cui però non vedo esempi, quando invece figure di un simile autolesionismo sacrificale
sono tipiche della mitologia militare violenta, in tutta la storia, fino alla figura tristemente attuale
dell'attentatore sui-omicida.
8. Raniero La Valle, Introduzione a Claudio Napoleoni, Cercate ancora.
Lettera sulla laicità e ultimi scritti, Editori Riuniti, Roma 1990, p. XXX.
9. Giovanni 4, 37, che cita la bella immagine del salmo 126, 5-6.
10. Luigi Pintor, I luoghi del delitto, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p.
15.
11. Principio della sapienza è il timore del Signore (Proverbi 1, 7).
12. In La politica è pace, Cittadella, Assisi 1998, pp. 135-138.
13. Mohandas K. Gandhi, Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi, Torino 1996, pp. 64-65.
14. Norberto Bobbio, Introduzione a Capitini, Il potere di tutti, La Nuova Italia, Firenze 1969, p. 31.
15. Aldo Capitini, Elementi di un'esperienza religiosa, Laterza, Bari 1937, p. 111; pp. 115-116 della
riedizione Cappelli 1990.
16. Questo pensiero di Capitini si ricava dalle pp. 16-17 e 30-31 di Teoria della nonviolenza,
Edizioni del Movimento Nonviolento, Perugia 1980, e anche nella citata Introduzione di Bobbio a Il
potere di tutti, p. 33.
17. Scritti filosofici e religiosi, a cura di Mario Martini, Protagon, Perugia 1994, p. 199; citato da
Curzi, p. 130.
18. Teoria della nonviolenza, citato, p. 4, da Il problema religioso attuale (1948).
19. Raimon Panikkar, La torre di Babele. Pace e pluralismo. Edizioni Cultura della Pace, Fiesole
(Firenze) 1990, p. 47.
20. Gene Sharp, Politica dell'azione nonviolenta, vol I, Potere e lotta, Edizioni Gruppo Abele,
Torino 1985, Capitolo I, La natura e il controllo del potere politico, pp. 49-94.
21. Raniero La Valle, Introduzione a Enrico Peyretti, La politica è pace, Cittadella, Assisi 1998, p.
8.
22. Vedi nel sito http://db.peacelink.org/tools/author.php?l=peyretti un mio articolo.
23. Jean-Marie Muller, Il principio nonviolenza. Una filosofia della pace, citato, pp. 172-177.
24. Aldo Capitini, Il potere di tutti, citato, p. 327.
25. Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1979; Il principio
responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990, p. 16.
26. Vedi la discussione nei seguenti articoli: La pace, fine della politica, di Claudio Ciancio, in "il
foglio" n. 306, novembre 2003 (l'articolo di Ciancio giocava sul duplice significato di "fine",
volendo dire che la politica deve preparare la pace, ma questa trascende la politica, che non può
realizzarla); Pace, fine o principio della politica?, di Enrico Peyretti, in "il foglio" n. 310, marzo
2004 ["il foglio" di cui qui si parla è il prestigioso mensile redatto da "alcuni cristiani torinesi" da
trentacinque anni a questa parte - ndr -].
27. Aldo Capitini, Elementi di un'esperienza religiosa, citato, p. 50; questa citazione è a p. 192 di
Curzi.
28. Dietrich Bonhoeffer (citato da Curzi a p. 193), Hans Jonas (citato qui sopra), Giuliano Pontara
(in vari scritti: per esempio Etica e generazioni future, Laterza, Roma-Bari 1995; problema
richiamato da Pontara in La personalità nonviolenta, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996, pp. 2325).