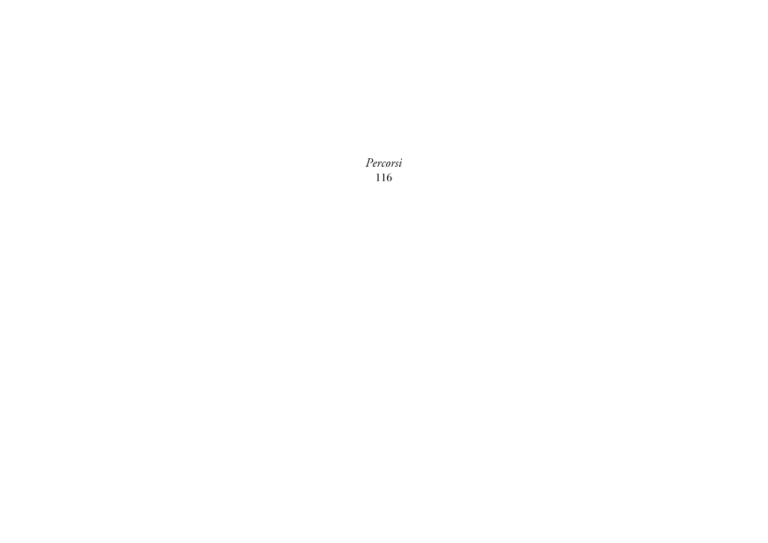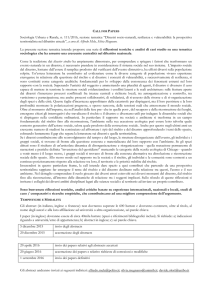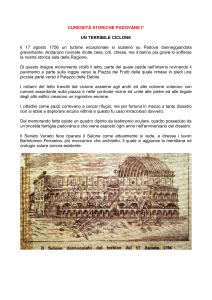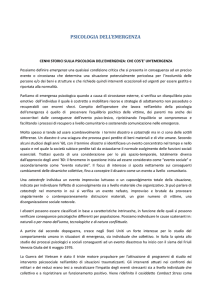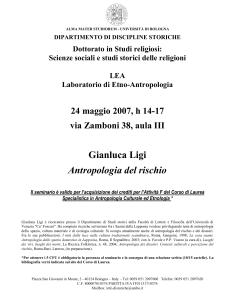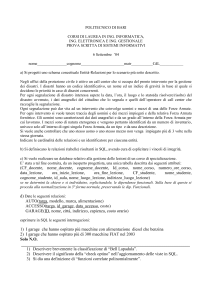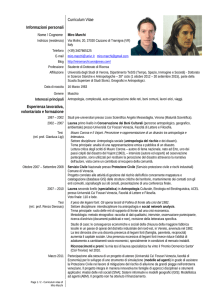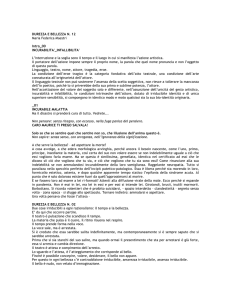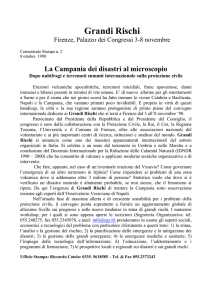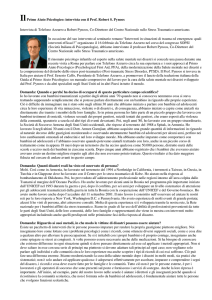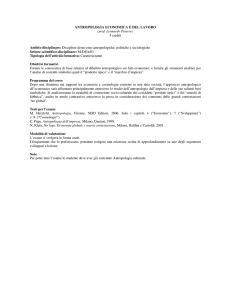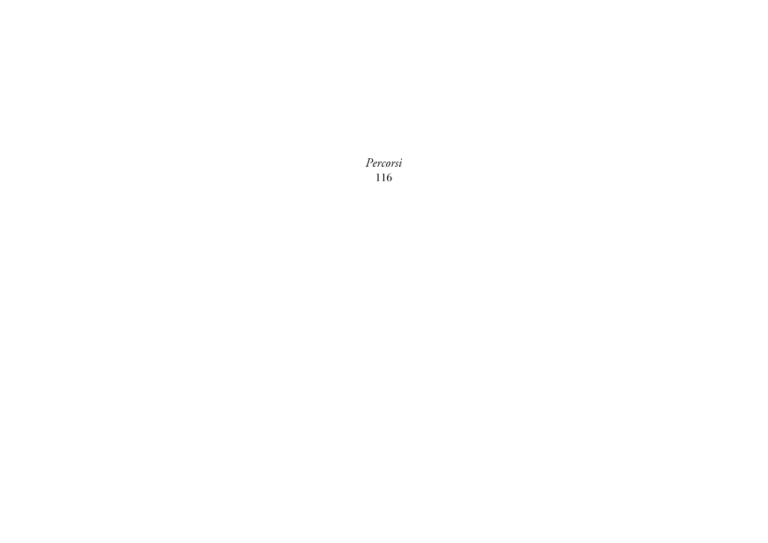
Percorsi
116
Gianluca Ligi
ANTROPOLOGIA
Serie diretta da Francesco Remotti
VOLUMI PUBBLICATI
Stefano Allovio
La foresta di alleanze.
Popoli e riti in Africa equatoriale
Antropologia
dei disastri
Pier Paolo Viazzo
Introduzione all’antropologia storica
Leonardo Piasere
L’etnografo imperfetto.
Esperienza e cognizione in antropologia
Adriano Favole
Resti di umanità.
Vita sociale del corpo dopo la morte
Alessandro Gusman
Antropologia dell’olfatto
Leonardo Piasere
I rom d’Europa.
Una storia moderna
Chiara Pussetti
Poetica delle emozioni.
I Bijagó della Guinea Bissau
Maria Arioti
Introduzione all’antropologia
della parentela
Alice Bellagamba
L’Africa e la stregoneria.
Saggio di antropologia storica
Enrico Comba
Antropologia delle religioni.
Un’introduzione
Gianluca Ligi
Antropologia dei disastri
Editori Laterza
© 2009, Gius. Laterza & Figli
Prima edizione 2009
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Finito di stampare nel gennaio 2009
SEDIT - Bari (Italy)
per conto della
Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 978-88-420-8609-3
È vietata la riproduzione, anche
parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche
ad uso interno o didattico.
Per la legge italiana la fotocopia è
lecita solo per uso personale purché
non danneggi l’autore. Quindi ogni
fotocopia che eviti l’acquisto
di un libro è illecita e minaccia
la sopravvivenza di un modo
di trasmettere la conoscenza.
Chi fotocopia un libro, chi mette
a disposizione i mezzi per fotocopiare,
chi comunque favorisce questa pratica
commette un furto e opera
ai danni della cultura.
ai miei genitori
La fine dell’ordine mondano può essere considerata
in due sensi distinti, e cioè come tema culturale
storicamente determinato, e come rischio antropologico
permanente. [...] Come rischio antropologico permanente
il finire è semplicemente il rischio di non poterci essere
in nessun modo culturale possibile, il perdere la possibilità
di farsi presente operativamente al mondo, il restringersi
– sino all’annientarsi – di qualsiasi orizzonte di operabilità
mondana, la catastrofe di qualsiasi progettazione
comunitaria secondo valori. La cultura umana in generale
è l’esorcismo solenne contro questo rischio radicale,
quale che sia – per così dire – la tecnica esorcistica adottata.
Ernesto De Martino
La fine del mondo
Ventisei tentativi hanno preceduto la genesi attuale
e tutti erano destinati a fallire. Il mondo dell’uomo
è uscito dal grembo caotico di questi detriti anteriori,
ma nemmeno esso ha un certificato di garanzia:
anche esso è esposto al rischio del fallimento e del ritorno
al nulla. «Speriamo che questo funzioni», esclamò Dio
creando il mondo, e questa speranza che ha accompagnato
tutta l’ulteriore storia del mondo e dell’umanità
ha sottolineato fin dall’inizio come questa storia sia segnata
col marchio della radicale incertezza.
André Neher
Vision du temps et de l’histoire dans la culture juive
VII
Premessa
Da diversi anni si è sviluppata una ricca letteratura, in buona parte
di carattere divulgativo, in cui il tema del rischio è affrontato con una
serie di approcci alquanto diversi fra loro (sociologico, bio-medico,
statistico, geologico ecc.)1. È quindi indispensabile fare subito due
precisazioni. La prima è che in questo libro non verranno prese in
considerazione alcune categorie di rischio: non tratteremo i «rischi
dello stile di vita», quelli cioè che deriverebbero dall’uso di stupefacenti, dal modo di guidare, dallo stress, dal tempo libero, dall’attività sessuale, dal gioco d’azzardo, e così via; e non analizzeremo
nemmeno i «rischi economici» (legati a disoccupazione, prestiti, investimenti, insuccessi d’impresa, mercati ecc.), né i «rischi della criminalità» (sia quelli che si corrono partecipando ad azioni criminose, sia quelli a cui si è esposti come potenziali vittime)2. Naturalmente affronteremo alcuni aspetti teorici comuni a tutti questi ambiti, ma in particolare rivolgeremo l’attenzione ai concetti di rischio
utilizzati nello studio dei disastri. E qui occorre fare la seconda precisazione: con il termine disastro – che verrà dettagliatamente problematizzato in un apposito capitolo del libro – intendiamo riferirci
sia alle catastrofi naturali (terremoti, tornado, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, alluvioni, tsunami ecc.), sia ai gravi incidenti tecnologici (esplosioni di impianti nucleari, contaminazioni batteriologiche e
virali, gravi forme di inquinamento ambientale ecc.). Non ci occuperemo invece di quelle situazioni, ugualmente critiche per numero
di vittime e/o per danni ambientali, provocate da atti criminali, come ad esempio la strage delle Torri Gemelle di New York.
1
Si vedano ad esempio: Bauman 1999; Castel 2004; Appadurai 2005; Tozzi
2005.
2 Questa sintetica classificazione è descritta in Lupton 2003, p. 19.
IX
Le catastrofi sono esperienza di ogni generazione, ma negli ultimi decenni il modo di percepire e rispondere a questi fenomeni sta
cambiando. Da un canto, le nuove potenzialità offerte dalle tecniche
e dai saperi hanno rinnovato la speranza e forse l’illusione di poter
contrastare l’imprevedibile e il terrificante; dall’altro, l’accresciuta
cultura della solidarietà sta rendendo i gruppi di primo aiuto e le successive reti di sostegno molto più efficaci nei confronti di chi si trova improvvisamente da solo nella tragedia. Nuova è anche la risonanza massmediatica che hanno gli eventi estremi, così come gli effetti sociali di tale risonanza. Molte discipline scientifiche, sia
nell’ambito delle scienze naturali (fisica, geofisica, ingegneria antisismica ecc.) sia in quello delle scienze sociali (psicologia, sociologia
delle organizzazioni, statistica ecc.), stanno sviluppando teorie e metodi specifici per affrontare il problema dei disastri. Eppure alcuni
studiosi (come Deborah Lupton, Pat Caplan e altri) hanno sottolineato che in questo quadro interdisciplinare si avverte fortemente
l’esigenza di un approccio antropologico adeguato. Ma in che modo
il sapere e le metodologie tipiche delle scienze etno-antropologiche
possono apportare un contributo efficace e originale allo studio dei
disastri? È possibile (e soprattutto utile) tentare di elaborare una vera e propria «antropologia dei disastri»?
Lo scopo del presente volume è descrivere come l’analisi antropologica sia una componente essenziale e irrinunciabile nelle ricerche sui disastri. Questo genere di indagini rivela aspetti problematici riguardo alle interconnessioni fra credenze, strutture politiche,
istituzioni sociali e relazioni di potere, il cui studio riveste un’importanza teorica che va ben oltre l’ambito specifico dell’antropologia applicata. Ad esempio, l’analisi dei processi sociali di attribuzione di colpa (blaming) dopo eventi catastrofici, sia in società tradizionali e «primitive» sia nella nostra società occidentale, mostra una
fondamentale relazione fra sistemi sociali, razionalità delle credenze
native rispetto ai nessi causali e rappresentazioni simboliche dell’ambiente naturale. La comprensione di come le istituzioni sociali contribuiscano a costruire la percezione del rischio e le categorie di colpa, pericolo, caso e causalità – e di come queste percezioni e categorie determinino il grado di vulnerabilità a un disastro – si lega a
difficili problemi di natura decisionale, politica ed etica.
Il libro è articolato in quattro capitoli. Nel primo vengono illustrati in forma introduttiva alcuni fra i principali problemi di ricerca in antropologia dei disastri e gli esiti più importanti del dibattito
X
che si è sviluppato nelle scienze sociali (con particolare attenzione ai
contributi dell’antropologia culturale) intorno al concetto di disastro (principalmente il rapporto fra nozioni tecnocentriche e nozioni socio-antropologiche di disastro); per poi passare – nel secondo e
nel terzo capitolo – a descrivere la fondamentale nozione di vulnerabilità sociale, mostrando in che modo il concetto di rischio debba
esservi teoricamente connesso. Il quarto capitolo tematizza i concetti nativi di disastro e i molteplici dispositivi simbolici che nelle varie
società vengono attivati per dare senso al male (in particolare in occasione di gravi incidenti o catastrofi naturali). L’analisi dei processi di attribuzione di colpa (sostenuti da credenze magico-religiose,
cosmologie, sistemi di classificazione della realtà naturale, strutture
e relazioni di potere ecc.) condurrà all’esposizione della teoria forense del pericolo e della teoria culturale del rischio. Sulla base di casi concreti di studio antropologico di un disastro, con le relative
esperienze di ricerca etnografica, saranno illustrati sostanzialmente,
oltre ai contributi di Mary Douglas, le istanze critiche e gli sviluppi
recenti (costruzionismo forte, costruzionismo debole, realismo).
Tenendo fede al principio secondo cui le premesse dovrebbero essere brevi per definizione, ringrazio complessivamente i colleghi e gli
amici che hanno letto in tutto o in parte i capitoli del libro, salvandomi da numerosi errori e fornendomi utili indicazioni bibliografiche.
Ho un grande debito di riconoscenza con Stefano Allovio e Pier Paolo Viazzo che, in modi e circostanze diverse, mi hanno fatto scoprire
un entusiasmante e innovativo campo di ricerca poco noto nel panorama italiano. Sono molto grato anche a Francesco Remotti che ha
colto subito l’importanza di questo filone di studi e mi ha proposto di
pubblicare il volume nella collana da lui diretta. Infine, per le preziose domande e per la loro sempre attiva e vivace partecipazione, rivolgo un ringraziamento particolare ai miei studenti dei corsi di Antropologia culturale (Facoltà di Filosofia, Università Statale di Milano,
per l’a.a. 2004-2005) e di Antropologia sociale (Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Venezia Ca’ Foscari per gli a.a. 2004-2007) che
ho tenuto sulle tematiche affrontate in questo libro.
Venezia, 20 settembre 2008
G.L.
Antropologia dei disastri
1
Concetti di disastro
Da un certo punto di vista,
un disastro diventa un disastro solo
quando vengono coinvolti uomini
o ambienti creati dagli uomini.
Una valanga in una valle disabitata
o un terremoto in Artide sono
eventi geofisici, non sono disastri.
Karl A. Western
The Epidemiology of Natural
and Man-made Disasters
1. Problemi di ricerca e definizioni
Un buon punto di partenza per comprendere il senso di una disciplina scientifica è individuarne i problemi di ricerca, ovvero le domande a cui tenta di rispondere, e chiedersi perché le rintenga importanti e quali metodi utilizzi per trovarvi risposta. Ogni ricercatore dovrebbe sempre identificare con chiarezza i propri problemi di
ricerca e ogni ricerca nel suo progettarsi e ridefinirsi continuo è un
lavoro incessante attorno a questi problemi. Si può estendere all’antropologia quanto Francesco Ferrarotti ha scritto per la sociologia:
entrambe – anche se con modalità talvolta profondamente diverse –
si occupano «di fatti sociali espressi in termini scientificamente rilevanti, ovvero di fatti che si pongono come problemi» (1999, p. 7). In
questo primo capitolo tracceremo dunque una mappa dei principali problemi teorici e di ricerca che caratterizzano l’antropologia dei
disastri. Da principio, analizzando alcuni casi concreti, formuleremo
questi problemi in modo molto generale, per poi passare, nei capitoli successivi, a definirli e circoscriverli sempre più in dettaglio, de3
lineando al tempo stesso un quadro degli approcci elaborati per risolverli.
È necessario innanzitutto un chiarimento terminologico. Nelle
scienze etno-antropologiche vi è l’abitudine assai diffusa di definire
dei settori disciplinari utilizzando etichette per così dire «al genitivo»: antropologia del corpo, antropologia dell’arte, antropologia del
rito, della città, dello sviluppo, dell’educazione, e così via. Queste
denominazioni non si riferiscono però al tentativo di fare antropologia di qualcosa, ma – più correttamente – all’intento di analizzare
qualcosa in prospettiva antropologica: cioè di porre l’attenzione sulle
modalità particolari, storicamente determinate, con cui gruppi etnici e sociali differenti, talvolta in conflitto fra loro, in differenti angoli di mondo, hanno culturalmente costruito e plasmato i loro concetti di corpo, di arte, di rito, di città, di sviluppo, di educazione ecc.
L’antropologia come scienza sociale si fonda per l’appunto sul principio epistemologico di base che per studiare e comprendere una data particolarità culturale sia indispensabile ricorrere allo studio di altre particolarità culturali ponendole in connessione fra loro (Remotti 1990). La denominazione antropologia dei disastri indica quindi
quel filone recente ma già piuttosto consistente di ricerche in cui si
applicano le teorie e i metodi tipici dell’antropologia socio-culturale allo studio dei disastri, nel senso di eventi naturali estremi (terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, tornado) e in quello di catastrofi tecnologiche (esplosioni di impianti nucleari, contaminazioni batteriologiche e virali, gravi forme di inquinamento ambientale)1. Ma che significa esattamente? Da alcuni anni molte altre
discipline, sia nell’ambito medico e delle scienze naturali (biostatistica, biochimica, epidemiologia, geofisica, ingegneria antisismica
ecc.) sia in quello delle scienze sociali (sociologia delle organizzazioni, psicologia delle emergenze di massa ecc.), stanno sviluppando
approcci specifici per affrontare il problema delle catastrofi. In che
modo allora il sapere e le metodologie tipiche delle scienze etno-antropologiche possono apportare un contributo ulteriore, originale, e
forse addirittura più efficace? Cosa ha a che fare una scienza tradizionalmente dedita allo studio di bizzarri costumi nativi, dolorosi rituali di iniziazione, fantasiose e incredibili mitologie, con i terremoti, le radiazioni nucleari, le nubi tossiche e i tornado? Questi inter1
Cfr. Hoffman, Oliver-Smith 1999; Hoffman, Oliver-Smith 2002.
4
rogativi pongono chiaramente un problema generale e molto complesso che, come vedremo, è al cuore stesso dell’antropologia dei disastri: la questione cioè di cosa si debba intendere esattamente con
la parola disastro e a quali tipi di eventi o circostanze fisiche, ecologiche e sociali la si debba più correttamente applicare.
In genere non si ritiene che l’antropologia possa occuparsi di disastri perché si tende a sottovalutare l’importanza degli aspetti socio-culturali di un disastro rispetto a quelli più marcatamente tecnici e fisici. Lo scopo di questo libro è invece mostrare come, al contrario, proprio gli aspetti socio-culturali siano le dimensioni preminenti di un evento naturale estremo, o di un disastro tecnologico, in
ogni sua fase (prima, durante e dopo l’impatto). Si potranno fare
passi avanti verso la comprensione e la prevenzione dei disastri, e la
mitigazione dei danni post-impatto, non soltanto migliorando l’analisi e la modellistica di tipo tecnico-fisico e ingegneristico, ma soprattutto concettualizzando in modo più sofisticato l’importanza
delle componenti sociali di un disastro e la loro variabilità trans-culturale. Un disastro non è qualcosa che semplicemente accade, ma è
una situazione estremamente critica che si produce quando un agente potenzialmente distruttivo – di origine naturale o tecnologica –
impatta su una popolazione che viene colta in condizioni di vulnerabilità fisicamente e socialmente prodotta. La circostanza disastrosa si presenta quando le sfere ambientale, sociale e tecnologica interagiscono fra loro in una specifica modalità, innescando un processo di connessione causale fra eventi che si verificano a catena. Se non
viene scoperto e bloccato in tempo, questo processo raggiunge rapidamente, o talvolta anche nell’arco di mesi o anni, un punto culminante che dà luogo alla catastrofe. Come vedremo, le particolari condizioni di vulnerabilità di una società sono l’elemento chiave per
comprendere un disastro e dipendono direttamente dalle concezioni del rischio prevalenti in quella società rispetto a determinati eventi pericolosi. Sono queste concezioni e valutazioni che orientano più
o meno efficacemente le scelte politiche, economiche e sociali su cui
poi si basano le opere concrete di intervento per prevenire i disastri.
Purtroppo però la questione non è così semplice: perché il rischio
come realtà oggettiva non esiste. Il rischio non è una caratteristica fisica della realtà, un oggetto naturale, un dato di fatto misurabile in
senso assoluto, ma è una categoria cognitiva, un costrutto della nostra comprensione mediante il quale rappresentiamo correlazioni fra
eventi concreti così da poterli governare con tecniche particolari e
5
per particolari obiettivi. In altri termini il rischio è una categoria del
pensiero che rende rappresentabile e manipolabile in termini statistici, sociologici, epidemiologici una data serie di eventi e fenomeni
concreti2. La natura non oggettiva del rischio è un concetto decisamente complesso e profondo al quale dedicheremo ampio spazio nei
capitoli successivi; da esso ricaveremo l’idea che l’antropologia dei
disastri si configura essenzialmente come una antropologia delle concezioni locali di rischio 3. L’antropologa Deborah Lupton scrive:
i fenomeni che selezioniamo e identifichiamo come «rischi» hanno uno statuto ontologico importante nella interpretazione di noi stessi e dei nostri
mondi sociali e materiali. Le società – e all’interno di esse le istituzioni, i
gruppi e gli individui – hanno bisogno di questo processo di selezione in
quanto elemento del loro continuo funzionare. La selezione dei rischi e le
attività associate alla loro gestione sono centrali per il loro ordine, la loro
capacità di funzionare e l’identità sia degli individui sia delle culture.
Secondo la stessa antropologa i principali problemi di ricerca
sono:
valutare secondo quali modalità il concetto di rischio operi nelle società occidentali giunte alla fine del ventesimo secolo, ed esaminarne le implicazioni rispetto ai modi in cui interpretiamo noi stessi, gli altri, le organizzazioni, le istituzioni, i governi e il mondo non umano (Lupton 2003, p. 20).
L’antropologia, fin dai suoi esordi, ha fatto largo uso della metafora architettonica, paragonando le società a edifici e focalizzando
l’attenzione sulla nozione di «struttura» e di «equilibrio». Attualmente l’analisi dei processi mediante i quali gli esseri umani «costruiscono» le loro culture svolge un ruolo centrale nella ricerca. Si
può dire che la metafora architettonica sia scivolata dai prodotti, le
società come edifici e strutture, ai processi, le società come cantieri,
nei quali si esercita l’opera costruttiva o poietica degli esseri umani,
2
Cfr. Dean 1999. Precisiamo che sostenere che il rischio esista solo in quanto
costrutto mentale non significa affatto sostenere che il pericolo non esista in quanto dato oggettivo. A tale proposito esamineremo il paradigma cosiddetto del «costruttivismo forte», ponendolo a confronto con il «costruttivismo debole» (o «realismo critico») e con il «realismo», v. capitoli 3 e 4.
3
L’espressione «concezioni locali» si riferisce direttamente al concetto antropologico geertziano di local knowledge, nel senso che si danno differenti nozioni di
rischio nel contesto di differenti sistemi nativi di significato (Geertz 1988).
6
che incessantemente e quotidianamente costruiscono significati, istituzioni sociali, visioni del mondo, modelli di comportamento, concezioni di genere, relazioni di potere, e così via4. Che ne è di questa
intensa opera di costruzione culturale di fronte a un disastro? In un
disastro, con il crollo improvviso e devastante del contesto quotidiano, sembra andare in frantumi l’ordine stesso con cui una cultura dà senso al mondo e ai rapporti sociali. I disastri non sono forse il
segno più evidente dell’irreparabile sconfitta di questo atteggiamento poietico? Non sono forse la prova più schiacciante dell’intrinseca
precarietà delle società umane e della fragilità dei loro costrutti culturali? Come viene culturalmente concettualizzata l’idea stessa della distruzione, dell’eventualità di una rottura repentina e irreversibile di ogni equilibrio, dello sgretolarsi di ogni struttura?
Per affrontare questioni di tale portata è indispensabile partire
dalla definizione di disastro. Il fatto che questo problema non sia stato ancora del tutto risolto la dice lunga sulla complessità del tema. I
disastri possono essere più facilmente riconosciuti che definiti. Un
conto è sentire il disastro, saperlo riconoscere quando vi si è coinvolti, ben altro conto è invece darne una definizione scientifica esauriente, efficace e non ambigua. La parola disastro esibisce pertanto
le caratteristiche di una tipica «sponge word» (Quarantelli 1978),
una parola spugnosa o, per meglio dire, porosa: assorbe molto, cogliendo un’esperienza della realtà estremamente complessa e drammatica, ma quando si tenta di spremerla e strizzarla per concettualizzarne in termini generali il significato restituisce assai poco. Cionondimeno, costruire una o più nozioni scientificamente adeguate
di disastro è un’operazione analitica indispensabile, in particolare
per chi si occupa di antropologia.
Se le scienze naturali utilizzano in buona parte strumenti di ricerca piuttosto concreti – come ad esempio i microscopi a scansione (biologia), o gli acceleratori di particelle (fisica) –, l’antropologia, in quanto scienza sociale, è provvista di strumenti che sono essenzialmente di
tipo concettuale, e cioè esprimibili mediante parole. Occorre dunque
prestare la massima attenzione a come si definiscono i termini da utilizzare in una ricerca antropologica. L’antropologo lavora con le pa4
Cfr. ad esempio: Berger, Luckmann 1966; Maturana, Varela 1985; Cohen
1985. Più recentemente alcuni aspetti del paradigma dell’autopoiesi sono stati ripresi e sviluppati in modo originale (si parla di antropo-póiesi) da Francesco Remotti (1994, 1999); cfr. anche Calame, Kilani et al. 1999.
7
role: egli è impegnato in un costante tentativo di costruzione di senso
– un «trying to make sense» (Winch 1987) – e si sforza (e secondo alcuni si illude) di connettere fra loro mondi sociali radicalmente differenti interpretando e traducendo concetti nativi, che sono a loro volta interpretazioni della realtà. La traduzione antropologica è inoltre
un’operazione intersoggettiva in cui i significati che si traducono (interpretano-comprendono) vengono generati nell’incontro etnografico fra l’antropologo e i propri informatori. Come ha scritto Clifford
Geertz (1988), il pensiero umano è essenzialmente un fatto sociale,
per cui il pensare non consiste in «avvenimenti nella testa» (sebbene
l’attività cerebrale sia indispensabile perché il pensare abbia luogo),
ma in un traffico di simboli significativi, e il suo habitat naturale è il
cortile di casa, il mercato e la piazza principale della città. Conseguentemente la comprensione antropologica è un’impresa pratica: un
tentativo di to make sense, cioè di fare senso, fabbricarlo, costruirlo immergendosi nelle medesime pratiche quotidiane in cui sono impegnate le persone del gruppo sociale che stiamo studiando.
In questo capitolo vedremo quindi come il termine disastro assuma significati differenti in differenti tradizioni di studio; esamineremo quale fra queste definizioni sia la più opportuna per l’indagine antropologica e che importanza abbia l’interpretazione di eventuali nozioni native di disastro in rapporto alle nostre. Definizioni diverse dovrebbero essere elaborate in modo tale da potersi integrare
fra loro, e avere così la capacità di porre in luce aspetti diversi (di tipo sociologico, geologico o psicologico) di un fenomeno che per sua
natura è poliedrico e multifattoriale, e non si lascia comprimere e incasellare facilmente in un rigido schema analitico. Come si è detto,
la questione è piuttosto rilevante, giacché da essa dipendono, sul piano teorico, la validità di un modello interpretativo degli eventi estremi e, sul piano pratico, la conseguente capacità di intervento efficace nella previsione delle catastrofi e nelle emergenze di massa. Dice
bene il geologo Mario Tozzi (2005, p. 10):
[...] Le calamità naturali non esistono, esistono solo il naturale divenire di
un pianeta attivo e dinamico e la nostra incapacità di tenerne conto.
Questa considerazione critica sulla innaturalità di molti disastri
naturali (e vedremo anche sulla non casualità – o non fatalità – di
molti disastri tecnologici) riprende ed estende il concetto di Western
– per il quale un disastro diventa tale solo quando vengono coinvolti esseri umani o ambienti creati dagli esseri umani – e costituisce il
punto di partenza dell’antropologia dei disastri. Ma non basta riconoscere che un disastro presenta degli aspetti socio-culturali, né è
sufficiente ritenere che un qualsiasi evento critico si debba classificare come disastro se e solo se coinvolge una comunità umana. Il
punto è stabilire esattamente come le componenti socio-culturali
dell’evento disastroso debbano essere concettualizzate nei nostri
modelli interpretativi.
I pericoli più pericolosi sono quelli che non riconosciamo come
pericoli, i rischi gravi che non sappiamo di correre. Questo genere
di pericoli si può annidare in uno schema interpretativo errato o incompleto; in un modello teorico le cui variabili risultano insufficienti
o non efficacemente correlate; in errori di valutazione nell’attribuire importanza a certi aspetti piuttosto che ad altri, nell’indirizzare le
ricerche in una direzione piuttosto che in un’altra. Alla base delle
difficoltà scientifiche di comprendere tutte le cause di un evento naturale estremo o di una catastrofe tecnologica vi sono spesso problemi irrisolti perché malposti o perché nessuno ha mai pensato di
porseli; così come vi sono anche domande piuttosto rilevanti riguardo alla «fisiologia» dei sistemi sociali e delle culture umane nelle gravi emergenze di massa, alle quali non siamo ancora in grado di rispondere. Questi fattori aumentano pericolosamente la nostra vulnerabilità ai disastri, e per la loro natura così elusiva ed enigmatica
possiamo a buon diritto definirli i nostri nemici invisibili.
2. Nozioni tecnocentriche e nozioni socio-antropologiche
In Oriente, per esempio, si è ormai pienamente compreso che fenomeni come le eruzioni o i terremoti rientrano in un ordine naturale di eventi esattamente come la pioggia o il vento (Kashima è da tempo immemore
l’unico dio giapponese che riesce a tenere sotto controllo Namazu, il pesce-gatto che dimenandosi nel sottosuolo fa vibrare la superficie terrestre).
In generale ci ostiniamo a chiamare catastrofi naturali disastri in realtà provocati esclusivamente dalle azioni o dalla semplice presenza dell’uomo.
8
Il profilo caratteristico della nozione più comune di disastro affiora
chiaramente nello stile allarmante e lapidario tipico dell’informazione giornalistica:
Dopo la strage di Haiti (oltre mille morti) la minaccia torna sugli Stati Uniti. Florida senza pace. Arriva Jeanne il quarto uragano. L’occhio del
9
ciclone attraverserà l’intera costa orientale dello Stato. Allarme a Cape
Canaveral. Danni per cinquanta miliardi di dollari («La Stampa», 25 settembre 2004).
Il bilancio potrebbe aggravarsi. Centinaia di feriti, case distrutte. Colpiti anche Porto Rico e la Repubblica Dominicana. Haiti, l’uragano Jeanne fa una strage. Le vittime sono 500. Decine di dispersi, ottantamila senzatetto («la Repubblica», 21 settembre 2004).
Ottobre 2004, Giappone: la Prefettura di Niigata viene colpita dal sisma più violento degli ultimi 10 anni, un evento di magnitudo 6,6 che
causa decine di morti e lascia 100.000 persone senza tetto. Gli scienziati
possono calcolare la zona in cui colpirà un forte sisma, ma non il momento («National Geographic», aprile 2006).
A parte l’enfasi e le inevitabili semplificazioni giornalistiche, questo modo di «scattare delle istantanee» di un disastro deriva concettualmente da una prima classe di nozioni di disastro, che d’ora in poi
chiameremo tecnocentriche, formulate nell’ambito delle scienze fisiche, geologiche e dell’ingegneria, per le quali si tende a identificare un
disastro con qualche caratteristica di un agente di tipo fisico e con gli
effetti fisici di tale agente in termini di danni a cose e persone. Un disastro può essere ad esempio un terremoto (un agente fisico naturale,
come un movimento geologico di un certo tipo), oppure un’esplosione (un agente artificiale, o tecnologico, come la fuoriuscita di scorie
radioattive da una centrale nucleare), che procura effetti «fisici» in
termini di danni a cose (edifici crollati, infrastrutture distrutte, impianti fuori uso ecc.) e a persone (cioè le vittime: morti, feriti, dispersi, senzatetto, contaminati, evacuati).
In questa prospettiva, i requisiti e i caratteri del disastro vanno ricercati nella non comune gravità dell’evento e nell’estensione e complessità dei danni. Il sismologo Enzo Boschi, in un interessante volume sui terremoti d’Italia, scrive:
La prova generale avvenne nel 1905 in Calabria, con un terremoto del
decimo grado e mezzo che colpì l’area fra Cosenza e Vibo Valentia. I morti furono circa 600, e 300.000 i senzatetto. I centri danneggiati furono circa 326, fin nella provincia di Messina e nelle isole Eolie, 37 dei quali distrutti completamente o quasi. Una commissione di inchiesta parlamentare, cinque anni dopo, definì le case della zona «tuguri da trogloditi». Per
l’emergenza i prefetti dovettero servirsi esclusivamente dei fondi che ave10
vano a disposizione, e solo quando sorsero problemi di ordine pubblico le
autorità centrali si mossero sospendendo le imposte. [...] i due maggiori sismologi dell’epoca, Baratta e Mercalli, individuarono con precisione le
cause del terremoto in «assestamenti della massa arcaica sul nucleo terrestre giocando tra le strutture», spiegarono la ragione dei danni più o meno
gravi in rapporto alla capacità degli strati geologici di trasmettere le onde
sismiche nelle varie direzioni, richiamarono l’attenzione sulle condizioni
penose del patrimonio edilizio e proposero lo spostamento di alcuni abitati. Se ne discusse molto in Parlamento e nei ministeri, ma non se ne fece
nulla. E non servì a molto nemmeno il terremoto di ottavo-nono grado che
l’anno dopo colpì la provincia di Reggio Calabria, soprattutto i centri di
Ferruzzano e Bruzzano, provocando 167 morti e danni più o meno ingenti in 98 comuni (Boschi, Bordieri 1998, pp. 108-109).
Come si vede, anche da un punto di vista storico il concetto di disastro viene costruito essenzialmente in termini fisici. L’approccio
interpretativo globale e le strategie di intervento e di gestione del disastro sono di tipo tecnico-fisico e ingegneristico. Il disastro è inteso come evento grave, improvviso e imprevisto. Il problema della
predittività, vale a dire dell’analisi delle condizioni pre-impatto, è
posto quasi esclusivamente in termini di miglioramento dei modelli
esplicativi geofisici, degli strumenti di rilevamento (come i sismografi), delle carte di zonazione del pericolo sismico o dei movimenti
di massa. La gravità dell’evento è misurata unicamente attraverso parametri quantitativi: come le scale di magnitudo (magnitudo locale,
scale di Richter e Mercalli, accelerazioni di Cancani, scala di Fujita
per i tornado ecc.); oppure con stime numeriche sul tipo e l’estensione dei danni fisici; e mediante il calcolo del numero delle vittime
e la loro classificazione (morti, feriti, senzatetto, dispersi, contaminati, evacuati) (v. schema 1).
Schema 1. Nozioni tecnocentriche di disastro
DISASTRO (D)
=
(I) AGENTE D’IMPATTO fisico
(naturale o tecnologico)
EFFETTO fisico
(in termini di danni a persone e cose)
11
Questo approccio tecnocentrico all’analisi e alla gestione dei disastri è ovviamente utile e indispensabile. Cionondimento presenta
dei limiti concettuali profondi: il necessario miglioramento dei modelli geofisici o informatici e delle tecniche di gestione degli impianti (perfezionamento dei controlli automatici, delle installazioni industriali ecc.) si è dimostrato paurosamente insufficiente per comprendere, prevedere ed evitare un disastro. Facciamo un paio di
esempi.
Il Giappone è un paese tecnicamente all’avanguardia nel fronteggiare qualunque tipo di disastro, in particolare i terremoti. Ha sviluppato tecnologie avanzatissime per il monitoraggio sismico e l’evacuazione; e malgrado vi siano (come ovunque nel mondo) anche periferie urbane con abitazioni fatiscenti, i grattacieli che costituiscono gran parte delle metropoli giapponesi non sono proprio dei «tuguri da trogloditi». Ciononostante, il terremoto di Hyogo-ken Nambu del 17 gennaio 1995, di magnitudo 6,9, noto come il «terremoto
di Kobe» – verificatosi a Kobe, una città di circa un milione e mezzo di abitanti, tecnologicamente avanzata, il maggior porto del Giappone (e il sesto porto del mondo) –, ha prodotto ingenti danni strutturali (palazzi crollati, interi tronchi della mirabile autostrada sopraelevata Hanshin distrutti, una linea ferroviaria divelta, il centro
urbano devastato), causando la morte di circa 7000 persone. In
Giappone sono stati inventati anche i cosiddetti EWS (Early Warning
Systems), ovvero i Sistemi di Allertamento Anticipato per gli tsunami che consentono di anticipare l’onda di circa 20 minuti. Malgrado
ciò, recenti ricerche di psicologia dinamica hanno mostrato che non
più del 2-3% della popolazione risponde positivamente in casi concreti: al contrario, un’alta percentuale di persone rimane pericolosamente ferma in attesa di vedere l’onda prima di mettersi in salvo
(cioè di adottare il comportamento attivo efficace previsto dal modello), ma allora è troppo tardi5. A tale proposito il caso di Hilo è alquanto significativo.
Nel 1948, nella città di Hilo, alle Hawaii, venne fondato uno dei
più importanti centri per l’allertamento del pericolo tsunami: il Pacific Tsunami Warning Center, coordinato per un lungo periodo da
Michael E. Blackford, uno dei massimi esperti in materia. Il centro
opera rilevando segnali da un complesso sistema di boe oceaniche
interconnesse da reti satellitari, ed è in grado di monitorare eventi sismici in tutto il mondo mediante un’efficace circolazione di informazioni fra vari istituti di ricerca, che vengono messe in correlazione con la dinamica del mare. Il 22 maggio del 1960 (ben dodici anni dopo la fondazione, quando l’attività del Centro era già ben nota
e rodata e la sua importanza indiscussa) il Centro lanciò un allarme
proprio alle cittadine sulle coste orientali delle isole Hawaii, fra cui
Hilo. Per effetto di un intenso terremoto al largo del Cile meridionale6, si sarebbe di lì a poco prodotto un terribile tsunami. L’impatto sulle coste di Hilo fu previsto per la mezzanotte del 22 maggio,
con diverse ore di anticipo, sufficienti a organizzare l’evacuazione.
Ciò che accadde fu invece sorprendente e paradossale: molti sottovalutarono il pericolo, l’evacuazione non si svolse in modo pieno e
ordinato, e parecchi abitanti rifiutarono di andarsene. Addirittura,
nella notte, molte persone si recarono al mercato del pesce nel porto di Suisan per «vedere l’onda», che inesorabilmente arrivò alle
3.40, causando decine di morti e distruggendo buona parte della
città (con danni per 30 milioni di dollari). Una questione che presenta molteplici risvolti antropologici (in buona parte non ancora
adeguatamente studiati) è dunque quella relativa alla comprensione
culturale complessiva di una situazione critica – nel contesto locale –
e del conseguente uso appropriato dei dispositivi tecnologici7.
Come ha ampiamente mostrato David Alexander, in un recente
e importante volume di sintesi dal titolo Confronting Catastrophe
(2000), i progressi nel funzionamento dei dispositivi tecnologici di
controllo e i miglioramenti delle strutture ingegneristiche, per quanto importanti, purtroppo non bastano ad evitare una strage; né l’analisi delle sole caratteristiche fisiche dell’evento estremo è in generale sufficiente a comprenderne la natura e gli effetti. Ad esempio, il
terremoto in Armenia (7 dicembre 1988), di 6,9 gradi Richter, ha
provocato 55.000 morti, mentre il terremoto in India del gennaio
5
Si veda L. Brait, Il terremoto in Giappone: antropologia del rischio nel disastro
di Kobe, tesi di laurea non pubblicata, Università di Venezia Ca’ Foscari, relatore
prof. G. Ligi, a.a. 2004-2005; e cfr. Iwata, Hatayama, Kawase et al. 1995.
6
Il terremoto del 21-30 maggio del 1960 che colpì il Cile meridionale sviluppò
una magnitudo pari a 8,3 gradi Richter causando la morte di circa 5000 persone.
7
In particolare devono essere ancora sistematicamente studiate le tendenze di
percezione minimalista che si sviluppano talvolta nel corpo sociale rispetto ai sistemi di allertamento anticipato: ovvero il fatto che si è inconsapevolmente portati a
sottostimare l’urgenza e l’importanza dell’allerta dopo uno o due casi di falso allarme. Questo incide profondamente sui comportamenti sociali attesi e riduce drasticamente l’efficacia di molti strumenti tecnologici.
12
13
2001, nella regione del Gujarat, di intensità assai maggiore – 7,9 gradi Richter – ha causato un numero molto inferiore di vittime: circa
33.000 morti8. Da questi casi ricaviamo la considerazione fondamentale che non esiste mai un rapporto lineare, di proporzionalità
diretta, fra intensità dell’impatto e gravità del danno. È vero che gli
effetti di un terremoto (così come gli effetti di altri tipi di disastro
tecnologico, quale l’esplosione di un impianto nucleare) dipendono
da una serie di fattori tecnico-fisici variabili (ad esempio fattori intrinseci al sisma: tipo di fagliazione, profondità dell’epicentro ecc.;
fattori geologici: condizione dei terreni, composizione dei suoli in
cui si propagano le onde ecc.); ma queste variabili da sole non sono
ancora sufficienti a spiegare perché eventi naturali di uguale magnitudo provochino danni notevolmente differenti. Perché, ad esempio, il terremoto dell’Irpinia ha causato migliaia di morti, contrariamente a quanto avvenuto in California per sismi di magnitudo simile?9 Il sociologo Marco Lombardi esplicita questo punto con particolare chiarezza:
ciò significa che il problema non è più «dentro all’evento», ma è fuori
dall’evento, nel sistema sociale che è colpito. Ricordo un dibattito con alcuni medici, dopo l’intervento in Irpinia. Uno di essi raccontava, disperato, che a distanza di quindici giorni gli avevano portato una ragazza che
stava morendo di polmonite perché, per quindici giorni, i genitori l’avevano nascosta in una stalla, piuttosto che farla curare dai medici che venivano dal Nord e che erano «incomprensibili», cioè parlavano un’altra
lingua e avevano altri modi di comportamento. Il problema, allora, non è
più professionale, tecnico, ma è di relazione culturale; ancora una volta non
è dell’evento, ma del sistema colpito (Lombardi 1993, corsivi miei).
Si pensi anche a cosa ha comportato gestire l’esplosione di Bhopal in alcuni villaggi indiani del Madhya Pradesh10, oppure il controllo della diffusione del virus Ebola Marburg (un agente caldo del
4° livello) a Entebbe in Uganda, o della variante ancor più contagiosa denominata «Ebola Zaire» in Congo. Il virologo Karl M. John-
son – fondatore della sezione che si occupa di virus sconosciuti (Special Pathology Branch) presso l’Istituto di Malattie Infettive di
Atlanta (Georgia) – guidò, nell’autunno del 1973, la squadra medica di intervento in Congo (l’ex Zaire) subito dopo che il virus Ebola venne isolato per la prima volta, e descrisse ciò che vide appena
giunto a Kinshasa con queste parole:
Kinshasa si era trasformata in una specie di manicomio. Dalla provincia di Bumba non arrivavano più notizie, e i contatti radio erano interrotti. Sapevamo che laggiù la situazione era molto grave, e che ci trovavamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo. Non sapevamo ancora se il virus avesse la capacità di diffondersi nell’aria attraverso minute goccioline, un po’ come fa quello dell’influenza. Se Ebola avesse avuto questa caratteristica, oggi il mondo sarebbe un posto molto diverso
(Preston 1994, p. 98).
E Richard Preston, nel suo libro inchiesta The Hot Zone (1994),
ha in seguito raccontato dettagliatamente le prime reazioni della popolazione locale al contatto con i soccorritori:
Si diressero a nord, in direzione del fiume Ebola. Si era nella stagione delle piogge e la «strada» era una sequela ininterrotta di pozzanghere
attraversate da torrentelli. Le ruote giravano vorticosamente e i motori
gemevano mentre il piccolo convoglio avanzava a passo d’uomo nella foresta, oppresso dalla pioggia incessante e dal caldo. Di tanto in tanto, si
imbattevano in un villaggio, preannunciato da un blocco stradale fatto di
tronchi. Resi esperti da secoli di convivenza con il vaiolo, gli anziani avevano preso le misure necessarie a contenere la diffusione del virus, isolando le loro comunità dal mondo esterno. Era una forma di quarantena
al rovescio, e una pratica antica in Africa, dove in tempi di malattia i villaggi si barricano contro gli stranieri e allontanano chiunque voglia penetrarvi. «Chi siete? Cosa volete?» gridavano verso le Land Rover da dietro le barriere di alberi. «Siamo dottori! Siamo venuti per aiutarvi!» (Preston 1994, p. 100).
Fonti: The World Almanac, 2003 e 2006; Worldwatch Institute, State of the
World - 2003; Environmental Protection Agency, USA. Cfr. Alexander 1997.
9
Irpinia, 23 novembre 1980, 7,2 gradi Richter, 2735 morti; baia di San Francisco (California), 17 ottobre 1989, 6,9 gradi Richter, 65 morti; Northridge (California), 17 gennaio 1994, 6,8 gradi Richter, 61 morti. Fonte: The World Almanac, 2003.
10 Si vedano ad esempio Jasanoff 1994; Chohan et al. 1994.
Se un evento estremo si verifica con la stessa intensità ed è caratterizzato grosso modo da simili variabili fisiche in due differenti sistemi sociali, i danni che produce in ciascun sistema non risultano mai
uguali e talvolta sono anche difficilmente paragonabili, perché non
dipendono soltanto dalla fisica dell’evento e degli agenti di impatto,
ma derivano soprattutto dalle reazioni sociali che si attivano durante
14
15
8
Schema 2. Nozioni socio-antropologiche di disastro
AGENTE D’IMPATTO
(I)
=
a) un fenomeno «naturale»
(sisma, vulcanismo,
inondazione ecc.)
b) un incidente tecnologico
(esplosione nucleare,
contaminazione ecc.)
DISASTRO (D)
=
Il tipo e il grado di disgregazione
sociale che segue spesso l’impatto
di un agente distruttivo su una
comunità umana
EVENTO FISICO
FENOMENO SOCIALE
e dopo la crisi, in funzione del tipo di cultura specifico posseduto da
ciascun sistema sociale nei confronti di quell’evento. Da ciò si ricava
l’importantissima conseguenza logica di togliere all’evento scatenante il significato di disastro, per ricollocarlo nell’ambito del sistema sociale. Accanto alle nozioni tecnocentriche, nasce così l’esigenza di elaborare delle nozioni socio-antropologiche di disastro. In questo secondo tipo di concezioni si fa una sostanziale differenza fra agente fisico distruttivo e disastro. Ad esempio, un’inondazione, un terremoto, un’esplosione nucleare, una contaminazione ambientale sono
agenti distruttivi (o «agenti d’impatto», più o meno naturali); con il
termine disastro si intende invece il tipo e il grado di disgregazione sociale che segue l’impatto di un agente distruttivo su una comunità umana (v. schema 2 e cfr. con lo schema 1), e si parla di disastro solo se si
verifica questa situazione, anche in assenza di morti o in assenza di
agenti d’impatto: la semplice minaccia di un impatto può essere socialmente dirompente tanto quanto un impatto effettivo11.
Questa prospettiva è ben descritta dalla definizione di disastro
formulata da Enrico Quarantelli e Dennis Wenger:
i disastri sono fenomeni sociali, osservabili nel tempo e nello spazio, in
cui entità sociali (dalle società fino a subunità minori come le comunità)
subiscono uno sconvolgimento delle loro attività sociali quotidiane, come risultato di un impatto effettivo o di una percezione di minaccia a causa dell’apparire relativamente improvviso di agenti naturali e/o tecnolo11
È appunto questo il senso del reato di procurato allarme.
16
gici, che non possono essere controllati direttamente e completamente
dalla conoscenza sociale esistente12.
Secondo le nozioni tecnocentriche il disastro è un evento fisico,
secondo quelle socio-antropologiche è invece un fenomeno sociale.
In termini antropologici un disastro è innanzitutto un fenomeno sociale che si manifesta con una vistosa disarticolazione della struttura sociale e del sistema nativo di significati che sorregge e rende comprensibile il flusso di azioni. Diminuisce o si annulla del tutto il grado di integrazione sociale, compaiono drammatici conflitti di ruolo,
le strategie d’azione adeguate che connettono tipi di ruoli e tipi di
gruppi divengono contraddittorie, saltano le normali relazioni di potere, si instaurano nuove e differenti catene decisionali (si pensi ad
esempio a società in cui un sistema di credenze è del tutto solidale al
sistema politico, come in alcune comunità islamiche)13. Uno dei contributi concettuali più profondi dell’analisi antropologica in questo
campo consiste quindi nell’aver elaborato una definizione di disastro
esterna all’evento fisico, che mette in evidenza come gli effetti della
crisi (scatenata da un agente d’impatto) siano già potenzialmente
iscritti nel sistema sociale colpito, il quale manifesta, per così dire,
una quota di vulnerabilità specifica per ogni emergenza. Il primo elemento di vulnerabilità è dato dal fatto che l’evento può non essere
dominabile cognitivamente dal sistema sociale (come ad esempio nel
caso del terremoto catastrofico che ha colpito nel 2003 il villaggio di
Bam in Iran, oppure in quello della contaminazione da radioattività
nella regione saami di Brurskanken)14.
Il concetto antropologico di vulnerabilità è il primo fattore variabile di tipo essenzialmente socio-culturale che caratterizza i sistemi sociali e le comunità. Schematizziamo utilizzando una semplice
notazione compatta che non rappresenta un calcolo matematico in
senso stretto, ma che sarà utile in seguito per rendere più chiaro il
ragionamento: il disastro (D) si configura allora come relazione fra
12
La definizione è tratta dalla voce «Disastro» redatta da Quarantelli e Wenger
per il Nuovo Dizionario di Sociologia (De Marchi, Ellena, Catarinussi 1987, p. 675).
Nei paragrafi successivi riprenderemo questa definizione commentandola analiticamente e inquadrandola nel contesto delle ricerche e di Quarantelli e Wenger.
13
È bene sottolineare che talvolta, nei contesti di emergenza di massa, si verificano anche reazioni «aggregative», che ricompattano i nuclei sociali, creando
nuovi e più forti legami di solidarietà.
14 Cfr. Torry 1978, 1979a, 1979b.
17
un impatto con un agente fisico (I), naturale o tecnologico (un terremoto, un’inondazione, oppure una contaminazione ambientale o
un’esplosione di un impianto chimico) e la vulnerabilità socio-culturale (V) specifica della comunità colpita.
(1)
D =
I
(variabili fisiche)
×
V
(variabili antropologiche)
no determinati da errori sistemici (cioè diffusi e delocalizzati lungo le
componenti di una data struttura sociale), che spesso provocano errori di singoli individui. Tali precondizioni presentano talvolta delle
caratteristiche comuni. Il periodo di gestazione di un disastro è costellato da numerosi piccoli segnali di avvertimento che però vengono ignorati o male interpretati (Turner, Pidgeon 2001). Secondo l’approccio antropologico ai disastri, il corto circuito nella gestione delle
informazioni è sempre legato a molti altri fattori di tipo tecnico, sociale, organizzativo e istituzionale. Il modo con cui questi fattori si
connettono fra loro varia da società a società, ed è pertanto un fattore
tipicamente antropologico che deve essere studiato non in astratto, ma
immergendolo nel proprio contesto culturale (borgo di pescatori
giapponesi, comuni della Basilicata, villaggi del Congo, comunità rurali dell’Iran, gruppi di pastori saami ecc.). Da quanto detto risulta
quindi che il tema fondamentale per cui si rende indispensabile l’analisi antropologica di un disastro è quello relativo alla valutazione della vulnerabilità (V) di un sistema sociale, specifica rispetto a un particolare tipo di crisi potenziale. Che significa però esattamente «vulnerabilità sociale»? Quali sono le variabili principali che la caratterizzano? Come possono essere studiate mediante indagini etnografiche?
Qual è il nesso fra vulnerabilità sociale e vulnerabilità fisica?
Per affrontare questi problemi cruciali è necessario approfondire ulteriormente il percorso scientifico interdisciplinare che ha storicamente condotto al superamento del paradigma tecnocentrico e
alla formulazione delle nozioni socio-antropologiche di disastro.
La relazione (1) mostra perché a parità di intensità di impatto –
ovvero con variabili fisiche (I) molto simili – il danno può essere talvolta enormemente differente. Il livello di vulnerabilità (V) può amplificare o diminuire gli effetti fisici dell’agente distruttivo. Non è
sufficiente quindi misurare la gravità di un disastro soltanto in termini numerici (con variabili di tipo quantitativo, come le stime dei danni a cose e persone), ma si pone il problema di stabilire delle variabili socio-culturali per determinare il livello di vulnerabilità e il grado
di disarticolazione sociale della comunità colpita. Si parte cioè dal
presupposto che gli effetti disastrosi della crisi siano già potenzialmente presenti nel sistema sociale colpito, nascosti come pericolosi
nemici invisibili in particolari aspetti di una data struttura sociale,
nei modi in cui i gruppi sono costituiti e connessi, in una data struttura di parentela, nei processi decisionali istituzionalizzati, nel ruolo
attivo di un dato sistema di credenze o di un dato schema di relazioni
economiche o di potere che influiscono sui comportamenti quotidiani delle persone. Questo ragionamento implica però un’altra conseguenza profonda in termini teorici e applicativi: è possibile spostare la portata dell’analisi alle condizioni precedenti l’impatto, e indirizzarla etnograficamente, in modo preventivo, sulla vita normale
e quotidiana di una comunità che potrebbe essere più o meno socialmente vulnerabile a una serie di agenti distruttivi (terremoti, inondazioni, esplosioni nucleari, contaminazioni biologiche ecc.).
Interpretare un disastro come fenomeno sociale, e connetterlo al
concetto di vulnerabilità, ha il pregio di togliere all’evento scatenante i connotati della fatalità ineluttabile. Come vedremo, i disastri (soprattutto quelli di tipo tecnologico) non sono eventi repentini e imprevedibili dovuti esclusivamente a imperfezioni tecniche, bizzarrie
climatiche della natura, casualità o tragici errori umani; ma sono processi complessi che si attivano gradualmente durante un lungo periodo di incubazione e che alla fine precipitano dando luogo a una situazione catastrofica. Questi processi hanno delle precondizioni, so-
Intorno al primo decennio del Novecento, la città di Halifax era il
più importante capoluogo del dominion canadese sull’Atlantico. Sorta in posizione favorevole, sulla Chebucto Bay, all’estremità di un’ampia e profonda insenatura della costa sudorientale della Nuova Scozia, Halifax divenne il terzo porto commerciale dell’impero britannico, con possibilità di attracco per centinaia di navi, e dall’inizio del
1914 fu anche la principale base militare del dominion. Il 6 dicembre
del 1917, la nave da carico francese Mont Blanc, di proprietà della
Compagnie Générale Transatlantique, da 3121 tonnellate di dislocamento complessivo, giunse ad Halifax proveniente da New York, trasportando 450.000 libbre (circa 170 tonnellate) di trinitro-toluene
(TNT), il più pericoloso e micidiale esplosivo allora conosciuto. Alle
18
19
3. Il disastro di Halifax
9.06 del mattino, la Mont Blanc procedeva lungo il bacino portuale
per raggiungere la posizione di attracco, quando all’improvviso, per
un fatale errore nelle segnalazioni, entrò in collisione con un bastimento belga, l’Imo, della Southern Pacific Whaling Company, adibito al trasporto di rifornimenti. Vi fu una tremenda esplosione che produsse uno spostamento d’aria simile al passaggio di un tornado: in
pochi istanti, chiese, scuole, fattorie vennero bruciate o rase al suolo
dall’onda d’urto, con danni materiali per 30 milioni di dollari. Circa
3000 acri di territorio, fra il porto e il centro cittadino, furono trasformati in una raccapricciante distesa di rovine fumanti. Il disastro
di Halifax, considerato la più grande esplosione accidentale singola
della storia, causò 2000 morti, 6000 feriti e 10.000 senzatetto.
Un giovane canadese laureatosi a Toronto, Samuel Henry Prince, all’epoca studente di dottorato in Scienze sociali alla Columbia
University di New York, su suggerimento del suo professore supervisore, Franklin Henry Giddings, si recò ad Halifax subito dopo il
disastro e vi rimase per diversi mesi compiendo un’approfondita ricerca sul campo con modalità che oggi potremmo ben definire etnografiche. La sua tesi di dottorato, basata su quell’indagine di terreno, venne poi pubblicata nel 1920 con il titolo Catastrophe and Social Change. Based upon a Sociological Study of the Halifax Disaster,
e rappresenta il primo studio empirico di un disastro da una prospettiva marcatamente socio-culturale15.
Negli anni Venti del secolo scorso, quando Prince concludeva i
suoi studi, la sociologia statunitense era impegnata a rielaborare temi cari a Comte, Spencer e Durkheim, e si ispirava alla dottrina evoluzionistica, «adatta a una società in rapido sviluppo che non considerava questo un peso» (Jonas 1970, p. 630). La nuova scienza dell’uomo si dibatteva intorno ai pressanti problemi strutturali e organizzativi – fra prerogative del singolo ed esigenze della collettività
– posti dal progresso tecnologico e dalle contrastanti tendenze sociali individualistiche e pluralistiche16. In un tale contesto culturale
e intellettuale apparve dunque di particolare interesse una ricerca
sulle reazioni sociali alla catastrofe che aveva colpito una città come
Halifax, dinamica, attiva e tecnologicamente avanzata. In quel perio-
do Giddings lavorava sui temi dell’adattamento, della personalità e
della coscienza sociale, e fu – con Sumner, Small, e altri – fra gli studiosi che maggiormente contribuirono alla fondazione della sociologia americana17.
La tesi di Prince, che si apre con un ringraziamento ai professori del Dipartimento di Sociologia della Columbia University, in particolare a Giddings per aver ispirato l’approccio così innovativo della ricerca, è articolata in nove capitoli più un’introduzione. In sole
147 pagine, i dati sul disastro di Halifax, ricavati dalla ricerca empirica, vengono accuratamente disposti e analizzati seguendo uno
schema concettuale volto a scomporre l’evento in tutte le sue principali componenti sociali18. L’importanza di questo breve, pionieristico lavoro appare a più livelli e non consiste tanto nei risultati specifici relativi al caso Halifax, quanto nel metodo d’indagine e nelle
strategie interpretative utilizzate. Innanzitutto si tratta di uno studio
per il quale il valore della ricerca empirica (diremmo dell’«osservazione partecipante») – che contribuisce a renderlo originale e innovativo – è esplicitamente dichiarato:
La ricerca affronta lo studio dello shock e della disintegrazione sociale così come l’autore li ha osservati. Vengono poi esaminate, alla luce della teoria sociale, le reazioni individuali e di gruppo. [...] I capitoli sull’or-
15
La tesi è pubblicata dalla Columbia University Press (Faculty of Political
Science), serie Studies in History, Economics and Public Law, volume XCIV, numero 1, 1920.
16 Cfr. Jonas 1970, pp. 631 sgg. e Martindale 1968, pp. 120 sgg. e 269 sgg.
17
Fra le opere principali di Giddings dobbiamo ricordare i volumi Studies in
The Theory of Human Society (1922) e The Scientific Study of Human Society (1924).
William Graham Sumner formulò in modo articolato il concetto di «etnocentrismo» nel suo Folkways (Ginn, Boston 1906, trad. it. Costumi di gruppo, Edizioni di
Comunità, Milano 1962). Nel 1895, Albion Woodbury Small fondò l’«American
Journal of Sociology» e, dieci anni dopo, ebbe un ruolo importante nell’istituzione
dell’American Sociological Society.
18
«L’idea di questo lavoro mi è stata proposta mentre effettuavo, sotto la supervisione del prof. F.H. Giddings della Columbia University, uno studio di comunità
nella città disastrata. [...] Nella preparazione di questo lavoro – che l’autore ritiene
essere il primo tentativo di presentare un’analisi scientifica puramente sociologica di
un grande disastro – egli ha ricevuto una preziosa assistenza. Alcune righe di ringraziamento esprimono in modo certo inadeguato la gratitudine ai professori del Dipartimento di Sociologia. Al prof. F.H. Giddings il volume deve la propria ispirazione e gran parte della filosofia sociale che vi è contenuta» (Prince 1920, p. 7). L’impianto della tesi, che affiora chiaramente già dall’indice, è il seguente: Catastrofe e
disintegrazione sociale (cap. I), Catastrofe e psicologia sociale (cap. II), Catastrofe e
organizzazione sociale (capp. III e IV), Catastrofe ed economia sociale (cap. V), Catastrofe e legislazione sociale (cap. VI), Catastrofe e surplus sociale (cap. VII), Catastrofe e mutamento sociale (cap. VIII), Conclusioni (cap. IX).
20
21
ganizzazione sociale sono uno sforzo di inquadrare quel processo così come è effettivamente accaduto (Prince 1920, p. 7).
dall’esterno dei gruppi – come ad esempio gli incidenti e gli eventi drammatici (Prince 1920, p. 15).
In secondo luogo, per la prima volta si conferisce una legittimazione scientifica all’assunzione di un disastro come oggetto di studio
per le scienze sociali: la catastrofe viene trattata non solo come evento che pone problemi pratici e applicativi (gestione dei soccorsi, miglioramenti tecnici nelle procedure di emergenza ecc.), ma soprattutto come una situazione sociale complessa la cui interpretazione
chiama in causa questioni teoriche più generali sulla natura e il funzionamento dei sistemi sociali:
Con l’espressione mutamento sociale ci si riferisce a quei rapidi cambiamenti che accompagnano improvvise interferenze nell’equilibrio di
una società, che rompono lo status quo, dissipano l’inerzia mentale e ribaltano le tendenze a resistere ai mutamenti strutturali. Le forze di vario
tipo che producono il disordine sono fattori di mutamento sociale. Questi fattori possono essere intra-sociali – interni ai gruppi – come quelli che
operano nei regolari processi, ad esempio di imitazione o adattamento;
oppure possono essere extra-sociali, fattori «stimolo» – che provengono
Come vedremo, il tema dell’analisi antropologica dei processi di
mutamento sociale è presente in gran parte della letteratura recente.
La questione del rapporto fra catastrofe e mutamento, così chiaramente individuata nella ricerca di Prince già nel 1920, si pone in modo cruciale. Da un canto, il disastro produce infatti una trasformazione profonda nell’organizzazione sociale (e fisico-spaziale) della comunità colpita, che deve attraversare un periodo di dis-integrazione
per poi riorganizzarsi e integrarsi in un ordine nuovo volto a ricreare
la «normalità». Dall’altro canto, il livello di vulnerabilità a un dato genere di catastrofe è determinato in larga misura proprio da fenomeni
di mutamento sociale non correttamente pianificato, attivati da errori
o sottovalutazioni, riguardanti: a) progetti rivolti espressamente alla
prevenzione dei disastri naturali o tecnologici (rilocazioni di comunità, abbattimento di insediamenti tradizionali e ricostruzione di abitazioni secondo norme di sicurezza, ecc.); oppure, b) progetti di cooperazione allo sviluppo che possono non essere in relazione diretta con
il disastro, e che talvolta si rivelano inefficaci o addirittura dannosi.
Riguardo a molti grandi disastri, il dibattito su quali tipi di mutamento sociale si fossero prodotti, sul grado della loro radicalità e rapidità, è stato spesso intenso. È indispensabile ricordare, seppur brevemente, il ricco e dettagliato volume di Raymond Firth, Social Change in Tikopia. Re-Study of a Polynesian Community after a Generation,
che analizza i processi di cambiamento socio-economico verificatisi
nell’isola di Tikopia (Salomone) a seguito del tremendo uragano che
nel 1952 aveva drasticamente ridotto le fonti di sostentamento, costringendo la comunità, e in particolare il sistema economico isolano,
a riorganizzarsi e a riadattarsi di fronte all’emergenza, ma anche a seguito delle influenze del mercato esterno e della modernizzazione tecnica. Ne risulta uno studio assai articolato nel quale Firth prende in
considerazione le trasformazioni della società a Tikopia osservandone molteplici aspetti: il periodo della fame post-uragano, gli effetti sociali dell’insicurezza alimentare, i mutamenti nei diritti sulla terra e
nei modelli di residenza e matrimonio, nella struttura e funzione dei
gruppi di discendenza, nel sistema politico, e così via20.
19 Testualmente: «An event producing a subversion of the order or system of
things [...] may or may not be a cause of misery to man».
20 Si veda Firth 1959. Firth svolse il suo primo periodo di ricerca a Tikopia nel
1928-29, e vi ritornò nel 1953, ventiquattro anni dopo, per produrre, con dichia-
22
23
Questa monografia non è in alcun modo una ricerca sulle procedure
di soccorso. Il suo contributo principale alla letteratura in merito è relativo allo studio della prevedibilità dei movimenti sociali nelle grandi
emergenze. Questo libro non è nemmeno una storia del disastro. Esso è
piuttosto – come indica il titolo – uno studio intensivo di due ordini sociali fra i quali si colloca una grande catastrofe, e la sua tesi concerne il
ruolo svolto da un disastro nei fenomeni di mutamento sociale (Prince
1920, p. 7).
Quello delle dinamiche di mutamento della struttura sociale, innescate dalle crisi estreme, appare immediatamente come il tema
centrale e addirittura costitutivo della nozione stessa di disastro che
Prince si impegna a formulare. Secondo questa nozione un disastro
è «un evento che produce una sovversione dell’ordine o del sistema
di cose» e che «può, o può non essere, causa di miseria per l’uomo»
(Prince 1920, p. 14)19. Di conseguenza anche la nozione di mutamento sociale (social change) deve essere propriamente ridefinita:
Uno dei casi forse più noti di profondo mutamento sociale indotto da un disastro è quello della regione asiatica del Pakistan orientale
che, a seguito di un’insurrezione nazionale appoggiata dall’India dopo il tremendo ciclone tropicale che colpì l’area nel 1970, conquistò
l’indipendenza con il nome di Bangladesh. In quel disastro, nella notte fra il 12 e il 13 novembre 1970, persero la vita circa 500.000 persone e i danni economici furono ingenti: l’acquedotto, reso inutilizzabile per settimane, non consentì l’approvvigionamento di acqua potabile per più di un milione di persone, facendo temere l’esplosione
di epidemie di tifo e colera per il rapido peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie; il 75% del raccolto di riso andò perduto, e tutti i porti della costa furono seriamente danneggiati. Dopo alcuni giorni dal passaggio del ciclone, grazie all’intervento della Croce Rossa Internazionale, della Marina Inglese e di varie organizzazioni umanitarie, giunsero i primi aiuti con viveri, medicinali e indumenti. Il governo pakistano sembrò invece operare con una certa approssimazione
e lentezza, dovute probabilmente alla complessa situazione etnica e
politica interna. Qualche settimana dopo il disastro, l’etnia bengalese che viveva nel Pakistan orientale, esasperata dalla tragica situazione, insorse contro il governo centrale con violente proteste di piazza,
che nel marzo 1971 degenerarono in una vera guerra civile da cui nacque lo Stato indipendente del Bangladesh21.
In Cina, i terremoti rappresentano tradizionalmente il presagio di
imminenti rivoluzioni politiche. Sono il segno che è scaduto il mandato celeste per la dinastia al potere, e che dunque essa sarà presto
rovesciata. La morte di Mao Zedong – avvenuta per coincidenza appena sei settimane dopo il grande terremoto di Tangshan – parve
confermare la fondatezza di queste credenze tradizionali. La nazione cinese entrava di colpo in una nuova era22. Per quasi tre anni vi
rati intenti comparativi, quest’opera fra le più riuscite del genere «re-study». Si veda il suo ormai classico We, the Tikopia, Beacon Press, Boston 1963, con introduzione di Bronislaw Malinowski (Firth 1976).
21
Un quadro accurato del problema delle alluvioni in Bangladesh è in Alexander 2000, pp. 239-250.
22
Durante la notte del 28 luglio 1976, alle 3.45, un violentissimo sisma di intensità fra 7,8 e 8,2 gradi Richter scosse la città di Tangshan, a 160 chilometri a nord
di Pechino, densamente popolata per le numerose industrie di estrazione del carbone e di produzione dell’energia elettrica. Soltanto 23 secondi furono sufficienti
a provocare 242.000 vittime. Su questo disastro si veda lo straordinario resoconto
in molti sensi «etnografico» (su cui torneremo più avanti) realizzato da uno dei
24
furono aspre polemiche in seno al governo sulla scelta di ricostruire
la città esattamente dov’era, in una zona così soggetta ai terremoti,
finché nel 1979 si decise di far risorgere Tangshan nel luogo originale; e sebbene oggi sia sorta dalle macerie una nuova metropoli meno vulnerabile ai terremoti, la città e i suoi abitanti recano ancora le
cicatrici fisiche e psichiche di quei terribili 23 secondi del 1976.
Il dibattito degli studiosi sul rapporto fra catastrofe e mutamento sociale si è sviluppato anche in merito ai disastri tecnologici (manmade), come ad esempio l’incidente nucleare di Černobyl’:
È stata una cosa anche simbolica, perché si vedeva che il paese stava
per crollare, ci voleva qualche colpo di grazia e allora... questo sicuramente lo è stato [...]. E dopo i paesi baltici, subito, tutti quanti, nel ’91
ormai l’Unione si era disgregata. Quindi è stato Vilnius, e poi il golpe del
’91: i tre stadi della caduta dell’Impero23.
Nel contesto di una situazione politica complessiva – resa già incandescente dalle manifestazioni nella città lituana di Vilnius e, successivamente, dai colpi di stato che portarono molte repubbliche
all’indipendenza – il disastro di Černobyl’ assunse indubbiamente
una considerevole importanza simbolica nel crollo dell’Unione Sovietica, in quanto contribuì a mostrare in modo eclatante e doloroso i guasti di un regime politico totalitario, che aveva smentito gli slogan propagandistici per un’energia pulita, economica e fonte di benessere per tutti, non riuscendo a garantire né il diritto di vivere in
un ambiente sicuro, né – soprattutto – quello di potersi avvalere di
un sistema sanitario efficiente e adeguato per far fronte alle emergenze (Gould 1990). Una catastrofe può dunque essere il fattore di
stimolo determinante per il mutamento sociale, in forme dirette e
indirette: predisponendo le condizioni ambientali al cambiamento,
alterando o arrestando temporaneamente il flusso delle consuetudini normali, riconfigurando le istituzioni, esasperando o rendenmaggiori giornalisti e intellettuali cinesi contemporanei, Qian Gang, nel suo The
Great China Earthquake (Tangshan da dizhen), Foreign Languages Press, Pechino
1989 (in inglese, ed. or. cinese del 1986); cfr. anche Cheng, Kam-ling, Chen 1988;
Freeberne 1962.
23
Cit. in E. Geremia, Il «Vij atomico»: antropologia del rischio nel disastro di
Černobyl’, tesi di laurea non pubblicata, Università di Venezia Ca’ Foscari, prof. G.
Ligi, a.a. 2003-2004, p. 48; testo integrale dell’intervista a Ksenya Konstantinenko,
pp. 80-96.
25
do manifeste tensioni latenti, conflitti economici e sociali o dissensi
politici.
Come si è visto, il lavoro di Samuel Henry Prince, Catastrophe and
Social Change, basato sull’analisi del disastro di Halifax, è considerato unanimemente il testo fondativo per lo studio dei disastri da un
punto di vista socio-antropologico. Significativamente molti dei suoi
temi principali vennero ripresi e notevolmente ampliati, alcuni anni
dopo, dal sociologo americano di origine russa Pitirim Sorokin, che
nel 1942 pubblicò il volume divenuto poi il secondo grande classico
del campo: Man and Society in Calamity24. Lo studio di Sorokin è teoricamente più vasto e articolato rispetto a quello di Prince e prende in
considerazione diversi altri aspetti oltre al mutamento sociale:
Noi viviamo in un’epoca di grandi calamità. [...] Ancora esse influenzano in ogni momento la nostra esistenza: la mentalità e il comportamento, la vita sociale e i processi culturali [...]. Questo libro tenta di studiare gli effetti che le calamità producono sui processi mentali, sul comportamento, l’organizzazione sociale e la vita culturale delle popolazioni
colpite25.
Sin dall’introduzione, Sorokin afferma chiaramente che lo scopo
prioritario e l’importanza dello studio delle calamità26 consistono
nel tentativo di produrre delle tipizzazioni riguardo agli effetti, vale
a dire di focalizzare l’analisi sugli effetti che si possono considerare
comuni o «tipici» di ogni catastrofe. In ciò egli intende giungere alle
ve: e cioè il fatto che analizzare gli effetti di un disastro su un sistema sociale significa analizzare indirettamente la natura stessa dei
sistemi sociali, le loro dinamiche interne, i loro processi costitutivi
e disgregativi. Questo approccio condurrà a quella profonda riformulazione del problema che abbiamo delineato nel paragrafo 1: non
più ricerche sugli «effetti di un disastro su una comunità» (paradigma tecnocentrico), ma ricerche sugli «effetti di un agente distruttivo
che impatta con un sistema sociale vulnerabile» producendo un disastro, vale a dire uno sconvolgimento profondo dell’organizzazione sociale e del sistema nativo di significati (paradigma socio-antropologico).
Nonostante abbia dato questo rilevante contributo teorico, purtroppo Sorokin mostra – forse più di Prince – di riporre un’eccessiva fiducia epistemologica nel potere della generalizzazione, derivato
a sua volta da quello delle analisi comparative. Le possibilità e i limiti della comparazione (sebbene indispensabile per le scienze sociali) apparvero chiari nell’arco di qualche decennio sia in sociologia
sia (soprattutto) in antropologia.
4 Che cos’è un disastro?
Le molte anime di un dibattito interdisciplinare
24
Si veda Sorokin 1942. Il seminale lavoro di Prince viene citato direttamente
più volte (pp.168-173) in particolare nel capitolo X, How calamities affect the religious and ethical life of society, pp. 161-194. Sorokin fu professore di sociologia presso la Harvard University e diede fondamentali contributi teorici sul tema della mobilità sociale nel quadro della sociologia funzionalista americana (Sorokin 1965).
25
Sorokin 1942, p. 9.
26 Sorokin utilizza sempre il termine calamity e non disaster, e lo estende alle
guerre, alla fame, alle pestilenze e alle rivoluzioni.
Come abbiamo visto, la profonda svolta concettuale che le scienze
sociali hanno impresso alle ricerche di impianto tecnocentrico consiste soprattutto nell’aver separato la nozione di «agente di impatto»
da quella di «disastro». Questa impostazione considera l’agente di
impatto nei termini di un evento essenzialmente fisico (che può essere «naturale»: ad esempio un sisma, o un’inondazone; oppure «tecnologico»: come un incidente in una centrale nucleare o in un’industria chimica); mentre applica il concetto di disastro per definire il
tipo e il grado di mutamento o di disgregazione sociale (ad esempio
l’interruzione delle normali catene decisionali, l’instaurarsi di conflitti di ruolo ecc.) che è spesso prodotto dall’impatto di un agente
distruttivo su una comunità umana colta in condizioni di vulnerabilità (McLuckie 1975). Osservati secondo questa prospettiva, i disastri sono dunque essenzialmente dei fenomeni sociali. Ma che caratteristiche hanno? A partire dai precursori illustri – Samuel Henry
Prince e Pitirim Sorokin – come si è svolto storicamente questo processo di riformulazione critica della nozione di disastro? Quali discipline, fra le scienze sociali, vi hanno maggiormente contribuito?
26
27
più ampie generalizzazioni induttive della scienza sociale, gettando una
luce considerevole sui mutamenti basilari nella struttura e nella mobilità
sociale. [...] Qui la sociologia delle calamità diventa sociologia generale e
anche filosofia induttivista della storia (Sorokin 1942, p. 10).
Probabilmente il maggior merito di Sorokin è quello di aver colto un punto teorico che diverrà essenziale nelle ricerche successi-
In che modo le nozioni socio-antrologiche possono dialogare e integrarsi proficuamente con i modelli tecnocentrici?
È bene dire subito che la molteplicità e la diversità degli approcci nei quali si articola l’impostazione socio-antropologica sono un
sintomo interessante della complessità del tema, ma soprattutto sono un buon segno della vitalità di questo campo di studi. Tuttavia
non ritengo utile proporne qui un quadro completo e dettagliato27,
mentre credo sia più significativo delineare il processo di costruzione di una prospettiva marcatamente socio-antropologica commentando alcune importanti definizioni di disastro, enunciate in successione cronologica, che hanno contribuito a caratterizzare i principali approcci teorici che oggi animano il dibattito.
Dovendo ricorrere a una sintesi preliminare estremamente schematica, concordo con Elisa Bianchi28, secondo cui tutte le impostazioni di natura «non tecnocentrica» possono essere raggruppate in
tre grandi filoni: a) l’approccio sociologico (il primo, storicamente,
ad essere stato utilizzato dai «padri fondatori», Prince e Sorokin, e
in seguito potenziato e raffinato in particolare dalle ricerche di Enrico Quarantelli con la nascita, nel 1963, del Disaster Research Center (DRC) dell’Università del Delaware); b) l’approccio geografico,
sviluppato all’Institute of Behavioral Science di Boulder in Colorado, soprattutto ad opera di Gilbert White, l’ispiratore della cosiddetta Scuola ecologica di Boulder; c) l’approccio più marcatamente antropologico, con i lavori di William Torry e Anthony OliverSmith. Quest’ultimo ramo di ricerca affonda le radici negli studi pionieristici di Anthony Wallace29 e si basa, più o meno esplicitamente,
sull’assetto espistemologico della teoria culturale del rischio elaborata da Mary Douglas e Aaron Wildavsky, di cui ci occuperemo diffusamente nel prossimo capitolo.
Se la tripartizione appena proposta è utile per un preliminare inquadramento degli studi, essa non dovrebbe però indurre a schematizzazioni troppo rigide. È cioè indispensabile prestare attenzio-
ne affinché l’intento di sottolineare l’originalità e la peculiarità dei
contributi specifici forniti da ciascuna disciplina non produca una
visione astrattamente frammentata. Piuttosto che stabilire con accuratezza chirurgica quanto vi sia di sociologico oppure di antropologico, o di geografico, in questa o in quella definizione di disastro, è
assai più fruttuoso rilevare i motivi di fecondazione reciproca e l’interconnessione fra approcci30.
Durante i primi anni Cinquanta, nel decennio successivo al lavoro di Pitirim Sorokin, l’amministrazione militare statunitense finanziò studi sulla possibile reazione della popolazione civile a un attacco atomico diretto. Venne così fondato all’Università di Chicago il
NORC – National Opinion Research Center –, che sviluppò ricerche
su disastri naturali in tempo di pace, con la speranza di estrapolare
risultati applicabili a potenziali situazioni belliche. In questo contesto si colloca il contributo di Charles Fritz, importante sotto il profilo antropologico perché presenta una serie di interessanti caratteristiche operative che diverranno poi tipiche nelle ricerche statunitensi sui disastri (Fritz, Marks 1954), e cioè: l’invio di équipe sul luogo del disastro durante l’emergenza; l’impiego di tecniche di indagine qualitativa per la raccolta dei dati (come le interviste libere o semi-strutturate), un metodo di interazione costante diretta con gli
attori sociali coinvolti, definibile nei termini antropologici classici di
«osservazione partecipante», e la raccolta di ampia documentazione31. Anche in seguito, nella seconda metà degli anni Cinquanta,
quando fu iniziato un programma esteso di ricerca senza più il so-
27
Si vedano ad esempio: Alexander 1991a, 1991b, 1997; Oliver-Smith 1996,
1999; Quarantelli 1998.
28
Si veda Bianchi 1993a, intervento al Convegno internazionale Eventi naturali oggi. La geografia e le altre discipline, organizzato dall’Istituto di Geografia umana dell’Università Statale di Milano (19-20 novembre 1991).
29
Wallace studiò molteplici aspetti socio-antropologici della reazione della comunità al tornado che colpì Worcester (seconda città del Massachussets, USA) il 9
giugno del 1953, causando la morte di 94 persone (Wallace 1956a, 1956b, 1956c).
30
Non mi convince ad esempio l’utilità dell’ulteriore classificazione e frammentazione proposta da David Alexander, che in aggiunta alle tre prospettive già citate
per l’ambito socio-antropologico e alla quarta per quello tecnocentrico (che comprende tutte le discipline di impianto fisico-ingegneristico) ne individua altre due: la
prospettiva che concentra l’analisi sui casi di catastrofe nei paesi in via di sviluppo e
quella più recente di orientamento medico ed epidemiologico, che prende in considerazione le modalità di organizzare i soccorsi nelle emergenze di massa. Come giustamente rileva Elisa Bianchi, entrambi questi approcci non hanno sviluppato un’impostazione epistemologica e teorica nuova, ma si inscrivono in prospettive già esistenti e producono lavori di carattere alquanto tecnico e gestionale. Alexander ha
utilizzato anche una classificazione differente, che distingue fra approccio geografico, sociologico, tecnico, e ricerche nel Terzo Mondo, ma ignora completamente il
contributo dell’antropologia culturale (Alexander 1991a, 1991b, 1993).
31
Un ottimo esempio recente di questo metodo di ricerca diretta sul campo,
durante la crisi o nelle fasi immediatamente successive, è il celebre lavoro di Robert
Geipel sul terremoto del Friuli (Geipel 1979).
28
29
stegno finanziario militare, l’orientamento prevalente rimase di tipo
socio-psicologico, attento ai nessi fra la dimensione psicologica, e
comportamentale, e le caratteristiche del sistema sociale colpito, sulla base dell’analisi di una serie molto ampia di studi su casi singoli32.
A Charles Fritz dobbiamo il primo tentativo organico di sistematizzare le conoscenze acquisite sugli aspetti sociali del comportamento
in caso di disastro. Egli ha inoltre l’indiscusso merito di aver elaborato una serie di osservazioni critiche sugli stereotipi riguardanti le
vittime di un disastro. Dalle sue ricerche emerge che non sempre e
non necessariamente le persone cadono in preda al panico o subiscono traumi psicologici violenti o «shock da disastro», e neppure si
comportano in modo irrazionale. Secondo Fritz la rapida ed elevata
concentrazione sul luogo del disastro di materiali, informazioni e individui – per lo più esterni ed estranei alla comunità colpita – pone
talvolta problemi organizzativi e interpretativi assai più seri di quelli derivanti dall’assenza di tali risorse. In determinate circostanze,
inoltre, gli eventi estremi sembrano in grado di creare una sorta di
«comunità terapeutica» o sistema di sostegno sociale che può produrre effetti benefici per i sopravvissuti. L’inclinazione a porre l’accento sulle reazioni psicologiche individuali nell’evenienza disastrosa in relazione al sistema sociale, se da un lato rappresenta una vistosa differenza di prospettiva rispetto alle analisi tecnocentriche,
può però, dall’altro, risultare distante anche dall’orientamento più
segnatamente antropologico. In realtà, come vedremo, è anche grazie all’humus culturale costituito da queste prime esperienze di ricerca che gradualmente emergerà il principale approccio contemporaneo in antropologia dei disastri: ovvero quello che studia i modelli a «razionalità multiple» nella percezione differenziata del rischio, collegando variabili psicologiche a variabili socio-culturali.
Fu soprattutto Allen H. Barton che, sulla base del ricco inventario
descrittivo delle conoscenze acquisite – elaborato da Fritz e dai ricercatori del NORC –, si impegnò nello sforzo di realizzare un maggior livello di codificazione teorica, tentando – senza peraltro riuscirvi completamente – di integrare i risultati in un quadro complessivo unico33.
Barton definisce «disastro» una «situazione di stress collettivo» («a
collective stress situation»), che si verifica quando la maggior parte
dei membri di una comunità ritiene di non trovarsi più in quelle condizioni di vita che si aspetta vengano garantite dal normale funzionamento del sistema sociale. Queste «condizioni di vita» («conditions
of life») includono: la sicurezza dell’ambiente fisico, la protezione da
attacchi armati, l’approvvigionamento di cibo, la possibilità di disporre liberamente delle proprie abitazioni e di adeguate risorse economiche, e – sul piano simbolico generale – la permanenza di una costellazione stabile di significati, indispensabili per comprendere le
informazioni e coordinare le pratiche sociali quotidiane (Barton
1969, pp. 37-39). Sul piano più strettamente metodologico, Barton
pone il problema dell’uniformità dei dati da comparare nel confronto fra disastri, sia dal punto di vista delle caratteristiche complessive
dell’evento critico (anche quelle di tipo fisico), sia da quello di esperienze e reazioni individuali differenti in diverse comunità colpite, costruendo un’interessante rete di ipotesi di lavoro per future ricerche:
ad esempio sulla possibilità di insorgenza di conflitti di ruolo, oppure sui fattori che influenzano la mobilizzazione organizzativa.
Nel 1974 Michael Barkun elabora una definizione di disastro che
riprende il concetto di Barton ma lo estende in una direzione innovativa:
Con il termine disastro intendiamo la distruzione grave, relativamente improvvisa e frequentemente imprevista, della struttura organizzativa
normale di un sistema sociale, provocata da una forza «naturale» o «sociale», «interna» al sistema o «esterna» ad esso, su cui il sistema stesso
non ha completo «controllo» (Barkun 1974, p. 51).
32
Ad esempio i risultati delle ricerche di Fritz e Marks si basavano su mille interviste a persone coinvolte in circa settanta tipi diversi di disastro.
33 Si veda il classico Barton 1969; e cfr. Baker, Chapman 1962; Dynes 1974.
Le tre coordinate frequentemente utilizzate per definire l’evento
fisico disastroso secondo l’impostazione tecnocentrica classica – ovvero la sua gravità, repentinità e imprevedibilità – vengono qui applicate invece per descrivere il mutamento subito dalla struttura organizzativa normale di un sistema sociale. Il tentativo di connotarne
le cause è esplicitamente problematizzato con l’uso delle virgolette
che segnalano subito l’ambiguità di questi aggettivi (forza «naturale» o «sociale», «interna» o «esterna» al sistema), fino ad allora assunti – per Barkun – in modo acritico. È altresì posta in evidenza la
tematica del «controllo» (fisico, organizzativo, cognitivo) dell’evento estremo da parte della comunità, e introdotto implicitamente il tema chiave della vulnerabilità. In un contributo di poco successivo
(1977), Barkun si affianca alle posizioni prevalenti fra i geografi cul-
30
31
turali come Burton e Hewitt – per i quali i parametri essenziali nel
quadro tecnocentrico (come la magnitudo), impiegati per stabilire la
gravità di un disastro e l’entità del danno, non sono di per se stessi
significativi – e accentua in senso nettamente costruzionista la prospettiva socio-antropologica delle proprie ricerche:
Il «disastro» è un costrutto mentale imposto all’esperienza. Non è sufficiente conoscere il numero di morti, il valore economico delle proprietà
distrutte o la riduzione dei redditi pro capite. La componente simbolica
richiede la comprensione del senso di vulnerabilità, dell’adeguatezza delle spiegazioni disponibili e delle rappresentazioni che una società ha della morte e della distruzione (Barkun 1977, p. 221).
Come vedremo, negli anni Ottanta, in una prospettiva ancor più
marcatamente antropologica, sarà Mary Douglas a sottolineare l’importanza che le concezioni cosmologiche, i valori morali, gli orientamenti simbolici e religiosi hanno nel determinare una data rappresentazione sociale della realtà, in modo tale che venga percepita
come più o meno pericolosa. Il concetto di percezione del rischio entrerà stabilmente nel dibattito fra realisti e costruzionisti, affermando l’idea che il rischio non debba essere considerato come un «oggetto naturale» (o una caratteristica in qualche senso oggettiva della
realtà e dei fenomeni fisici), ma piuttosto come un «costrutto sociale» derivante da sofisticati processi politico-istituzionali.
5. Le coordinate sociali di un disastro
Gli studi di Allen H. Barton sono stati il punto di partenza della maggiore istituzione statunitense per la ricerca sui disastri secondo l’ottica delle scienze sociali: il Disaster Research Center (DRC), fondato
nel 1963 alla Ohio State University da Enrico Quarantelli con la collaborazione di Russell R. Dynes e J. Eugene Haas, che si diedero come primo obiettivo quello di riesaminare tutti i casi di studio utilizzati da Barton, concentrando l’analisi in particolare sulle risposte organizzative34. Sin dal primo periodo della sua fondazione, il DRC im-
presse un forte impulso alle ricerche in questo campo, formando vari gruppi di lavoro sui molteplici aspetti delle emergenze di massa.
Essendo operativo ininterrottamente da più di quarant’anni, il DRC
ha inoltre realizzato un imponente database sui disastri, e istituito
una vastissima biblioteca specializzata. Incentivando un gran numero di progetti di ricerca e addottorando, negli anni, centinaia di studenti provenienti da molte parti del mondo, il Centro è via via diventato il nodo principale di una rete scientifica internazionale sempre più estesa35.
Possiamo ricavare un’ottima sintesi dell’impostazione teorica e
problematica del DRC riproponendo la definizione di disastro di
Quarantelli e Wenger (già vista nel paragrafo 1), ed esaminadola ora
in dettaglio:
I disastri sono eventi sociali, osservabili nel tempo e nello spazio, in
cui entità sociali (dalle società fino a subunità minori come le comunità)
subiscono uno sconvolgimento delle loro attività sociali quotidiane, come risultato di un impatto effettivo o di una percezione di minaccia a causa dell’apparire relativamente improvviso di agenti naturali e/o tecnologici, che non possono essere controllati direttamente e completamente
dalla conoscenza sociale esistente. Pertanto un terremoto o un’esplosione chimica non possono essere considerati disastri, dal punto di vista sociologico, se non accompagnati da tutte le caratteristiche suddette.
Vi sono almeno cinque coordinate concettualmente rilevanti in
questo modo di intendere un disastro:
1) Innanzitutto Quarantelli e Wenger pongono subito in apertura la definizione netta e stringente secondo cui «i disastri sono eventi sociali» e non quindi fenomeni fisici (terremoti, alluvioni, incidenti
nucleari ecc.) come comunemente si ritiene. Questo assunto di partenza è teoricamente molto rilevante, perché concepire i disastri in
termini di «eventi sociali» significa di fatto assimilarli a tutti gli altri
eventi sociali dei quali si occupano di norma gli antropologi, cioè
renderli essenzialmente simili ai matrimoni, ai riti di intronizzazione
o iniziazione, alle grandi cerimonie funebri, alle elezioni politiche o
Nel 1984 il Centro si è trasferito presso l’Università del Delaware e al suo
staff si è aggiunto Dennis Wenger. Attualmente le ricerche sono focalizzate soprattutto su situazioni critiche provocate da contaminazioni ambientali chimiche
con elementi a elevata tossicità.
35
Vorrei segnalare anche alcune importanti esperienze di ricerca italiane, come quella dell’Istituto di Sociologia internazionale di Gorizia (Isig), in particolare
il Programma emergenze di massa; e quella del Master universitario in «Interventi
relazionali in contesti di emergenze di massa», in collaborazione con l’Università
Cattolica di Milano (Castelli, Sbattella 2003).
32
33
34
alle manifestazioni pubbliche. Si tratta cioè di accadimenti o fatti che
non solo coinvolgono le persone passivamente, ma vengono in qualche modo posti in essere attivamente, ovvero costruiti dalle «società
fino a subunità minori come le comunità» mediante pratiche e processi di interazione sociale che si svolgono su scala individuale, familiare, comunitaria, e contemporaneamente su più livelli: simbolico, politico, religioso, rituale, istituzionale ecc. Ciò estende l’orizzonte dell’analisi – almeno in via preliminare come ipotesi di ricerca
– dalla prospettiva tecnocentrica dei fisici, dei geologi, dei sismologi, ai territori (fino ad allora quasi inesplorati) dell’indagine socioantropologica, che diviene applicabile alle emergenze di massa.
2) Per Quarantelli e Wenger, le prime due coordinate, tutt’altro
che banali, da utilizzare per descrivere questo particolare tipo di
evento sociale, cioè il disastro, sono la sua «osservabilità» nel tempo
e nello spazio. Tenendo presente anche altri importanti contributi di
Quarantelli36, per «osservabilità» non si intende qui solo l’evidenza
fisica osservativa del fatto, ma anche la possibilità di studiarlo dal
punto di vista di come esso si manifesta nel corso del tempo, seguendo una sua propria «cronologia interna», e di come effettivamente si presenta nello spazio territoriale, geografico37.
A) Tempo. Sottolineare la dimensione tempo, significa introdurre il fondamentale principio della «processualità»38. In molti casi il
disastro non solo è un «evento» (in senso stretto un accadimento che
si verifica in modo istantaneo e repentino, qui e ora) ma anche un
«processo», ovvero un evento che risulta scomponibile in una catena assai lunga di micro-eventi estesi nel tempo e fra loro causalmente interconnessi. A disastri deflagranti, rapidi e improvvisi, si contrappongono disastri silenziosi, lenti e graduali39. La dimensione
tempo è estremamente rilevante anche dal punto di vista soggettivo
e interiore delle persone. Il disastro viene percepito e rappresentato
(talvolta anche descritto nei narrati di sofferenza delle vittime) come
ferita cronologica non più rimarginabile che taglia in due le storie di
vita, la memoria individuale e quella della comunità: la storia locale
e il flusso di ricordi personali si riorientano a partire dal «prima» e
dal «dopo» l’evento catastrofico.
B) Spazio. Considerare la variabile spazio significa tener conto del
fatto che uno stesso disastro può manifestarsi in modi diversi in differenti luoghi di un continuum territoriale. Pensiamo ad esempio ai
diversi effetti sociali prodotti dall’impatto del fronte d’onda di un medesimo tsunami in diversi punti abitati di un litorale; oppure – come
abbiamo visto nel primo capitolo – agli effetti di fall-out negli incidenti nucleari, per cui nel caso di Černobyl’, paradossalmente, alcune zone della Lapponia, nel nord della penisola scandinava, sono
risultate molto più contaminate dal Cesio-137 che la periferia urbana
di Kiev. La cesura spaziale causata dalla catastrofe nella vita quotidiana delle vittime si manifesta in un più doloroso uso dei deittici: nel
qui di dove ci si trova ora (nell’esperienza traumatica degli sfollati, dei
rilocati, degli assegnatari di tende da campo o di strutture abitative
prefabbricate temporanee, ma spesso «permanentemente» temporanee) e nel là dell’evento critico, dell’epicentro della catastrofe, che è
anche il là della vera casa, del luogo di nascita, del paesaggio architettonico, naturale e affettivo della quotidianità di una vita, forse perduto per sempre. Il raggio e la profondità di queste rappresentazioni
spaziali variano in modo consistente in rapporto al tipo di disastro, ai
danni fisici subiti, alla conformazione del territorio, alle caratteristiche antropologiche e socio-economiche della comunità colpita.
3) Un altro punto essenziale è che l’evento sociale «disastro», costituito in sostanza dallo sconvolgimento delle attività sociali quotidiane a seguito di un impatto effettivo di agenti naturali e/o tecnologici, può anche determinarsi a seguito di una «percezione di minaccia» causata dall’apparire improvviso o imprevisto di tali agenti potenzialmenti distruttivi. Dunque la semplice percezione di minaccia
Fra la vastissima bibliografia di Quarantelli si vedano ad esempio la preziosa raccolta di saggi da lui curata: Quarantelli 1978, e Quarantelli 1995; e, sempre
su questioni teoriche e definitorie, la più ampia raccolta di saggi Quarantelli 1998.
37
Una preziosa, ma sintetica, analisi del rapporto spazio-tempo nei disastri è in
Alexander 1993.
38
L’idea di «processualità» nell’analisi dei disastri è stata sviluppata in modo
assai efficace da Barry Turner (Turner, Pidgeon 2001).
39
In generale, qualunque evento può essere visto come il prodotto di una sterminata catena di altri eventi fra loro connessi e correlati. Anche un disastro che si presenta all’improvviso può essere considerato come prodotto finale, culminante, di
svariate serie causali. Qui però si vuole sottolineare una differenza, di cui tener conto nell’analisi, fra le forme di mutamento e reazione sociale che compaiono istanta-
nemente, ad esempio con un terremoto, e quelle invece che affiorano quando una comunità apprende di essere stata esposta per anni a un’impercettibile e gravissima
contaminazione ambientale (come nel caso di Love-Canal di cui tratteremo in seguito).
34
35
36
può essere socialmente dirompente tanto quanto un impatto reale.
Quarantelli e Wenger hanno posto qui il problema (diventato oggi fra
quelli più teoricamente rilevanti in prospettiva socio-antropologica)
del disastro come costruzione sociale della realtà, come «discorso» in
senso foucaultiano, come struttura simbolica con aspetti religiosi, storici, politici, giuridici (ad esempio nel caso dell’attribuzione discrezionale di «stato di calamità naturale» a una cittadina piuttosto che a
un’altra), che è prodotta da una collettività per ordinare e conferire
senso a una data esperienza. Si tratta, come vedremo, di una forma di
«costruzionismo forte» attualmente molto in voga, e senz’altro interessante, ma a mio avviso non del tutto condivisibile.
4) Un quarto punto da sottolineare è il superamento della semplicistica categorizzazione fra «disastro naturale (natural)» e «disastro
tecnologico (man-made)»: non è il disastro di per sé a essere suscettibile di una tale differenziazione, sono piuttosto gli agenti fisici di
impatto, che inducono gravi effetti dinamici nella società, disarticolandone strutture, pratiche e istituzioni (oltre che danneggiandone
edifici, strade ecc.), che possono essere naturali o tecnologici. È meglio abbandonare del tutto la connotazione oltremodo ambigua di
evento man-made, cioè «prodotto dall’uomo» (intendendo ad esempio un incidente nucleare, come a Černobyl’, piuttosto che un’inondazione come lo tsunami del 2004 nel Sudest asiatico), e riferirsi ai
fattori non naturali denotandoli generalmente come «tecnologici»,
ovvero dipendenti dalla tecnologia umana. In altri termini, cosa è
davvero natural oppure man-made? Dobbiamo intendere il man-made come il risultato di un’azione cosciente e volontaria di uomini che
deliberatamente causano un disastro? Allora anche un omicidio di
massa, come la bomba atomica su Hiroshima, è un disastro40. Oppure ci limitiamo a considere episodi in cui l’uomo è il fattore causale
principale, ma per imperizia, per disattenzione, o per l’effetto di una
mancata coordinazione complessiva della struttura gestionale (come
ad esempio per la NASA nel disastro del Challenger)?41
40
E lo è di fatto, ma non nei termini analitici che sono stati qui adottati. È pertanto indispensabile mantenere qualche criterio che delimiti il campo d’indagine,
per non rendere del tutto inutile il termine disastro. Ad esempio non dovremmo tener conto nemmeno del numero delle vittime, o della dimensione fisica della catastrofe: anche la morte di un figlio per i genitori è un «disastro» altrettanto devastante di una bomba atomica.
41 Sul rapporto concettuale e terminologico natural/man-made (technological)
si veda la stringente analisi di Elisa Bianchi (1993a, 1993b).
36
5) Il quinto elemento che rende interessante questa definizione di
disastro è che per Quarantelli e Wenger la gravità della crisi non va
determinata in funzione dell’intensità fisica degli agenti di impatto
(insistendo sul problema di stabilirne dei criteri di misura adeguati),
ma deve essere invece studiata rispetto al fatto che tali agenti potenzialmente distruttivi «non possono essere controllati direttamente e
completamente dalla conoscenza sociale esistente». Si sposta quindi
in modo netto l’attenzione dalle scale di magnitudo e dai dispositivi
di rilevamento anticipato alla effettiva capacità della popolazione di
utilizzare tali strumenti e le informazioni da essi fornite. Come dire:
non è sufficiente il sismografo, se poi la popolazione non viene allertata in tempo, oppure se una comunità, pur essendo stata allertata, decide di non evacuare perché percepisce in modo differente la minaccia e la pericolosità (come nel caso di talune contaminazioni alimentari che non sono prese sul serio dalle persone che continuano a mangiare cibi vietati) o per motivi più strettamente «culturali», dovuti ad
esempio al senso di profondo legame – mitico, tradizionale, familiare
– con il territorio. Il punto essenziale non è più solo quello di assumere
con urgenza informazioni scientificamente adeguate sulla crisi, ma
quello di verificare se poi queste informazioni circolano, vengono recepite correttamente, risultano coordinate fra loro e non ambigue, e
se quindi le risposte sociali che ne seguono sono appropriate. In altri
termini, si parla di una significativa estensione del concetto di vulnerabilità dal mondo fisico all’universo sociale.
6. La Scuola ecologica di Boulder
Sul tema chiave di comprendere i differenti comportamenti individuali di fronte a un disastro naturale si è concentrata la ricerca dei
geografi della cosiddetta Scuola ecologica di Boulder, formatasi intorno alla figura e all’opera di Gilbert White, che nel 1974, già professore di Geografia e direttore dell’Istitute of Behavioral Science
dell’Università del Colorado a Boulder, pubblicò un importante volume intitolato Natural Hazards. Local, National, Global. Il libro, destinato a suscitare accese critiche e a diventare un classico assai influente in questo campo, è una corposa raccolta di ben trentuno studi di caso in cui si esaminano altrettanti disastri naturali42 accaduti
42
White e colleghi utilizzano il termine disastro/rischio «naturale» intendendo
37
in varie parti del mondo (dalle Hawaii alla Norvegia, dal Giappone,
al Messico, all’Australia) con l’intento di analizzare la rete di nessi
che connettono l’occorrenza di eventi naturali estremi e il comportamento delle persone coinvolte alla percezione del paesaggio, agli
interventi antropici di modificazione dell’ambiente, alla organizzazione istituzionale e alla percezione della pericolosità.
Nei suoi primi lavori, White applica gli strumenti della geografia culturale al problema di capire perché negli anni Quaranta i massicci interventi del governo americano impiegati per ridurre i danni delle piene fluviali non avevano conseguito l’effetto desiderato.
Ne scaturisce una vasta riflessione scientifica del tutto originale e
innovativa, basata su una considerazione fondamentale rimasta valida ancora oggi (e su cui – come vedremo – si innesta direttamente il contributo antropologico della teoria culturale del rischio), e
cioè la considerazione che gli interventi di prevenzione e contenimento della catastrofe risultano spesso poco efficaci nonostante il
forte impegno economico e tecnico-scientifico dei governi, delle
istituzioni preposte a forme di protezione civile, delle organizzazioni pubbliche e private di controllo e monitoraggio del territorio43.
Scrive Bianchi:
Ciò che ci interessa in particolar modo illustrare è il vivo dibattito fra
la scuola ecologica di White e l’approccio degli antropologi, dal momento che i primi impersonano il filone più consolidato della ricerca in questione, i secondi quello attualmente forse più provocatorio e stimolante
(Bianchi 1993, p. 242).
gli eventi naturali estremi, cioè i disastri prodotti con agenti di impatto di tipo
esclusivamente naturale (terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, tornado, uragani, tsunami ecc.), e nonostante ritengano che il natural setting non esista – dato
che il rischio naturale è sempre collegato all’attività dell’uomo e della società in cui
questi opera – non si impegnano però nell’esplicitare chiaramente il rapporto con
la categoria dei disastri man-made. Sull’etimologia e le varie ambiguità semantiche
del termine rischio, e delle parole inglesi disaster, risk e hazard, talvolta utilizzate
come sinonimi, si veda il prossimo capitolo. Segnalo che tematiche simili, ma sviluppate in particolare per i technological hazard, sono trattate dagli studiosi della
Clark University, importante centro di ricerca che pubblica la nota rivista «Environment».
43
A tale proposito si vedano: White 1942, 1964; su questi temi e per un inquadramento critico della riflessione sul soggettivo nella geografia della percezione, e
in particolare nella geografia nordamericana, si vedano Bianchi 1987 e 1992; per un
quadro più dettagliato delle ricerche della Scuola ecologica di White, cfr. Burton,
Kates, White 1978.
38
E la questione chiave è appunto il fatto che la risposta delle persone di fronte ai disastri/rischi naturali non corrisponde, in genere,
all’idea che di essi si fanno i tecnici in base alla loro conoscenza «oggettiva» (quella prodotta dall’approccio che abbiamo chiamato «tecnocentrico»). Secondo la teoria di White, dato che gli individui non
sono in grado di calcolare esattamente le probabilità di rischio, agirebbero spinti dalla propria percezione, prodotta da variabili personali e socio-culturali, da esperienze e informazioni. Sarebbe inoltre
possibile elaborare dei modelli per descrivere (e prevedere) degli
«schemi comportamentali» simili derivanti da simili percezioni dei
singoli44.
Concentrando l’attenzione sul divario fra pensiero sociale (gente
comune) e pensiero scientifico (esperti) nelle interpretazioni di ciò
che si debba ritenere pericoloso, l’impostazione dei geografi della
Scuola ecologica di White mette a fuoco un aspetto essenziale nell’analisi dei disastri in prospettiva non tecnocentrica. Tuttavia le spiegazioni fornite sulle cause di questo divario, e soprattutto la modellistica elaborata per prevedere determinati «schemi comportamentali» in circostanze estreme, hanno sollevato aspre critiche. In sostanza, l’accusa alle teorie di White è quella di operare una sorta di
riduzionismo psicologistico, ipotizzando spiegazioni dipendenti in
gran parte da fattori tutti interni al mondo psichico degli individui,
alla loro sfera cognitiva e percettiva. L’impianto interpretativo nell’analisi delle risposte «sociali» al pericolo assume talvolta accenti di
natura quasi etologica. I modelli di previsione dei comportamenti
sono meccanicistici e concettualizzano il rapporto tra informazione
e individuo in termini di software/hardware, richiamando implicitamente la metafora computazionale del cervello tipica della più ingenua psicologia cognitiva. Le non meglio specificate variabili socioculturali, ancorché presenti nel quadro teorico, scompaiono poi dalla scena all’atto pratico, nelle analisi di campo. Questi problemi soCfr. White 1985. Si veda ad esempio Hagget 1975, in cui si riporta un modello assai semplificato che descriverebbe i meccanismi di difesa messi in atto
dall’individuo di fronte a un evento spaventoso; oppure il modello di Slovic e Fishhoff basato su un complesso «albero delle decisioni», sintesi del processo decisionale che si attiverebbe di fronte al pericolo (scomposto in fasi: identificazione di
tutte le azioni possibili; valutazione rischi/benefici per ognuna; valutazione dell’efficacia, ecc.). Si veda anche il lavoro di Evans e Cohen sui processi di adattamento
attraverso l’informazione, per cui un rischio produce meno stress quando diviene
familiare, ma spesso determina anche una sottostima del pericolo (Evans 1982).
44
39
no bene evidenziati da Thomas Drabek, il quale, mediante una rassegna critica estremamente vasta e minuziosa della letteratura in merito (Drabek 1965), dimostra quanto siano scarse le ricerche che tentano di connettere le scelte individuali e le caratteristiche antropologiche della società di appartenenza, e quindi di correlare fattori
psicologici e fattori sociali. Drabek condivide la rilevanza dell’ipotesi di partenza degli studiosi della Scuola ecologica, i quali
tanto impossibile da proporre qui anche in modo riassuntivo. Mi
preme tuttavia sottolineare almeno uno degli aspetti centrali della riflessione di Hewitt sull’importanza di definire e di concettualizzare
il disastro. L’approccio è nettamente costruzionista e scopre proprio
nella «visione dominante» degli esperti il primo nemico invisibile,
cioè il primo fattore di accrescimento della vulnerabilità sociale. Secondo Hewitt:
piuttosto che chiedersi «Come si comportano le persone durante e dopo
un’alluvione?», si sono chiesti invece: «In che modo le persone percepiscono e possono utilizzare il territorio che è stato colpito da un’alluvione?» (Drabek 1965, p. 4).
Vi è una stretta analogia tra la visione dominante dei disastri e la descrizione di Michel Foucault su come la «pazzia» viene trattata o, meglio,
«inventata» nell’Età della Ragione (Foucault 1965). La calamità naturale
in una società tecnocratica rappresenta lo stesso tipo di problema cruciale
che è la malattia di mente per i campioni della ragione. [...] la pazzia e la
calamità sono molto allarmanti. Esse sfidano direttamente la nostra nozione di ordine. Entrambe sono trattate e interpretate come una «punizione per una scienza inutile e disordinata» (p. 32). Possono essere chiaramente considerate dei limiti alla conoscenza e al potere per il fatto che
affiorano con una modalità che sembra del tutto incontrollabile dalla società (Hewitt 1983, p. 9)45.
E richiamando il lavoro di Burton, Kates e White (1978), egli sottolinea quanto sia stato saggio porre, in sede teorica, il problema della comprensione dei processi decisionali di scelta non solo sul piano
individuale dei singoli, ma anche su quello dei sistemi sociali e delle
politiche degli Stati. Tuttavia per Drabek è fuor di dubbio che all’atto pratico, nei casi concreti di ricerca,
l’analisi dei processi istituzionali che pongono le popolazioni in situazioni di rischio – spesso a vantaggio di pochi – ha ricevuto scarsa attenzione
da parte della comunità scientifica (Drabek 1965, p. 5).
Sempre su questa linea, William Torry, antropologo impegnato a
studiare le emergenze di massa e le condizioni di vulnerabilità sociale
in paesi in via di sviluppo, ha criticato l’efficacia dei questionari utilizzati da White, sostenendo che nel modello interpretativo complessivo dell’evento critico la cultura e le strutture organizzative sono valutate in termini di «costanti», rendendo questi fattori trascurabili ai fini della previsione e dell’attenuazione della vulnerabilità.
Il concetto di pericolo, secondo Torry, viene assunto in modo oggettivo, a prescindere dalla percezione che ne hanno i singoli individui, la quale è considerata soltanto come reazione erronea alla crisi,
da comprendere e da correggere (Torry 1979b, 1979c).
Ma la critica forse più penetrante e incisiva alla Scuola ecologica,
e agli assunti teorici degli studiosi che vi si riconoscono, è provenuta,
all’inizio degli anni Ottanta, dal geografo canadese Kenneth Hewitt.
Il contributo che egli dà per elaborare una nuova prospettiva socioantropologica nello studio dei disastri è vasto e assai articolato, per40
Hewitt si richiama direttamente allo sguardo critico foucaultiano, per il quale i discorsi non rappresentano mai passivamente i loro
oggetti, ma come potenti costellazioni simboliche e lessicali, storicamente formate, essi di fatto li producono. L’errore interpretativo, ovvero il pericolo di utilizzare modelli descrittivi sbagliati delle situazioni critiche – che non contribuiscono a comprenderle per prevederle e attenuarne il danno, e che invece ne accrescono la gravità –,
si annida per Hewitt innazitutto nelle strategie retoriche con le quali la nozione di disastro è costruita e con le quali i discorsi sul disastro sono proferiti dagli esperti della visione dominante:
Il lessico del discorso è spesso un buon indicatore delle assunzioni
teoriche di fondo. Negli studi sui disastri si può vedere come il linguaggio venga utilizzato per mantenere un senso di discontinuità e di alterità,
che separa questi eventi dal resto delle relazioni uomo/ambiente e della
vita sociale. È assolutamente ovvio nell’uso ricorrente dei termini sottolineare la radicale diversità del problema [the «un»-ness of the problem].
I disastri sono fenomeni in-controllabili, in-aspettati e in-prevedibili. Essi derivano da processi naturali o eventi che risultano altamente in-certi.
45
I due riferimenti di Hewitt sono a Foucault 1965.
41
L’in-consapevolezza e l’in-preparazione sono ritenute le caratteristiche
principali per tipizzare le condizioni delle vittime umane. Perfino l’uso
comune della parola «evento» [disastroso] può rinforzare l’idea che si
tratti di una unità discreta, nel tempo e nello spazio. In Nord America,
nell’eufemismo che suona ufficiale, i disastri sono «eventi non programmati» [«unscheduled events»] (Hewitt 1983, p. 10)46.
Se dunque, seguendo Hewitt, una delle indicazioni preliminari
più rilevanti è quella di rifiutare una concezione «discreta», «puntuale», «discontinua» (e in fondo fatalista) del disastro, ritenendolo
un evento «altro», separato e indipendente dalla catena di eventi e
processi propri della sfera antropica, allora:
una visione aggiornata di come e perché si verifica il disastro dovrebbe
tenere in maggiore considerazione le relazioni variabili fra società/esseri
umani e ambiente, che prefigurano la situazione critica. Ciò rende subito di estremo interesse tutto il quadro di fenomeni che costituiscono gli
oggetti tipici dell’analisi delle scienze sociali. Vale a dire che i temi di più
stretta competenza della geografia umana, dell’ecologia umana e dell’antropologia diventano cruciali per la comprensione di un disastro (Hewitt
1983, p. 27, corsivo mio).
Negli anni Novanta, l’invito di Hewitt a disegnare un quadro teorico più sofisticato, che sappia collegare il microlivello (reazioni/
scelte/comportamenti individuali) e il macrolivello (processi istituzionali, politiche e interventi della collettività) è stato raccolto da
Anthony Oliver-Smith, oggi l’esponente senz’altro più autorevole
dell’approccio antropologico allo studio dei disastri. Oliver-Smith,
già professore di Antropologia culturale all’Università della Florida,
dopo una lunga ricerca pluriennale sulle condizioni di vulnerabilità
storicamente prodotte e sui processi di revitalizzazione della cittadina peruviana di Yungai, colpita dal grave terremoto del 31 maggio
1970 (7,7 gradi Richter, 66.794 morti)47, ha avviato un’intensa attività di indagine etnografica e di riflessione teorica sulle interazioni
46
Sull’idea di catastrofe come singolarità, come rottura improvvisa dell’equilibrio nei sistemi dinamici, è essenziale considerare l’impianto concettuale della Teoria delle catastrofi con la quale René Thom ha modellizzato in termini matematici
(topologia differenziale) i fenomeni di mutamento e la fisica del divenire: Thom
1980; cfr. Arnol’d 1990.
47 Si veda Oliver-Smith 1986a, 1986b.
42
fra individui, gruppi e sistemi culturali che in ogni società rendono
caratteristiche le reazioni sociali al disastro48. Ne è scaturito un proficuo approccio analitico interdisciplinare, sistemico e multifattoriale, assai bene sintetizzato dall’ultima definizione di disastro che verrà
qui proposta. Per Oliver-Smith,
un disastro è un processo/evento che interessa la combinazione di agenti potenzialmente distruttivi derivanti da un ambiente tecnico o naturale
e una comunità umana che si trova in una condizione di vulnerabilità socialmente o tecnologicamente prodotta. Si manifesta in termini di percepita distruzione dei dispositivi che assicurano il normale ottemperamento dei bisogni individuali e sociali di una comunità, necessari per la sopravvivenza fisica, per l’ordine sociale e il mantenimento del sistema di
significati. [...] il disastro è un fenomeno che si manifesta nel punto di
connessione fra società, tecnologia e ambiente, e può essere interpretato
come effetto particolarmente eccezionale causato dalle interazioni profonde di questi tre elementi49.
Gli elementi innovativi che pongono la nozione di disastro di Oliver-Smith al cuore della prospettiva socio-antropologica – a cui questo libro è dedicato – verranno gradualmente evidenziati nei paragrafi e nei capitoli seguenti, a cominciare da un doveroso approfondimento critico del concetto chiave di vulnerabilità.
48 Si veda ad esempio il seminario avanzato della School of American Research, organizzato nell’ottobre del 1997 a Santa Fe, New Mexico, dal titolo Catastrophe and Culture. The Anthropology of Disaster, a cui parteciparono fra gli altri
Virginia García-Acosta, Susanna M. Hoffman, Robert Paine, Michael Moseley. I
risultati dei lavori del seminario sono sintetizzati nel volume Hoffman, OliverSmith 2002. Cfr. anche il precedente Hoffman, Oliver-Smith 1999.
49 Questa definizione è costruita affiancando due diversi passi di Anthony Oliver-Smith, tratti da Hoffman, Oliver-Smith 1999, p. 24, e Hoffman, Oliver-Smith
2002, pp. 3-4.
2
Un mondo fragile
Rimane da scrivere una storia
degli spazi, che dovrebbe essere
allo stesso tempo una storia
dei poteri, dalle grandi strategie
geopolitiche alle piccole tattiche
dell’habitat.
Michel Foucault
Body/Power
1. «Tuguri da trogloditi» e il paradosso delle catastrofi
Una delle migliori sintesi del concetto di vulnerabilità sociale, in cui
sono già presenti tutti gli elementi teorici essenziali del problema, ed
espressi con un linguaggio – vorrei dire – opportunamente etnografico, vicino all’esperienza diretta, è contenuta nell’opera di una figura cardine della geografia italiana della prima metà del Novecento,
Roberto Almagià:
la serie dei paesi, dei villaggi danneggiati o minacciati da frane è assai lunga e lunga è anche la lista dei più grandi disastri che hanno prodotto rovine di case e colti e uomini; né mancano esempi di paesi che più volte
subiscono le stesse distruzioni, poiché la carità del natio loco, più forte negli abitanti che il timore del pericolo, li fa restii ad abbandonare le loro dimore, anche quando conoscono che sono votate a certa ruina. [...] per quanto la carità del natio loco – in alcuni casi mirabilmente tenace – renda restii gli abitanti ad abbandonare il loro paese, anche quando questo, sbranato dalle frane, appaia inesorabilmente condannato a rovina, tuttavia a
lungo andare la necessità si impone. Talora un nuovo paese sorge in lo44
calità più sicura, ma il più vicino possibile, magari su un altro fianco della stessa collina1.
Nei primi anni del secolo, Roberto Almagià, ancora giovanissimo, sostenuto dal suo maestro Giuseppe Dalla Vedova, oltre che da
una serie di efficaci accordi con le istituzioni pubbliche (ministero
dei Lavori pubblici, Comuni ecc.), e stimolato dalla vitalità scientifica della Società Geografica Italiana, si impegna nell’impresa lunga e
difficile di studiare e classificare in modo sistematico il fenomeno
delle frane in Italia. Mediante accurate e minuziose indagini sul territorio (da questo punto di vista all’epoca quasi del tutto inesplorato), Almagià individua i nodi cruciali che oggi legano geologia, geografia umanistica e antropologia nello studio dei disastri (Botta 1987;
Corna Pellegrini 1988). Si scorge subito un approccio di tipo olistico e sistemico, secondo il quale il rapporto società-ambiente si configura come una forma complessa e dinamica di reciprocità, cioè come una relazione di interdipendenza che coinvolge, allo stesso tempo, la sfera materiale e quella simbolica (ideativa, sensoriale) dell’attività e dell’esistenza umana. Tale prospettiva – piuttosto avanzata
per l’epoca – favorisce un’efficace visione connessionistica e processuale del disastro, analoga a quella che molti anni dopo formulerà
Anthony Oliver-Smith.
Le considerazioni del geografo Almagià sui prodotti della cultura
materiale, sulle tecniche agricole e sulle caratteristiche fisiche degli insediamenti nelle aree franose non assumono mai quel tono di etnocentrico disprezzo con il quale la commissione di inchiesta parlamentare (che abbiamo citato nel precedente capitolo), inviata nel
1910 a Reggio Calabria per ispezionare la situazione dopo il grande
terremoto, definì «tuguri da trogloditi» le case dei contadini nelle zone fra Cosenza e Vibo Valentia. Sulla base di dettagliati resoconti redatti dalle osservazioni dirette sul campo, Almagià descrive le molteplici iniziative delle popolazioni insediate in zone franose: come ad
esempio spostamenti di sede, ricostruzioni parziali, abbandoni definitivi che caratterizzano molti luoghi dell’Italia centrale e meridionale. Determinante per l’autore è anche lo studio degli interventi antropici diretti che modificano il paesaggio (spesso radicalmente) aumentando il rischio di frane (come scavi minerari, oppure tagli stra1 La citazione è costituita da due brani tratti dal Almagià 1907, p. 316 e Almagià 1910, pp. 391 e 392 (corsivo mio).
45
dali a mezza costa che accentuano l’inclinazione del pendio ed espongono strati di terreno agli agenti atmosferici). Per Almagià è dunque
notorio che un vincolo strettissimo e continuo di dipendenza lega l’ambiente antropico alle condizioni geologiche e morfologiche del paese. [...]
Senza dir poi che, quando si tratta particolarmente di alcuni tra i più importanti fenomeni antropogeografici, intervengono, tra le cause determinanti, anche fattori d’ordine storico e sociale (Almagià 1910, pp. 376 e 377,
corsivo mio).
La comprensione di un disastro richiede quindi l’applicazione di
una modellistica teorica alquanto raffinata, nella quale la visione tecnocentrica standard sia resa meno semplicistica da un’accurata analisi dei «fattori d’ordine storico e sociale» che contribuiscono a provocare la catastrofe, ne caratterizzano la distribuzione del danno e le
possibilità effettive di recupero nel periodo post-impatto. Fra i molteplici fattori d’ordine storico e sociale, ad Almagià non sfugge quello che – come vedremo – può considerarsi il più importante: la percezione della pericolosità da parte della popolazione (o anche di sottogruppi differenti di essa), per la quale «la carità del natio loco, più forte negli abitanti che il timore del pericolo, li fa restii ad abbandonare
le loro dimore, anche quando conoscono che sono votate a certa ruina». Da cosa dipende un simile comportamento? Che cos’è questo
sentimento individuale, ma anche collettivo, diffuso, socializzato, di
«carità del natio loco»? È presente in tutte le società, in ogni angolo
di mondo, e le motivazioni che lo animano sono le medesime ovunque, oppure sono culturalmente variabili e cioè dipendono da fattori
storico-sociali-ambientali specifici della società considerata? Ancora:
il comportamento ostinato di comunità che non vogliono andarsene,
che non vogliono abbandonare il paese e le case in cui abitano esponendosi così a gravissimi rischi, appare oltremodo paradossale, non
solo nei casi in cui questa scelta radicale permane nonostante le persone siano state correttamente avvertite del pericolo dagli esperti
(geologi, sismologi, autorità locali ecc.), ma ancor più nei casi in cui la
comunità stessa conserva nella propria memoria storica (tradizioni,
miti, leggende, esperienze personali dirette e condivise ecc.) il ricordo di precedenti catastrofi che si sono abbattute in quei luoghi2.
Questa bizzarra forma di ostinazione, notata da Almagià nel 1910
studiando le frane in Italia, è in buona misura confermata dalla letteratura recente, e non solo nei casi di disastri naturali, ma – come vedremo nella vicenda tristemente emblematica di Love Canal – anche
quando si verificano forti opposizioni della cittadinanza ai provvedimenti di evacuazione per incidenti chimici, nucleari, di contaminazioni biologiche o batteriologiche. Tale comportamento «paradossale» può essere ancor meglio definito utilizzando un altro aggettivo,
più pesante e complesso, assai caro agli antropologi, e che coglie ulteriori dimensioni del problema: e cioè l’aggettivo irrazionale. Per
esempio, l’atteggiamento ostinato, logicamente inspiegabile, dei nativi dell’isola di Tanna nell’arcipelago delle Vanuatu, che non pensano di trasferirsi pur essendo consapevoli dei rischi che corrono vivendo alle falde di Yasur, uno dei più pericolosi vulcani attivi del
mondo – già causa della grave contaminazione delle falde acquifere –, oppure l’atteggiamento irremovibile di alcuni anziani residenti
nella zona del Vajont, che rifiutarono di muoversi quando si cominciò l’evacuazione per allagare l’invaso della diga3, richiamano la palese irrazionalità dei primitivi i quali, ignorando (apparentemente) i
veri nessi causali tra gli eventi, si curano seguendo le diagnosi dell’oracolo del benge (Azande), oppure credono che gli uomini siano
pappagallini Arara rossi (Bororo). Prenderemo attentamente in considerazione tutte le implicazioni antropologiche più rilevanti del tema della razionalità nella comprensione dei comportamenti sociali
(anche e non solo di membri di culture diverse da quella occidentale) nel prossimo capitolo, in quanto è la questione chiave per impostare il tema della percezione del rischio. Per ora ci basta aver descritto in breve il cosiddetto paradosso delle catastrofi, che Almagià
considera tra i fattori cruciali di vulnerabilità.
È sufficiente invocare le pur importanti ragioni economiche relative alla fertilità dei suoli vulcanici per spiegare perché interi villaggi accettano il rischio di morire (ad esempio per i vulcani sacri giapponesi), oppure è ancora una prospettiva analitica troppo ingenua,
riduttiva e semplicistica? Il paradosso delle catastrofi lancia una difficile sfida sul terreno delle scienze sociali, in particolare all’antro-
2 Questo tema è stato affrontato da Amalia Signorelli in un interessante saggio:
Signorelli 1992, pp. 147-158.
3
«Perché devo andarmene io?! Se ne vada lei [la diga]! Io sono qui da molto
prima, la mia famiglia è qui da generazioni!»: così nell’efficace ricostruzione, basata su documenti e testimonianze dirette, del film Vajont, di Renzo Martinelli (Rai
Cinema, Istituto Luce, Canal +), 2004.
46
47
pologia: la corretta comprensione di un disastro dipende anche dall’interpretazione dello spessore storico, economico, affettivo, simbolico, spesso esplicitamente religioso e rituale, del nesso uomo-luogo che caratterizza ciascuna comunità. Si tratta allora di mappare, etnografare e comprendere forme altrettanto differenti e specifiche,
«locali» (Geertz) di percepire e valutare il rischio. È tutt’altro che
trascurabile il ruolo svolto da tali valutazioni, percezioni e rappresentazioni – rese esplicite, dichiarate, codificate, oppure mantenute
implicite, inconsapevoli, e attivate quasi automaticamente – nel motivare comportamenti, scelte, decisioni collettive, piani di sviluppo.
Sono proprio questi orientamenti «culturali», in senso antropologico, che plasmano la vulnerabilità sociale di una comunità rispetto a
un certo tipo di evento estremo.
2. Temi di antropologia dello spazio e del paesaggio
per lo studio dei disastri
La sfida di senso lanciata da quell’imprecisato sentimento di «carità
del natio loco» (ancorché il luogo sia temibile e foriero di sventure),
che troviamo negli appunti di Almagià, può ben essere raccolta
dall’antropologia dello spazio. Questo filone di ricerca si pone il problema di interpretare i significati simbolici conferiti allo spazio dalle varie società umane, spiegando la funzione che essi svolgono nello strutturarsi dei rapporti interpersonali dell’individuo, all’interno
e all’esterno delle abitazioni (mediante analisi delle componenti socio-culturali dell’architettura); nel processo di acquisizione della cultura; nella percezione e nell’organizzazione culturale del territorio;
nell’appropriazione e gestione delle risorse (corsi d’acqua, pascoli,
vie di comunicazione); e in generale in ogni processo di azione sociale4. In Italia, a partire dalla fine degli anni Ottanta, la riflessione
antropologica di maggior rilievo su questi temi è stata avviata da
Francesco Remotti, per il quale la nozione stessa di «abitare», intuitiva e autoevidente, si rivela invece insospettabilmente complessa in
quanto rinvia a una serie di processi di costruzione culturale di forme di umanità:
Ogni società è fatta di luoghi e di corpi, ovvero di corpi che vivono,
operano, interagiscono, abitano certi luoghi. Rispetto a una qualsiasi dimensione immaginativa o simbolica [...], corpi e luoghi rivendicano una
loro evidente e innegabile fisicità. Come non possiamo pensare a una società se non in quanto costituita da individui che coincidono visibilmente con i loro corpi, così non possiamo considerare una società se non occupante un certo spazio, e più precisamente luoghi dello spazio. Lo spazio sociale (occupato dalla società) non è mai neutro e uniforme: è variegato, è fatto di luoghi che si differenziano spesso in modo notevole (luoghi
del lavoro, dello svago, della vita familiare, della vita religiosa individuale
e collettiva, luoghi dei vivi, luoghi dei morti, e così via). [...] ogni società
si distende in uno spazio, lo articola e lo organizza in certi luoghi, eleggendo o ritagliando certi ambiti specifici del suo territorio in quanto destinati a certe attività [...]. La cultura è un «abitare», un intervento modificatore
dello spazio e dei corpi che lo abitano mediante la produzione di «abiti»
(di costumi, di mores), i quali conferiscono a corpi e ad animi un’impronta, uno stile, una foggia, una forma particolare di umanità (Remotti 1993,
pp. 31 e 44-45, corsivi miei).
4
Per brevità non è possibile descrivere qui i molteplici approcci teorici di questo ambito disciplinare dell’antropologia. Per una sintesi tematica e bibliografica
generale si rimanda a Lawrence, Low 1990; Ligi 2003, pp. 239-285; cfr. Rapoport
1976.
L’antropologa Setha M. Low ha sintetizzato questa impostazione teorica con l’espressione «spatializing culture» (spazializzare le
culture): «Per spazializzare, intendo collocare, sia fisicamente sia
concettualmente, le pratiche e le relazioni sociali nello spazio sociale» (Low 1986, p. 861). Ciò significa considerare la rilevanza che l’organizzazione sociale dello spazio (il nesso uomo-luogo) assume nella
vita quotidiana e dunque nella ricerca antropologica, focalizzando le
indagini sulla connessione fra le componenti spaziali del comportamento umano, i processi mentali e le concezioni del sé; sulle modalità con le quali la società produce determinate forme costruite (abitazioni, strade, villaggi, città) che a loro volta manifestano e riproducono determinati valori sociali; oppure sul ruolo svolto dalla storia locale e dalle istituzioni sociali nel generare e plasmare gli ambienti naturali e quelli costruiti; sulle relazioni fra spazio e potere.
Questo approccio ecologico-relazionale, utilizzato attualmente in
antropologia e in geografia, ridefinisce il paesaggio (intendendo anche un paesaggio «urbano») come prodotto della sintesi fra un dato
naturale e una percezione sensoriale. Non esiste un «paesaggio» in
senso oggettivo e indipendente da un osservatore che considera tale
una determinata porzione di territorio. Solo l’ambiente naturale è
oggettivamente «dato», nei termini di un frammento di realtà esterna che giace semplicemente là: il paesaggio invece è sempre un pro-
48
49
dotto della cognizione umana (Tuan 1979). Ma gli individui e le comunità non si limitano a modificare l’ambiente in senso fisico, con
azioni concrete, e a percepirlo con modalità sensoriali. Ne costruiscono rappresentazioni simboliche complesse, frutto di processi immaginativi, narrativi, mitopoietici, emozionali, e così via. Un classico esempio dell’elaborata plasmazione simbolica a cui i gruppi umani sottopongono l’ambiente, rendendolo un paesaggio denso di significati culturali, ci viene offerto dall’analisi etnografica di Bronislaw Malinowski a proposito delle Isole Trobriand nel Pacifico Occidentale:
Dobbiamo cercare qui di ricostruire l’influenza del mito su questo vasto paesaggio; come lo rappresenta, che significato gli dà e come lo trasforma in qualcosa di vivo e di familiare. Quella che era solo una roccia assume una personalità, quello che era un punto all’orizzonte diventa un faro reso sacro dalle leggendarie associazioni con gli eroi, una conformazione insignificante del paesaggio acquista un senso, oscuro senza dubbio, ma carico di intensa emozione. Navigando con gli indigeni, specialmente con dei novizi del kula, ho spesso osservato quanto profondo sia
il loro interesse per quelle parti del paesaggio impregnate di significati
leggendari, come i più anziani le indichino e le spieghino, come i più giovani le guardino con attenzione e con curiosità, mentre la conversazione
si riempie di nomi mitologici. È l’aggiunta di un interesse umano alle caratteristiche naturali, che posseggono di per sé meno potere di attrazione per
un indigeno che per noi, che rende diverso ai suoi occhi il paesaggio [...].
Questo potere di trasformare il paesaggio, l’ambiente visibile, è solo una
delle tante influenze che il mito esercita sul modo di vedere la realtà in
generale degli indigeni [...]. A questo proposito si deve notare che le caratteristiche del paesaggio trasformate miticamente testimoniano per l’indigeno la verità del mito. Il mondo mitico si concretizza nelle rocce e nelle colline, nei mutamenti della terra e del mare. I passaggi marini forati, i
macigni spaccati, gli esseri umani pietrificati, tutto ciò avvicina il mondo
mitologico agli indigeni, glielo rende tangibile e permanente. D’altra parte, la storia così potentemente illustrata reagisce sul paesaggio, lo riempie
di accadimenti drammatici che, fissati in esso per sempre, gli danno un significato preciso (Malinowski 1973, pp. 286-287, corsivi miei).
Nelle loro città, paesi, campagne, nei loro contesti fisici di vita,
alle prese con le normali attività della loro vita quotidiana, le persone non si muovono mai fra punti geometrici di uno spazio astratto, indefinito e neutro, ma si orientano fra nodi significativi in una
rete di micro-esperienze. Scrive Tim Ingold: «Places do not have
locations, but histories» (Ingold 2000, p. 219), ed è per questo che
il paesaggio acquisisce il valore di risorsa, di patrimonio, di bene
culturale, di elemento che organizza e rafforza la memoria collettiva e il senso del «noi». Si tratta di un processo sociale profondo per
il quale sulla struttura fisica, ecologica, di un luogo, viene proiettata e saldata una particolare struttura di sentimento5. Il luogo viene
così ad assumere tutta la complessità di un microcosmo (Magris
1997).
3. Microcosmi e disastri
L’idea di microcosmo esprime dunque tutta la ricchezza e la complessità del nesso uomo-luogo, dei rapporti fra una comunità umana
e un ambiente naturale, fra saperi ecologici nativi e pratiche sociali.
Ma cosa capita quando questo nesso salta e si spezza? Quando cioè
si verifica una situazione estremamente critica in cui queste correlazioni quotidiane (normali e date per scontate) – di tipo economico,
politico, religioso, affettivo – che legano comunità e ambiente subiscono un radicale sconvolgimento? Si tratta allora di una catastrofe
grave nella quale la cultura si mostra estremamente fragile e precaria, ma al contempo indispensabile e insostituibile: le stesse categorie cognitive, le strutture simboliche mediante le quali una comunità
percepisce e comprende il mondo rendendolo pensabile, smarriscono il loro significato proprio nel momento in cui se ne avrebbe più
bisogno. Sembra allora che il mondo letteralmente finisca. La percezione della perdita di tutto e il senso della fine imminente e irreparabile diventano insopportabili. Come si può leggere in questo testo già citato di De Martino:
L’ambiente naturale, percepito con i sensi, viene sempre in qualche modo ricostruito culturalmente dalla comunità che vi è insediata.
Ed è questa opera di incessante manipolazione che produce lo spessore storico ed emozionale dei luoghi trasformandoli in paesaggi.
5
Ricavo l’espressione «struttura di sentimento» da Arjun Appadurai (2001),
che l’ha utilizzata, derivandola da Raymond Williams, per spiegare l’intensità e la
capillarità con cui si radica la violenza etnica nei gesti, nei discorsi, nelle conversazioni casuali, nei microcontesti di socialità. Cfr. anche l’uso della medesima espressione nelle ricerche di geografia culturale di Doreen Massey e Pat Jass (2005).
50
51
La fine dell’ordine mondano può essere considerata in due sensi distinti, e cioè come tema culturale storicamente determinato, e come rischio antropologico permanente. [...] Come rischio antropologico permamente il finire è semplicemente il rischio di non poterci essere in nessun modo culturale possibile, il perdere la possibilità di farsi presente
operativamente al mondo, il restringersi – sino all’annientarsi – di qualsiasi orizzonte di operabilità mondana, la catastrofe di qualsiasi progettazione comunitaria secondo valori. La cultura umana in generale è
l’esorcismo solenne contro questo rischio radicale, quale che sia – per così dire – la tecnica esorcistica adottata (De Martino 1977, p. 219).
In un disastro naturale o tecnologico non si ha purtroppo soltanto una penosa conta di vittime, l’arresto di un ciclo produttivo, o
l’alterazione geomorfologica di un territorio, ma ci si trova dinnanzi
a una profonda crisi di interi microcosmi. Da un punto di vista antropologico, comprendere l’evenienza disastrosa e comprendere le
caratteristiche del microcosmo che la subisce sono due operazioni
inestricabilmente connesse.
Molto spesso però l’intima struttura di sentimento che anima un
microcosmo comincia a incrinarsi e a vacillare ben prima che si scateni il cataclisma. È sufficiente una lenta, progressiva trasformazione del paesaggio quotidiano per «generare una pluralità di fenomeni negativi, con l’emergere di situazioni di anomia e angoscia esistenziale, [che] denunciano da tempo il grado di sofferenza collettiva e individuale nei rapporti fra natura e cultura» (Bernardi 2004, p.
13). Le ricerche recenti di Francesco Vallerani, ad esempio in alcune aree della media pianura veneta, mostrano chiaramente come l’insorgenza tutt’altro che episodica di psicopatologie e crisi depressive
può essere collegata alla perdita traumatica del senso dei luoghi. Secondo Vallerani:
sibile tutelare e incoraggiare il senso di appartenenza alla comunità, nutrendosi di valori identitari, trovandovi valide opzioni per il tempo ricreativo in un ambiente salubre (Vallerani 2004, p. 13).
Senza dubbio l’elemento che più di ogni altro conferisce familiarità e connotazioni affettive al paesaggio è la presenza in esso della
propria casa. Lo spazio domestico, come ambiente costruito, rappresenta un ulteriore microcosmo entro il più ampio spazio ecosistemico e naturale che lo contiene. Sebbene, talvolta, per motivi storici di
deprivazione e subalternità socio-economica, oppure in base a un
giudizio etnocentrico e razzista, si possa definire un «tugurio da troglodita», la «casa è il nostro primo universo» (Bachelard 1975, p.
32)6. Quando l’evenienza disastrosa lambisce la soglia di casa o addirittura vi penetra (anche senza causarne la distruzione fisica) un intero universo vacilla.
L’antropologa Janet M. Fichten (1989) ha condotto un’indagine
multidisciplinare sull’inquinamento delle falde freatiche che rendeva
inutilizzabile l’acqua corrente nei rubinetti delle case in 12 comunità
nello Stato di New York e in varie cittadine di provincia. Queste ricerche hanno mostrato chiaramente come le percezioni di una grave
contaminazione ambientale, e le risposte attive della popolazione, siano influenzate dai valori e dalle strutture di sentimento che caratterizzano l’ambiente contaminato. Nel caso specifico, oltre i possibili rischi per la salute e per le perdite finanziarie, l’agente inquinante rappresenta un attacco alle fondamentali istituzioni culturali della casa e
della proprietà. Fichten ha messo bene in evidenza il fatto che proprio
in quelle circostanze critiche nelle quali la minaccia maggiore penetra
nello spazio domestico affiorano alcuni fra i più importanti significati culturali attributi alla casa nella società americana:
Sostengo che, lontani dall’essere considerati «irrazionali» nei loro
comportamenti, gli americani che reagiscono violentemente alla contaminazione dell’ambiente domestico mostrano una «razionalità culturale».
Essi rispondono in termini di concetti, assunzioni e valori che sono ampiamente diffusi e profondamente radicati nella società americana. [...]
Noi ipotizziamo che la contaminazione dell’acqua possa essere percepita
dai residenti come una particolare calamità perché, in aggiunta alla mi-
Il ben distribuito formarsi della campagna urbanizzata ha frantumato la tradizionale opposizione con la città, producendo un senso di incomprensione e illeggibilità dei nuovi assetti territoriali. Lo stesso dicasi
dell’omologazione fisionomica dei paesaggi agrari, sottoposti alle logiche
produttivistiche delle massime rese con la minima spesa. In entrambi i casi allo stravolgimento delle geografie della memoria si accompagna l’avvilente convivenza con nuove minacce e concreti danni alla qualità della
vita a cui si è già accennato. La psicologia ambientale e la geografia umanistica sono prodighe di informazioni circa l’importanza di poter disporre di una quotidianità ambientale affidabile e riconoscibile, ove sia pos-
6
Cfr. gli studi dell’antropologa olandese Irene Cieraad (1999) e l’interessante
applicazione della teoria dei grafi all’analisi dei significati culturali dell’ambiente
domestico presentata da Billy Hillier e Julianne Hanson (1984).
52
53
naccia personale per la salute fisica e per gli investimenti economici, essa
mette in crisi le concezioni e i valori che le persone hanno della loro casa
(Fichten 1989, pp. 314-315).
Fichten delinea l’importanza antropologica di una serie di connotazioni culturali della casa, rilevate dalla ricerca sul campo mediante un’estesa rete di interviste in profondità e un’attenta analisi
delle più ricorrenti modalità espressive dell’accaduto (luoghi comuni, detti, gergo, metafore). Qui ne indichiamo alcune: 1) «Casa come luogo/spazio della famiglia». Benché la famiglia sia molto cambiata in America, sostiene Fichten, il concetto di legame familiare e
il valore affettivo attribuito a una qualche forma di unità minima di
socialità rimangono presenti e importanti. Il disastro ambientale che
si manifesta con la contaminazione dell’acqua tocca il cuore della famiglia, alterandone o impedendone del tutto le normali attività quotidiane, sovvertendo non solo l’ordine della vita in sé, ma l’ordine
della vita «in famiglia». Così le prime vittime delle quali ci si preoccupa non sono genericamente «persone», ma persone «di famiglia».
2) «Casa come struttura che garantisce protezione e rappresenta sicurezza». Per Fichten nella società americana la concezione della casa come luogo sicuro che conferisce protezione, e che deve essere difesa ad ogni costo, si è radicata sin dall’epoca della colonizzazione,
quando i pionieri consideravano la propria casa davvero un rifugio
stabile e sicuro dalle molteplici minacce (intemperie, animali, tribù
indigene) dei vastissimi territori selvaggi ancora inesplorati. È interessante notare come, una volta incrinato questo senso di sicurezza
(con la contaminazione), sia poi estremamente difficile riconquistarlo. Anche in casi in cui gli aspetti concreti, chimici oppure biomedici, della contaminazione sono stati superati e risolti, la casa non
è più percepita come completamente sicura: il fatto di essere stata
«violata», o «penetrata», una volta è come se ciò l’avesse privata per
sempre di ogni suo potere protettivo. 3) «Casa come àncora affettiva con connotazioni sacre», centro e soggetto di consistenti investimenti emotivi. 4) «Casa come espressione dell’identità individuale»: per cui l’attacco alla casa è un attacco a se stessi. La casa come
ambiente fisico si identifica profondamente con chi la abita. 5) «Casa come privacy e intimità». La contaminazione in questi casi è percepita come ancora più minacciosa, perché varca la soglia di casa
intesa come ultimo luogo possibile per vivere la propria intimità e
privacy.
54
Infine, si ricava chiaramente dalle ricerche di Fichten come, nei
casi di una contaminazione ambientale dello spazio domestico, le
percezioni sociali di gravità vengano plasmate non solo dai valori
collettivi attribuiti alla casa in quanto tale, ma anche da quelli conferiti alla proprietà, alla condizione di essere proprietari della casa in
cui si abita. Il «sogno americano» della proprietà della casa diventa
un incubo, nel quale la casa-castello assume l’aspetto di una prigione. Essere proprietari è una condizione, spesso raggiunta dopo anni
di lavoro e sacrifici, che promuove indipendenza, conferisce diritti,
attribuisce status, e rende membri di una categoria sociale di rispetto. La presenza invisibile e pericolosa di agenti tossici contaminanti,
allora, non solo inquina la struttura chimica dell’acqua corrente, ma
intacca e sovverte l’identità sociale degli individui colpiti, anche lungo questa molteplicità di livelli simbolici diversi.
Conclude Janet Fichten che il personale delle agenzie ambientali governative, gli amministratori della salute pubblica, gli ingegneri
che lavorano con le comunità che hanno sperimentato problemi di
contaminazione dovrebbero essere più sensibili agli assunti culturali e ai valori che plasmano la percezione che la gente ha di essere contaminata. In ciò si rivela la non scarsa potenzialità applicativa dell’indagine etnografica sulle rappresentazioni culturali diffuse dell’ambiente contaminato, come parte integrante dell’analisi previsionale,
degli interventi concreti di soccorso, di bonifica e di sostegno fino al
ripristino di condizioni normali.
4. Case, paesaggi e vulnerabilità: l’esperienza dei Saami
Nelle estreme regioni settentrionali della penisola scandinava, in
prossimità del Circolo Polare Artico, alla stessa latitudine dell’Alaska
e della Groenlandia centrale, si estende un territorio immenso coperto per chilometri e chilometri da gigantesche foreste di conifere, che
gradualmente verso nord cedono il passo alla solitudine severa della
tundra. Sul finire dell’estate le ultime driadi, basse, con petali bianchi
e al centro una pennelata di giallo intenso, e i papaveri artici dagli steli lunghi e sottili piegati dal vento salutano le corse dei branchi di renne verso i pascoli autunnali. Nella lingua nativa si dice Sápmi ed è stata menzionata, come una delle ultime zone selvagge d’Europa, fra le
ricchezze naturalistiche dell’umanità dalla Convention Concerning
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, istituita
dall’UNESCO nel 1972: è la Lapponia, la «terra dei Saami».
55
I Saami sono pastori seminomadi di renne che abitano da secoli
questa regione sconfinata, estesa per circa 280 mila chilometri quadrati tra il Finnmark norvegese, le contee settentrionali della Svezia
(Norrland) e della Finlandia (Läpin lääni) e la penisola di Kola, nella provincia di Murmansk (Federazione di Russia). Alcuni anni fa
ero impegnato in una ricerca etnografica tra i gruppi saami della
Lapponia svedese, nel comune di Arvidsjaur, e come chiunque abbia avuto l’opportunità di vivere per un certo periodo in una cittadina della Svezia o della Norvegia settentrionale dovevo molto spesso scendere a patti con le raffiche improvvise di vento che quotidianamente mi accompagnavano. Si dice che i cieli della Lapponia siano i più ventosi del pianeta e ciò dipende probabilmente dai banchi
di alta pressione stazionari sul mare Artico. D’inverno, quando le improvvise folate possono raggiungere anche i 40-50 chilometri all’ora,
la sensazione di freddo pungente è quasi insopportabile e si cammina in una danza di aghi di ghiaccio che si attaccano ovunque bagnando gli abiti in pochi minuti.
Per i Saami – i cosiddetti Hyperborei nelle fonti medievali, coloro cioè che abitano «oltre il vento del Nord» – questa caratteristica
climatica è però di fondamentale importanza. Essi vivono seguendo
le renne nelle loro migrazioni stagionali e sentono il vento come
un’entità viva che riempie il paesaggio animandolo con la propria voce e il proprio odore. Nell’arco di intere generazioni, i pastori di queste estreme regioni del pianeta hanno sviluppato un corpus di valori, sistemi simbolici, comportamenti, saperi socialmente codificati,
pratiche e abilità quotidiane per rappresentare e gestire nel modo
più economico e produttivo possibile un ambiente naturale così
proibitivo7. Ad esempio, per guidare un branco da un pascolo all’altro la capacità sensoriale di avvertire i cambiamenti del vento è determinante. Ciò affiora in molti canti tradizionali:
Naa na vaa na
naa na vaa na
...
La renna appartiene al vento
dove soffia il vento
là si volge il branco
la renna tira indietro le orecchie
e comincia lentamente a muoversi
non proprio camminando,
ma trotterellando verso il vento
rivolgendosi in direzione del vento
è una renna.
...
Naa na vaa na8.
In quella precedente ricerca avevo studiato in che modo per un popolo nomade come i Saami l’idea di casa, di spazio domestico, con tutte le relative connotazioni di intimità e affettività, varcasse i confini
angusti di una singola struttura abitativa per estendersi a intere porzioni dell’ambiente naturale. Si può dire che le famiglie saami ancora
interamente dipendenti dalla pastorizia di renne non attribuiscano
valore tanto all’idea di avere una casa in un territorio quanto piuttosto
a quella di avere un territorio come casa (Ligi 2003; cfr. Ligi 2002,
2004). Spinti dalla vitale esigenza quotidiana di comprendere e saper
gestire le caratteristiche naturali dell’habitat e i severi fattori climatici, i Saami hanno sottoposto il paesaggio a un’intensa e secolare opera di simbolizzazione. Espressioni quali «le meravigliose terre dentro
le montagne», o «i silenzi del ghiaccio» oppure «le canzoni del vento», tipiche di molti racconti tradizionali, sono soltanto alcune delle
tracce culturali di come un ambiente percepito dagli stranieri come
pericoloso e ostile possa trasformarsi nel paesaggio rassicurante e familiare, in cui ci si sente a casa, di chi vi abita. Il poeta saami Nils-Aslak
Valkeapää ha scritto in proposito splendidi versi:
Vento, fummo uno dei venti
il vento che cantava la vita
e accarezzava le gote della tundra
le foreste, le valli, uno joik che scompariva,
i colori accesi della sera, vento,
fummo uno dei venti, arrivammo e ripartimmo
7
L’antropologo Michael Fortescue, dell’Istituto di Eschimologia di Copenaghen, ha dimostrato ad esempio che tra gli Inuit groenlandesi la costruzione linguistica dei deittici di luogo è profondamente connessa con la percezione delle direzioni dei venti dominanti (Fortescue 1988).
8 Svensson 1978, pp. 213-236. D’ora in poi, se non diversamente specificato,
tutte le traduzioni in italiano dei brani citati sono da considerarsi mie.
56
57
non è rimasto niente di noi
solo uno joik nel vento che canta
un sogno di vita9.
E davvero il vento «canta un sogno di vita», in quanto è l’artefice di un grandioso miracolo ecologico. Tutte le conifere, come quelle della sconfinata taiga subartica, sono sempre verdi e attecchiscono in ambienti proibitivi per gran parte delle altre specie arboree.
Affinché avvenga la fecondazione, per sopperire alla mancanza di insetti che volano metodicamente da un fiore all’altro, nelle conifere il
solo agente impollinatore è il vento. Nella prima fase della sua vita
la pigna, stando dritta, rivolta verso il cielo, presenta – all’azione fecondatrice del polline trasportato dal vento – le cellule-uovo poste
su ognuna delle molte squame. Una volta fecondata, ogni cellula si
sviluppa dando un seme: un minuscolo pino in embrione. In seguito, quando la pigna matura si volge verso terra, le sue squame si aprono e i semi cadono al suolo, pronti a germinare e a crescere, creando nuove foreste.
Nella tarda primavera del 1986, però, i venti che soffiavano da
nord-est, animando la Lapponia con antiche canzoni e «sogni di vita», assieme al polline e all’odore dell’estate imminente, sparsero
ovunque milioni e milioni di microscopiche particelle di cesio-137,
radioattivo.
5. Il disastro ambientale di Brurskanken in Lapponia
Nell’aprile del 1986 l’esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare di Černobyl’, a nord di Kiev in Ucraina, provocò una nube tossica di polveri radioattive dell’altezza di circa un chilometro. I
forti venti della primavera slava, mutando spesso direzione, resero
praticamente impossibile prevedere la zona di fall-out, con la conseguenza paradossale che alcune aree lontane da Černobyl’ risultarono maggiormente colpite di altre assai più vicine alla centrale evacuata. Nei giorni successivi al disastro, la nube si diffuse a nord-ovest verso la Scandinavia, percorrendo i quasi 2000 chilometri che separano Kiev dalla valle norvegese di Brurskanken nell’Helgeland,
dove, con i temporali e la pioggia copiosa, le particelle di cesio ra-
dioattivo si depositarono sui laghi, sulle colline, sui campi, provocando una forte contaminazione, resa ancor più grave dalle caratteristiche specifiche della flora subartica.
Una delle più importanti forme di vegetazione in Lapponia è la
Cladonia rangiferina, il cosiddetto «lichene delle renne». I licheni, di
cui esistono numerose specie presenti sia nel sottobosco della taiga
sia nella tundra, sono un meraviglioso esempio di organismi simbiotici, essendo formati da un fungo e da un’alga verde o azzurra: il fungo si àncora alla roccia e produce una massa di tessuto spugnoso che
trattiene grandi quantità d’acqua. L’alga vive protetta da questo riparo ricco di umidità e provvede con la fotosintesi agli alimenti che
divide col fungo. I vari tipi di lichene costituiscono l’alimento indispensabile per le renne in tutto l’arco dell’anno. Ma purtroppo essi
crescono lentamente e non avendo un sistema di radici prendono
nutrimento soltanto dall’acqua e dall’aria; perciò assorbirono il cesio di Černobyl’ in misura molto maggiore di qualunque altro vegetale, rimanendo contaminati per anni. L’ecosistema di parecchie zone della Lapponia e la catena alimentare, che mediante la pastorizia
di renne comincia da queste minuscole piantine e arriva fino ai Saami, furono profondamente alterati. Durante l’estate del 1986 la presenza di radioattività fu riscontrata nel pesce, nel bestiame e nei raccolti. Da principio il governo norvegese fissò in 600 Becquerel per
chilo il limite massimo consentito di radioattività per la carne destinata all’alimentazione umana. Su ogni carcassa contaminata veniva
tracciata una striscia blu e poi veniva portata via per nutrire altri animali allevati per le loro pelli pregiate come i visoni. Le autorità stabilirono anche un risarcimento per i Saami, fissando il prezzo di 40
corone per chilo (da cui andavano dedotti il compenso per il macellaio e altre spese), che venne giudicato però assai insufficiente10.
9 Traduzione dall’inglese di Lucia Zorzi (2000, p. 11), dalla raccolta The Sun,
My Father (DAT O.S., Kautokeino 1988), sull’originale Beaivi Áhcázan.
10
I Saami commerciano la carne di renna come bene di lusso vendendola alle
catene di macellerie scandinave del sud, dopo essersi tenuti una parte di carne per
il fabbisogno familiare, le interiora, le pelli e le corna. La macellazione avviene direttamente sui campi, entro enormi camion allestiti come mattatoi mobili. Se invece il tempo non lo consente, dopo l’uccisione e la scuoiatura, i capi venduti vengono caricati su automezzi-frigorifero e trasportati nella grande città più vicina per
terminare la macellazione. A seguito del disastro di Černobyl’, per ottenere il risarcimento, ogni famiglia doveva cedere tutto ai macellai, anche la pelle, le ossa e
le interiora; e non era previsto alcun risarcimento per la carne di loro consumo: o
mangiavano quella più o meno contaminata, oppure avrebbero dovuto ricomprarla loro stessi nei negozi.
58
59
Su questo disastro ambientale abbiamo un eccezionale documentario etnografico realizzato nel 1987 dall’antropologo Georg Henriksen. Si tratta di un documento praticamente unico per la cultura
saami sugli effetti della contaminazione da scorie radioattive11. Tentando una traduzione intersemiotica non troppo maldestra (nel rendere le immagini con parole), ne utilizzeremo alcune sequenze per
mettere in evidenza una serie di importanti temi di ricerca in antropologia dei disastri che in questo caso emergono direi in modo emblematico. Henriksen intraprese la sua ricerca con le due famiglie
saami di Brurskanken, i Renberg e gli Apfjell, che da generazioni allevavano renne nella zona, proprio nel momento in cui l’emergenza
fu più acuta. La prima delle sequenze che vorrei commentare è quasi all’inizio12.
PRIMA SEQUENZA
Interno. Verso sera. Siamo di fronte a un uomo robusto, di circa settant’anni, seduto in soggiorno. L’arredamento è semplice e modesto
ma dignitoso, illuminato dalla luce fioca di una abat-jour. Tutto sembra immerso in quella atmosfera calda e accogliente che si respira
nelle piccole abitazioni scandinave di campagna.
Si chiama Tomas Renberg, di etnia saami, e ha fatto il pastore di
renne nella valle di Brurskanken per una vita. A destra, alle sue spalle, sulla mensola di una credenza, si intravede una fila di portaritratti con cinque o sei foto della famiglia. Mentre parla le sopracciglia
sono corrugate, il volto assorto, chiuso, come le braccia che tiene
sempre conserte, strette avanti a sé, per proteggersi da un pericolo
pur essendo ben risoluto ad affrontarlo. Si intuisce chiaramente che
è un uomo dal carattere forte, abituato al lavoro duro e a prendere
decisioni drastiche, a volte dolorose.
Ma ora è diverso. È di fronte a un problema grave. Sa che deve agire, e presto, ma cosa fare? La sua lunga esperienza di pastore non gli
è più, d’un tratto, di alcun aiuto. Non guarda mai l’obiettivo – quasi
lo ignora – perché con lo sguardo rivolto in basso, da qualche parte,
in un punto indefinibile della stanza – come di chi stesse pensando a
voce alta – i suoi occhi sono intenti a cercare: cercano non tanto le parole per descrivere ciò che prova, quanto il senso, il significato complessivo di ciò che sta capitando in quella valle, a lui, alla sua famiglia
e ai suoi animali. È un uomo forte, ma visibilmente spaventato, che
forse ora per la prima volta in vita sua si sente davvero impotente:
Nel nostro lavoro con le renne noi Saami abbiamo dovuto affrontare
molte situazioni difficili, ma abbiamo sempre trovato una soluzione nel
corso degli anni. [Pausa] I nostri problemi sono i predatori, i pascoli insufficienti, e ogni genere di pericolo per le renne, i conflitti di interesse
con gli agricoltori, [pausa] con i pescatori e con le industrie. Finora siamo riusciti a risolvere tutti questi problemi perché sono difficoltà che
possiamo vedere con i nostri occhi. Questo della contaminazione invece
[pausa] non possiamo vederlo e per questo motivo noi Saami lo chiamiamo il nemico invisibile13.
Affiora qui un primo tema centrale in antropologia dei disastri:
l’invisibilità. In alcune zone della Lapponia è penetrato un nemico invisibile che ha invaso i campi, le montagne, i fiumi, i pascoli, contaminando il paesaggio, cioè il cuore stesso della casa saami. Ma la presenza di questo pericoloso nemico non può essere immediatamente
percepita. L’invisibilità della contaminazione radioattiva di cui parlano i pastori non è soltanto l’incapacità di «vedere» con gli occhi la minaccia, ma si riferisce all’impossibilità di averne una percezione sensoriale complessiva mediante la vista, il tatto, l’udito, l’olfatto, il gusto
e con la propria esperienza corporea dello spazio naturale e dei fenomeni atmosferici: quella esperienza che ha consentito da secoli la pastorizia di renne e ha permesso di sconfiggere tutti gli altri «nemici»14.
11
Georg Henriksen insegna Antropologia sociale all’Università di Bergen
(Norvegia). Il documentario, intitolato An Invisible Enemy, è stato realizzato dalla
Granada Television International Ltd., London 1987, per la regia di Peter Carr
(dur. 53’). Vi è un’edizione italiana dal titolo I Saami della Lapponia all’ombra di
Černobyl’ per la Inedita Milano, 1991.
12
Per tutto il documentario l’intervistatore è sempre Georg Henriksen, che
però non compare mai: si sente soltanto la sua voce fuori campo. I colloqui si svolgono in norvegese senza registratore, utilizzando il microfono ambientale della cinepresa, che negli interni rimane fissa in un punto della stanza per tutta la durata
dell’intervista. L’effetto in soggettiva di chi pone le domande, realizzato con le inquadrature, dà l’impressione che gli intervistati rispondano rivolgendosi direttamente allo spettatore.
Letteralmente in norvegese: «den usynlige fiende».
«Molti filosofi e storici hanno evidenziato l’‘oculocentrismo’ della tradizione
occidentale, che ha privilegiato la vista sugli altri sensi come fonte di conoscenza.
Gli antropologi, dal canto loro, hanno invece sottolineato l’importanza delle percezioni uditive nella sfera sensoriale delle popolazioni non occidentali. La compa-
60
61
13
14
È significativo un frammento dell’intervista di Georg Henriksen al
veterinario dell’Helgeland:
Veterinario: La carne è di prima qualità. Gli animali hanno un
bell’aspetto e sono ben nutriti. È raro che la carne di renna non venga accettata per qualche motivo, dato che gli animali malati restano indietro
sui monti e non arrivano alla macellazione. In ogni caso dovranno essere
scartati. Il ministero dell’Agricoltura ha stabilito così anche se la carne ha
un buon aspetto.
Henriksen: La situazione è dunque rimediabile per il momento?
Veterinario: È difficile rispondere a questa domanda. Ma se non si verificheranno altri incidenti gli animali mangeranno tutti i licheni contaminati e nuovi licheni cresceranno senza radioattività perché si sviluppano principalmente per mezzo dell’acqua e dell’aria. [pausa] Penso che
non converrebbe uccidere gli animali adesso, ma invece far loro mangiare i licheni radioattivi. Non ci resta che fare affidamento sui nuovi licheni, ma questi non cresceranno in fretta, avranno bisogno di alcuni anni
prima di svilupparsi.
Quello di «radioattività» è un concetto astratto incomprensibile
per un pastore saami: non sa come è fatta, che forma ha, quanto pesa, quindi non capisce bene che cos’è. Gli animali contaminati in apparenza sembrano sani, hanno comunque un bell’aspetto; i licheni
sono freschi e rigogliosi, i pascoli verdi, il vento non porta odori sospetti o non familiari, il rosso dei papaveri artici è sempre brillante
anche se nasconde un temibile veleno. L’invisibilità percettiva diventa un’invisibilità cognitiva.
Tomas Renberg, come gran parte degli altri pastori saami, non dispone delle risorse cognitive necessarie per comprendere appieno il
senso di ciò che sta accadendo. Ovviamente qui il punto non è leggere in un dizionario la voce «radioattività» e poi farsela spiegare. Non
tutto ciò che è spiegabile è per ciò stesso comprensibile. Il problema
dell’invisibilità non chiama in causa la mancanza della pura e semplice «nozione» di un fenomeno fisico, da imputare a una «carenza cul-
turale» nel senso di una inadeguata preparazione scolastica o di un ciclo di studi insufficiente15. Si tratta di un problema profondo nel rapporto con la realtà, un blocco di senso nei dispositivi «culturali» (ovvero rappresentazioni, memoria, coscienza, linguaggio) mediante i
quali una comunità percepisce e «ordina» il proprio ambiente. Gli esseri umani fanno molto di più che vedere, udire, sentire, toccare, odorare, nel semplice senso di registrare il loro ambiente. Contemporaneamente, proprio mediante le esperienze corporee, essi lo interpretano, avanzano inferenze riguardo ad esso, lo sognano, lo giudicano,
lo immaginano, e si impegnano in ancora altre forme di conoscenza.
Ciò significa che i processi percettivi sono sempre anche simbolici.
Soltanto mediante la costruzione delle rappresentazioni simboliche
delle esperienze, ad esempio, la percezione visiva, oppure il linguaggio, risultano comprensibili. Queste forme di conoscenza variano a
seconda del contesto socio-culturale, proprio perché esse stesse sono
generate da, e rese significative in, un determinato contesto socio-culturale, storicamente e geograficamente definito.
Nella formulazione di Lev Vygotskij, i sistemi cognitivi funzionali
sono il prodotto del contesto storico-sociale entro cui il soggetto attiva i processi cognitivi elementari, ovvero quella serie di capacità
universalmente presenti in tutti gli esseri umani (non colpiti da particolari patologie): astrazione, categorizzazione, induzione e deduzione. Questi processi però non funzionano sempre allo stesso modo
per chiunque e dovunque, ma vengono «strategicamente» organizzati per risolvere particolari problemi che variano a seconda del contesto culturale (Vygotskij 1973). Si delinea qui il tema dei cosiddetti stili cognitivi differenti, ma per evitare sterili semplificazioni (logico/prelogico, razionale/prerazionale, moderno/tradizionale ecc.) ricordiamo che Claude Lévi-Strauss ha osservato come il pensiero delle popolazioni definite «primitive» non sia affatto privo di valenze
speculative, riflessive e teoretiche. Rispetto al pensiero scientifico
moderno nei selvaggi tali capacità sono esercitate solo in relazione a
contesti di esperienza e non in funzione di problematiche logico-formali astratte. L’antropologo francese definì la molteplicità degli
razione stessa è posta in termini di una dicotomia fra la visione e l’ascolto, le cui radici affondano nella storia intellettuale dell’Occidente. Nei termini di questa dicotomia, la vista è distanziante, oggettificante, favorisce un atteggiamento analitico e
atomizzante; l’udito è unificante, soggettivo, sintentico e olistico. La vista rappresenta un mondo esterno di esseri, l’udito partecipa nell’intimo al divenire del mondo...» (Ingold 2000, p. 155; cfr. Gusman 2004).
15
La definizione secca di radioattività è: «Proprietà dei nuclei di alcune sostanze di disintegrarsi spontaneamente, emettendo radiazioni particolarmente intense e trasformandosi in nuclei di altri elementi solitamente più leggeri», da La
Nuova Enciclopedia delle Scienze Garzanti, Garzanti, Milano 2000, voce «Radioattività», pp. 1193-1194.
62
63
aspetti speculativi del pensiero selvaggio con l’espressione «scienza
del concreto» (Lévi-Strauss 1964)16.
Si può affermare, per esempio, che la concettualizzazione dei
cambiamenti atmosferici differisca molto tra i Saami e i meteorologi.
Per questi ultimi il problema di determinare i cambiamenti climatici
consiste nel misurare variabili standard (temperatura, precipitazioni,
pressione dell’aria, velocità del vento ecc.) che devono essere isolate tra loro per poter eseguire i rilevamenti. Da questo punto di vista
il clima è quindi un concetto astratto e non vissuto. Per i Saami invece si tratta di percepire fasci complessivi di sensazioni corporee attraverso cui il tempo è qualcosa che ha a che fare con l’avere caldo
o freddo, con il sentirsi bagnati dalla pioggia o impauriti per l’arrivo
imminente di una tempesta. In altre parole, come hanno ben dimostrato le ricerche di Ingold e Kurttila (2000), il clima dei meteorologi è un fenomeno registrato, mentre il tempo dei Saami è un fenomeno esperito. La costruzione sociale del paesaggio (landscape) nella cultura saami è quindi un chiaro esempio di come operi uno specifico stile cognitivo. Si tratta di un processo costantemente attivo e
mai concluso, in cui la consapevolezza ecologica delle qualità sensoriali dei luoghi – prodotta da un raffinato adattamento ambientale –
inter-agisce e retro-agisce con un sistema di pratiche quotidiane (taskscape) che è appunto il modo specifico con cui i Saami svolgono la
pastorizia transumante di renne. Ed è proprio grazie a questo processo che si forma il sapere tradizionale saami sull’ambiente, che è
perciò un sapere su un fare, o meglio un saper fare: il saper fare i pastori di renne nell’ambiente naturale della Lapponia (Ligi 2007).
Le pratiche rivestono dunque un ruolo di fondamentale importanza nei processi di produzione e riproduzione culturale. Si usa dire con uno slogan propriamente anti-essenzialista: la cultura non è
solo qualcosa che hai, ma è soprattutto qualcosa che fai. Nello stile
cognitivo dei pastori saami, in cui il capire è strettamente connesso
al fare, molte forme di comprensione della realtà sono effettivamente dei «saperi della mano» (Angioni 1986): quando c’è qualcosa di
molto grave che non va, può essere proprio l’attività – o l’inattività
– delle tue mani a dirtelo per prima. Fra le famiglie di Brurskanken,
alcuni drammatici segnali della presenza invisibile e disastrosa di un
nemico comparvero proprio nello svolgimento delle normali faccende domestiche.
SECONDA SEQUENZA
Una casa immersa nel silenzio della campagna, fra le betulle bianche
ai margini della taiga. Interno. Giorno. Gunilde Apfjell, un’anziana
donna saami, è seduta in cucina insieme al marito. Il tavolo con l’incerata è accostato accanto al frigorifero proprio sotto la finestra, da
cui entra il sonnolento chiarore di uno degli ultimi pomeriggi estivi
in Lapponia. Ci parla una signora dall’aspetto stanco e rassegnato.
Le braccia sembrano inerti: le tiene costantemente appoggiate in
grembo come fossero fardelli pesantissimi. L’espressione del viso è
di una persona dolce e svuotata.
Gunilde Apfjell: Ora, dopo la macellazione c’è calma, [pausa] e rimarrà così per un po’, ma presto sarà la stagione degli accoppiamenti e il
branco ha bisogno di sparpagliarsi. Occorrerà un mese, un mese intero
prima che sia tutto finito, ma dopo questo periodo li raduneremo di nuovo. [Pausa] Nel frattempo gli uomini riposeranno, dopo un così duro lavoro svolto sulle montagne.
Henriksen: Gli animali vengono lasciati completamente soli?
Gunilde Apfjell: Sì, restano soli perché devono essere liberi di sparpagliarsi. Infatti quando i maschi delle renne si incontrano diventano
molto aggressivi e possono anche arrivare ad uccidersi fra loro.
[Pausa]
Henriksen: Ciò che lei ha descritto, e che abbiamo visto finora, sembra normale. Il bestiame viene radunato e messo dentro al recinto.
Gunilde Apfjell: Sì è normale. [Pausa] Quello che non è normale è
che io come massaia provi una gran pena: [pausa] non riesco ad abituarmi al fatto di non poter utilizzare la carne di renna e che mi sia proibito
di portarla a casa. [Pausa] Adesso per esempio dovrei essere indaffarata
a sistemare le interiora, invece non ho niente da fare.
6. La debole ragione dei numeri
16 Per un esempio di «scienza del concreto» saami si veda Århen 1994; Ligi
2003, pp. 268-273.
L’invisibilità cognitiva, aggravata spesso da mutamenti improvvisi nel
flusso delle pratiche sociali quotidiane, è un fattore problematico che
accompagna molti tipi di disastro. In genere è necessario un notevole sforzo culturale da parte dei singoli individui – e del gruppo sociale nel suo insieme – per riattivare quei delicati processi di attribuzio-
64
65
ne di senso alla realtà e interpretare gli eventi terribili che li hanno colpiti. A tale proposito Ulrich Beck ha scritto pagine molto significative, sulle quali torneremo più analiticamente in seguito: proprio all’inizio della sua opera più famosa, esattamente nella prima parte intitolata Sul vulcano della civiltà: il profilo della società del rischio, egli introduce il tema dell’invisibilità in modo assai eloquente:
Si racconta che nel XIX secolo i marinai, se cadevano nel Tamigi, non
morivano per annegamento, bensì per i fumi maleodoranti e le esalazioni velenose di questa cloaca londinese. Anche una passeggiata per gli angusti vicoli di una città medievale non poteva che essere un vero supplizio per il naso. «Gli escrementi sono ammucchiati ovunque, nelle strade,
attorno agli sbarramenti, nelle carrozze [...]. Le facciate delle case parigine sono cosparse di urina [...]. L’occlusione socialmente organizzata
minaccia di trascinare tutta Parigi in un processo di putrescente decomposizione» [cit. da A. Corbin, Pesthauch und Blütenduft, Berlin 1983, pp.
41 sgg.]. Tuttavia è evidente che i pericoli di allora, diversamente da quelli di oggi, pungevano il naso, o gli occhi, ed erano quindi percepibili dai
sensi, mentre l’aspetto tipico dei rischi della civiltà odierna è che essi si sottraggono alla percezione, e sono localizzati nella sfera delle formule fisiche
e chimiche (si pensi alle sostanze tossiche negli alimenti o al periodo atomico) [corsivo mio]. A ciò è direttamente connessa anche un’altra differenza. Nel passato questi tipi di pericoli potevano essere ricondotti ad
uno sviluppo insufficiente delle tecnologie dell’igiene. Oggi essi sono il risultato di un eccesso di produzione industriale (Beck 2001, p. 28)17.
Nella postfazione alla Società del rischio, citando il lavoro di Joost
van Loon, Beck osserva:
Solo pensando al rischio nei termini di una costruzione possiamo
comprendere la sua «essenza» indefinibile. I rischi non possono essere
compresi al di fuori della loro materializzazione in particolari mediazioni, siano esse scientifiche, politiche, economiche o popolari. Ritengo che
questo sia il modo in cui i concetti di costruttivismo e realismo, sebbene
in apparenza incompatibili, possano essere complementari. I media elettronici coinvolti nella crisi della mucca pazza (ESB, encefalite spongiforme bovina) coniugano scienza, politica e cultura popolare del consumatore. Nel far ciò rendono visibile l’invisibilità del rischio, ad esempio i
prioni, mutevoli agenti patogeni della ESB. Noi, i consumatori di queste
immagini, non abbiamo alcun mezzo di saggiare l’adeguatezza di tali rappresentazioni, e non dobbiamo assolutamente farlo.
E aggiunge:
La loro origine [delle rappresentazioni] è fabbricata, prodotta in laboratorio sotto i microscopi e ulteriormente ingrandita dalle simulazioni
computerizzate. La loro fonte è una realtà cybertecnologica, unendo chimica, biologia molecolare e medicina alla grafica computerizzata e alla televisione. Il fatto di rendere visibile il prione in quanto simulazione computerizzata ha permesso a nuove trasmissioni di iniziare a interpretare
l’ininterpretabile (ad esempio a dirci cosa «sono» realmente la ESB e la SCJ)
e a spiegarci l’inspiegabile (come un prione normale – qualsiasi cosa possa essere – può diventare «patologico»). [...] Il «farsi realtà» del rischio
della mucca pazza è direttamente correlato con la sua diffusione mediatica (Beck 2001, p. 328, corsivi miei).
Il documentario etnografico di Georg Henriksen mette bene in
evidenza anche un’altra serie di problemi di ricerca che si pone l’antropologia dei disastri, come per esempio quello di studiare il ruolo
svolto dalle autorità nel gestire l’evento critico. I provvedimenti pubblici nelle situazioni di emergenza di massa, come vedremo, hanno
effetti diretti sulla percezione differenziata del rischio e soprattutto
sulla costruzione della vulnerabilità sociale. Nel caso di Brurskanken, in cui il disastro è costituito da una gravissima forma di contaminazione ambientale, uno dei primi provvedimenti del governo
norvegese fu quello di elevare il livello massimo di radioattività consentito nella carne di renna per alimentazione umana da 600 a 6000
Becquerel.
17
Anche Deborah Lupton (2003, pp. 7-11) insiste sulla problematizzazione degli aspetti percettivi/cognitivi del rischio citando il lavoro di Robert Muchembled
sulla vita quotidiana nella Francia medievale.
Henriksen: Qualcuno compra la carne di renna?
Un macellaio dell’Helgeland: Pochissime persone.
Henriksen: Come mai non è in mostra?
Macellaio: Non ne vale la pena.
Henriksen: Se qualcuno la chiedesse lei la venderebbe?
Macellaio: È stata controllata ed è garantita sotto i 600 Becquerel.
Henriksen: Anche le altre carni?
Macellaio: Tutte le carni vendute in Norvegia sono garantite sotto i
600 Becquerel.
Henriksen: Le cose peggioreranno se il limite verrà elevato solo per la
carne di renna?
66
67
Macellaio: No, io penso che le cose non potranno andare peggio di
come vanno ora. Se alzeranno il limite certamente avranno le loro buone
ragioni, ma per i consumatori non cambierà niente, resteranno sempre
diffidenti.
Henriksen: Lei mangerebbe carne che contiene 6000 Becquerel?
Macellaio: Certo, senza problemi.
Per i bovini e gli ovini la contaminazione era sotto controllo, ma
per le renne i limiti dovevano essere alzati. Secondo i calcoli congiunti dei ministeri della Sanità e dell’Agricoltura, portando la soglia massima da 600 a 6000 Becquerel, si sarebbe potuto consumare, nell’anno, il 75% della carne di renna per alimentazione umana. Il provvedimento avrebbe avuto l’effetto di normalizzare la situazione per gli
allevatori di renne senza comportare rischi per la salute delle persone. Le autorità ministeriali per gli Affari sociali, responsabili finali della decisione, dichiararono che inizialmente l’aver fissato il limite a 600
Becquerel fu un provvedimento affrettato e forse parzialmente ingiustificato, frutto dell’emergenza e della paura di esporre la gente al rischio delle radiazioni provocate dal cibo contaminato. Si sviluppò
un’intensa discussione con i governi vicini della Svezia e della Finlandia, poiché apparve chiaro che l’innalzamento del valore limite avrebbe provocato sulla cultura saami degli effetti molto difficili da controllare e non si disponeva di alcun genere di informazione scientifica su casi analoghi. Fu possibile alimentare gli altri animali con foraggio speciale per riportarli sotto il limite di radioattività, ma purtroppo con le renne la situazione si presentò più grave: esse vivono allo stato brado e non possono essere alimentate in modo programmato, così l’innalzamento del limite fu ritenuto indispensabile. Qui
emerge il tema del rapporto tra informazione, emergenza e decisioni
politiche. Talvolta, in situazioni particolarmente gravi, o per crisi acute senza precedenti, il contesto operativo di «emergenza», in cui si trova il decisore, può caratterizzarsi proprio per il fatto che si è costretti
a prendere urgentemente decisioni importanti senza poter attendere
i tempi lunghi della ricerca scientifica, e dunque senza poter disporre
di tutte le informazioni necessarie sul caso, con il rischio di inviare
messaggi ambigui o contraddittori alla popolazione.
Henriksen: Lo farete solo per la carne di renna?
Ministro: Sì, per il momento abbiamo deciso così. La maggior parte
della gente mangia carne di renna da una volta alla settimana a una volta
68
al mese, quindi portare il limite sopra i 600 Becquerel non comporta rischi per la salute dei cittadini. Possiamo alzare il limite o decidere di lasciarlo com’è, ma comunque dobbiamo fare qualcosa per i Saami, perché
essi si nutrono di questa carne più degli altri. [Pausa] In ogni modo ancora non abbiamo preso una decisione definitiva. Stiamo valutando gli effetti psicologici che deriverebbero da un limite più elevato e quelli economici provocati dall’attuale limite, potremmo distruggere una cultura e
una tradizione di grande importanza per la vita dei Saami.
Come si armonizza la razionalità scientifica che si sforza di determinare numericamente il livello di pericolo con la razionalità sociale
delle persone che rifiutano in ogni caso di mangiare carne? Oppure
al contrario: come si gestisce la propaganda pericolosa (poiché può
essere causa dell’aumento di vulnerabilità, se non addirittura di casi
di contaminazione umana) da parte di commercianti e macellai che
dichiarano di mangiare in sicurezza bistecche di renna da 6000 Becquerel, in barba ai valori limite forniti dal ministero della Sanità? Su
quali basi di conoscenza si attivano le catene decisionali che decretano «d’ufficio» l’innalzamento della soglia di radioattività consentita, da 600 a 6000 Becquerel (quindi decuplicando il valore limite)?
Come si accorda la naturale lentezza degli esperimenti scientifici di
controllo sulla sicurezza entro un certo valore, e la prudenza degli
esperti, con la rapidità e soprattutto con l’efficacia dei provvedimenti volti ad arginare un’emergenza di massa?
L’antropologia dei disastri si pone il problema se sia possibile rispondere in modo univoco a domande come queste; o se, al contrario,
nell’analisi socio-economica delle soluzioni, occorra tener conto del
fatto che il corpo sociale non è un unico blocco compatto e uniforme
da inscatolare ed etichettare come «i Norvegesi» (oppure «gli Arabi»,
«gli Azande», «i Cinesi» ecc.). Esso è invece stratificato, variegato,
eterogeneo, e non presenta più solo i classici «dislivelli interni di cultura» (Cirese 1966, 1971) ma risulta articolato, secondo modalità più
complesse, in differenti componenti culturali – spesso già in conflitto
fra loro prima dell’evento critico – quali, ad esempio: la popolazione
norvegese, la comunità finnica, quella degli immigrati turchi e slavi, i
gruppi saami (a loro volta internamente differenziati in Saami pastori
e Saami non più pastori; Saami che allevano in ecosistemi montani e
Saami insediati in habitat di taiga; e così via)18. Disarticolare il con18
Per autodefinirsi, i Saami utilizzano una suddivisione interna in vari sotto-
69
cetto astratto di «società norvegese» in forme concrete di umanità,
per interpretarne i comportamenti sociali sulla base delle loro razionalità multiple, è esattamente un’operazione di analisi antropologica.
Si tratta certo di un’operazione difficile ma indispensabile per elaborare corretti modelli di vulnerabilità. La sola modellistica matematica, in cui talvolta si ripone la vana speranza di catturare oggettivamente il profilo di un evento estremo (fotografando con chiarezza il
volto del nemico), non è purtroppo sufficiente. Per dirla con un noto
slogan, la domanda chiave è: how safe is safe enough? Quanto al sicuro
occorre essere, per essere abbastanza al sicuro? Come vedremo la risposta è una questione di politica, non di fisica, di fronte alla quale la
ragione debole dei numeri è destinata a soccombere: non perché le
analisi tecnico-fisiche, epidemiologiche e bio-mediche non siano importanti, ma perché esse non sono costitutivamente in grado di fornire la certezza. Le decisioni prese su modelli probabilistici, in condizioni di incertezza, sono sempre frutto di un dibattito socio-politico:
quindi – in senso antropologico – sono sempre un prodotto culturale.
TERZA SEQUENZA
Henriksen accompagna Gunilde Apfjell e suo marito Arne nello studio del veterinario di Mosjön, incaricato dal ministero della Sanità
di verificare i livelli di radioattività presenti nella mandria di proprietà della famiglia Apfjell. L’antropologo riprende in diretta, senza mai intervenire, il dialogo in cui il medico comunica ai due Saami
il referto delle analisi.
Interno. Giorno. Laboratorio di analisi cliniche. Il medico veterinario entra nella stanza accompagnato da un’infermiera. È un uomo di mezza età tipicamente scandinavo: magro, molto alto, capelli
biondi. Si muove con modi affettatamente cortesi e supponenti, indossa un lungo camice verde che trasmette un senso di igiene e al
tempo stesso di pericolo. Occhiali ampi, montatura d’acciaio, forma
geometrica. Lo sguardo delle scienze esatte. Tenendo in mano un foglio, si rivolge a una coppia di anziani piuttosto tarchiati e non alti
(gli arrivano entrambi appena all’altezza della spalla). Indossano delle pesanti giacche a vento blu scuro che li rendono goffi. Gunilde
porta un tipico cappello saami, un kufte di lana fatto a mano. Sono
visibilmente a disagio, come intimiditi, e anche molto preoccupati.
Veterinario: Vediamo i risultati. Questa arriva a 39.505 Becquerel.
[In quel periodo, in Norvegia, il livello massimo di radioattività consentito nella carne di renna per alimentazione umana era di 6000 Becquerel. Il livello medio riscontrato nelle carni in Gran Bretagna era di 300
Becquerel].
Il medico porge il referto ad Arne Apfjell. Il pastore prende in mano il foglio senza dire una parola. Non lo legge, lo osserva, come se
stesse afferrando un oggetto strano di cui non capisce bene cosa fare.
Gunilde Apfjell: È questa la media?
Veterinario: No, si riferisce a questa carne [indica una porzione di
carne sotto vetro sul tavolo del laboratorio]. Facciamo 15 o 20 rilevazioni sugli animali macellati. Le cifre variano.
Il medico toglie di mano il referto ad Arne Apfjell, non comprende il senso della domanda e offre l’unica risposta possibile, cioè
una risposta tecnica: legge di seguito l’intero referto riversando sui
due pastori una raffica di cifre.
Veterinario: Ce n’è uno che raggiunge i 43.470 Becquerel, su quest’altro ne abbiamo riscontrati 39.535, su un altro 32.128 Becquerel, poi
37.857 e 37.772 Becquerel.
Si sta verificando una separazione sempre più netta dell’«ordine
delle parole» dall’«ordine delle cose» (Foucault 1988; cfr. Paine 1982,
1987). Per un Saami, che sa riconoscere e chiama per nome una ad una
le renne del suo branco (a volte qualche centinaio), la perdita degli
animali a causa della contaminazione non è solo un fatto economico,
ma rappresenta anche un grave problema affettivo:
Gunilde Apfjell: Allora non ci sono molte variazioni.
gruppi etnici fondata proprio sulle caratteristiche geografiche locali, da cui dipendono diversi tipi di risorse e differenti forme di insediamento (Fjellström 1985).
Il veterinario non coglie ancora il punto: all’anziana saami – che
vive con una numerosa famiglia esclusivamente grazie alla pastorizia
– non interessano affatto i coefficienti di variazione tra valori sul
campione analizzato. Vuole soltanto sapere se e quando potrà mangiare la sua carne:
70
71
Veterinario: Ci sono sempre variazioni. Come vede ce ne è uno con
32.000 Becquerel e un altro con 43.000 Becquerel. Generalmente ci sono varizioni.
Gunilde Apfjell: Ma nessuna è al di sotto dei 6000 Becquerel.
Veterinario: Per ora no, è improbabile che lo sarà.
[Pausa]
In questa situazione, da un punto di vista antropologico, potremmo dire che a una misura aritmetica (quantitativa) della gravità
– prodotta mediante modelli matematici – viene contrapposta una
misura affettiva della gravità, formatasi attraverso un’esperienza di
sé, col proprio corpo: due misure che sono fra loro incommensurabili, ma che, nell’evenienza di un disastro, devono potersi correlare.
Arne Apfjell, che fino a quel momento aveva tenuto gli occhi bassi, con un aspetto avvilito, o meglio, smarrito, solleva lo sguardo verso il medico:
Arne Apfjell: Noi abbiamo portato qui soprattutto animali giovani,
ma vorrei sapere qualcosa sulle femmine gravide. Che accadrà ai piccoli
che nasceranno?
Veterinario: Forse subiranno degli effetti genetici. Ma soltanto quando la ricerca avrà fatto luce sulla situazione conosceremo la loro entità e
l’effetto delle radiazioni.
[Pausa]
Gunilde Apfjell: Non possiamo mangiare la carne così contaminata?
Veterinario: No, 30.000 o 40.000 Becquerel sono cifre molto preoccupanti.
Gunilde Apfjell: Sono contenta di non aver preso carne prima. Nemmeno questa volta lo farò.
QUARTA SEQUENZA
Casa Apfjell. Interno. Sera. Un piccolo soggiorno con una poltrona
su cui siede Gunilde, al centro un tavolinetto basso e di fronte un divano su cui è seduto Arne, che armeggia con la pipa; sullo sfondo un
abete decorato con le luci intermittenti di Natale.
Gunilde Apfjell: È difficile farsi un’opinione sulle conseguenze della
radioattività. [Pausa] Se solo gli esperti, le persone colte sapessero qualcosa. [Pausa] Ma purtroppo non sanno niente e noi siamo altrettanto disorientati. Penso spesso con preoccupazione ai giovani che hanno scelto
questo lavoro.
Il senso di profonda fragilità del sapere scientifico occidentale di
fronte a disastri di questo tipo viene colto ed espresso con amara semplicità da un’anziana donna saami quasi analfabeta, che però – come
tutti i pastori della Lapponia – ha provato l’esperienza concreta
dell’essere fragili e precari. Il poeta saami Paulus Utsi ha racchiuso
questo millenario sapere della precarità in uno splendido verso:
La nostra vita
è come una traccia di sci
sulle bianche pianure aperte:
il vento la cancella
prima che nasca il giorno19.
Queste sequenze del documentario etnografico di Georg Henriksen ci hanno aiutato a delineare alcuni problemi di ricerca in antropologia dei disastri connessi al concetto di vulnerabilità sociale.
Abbiamo visto, ad esempio, che esistono eventi i cui agenti distruttivi o potenzialmente letali si manifestano in modo quasi, o del tutto, impercettibile, ma non per questo meno grave, e determinano
una situazione complessiva che si presta ugualmente ad essere classificata come disastro. È appunto il caso di alcuni tipi di contaminazioni ambientali: si può vivere per anni in una certa zona senza sapere di essere quotidianamente esposti ad agenti inquinanti altamente tossici presenti nell’acqua, nell’aria o nei prodotti agricoli.
Come abbiamo visto, però, a differenza di molti composti chimici,
la radioattività, essendo incolore, inodore e insapore, è ancora più
insidiosa e pericolosa. La nozione operativa di disastro va estesa a situazioni con agenti distruttivi i cui effetti – la loro disastrosità per la
salute della popolazione – possono manifestarsi lentamente, al termine di un lungo periodo di latenza o incubazione. Un disastro
all’inizio può essere invisibile.
Henriksen: Che accadrà se il livello di radioattività nei licheni resterà
alto per anni, rendendo difficile o impossibile l’allevamento delle renne?
Che probabilità di sopravvivenza avrà la cultura saami?
[Pausa]
19
Traduzione dall’inglese di Lucia Zorzi (2000, p. 171), dalla raccolta In the
Shadow of the Midnight Sun. Contemporary Sami Prose and Poetry, a cura di H. Gaski, Davvi Girji OS, Karasjok 1997.
72
73
Nel corso di questo capitolo abbiamo messo in evidenza l’importanza antropologica del nesso uomo-luogo per comprendere il
cosiddetto paradosso delle catastrofi. Vale a dire un complesso comportamento sociale per il quale alcuni gruppi umani, o addirittura
intere popolazioni, ritengono maggiore il rischio di smarrire la propria cultura essendo costretti ad abbandanare il loro territorio d’origine rispetto al rischio di essere esposti a gravi disastri naturali o tecnologici continuando a vivere nei loro insediamenti tradizionali. Come vedremo nei prossimi due capitoli, i profondi vincoli antropologici, oltre che storico-culturali ed economici, che legano una comunità al proprio ambiente, se da un lato, in alcuni casi, possono costituire una sorta di «ottundimento» – e cioè possono portare a una
percezione sottostimata del rischio e a un’errata comprensione del
pericolo –, da un altro lato, rispetto ad altri generi di disastro, producono al contrario quella sorta di «lungimiranza» nativa nei confronti delle catastrofi, che talvolta si osserva in qualche popolazione
tradizionale. Di fronte alla variabilità dei rischi e alla molteplice varietà di disastri che possono accadere, potremmo dire che ogni comunità, nell’arco della propria storia, e a seconda del tipo di pericolo che si trova di volta in volta ad affrontare, si caratterizzi per una
oscillazione fra atteggiamenti «ottusi» e atteggiamenti «lungimiranti». All’interno di una stessa comunità, gruppi sociali differenti possono contrapporsi, e talvolta anche entrare in conflitto fra loro, sulla base di questa opposta percezione del rischio, e mettere in atto
comportamenti ritenuti reciprocamente irrazionali e pericolosi. Per
comprendere questi atteggiamenti sociali e porli in relazione con il
grado di vulnerabilità, l’antropologia dei disastri ha elaborato i cosiddetti modelli a razionalità multiple, dei quali parleremo nei prossimi due capitoli.
3
Storicizzare la vulnerabilità
Qui su l’arida schiena
del formidabil monte
sterminator Vesevo [...]
tuoi cespi solitari intorno spargi,
odorata ginestra,
contenta dei deserti [...] dove
e la sede e i natali
non per voler ma per fortuna avesti;
ma più saggia, ma tanto
meno inferma dell’uom, quanto le frali
tue stirpi non credesti
o dal fato o da te fatte immortali.
Giacomo Leopardi
La ginestra
1. Rifare il mondo
Nel primo capitolo abbiamo visto che l’approccio antropologico agli
eventi disastrosi, e ai contesti di emergenze di massa, consiste in una
ridefinizione generale del concetto di «disastro», espressa dalla relazione:
(1)
D = I × V1
Lo studio tecnocentrico delle sole variabili fisiche (I) non è di per
sé sufficiente a spiegare le cause, la dinamica dell’evento e i danni
prodotti, né tanto meno può essere utilizzato per elaborare un mo1 Dove «D» sta per disastro, «I» per agente di impatto (variabili fisiche) e «V»
per vulnerabilità (fisica e sociale).
75
dello teorico efficace di comprensione e prevenzione. A questo set
di variabili fisiche se ne deve aggiungere un altro, che abbiamo definito come l’insieme delle variabili socio-culturali che possono avere
l’effetto di elevare o abbassare (talvolta anche annullare del tutto) la
pericolosità fisica dell’evento o l’intensità e la gravità del danno. Seguendo la letteratura più recente, abbiamo denominato questa seconda tipologia di variabili vulnerabilità sociale: qualunque situazione critica estrema si produce dall’interazione spesso imprevista, e
purtroppo ancora talvolta imprevedibile, fra vulnerabilità fisica e
vulnerabilità sociale.
L’antropologia dei disastri tenta di studiare non solo a livello
esclusivamente pratico applicativo, ma soprattutto a livello teorico
profondo, ciò che si debba intendere con l’espressione che un gruppo umano, una comunità, un villaggio (in società occidentali o extraoccidentali) è socialmente vulnerabile a una data categoria di eventi.
Nel capitolo precedente abbiamo sviluppato l’analisi di qualche
esempio concreto di vulnerabilità sociale, mostrando alcune delle
numerose componenti che la possono caratterizzare, come l’invisibilità cognitiva o la sottovalutazione dell’importanza antropologica
del nesso uomo-luogo. Continueremo ora ad approfondire questi temi chiave con lo scopo di mostrare come il concetto di vulnerabilità
(V) possa essere espresso nei termini del concetto di rischio (R).
L’idea di base che è contenuta nel concetto di vulnerabilità, l’idea
che in qualche modo sostiene il tema della vulnerabilità e gli dà efficacia interpretativa, è proprio il concetto di rischio. Fare antropologia dei disastri, significa, in realtà, fare soprattutto «antropologia
delle nozioni locali di rischio».
Il sentimento di carità del natio loco – descritto da Roberto Almagià – motiva quel duplice paradosso delle catastrofi, per il quale riscontriamo sia l’atteggiamento in apparenza irrazionale di chi non
vuole abbandonare la propria casa divenuta luogo pericoloso, sia il
profondo desiderio, parimenti «irrazionale», di chi vuole tornarci, dopo un’evacuazione forzata: «Talora un nuovo paese sorge in località
più sicura, ma il più vicino possibile, magari su un altro fianco della
stessa collina» (Almagià 1910, p. 391). Dopo la catastrofe, il problema ingegneristico e urbanistico di ricostruire le strutture fisiche, architettoniche, del centro abitato, si traduce sempre nel problema
strettamente antropologico di interpretare il senso di spaesamento
(displacement) dei sopravvissuti, e di contribuire alla ricostruzione del
loro paesaggio culturale. Scrive Oliver-Smith: «Ricerche recenti pon-
gono grande attenzione al concetto di luogo [place] nella costruzione
delle identità individuali e di comunità, nella codifica culturale e nella contestualizzazione della storia e delle categorie di tempo, e nelle
politiche delle relazioni interpersonali, interculturali e comunitarie»
(Oliver-Smith 1996, p. 308; cfr. Oliver-Smith 1982). Come rimarginare le ferite del paesaggio? Che fare delle strade, delle piazze, delle
abitazioni ridotte in macerie? Rifarle tutte perfettamente uguali a
com’erano prima del disastro, oppure riprogettarle in modo differente? Rifarle lì, nello stesso identico luogo, oppure altrove? Il problema
si può riassumere in ciò che scrive Jean Cuisenier per le case tradizionali di interesse etnografico e storico-demologico, ma che in linea di
principio può estendersi a qualunque genere di casa: «Le abitazioni
sono fatte di pietra e di terra, di legno e di stoppie non meno che di
operazioni e categorie dello spirito» (Cuisenier 1991, p. 12).
È prima di tutto un problema strettamente antropologico – e poi
anche un profondo problema di ricerca in antropologia dei disastri –
comprendere sempre meglio, a partire da casi concreti, come siano
legate queste «operazioni e categorie dello spirito» con le pietre, la
terra, il legno e le stoppie; ovvero comprendere come le costellazioni
simboliche di significati, affetti e valori si saldino alle strutture fisiche
dei centri abitati e degli ambienti naturali. Non è sufficiente ricostruire la struttura fisica dei luoghi, se non si tiene conto della struttura di sentimento che li anima; né, d’altro canto, è possibile occuparsi
del recupero affettivo, emotivo, psicologico, relazionale delle vittime
in modo del tutto indipendente dai luoghi in cui si trovano, dalla ricostruzione fisica dei riferimenti concreti, materiali (una strada, un
negozio, una chiesa, un bivio, una piazza ecc.), che hanno orientato
per decenni la loro vita quotidiana e che ora rimangono nella memoria come preziose ancore di nostalgia. Scrive Ernesto De Martino:
76
77
Quando gli uomini non sono al loro posto giusto. Ma non soltanto gli
uomini non sono al loro posto giusto, ma anche gli alberi, le case – in generale tutte le cose. Ha avuto luogo un cambiamento [...]. Gli uomini non
hanno più le loro cose con sé e ora le cercano. [...] Essi vogliono riavere
le loro cose e la loro patria. Il bel mondo non si può ricomporlo in modo
giusto. Il mondo di prima non c’è più, il bel mondo. (Ora com’è?) Mutato. (Che cosa è mutato?) Le case, le strade. Il globo terrestre è rimpicciolito, i monti non ci sono più. Essi più non sanno dove passano i confini. Il mondo è più piatto. Gli uomini non sono più a loro agio, sono spaesati. Anche io non sono più al posto giusto (Qual è il posto giusto?) Dove si è a casa. [...] (Quando andranno meglio le cose del mondo?) Quan-
do essi riavranno le case, quando saranno di nuovo a casa loro (avranno
il loro ambiente domestico nel luogo giusto). Quando tutto tornerà in ordine (De Martino 1977, p. 197, corsivi miei).
De Martino si riferisce a un giovane contadino affetto da crisi isteriche: un giorno il padre ha tagliato a sua insaputa la quercia piantata di fronte alla loro casa per venderla, e da quel momento il ragazzo
si è ammalato. Quel gesto, in apparenza insignificante, ha eliminato
un punto di riferimento fisico essenziale nell’orizzonte del paesaggio
domestico del ragazzo. L’albero non è più al posto giusto, né lui si sente più, d’un tratto, al posto giusto. Quell’albero orientava la sua vita e
la sua presenza lì, e contemporaneamente era un sostegno complessivo al senso del divenire del microcosmo intorno a lui. Il concetto
demartiniano di «crisi della presenza» non si riferisce agli individui a
sé stanti, isolati e astratti dal loro contesto di vita. Al contrario: la capacità del soggetto di pensare se stesso nel mondo è un tutt’uno con
la sua capacità di pensare il mondo, di riflettersi cioè negli elementi
familiari del suo spazio vitale, muovendosi e agendo concretamente
in esso. L’alterazione e il mutamento, a volte irreversibile, di qualche
riferimento concreto del proprio paesaggio quotidiano (specie quando il mutamento è repentino e radicale come nei disastri) provocano
una crisi della soggettività che si lega affettivamente al mondo, una
soggettività che non si dà soltanto in termini intimi, interiori, chiusa
negli oggetti interni della psiche, ma che – per dirla con Husserl – è
sempre una soggettività piena di mondo2. Si potrebbe dire sinteticamente che la relazione «io-cose» (alberi, oggetti, vie, mobili ecc.) è
un’espressione particolare della più profonda relazione «io-mondo»:
con la rottura della prima, va in frantumi anche la seconda. Per dirla
con Paolo Jedlowski (1989, p. 88), tale crisi «nella continuità delle
memorie e delle abitudini corrisponde [...] alle profonde trasformazioni che si operano nel mondo oggettivo della vita quotidiana» e
contemporaneamente «al cambiamento nel mondo oggettivo corrisponde un cambiamento nelle forme di esperienza».
Il mondo nel quale poco prima sono stato non c’è più, il bel mondo
[...]. L’esistenza abbandonata alla mancanza di delimitazione di questa
spazialità senza interni limiti di articolazione non ritrova più il qui e il là,
il determinato luogo e posto, in cui si collocano e a cui appartengono le cose. [...] La spazialità di tale mondo era determinata dalla casa e dal paesaggio in quanto sicura patria esistenziale (Heimat) (De Martino 1977,
pp. 200 e 205, corsivo mio).
Queste considerazioni di De Martino sul disagio di malati in terapia psichiatrica si applicano perfettamente alle sindromi da stress
che sono generate dai disastri e che scaturiscono, fra l’altro, dal senso di anomia territoriale delle vittime, costrette a ridefinire completamente se stesse e il loro rapporto con i luoghi e con le cose.
Un esempio particolarmente appropriato ci viene da un’ottima
etnografia sul terremoto di Nocera Umbra del 19973, nella quale un
frammento di quella impalpabile struttura di sentimento che conferisce spessore affettivo e culturale ai luoghi si mostra nel profondo
attaccamento della comunità alla torre dei Trinci, il «Campanaccio»,
distrutta dal sisma:
«Senza il Campanaccio non siamo più noi!» [...]. La ricostruzione dei
luoghi pubblici serve a rimettere in piedi la storia civica. «La cosa che c’ha
dato più fastidio è il Campanaccio (qui Pina intende il suo crollo), il nostro Campanaccio, la torre dei Trinci». La rovina del Campanaccio, come viene chiamata la torre civica nel linguaggio colloquiale, è stato un
trauma per tutto il paese. Vedere la polvere che usciva dalla porta vecchia e udire il frastuono dei mattoni della rocca frantumarsi al suolo è stato così impattante che molte persone sono svenute. «Per un momento ab-
2
Su questa radicale relazione io-mondo che non in astratto, ma mediante concrete pratiche di azione sociale costruisce l’individuo e allo stesso tempo la pensabilità delle cose, cfr. la significativa descrizione dell’habitus data da Pierre Bourdieu:
«L’esistenza umana, l’habitus come sociale fatto corpo, è ciò che al mondo fa sì che
vi sia un mondo: ‘il mondo mi comprende, io però lo comprendo’, diceva pressappoco Pascal. La realtà sociale esiste per così dire due volte, nelle cose e nei cervelli,
nei campi e negli habitus, all’esterno e all’interno degli agenti. E quando l’habitus entra in relazione con un mondo sociale di cui è il prodotto, è come un pesce nell’acqua e il mondo gli appare del tutto naturale. Per farmi capire meglio potrei prolungare la battuta di Pascal: il mondo mi comprende, io però lo comprendo, perché mi
comprende; proprio in quanto mi ha prodotto, in quanto ha prodotto le categorie
che gli applico, esso mi appare così naturale, così ovvio» (Bourdieu 1992, pp. 94-95).
3
Il sisma, di magnitudo 5,6 gradi Richter, colpì una vasta area dell’Appennino
umbro-marchigiano durante la notte del 26 settembre 1997 (alle ore 2.33), con epicentro nella piana di Colfiorito. La citazione è tratta da E. Marcorè, Abitare a Nocera Umbra dopo il terremoto del 1997, tesi di laurea non pubblicata, Università di
Roma La Sapienza, relatore prof. A. Sobrero, correlatore prof. A. Simonicca, a.a.
2004-2005, pp. 132-134. Questo minuzioso lavoro di campo sorretto da una solida
e ben articolata impostazione teorica è una delle rarissime tesi di tipo strettamente
antropologico assegnate in Italia su questi temi.
78
79
biamo pensato alla fine del mondo», dice Pina, intrappolata nel quartiere Santo Spirito al momento della scossa, mentre suo nipote, passando
sulla via Flaminia, vedeva in diretta il Campanaccio venire giù. «In quel
momento non ho pensato a nulla, ho solo avuto voglia di piangere», mi
racconta Tommaso. [...] «Io c’ho l’orto sotto alla torre, pensa che il figlio
mio... tutta questa torre è andata dentro l’orto e non si poteva entrare...
siccome i figli miei, io la domenica quando erano piccoli li portavo su perché c’avevano il giardino, loro si divertivano, giocavano, lui è molto attaccato a questo posto. Lui per esempio costruendo casa a Perugia è voluto andar su, ha preso una pietra del campanaccio e l’ha incastonata nel
camino. Sotto il camino c’ha questa pietra che è della torre campanaria.
Lui ne è orgogliosissimo di questa pietra che ha incastonato lì. Allora mi
diceva: ‘Anche tu la devi andà a prende mamma, quanno lo fai la metti
nel camino’. ‘No,’ – dico – ‘perché tu sei giovane a me dico po’ darsi che
me porta pure iella!’. Per dirti come uno è attaccato».
Un altro caso assai emblematico è quello della ricostruzione di
Longarone dopo il disastro del Vajont4. La ricostruzione fisica è terminata da vent’anni, pur essendo penosamente ancora in corso la ricostruzione sociale di una nuova comunità, che tenta con fatica di
formarsi fra i pochi superstiti rimasti a vivere lì, e i molti nuovi, giovani, abitanti, immigrati a Longarone da altre province. Così in alcune testimonianze dirette:
Perché qua, a Longarone tanti anni fa... era come il centro, come è adesso per noi Belluno che si va a Belluno perché si trova un po’ di tutto. E qua
tutti i paesi allora venivano a Longarone. Non avevano negozi, come anche a Podenzoi, Castellavazzo. C’erano pochi negozi. Ma quei paesi là
quando dovevano venire a fare la spesa: dovevano venire tutti a Longarone. [...] Longarone è sempre stato un paese dove siamo vissuti bene. [...]
C’era più cordialità fra noi altri, più fratellanza, come si dice; anche la gente era più socievole, eravamo come tutta una famiglia (Gina Pradella)5.
4
Mercoledì 9 ottobre 1963, alle ore 22.39, mentre era in corso la partita Rangers Glasgow contro Real Madrid, trasmessa in Eurovisione, e centinaia di persone si affollavano nella piazza e nel bar principale di Longarone, il versante del monte Toc scivolò nell’invaso artificiale, un immenso serbatoio a cielo aperto costruito
dietro a quella che all’epoca era la più grande diga del mondo. La frana gigantesca
fece traboccare l’invaso, provocando una catastrofica valanga d’acqua (50 milioni
di metri cubi d’acqua sollevati a un’altezza di 230 metri). In pochi minuti la cittadina di Longarone, a valle della diga, fu letteralmente cancellata e circa 2000 persone persero la vita.
5 Testimonianza in Mattozzi 2003, pp. 66-67.
80
Longarone era luogo di riunione per gli amici di tutte le frazioni e della vallata ed anche del Bellunese. C’era questa profondità di legame. Il disastro non ha distrutto Longarone come struttura architettonica che oggi potrebbe essere migliore di ieri. L’elemento umano è stato distrutto, le
trame dei rapporti umani che a Longarone non si ricostruiranno purtroppo mai più... se non ne verranno intrecciate di nuove dalle nuove generazioni [...]. Lo sfascio di questi rapporti si è manifestato proprio col
disastro, con lo smembramento delle famiglie, con la mancanza del novantanove per cento degli amici (Vincenzo De Villa)6.
Il tentativo di ricreare un centro abitato partendo dalle sole strutture urbane senza studiare a fondo le caratteristiche socio-antropologiche e storiche della comunità colpita, come nel caso del villaggio
di Vajont, costruito ex novo nell’alta pianura friulana per accogliere
gli abitanti di Erto e Casso, è completamente fallito (Vendramini
1994; Tessarin 1994). Attualmente in esso abitano persone di diversa origine e provenienza che stentano a formare un nucleo abitativo
con un proprio senso di comunità. Scrive Mario Passi (2003, p. 50):
Verrà infatti a Longarone il vecchio illustre Giuseppe Samonà, direttore dell’Istituto universitario di architettura di Venezia, con la squadra
dei suoi assistenti. Ma neanche loro, pur ricchi di un sincero entusiasmo,
riusciranno a immedesimarsi nell’animo dei superstiti, nello spirito dei luoghi. Anziché ripensare un paese di montagna, daranno vita in modo paternalistico a un progetto di scampolo di città moderna, edifici grigio cemento dal profilo orizzontale, senza spioventi per proteggerli dalla pioggia e dalla neve. E la gente di Longarone finirà per rifiutare questo regalo del governo che sente estraneo.
Oltre alle case, nel microcosmo naturale, ecosistemico e sociale
che viene scosso dal disastro vi sono poi ulteriori luoghi cardine che
sostengono il senso del «noi», orientano le pratiche sociali, le ritualità tradizionali, le concezioni, i valori, che sostengono il senso di comunità e offrono un valido motivo per non abbandonare quel territorio: sono i cimiteri. Si tratta, per così dire, di «luoghi sociali totali»,
caratterizzati da un denso spessore antropologico, a cui prestare la
massima attenzione per le eventuali opere di riconfigurazione urbanistica in fase preventiva, nel tentativo di mettere in sicurezza una
zona a rischio; per la scelta del sito di rilocazione (temporanea o per6
Testimonianza in Mattozzi 2003, pp. 92, 94.
81
manente) della comunità dopo il disastro; ed infine per gestire la lunga fase della ricostruzione. Il nuovo cimitero di Longarone, ad esempio, rappresenta un controverso caso di luogo intimo e privato per
custodire e onorare le spoglie dei propri cari, a cui si rivolge l’attenzione del singolo e della comunità; ma nello stesso tempo è anche un
monumento nazionale aperto a tutti, luogo di una memoria collettiva più allargata, che varca i confini della comunità e si apre a visite
guidate.
Da un punto di vista etnografico, gli esempi che mostrano la rilevanza dei cimiteri negli eventi estremi sono assai numerosi. Il problema di gestire la risoluzione del lutto, garantendo il pieno svolgimento della ritualità funebre, diventa cruciale in vari tipi di situazioni critiche: nelle emergenze di massa (in cui non sono rari addirittura i funerali senza corpo); nelle catastrofi naturali, tecnologiche
o provocate appositamente (come in taluni casi di guerra) in cui il cimitero è inaccessibile perché fisicamente distrutto; oppure quando
la sepoltura dei propri morti e/o la visita al cimitero viene impedita
a causa del permanere della condizione di rischio (ad esempio per le
gravi contaminazioni ambientali); oppure nei contesti di guerriglia,
in conflitti armati con profughi o deportati7. Dalla constatazione che
i disastri non si abbattono semplicemente su un luogo, ma che scuotono in profondità interi microcosmi, ricaviamo una volta di più la
convinzione che l’antropologia è uno strumento analitico essenziale
non tanto per la sola interpretazione e la decodifica dei significati
culturali conferiti allo spazio da una qualunque società occidentale
o indigena, ma soprattutto per la comprensione del disagio causato
dall’assenza di luogo, dallo spaesamento, di quel malessere profondo che De Martino definì angoscia territoriale (1952), ovvero lo sradicamento, e soprattutto l’incapacità di riambientarsi, il blocco di
una qualunque efficace strategia del fare, singola e comunitaria, di
operare e agire nei luoghi8.
Per un quadro aggiornato sulla rilevanza antropologica dei cimiteri, ma ancor
più in prospettiva trans-culturale, di tutte quelle porzioni dell’ambiente destinate
(con varie modalità) a ospitare i morti e a diventare fisicamente e simbolicamente
luogo dei morti, si vedano Favole 2003 e Favole, Ligi, Viazzo 2004.
8
Il fondamentale apporto dell’antropologia medica e dell’etnopsichiatria per
l’analisi teorica e per un contributo applicativo nella gestione delle emergenze di
massa in società non occidentali (ad esempio nei casi di sindromi da stress post-traumatico, PTSD) meriterebbe una trattazione specifica, che però rimandiamo ad altra
occasione. Per un orientamento bibliografico preliminare, e limitandoci all’ambito
7
82
2. Il sole di movimento
Nei paragrafi precedenti abbiamo messo in luce l’importanza storica, culturale e affettiva del vincolo che lega una comunità al proprio
ambiente e che determina scelte paradossali e in apparenza incomprensibili di attaccamento ai propri luoghi, quando ciò significa
esporsi a gravissimi pericoli. Cionondimento esistono numerosi
gruppi sociali che vivono in circostanze pericolose e sono insediati
in ambienti ad alto rischio, non soltanto perché non sono sufficientemente informati del pericolo, oppure perché lo percepiscono in modo differente dagli «esperti», o non hanno ricevuto una formazione
adeguata sui comportamenti in casi di emergenza; in alcune parti del
mondo, purtroppo, molte comunità non se ne vanno perché non se
ne possono andare. Non hanno altra scelta che vivere in aree a rischio
di frane, alluvioni, o terremoti, oppure esposte al pericolo di contaminazioni chimiche per la prossimità delle loro case con strutture di
deposito e stoccaggio di scorie tossiche. Si tratta di gruppi sociali
marginalizzati che vivono in aree cosiddette «in via di sviluppo», nelle quali le condizioni di povertà, di subalternità alla società inclusiva, la forte precarietà socio-economica, con scarsissime o nulle possibilità lavorative, sono diventate ormai croniche – se non addirittura strutturali. Molti di questi siti ad alto rischio, con abitazioni insicure e condizioni igieniche penose, sono sorti nelle periferie di enormi complessi urbani, in Brasile, in Africa, in India, che nel processo
di de-colonizzazione hanno attraversato una fase di esplosione demografica e di rapidissima quanto disordinata modernizzazione. In
questi contesti particolari l’antropologia dei disastri tende a connettersi con le ricerche antropologiche sui processi di mutamento pianificato, e di consulenza in piani di cooperazione allo sviluppo, in zone
fortemente depresse del pianeta, nelle quali programmi di massicci
resettlements e le pratiche di autocostruzione degli insediamenti
informali o spontanei sono anche focolaio di aspri conflitti, come ad
esempio le favelas a San Paolo, le gecekondus a Istanbul, le bidonvilles in Marocco, le jhuggis a Calcutta. Molte popolazioni che si trovano alla periferia territoriale e sociale del sistema economico globale
italiano recente, si vedano, da un punto di vista marcatamente psicologico, Axia
2006; Castelli, Sbattella 2003; cfr. Severi 2000. Per un percorso di riproblematizzazione critica dei concetti di malattia, cura e corpo, in ambito antropologico, si vedano, ad esempio, Cozzi, Nigris 1996; Beneduce, Roudinesco 2005; Galzigna 2006.
83
sono loro malgrado strutturalmente rese più vulnerabili da asimmetriche e non equilibrate relazioni economiche e di potere, che non
permettono loro l’accesso alle risorse di base del territorio, dell’alimentazione e della casa (Torry 1979a, 1979b, 1979c; Maskrey 1989).
Città del Messico – una metropoli di quasi 20 milioni di persone,
circondata da vulcani attivi – ha una lunga esperienza di terremoti,
che affiora sin dall’antica mitologia azteca, nella quale l’ultima era,
quella della quinta distruzione del mondo, è denominata epoca del
quinto sole, o sole di movimento, in cui appunto il mondo verrà devastato da uno spaventoso terremoto. Attualmente gran parte del
nuovo centro urbano è stato edificato su basi di fango molle, residui
di un antico lago prosciugato dai coloni spagnoli (che probabilmente poco sapevano sia della sismicità dell’area, sia dei terremoti in generale). Nel terremoto del 19 settembre 1985 (di intensità pari a 8,5
gradi Richter) persero la vita oltre 9500 persone in seguito a una riattivazione catastrofica della zona di subduzione al largo della costa
occidentale del Messico, che propagò onde sismiche per centinaia di
chilometri, fino alla capitale. L’ospedale Benito Juárez, una delle
principali strutture che avrebbero dovuto gestire l’emergenza, fu
completamente distrutto. Da allora la normativa di sicurezza degli
edifici è migliorata, ma si applica solo alle nuove costruzioni. Un sisma di tale intensità, che ucciderebbe decine o centinaia di persone
in California o in Giappone, in genere ha un bilancio assai più grave in America Latina o in Asia, dove molti edifici sono poco più che
pile di mattoni senza adeguati rinforzi9. In altro contesto, le ricerche
di Kakhandiki e Shah hanno mostrato, ad esempio, che nonostante
il rischio di terremoto nella regione sia molto moderato, a Lagos, Nigeria (popolazione nel 1995 di 10,3 milioni di persone), gli edifici
tendono a essere piuttosto vulnerabili ai danni sismici, considerando anche che il tasso di crescita della popolazione è di 5,7 per cento
per anno, e che il 23 per cento della popolazione urbana della Nigeria vive in quella città. Ciò tende a collocare Lagos in una categoria
di alto rischio per i disastri sismici, per quanto i dati sulla sismicità
della zona non lo indicherebbero (Kakhandiki, Shah 1998).
Tali questioni sul come costruire le case e dove rimandano a problemi che richiedono un’analisi molto meno tecnocentrica di quanto
non sembri: da un punto di vista strettamente antropologico, non è
mai facile attuare un progetto di mutamento pianificato mediante interventi esclusivamente locali, oppure con la cooperazione internazionale, volti a modificare le strutture degli abitati, le piante delle case, le loro forme e la loro disposizione sul territorio dei villaggi, senza considerare gli effetti trasformativi complessivi che questi interventi inevitabilmente comportano in tutto il sistema socio-culturale
locale10. Il tema diventa ancora più cruciale in società «tradizionali»
di interesse etnologico. Basti pensare al devastante processo deculturativo avviato fra i Bororo dell’Amazzonia brasiliana da parte dei
missionari salesiani negli anni Venti del Novecento, proprio a partire dalle modifiche della pianta del villaggio. Christopher Crocker,
celebre esperto di quella comunità, ha così descritto lo strettissimo
rapporto fra case e cultura:
9
Si veda l’importante antologia di studi antropologici sui disastri in Messico
curata da Mario Garza Salinas e Daniel Rodriguez Velázquez (1998) e quella di N.
Garita, J. Nowalski (1996); vanno anche menzionati i fondamentali studi teorici e
le ricerche etnografiche di Virginia García-Acosta sul tema della vulnerabilità sociale in America Latina (1995, 1996, 1997), cfr. Macías 1992.
10
Oliver-Smith ha dedicato diversi ottimi saggi al tema del rapporto fra ricostruzione, mitigazione e programmi di sviluppo. Si vedano, ad esempio, OliverSmith 1986a, 1986b, 1992; Oliver-Smith, Parker 1992.
11 Si veda anche il caso di modernizzazione e de-culturazione delle comunità
shuar dell’Amazzonia ecuadoriana attuato con grande efficacia mediante la pro-
84
85
Nella struttura circolare del villaggio i clan della parte Exerae occupano una posizione determinata nel semicerchio a nord, mentre quelli
della parte Tugarege sono situati di fronte, nel semicerchio a sud. Ma
all’interno della casa degli uomini, che è «l’asse dell’ordine categorico che
collega uomini a uomini, a natura e a divinità», la posizione relativa delle due parti è invertita, esprimendo così il dogma fondamentale di quest’ordine: che attraverso il rito gli uomini si trasformano in creature antitetiche alla loro identità sociale abituale, in membri, cioè, dell’altra parte
(Crocker 1969, p. 251; cfr. Fabian 1992).
Quando i salesiani iniziarono i programmi di catechesi e di conversione, si resero conto che per disarticolare il sistema di credenze
locale era necessario intervenire sull’organizzazione dello spazio fisico degli insediamenti. Obbligarono così i Bororo a riordinare le capanne in file parallele: l’effetto sui nativi fu devastante. La perdita
del supporto fisico-spaziale del loro millenario assetto culturale dapprima provocò shock e disorientamento, poi avviò un progressivo e
inesorabile processo di de-culturazione11.
3. «L’acqua coi denti»: saperi nativi, vulnerabilità, sviluppo
Nel 1292, il giovane Marco Polo, durante il viaggio di ritorno dalla
Cina verso Venezia, veleggiando lungo le coste dell’Indocina e della
penisola di Malacca fino all’India, dove avvistò le Nicobare e le Andamane, rimase colpito dalla rigogliosa bellezza dell’arcipelago indonesiano e sopratutto della «piccola Iava» (la piccola Giava), cioè
Sumatra:
Qui à grande abondanza di tesoro e di tutte care spezie [...], ànno il
migliore pesce del mondo, e non ànno grano ma riso; [...] a quest’isola
viene grande quantità di navi e di mercatantie, e fannovi grande guadagno; qui à molto tesoro che non si potrebbe contare12.
In Indonesia esistono più di trecento distinti gruppi etnici, ognuno
dotato della propria identità culturale, e vengono parlate più di 250 lingue diverse. Anche le credenze religiose sono molto varie: quasi tutte le
più importanti religioni del pianeta sono rappresentate nell’arcipelago, in
aggiunta ad una vasta gamma di culti locali. Le attività economiche includono l’orticoltura itinerante, la coltivazione del sago e dell’albero della gomma, la coltivazione del riso in campi irrigati, piantagioni di prodotti
per l’esportazione, il commercio ambulante, il commercio su larga scala,
la piccola industria, la manifattura moderna. I tipi di comunità variano
dal piccolo villaggio isolato alla grande città moderna; i sistemi di parentela sono sia matrilineari e patrilineari, sia bilaterali e la gamma delle
strutture politiche tradizionali include tutte le forme dalla tribù al regno
(Geertz 1963, p. 28).
gressiva trasformazione dell’unità abitativa tradizionale (la jibaría) nei più moderni «centri shuar», di pianta quadrata e con disposizione modulare (Israel 1985).
Cfr. La Cecla 1988.
12
Si veda Marco Polo, Milione. Le divisament du monde, a cura di G. Ronchi
(redazione toscana e franco-italiana), Mondadori, Milano 1982, pp. 18, 223-229
(ed. or. 1298).
In anni recenti, tutto il Sudest asiatico è diventato meta di sempre più intensi flussi turistici. Le città e i villaggi del circuito classico, Thailandia-Singapore-Indonesia-Malesia, e in particolare le isole
di Sumatra, di Giava e il Borneo, vengono rappresentati come territori mitici e favolosi, l’ultima spiaggia dell’Estremo Oriente misterioso (Hannerz 2001). Circa sette secoli dopo il viaggio di Marco Polo, le brochure turistiche e il materiale illustrativo delle agenzie internazionali e della promozione locale contribuiscono a rielaborare e
alimentare potenti stereotipi sull’Altro e sull’Esotico. Accanto al mito del buon selvaggio e a quello dell’Eden primordiale incontaminato, affiorano immagini nuove: «La Thailandia appare come il ‘paese
del sorriso’; Bali è la società della leggerezza e dei teatri; Bangkok vive nell’immaginazione mondiale per la vita notturna e per l’instant
sex di Patpong Road» (Simonicca 1997, p. 127). A questo proposito
l’antropologo Alessandro Simonicca ha diffusamente analizzato le
modalità con cui il fenomeno turistico si innesta nei processi di sviluppo e di trasformazione sociale del Sudest asiatico e come diventi
un fattore importante nelle dinamiche locali di costruzione dell’identità etnica in un contesto culturale così articolato. Molte feste e
danze tradizionali, per esempio, sono tutt’altro che scomparse, ma
appaiono revitalizzate e arricchite di elementi nuovi (Simonicca 1997,
pp. 99-147).
Nel tardo pomeriggio di una domenica di dicembre quest’«ultimo
paradiso» alle porte dell’Estremo Oriente è stato sconvolto da una
tremenda catastrofe. Il 26 dicembre 2004, alle 18.58, a poche miglia a
ovest dell’isola di Sumatra, nell’Oceano Indiano, a circa 10 chilometri sotto la crosta terrestre si è verificato uno dei più intensi terremoti
86
87
Ben tremila isole disseminate in un’area vasta più di cinquemila
chilometri fra Sumatra e la Nuova Guinea occidentale costituiscono
l’Indonesia e si presentano come una «gigantesca ghirlanda intrecciata intorno all’Equatore» (Scarduelli 1992, p. 11). Lussureggianti
foreste e catene montuose punteggiate di vulcani, molti dei quali attivi, si alternano a praterie di eucaliptus e sconfinate distese di campi di riso. L’Oceano Indiano e le acque dei vari mari interni che lambiscono le coste dell’arcipelago, come il mar Cinese Meridionale e il
mar delle Andamane, non sono percepiti dagli indigeni come elementi separatori o barriere, ma, al contrario, costituiscono il tessuto
vivo di connessione fra le isole, che ha consentito per millenni contatti, scambi, commerci.
La multiforme realtà geografica e culturale di questo angolo di
mondo, inserita nel più ampio contesto delle regioni circumvicine
(Thailandia, Filippine, Vietnam), è considerata di straordinario interesse dagli antropologi. Un mosaico di etnie (i Gayo, i Rejang e i Lampong di Sumatra, i Toraja di Sulawesi, i Dayak del Borneo, solo per citarne alcune), di credenze, di festività e rituali, è attraversato da rapidi quanto radicali processi di modernizzazione e mutamento socioeconomico. Hildred Geertz ne offre un quadro dettagliato:
mai registrati nella storia dell’umanità: 8,9 gradi della scala Richter,
pari a 12 gradi della scala Mercalli. I sismografi di tutto il mondo sono balzati istantaneamente a fondo scala. L’evento ha sprigionato
un’energia al livello massimo rilevabile dagli strumenti (Tozzi 2005,
p. 23-68). Verificatosi in mare aperto, il sisma ha inoltre provocato un
maremoto di proporzioni bibliche: dal punto dell’epicentro, un’onda concentrica, alta da principio meno di un metro, ha cominciato la
sua folle corsa alla velocità di circa 800 km/h. In prossimità delle coste l’abbassamento graduale dei fondali ha provocato un progressivo
innalzamento del muro d’acqua, finché l’onda si è trasformata in tsunami, ovvero un gigantesco maremoto in grado di distruggere buona
parte di ciò che incontra sul proprio cammino. E così purtroppo è avvenuto. Qualche superstite, scampato per miracolo al cataclisma, ha
raccontato di aver visto all’improvviso il mare ritrarsi completamente, i pesci agitarsi impazziti sul fondo, poi il vento e lo spostamento
d’aria; quindi, qualche secondo dopo, all’orizzonte, il muro d’acqua.
Lo tsunami si è abbattuto sulle coste di Sumatra, Thailandia, Sri
Lanka, India, Malesia, Maldive, provocando più di 200.000 morti.
Anche l’ultimo paradiso è parso perduto. L’«acqua coi denti» ha famelicamente morso la terra e ingoiato la vita di migliaia di persone13.
Dopo la catastrofe, in numerosi talk show, notiziari in edizione
straordinaria, trasmissioni – come si usa dire – «di approfondimento», è affiorata la retorica su «Madre natura» non proprio materna e
sull’estrema fragilità dell’uomo alla mercé di forze più grandi di lui.
Sulla scorta dell’aforisma di Will Durant: «Le civiltà prosperano con
il consenso della geologia, che però può cambiare opinione senza alcun preavviso»14, alcuni commentatori hanno sollevato il tema
dell’assoluta casualità di alcuni tipi di eventi naturali estremi. Per
esempio, Vittorio Feltri ha presentato un dvd dal titolo Il cataclisma
con queste parole15:
Voglio fare polemica contro quelli che fanno polemiche. I quali dicono che tutto era prevedibile e che quindi si poteva prevenire la disgrazia
enorme che ha colpito l’umanità. Non è vero niente! L’uomo non è in grado di fare nulla di fronte a certi fenomeni naturali. La natura è quello che
è, e noi facciamo parte della natura e non possiamo dominarla, purtroppo è la natura che comanda e noialtri dobbiamo soltanto ubbidire.
Questa impostazione, per altro assai diffusa, e che potrebbe essere definita come una sorta di paradigma dell’ineluttabilità, si fonda su almeno tre idee implicite: a) l’idea che vi siano dei fatti, degli
accadimenti, delle situazioni, che si possono definire in modo non
ambiguo come «disastri naturali», e tale definizione è assunta come
certa, appare autoevidente e non viene problematizzata; b) vi è una
ben precisa idea di «natura», di cosa debba intendersi con il termine «natura», e tale concetto è un dato oggettivo, indipendente dal
contesto e dai sistemi di significato che lo utilizzano; non viene per
nulla considerato (oppure viene considerato irrilevante) il fatto che
esistano concetti localmente differenti di natura e che il concetto di
«natura» possa essere formulato in modo del tutto indipendente
dall’uomo (dalle comunità umane e dai processi di antropizzazione);
c) vi è una ben precisa idea di «caso», o per meglio dire: una ben precisa teoria della causalità, ovvero un punto di vista sulle connessioni
«causali» fra eventi e sul loro margine di conoscibilità.
Secondo il paradigma dell’ineluttabilità, molti disastri naturali (la
maggior parte di quelli più gravi, soprattutto terremoti ed eruzioni
vulcaniche) sarebbero degli eventi del tutto casuali e ineffabili, dipendenti da infinite variabili fisiche relative a fenomeni geologici che
l’uomo ancora non comprende completamente o che di certo non
può ancora prevedere né controllare16. L’argomento, proposto talora con la rigidità delle certezze dogmatiche, è tuttavia importante e
ha implicazioni, potremmo dire filosofiche, assai profonde, ovvero
di interpretazione complessiva della realtà umana, su cui avremo
modo di tornare più volte nell’ultimo capitolo. A seconda della concezione che si ha del ruolo svolto dal caso e dalle attività umane (volontarie o involontarie) nel provocare alcuni disastri, si affronterà in
modo radicalmente diverso tutta una serie di questioni cruciali: che
13
Riprendo questa metafora dall’efficace titolo del servizio di Paola Mordiglia
per la trasmissione di Gad Lerner L’infedele del 15 gennaio 2005, dedicata al tema
del rapporto fra religioni e catastrofi naturali.
14
Cit. in Winchester 2004, p. 285.
15
Il dvd, uscito in allegato al giornale «Libero», è stato curato da P. Monesi in
collaborazione con L. Ronchi, Sodip, La7 e Radio Montecarlo. Il ricavato è stato
devoluto in supporto delle vittime del maremoto.
16
Si veda anche il provocatorio articolo del filosofo Fernando Savater, Lo tsunami è cattivo solo per noi uomini, nel quotidiano «La Stampa» del 5 febbraio 2005
(p. 26, copyright «El País»), nel quale, a parte un generico invito alla solidarietà, si
sostiene l’irriducibile ineluttabilità dei disastri naturali e la vanità di ogni tentativo
umano di comprenderne il senso.
88
89
cos’è una catastrofe? Possiamo elaborare una tipologia di catastrofi? Come si chiede Ted Steinberg nel suo volume Acts of God. The
Unnatural History of Natural Disasters in America, che cosa significa esattamente che un evento è «naturale»? (cfr. Klein 2007). Oppure: secondo quali criteri siamo in grado di distinguere un evento
naturale da uno prodotto dall’uomo?17 Paul Crutzen, premio Nobel
per la chimica nel 1995, ha introdotto la definizione di Antropocene
per il periodo geologico apertosi con la Rivoluzione industriale della seconda metà del Settecento18. La civiltà umana non sarebbe più
in balia di forze naturali di tale intensità da plasmare la storia geologica del pianeta, poiché l’umanità stessa, con il vertiginoso progresso tecnologico degli ultimi due secoli, sarebbe diventata una forza di
portata geologica: «...l’Antropocene è l’unica epoca geologica in cui
la natura non è una forza esterna che domina sul destino degli uomini: siamo noi, al contrario, a determinare i suoi equilibri»19. Che
concetto di «natura» utilizziamo parlando di catastrofi naturali?
Che cosa significa esattamente affermare che un evento (ad esempio contrarre una malattia rara, evitare un incidente, il guasto di un
impianto chimico ecc.) si è verificato «per caso»? Il verificarsi di un
evento qualunque è in generale un fatto più o meno probabile, ma
per certi eventi non siamo in grado di determinare con certezza se si
verificheranno oppure no: ciò è dovuto ai limiti attuali e contingenti delle nostre teorie scientifiche, o esistono invece dei limiti più
profondi, per così dire intrinseci alla conoscenza umana o alla struttura della realtà in cui viviamo, che ci impediranno sempre di stabilire con certezza se quel dato evento avrà luogo?20 Queste difficili domande sono molto meno astratte di quanto sembri, poiché dal modo di rispondervi dipende l’efficacia di interi filoni di ricerca, sviluppati con l’obiettivo di comprendere adeguatamente gli eventi
estremi, al fine concreto di intervenire nella gestione delle emergenze di massa per salvare delle vite umane.
Studiare in prospettiva antropologica il disastro naturale che nel
2004 ha devastato il Sudest asiatico significa porsi una serie di specifici problemi di ricerca, che essenzialmente sono di natura analoga a
quelli suscitati dai casi di contaminazione ambientale a Brurskanken
e dell’incidente nucleare di Černobyl’: sarebbe stato possibile costruire micro-modelli locali di vulnerabilità sociale al sisma e agli tsunami avvalendosi delle conoscenze etnografiche specifiche relative
ad ogni singola area o comunità colpita? Quindici minuti dopo la
scossa di terremoto, dal centro di rilevazione sismica Richard H. Hagemeyer - Pacific Tsunami Warning Center di Honolulu (Hawaii)
viene emesso un bollettino di massima allerta sul pericolo maremoto: perché è rimasto inascoltato? Perché gli esperti di geologia marina, di oceanografia, di sismologia, ritengono che un evento del genere diretto verso le coste delle Hawaii o della California avrebbe
prodotto danni assai minori?
Il geologo Mario Tozzi si è inserito nell’acceso dibattito sull’ineluttabilità o sulla supposta prevedibilità di questo disastro richiamando l’attenzione molto opportunamente sui saperi ecologici nativi delle popolazioni che abitano le isole Andamane e Nicobare, solo
politicamente indiane ma geograficamente indonesiane. In lingua tamil la foresta di mangrovie è definita da un etnema che significa «albero-controlla-le-onde»: come si possono valutare gli effetti amplificativi del disastro causati dal decennale e selvaggio abbattimento delle foreste di mangrovie a scopo edilizio? È ragionevole ipotizzare che
la struttura forte e ramificata di queste piante avrebbe agito positivamente sulla frammentazione e la conseguente perdita di potenza distruttiva del fronte d’onda (come ha fatto ad esempio, in profondità,
la barriera corallina in altre zone). Perché la maggior parte della popolazione autoctona, come gli isolani delle Andamane (noti ad ogni
buon studente di antropologia del primo anno), ha scelto da secoli di
abitare nell’interno e non sulla costa? Quali complesse concezioni
ecosistemiche, saperi naturalistici ed etno-scientifici, quali categorie
ecologiche native, hanno permesso ai gruppi Onge delle Piccole Andamane, agli Jerowa, agli Shompens della Grande Nicobar, ai Sentinelesi di North Sentinel Island, e ad altre popolazioni del Pacifico di
convivere con le catastrofi naturali?21 Al contrario di quanto può ca-
Nella terminologia anglosassone si utilizzano le espressioni natural e man-made hazards (disasters).
18
In verità l’era geologica attuale si chiama Olocene ed è iniziata 10-12 mila anni fa con la Rivoluzione agricola (o neolitica).
19
Si veda Crutzen 2005. «Noi siamo la prima specie a essersi trasformata in una
sorta di forza geofisica in grado di alterare il clima della Terra, ha detto Edward O.
Wilson, il fondatore della sociobiologia. Detta in altri termini, l’uomo è diventato
un fattore, anzi un attore, ecologico globale» (Bettin 2004, p. 10).
20 Cfr. Hacking 1994; Prigogine 1997; Ekeland 1999.
21
Anche se consideriamo soltanto l’Ottocento, i maremoti a Sumatra e dintorni
risultano assai frequenti: 10-2-1797, Sumatra occidentale (Padang), oltre 300 vittime; 24-11-1833, Sumatra occidentale, numerose vittime; 5-1-1843, Sumatra centra-
90
91
17
pitare in altre parti del mondo rispetto ad altri tipi di disastro – come
ad esempio in Lapponia per i Saami riguardo alla contaminazione radioattiva – nel Pacifico gli stili cognitivi delle popolazioni locali colgono perfettamente la pericolosità di certi fenomeni naturali, potenzialmente distruttivi, e sono in grado di leggere nell’ambiente anche i
più piccoli segnali d’allarme22. Questi esempi mostrano la complessità delle dinamiche sociali di fronte a un disastro, e l’importanza di
elaborare modelli analitici non univoci e rigidi, ma flessibili, «a razionalità multiple», che tengano conto del fatto che le variabili antropologiche possono orientare la comprensione locale del pericolo verso
l’ottundimento, ma anche verso la lungimiranza.
I gruppi sociali andamanesi, pur essendo coinvolti, da alcuni decenni, in un processo di cambiamento e di modernizzazione, continuano a vivere a stretto contatto con la natura, praticando caccia e
pesca, e una modesta attività di orticoltura. Essi «non dispongono di
tecnologie né di sistemi di allerta contro gli tsunami: sono stati quindi salvati dagli sciamani, si tratta solo di fortuna o c’è dell’altro?» si
chiede Tozzi. «In realtà queste popolazioni hanno agito secondo natura, tenendo conto della memoria della Terra più di quanto non abbiano saputo fare molti esperti e commentatori. [...] Non hanno dimenticato che è una terra di terremoti, di eruzioni vulcaniche, [...]
sono scappati nell’interno della boscaglia appena hanno capito che
quella marea era fuori fase rispetto al ritmo tidale consueto» (Tozzi
2005, p. 67, corsivo mio). Tali fenomeni erano già accaduti decine di
volte in quel contesto, la loro conoscenza (su cui si basa la millenaria scelta aborigena di non vivere lungo la costa ma di insediarsi
all’interno) è stata codificata e incorporata in narrazioni mitiche ed
elaborati sistemi di credenze, e poteva essere adeguatamente mappata con indagini etnografiche preventive. Al contrario, invece, per
quanto riguarda le isole Maldive,
a venire meno è stata la comprensione culturale dello tsunami, quella propria dei giapponesi che la parola hanno inventato: se pure si fosse riusci-
ti ad avvisare tutti, la gente non avrebbe compreso la gravità del fenomeno. Questo dimostra che oltre cento anni indietro, con la memoria, non
si riesce proprio a tornare, non solo perché quella popolazione è giovane, ma soprattutto perché la frammentazione di villaggi e famiglie non
consente più la trasmissione e la condivisione del patrimonio di esperienze degli avi che un tempo erano maestre di vita [...]. Anche il direttore della divisione sismologica del Servizio meteorologico indiano confessa: «Non abbiamo mai avuto a che fare con un fenomeno del genere»,
frase appena tollerabile se pronunciata da uno sprovveduto, decisamente inammissibile per uno scienziato. In Thailandia i responsabili del Dipartimento meteorologico e quelli delle Risorse minerarie hanno ampiamente sottovalutato l’allarme perché la memoria si era focalizzata sul
1998, quando fu previsto uno tsunami sulla costa di Phuket che però non
si verificò: furono condannati da tutti per avere allontanato i turisti e per
la cattiva pubblicità che da questo era derivata (Tozzi 2005, pp. 67 sgg.)23.
A mio avviso è assai importante dare risalto a questo genere di
considerazioni di tipo non tecnocentrico sulla vulnerabilità sociale alle catastrofi, proprio perché provengono da un geologo e dunque
dovrebbero contribuire ad arricchire il dibattito interdisciplinare
con le scienze sociali, e in particolare con l’antropologia – che può
essere talvolta accusata (in questo caso a torto) di tenere un atteggiamento «iper-culturalizzante», ovvero incline a trascurare l’empiricità oggettiva degli aspetti geofisici in favore di analisi interpretative, simboliste e soggettiviste dei nessi causali.
Qual è l’effettiva ricaduta sociale sulle popolazioni locali degli
immensi ricavi turistici, in termini di servizi, di assistenza medico-sanitaria, di dispositivi di sicurezza, di miglioramento generale della
qualità della vita? Nella trasformazione del rapporto sistemico uomo-ambiente, qual è l’influenza delle grandi catene alberghiere a gestione multinazionale, pronte ad appagare il gusto estetico del ricco
e annoiato turista occidentale in viaggio di nozze – in cerca del paradiso a due passi dal mare incontaminato e dalle sabbie chiare e
le (isola Nias), molte vittime; 16-2-1861, Sumatra occidentale, diverse migliaia di vittime; 27-8-1883, Isola Krakatoa (fra Giava e Sumatra), 36.000 vittime (Tozzi 2005,
p. 29).
22
Si pensi ai vari gruppi umani che convivono con l’intenso fenomeno del vulcanismo particolarmente presente in Oceania, ad esempio la popolazione di Tanna (Vanuatu), insediata da secoli alle falde del vulcano con attività esplosiva chiamato Yasur.
23
Sull’efficacia dei dispositivi di allertamento anticipato rispetto alla misura
della vulnerabilità sociale di molte comunità del pianeta, è significativo quanto ha
recentemente osservato il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, rispondendo così alla questione sul buco nel sistema internazionale di allarme anti-tsunami evidenziato nella catastrofe del 2004: «Rovesciamo la domanda. Non dobbiamo
chiederci se esistono buchi nei sistemi di allarme, ma dove esistono sistemi di allarme. La risposta è: solo in Giappone, California e Hawaii. Tutto il resto è un buco
nero», in «Focus», n. 21, primavera 2005, p. 7 (intervista di Claudia Giammatteo).
92
93
splendenti – intriso di retorica paternalistica sul nativo buono e servizievole, sempre pronto a rimboccarsi le maniche, ora però non più
per trasportare valige dal taxi alla suite, ma per tentare di ricostruirsi la casa?
Quali effetti hanno le religioni, i sistemi di credenze locali, le relazioni di potere che si instaurano quotidianamente nel tessuto sociale di quelle zone, nel plasmare le dinamiche psichiche in caso di
disgrazia? Quale rilevanza hanno vecchi miti di «apocalissi rovesciate», che danno inizio anziché porre fine al tempo umano, come
le credenze sré (Indocina) sull’inondazione primordiale, da ling kwo
(«il mare ribolle», in lingua jörai), da cui sarebbe scaturita l’umanità
stessa? Quale rilevanza può avere la comprensione antropologica
delle forme locali di famiglia, delle dinamiche di genere, degli schemi percettivi ed emotivi, e di molteplici altri elementi socio-culturali, nell’assistenza psicologica ai superstiti colpiti da gravissime sindromi da stress post-traumatico (PTSD)?
William Torry ha studiato le strategie governative di distribuzione
del cibo nelle emergenze dovute a siccità in India, proponendo di
differenziare l’analisi etnografica in base ai problemi specifici di
gruppi diversi secondo criteri che tengano conto dell’età, del genere, del senso di appartenenza etnica, della organizzazione tradizionale delle comunità, e così via (Torry 1986). In molte parti del mondo, i governi coloniali e i loro successori hanno attuato politiche rispondenti a pressioni e forze non indigene, hanno imposto sistemi
di produzione, riorganizzato insediamenti urbani e rurali, realizzato
massicci interventi di trasformazione dell’ambiente (miniere, centrali idroelettriche, silvicoltura, imprese industriali ecc.), limitando
sovente la mobilità della popolazione e apportando drastiche alterazioni a quel corpus di saperi ecologici nativi che per secoli aveva assicurato agli indigeni un controllo sui pericoli ambientali. Sulla base
di un’estesa etnografia in Bangladesh, Mohammad Q. Zaman, ad
esempio, ha messo in dubbio l’efficacia dei costosissimi sforzi ingegneristici – su larga scala – per il controllo delle inondazioni, raccomandando al contrario un programma di ricerca che sappia valorizzare, ed eventualmente potenziare (anche con mezzi e tecniche occidentali), le tecniche di controllo locali, basate sul modo di vita indigeno di convivere con le piene (Zaman 1989, 1991). Analogamen-
te, Oliver-Smith, con una pluriennale attività di ricerca storico-archeologica e antropologica in Perù, ha mostrato che gli adattamenti
generali e specifici delle culture andine precolombiane al loro ambiente sottoposto a forti rischi (un tipico hazard-prone environment)
erano ragionevolmente efficaci. Mentre l’alta mortalità prodotta dal
terremoto nel Perù settentrionale, del 31 maggio 1970 (7,7 gradi
Richter, con 66.794 morti), può essere messa in correlazione con i
cambiamenti indotti dagli spagnoli nella modificazione dei materiali da costruzione per le case, nel disegno urbanistico delle città, nei
modelli di insediamento, che nel lungo periodo hanno gradualmente determinato una condizione di forte vulnerabilità, fisicamente e
socialmente prodotta (Oliver-Smith 1994, 1999). In Amazzonia la
promozione governativa di schemi organizzativi basati su piccoli
produttori ha favorito una strategia di sopravvivenza di corto periodo, che a sua volta ha contribuito all’erosione dei suoli e alla definitiva perdita degli interessi nel ranching su larga scala del territorio
(Schmink 1982).
Da tutti questi esempi, appare dunque essenziale e imprescindibile stabilire delle connessioni tematiche fra gli obiettivi dell’antropologia dei disastri e l’analisi antropologica dei fenomeni di mutamento sociale, proprio come fu suggerito da Samuel Henry Prince,
nel suo pionieristico contributo del 1920, Catastrophe and Social
Change. Però il tema del mutamento non dovrebbe essere affrontato soltanto dal punto di vista della catastrofe, che già di per sé è uno
straordinario agente (naturale e/o tecnologico) di trasformazione sociale, ma anche da quello che applica all’analisi sociale un approccio
essenzialmente dinamista, considerando il flusso, il mutamento, il
conflitto non come una patologia, ma come la dinamica fisiologica
normale delle società, che fluidamente e contraddittoriamente sfuggono alla rigida modellizzazione normativa che ne dava l’etnologia
tradizionale, essendo aperte ed esposte a continue forme di contatto interculturale. Come vedremo, è quindi ingenua ed errata in più
sensi la visione dicotomica stretta che contrappone la società occidentale, l’Occidente modernizzato e sviluppato, alle società tradizionali «pure», «originali», «statiche», «incontaminate», e da sviluppare, che recepirebbero in modo automatico e indifferenziato non solo merci, tecniche e saperi elargiti dagli sviluppatori, ma addrittura
il significato stesso della parola «sviluppo».
Quindi il rapporto fra mutamento sociale e disastro va stabilito su
almeno tre livelli principali di analisi: a) sul piano generale: cioè le no-
94
95
4. Disastri e mutamento sociale
zioni socio-antropologiche di disastro devono basarsi su un approccio dinamista all’analisi sociale; b) sul piano del singolo evento disastroso, considerato come fattore specifico di mutamento, che attiva o
amplifica tendenze al cambiamento più o meno nascoste o latenti già
presenti nel corpo sociale della comunità colpita; c) sul piano delle
azioni politiche, economiche, sociali, locali e/o di cooperazione allo
sviluppo, che in fase preventiva sono attuate per diminuire la vulnerabilità e il rischio, oppure che vengono effettuate nel periodo postimpatto per il coping, l’assistenza sanitaria e la ricostruzione: tutti gli
interventi che concorrono in quella delicatissima opera tendente a rifare il mondo dopo un disastro diventano agenti di cambiamento che
influiscono sulla vulnerabilità sociale della comunità24.
Sviluppando questa impostazione, ricaviamo tre ulteriori aspetti
che caratterizzano l’idea di vulnerabilità e che sono connessi ai precedenti: a) non esiste una vulnerabilità a se stante, definita in termini generici e riferita in astratto a una società: si è sempre vulnerabili
a qualcosa; b) analogamente non esiste una vulnerabilità come fenomeno in sé, senza specificare non solo a cosa si è vulnerabili, ma anche chi è vulnerabile, quale sottogruppo sociale si trova, o è percepito (e da chi), in condizioni di vulnerabilità. Talvolta la definizione di
vulnerabilità può mascherare un pericoloso atteggiamento reificante, come se l’etichetta di popolazione «marginale» contribuisse di
fatto al fenomeno reale di marginalizzazione del gruppo (Bankoff
2001); c) infine: la vulnerabilità sociale di un dato gruppo a un dato
fenomeno critico non è mai definibile e mappabile una volta per
sempre, in modo rigido e statico. Anche il concetto di vulnerabilità
deve essere utilizzato in una prospettiva dinamista: la vulnerabilità è
variabile, si modifica continuamente nel tempo, e può essere accresciuta in modo insospettabile anche da quelle stesse azioni messe in
atto per ridurla.
Come ha recentemente osservato David Alexander (2000, pp. 74
sgg.), questa impostazione teorica per studiare i disastri attende ancora di essere adeguatamente sviluppata e le conseguenti ricerche etnografiche sono ancora, in buona parte, tutte da fare. Nel dibattito
24
Su queste cruciali questioni antropologiche si veda Colajanni 2007 (soprattutto il cap. 5, Il cambiamento sociale e culturale come tema centrale della ricerca antropologica, pp. 99-105; e poi i capp. 6, 9, 12, 14 e 15, dove i processi di mutamento vengono messi in relazione con i fenomeni di globalizzazione e con i dispositivi
rituali); Colajanni 1994. Cfr. Voget 1984, Lai 1996.
attuale il contributo antropologico – benché indispensabile – non è
ancora presente in forma stabile ed efficace. In molti saggi, relazioni,
rapporti di ricerca di impianto applicativo su questi temi, affiora ancora troppo spesso una visione rudimentale e semplicistica delle reazioni sociali al disastro nei paesi in via di sviluppo (come se tutte le
nazioni così definite fossero uguali). Si ha l’impressione che la povertà, il basso PIL, la mancanza di risorse vengano considerati fattori che
rendono le relazioni sociali e i sistemi culturali locali davvero «primitivi», per cui le azioni e le reazioni sociali comunitarie all’evento
estremo sono trattate in modo semplicistico e sono ritenute non così rilevanti da essere studiate a fondo. Concordo pienamente con
Alexander anche quando sottolinea gli sforzi di alcuni autori, ad
esempio di Turton (per il Corno d’Africa) e di Oliver-Smith (nelle
Ande), di sfatare questo mito evoluzionista della «semplicità» delle
società extra-occidentali di fronte alle emergenze di massa e delle categorie cognitive, simboliche, rituali, utilizzate dai nativi per interpretare i disastri. Il solo approccio realmente efficace è quello di «vedere l’impatto sociale del disastro in termini di due fattori determinanti fondamentali: la storia e la cultura» (Alexander 2000, p. 34). È
impensabile non considerare il contesto sociale di un disastro che
colpisse la comunità di Santa Barbara in California e un villaggio
dell’Andhra Pradesh in India, dato che nel primo caso la collettività
esiste dal 1890 e nel secondo è invece il prodotto di un’opera di costruzione storico-sociale e culturale che agisce da secoli: «Gli eventi
sono trasformati in storia, la storia è assorbita nella cultura e ciò produce una matrice bene determinata [diremmo etnograficamente locale] di reazioni al disastro» (Alexander 2000, p. 34). In molte ricerche che utilizzano esclusivamente le nozioni tecnocentriche di disastro, la società colpita è trattata come se fosse un’entità chiusa e isolata, perfettamente modellizzabile, sospesa in un vuoto storico-culturale, fatta di vittime studiate essenzialmente come individui per i
quali la cultura – in senso antropologico – è poco più che un’appendice irrilevante. Ne risulta una visione irrimediabilmente meccanicistica dei microcosmi sociali, i quali sono immaginati come terreni
fertili per impiantarvi soluzioni tecnologiche all’evenienza disastrosa, o per la riduzione del rischio. Entro l’orizzonte tecnocentrico
– che giustamente riveste un ruolo di grande influenza nella ricerca
in questo campo – la variabile della differenza socio-culturale, in sede teorica, non viene adeguatamente considerata, e lo studio dell’impatto della tecnologia sulla società è scarsamente problematizzato.
96
97
Questo stile complessivo di produrre conoscenza sui fenomeni della realtà può trasformarsi in un pericoloso nemico invisibile.
Storicizzare la vulnerabilità significa, al contrario, circoscrivere e
soprattutto relativizzare la dinamica e le strategie interpretative degli eventi estremi ai contesti specifici nei quali si sono verificati: storicizzare come capacità di ricostruire la storia politica, economica,
sociale, religiosa – anche di lungo periodo – dell’area colpita e della
situazione critica, seguendo l’evolversi di tendenze apparentemente
estranee al disastro, come un’oscillazione demografica, i cambiamenti di un sistema economico, un flusso migratorio o un fenomeno
turistico, l’impatto graduale dei processi di modernizzazione (su varia scala, dalle singole comunità a un intero Stato), e così via.
Fare «antropologia dei disastri» o, per meglio dire, applicare i
metodi e le teorie antropologiche all’analisi dei disastri significa esattamente operare questa immersione degli eventi nel loro contesto, e
leggere la situazione critica in modo olistico e relazionale: ovvero posizionare i fenomeni che si vogliono conoscere entro un campo di relazioni, complesso e variabile, fisico e sociale, materiale e simbolico,
che li determina ed entro il quale acquistano senso i vari soggetti del
processo osservativo: le comunità, le scelte politiche, gli interventi di
sviluppo, le ideologie politiche, i comportamenti individuali, le grammatiche di azione degli sviluppatori e degli sviluppati, le percezioni
sociali, e così via. Il cuore dell’approccio socio-antropologico agli
eventi estremi, per dirla con Oliver-Smith, è quello secondo cui il disastro è un fenomeno che si manifesta nel punto di connessione fra
società, tecnologia e ambiente, e può essere interpretato come effetto particolarmente eccezionale causato dalle interazioni profonde di
questi tre elementi. Dunque storicizzare la vulnerabilità vuol dire ricostruire la storia politica, economica, culturale e affettiva delle persone, e della comunità; ma contemporaneamente vuol dire anche ricostruire la storia fisica, climatica, geologica dei luoghi, del territorio, e dell’ecosistema, colpiti dalla catastrofe; significa infine porre
in relazione queste «biografie» di comunità e di contesti con la storia e le caratteristiche specifiche delle tecnologie utilizzate. Contro
atteggiamenti inclini al riduzionismo tecnocentrico, al fatalismo irresponsabile, oppure al catastrofismo ideologico, svelare con l’etnografia la struttura «diacronica», processuale, dell’evento estremo e
accettare la sfida teorica di comprenderne l’ineludibile storicità costituiscono a mio avviso la principale condizione di possibilità per
prevenire e comprendere il disastro.
98
5. Percezioni locali di rischio e vulnerabilità
A questo punto è indispensabile costruire una definizione più operativa di vulnerabilità, ovvero sottoporla a un processo di modellizzazione dalla quale possano scaturire variabili utili per una ricerca empirica di tipo etnografico. Abbiamo visto che la vulnerabilità sociale
di una comunità a un certo tipo di evento estremo non è data dalla
semplicistica somma dei fattori interni o esterni al sistema sociale, ma
è generata dalla loro complessa, multiforme e storicamente variabile
combinazione. I diversi fattori, modificandosi nel tempo, producono
situazioni e contesti irripetibili. Ma allora è possibile esplorare più in
dettaglio la struttura concettuale dell’idea di vulnerabilità e formulare un criterio per darne una sorta di misura qualitativa?
Partiamo dalla definizione di vulnerabilità dell’Unesco riportata
dal geologo Fred G. Bell:
Questo parametro V [vulnerabilità] è stato definito dall’Unesco come l’entità del danno inferto a un elemento o gruppo di elementi a rischio
dal manifestarsi di un fenomeno naturale di una data dimensione. Si
esprime con una scala che va da zero (niente danni) all’unità (perdita totale), quindi con valori frazionari. I fattori che di solito influenzano il danno sono la distribuzione della popolazione, le infrastrutture sociali o socioculturali e la differenziazione e diversità sociopolitica. Gli effetti di un
disastro si possono mitigare riducendo la vulnerabilità (Bell 2005, p. 5,
corsivo mio).
Il tema centrale di questa formulazione, secondo la nostra prospettiva, è appunto la presenza di «infrastrutture sociali o socioculturali e la differenziazione e diversità sociopolitica» che influenzano
l’entità del danno e su cui occorre agire sia nel momento di analisi
teorica, sia in quello di intervento applicativo per la riduzione della
vulnerabilità. A tale proposito David Alexander ha notato, con grande acutezza, che una delle ragioni per le quali non si sono fatti ancora grandi passi avanti nell’interpretazione globale di un evento naturale estremo (e dunque nemmeno verso una sua effettiva prevenzione) è la scarsa considerazione per l’analisi dei rapporti fra vulnerabilità e comportamento umano (e modellamento «culturale», non
solo psicologico, del comportamento umano)25. Il punto è cruciale:
25 Rinvio al dibattito già esaminato fra Kennet Hewitt e la scuola di Boulder. Si
veda il capitolo 1.
99
il modo di comportarsi (a livello individuale, collettivo, istituzionale), gli interventi concreti, le azioni, il piano delle pratiche sociali con
le quali di fatto funziona il processo di produzione e riproduzione di
un dato assetto culturale, possono tendere in modo determinante ad
aumentare o a diminuire la vulnerabilità, giocando proprio sulle «infrastrutture sociali o socioculturali e la differenziazione e diversità
sociopolitica». Da un punto di vista socio-antropologico lo studio
della vulnerabilità consiste essenzialmente in uno studio di comportamenti, di processi di azione sociale, e di strutture simboliche, di sistemi nativi di significato che rendono quei comportamenti comprensibili e li motivano.
Un ottimo esempio è offerto dalla conurbazione vesuviana e flegrea. Si tratta di un vasto insediamento con densità di oltre 15 mila
abitanti per chilometro quadrato e che si sta ancora sviluppando alle pendici di uno dei vulcani più pericolosi d’Italia e in un’area di
vulcanismo diffuso. L’area è priva di una rete stradale adeguata per
sostenere un’eventuale evacuazione e ciò ne accresce di molto la pericolosità. Le ragioni della scelta di esporsi a un rischio così elevato
(a parte l’incoscienza e l’assenza di vincoli) si possono comprendere
soltanto ponendole in relazione con valori, atteggiamenti, orientamenti complessivi della comunità rispetto all’«utilità» di un dato
comportamento (ovvero rimanere lì e non vivere altrove): ad esempio in termini di beneficio di potersi insediare in posizioni buone
nell’area metropolitana e con costi relativamente più bassi rispetto a
quelli di zone di uguale centralità e di minore rischio dell’area metropolitana stessa. Altrettanto significativa da questo punto di vista
è la situazione olandese. Tra gli eventi dannosi di questo secolo vi è
indubbiamente l’alluvione disastrosa che ha colpito l’Olanda nel
1953. Questo paese, che tra l’altro è uno dei più densamente popolati d’Europa, rappresenta un caso tipico di sfida al rischio – basata
su un raffinatissimo equilibro e su un contro-bilanciamento di «azioni», scelte, comportamenti, pratiche sociali e interventi urbanistici –
in quanto è posto al di sotto del livello del mare. Il modo di valutare il rischio nell’equazione di utilità è ben diverso da quello citato
dell’urbanizzazione vesuviana. Dopo il disastro tutte le dighe sono
state riprogettate ed è stato calcolato che il sistema sia esposto a rischio solo a partire da tempeste la cui probabilità sia di 10-4 per anno. A seguito di questi provvedimenti è tecnicamente escluso che
possa ripetersi un evento analogo a quello del 1953. Tuttavia, quest’ultimo resta presente nelle statistiche del rischio, anche se si è ve-
26
Per una discussione più approfondita di questo caso rinvio al saggio teorico
di Luciano Di Sopra (1984).
27
Si tratta di fiumi di fango incandescente, che scorrono a valle alla temperatura di circa 200 °C e con la consistenza del cemento liquido, dotati di alto potere
distruttivo e difficilmente contenibili.
100
101
rificato una volta e non si verificherà più a seguito di una avvenuta
prevenzione26.
Marie Augendre, geografa del Dipartimento di Ambiente, città e
società dell’Università di Lione 2-Lumière, ha svolto delle interessanti ricerche sulle modalità di percezione, rappresentazione e gestione fisica del rischio vulcanico in alcune comunità del nord del
Giappone, in particolare quella della moderna cittadina di Toyako
Onsen, che conta circa 7.000 abitati, nell’isola di Hokkaido, colonizzata tardivamente e per un lungo periodo territorio esclusivo degli Ainu (Augendre 2004; cfr. Perry, Hirose 1991). Toyako Onsen è insediata alle pendici del monte Usu, uno dei vulcani attivi più pericolosi
del mondo, con spettacolari e ricorrenti eruzioni, l’ultima delle quali, nel 2000, ha comportato l’evacuazione totale nel raggio di 8 chilometri, per la durata di 6 mesi. Come osserva Augendre, il rischio vulcanico presenta una doppia specificità. Da un lato può estendersi di
molto al di fuori dello stretto contesto locale: i lapilli e le colate di lava, come pure i lahar27 e le nubi piroclastiche, possono colpire zone
lontane dal luogo dell’eruzione; dall’altro esso interagisce direttamente con la società anche a prescindere dall’evenienza disastrosa
(nel fenomeno eruttivo), poiché obbliga alla costruzione e alla manutenzione di complesse e costosissime strutture di protezione (sabo)
(Ikeya 2002), e favorisce lo sviluppo di stazioni termali (onsen) di cui
i giapponesi sono appassionati, e che rivestono un grande valore culturale per la comunità.
Nella tradizione shinto, le onsen sono state considerate per secoli manifestazioni tangibili del sacro, e anche se attualmente il bagno
caldo ha perduto il significato di atto spiritualmente purificante, rimane una pratica quotidiana importante (Hori 1968, pp. 141-181;
Raveri 1989; Reader 1990). Inoltre, i vulcani attivi in Giappone sono fra le montagne maggiormente attrattive e preservate: 19 di esse
costituiscono o sono integrate in almeno uno dei 22 parchi nazionali del paese. Le stazioni termali-turistiche (che ad esempio nel 1990
hanno richiamato circa 4 milioni di visitatori, secondo le statistiche
della municipalità di Toyako Onsen) sono microcosmi resi ancora
più fragili dal fatto che le attività alberghiere, di svago e divertimento sorte intorno ai siti eruttivi hanno preso il posto dell’agricoltura e
costituiscono un’ingente risorsa economica alla quale nessuno vuole
rinunciare (Knight 1995). Gli altissimi costi sostenuti dalla comunità
per le opere di controllo e protezione, che la scelta di continuare a
vivere lì comporta, vengono contro-bilanciati, secondo la percezione locale del rischio, dagli elevati ricavi turistici, e sostenuti mediante una motivazione socio-culturale profonda, che deriva dal rapporto strettissimo fra uomo e ambiente radicato nella cultura giapponese, in cui la montagna può essere considerata come la coordinata
principale di una complessa geografia del sacro.
L’ampiezza dei «tempi di ritorno» delle catastrofi vulcaniche
(cioè la lunga durata fra due eventi distruttivi gravi), malgrado le
commemorazioni di passate eruzioni e l’informazione disponibile,
indebolisce la coscienza del pericolo e modella la percezione del rischio. Dalle ricerche di Augendre emerge inoltre che la messa in
opera di sistemi di protezione ha avuto l’effetto collaterale perverso
di rafforzare il sentimento di sicurezza degli abitanti, i quali ripongono un’eccessiva fiducia nei soli dispositivi tecnologici di controllo
del pericolo, dimenticando l’elevatissimo potenziale distruttivo dei
fenomeni naturali. Questo atteggiamento – che, come vedremo, è
stato definito minimalista, ovvero di inconsapevole e tendenziale
sottovalutazione collettiva del rischio – è a sua volta rinforzato dalle
enormi poste economiche in gioco in questi luoghi turistici.
Un’altra questione assai rilevante è poi quella relativa al problema del poco spazio nel territorio giapponese in relazione all’elevata
popolazione e alle numerosissime zone a rischio. Questo è il motivo
molto spesso avanzato per spiegare l’esposizione al pericolo come un
male necessario. Il processo di iper-concentrazione demografica,
delle attività industriali e del comparto terziario, è però effettivamente reale soltanto intorno alla città di Tokyo. Per il resto del Giappone, si registra invece un soprendente dato di crescita dello spopolamento periferico che interessa un numero sempre maggiore di comuni: nel 1995, il 45% del territorio veniva classificato come «zona
di spopolamento», di cui una buona parte nell’isola di Hokkaido: secondo Pelletier, l’idea di mancanza di spazio fisico edificabile in rapporto alla sovrappopolazione sarebbe soprattutto un luogo comune
degli osservatori stranieri e un mito che permette agli imprenditori
locali di far approvare grandi progetti urbanistici (Pelletier 2000, pp.
223-230; cfr. Berque 1976).
L’analisi della vulnerabilità sociale a Toyako Onsen richiede dunque uno studio etnografico attento della volontà di coesistenza della popolazione con il pericolo. In questo contesto, storicizzare la vulnerabilità significa mappare contrastanti processi di azione sociale,
economica, politica e progetti di intervento concreto sull’ambiente,
nei quali si alternano sofisticate precauzioni e occupazione sconsiderata dei luoghi vulcanici, volontà di protezione e sfruttamento di
queste millenarie takara no yama («montagne dei tesori»). I territori vulcanici con i quali le comunità di Hokkaido hanno sviluppato
una raffinata forma di simbiosi, secondo Augendre, si caratterizzano
per un fragile equilibrio in cui la coesistenza degli uomini con l’ambiente capriccioso oscilla tra la sottovalutazione del pericolo e la volontà di dominarlo. L’ambivalenza del rapporto con la natura è resa
evidente da due situazioni simmetriche e opposte per cui il vulcano
viene temuto, ma allo stesso tempo strumentalizzato: la catastrofe è
diventata una «anastrofe»: un’inversione dell’ordine naturale delle
cose, per cui il processo di adattamento si basa sugli elementi propizi della natura che però sono allo stesso tempo anche i più pericolosi (Pelletier 1991). Nel caso di Toyako Onsen il pericolo diventa la
maggiore risorsa economica, oltreché un grande bene culturale della
comunità, nonostante la conclusione della geografa francese sia impegnativa e allarmante:
102
103
I piani di emergenza in caso di disastro hanno mostrato la loro efficacia nel 2000. Tuttavia gli spazi esposti, sul monte Usu e sul monte Tokachi Dake, sono considerati come risorse vitali e, a questo titolo, restano
sfruttati malgrado il rischio. Niente permette di affermare che i successi
recenti siano il segno di un controllo effettivo della situazione (Augendre
2004, p. 116).
Sintetizziamo quindi il modello di riferimento teorico per definire il concetto di vulnerabilità sociale mostrato in questi esempi, utilizzando le parole di David Alexander:
Si può, quindi, ipotizzare che la vulnerabilità totale al disastro sia
uguale alle azioni che amplificano il rischio meno le misure, sia strutturali sia non strutturali, prese in favore della sua riduzione, entrambe influenzate dai vari fattori della percezione del rischio, i quali possono avere l’esito di aumentare o diminuire la vulnerabilità generale secondo il livello di addestramento e di interesse mantenuto dalla popolazione
(Alexander 1993, p. 23, corsivo mio).
Per Alexander la vulnerabilità deriva dalla composizione di tre
fattori variabili importanti: una funzione amplificatrice del rischio
(Ra), costituita dall’insieme di conseguenze che derivano dalla cattiva pianificazione e dalla negligenza nell’applicazione delle norme
per l’edificazione in zone pericolose; una funzione mitigatrice del rischio (Rm), costituita da opere di efficace pianificazione e uso corretto delle giuste misure di sicurezza nell’edificazione; una funzione
di percezione del rischio (Rp), che tende a essere condizionata dalla
cultura che prevale nell’area pericolosa:
V = R a – Rm ± Rp
Quindi anche il rischio totale è una funzione di questi fattori
(Alexander 2000, pp. 14 sgg.).
Tra i fattori che maggiormente influiscono nella percezione del
rischio e di conseguenza nella valutazione costi/benefici dei comportamenti organizzativi da adottare, vi è ad esempio l’informazione
tecno-scientifica sull’evento e il ruolo dei mass media nel ricostruire
la realtà dei fatti modellandola in accordo o in contrasto con le aspettative, gli orientamenti politici e gli stereotipi, largamente diffusi nella comunità.
In sintesi, semplificando e chiarendo meglio la formula di
Alexander, potremmo dire che è possibile costruire una misura qualitativa della vulnerabilità di un sistema sociale in termini di differenza fra azioni sociali (AS), tecniche, politiche, economiche ecc. che
tendono ad aumentare il rischio (> R) e azioni sociali (AS), tecniche,
politiche, economiche ecc. che tendono a diminuire il rischio (< R):
Sostituendo V con la relazione (2), nella (1)28, si ottiene la relazione (3):
(3)
D=
I
×
(variabili fisiche)
[(AS ----- > R) – (AS ----- < R)]
(variabili antropologiche)
Da cui appare chiaramente come il concetto di rischio (R), che
orienta pratiche quotidiane, scelte politiche e strategie d’azione differenti, determini direttamente la vulnerabilità di un sistema sociale
e svolga un ruolo essenziale nell’amplificare o diminuire gli effetti fisici dell’impatto (I) di un agente distruttivo (naturale o tecnologico)
su una comunità umana colpita da un disastro (D)29:
I concetti del rischio e della vulnerabilità umana, contrapposti all’impatto e alla ricorrenza dell’evento geofisico, sono fondamentali in tutte le
formulazioni teoriche finora sviluppate per facilitare la riduzione dei rischi e la previsione degli eventi naturali30.
V = (AS ----- > R) – (AS ----- < R)
Da quanto detto si ricava la fondamentale considerazione che il
contenuto dell’espressione «eventi naturali estremi» non è riducibile né a un fatto esclusivamente oggettivo (paradigma tecnocentrico),
né a un fatto esclusivamente soggettivo (paradigma socio-antropologico). Non è possibile stabilire la natura estrema di un evento fissando in assoluto una soglia di magnitudo; questa misura quantitativa deve essere collegata all’analisi della vulnerabilità (fisicamente e
socialmente prodotta), la quale a sua volta è determinata da valutazioni di costi e benefici che sono sempre soggettive e locali, cioè acquistano senso e possono essere comprese soltanto collocandole entro particolari circostanze di tempo e di spazio, storicamente e an-
Detto molto in breve, ciò significa, ad esempio, che una comunità di contadini giapponesi dell’isola di Honshu, che non vuole rinunciare per motivi religiosi ad abitare alle falde di un vulcano come il Fuji-yama (in Giappone, come abbiamo visto, i vulcani sono ritenuti sacri e sono meta di numerosi pellegrinaggi), ma che delibera
uno stanziamento di risorse per adeguare le proprie abitazioni tradizionali alle norme antisismiche, sarà meno vulnerabile di un’altra
comunità della zona che non accetta di spendere soldi per modificare la pianta e la struttura delle proprie case perché ritiene che esse costituiscano una rappresentazione tradizionale del cosmo.
28
Ricordo che la relazione (1) è stata ricavata dall’analisi dei limiti delle sole nozioni tecnocentriche per comprendere la variabilità del danno in contesti nei quali
l’entità dell’agente d’impatto è invece molto simile, per cui alle variabili che descrivono la fisica dell’evento (I), vanno aggiunte le variabili di tipo socio-antropologico che determinano il livello di vulnerabilità della comunità colpita da quel determinato agente distruttivo: (1) D = I × V. Si veda il capitolo 1.
29
Si vedano anche Bankoff, Frerks, Hilhorst 2004; Bankoff 2003; Alexander
1997, in particolare il paragrafo The problem of definition con una classificazione
dei molteplici aspetti della vulnerabilità, p. 292.
30
U.S. Research Council, Confronting Natural Disasters: An International Decade for Natural Hazard Reduction, National Academy Press, Washington, D.C.,
1987, cit. in Alexander 1991b, p. 110.
104
105
(2)
tropologicamente determinabili, ovvero relativizzandole al contesto
socio-culturale che le ha prodotte:
4
La costruzione culturale del rischio
In conclusione, se esaminiamo come si costruisce il concetto di evento naturale, dobbiamo concludere che esso si riferisce sempre a fatti umani, non tanto nel senso di fenomeni oggettivamente rilevanti per l’esistenza o per l’agire degli esseri umani, quanto piuttosto perché esso descrive attribuzioni di senso a insiemi di fenomeni, variamente percepibili e
valutabili. Nel primo caso la definizione è referenziale, riguarda cioè i nostri rapporti fattuali con oggetti esterni; nel secondo caso si tratta di una
definizione autoreferenziale, che si riferisce cioè al nostro modo di rappresentare il mondo esterno (Dematteis 1993, p. 15, corsivi miei).
Un’Intelligenza che, per un dato
istante, conoscesse tutte le forze
da cui è animata la natura
e la situazione rispettiva degli esseri
che la compongono, se per di più
fosse abbastanza profonda
per sottomettere questi dati
all’analisi, abbraccerebbe nella stessa
formula i movimenti dei più grandi
corpi dell’universo e dell’atomo
più leggero: nulla sarebbe incerto
per essa e l’avvenire, come il passato,
sarebbe presente ai suoi occhi.
Pensando la vulnerabilità sociale come prodotto della relazione
fra azioni volte ad aumentare il rischio e azioni volte a ridurlo, abbiamo progressivamente spostato il fuoco dell’analisi sul criterio di
base che inconsapevolmente o esplicitamente, in modo dichiarato
oppure informale, detta la scelta più adeguata fra differenti schemi
di comportamento a più livelli (individuale, collettivo, comunitario,
istituzionale, nazionale ecc.): ovvero la percezione del rischio. L’antropologia dei disastri si riconfigura allora in termini di una antropologia delle percezioni locali di rischio.
Ma che cos’è il rischio? Come lo si determina? In che senso si usa
la parola «percezione»? Perché non utilizzare ad esempio le espressioni «valutazione», o «calcolo» oppure «determinazione» o anche
«rappresentazione», del rischio? Il rischio è una variabile oggettiva
o una costruzione sociale? Tali stringenti e ineludibili questioni fondano la possibilità stessa di un approccio non esclusivamente tecnocentrico allo studio dei disastri, e verranno esaminate in dettaglio nel
prossimo capitolo.
Pierre-Simon de Laplace
Saggio filosofico sulle probabilità
Non natura, sed peccatum est.
Agostino
Confessioni
1. Comprendere il male
Nei capitoli precedenti abbiamo descritto e analizzato numerosi
concetti occidentali di disastro. Le definizioni «tecnocentriche» e
quelle «socio-antropologiche» di cui abbiamo parlato finora sono
state elaborate all’interno di quadri disciplinari tipici delle società
occidentali, ma esistono concettualizzazioni non occidentali, native,
di disastro? Esistono risposte tradizionali alla domanda: perché è
successo? Le rappresentazioni native sul senso del male modellano i
comportamenti reattivi? E in che misura? Il significato che una da107
ta comunità attribuisce al male e alla disgrazia ha degli effetti nel costruire la percezione del rischio e dunque nel determinare la vulnerabilità sociale di quella comunità? Scrive la poetessa ucraina Lina
Kostenko (1994, p. 16) di fronte alla tragedia di Černobyl’:
Il Vij atomico ha abbassato la sue palpebre di cemento.
Attorno a sé ha tracciato un cerchio ferale.
Perché la stella amara è caduta nei nostri fiumi?
Chi ha seminato questa disgrazia? Chi la raccoglierà?
Chi ci ha offeso, annientato, scarnificato?
Quale orda ha calpestato la nostra dignità?
Se la scienza ha davvero bisogno di vittime,
allora, perché non è voi che s’è divorata?1
I terremoti (come pure gli altri eventi naturali estremi, e i disastri
tecnologici) provocano altrettanto gravi terremoti invisibili, che
scuotono il mondo interiore delle persone coinvolte, così come distruggono il loro micrososmo esterno. Si generano sindromi da
stress post-traumatico che accompagnano una sorta di shock antropologico. In una breve nota sull’inondazione di Parigi, nel gennaio
del 1955, Roland Barthes ha descritto in modo molto incisivo questa crisi di senso che affiora nel disastro:
automobili ridotte al loro tetto, lampioni troncati, con la loro testa a fior
d’acqua come una ninfea, case tagliate come cubi di bimbi [...]. Tutti questi oggetti quotidiani sono improvvisamente apparsi separati dalle loro
radici, privati della sostanza ragionevole per eccellenza, la Terra. La piena non ha solamente scelto e spaesato certi oggetti, ma ha stravolto la stessa cenestesia del paesaggio, l’organizzazione ancestrale degli orizzonti: le
linee abituali del catasto, i sipari di alberi, le file di case, le strade, perfino il letto del fiume, questa stabilità angolare che organizza così bene le
forme della proprietà, tutto ciò è stato cancellato, dispiegato dall’angolo
del piano: non più vie, non più rive, non più direzioni; una sostanza piana
che non porta da nessuna parte, e che così sospende il divenire dell’uomo,
lo distacca dalla ragione e da una utensilità dei luoghi (Barthes 1974, p. 54,
corsivo mio).
Ulrich Beck ha caratterizzato il disastro proprio come un momento di «shock antropologico» che muta definitivamente il modo
di pensare della gente alla tecnologia e all’ambiente naturale (Beck
1995). Il termine si riferisce alla incommensurabilità della conoscenza scientifica circa i rischi ambientali e delle esperienze quotidiane delle persone esposte a questi rischi. Di fronte a quel tremendo collasso del quotidiano causato da un disastro affiora un grave senso di disagio, che può anche non comportare reazioni isteriche, violente, di panico collettivo e può nascere anche in contesti nei quali
la popolazione mostra una reazione inaspettatamente composta,
muta e silenziosa, come nel caso delle anziane donne giapponesi nel
terremoto di Yokoama, descritte da Ernest Hemingway: in piedi nell’acqua dei canali, per tutta la notte, nel tentativo di sfuggire ai pericolosissimi incendi2.
La riflessione nativa sul senso del male, scaturita direttamente
dall’esperienza fisica del dolore, e dall’enigma finale della morte,
produce un corpus di conoscenze più globale e complesso sulla natura umana e sul mondo. Ogni antropologia implicita – che si mostra perciò anche in termini di una cosmologia implicita e soprattutto di una tanatologia implicita – elabora un sapere sul male profondamente connesso alla teoria della causalità, alla percezione del rischio, all’idea di pericolo, al senso di potere o di impotenza dell’uomo rispetto al proprio ambiente. In un disastro, i molteplici «sensi»
vacillano, si smarriscono. Questi dispositivi simbolici e bio-sociali di
interpretazione del male si bloccano, si arrestano, svelano – come abbiamo già ricordato – tutta la loro costitutiva e ineludibile fragilità,
e occorre un incessante e davvero intenso lavoro della cultura per
consentire nuovamente la vita (Rosaldo 2001). A tale proposito
Francesco Remotti scrive:
Una volta riconosciuto che non esiste una società «senza male» e che
comunque gli esseri umani individuano e classificano come «male» certi
eventi (il dolore fisico, le malattie, la morte non rientrano forse in una qualche categoria di male?), si aprono immediatamente questioni attinenti alla natura del male, alle sue tipologie, ai rapporti gerarchici che si possono
Il «Vij» a cui si riferisce la poetessa è un personaggio delle leggende russe,
l’enigmatico re degli gnomi, dall’aspetto tozzo e completamente ricoperto di terra,
ripreso dallo scrittore ucraino Nikolaj Vasil’evic Gogol’.
2
Mi riferisco qui all’articolo del 25 settembre 1923, che Ernest Hemingway scrisse sul luogo della sciagura, ove fu inviato come cronista dal «Toronto Daily Star»
(l’11 settembre 1923, in Giappone, a Yokoama, il sisma raggiunse la magnitudo di
8,3 gradi Richter, causando 200.000 morti). Si veda Barillari 2007, pp. 73-80.
108
109
1
La tradizione religiosa hindu, la più diffusa nelle aree indonesiane e
del Sudest asiatico sconvolte dallo tsunami del 2004, è caratterizzata
da un concezione circolare – ma non statica – del tempo (nel senso che
ogni ciclo è differente dal precedente). Il mondo, che di per sé non ha
né principio né fine, attraversa quattro cicli che via via peggiorano,
dalla perfezione iniziale (una prima età dell’oro del tutto simile a quella del mito greco-romano), fino alla catastrofe finale, che determina la
scomparsa del mondo attuale, ed è seguita dalla creazione di un nuovo mondo, ad opera di un nuovo demiurgo. Ciascun mondo deve co-
noscere queste quattro età (yuga), e mille yuga formano un kalpa, che
rappresenta una giornata del dio Brahma, attuale delegato del Dio supremo che è eterno. Tra uno yuga e l’altro, Brahma si addormenta, e
l’universo è sospeso tra la fine di un mondo e l’inizio di un altro. La
vita di Brahma deve durare cento kalpa. Durante questo processo di
progressivo deperimento dell’universo, il grande Toro, che rappresenta il darma, la Legge universale, perde via via una gamba, una per
ogni era (le quattro gambe sono la verità, la non violenza, la generosità e la penitenza, nel senso di capacità di signoria su se stessi). La nostra è la quarta era, la fase di massima decadenza (detta kaliyuga, cattivo yuga di Kali), iniziata nel 3102 a.C. e che durerà ancora per
400.000 anni. Il Toro si mantiene in bilico sull’ultima gamba rimasta
(precisamente la generosità). Alla fine si manifesteranno terribili sciagure, si alterneranno siccità e gelo, le acque sommergeranno i cieli,
finché pralaya, il disastro definitivo in forma di diluvio, concluderà il
ciclo completo per aprire il successivo (Manu, il Noè della tradizione
hindu, si salverà costruendo una barca, su cui porterà una coppia di
tutte le specie viventi).
Nell’induismo non c’è relazione diretta fra responsabilità umana
e catastrofi, non vi sono intenti punitivi, né rapporti di causalità fra
degenerazione umana e naturale: è il tempo a smagliarsi irreparabilmente. Tuttavia, anche se non siamo di fronte a una correlazione
stretta fra male fisico e male morale, la visione hindu non è per nulla fatalista, come si potrebbe essere indotti a credere. La teoria della causalità e il dispositivo simbolico complessivo di interpretazione
del male sono comunque presenti, ma in una forma ben più articolata rispetto a quella cristiana. Il punto centrale è costituito dalla fondamentale concezione del karman (in comune col buddismo), che si
può riassumere così: la convinzione che ogni atto che l’essere umano compie (pensieri, parole e opere) ha conseguenze dirette nella vita attuale, ma ogni azione lascia anche cadere un seme la cui natura
non può essere falsificata: se l’azione è eticamente pregevole il seme
è pregevole, se l’azione è spregevole anche il seme sarà spregevole.
Il punto essenziale è che tutti questi semi devono fruttificare e ciò richiede necessariamente molte vite. Individualmente gli uomini vivono all’interno di una certa parte di un ciclo, nel corso del quale
passano da uno stato umano a uno stato animale e vegetale, per metempsicosi. La durata di questa vita multipla e la forma delle reincarnazioni dipendono appunto dalle azioni e dai meriti dell’individuo, fino all’esaurimento del karman.
110
111
instaurare tra i vari tipi di male, alle modalità di reagire che li riguardano,
nonché alle spiegazioni che l’insorgenza del male sembra comunque richiedere: tutti questi problemi sono di natura squisitamente culturale, nel
senso che rinviano a specifici contesti culturali (Remotti 2002, p. 147).
E sulla base del contributo di Marc Augé e Claudine Herzlich,
nel loro saggio introduttivo a Il senso del male (1986), prosegue Remotti:
i fenomeni che normalmente vengono collocati nelle categorie di «male»
(male fisico o male morale) da parte delle varie società richiedono urgentemente un’«interpretazione», un conferimento di «senso». Difficilmente una società può sopportare che esista il male, che si verifichi «e basta», che colpisca i suoi componenti, senza provvedere a fornire una qualche spiegazione. Un male senza senso farebbe troppo male: per essere in
qualche modo tollerabile occorre rinvenire il «senso del male» e le società
– nessuna delle quali è ovviamente esente da malattie, sciagure, disgrazie,
infine dalla morte – non possono esimersi dal ricercarne motivi e ragioni, classificazioni e rimedi (Remotti 2002, p. 148, corsivo mio).
Seguendo questa efficace impostazione è essenziale affrontare da
un punto di vista antropologico le modalità con le quali il male produce cognizioni locali del male (teorie interpretative, rappresentazioni simboliche, sistemi di credenze, processi di attribuzione di colpa ecc.) etnograficamente variabili e frutto di lunghi quanto articolati processi storici, al fine di studiare la vulnerabilità ai disastri e soprattutto comprenderne gli effetti sulle modalità culturali che orientano la percezione del rischio.
2. Astrologie e disastrologie:
rappresentazioni native della catastrofe
Le conseguenze sulla sensibilità diffusa induista (e in parte buddista) di questo sistema di credenze sono piuttosto interessanti: a) la
persona si sente non colpevole ma responsabile della situazione nella
vita attuale, perché a seconda del bilancio dei semi lasciati cadere
nelle vite precedenti si troverà in una situazione materiale e spirituale migliorata, oppure via via peggiorata; b) la morte non è la fine
di tutto a cui segue un eventuale premio o punizione eterna, ma vi
sono molte altre chance in altre vite. Questa concezione forse non
sdrammatizza la reazione individuale immediata davanti alla morte,
o al disastro, ma genera senz’altro una particolare sensibilità al pericolo, al rischio, alla solidarietà e al rapporto fra comunità umane e
ambiente3.
Il tema del diluvio universale, presente come abbiamo visto nella
tradizione hindu, costituisce una concettualizzazione assai frequente, in altri sistemi mitico-religiosi, del male fisico imputabile a una
qualche forma di male morale commesso dall’umanità. Ad esempio,
ben prima del noto racconto biblico della Genesi4, la Tavoletta sumerica XI, in cuneiforme (la cosiddetta «Tavoletta del Diluvio»),
narra della decisione presa dagli dèi di punire l’umanità distruggendola con una catastrofica inondazione:
In quei giorni il mondo pullulava, la gente si moltiplicava, il mondo
mugghiava come un toro selvaggio e il grande dio venne destato dal clamore. Enlil udì il clamore e disse agli dèi in consesso: «Lo strepito
dell’umanità è intollerabile e il sonno non è più possibile a cagione di questa babele». Così gli dèi si accordarono per sterminare l’umanità. [...] Alle prime luci dell’alba venne dall’orizzonte una nube nera; tuonava da
dentro, là dove viaggiava Adad, signore della tempesta. [...] Sgomento e
disperazione si levarono fino al cielo quando il dio della tempesta trasformò la luce del giorno in tenebra, quando infranse la terra come un
coccio [...]. Per un giorno intero imperversò la bufera [...] anche gli dèi
furono terrorizzati dal diluvio, fuggirono nel più alto cielo, nel firmamento di Anu [...]. Fiumana, bufera e piena sopraffecero il mondo, [...]
infuriarono insieme come schiere in battaglia. [...] «Saggissimo fra gli dèi,
Enlil eroe, come hai potuto così stoltamente far scendere il Diluvio? Imponi sul peccatore il suo peccato, imponi sul trasgressore la sua trasgressione [...]» (Sandars 1986, pp. 139-140).
Si vedano Boccali, Milanetti 1997; Doninger 2002; Filippi 2005.
4 Si veda Genesi, 6, 5-22; 7; 8.
3
112
In altre tradizioni religiose la catastrofe è concepita come punto
di culmine o di definitivo esaurimento del tempo, come epilogo e destinazione finale delle peregrinazioni umane. Il tema apocalittico, a
cominciare da quello dell’Apocalisse di Giovanni, esibisce spesso
un’interessante ambivalenza: il disastro finale è allo stesso tempo
giudizio/punizione, da un lato, e visione/rivelazione, dall’altro:
Quando ruppe il sesto sigillo, ci fu un gran terremoto; il sole si fece
nero come il carbone, la luna tutta quanta si fece color sangue. [...] E un
gran terremoto scosse e rovinò la decima parte della città, causando la
morte di settemila persone. Impauriti i superstiti diedero gloria al Dio del
cielo [...]. Si aprì il santuario di Dio che è in cielo e apparve l’Arca dell’Alleanza, tra voci e fòlgori e tuoni e terremoti e grossa grandine, i re della
terra e i principi e i ricchi e i servi e i liberi si nascosero nelle caverne e tra
le gole dei monti, e in quel franamento dicevano ai monti: «Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono, e dall’ira
dell’Agnello, perché è venuto il gran giorno dell’ira. Ma chi potrà resistere?»5.
Nel senso tipicamente apocalittico, la catastrofe rappresenta anche il momento escatologico sommo, il disvelamento della verità delle cose, il giudizio sui cuori, la venuta del Messia. Le concezioni escatologiche prevedono spesso, tra il quaggiù e l’aldilà della fine dei
tempi, un lungo periodo «quaggiù» che è una prefigurazione terrena dell’aldilà. Questa nuova era, questa instaurazione del cielo sulla
terra, deve, secondo l’Apocalisse (20, 1-5), durare «mille anni», cifra
simbolica che indica una lunga durata sottratta al trascorrere normale del tempo. Il Millennio ha dato il suo nome a una serie di credenze, di teorie, di movimenti orientati verso il desiderio, l’attesa, la
realizzazione di questa era: si tratta dei millenarismi. Spesso l’avvento di questa era è legato alla venuta di un salvatore, di una guida consacrata alla preparazione della fine dei tempi, dio o uomo, o uomodio, chiamato dalla tradizione giudaico-cristiana Messia, donde il
nome di messianismi attribuito ai millenarismi o movimenti simili incentrati attorno a un personaggio6.
Le catastrofi «finali», che pongono termine al genere umano e al
sistema del mondo, non sempre però hanno questa funzione prefi5
Apocalisse, 6, 12-13; 11, 13-14; 11, 19-20, si veda anche Apocalisse, a cura di
C. Angelini, Einaudi, Torino 1972, pp. 29 e 49.
6 Si vedano Lanternari 1974; Cohn 1999; Weber 1999.
113
guratrice e morale. Basti pensare ad esempio allo schema ciclico della genesi secondo gli Aztechi. A un primo sole (Ocelotonatiuh, sole
di giaguaro, della durata di 676 anni) segue un primo disastro, in cui
il mondo è divorato dai giaguari. Dopo il secondo sole (Ehecatonatiuh, sole di vento, della durata di 364 anni) il mondo viene distrutto da una tempesta e i superstiti sono trasformati in scimmie. Al
quinto sole (Ollintonatiuh, sole di movimento) l’universo viene invece distrutto da un terremoto (Vaillant 1992).
Gli Sré, appartenenti al gruppo linguistico mon-khmer, vivono in
villaggi vicini a Djiring, all’estremità meridionale della Catena
dell’Annan, nel Vietnam del Sud. Coltivano il riso in sommersione sul
fondo delle loro alte valli, con il bufalo e l’aratro. Abitano in case col
tetto di paglia, costruite su basse palafitte. Nella cultura sré (Indocina) vi è l’idea di una catastrofe primordiale, ling («inondazione», oppure da’ ling kwo in lingua jörai, cioè «il mare ribolle»), provocata
dall’incesto mitico di una donna che si unisce al proprio figlio per generare l’umanità. Il rito che ancora oggi si pratica per la siccità catastrofica in un paese tropicale arido non si può comprendere se non nel
contesto del racconto mitico. Le etnie mnong parlano del potere generativo di mang-ling, un disastro in cui il sole si oscura e da cui si originano delle «fratture cosmiche» (dette börling-börlang in lingua sré),
ritenute essenziali per la creazione dell’umanità. In entrambi questi
casi, l’evento apocalittico non è un’escatologia, il disastro non sopraggiunge al termine del tempo umano, ma al contrario è collocato
all’inizio, è il fondamento stesso dell’umanità e dell’ordine culturale7.
L’importanza di questi patrimoni mitici, che in alcuni casi (ma
non sempre) si sono trasformati in favole per bambini, non va affatto sottovalutata. Questi racconti, connessi a elaborati sistemi di credenze, rivelano tracce profonde di come, in differenti contesti culturali, sia stata plasmata l’idea della precarietà umana, del destino,
della colpa e della causalità degli eventi, sulla cui base molti gruppi
sociali compiono ancora oggi scelte concrete, assumendo atteggiamenti di reazione o di rinuncia e rassegnazione di fronte al disastro.
Come abbiamo detto, in tutte le culture, di fronte all’esperienza
drammatica di un disastro la prima domanda è: perché è successo?
Cioè si pone insistentemente un interrogativo profondo sulle cause,
sul senso complessivo da attribuire all’evento estremo. Studiare le
7
Si vedano Dam Bo 1950; Dournes 1970, 1978.
114
modalità secondo cui in società differenti si stabiliscono differenti
nessi causali sul perché è capitata una disgrazia è un obiettivo tipicamente antropologico, che risulta indispensabile per condurre ricerche sulla percezione locale del rischio, etnograficamente e storicamente variabile.
3. Il problema di Giobbe e il terremoto di Lisbona
Monsignor Aleixo Dias, vescovo di Port Blair, capitale delle isole
Andamane, nelle settimane successive allo tsunami che nel dicembre
del 2004 scosse gravemente il Golfo del Bengala e tutta l’Indonesia,
in un appunto per l’omelia scriveva:
Grazie all’aiuto di Dio negli ultimi venti anni, da quando sono diventato il primo vescovo di questa nuova diocesi, sono state costruite nuove
parrocchie, conventi, case di accoglienza e scuole: ora, vedendo tutte
queste opere distrutte, mi chiedo quale messaggio il Signore stia dando a
me, a noi. [...] Mi inchino davanti a Dio e dico: «Sia fatta la tua volontà»8.
Il cristianesimo – in quanto corpo di credenze e rituali formalizzati in un sistema dogmatico complesso – contiene una precisa interpretazione del male, e dovrebbe essere attentamente analizzato dal
punto di vista della riflessione male-causalità-responsabilità, sul piano antropologico, almeno per due valide ragioni: la prima è il fatto
che, seguendo Croce, «non possiamo non dirci cristiani», data la
profondità e la radicalità con la quale il cristianesimo si è installato nel
cuore stesso dell’Occidente, modellandone storicamente categorie di
pensiero, giudizi di valore, rappresentazioni del mondo, in cui si trova immerso anche colui che ora intraprende un percorso di laicità o
di dichiarato ateismo9. La seconda ragione, connessa alla prima, è che
il cristianesimo ha costituito il principale (e determinante) ingredien8
Cit. in AsiaNews.it, periodico on-line, url: www.asianews.it, data dell’articolo: 2-1-2005, data di consultazione del sito: 23-6-2005. La diocesi di Port Blair conta 38.860 cattolici, 12 parrocchie, 38 sacerdoti, 24 religiosi e 88 religiose.
9
Basti pensare che la stessa parola «religione» si è diffusa in Occidente (e in
tutte le lingue europee, non solo in quelle romanze) per cristianizzazione e non per
latinizzazione (il termine religio, che i cristiani adottarono per definire le loro pratiche rituali, indicava in latino un comportamento «scrupoloso», «rigoroso», «devoto»), così le contrapposizioni sacro/profano, civico (laico)/religioso hanno senso solo in ambito cristiano, non certo in società di interesse etnografico, ancorché
cristianizzate.
115
te simbolico dei processi di colonizzazione, per cui oggi buona parte
dei sistemi magico-mitici nativi (quelli ancora non completamente
estinti) si trovano in un qualche grado di relazione sincretica, conflittuale, oppure latente e inconsapevole, con il cristianesimo.
I testi biblici, del Vecchio e del Nuovo Testamento, i volumi della patristica, i ponderosi scritti di sant’Agostino e di san Tommaso
d’Aquino e in generale tutti i testi dottrinari e catechetici cristiani sono attraversati dalla multiforme presenza del male, contengono molteplici nozioni di male (fisico, spirituale, morale), talvolta in contrasto fra loro, e sarebbe un compito immane, oltreché inutile, analizzarli qui10. Esiste però almeno un elemento centrale e profondo,
nell’impianto concettuale della dottrina cristiana, così come si è formata e stratificata nel corso dei secoli, che ritengo indispensabile
trattare seppur brevemente.
L’omelia del vescovo di Port Blair, pronunciata dopo il grande
tsunami, è pervasa da un sentimento di rassegnazione e di fiducioso
abbandono alla volontà di Dio. E tuttavia affiora un velato accenno
al rapporto causa-responsabilità – quindi al problema della comprensione del disastro appena accaduto – quando monsignor Dias
elenca tutte le opere buone compiute dagli isolani (la costruzione di
chiese, scuole, ospedali), chiedendosi quale sia il messaggio che Dio
ha voluto mandare sotto forma di quella gravissima sciagura. Sulla
stessa linea, ma di ben altro timbro, e con toni assai più aspri e infuocati, è la celebre predica di Padre Paneloux, nella Orano di Camus, isolata e chiusa in quarantena per l’epidemia di peste (ciò che
oggi potrebbe paragonarsi al disastro di una gravissima contaminazione biologica o batteriologica). Il ragionamento teologico di Padre
Paneloux risulta scarno ma diretto, quanto pieno di passione, e addirittura paradigmatico in termini di teoria della causalità.
È domenica, in chiesa, davanti a una folla traboccante che invade la navata e vi si accalca. Il sacerdote sale sul pulpito:
«Fratelli miei, voi siete nella sventura, fratelli miei, voi lo avete meritato», un fremito percorse l’uditorio fino al vestibolo. [...] Paneloux, subito
dopo quella frase, infatti, citò il testo dell’Esodo relativo alla peste in Egitto e disse: «La prima volta che il flagello appare nella storia, è per colpire i
nemici di Dio. Il Faraone si oppone ai disegni eterni e la peste, allora, lo fa
cadere in ginocchio. Dal principio d’ogni storia, il flagello di Dio mette ai
10
Rinvio al fondamentale testo di Herman Häring (2001).
116
suoi piedi gli orgogliosi e gli accecati. Meditate e cadete in ginocchio. [...]
Sì, l’ora di riflettere è venuta. Voi avete creduto che vi sarebbe bastato visitar Dio la domenica per esser liberi dei vostri giorni; avete pensato che alcune genuflessioni lo ripagassero abbastanza della vostra incuria criminale. Ma Dio non è tepido, questi rari rapporti non bastavano al suo divorante affetto. Vi voleva vedere più a lungo, è la sua maniera di amarvi e, a
dir la verità, è la sola maniera di amare» (Camus 1989, pp. 73 e 75).
Nel cristianesimo, il problema antropologico più rilevante per le
questioni che stiamo trattando è dunque la possibilità di stabilire
una connessione persuasiva tra male fisico e male morale, secondo
cui di fronte al dolore, alla malattia, a un grave disastro, lo sforzo di
elaborare un’interpretazione dell’accaduto, in termini di ricerca della cause (come analisi empirica dei nessi causali), si traduce in un
processo di attribuzione di colpa, e tende a spostare la questione sul
piano dei valori e delle responsabilità individuali11. La possibilità di
un’identificazione logica fra male e peccato, assieme alla convinzione
che l’uomo non è in grado di redimersi facendo appello soltanto alle proprie forze, sorregge complessivamente la metafisica cristiana,
sia sul versante della teologia cattolica, sia su quello della teologia
protestante. Come vedremo, sulla base dell’opera di Mary Douglas,
questo dispositivo simbolico che collega «colpa» a «dolore/sofferenza fisica» fa parte della struttura generale dei concetti di male, anche se naturalmente non è presente in modo esplicito in tutte le tradizioni religiose. Nel cristianesimo però esso assume una forma, per
così dire, paradigmatica, che è delineata nella famosa vicenda di
Giobbe, esemplare non tanto per la soluzione, quanto per la riflessione sulla natura intrinseca del problema posto. Il problema di
Giobbe, il suo vero e autentico dramma, non è tanto la comprensione del male, quanto il credere in Dio. Non è l’esistenza del male in se
stesso, ma il credere. È il silenzio di Dio che fa irrimediabilmente saltare tutte le categorie simboliche della tradizione. Per un ateo, benché rimanga profondamente aperta la domanda sul senso del male,
il problema è di tutt’altro genere, simile al ben noto rasoio di Occam:
perché Dio non fa nulla? Perché Dio non dice nulla? Forse perché
Dio non c’è. È dalla scelta di credere che scaturisce la questione gra11
Si veda Gevaert 1989 e la voce «Colpa» di Pier Paolo Portinaro, in Portinaro 2002, pp. 53-68 (cfr. nello stesso testo le voci «Dio» di Giovanni Filoramo e
«Peccato originale» di Marco Ravera).
117
ve della cosiddetta teodicea, ovvero il discorso classico in difesa di
Dio: se Dio è bene, perché permette il male, il dolore, la malattia, le
sciagure, i disastri che si abbattono sull’umanità, colpendo tutti indistintamente, i buoni e i cattivi, i puri e gli empi?
Questo tema, la cui formulazione classica (nel senso stretto del
termine) risale a Epicuro (341-270 a.C.), poi ripresa da Lattanzio
(250-317 d.C.), è stato affrontato da Gottfried W. von Leibniz nel
celebre trattato Saggi di teodicea. Sulla bontà di dio, la libertà dell’uomo e l’origine del male (1697) – in cui egli utilizza per primo la parola «teodicea»12 –, che propone un’analisi dettagliata dei molteplici aspetti della questione, indicando vari percorsi interpretativi: il
male è privatio boni (da Agostino), ovvero una modalità privativa
dell’essere; Dio permette dei mali per realizzare un bene maggiore
(ancora da Agostino): de malo, bonum; le imperfezioni di una parte
permettono di apprezzare meglio la bellezza dell’insieme; il male è
castigo e punizione, da cui deriva il grande valore formativo, educativo e pedagogico della sofferenza, anche in termini di messa alla
prova della fede. Il male morale è sempre un abuso della libertà di
Dio. Se Dio non lo permettesse ridurrebbe la libertà all’uomo, che è
dono. Questa specie di male sarebbe tollerata da Dio per salvaguardare un bene maggiore: la libertà stessa. La libertà morale si configura appunto come possibilità di commettere il male morale.
Il problema della teodicea quindi non si risolve, bensì si dissolve:
non si può rispondere definitivamente alla domanda «Se Dio è buono e onnipotente, allora perché c’è il male?», in quanto la domanda,
così formulata, è mal posta. È il tentativo di trasformare un supremo
enigma in un problema logico astratto, ma i codici della razionalità,
il bisogno di ordine classificatorio e normativo, le regole di coerenza e non contraddizione degli enunciati sono davvero sufficienti a
penetrare il mistero di Dio?
La messa in discussione del dispositivo di correlazione simbolica
del cristianesimo – basato sulla fede – fra male fisico e male morale costituisce il punto di partenza della filosofia morale moderna, che trova nel movimento illuminista la forma più compiuta. Questa radicale
consapevolezza critica sul problema del male come irriducibile agli
orizzonti interpretativi di tipo religioso (anzi, come mostra la storia di
Giobbe, reso forse ancor più difficile proprio dal suo trattamento sub
specie religionis) sorge e si afferma in termini di definitiva svolta epistemologica, non grazie alla pubblicazione di un libro, oppure
sull’onda di qualche importante convegno filosofico, ma all’indomani di un gravissimo disastro naturale: il terremoto di Lisbona.
Nel Settecento Lisbona era una grande metropoli, ricca e vivace,
come possono essere oggi Londra e Chicago. Quando l’11 settembre del 1755 un sisma violentissimo, di magnitudo pari all’8° grado
della scala Richter, distrusse completamente la città provocando
60.000 morti, l’Europa attonita si trovò di fronte a un evento unico
e sorprendente, un disastro che parve subito profondamente diverso da tutti gli altri. «Le cesure, le soluzioni di continuità della nostra
storia culturale, non sempre stanno lì dove libri e manuali credono
di averle collocate, una volta per tutte» (Tagliapietra 2004, p. XXII;
cfr. Dupuy 2006)13: il terremoto di Lisbona fu percepito dai contemporanei come un evento che, se da un lato riproponeva antichissimi enigmi (il senso del male, la giustizia di Dio, le colpe umane
ecc.), dall’altro determinava un modo del tutto nuovo di affrontarli.
Si affermava un approccio illuminista e post-metafisico legato ai concetti di rischio, di probabilità e di casualità, di cui il Poema sul disastro di Lisbona di Voltaire (1756) può essere a buon diritto considerato un manifesto ideale:
La natura è muta, vanamente la interroghiamo;
Abbiamo bisogno di un Dio che parli al genere umano.
Soltanto a lui compete di spiegare la sua opera,
Di consolare il debole e di illuminare il saggio [...]
Leibniz non mi insegna attraverso quali invisibili nodi,
Nel più ordinato dei possibili universi,
Un disordine eterno, un caos di infelicità,
Mescola i nostri vani piaceri ai reali dolori,
Né perché l’innocente, alla stregua del colpevole,
Subisce in egual modo questo male inevitabile.
12
Leibniz ricava il termine in riferimento al passo della Lettera di Paolo ai Romani (3, 5): «Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio che diremo?».
13
Un eccellente contributo di ricerca per delineare il quadro storico della svolta illuminista post-metafisica sul problema del male è quello di Augusto Placanica,
che sulla base di un consistente e accuratissimo lavoro d’archivio ha analizzato i risvolti socio-culturali del terremoto calabro-messinese del 1783. Placanica 1985,
1993.
118
119
Non concepisco neppure come tutto sarebbe bene:
Sono come un medico, ahimè, non ne so niente.
(cit. in Tagliapietra 2004, p. 7, corsivo mio)
Roland Barthes, nella Prefazione ai Romans et contes di Voltaire,
ha delineato con grande nettezza questa posizione: il Bene e il Male
esistono, ma devono essere intesi come felicità e infelicità, e non come innocenza o colpa. Non esiste alcuna possibilità di connessione
fra loro, se non quella che li lega a una forma di causalità universale
che sfugge al controllo umano; essi hanno un irriducibile carattere
di necessità, che però è meccanica e non morale: «il Male non punisce, il Bene non ricompensa» (Barthes 2002, p. 84). Gli esseri umani, essendone parte, non hanno alcun potere di influenzare questo
cieco ingranaggio cosmico, possono solo tentare di comprenderlo
utilizzando la Ragione.
In contrasto con Voltaire, ma in linea con quel progressivo processo di interpretazione post-metafisica del male e di messa in discussione della teodicea scaturito dal terremoto di Lisbona, Jean-Jacques Rousseau, nella sua Lettre à Monsieur de Voltaire, inviata il 18
agosto del 1756 (e rimasta senza risposta), sosteneva la totale autonomia morale dell’uomo e la sua imprescindibile responsabilità per
quanto gli accade. Per Rousseau l’ipotesi di Dio non è più necessaria,
anzi è un ostacolo alla corretta comprensione del mondo e dei nessi
causali che determinano fatti e situazioni, siano essi felici o dolorosi:
non ho che da farle osservare che, quando descrivevo le miserie umane,
il mio scopo era giustificato [...]; perché mostravo agli uomini che erano
causa dei loro stessi mali e che, di conseguenza, potevano evitarli [...]. Inoltre credo di aver dimostrato che, a parte la morte, [...] per la maggior parte i mali fisici sono di nuovo opera nostra. Restando al suo tema di Lisbona, dovrà ammettere, per esempio, che non era stata la natura a radunare in quel luogo ventimila case di sei o sette piani, e che se gli abitanti di quella grande città fossero stati distribuiti in modo più uniforme
e alloggiati in edifici meno imponenti, il disastro sarebbe stato molto minore, e forse non ci sarebbe stato affatto. Tutti sarebbero fuggiti alla prima scossa e li avremmo ritrovati il giorno dopo a venti leghe di distanza,
contenti come se non fosse successo niente. Invece bisogna restare, ostinarsi intorno a delle catapecchie, esporsi a nuove scosse, perché ciò che
si lascia vale più di ciò che si riesce a portar via14.
14
J.-J. Rousseau, Oeuvres complétes, Gallimard, Paris 1959, vol. IV, pp. 1061-
120
In questo passo affiora il carattere innovativo ed estremamente
attuale delle considerazioni di Rousseu, il quale delinea – a suo modo – il tema chiave della vulnerabilità sociale, che abbiamo lungamente sviluppato, e ci restituisce una visione «esterna» del fenomeno estremo, secondo cui le condizioni che preludono al disastro vanno colte integrando le variabili fisiche con le caratteristiche materiali e socio-culturali del sistema sociale colpito, e non soltanto utilizzando una modellistica tutta «interna» alla fisica dell’evento. Potremmo dire che quella di Rousseau è quasi una descrizione ante
litteram del concetto di «incubazione sociale» di un disastro. In Europa, nella seconda metà del Settecento, in un clima particolarmente drammatico, in cui gli animi erano stati già scossi dal terribile terremoto che, meno di dieci anni prima, nell’ottobre del 1746, distrusse Lima, la reazione intellettuale al disastro si configura dunque come l’ultima significativa ribellione all’ingiustizia divina e alle astruse
ragioni teologiche invocate per comprendere il male: nasce qui la
modernità.
4. La teoria forense del pericolo
Secondo la cosiddetta «teoria forense del pericolo», in voga in antropologia sociale negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento
(poi ripresa e ampliata dagli antropologi sostenitori della «teoria culturale» del rischio, fra cui Mary Douglas, Michael Thompson, Aaron Wildavsky e altri), la dicotomia fra credenza e conoscenza, e cioè
la classica dicotomia antropologica fra primitivi e moderni, si genera
proprio sulle idee relative al perché è capitata una disgrazia15. Secondo questa impostazione, la mentalità premoderna si caratterizzerebbe per il fatto di connettere causalmente le disgrazie con l’azione
di esseri «spirituali» (entità extra-umane, divinità, spiriti ecc.), mentre invece la mentalità moderna sarebbe sempre in grado di risalire
oggettivamente dagli effetti alle vere cause materiali, mediante l’applicazione del sapere scientifico e del metodo sperimentale. I primitivi sarebbero tali proprio perché – collegando male o ingenuamente (in modo immaturo come i bimbi) le cause agli effetti – sostengo1062 (corsivo mio). Si veda anche Voltaire, Candido (trad. di Riccardo Bacchelli),
in Id., Romanzi e racconti, Mondadori, Milano 1971, pp. 199-218.
15 Si vedano Douglas, Wildavsky 1982; Schwarz, Thompson 1993; Douglas
1996.
121
no credenze per noi moderni impossibili da condividere e si impegnano in pratiche rituali per noi difficili da comprendere.
Questo problema «triangolare» di connessione fra modalità differenti di rappresentare il mondo e di operare interventi concreti in
esso – e cioè la magia, la religione (due vertici che, seppure in posizioni diverse, giacciono però entrambi dal lato dei «primitivi») e la
scienza (il terzo vertice sul lato opposto, quello dei «moderni», v. lo
schema 3) – è stato al centro di un dibattito durato svariati decenni,
che è all’origine stessa dell’antropologia. Esso costituisce, in sintesi,
lo spinoso problema della razionalità delle credenze, emerso a partire dai viaggi esplorativi di missionari e mercanti, e poi con le successive spedizioni colonizzatrici, quando gli europei si trovarono per la
prima volta a diretto contatto con i nativi e con la loro irriducibile alterità culturale. Posta in questi termini, la questione della razionalità
è anche alla base di quel processo tutto interno alla mentalità europea (come abbiamo visto parlando degli scritti di Voltaire e Rousseau
sul terremoto di Lisbona), che si sviluppa a partire dalla seconda
metà del Settecento e si caratterizza come una progressiva e marcata
critica alla teodicea e all’interpretazione irrazionalmente metafisica
del male, su cui si è venuta modellando l’idea di modernità.
A questo proposito uno dei concetti portanti del paradigma evoluzionista vittoriano presupponeva che le concezioni magico-religiose del mondo fossero errate soprattutto sul piano teoretico e non fattuale: i «primitivi» – si diceva – riconoscono correttamente i fatti, ma
sbagliano nel collegarli causalmente fra loro facendo un uso incontrollato di ipotesi teoriche semplicistiche e fantasiose. Come per i pe-
riodi di crescita e di maturazione individuale che portano il bambino
a diventare adulto (abbandonando, presto o tardi, la credenza in Babbo Natale), l’emergenza del pensiero razionale andrebbe di pari passo con una lenta e progressiva maturazione intellettuale del genere
umano. Negli anni Venti del Novecento, l’impostazione di Lucien
Lévy-Bruhl considera il sociale come un’entità provvista di una logica di funzionamento autonomo e indipendente dalla comprensione
che gli individui possono avere di esso. Per il filosofo francese è indispensabile rinunciare alla pretesa di spiegare le rappresentazioni collettive dei popoli «primitivi» sulla base delle operazioni mentali di tipo individuale e soggettivo, perché tali rappresentazioni, per quanto
bizzarre e illogiche possano sembrarci, non sono, come vorrebbero
gli evoluzionisti, errori di valutazione compiuti dalla mente immatura del primitivo nel tentativo di rintracciare le cause reali dei fenomeni, ma costituiscono delle costellazioni di significati assai articolate,
comuni a un intero gruppo sociale, trasmesse fra le generazioni e imposte agli individui attraverso pratiche sociali inculturative. Dunque
per Lévy-Bruhl le rappresentazioni collettive costituiscono modelli
sociali di atteggiamento mentale che impediscono di fatto ai nativi di
concentrare la loro attenzione sui dati dell’esperienza oggettiva. Il
pre-logismo di queste rappresentazioni e di questi atteggiamenti non
ha niente a che fare con una disposizione irrazionale rispetto a quella
scientifica occidentale, oppure situabile in uno stadio cronologico
precedente, di minor compiutezza o realizzazione, entro una data linea di sviluppo psichico progressivo; indica invece una differenza di
tipo qualitativo e non quantitativo fra l’attività mentale del «primitivo» e quella del «moderno».
Come è del tutto evidente, nonostante il tema della razionalità
delle credenze e dei comportamenti ad esse associati sia discusso e
analizzato in modo più o meno differente, per buona parte del periodo fondativo della disciplina antropologica – fra la seconda metà
dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento – la mentalità magico-religiosa è sempre considerata come intrinsecamente illusoria rispetto alle norme assolute di validità desunte dalla tradizione del
pensiero occidentale. I «primitivi» (per un motivo o per un altro) sono tali perché credono, ovvero sono comunque inclini ad assumere
una complessa modalità di rappresentazione del mondo che li porta
a convinzioni essenzialmente false, a produrre un sapere sul mondo
sostanzialmente errato; al contrario i «moderni» sono tali perché, affrancatisi storicamente, nel corso dell’evoluzione culturale dell’Oc-
122
123
Schema 3
PRIMITIVI
MODERNI
scienza
religione
magia
cidente, dalla magia (e poi anche dalla religione), invece conoscono,
ovvero si orientano secondo una modalità di rappresentazione del
mondo che li porta a ottenere un sapere completamente vero e definitivo sulla realtà16. Schematizzando:
Schema 4
Perché è capitata la disgrazia?
(problema teorico dei nessi causali)
ALTRI
PRE-MODERNI
Primitivi
Credenza (falsa)
Magia
NOI
MODERNI
Civilizzati
Conoscenza (vera)
Scienza
DISASTRI:
peccato / ira di esseri spirituali
DISASTRI:
cause materiali / analisi scientifica
L’antropologa Mary Douglas, nel celebre volume Purezza e pericolo, del 1966, si è posta l’obiettivo di difendere i cosiddetti primitivi dall’accusa di avere una logica o un metodo di pensiero diversi. Il
tabu rappresenta una chiara volontà di proteggere la società da comportamenti distruttivi. Secondo Douglas, quando in una società si
accusano nemici, stranieri o donne peccatrici di aver provocato il
maltempo, un’eruzione vulcanica, il terremoto o altri generi di catastrofi, non è importante il regionamento in sé, o un errore empirico
nella costruzione dei nessi causali, ma il processo di attribuzione di
16
Si veda Lévy-Bruhl 1971. Cfr. Stocking 1999. Rinvio ad altra occasione un interessante approfondimento sul modo con cui molti autori, antropologi e filosofi,
hanno considerato i rapporti fra i vertici del triangolo raffigurato nello schema 3: a)
scienza e religione in conflitto, ad esempio, sul piano della rivoluzionaria teoria di
Darwin (che non poco contribuì alla costruzione dell’idea di modernità); b) scienza
e magia contrapponibili sul piano intellettuale e teorico rispetto alla nozione di causalità; c) magia e religione contrapponibili sul piano morale, ecc. Né è possibile dar
conto qui della posizione di Lévy-Bruhl rispetto alla Scuola sociologica francese di
Émile Durkheim e di Marcel Mauss; oppure dell’approccio all’intera questione adottato da Bronislaw Malinowski. Tuttavia, con un’inevitabile buona dose di semplificazione, la linea di ragionamento che stiamo descrivendo (sul rapporto primitivi/
moderni) rimarrebbe invariata anche considerando queste ulteriori posizioni.
124
colpa (blaming): come dire che di fronte al subbuglio che si verifica
in una società «primitiva» a seguito di una grave disgrazia o di un disastro, il suggerimento per l’etnografo è di non guardare quale errore commettono nell’attribuire una spiegazione causale empirica
all’evento, ma di osservare invece a chi danno la colpa.
Affiora qui, con tutta evidenza, il fondamentale contributo di
Edward E. Evans-Pritchard, di cui la Douglas fu allieva appassionata17. Nella sua ricerca etnografica sulla stregoneria fra gli Azande,
Evans-Pritchard (2002, or. 1937) ha l’indiscusso merito di aver mostrato come questa popolazione centrafricana non ignorasse i nessi
empirici fra gli eventi (ad esempio: il granaio è crollato perché le termiti ne hanno rosicchiato le fondamenta), ma credesse nel complicato sistema della stregoneria (mangu) per rispondere a una domanda sui nessi causali posta a un livello ben più profondo: perché nel
momento che è crollato il granaio c’era sotto proprio mio fratello e
non un’altra persona? Dunque: perché è capitata questa disgrazia?
E quindi: come dovrò comportarmi ora? Evans-Pritchard mostra
che nel sistema di pensiero zande, a prima vista ingenuo e «primitivo», sono invece all’opera ben due teorie differenti della causalità,
intrinsecamente connesse e sovrapposte. Egli ha inoltre evidenziato
per la prima volta, con grande nettezza, come un complesso sistema
di credenze contenga principi di coerenza interna che si attivano per
sciogliere le ambiguità risolvendo le contraddizioni interne, in modo da renderlo quasi del tutto impermeabile a eventuali dati oggettivi contrari, provenienti dall’esperienza quotidiana.
Secondo Mary Douglas, i «primitivi» attivano processi istituzionalizzati di blaming (cioè di attribuzione di colpa) seguendo repertori che, sulla base delle numerose ricerche storico-etnografiche
condotte in gran parte del mondo, sembrano presentarsi in modo
più o meno fisso e ricorrente. In breve: A) Si può avanzare una spiegazione riferita agli «avversari interni»: ad esempio, di fronte alla
lunga malattia e alla morte di una donna, si può ipotizzare che la
donna non sia riuscita a realizzare una magia più efficace di quella
17
Mary Douglas (1921-2007), dopo gli anni trascorsi in collegio presso il convento del Sacro Cuore, di ascendenza gesuitica, a Roehampton, in Gran Bretagna,
proseguì la formazione all’Università di Oxford, dove, appena ventenne, frequentò
le lezioni di Evans-Pritchard, che insegnò African Sociology a Oxford dal 1935 al
1940 (succedendo a Radcliffe-Brown, dopo la guerra, nella cattedra di antropologia). Fra Mary Douglas e Evans-Pritchard si sviluppò un’intensa amicizia, e lei fu
una delle poche persone che rimase accanto al maestro fino alla morte, nel 1973.
125
delle sue rivali, oppure che sia vittima di invidie e di malignità. In altri termini la disgrazia è ricondotta a un’azione concreta o all’influenza negativa di qualche membro della comunità stessa. Questo
genere di interpretazioni sorreggono e guidano conseguenti strategie di comportamento, provocando azioni sociali volte al risarcimento o alla vendetta. B) In altri contesti sociali, in altre comunità,
si utilizzano spiegazioni riferite all’opera di un nemico esterno (ad
esempio come nel caso suggerito dalla bella raffigurazione azteca di
Popocatepetl, il «monte fumante»: rappresentazione sacralizzata di
un’eruzione vulcanica scatenatasi contro i conquistadores spagnoli),
e ciò motiverebbe delle azioni sociali volte a individuare i nemici per
combatterli o per infliggere loro una giusta punizione. C) Infine – secondo Douglas – in molte società «primitive» di fronte alla sciagura
e al disastro si ricorre a una spiegazione di tipo moralistico: una donna si è ammalata o è morta perché ha commesso adulterio, ha peccato o ha infranto qualche tabu; si attuerebbero allora delle azioni
sociali espiatorie mediante rituali di purificazione. Nella cultura tradizionale cinese, ad esempio, il significato della morte per folgorazione dopo essere stati colpiti da un fulmine può essere ricondotto
a questo repertorio di blaming. Il cielo viene rappresentato come
un’entità che punisce soprattutto le donne colpevoli di aver violato
gli obblighi familiari, o compiuto trasgressioni sessuali.
A partire dal fondamentale contributo di Evans-Pritchard, l’analisi condotta da Mary Douglas sui processi di blaming dimostra che
il pensiero nativo non è affatto irrazionale. L’utilizzazione politica
del pericolo e della contaminazione è invece un’efficace risorsa giudiziaria. La minaccia di una catastrofe rafforzerebbe le istituzioni sociali e i codici morali. La connessione simbolica tra male fisico e male morale è in realtà un dispositivo di conferma di un dato assetto
ideologico: più forte è la solidarietà di una comunità, più tempestiva sarà la codifica delle calamità naturali come segni di comportamenti riprovevoli. I tre repertori di spiegazione hanno grande valore antropologico – ancorché presentati qui in modo schematico – in
quanto agiscono su molteplici livelli come modalità culturali estremamente raffinate per manipolare il problema del senso del male.
A un primo livello, i tre repertori di blaming descritti da Mary
Douglas si pongono a tutti gli effetti come teorie della causalità, forniscono cioè una risposta (anche in termini cognitivi) al perché della
disgrazia, arginano l’irruzione dell’assurdo nella vita quotidiana. Sono però teorie della causalità che in genere funzionano come «doppia
126
lancia», per utilizzare la metafora zande: nel senso che operano a prescindere e al di sopra del livello esclusivamente empirico, relativo alla comprensione fattuale corretta dei nessi empirici fra le cose (largamente insufficiente a superare il dolore nel momento critico, o a risolvere la situazione di lutto)18. A un secondo livello, i processi di blaming hanno un valore sul piano politico e sull’organizzazione delle
strutture sociali: dire che «una donna si è ammalata perché ha tradito il marito», se da un lato significa dare un senso alla malattia, contemporaneamente, dall’altro, significa affermare: «Da noi la fedeltà è
un valore», quindi sostenere un dato sistema assiologico. Ogni malattia o morte fornisce l’occasione per definire e ribadire ciò che è socialmente riprovevole, e la definizione del pericolo ha lo scopo di proteggere il bene pubblico e l’integrità del gruppo.
Le ricerche di antropologia medica recentemente condotte da Ivo
Quaranta sulla diffusione dell’Aids in Camerun confermano, sotto
certi aspetti, questa impostazione. L’analisi della costruzione locale di
waame (la categoria concettuale e semantica nativa che rappresenta
l’Aids), in rapporto a virim ve shui (i rapporti incestuosi, ovvero la
«stregoneria del sole o del giorno»), ha messo in evidenza che
a Nso’, come altrove, si distingue in modo esplicito fra afflizioni inviate
dagli dei e afflizioni «fatte» dagli uomini. In questo secondo caso si tratta di stregoneria. La differenza tra le due categorie sta, quindi, nel ruolo
dell’azione umana nel produrre le condizioni per l’insorgere di malattia e
sventura (Quaranta 2006, p. 142, corsivo mio).
Si tratta di situazioni particolarmente gravi in cui le leggi che regolano le relazioni fra i gruppi vengono (più o meno consapevolmente) violate:
Le concezioni locali, dunque, istituiscono un nesso esplicito fra violazione del costume, stregoneria, rischio di contaminazione, indebolimento della capacità di difesa (immunità) e, quindi, vulnerabilità. [...]
18
Vale a dire che, di fronte alla morte per un grave incidente stradale di un nostro amico, sentiamo che ci è, in fondo, di poco aiuto sapere esattamente la dinamica tecnica dell’incidente. A questo livello, la risposta al «perché» è successo è in
realtà una risposta relativa al «come» è successo, e non invece al più profondo perché una tale disgrazia sia capitata proprio a lui e non a un’altra persona a noi sconosciuta. Da questo punto di vista, espressioni tipicamente occidentali come «per
una tragica fatalità», oppure «sia fatta la volontà del Signore» ecc. non sono qualitativamente differenti, né tantomento più razionali, della stregoneria zande.
127
l’unità del gruppo costituisce la sua garanzia e la sua sicurezza: «waame»
[la parola nativa che indica l’Aids] è un atto di stregoneria nella misura
in cui mina l’unità del gruppo, esponendolo al rischio di contaminazione, riducendo la sua capacità di difesa e, quindi, rendendolo vulnerabile
ad attacchi esterni (Quaranta 2006, p. 143).
Dunque waame non è niente di diverso dalla corruzione del corpo derivante dalla contaminazione provocata dalle violazioni dell’ordine morale. Rispetto alla compresenza, nello stesso sistema nativo
di significati, di molteplici teorie della causalità, è interessante notare che,
come argomentato da un medico ospedaliero di Kumbo, la stregoneria
non è affatto incompatibile con le teorie biomediche sulla trasmissione
dell’HIV. Al contrario, la stregoneria entra in gioco a livello esplicativo lì
dove si ferma la bio-medicina: quest’ultima non riesce a spiegare il motivo per cui, ad esempio, nell’avere rapporti con la stessa persona sieropositiva, X viene contagiato, mentre Y non viene colpito dal virus. In questo caso l’ideologia della stregoneria non solo spiega il perché una persona è vulnerabile al contagio, mentre l’altra ne è esentata, ma non sembra
affatto negare la validità del discorso biomedico (Quaranta 2006, p. 273).
terminarsi), ma forniscono anche modelli culturali su come reagire
praticamente. In altri termini, gli attori sociali coinvolti hanno così a
disposizione delle strategie di comportamenti culturalmente adeguati
per canalizzare l’aggressività, rimettere in moto la capacità di fare, superare il dolore del momento critico, scongiurare il collasso della cultura, evitando «di perdere la possibilità di farsi presente operativamente al mondo, il restringersi – sino all’annientarsi – di qualsiasi progettazione comunitaria secondo valori» (De Martino 1977, p. 219).
Da un punto di vista antropologico complessivo, queste teorie
della causalità come processi di blaming (in quanto non sempre trovare la causa e dare la colpa coincidono) riescono ad essere efficaci,
a funzionare secondo le modalità descritte, perché sono embodied,
ma anche embedded: sono cioè «incorporate» negli attori sociali e soprattutto sono «immerse» nel tessuto culturale globale di una data
società. Scrive Mary Douglas:
Le persone che formano una comunità non decidono consapevolmente di adottare l’uno o l’altro modello di attribuzione di colpa. I pericoli per l’integrità fisica e per la stessa vita entrano automaticamente nel
dibattito sulla costituzione di una società e ricadono in modelli regolari
in conformità con il genere di costituzione che viene sostenuto (Douglas
1996, p. 27).
La stregoneria fornisce quindi, per un verso, un orizzonte di senso al cui interno dare ragione della vulnerabilità individuale e, per
un altro, una conferma della struttura sociale, del sistema di valori e
dei rapporti di potere esistenti nella comunità.
Anche per quanto concerne la categoria interpretativa che attribuisce la causa della disgrazia ai «nemici esterni», il blaming può essere rovesciato e studiato come dispositivo sociale per ribadire i confini della comunità. Dire che i mali che ci affliggono dipendono, in
buona parte, dagli stranieri (oggi diremmo dagli extracomunitari) significa attivare un’attrezzatura concettuale per stabilire chi siamo
noi, quindi chi sono gli altri da noi (che lingua parlano, in che cosa
credono, come si comportano, perché sono qui ecc.); dunque in tale circostanza, come per la precedente, siamo alla presenza di una
teoria della causalità che non solo è generata da una ben precisa antropologia implicita, ma allo stesso tempo contribuisce a rinforzarla.
Un ulteriore livello sul quale agiscono i repertori di blaming è poi
quello relativo alla connessione essenziale fra piano delle idee e piano
delle azioni. Intendo dire che le teorie della causalità proposte non solo spiegano perché ci si trova in quella situazione (come è venuta a de-
Comprendere un processo di blaming come dispositivo simbolico
che attribuisce senso al male significa non limitarsi al solo studio dei
sistemi di credenze, ma porsi il problema teorico ed etnografico di
evidenziare le connessioni che quel dato dispositivo realizza con la
struttura sociale, con il sistema politico, con le relazioni di parentela,
con i rapporti di potere, col sistema economico ecc. Affiora a questo
proposito, in Douglas, un altro aspetto rilevante della lezione di
Evans-Pritchard: la ricerca sulla stregoneria zande ha mostrato – per
la prima volta – in che modo le credenze «mistiche» istituiscono relazioni articolate e variabili con tutta la struttura sociale sottostante.
Fra gli Azande la credenza nella stregoneria forniva una spiegazione
alla sventura chiamando in causa il potere malevolo di altri membri
della comunità, ma le accuse non erano mai lanciate a caso, tendevano invece a colpire categorie di individui ben definite (Douglas 1996).
Evans-Pritchard ha (fra gli altri) l’indiscutibile merito di non aver limitato la sua analisi delle credenze al piano simbolico, espressivo o
narrativo, delle credenze stesse, e neppure soltanto a quello teoretico
128
129
relativo alla razionalità in termini di logicità dei contenuti di ciò che
si crede; ma di aver registrato accuratamente la direzione e la frequenza delle accuse, riuscendo in tal modo a tracciare una mappa delle tensioni interpersonali che attraversavano la società.
Sulla base di tutte le considerazioni svolte finora, Mary Douglas
conclude che la cosiddetta teoria forense del pericolo ci mostra dei
«primitivi» un po’ meno primitivi di quanto non li avessero ritenuti
un Frazer, un Tylor, e considerevolmente meno mistici e pre-logici
di quanto non li avesse dipinti un Lévy-Bruhl. I «primitivi» si impegnano a sostenere l’efficacia di complicati rituali, e sono convinti della fondatezza e coerenza delle loro teodicee native, perché attivano
dei raffinatissimi dispositivi di microfisica istituzionale: conferiscono un senso al male, proteggono la coesione sociale, tracciano confini comunitari, ribadiscono valori e codici morali, utilizzano in senso politico il pericolo, e così via.
Tuttavia la teoria forense del pericolo descritta così è ancora incompleta. E qui si dispiega il contributo antropologico forse più innovativo di Mary Douglas (anche rispetto al maestro Evans-Pritchard) sul tema che stiamo trattando. Per quanto sofisticate, molto
poco ingenue e rozze, le credenze dei nativi – ancorché di tutt’altra
portata rispetto alla credenza infantile in Babbo Natale – sono pur
sempre credenze; e, anche se lievemente riconcettualizzata, la dicotomia (schema 4) rimane:
Schema 5
Perché è capitata la disgrazia?
(problema teorico dei nessi causali)
ALTRI
PRE-MODERNI
Primitivi
Credenza (falsa)
Magia
NOI
MODERNI
Civilizzati
Conoscenza (vera)
Scienza
DISASTRI:
peccato / ira di esseri spirituali
DISASTRI:
cause materiali / analisi scientifica
Irrazionali
Teoria forense del pericolo
Processi di blaming
Razionali
Tecnologia
Controllo tecnico dei pericoli
130
Nonostante la teoria forense del pericolo, la dicotomia è sempre
generata dal fatto di concepire la differenza fra noi e loro, fra «moderni» e «primitivi», come un problema cognitivo, cioè relativo alla
possibilità di acquisire delle conoscenze certe e vere sulle cause degli eventi pericolosi ed estremi che possono capitare.
Schema 6
Perché è capitata la disgrazia?
(problema teorico dei nessi causali)
ALTRI
PRE-MODERNI
La mancanza di tecnologia
fa sì che vengano
lanciate accuse (blaming)
per rinsaldare le istituzioni
NOI
MODERNI
I principi morali vengono
imposti razionalmente
e il pericolo si comprende
e si controlla con la tecnologia
Per Mary Douglas, negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, in cui era assai diffuso un luminoso ottimismo tecnologico (fiducia nell’energia nucleare, nell’industria chimica ecc.) e il benessere per tutti a basso costo sembrava una meta a portata di mano, si
confermò l’idea che la teoria forense del pericolo fosse applicabile ai
soli «primitivi». La scienza e la tecnologia, si diceva, hanno sciolto
per sempre il legame fra morale e pericolo e lo spostamento verso la
funzione del pericolo (minaccia di un disastro) come sostegno delle
istituzioni sociali non era più necessario: «‘loro’ considerano i pericoli in termini politici, nell’interesse delle istituzioni, ‘noi’ abbiamo
separato i pericoli dalla politica e dalla ideologia, e li consideriamo
in una prospettiva scientifica» (Douglas 1996, p. 18).
5. «Non nel mio cortile!»
A partire dagli anni Settanta del Novecento, a seguito di una serie di
fatti importanti a cui accenneremo in breve, proprio la tecnologia,
fino ad allora considerata il prodotto costitutivo e mirabile della modernità, e soprattutto il mezzo più efficace per dominare il pericolo,
venne messa per la prima volta sotto accusa come principale fonte di
pericolo. Maturò una consistente riflessione intellettuale e scientifica
131
sui limiti dello sviluppo tecnologico che, se davvero è in grado di migliorare la vita degli esseri umani (ed è perciò di fatto insostituibile),
è altrettanto vero che porta inesorabilmente con sé tutta una serie di
effetti collaterali altamente dannosi, se non gestiti in modo opportuno. La reale rilevanza degli effetti collaterali della tecnologia occidentale non era mai stata fino ad allora considerata.
Il 16 giugno del 1972 viene indetta a Stoccolma la Conferenza
Mondiale dell’ONU, che costituisce il primo grande evento internazionale dedicato alla tutela ambientale. In quel fondativo momento
di riflessione mondiale che fu la Conferenza di Stoccolma (con 100
paesi e 400 organizzazioni governative, più una miriade di ONG), si
incominciò a considerare il rapporto fra crescita economica e tutela
ambientale, sottolineando la responsabilità internazionale nella tutela degli ecosistemi, e l’importanza di una governance internazionale per i mutamenti ecosistemici e climatici, oltre che per la gestione
delle situazioni di emergenza di massa19. L’anno successivo, il 1973
(in cui partì il Programma Azione Ambientale della CEE), a seguito
della grave crisi petrolifera, rappresentò un’altra tappa determinante di quel lento processo socio-culturale e politico di revisione del
mito della crescita occidentale illimitata. Il mito, prevalente nel periodo del boom economico, di un radioso e inarrestabile progresso
basato sulla fiducia cieca nella scienza, sul potere della tecnologia,
oltre che sulla capacità delle società occidentali di darsi un’efficace
organizzazione socio-politica per guidare al meglio lo sviluppo, si
scontrò con i limiti oggettivi delle risorse naturali non rinnovabili, e
con la gestione di una tremenda serie di disastri tecnologici. Il neonato «Club di Roma» – un gruppo di intellettuali e scienziati impegnati nell’analisi dei problemi ambientali – con la pubblicazione del
volume I limiti dello sviluppo, basato su uno studio del MIT sullo stato del pianeta, tracciava un profilo allarmistico a tinte fosche del de-
grado ambientale e delle irreversibili trasformazioni ecologiche indotte dal fenomeno dell’antropizzazione20.
In quegli anni si formarono anche i primi gruppi di «cittadinanza attiva», mediante i quali la popolazione mirava a costituirsi soggetto politico autonomo sulla base della rivendicazione ambientale,
criticando (e di fatto saltando) i meccanismi istituzionalizzati della
rappresentanza. Comparvero i cosiddetti fenomeni NIMBY e LULU,
celebri acronimi per «Not In My Backyard» («Non nel mio cortile»)
e «Locally Unwanted Land Use» («Utilizzazione del territorio localmente non voluta»), per indicare l’atteggiamento di contestazione
sociale secondo cui, nonostante la comunità (a livello regionale e/o
statale) dichiarasse indispensabile un intervento di ingegneria infrastrutturale (come ad esempio il passante di un’autostrada), oppure
l’istallazione di un impianto industriale (come un inceneritore per i
rifiuti), e nonostante che ogni cittadino, singolarmente, si ritenesse
d’accordo sull’attuazione dell’opera, poi in concreto gli abitanti del
piccolo paese, o i residenti del quartiere accanto al quale sarebbe dovuto sorgere l’impianto, scatenavano una fortissima opposizione,
rendendo di fatto irrealizzabile il progetto (come dire: tutti concordano sulla necessità dell’impianto, ma nessuno lo vuole accanto a casa propria). I fenomeni NIMBY e LULU richiamarono l’attenzione anche su una nuova forma di autoctonia, di indigenità, per cui al locale doveva essere accordata, in ultima istanza, la preminenza sul nazionale e sul globale.
Quel clima di dibattiti, a volte aspri e ideologicamente condizionati, non fu certo attenuato dal verificarsi, nel giro di pochi anni, di
gravissimi disastri: nel 1976 scoppia il caso della contaminazione di
diossina a Seveso (Centemeri 2006), e il 29 marzo 1979, presso la
centrale atomica di Three Mile Island, ad Harrisburg in Pennsylvania, viene sfiorato – per la prima volta nella storia dell’ingegneria nucleare – l’incidente di livello più grave nella scala di pericolosità: la
fusione del nocciolo, con conseguente possibilità di «sindrome cinese». Appena sette anni dopo, il disastro di Černobyl’ rappresentò
per molti paesi un punto di svolta radicale sul piano socio-culturale
ed economico (come per l’Italia, che rinunciò definitivamente al nucleare), e una fase di mutamento epistemologico profondo nel con-
19
Il tema dell’interconnessione globale dei fenomeni antropici, sia rispetto alla produzione di situazioni di pericolo, sia per la gestione degli interventi di soccorso, fu al centro del volume collettivo di Gilbert White (di cui abbiamo già parlato nel capitolo 1), significativamente intitolato Natural Hazards. Local, National,
Global (1974). Ricordo che una decina d’anni prima della Conferenza di Stoccolma, nel 1962, era apparso il celebre volume di Rachel Carson, Silent Spring, sul degrado ecologico, l’uso dei pesticidi e i problemi legati all’inquinamento ambientale negli Stati Uniti, che ebbe un forte impatto sull’opinione pubblica, determinando il costituirsi delle prime organizzazioni ambientaliste (i grassroots movements).
Il WWF nasce nel 1961.
20
Si veda MIT System Dynamics Group, I limiti dello sviluppo: rapporto del Club
di Roma sui dilemmi dell’umanità, Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, Milano 1972 (159 pp.); e cfr. Meadows, Meadows 1975.
132
133
cepire la tecnologia come capacità di intervento dell’uomo sull’ambiente, e nel prevedere le possibilità di controllo del pericolo.
La studiosa Bruna De Marchi, coordinatrice del Programma
emergenze di massa dell’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia, ha messo bene in evidenza il carattere di straordinaria unicità
assunto dall’incidente di Černobyl’:
La maggior parte dei media occidentali enfatizzarono l’evento anche
per esigenze politiche: il disastro avvenne nell’ex Unione Sovietica, durante gli anni della guerra fredda, e il frame interpretativo più ricorrente
era quello della superiorità della tecnologia occidentale: da noi – si scrisse – non sarebbe mai potuto accadere. In realtà, anche la centrale nucleare di Sellafield in Gran Bretagna è stata protagonista di svariati incidenti, che tuttavia non hanno ricevuto la stessa attenzione. Come se non
bastasse, di fronte alle telecamere la comunità scientifica apparve profondamente divisa: scienziati ugualmente accreditati espressero pareri contrapposti, contribuendo ad accrescere l’allarme e a smitizzare l’idea che la
scienza sia un sapere unitario e affidabile.
Inoltre, De Marchi osserva molto apportunamente, cogliendo il
nodo centrale della questione, che la situazione determinatasi con
Černobyl’
non fu una distorsione dei media bensì una rappresentazione fedele di
quanto normalmente avviene all’interno delle accademie, in cui il dibattito è linfa vitale per la costruzione del sapere scientifico. Semplicemente, per la prima volta in modo tanto eclatante, tale dibattito si svolse sotto i riflettori, mostrando a un vastissimo pubblico come lo stesso «fatto»
si presti a valutazioni differenti e come la «passione» non sia estranea alla comunità scientifica, che è solitamente considerata il reame della sola
«ragione»21.
L’incompletezza costitutiva e intrinseca della conoscenza scientifica ha infranto il mito illuminista dell’oggettivismo puro e ha messo in evidenza l’impossibilità di raggiungere la certezza del pericolo
o della sicurezza (di un dato impianto, di un dato processo produttivo, dell’evenienza di un dato fenomeno naturale estremo ecc.). Di
conseguenza si è reso necessario introdurre la categoria concettuale
di rischio.
21
Cit. in Sturloni 2006, p. 90, corsivi miei.
134
A partire dagli anni Ottanta, il rischio cominciò a configurarsi come nuova categoria analitica per gestire il pericolo tecnologico. Come ha osservato Mary Douglas22, grazie al contributo di ricerca e alla riflessione epistemologica di molte discipline scientifiche (fisica,
epidemiologia, biostatistica ecc.) divenne via via sempre più chiaro
che la vecchia connessione fra morale e pericolo, per decenni ritenuta tipica esclusivamente delle società «primitive», non è prodotta
dalla mancanza di conoscenza, perché la conoscenza è sempre insufficiente, è sempre incompleta, e l’ambiguità è sempre in agguato. Volendo attribuire una colpa si troverà sempre il modo di interpretare
le prove nel senso voluto. Dunque l’industrializzazione e la modernizzazione non hanno prodotto degli esseri umani capaci di non ricorrere al pericolo per proteggere il bene pubblico, e una qualche
forma di teoria forense del pericolo è attiva anche qui da noi nel moderno Occidente. Il rischio, in quanto irriducibile anomalia cognitiva, limite intrinseco alle classificazioni, categoria concettuale per
certi versi residuale, creata ad hoc per manipolare l’incerto, l’indefinibile, appunto l’inclassificabile (e dunque l’inconoscibile, che però
resta pur sempre ineliminabile), può essere considerato, per la nostra società, come il famoso pangolino (Manis tricuspis), mammifero
dal comportamento e dall’aspetto inclassificabile e contraddittorio
secondo l’accuratissima tassonomia nativa dei Lele del Kasai, sul
quale proprio Mary Douglas ha avanzato considerazioni antropologiche di grande interesse (Douglas 1993, pp. 245-271).
6. Il concetto di rischio e i limiti della «risk analysis»
La derivazione etimologica del termine rischio è quantomai controversa, e mancano ancora ricerche storico-filologiche adeguate; tanto più che anticamente la parola veniva utilizzata di rado e in contesti talvolta assai differenti. Secondo alcuni studiosi, deriva dal tardo latino risicum, a sua volta derivato dall’antico spagnolo risco,
«scoglio» (ovvero, una fonte di pericolo per le navi); secondo altri,
potrebbe derivare da lemmi di origine greca (rizicon, legato al concetto di «sorte», «fato» ecc.), o araba (rizq, che significa «ciò che
viene da Dio»), oppure dal latino classico resecare, cioè tagliare, in22 Si vedano le ricerche degli anni Ottanta, confluite in vari volumi e raccolte
di saggi, fra cui Douglas 1982, 1985, 1990, 1996.
135
teso anche nel senso di «tagliare le onde al contrario», quindi in
maniera pericolosa. Il termine resecare potrebbe aver generato risicare nel senso di «rischiare» o «osare» (Luhmann 1996, pp. 9-43;
cfr. Maso 2003). Qualunque sia l’esatta radice etimologica, il processo di costruzione della concezione moderna di rischio inizia nel
tardo Medioevo, con la nascita dei primi gruppi di assicuratori nelle grandi città europee, per la tutela dei mercanti-navigatori del Mediterraneo e del Baltico. L’assicurazione costituì a tutti gli effetti un
sistema finanziario basato sulla probabilità di occorrenza di un
evento temuto, contro la cui ricaduta economica ci si difende tramite la stipula di un contratto specifico. Nei contratti che regolavano chi avrebbe dovuto sopportare il danno nel caso che esso si
fosse verificato, si trovano formulazioni quali: «ad risicum et fortunam», «pro securitate et risiko», «ad omnen risicum, periculum er
fortunam...» ecc. Fra il XVI e il XVII secolo, dall’ambito marinaro, il termine si affermò in Europa, assumendo via via significati
molteplici: pericolo, audacia, caso, fortuna, coraggio, timore ecc. In
uno scritto del Cardinale Richelieu (1585-1642) troviamo una massima piuttosto interessante che contiene già tutta la struttura concettuale dell’idea moderna di rischio:
Un male che si presenti solo di rado può non essere preso in considerazione. Questo vale in tutti i casi in cui, per evitarlo, ci si espone a molti mali che sono inevitabili e con conseguenze maggiori (cit. in Luhmann
1996, p. 21).
Emergono qui due elementi essenziali: a) la situazione di rischio
ha sempre a che fare con una decisione, con l’atto di compiere una
scelta fra più alternative. Non si può non scegliere, ma si è costretti
a valutare la scelta migliore sulla base di una conoscenza che sarà
sempre intrinsecamente incompleta nel momento in cui la scelta deve essere compiuta; b) la situazione di rischio chiama sempre in causa il fattore tempo: la bontà della scelta fatta, l’efficacia dell’azione
intrapresa, è funzionale alla bontà degli effetti prodotti, degli obiettivi raggiunti, che tuttavia non si possono mai completamente determinare prima di aver operato la scelta e dato corso all’azione. Allora il rischio si configura come un’esposizione agli effetti di una
scelta di cui ci si potrà pentire, ma solo se effettivamente procurerà
un danno che si sperava di evitare. Vi è quindi l’idea che non si hanno vantaggi se non si mette in gioco qualcosa, se non si «rischia», ov136
vero se non si decide di agire accettando l’incompletezza costitutiva
della propria conoscenza, e l’incapacità – parimenti costitutiva e ineliminabile – di prevedere il futuro. Si fa strada dunque la nozione
fondamentale di probabilità: non potendo prevedere con certezza
quali effetti dannosi produrrà esattamente la mia scelta, mi chiedo
se sono in grado almeno di stabilire le probabilità che si verifichi un
evento dannoso a seguito delle mie azioni.
Tralasciando le importanti opere di Jacob Bernoulli e di Abraham De Moivre, del Settecento, è con la definizione del Teorema di
Bayes (1764), e i suoi conseguenti sviluppi, che si formò la base per
la trattazione logico-razionale della presa di decisioni in situazioni di
incertezza. Il flusso di informazioni che attraversava la comunità nel
corso del tempo cominciò ad essere considerato il fattore determinante per stimare le probabilità di un certo evento (perciò mai definibili in modo assoluto). La forma definitiva del concetto moderno
di rischio venne raggiunta con la pubblicazione, nel 1921, dell’opera di teoria economica Risk, Uncertainty and Profit di Frank Knight,
fondamentale per l’impianto concettuale della risk analysis. L’impostazione di Knight consiste nell’aver sviluppato la differenza tra rischio e incertezza: il rischio rappresenta una calcolabilità statistica,
mentre l’incertezza consiste nell’intrattabilità quantitativa: «I moderni avevano eliminato la naturale indeterminatezza o ‘incertezza’.
Grazie al mito della calcolabilità, avevano imparato a trasformare un
cosmo radicalmente indeterminato in uno maneggevole» (Reddy
1996, p. 237)23.
Si delinea così l’approccio cosiddetto realista al rischio, fondato
sull’idea che il concetto di rischio debba essere determinato opponendolo a quello di sicurezza. La scienza non può più garantire alcuna forma di certezza assoluta e dunque anche la sicurezza assoluta, rispetto all’eventualità che si verifichi un evento dannoso, non potrà mai più essere raggiunta. Qualunque azione non sarà mai esente
da rischi, perciò diventa essenziale padroneggiare almeno l’incertezza, valutando i rischi con una modellistica quantitativa adeguata. Nel
1980, in Gran Bretagna, con la costituzione della Royal Society for
the Risk Analysis, nascono gli esperti di sicurezza, i professionisti
nell’analisi dei rischi.
23
Sullo sviluppo storico delle idee di casualità, di rischio e di probabilità, ritengo indispensabili le opere dell’epistemologo e storico della scienza Ian Hacking,
in particolare Hacking 1987 e 1994.
137
Passando da una prospettiva deterministica a una probabilistica
sulla possibilità di conoscere i nessi causali tra i fatti, il concetto di
rischio è manipolato in modo ragionieristico per calcolare la misura
di ciò che si può razionalmente sperare di raggiungere. L’epistemologia modernista riformula così la nozione di rischio nei termini di
una esatta trattazione statistica della probabilità, ai fini di produrre
una più efficace analisi e gestione sociale degli eventi estremi, delle
sciagure e dei disastri, di ordine economico, tecnologico e ambientale.
Che cos’è dunque il rischio? Come lo si determina? Il rischio è
una variabile oggettiva o una costruzione sociale? La percezione del
rischio connesso a un dato evento (l’eruzione di un vulcano ritenuto sacro, l’evenienza di un’inondazione in una società tropicale,
l’esplosione di un impianto chimico in un paese in via di sviluppo
ecc.) si forma mediante processi psicologici individuali e in qualche
modo naturali, oppure varia in modo consistente a seconda della cultura considerata e risulta frutto di raffinati processi istituzionali?
Molto brevemente, si può dire che il rischio (R) è dato dalla relazione fra il danno (D) associato a un evento e le probabilità (P) che
l’evento ha di verificarsi (relazione 4):
(4)
R=D×P
schio è accettabile? Chi è responsabile di attuare scelte sociali, politiche, tecniche, industriali che espongono all’1% di rischio?
La cosiddetta risk analysis ha elaborato una complessa modellistica matematica per determinare oggettivamente l’accettabilità del
rischio connesso a processi economici e industriali, o a fenomeni naturali, che potrebbero dar luogo a un disastro. I principi di base della risk analysis sono:
a) che l’opinione pubblica consista di individui isolati e indipendenti, i quali naturalmente possono e debbono comportarsi razionalmente nel valutare le probabilità dei rischi ai quali sono esposti;
se non lo fanno è perché hanno una percezione distorta dei fatti dovuta a un gap di conoscenza fra gente comune ed esperti;
b) che il rischio sia un costrutto concettuale di tipo esclusivamente probabilistico e quindi possa essere descritto mediante la frequenza attesa degli eventi indesiderati;
c) che per valutare i beni individuali o sociali potenzialmente minacciati nel futuro (compresa la vita) si debba ricorrere a un calcolo
costi/benefici basato sulla loro monetarizzazione24.
La gestione sociale del rischio ambientale rimane profondamente asimmetrica e fondata sull’assunzione di superiorità del sapere tecnico-ingegneristico che viene comunicato ed elargito alla popolazione. L’assioma implicito di derivazione positivistica è che la conoscenza tecnico-scientifica condurrà a una comprensione completa
della natura, oltre che alla capacità di gestirla con sicurezza mediante modelli probabilistici.
Il motivo essenziale per cui questo modello non regge è perché si
applica nei calcoli una finzione concettuale: ovvero l’ipotesi che il
soggetto agente che percepisce il rischio sia provvisto di una razionalità oggettiva, contest-free (verrebbe da dire «naturale»). Il modello valuta i comportamenti considerando gli attori sociali come individui deculturati ed estranei a qualunque feedback di tipo morale o
politico che possano ricevere dalla società che li circonda.
La determinazione complessiva del rischio si attua dunque attraverso due fasi:
a) la determinazione che un dato evento costituisce un pericolo;
b) la determinazione delle probabilità che quel dato evento pericoloso si verifichi davvero.
Come vedremo, entrambi questi passaggi non sono completamente oggettivabili, cioè trattabili esclusivamente con una modellistica matematica, ma sono in gran parte delle costruzioni culturali
che pongono problemi eminentemente socio-antropologici: chi è
preposto a valutare che un dato evento è pericoloso? Su quali basi?
Si possono rendere meno ambigui i dati scientifici e ridurre i conflitti fra ricercatori? Quanto tempo ci vuole per accertare che un dato evento costituisce un pericolo? Chi e come è preposto a valutare
le probabilità che il danno si verifichi? Vi è sempre accordo nella comunità scientifica sulla stima di tali probabilità? Può essere raggiunto un valore di certezza? E infine: qualora si accerti che le probabilità di un danno siano ad esempio dell’1%, chi decide che il ri-
24
Per una trattazione approfondita di questi principi, in relazione al loro sviluppo storico e in rapporto alla teoria culturale, rinvio all’ottimo volume di sintesi
di Alberto Marinelli (1993); cfr. Lupton 2003; Trentini 2006; AA.VV., Rischio, numero monografico di «Parolechiave», nn. 22-23-24, 2000.
138
139
Il tentativo di formulare un metodo oggettivo per ridurre e rendere
accettabile l’incertezza rispetto al futuro si è scontrato con la pratica im-
possibilità di ricondurre entro un unico schema analitico la pluralità dei
processi di percezione e imputazione sociale del rischio. Anche quando
il costo per superare il gap di conoscenza non è sopportato dal singolo e
l’informazione aggiuntiva diviene disponibile, ciò non modifica necessariamente i comportamenti nel senso previsto dal modello della scelta razionale (Trentini 2006, p. 70).
Basti pensare semplicemente al fatto che molte persone rifiutano di assicurarsi contro inondazioni e terremoti, continuano ad attraversare incautamente strade molto trafficate, guidano veicoli non
sicuri, acquistano elettrodomestici potenzialmente pericolosi, e così via.
Il postulato di base che il soggetto agente che percepisce il rischio
sia razionale e soprattutto deculturato (o che le variabili culturali siano irrilevanti per l’analisi) risulta dunque profondamente errato. Al
contrario, come dimostra bene il celebre caso della contaminazione
ambientale di Love Canal (di cui parleremo nel prossimo paragrafo),
di fronte all’emergenza e alla percezione del rischio le comunità possono spaccarsi in sottogruppi sociali differenti in cui emergono differenti forme di razionalità che orientano comportamenti fra loro opposti, alcuni dei quali possono apparire incomprensibili, esattamente per gli stessi motivi per i quali possono apparire incomprensibili i
comportamenti dei «primitivi» Azande studiati da Evans-Prichard.
Il postulato a) del modello della risk analysis, a ben vedere, riproduce e riattualizza la dicotomia fra primitivi e moderni (v. schema 5),
riposizionandola però nell’ambito della stessa modernità, come dicotomia fra gente comune ed esperti:
In altre parole, il modello non tiene conto della natura sociale della razionalità25. E questo è un ulteriore tema di assoluta pertinenza
antropologica. Già Émile Durkheim e Marcel Mauss, nel 1902, nel
loro fondamentale saggio su alcune forme primitive di classificazione (uno dei primi lavori strettamente antropologici di Durkheim)
avevano sostenuto che i metodi del pensiero scientifico sono essi
stessi istituzioni sociali e che non esiste una distinzione netta fra pensiero sociale e pensiero scientifico. Gli scienziati (matematici, fisici,
economisti, filosofi, antropologi ecc.) costituiscono delle comunità
scientifiche, delle tribù, ovvero dei gruppi in cui si produce e si
scambia un certo sapere secondo certi costumi di pensiero in base a
determinati modelli culturali (Kuhn 1978).
Dallo studio antropologico comparato di alcuni recenti disastri
in società occidentali e extra-occidentali sta emergendo chiaramente che il concetto di sicurezza non si riferisce mai a un dato completamente oggettivo, ma si basa sempre su una componente di finzione sociale. L’antropologia dei disastri può studiare che cosa venga
consensualmente trattato come sicuro nella comunicazione sociale e
quanto queste finzioni siano stabili in caso di esperienze contrarie
(disastri). Come si usa dire: «How safe is safe enough?», «quanto dovrebbe essere sicura una cosa, per essere ritenuta abbastanza sicura?» (Bianchi 1993b). La risposta a questa domanda è una tipica variabile trans-culturale. Il caso forse più famoso, diventato ormai paradigmatico, in cui questi temi emergono chiaramente, è costituito
dal più grande disastro ambientale accaduto negli Stati Uniti, del
quale tratteremo nel prossimo paragrafo.
7. Il disastro di Love Canal: la natura sociale della razionalità
Schema 7
Modernità
(problema teorico della percezione del rischio
e delle «migliori» scelte possibili)
ALTRI
GENTE COMUNE
NOI
ESPERTI
Luoghi comuni
Credenze (false)
Comportamenti irrazionali
Certezza scientifica
Conoscenze (vere)
Comportamenti razionali
Pensiero sociale
Pensiero scientifico
140
Abbiamo definito il rischio come l’«eventualità che si verifichi una
situazione dannosa», mentre il «pericolo» è una situazione da cui
certamente deriva un danno per qualcuno o per qualcosa. Il rischio
rappresenta quindi la misura della probabilità che tale situazione si
presenti effettivamente. Allora per calcolare il rischio – come abbiamo detto – si devono compiere due passaggi collegati: a) determinare che una data situazione di fatto sia dannosa; b) determinare le probabilità che quella situazione si verifichi. Il disastro di Love Canal è
un esempio concreto di quanto entrambi questi passaggi, all’appa25
Si veda Shrader-Frechette 1991; Lupton 1999; Caplan 2000.
141
renza facilmente trattabili, pongano al contrario problemi estremamente difficili, per i quali non è in genere mai sufficiente la sola modellistica matematica. La prospettiva analitica esclusivamente tecnocentrica per lo studio degli eventi estremi deve essere opportunamente integrata (si badi bene, non sostituita) da una prospettiva socio-antropologica. Nel caso di Love Canal, su cui vi è una consistente
letteratura proprio per la rilevanza delle questioni che ha sollevato,
la situazione pericolosa è il contrarre una malattia e il rischio da valutare è il rischio di ammalarsi, in particolare di contrarre una gravissima patologia tumorale, come la leucemia linfatica acuta, in conseguenza dell’esposizione a una forma altrettanto grave di inquinamento ambientale da residui chimici tossici (il disastro)26.
Negli anni Cinquanta del Novecento, tutta la zona in cui attualmente sorge Love Canal – un sobborgo della cittadina di Niagara Falls, nello Stato di New York – faceva parte di un vasto progetto per la
realizzazione di un’imponente area industriale chiamata «Model
City». Lo sviluppo industriale non partì e di fatto il progetto andò incontro a un rapido fallimento, gli impianti rimasero inutilizzati, finché la Hooker Chemical Company, una grande industria chimica
americana, decise di servirsene per installarvi un proprio ciclo produttivo. Un grande e profondo canalone di cemento, progettato e realizzato anni prima dall’ingegner William Love, nel periodo in cui
l’area industriale di Model City sembrava sul punto di entrare in funzione, ma rimasto poi a lungo inutilizzato, venne adibito dalla Hooker
a deposito per lo stoccaggio definitivo di ogni genere di rifiuti industriali. Per circa una decina d’anni la Hooker si servì del «Love Canal»
come vera e propria discarica, collocandovi (e poi interrando) ben
21.800 tonnellate di sostanze chimiche altamente tossiche. Nel 1953,
l’area venne comprata dal comune di Niagara Falls, che gradualmente la trasformò in un piccolo centro urbano abitato in prevalenza dagli operai della Hooker e da pensionati. Sorsero una scuola elementare, una chiesa cattolica e due protestanti, si fecero strade, si aprirono negozi, e così via; finché nacque la comunità di Love Canal.
Nel 1978, circa vent’anni dopo, quando la comunità è diventata
ormai una vera e propria cittadina, gli ufficiali sanitari dello Stato
diffondono all’improvviso un comunicato d’emergenza nel quale si
annuncia alla popolazione che tutta l’area risulta contaminata da residui industriali che pongono un grave e immediato pericolo per la
salute. Nonostante il tono allarmante iniziale, le notizie successive
delle autorità sono vaghe e contraddittorie. Nei giorni seguenti
all’annuncio la prima misura d’emergenza è l’evacuazione di 6 donne incinte e di 20 bambini. Ma sotto la pressione dei residenti, che
non ritengono verosimile poter individuare e circoscrivere così nettamente gli individui a rischio, le autorità adottano una seconda misura: dispongono l’evacuazione di tutte le famiglie che vivono in 239
abitazioni situate nelle prime due file adiacenti al canalone. Tuttavia, come è facilmente immaginabile, nemmeno questa misura appare sufficiente, e scoppia un caso nazionale27.
Dopo le prime settimane, risulta chiaro che l’inquinamento è assai più vasto, rispetto a quello che si poteva immaginare, e che prevederne la reale estensione e i possibili effetti sulla salute sarebbe stato estremamente difficile, e avrebbe richiesto molti mesi di analisi.
Sarebbe stato impossibile riconoscere esattamente (con nomi e cognomi) le effettive vittime dell’inquinamento.
Come ha ben specificato Paolo Vineis, il riconoscimento di un
nesso causale tra un episodio di inquinamento ambientale e l’insorgenza di malattie croniche è una delle situazioni più complesse che
l’epidemiologo possa trovarsi ad affrontare. Questa situazione pone
in evidenza concretamente un punto essenziale: la crisi del concetto
di causa in medicina. Nella visione biomedica classica, la nozione di
causa era di tipo strettamente deterministico. L’idea di causa che ha
dominato nelle scienze mediche per un lungo periodo era strettamente associata alle scoperte della micro-biologia: l’agente causale,
si diceva, deve essere molto prossimo – spazialmente e temporalmente – all’effetto. Esso deve essere riscontrato fisicamente nelle lesioni proprie della malattia, o almeno un contatto con l’agente doveva essersi verificato di recente. Il modello implicito utilizzato è
quello della causa efficiente di derivazione aristotelica28. Il motto di
26
Sul caso di Love Canal si veda ad esempio Gordon Levine 1982. Tuttavia,
per le tematiche che ho sinora descritto in questo libro, ritengo essenziale l’approccio utilizzato dall’epidemiologo Paolo Vineis (1990) al quale mi riferirò costantemente nel corso di questo paragrafo.
27
Si tratta del noto problema del de minimis, ovvero di definire quando una sostanza presente nell’ambiente supera una certa soglia e diviene pericolosa. Questa
soglia dipende da una decisione di tipo arbitrario che vede spesso duri contrasti
non solo fra tecnici e non tecnici, ma anche fra gli stessi tecnici.
28
Sono i postulati di Henle-Koch, capisaldi dell’interpretazione causale
nell’era micro-biologica: a) un microorganismo può svolgere un ruolo causale nei
confronti di una malattia se la sua presenza è al contempo necessaria e sufficiente
142
143
quel periodo, la seconda metà dell’Ottocento, quando si sviluppò la
micro-biologia e l’anatomia patologica, era la famosa affermazione
di Bichat: «Una serie di autopsie farà più luce di vent’anni di osservazioni di sintomi» (Vineis 1990, p. 107).
Secondo Vineis, la svolta probabilistica in epidemiologia costituisce una rivoluzione concettuale rispetto a un’impostazione à la Bichat, e insospettabilmente contraddice l’immagine banale che fa
coincidere l’affermazione del cosiddetto metodo scientifico con una
progressiva semplificazione dei nessi causali, volta a ottenere certezze sempre maggiori. Questo punto ci riporta direttamente all’analisi antropologica di Mary Douglas sulla teoria forense del pericolo e
sull’idea modernista di una scienza come criterio ultimo di verità, un
tipo di sapere in grado di produrre certezze, rispetto alle illusioni dei
sistemi nativi di credenza.
È noto che non vi è una sola causa del cancro polmonare o dell’infarto, e che non tutti coloro che sono esposti a un fattore di rischio
(come il fumo) sono destinati a contrarre questa malattia. Il paradigma della causa efficiente si è dissolto in seguito al riconoscimento dei lunghi periodi di latenza propri delle malattie degenerative. Il
carattere non necessario del nesso causale è indicato non solo dal fatto che ad esempio il cancro può insorgere nei non fumatori (seppure con una frequenza molto più bassa che nei fumatori), ma dall’esistenza di molte altre cause (asbesto, alcuni metalli pesanti, idrocarburi aromatici policiclici, radiazioni ionizzanti ecc.). Il vocabolo
«causa» viene ad assumere quindi un senso modificato rispetto alla
tradizione aristotelica (Vineis 2002). Oggi si parla di causazione multipla, o di rete di causazione, per intendere che diverse esposizioni sono in grado, separatamente o con il concorso di più d’una, di provocare una malattia. Le malattie croniche sono interpretate come
processi a più stadi: non è più una singola esposizione, ma una successione di eposizioni nel corso del tempo a costituire un complesso
causale sufficiente.
I criteri per il riconoscimento della relazione causa-effetto in medicina si sono dunque complicati e indeboliti, e tale relazione ha assunto un carattere inequivocabilmente stocastico. Dal punto di vista
specifico del nostro caso di studio, la proprietà centrale di ogni processo stocastico è ovviamente l’impossibilità di predire la sorte indivi-
duale, ma – allo stesso tempo – questo è l’unico vero tipo di informazione «scientifica» a cui la gente comune è interessata in un contesto
di emergenza di massa: di fronte a un comunicato d’urgenza come
quello diffuso nel 1978 a Love Canal, le persone non si impegnano in
sottili digressioni epistemologiche, ma vogliono sapere esattamente
chi deve essere evacuato e perché29. Se il problema è quello di sapere
non solo il numero dei malati, ma soprattutto quali persone si ammalano (o se singole malattie già presenti nel momento in cui viene dato
l’allarme possano connettersi con l’esposizione all’agente inquinante) allora occore concentrarsi: a) sui rapporti specifici individuo-ambiente e b) sulle variazioni delle reazioni individuali.
In tale circostanza, il livello di complessità sale vertiginosamente:
non abbiamo più davanti a noi un oggetto dato (un cadavere da sezionare o un batterio da isolare); dobbiamo invece costruire un ambito di osservazione che ci consenta di far vedere le connessioni tra
comportamenti e insorgenza della malattia. Come ha osservato Vineis, il primo problema consiste nel ricostruire un reticolo di cause
che ha trasformato un individuo sano, o un gruppo di individui, in
altrettanti malati, ovvero costruire un campione di osservazione. Si
tratta di un’operazione fondamentale né semplice né meccanica: occorre definire il gruppo che è oggetto di analisi; tracciarne i confini;
stabilirne le dimensioni; determinare il peso da assegnare alle differenze fra i vari comportamenti (stili di vita, abitudini, attività lavorativa, malattie ereditarie, storia clinica personale ecc.). Ed è il concetto di rischio che presiede a tutte queste scelte. La sua definizione
socialmente determinata, passibile di manipolazione e di contrattazione, costruisce l’oggetto, detta i limiti e i caratteri della realtà da
indagare (Vineis 1990, pp. 108-121).
Torniamo al caso di Love Canal. Quando l’inquinamento viene
rilevato, il corpo sociale si frammenta, la popolazione assume inaspettatamente due atteggiamenti opposti. E qui si profila subito una
situazione di grande rilevanza dal punto di vista antropologico, il
quale invita a non considerare le «società» come strutture omogene,
all’induzione di quella patologia; o b) almeno un contatto con l’agente dove essersi recentemente verificato (Vineis 1990, p. 20).
29
Questo è il tema fondamentale delle strategie formative, informative e comunicative, della scienza: quali idee sulla natura della scienza, sui suoi scopi e metodi, circolano a livello del cosiddetto «uomo della strada»? Quale versione «popolare» di oggettivismo o di determinismo è ancora prevalente in ampi strati della
popolazione? Quali programmi educativi e informativi adeguati possono essere elaborati per diffondere una visione meno ingenua del processo di conoscenza scientifica?
144
145
fisse, compatte, rigide nei propri confini e nelle proprie assunzioni
identitarie.
Sulla base di un accurato studio etnografico, attraverso interviste
profonde integrate da indagini a campione, emerge il profilo di due
gruppi distinti. Circa 1/3 delle famiglie della comunità, che definiamo qui come il gruppo dei minimalisti, assume un atteggiamento incline a sottostimare il pericolo: per loro il problema è molto limitato e non tale da giustificare un provvedimento drastico come l’evacuazione. Per i restanti 2/3 circa delle famiglie di Love Canal, che
definiamo, al contrario, come il gruppo dei massimalisti, la situazione è percepita in modo radicalmente diverso: per loro si tratta di un
problema assai più allarmante di quanto è stato presentato dai giornali e dalle autorità, per cui non solo l’evacuazione è indispensabile,
ma la si deve attuare al più presto e per tutti.
Analizzando più in dettaglio il campione, si scopre che l’età e la
composizione familiare sono fortemente associate con l’atteggiamento verso il problema, e affiorano anche ulteriori caratteristiche
socio-culturali che i membri di ciascun gruppo hanno in comune fra
loro. I minimalisti sono in genere pensionati senza figli in giovane età
e hanno finito di pagare il mutuo della casa o le rate per altre forme
di proprietà. Alcuni hanno fatto una lunga carriera alla Hooker, lavorando in un periodo e in un contesto culturale nel quale il messaggio era «le sostanze chimiche sono nostre amiche»: dichiarano di
aver sempre lavorato bene, di non sentirsi in alcun modo responsabili dell’inquinamento. L’impresa aveva rappresentato per loro non
solo un’attività lavorativa, ma anche un progetto di vita e una sorta
di grande famiglia alla quale si sentivano con onore legati. Per i minimalisti, inoltre, l’evacuazione non deve essere stabilita dall’alto e
imposta d’autorità, ma va lasciata alla discrezionalità dei singoli abitanti e sotto la responsabilità delle singole famiglie.
All’opposto, il gruppo di massimalisti si compone di persone
per lo più giovani, di giovani coppie con figli piccoli, con un appartamento in affitto, o con buona parte del mutuo della casa da
estinguere. Non hanno mai avuto alcun rapporto diretto con l’industria chimica Hooker, e si mostrano estremamente attenti a rintracciare informazioni pertinenti sul caso, mobilitano conoscenze
personali (amici medici, giornalisti ecc.), scavalcano i normali canali istituzionali di informazione e si impegnano a stabilire reti di
relazioni fra i residenti, formando comitati; sono assolutamente favorevoli a un’evacuzione totale, che si pone in termini di scelta cau-
telativa massima, a prescindere dall’esito delle indagini epidemiologiche.
Naturalmente, quando scoppia l’allarme, esso viene recepito in
modo del tutto particolare da chi in quel momento si trova già ammalato, in casa propria oppure degente in ospedale in un reparto oncologico, così come da quelli che vengono colti dalla notizia mentre
si trovano in una struttura di pronto soccorso. Molte delle persone
che si trovano in tali circostante richiedono ai medici che il loro caso venga rivisto completamente da capo, che tutta la loro storia
clinica venga riesaminata dall’inizio. È estremamente interessante
l’analisi del campione dal punto di vista della descrizione dei sintomi. I minimalisti riportano condizioni convenzionali legate all’età:
disturbi cardiaci, calcoli renali, diabete ecc. In realtà più che sintomi riportano diagnosi. I massimalisti, al contrario, sono assai meno
convenzionali e più dettagliati. Riportano disturbi come cefalee, eruzioni cutanee, vomito persistente, nausea, emorragie improvvise e
massicce, ovvero manifestazioni che eludono una chiara diagnosi e
che, per la loro vaghezza e ambiguità, possono allo stesso tempo far
ipotizzare la presenza di una gravissima malattia o di un’affezione
banale. I massimalisti insistono su denunce di singoli casi di leucemia infantile nell’arco di uno o due anni, e mostrano con forza quanto la morte di un solo bambino sia di per sé inaccettabile e imparagonabile al disagio di un’evacuazione di massa. Le rappresentazioni
tendenziali che i due gruppi si sono costruiti rispetto al problema,
così come le loro percezioni del rischio e quindi le strategie di azione e i comportamenti che decidono di attuare nei confronti dei familiari, delle autorità, dei medici, degli altri cittadini ecc., si possono descrivere molto schematicamente nei termini di un calcolo di speranza (già noto a Pascal e Bernoulli). Non si tratta ovviamente di un
«calcolo» in senso stretto, quanto piuttosto di una valutazione, spesso in larga misura inconsapevole, che si produce gradualmente negli
attori sociali e che motiva i comportamenti conseguenti. In sintesi: a
parità di condizioni, i minimalisti tendono a considerare meno accettabile l’evacuazione e la perdita della casa rispetto a una piccola
probabilità di ridurre la propria (già modesta) speranza di vita. I
massimalisti, al contrario, considerano una sola leucemia di un bambino, la cui relazione causale con l’inquinamento può soltanto essere ipotizzata, di per sé sufficiente per compensare tutti gli svantaggi
dell’evacuazione. Il calcolo di speranza è dunque una combinazione
(che si sviluppa nei singoli individui e nei corpi sociali) fra percezio-
146
147
Schema 8
CALCOLO DI SPERANZA
P GRAVITÀ
che l’evento avrebbe per il soggetto
combinazione fra
P PROBABILITÀ che l’evento si verifichi davvero
ne della probabilità che l’evento si verifichi e percezione della gravità
che l’evento avrebbe per il soggetto (v. schema 8).
Questa valutazione configura differenti «ragioni» per le quali gli
atteggiamenti e i comportamenti dei vari gruppi si mostrano a tutti
gli effetti razionali. Si delineano, in altre parole, differenti forme di
razionalità, che sono tali dal punto di vista «emico», ovvero entro
l’orizzonte di ciascun gruppo che considera le proprie scelte come le
più giuste date le circostanze, ma che invece appaiono sempre più o
meno irrazionali dal punto di vista degli altri gruppi: per chi è fortemente determinato a evacuare e accusa le autorità di non aver provveduto con la necessaria urgenza, appare sommamente irrazionale e
incomprensibile l’atteggiamento di chi al contrario si oppone all’evacuazione, ritenendo il caso non grave, ma anzi frutto di un irresponsabile allarmismo. In più vi è la razionalità scientifica degli epidemiologi. Confrontiamo queste differenti ragioni tenendo presente lo
schema 5 di Mary Douglas per il quale la modernità si sviluppa contrapponendo nettamente il pensiero sociale (noi, «primitivi») al pensiero scientifico (noi, «moderni»).
La ragione degli epidemiologi si basa su modelli canonici: a una
popolazione «esposta» viene paragonata una popolazione «non
esposta», per un insieme dato di condizioni patologiche. Il numero
di eventi osservati tra gli esposti (nel caso concreto) viene confrontato al numero degli eventi attesi fra i non esposti (nel caso astratto,
rappresentato dalla cittadina media campione), sulla base di un modello semplificato di relazione causale. Una discrepanza fra osservati e attesi alla luce del modello biologico semplificato può costituire
una prova di relazione causale, ma l’assenza di tale discrepanza non
costituisce prova del contrario (in genere per il basso numero di osservazioni): la razionalità degli epidemiologi è dunque essenzial148
mente analitica, in quanto opera con varibili standard rigorosamente definite e tende a isolare e scomporre fenomeni e processi.
Nella comunità locale la concettualizzazione di ciò che sta accadendo è invece mediata da una complessa rete di fattori culturali, politici, economici, religiosi, nella quale ogni attore sociale è immerso.
Qualche leucemia tra i bambini, oltre che altri malanni o sintomi strani (non usuali, inspiegabili, apparentemente gravi) sono sufficienti a
stabilire una relazione causale con l’esposizione. Come dimostra con
grande efficacia Paolo Vineis, il caso di Love Canal ha messo in luce
l’esistenza di una fondamentale e non trascurabile relazione fra percezione del rischio e caratteristiche generali di sottogruppi della popolazione (età, condizione lavorativa, cultura ecc.). La diversa tendenza ad accettare un rapporto di relazione causale fra esposizione e
malattia, a seconda degli interessi materiali coinvolti e del conseguente calcolo di speranza, fa emergere nel corpo sociale la presenza
di differenti razionalità che sono di tipo essenzialmente olistico. Le stime degli epidemiologi sono basate su misure probabilistiche, mentre
le razionalità locali vengono prodotte dal posizionamento sociale degli individui e dalla loro percezione del rischio (v. schema 9). Queste
forme di razionalità sono irriducibili e fra loro incommesurabili (non
già incomprensibili oppure incomunicabili). Il conflitto fra varie razionalità migliora l’analisi complessiva dei problemi, ed è un motore
per la dinamica sociale (Schwarz, Thompson 1993).
8. La percezione del rischio fra costruzionismi
e realismo critico
Il carattere olistico del pensiero sociale è una delle prerogative antropologiche fondamentali (studiate prima da Evans-Pritchard e poi da
Mary Douglas) dei sistemi nativi di significato invocati per manipolare il senso del male. Anche da noi, non solo fra i «primitivi», la conoscenza è embedded nel tessuto socio-culturale complessivo, storicamente prodotto, della comunità in esame. Anche da noi la «natura»
può assumere valenze ideologiche e politiche, e anche da noi la percezione del rischio è influenzata da molteplici fattori culturali30.
30
Invito a riconsiderare, sotto la prospettiva degli studi di Vineis su Love Canal, ad esempio il caso della percezione del rischio nella comunità giapponese di
Toyako Onsen, che abbiamo esaminato nel capitolo 3. In merito alla frammentazione del corpo sociale lungo i confini variabili di razionalità multiple emiche, è di
149
Schema 9
CALCOLO DI SPERANZA
P GRAVITÀ
che l’evento avrebbe per il soggetto
combinazione fra
P PROBABILITÀ che l’evento si verifichi davvero
A. Minimalisti
B. Massimalisti
C. ...
D. ...
RAZIONALITÀ MULTIPLE (emiche)
olistiche
analitica
=
E. ... + Epidemiologi
Razionalità
scientifica
n. eventi osservati fra gli esposti
n. eventi attesi fra i non esposti
Non è possibile avvalersi di modelli interpretativi del comportamento sociale basati su una nozione oggettivista di razionalità, ovvero a partire dall’ipotesi che gli individui scelgano come comportarsi
sulla base del rapporto costi/benefici, secondo criteri razionalmente
contest-free (il modello della risk analysis). Un’ottima dimostrazione
di questo fatto mi pare quella del cosiddetto «paradosso di Olson»,
che è utile richiamare brevemente (Olson 1983)31.
Immaginiamo una popolazione di «egoisti razionali», ovvero di
individui che agiscono unicamente spinti dal proprio tornaconto. Se
essi unissero i loro sforzi, potrebbero soddisfare un interesse comugrande interesse il caso del conflitto fra Navajo, industrie e autorità locali, sulla riapertura delle miniere di uranio nella vastissima riserva che comprende la zona di
Church Rock, in New Mexico: cfr. V. Simeoni, Terre radioattive e comunità a rischio. Analisi antropologica della contaminazione ambientale da uranio nella riserva
Navajo (regione dei Four Corners, Sudovest americano), tesi di laurea magistrale in
Scienze antropologiche non pubblicata, Università di Venezia Ca’ Foscari, relatore prof. G. Ligi, a.a. 2007-2008.
31 Cfr. Douglas 1990, pp. 49 sgg., e soprattutto l’introduzione di Paolo Giglioli.
150
ne che altrimenti resterebbe insoddisfatto. Secondo Olson, se il
gruppo è sufficientemente ampio, il postulato della razionalità impedirà ai suoi membri di partecipare allo sforzo collettivo, per il fatto che soddisfare un interesse comune significa produrre un bene
pubblico, cioè un bene il cui godimento, per sua stessa natura, è indivisibile e a disposizione di tutti i membri del gruppo, anche di coloro che non hanno contribuito alle sua produzione32. Perché allora
un individuo razionale dovrebbe partecipare allo sforzo comune? Se
tutti gli altri partecipano, il suo contributo non influirà sulla produzione del bene pubblico. D’altra parte perché incorrere nei costi di
produzione del bene quando non si può essere esclusi dal suo godimento? La soluzione più razionale è far agire gli altri e godere gratuitamente i frutti del loro lavoro, assumere cioè il ben noto comportamento da free rider. Però se tutti gli individui sono razionali e
ragionano in questo modo, nessun bene pubblico verrà mai prodotto. E questa è palesemente una conclusione paradossale.
La soluzione al paradosso, su cui molto ha lavorato Mary Douglas, è che «il calcolo mezzi-fini presuppone un corpo di conoscenze sulla base delle quali calcolare, la cui creazione e mantenimento
sono analoghi a quelli di un bene pubblico. [...] È impossibile decidere razionalmente di non prendere parte all’azione collettiva che
permette di costituire, sostenere e tramandare un sistema di conoscenze, perché non si può stabilire il costo prima di aver acquisito le
conoscenze che ci servono per calcolare e decidere. In altri termini,
la possibilità di pensare individualmente riposa su una pre-esistente
conoscenza comune istituzionalizzata» (Giglioli 1990, p. 11). Per
dirla con Durkheim, la reciproca colonizzazione delle nostre menti
è il prezzo che paghiamo per pensare. Pertanto ogni istituzione deve essere radicata in un sistema di credenze che la giustifichino, e il
radicamento di qualsiasi idea o credenza è essenzialmente un processo sociale. Attraverso gli strumenti culturali che deve necessariamente utilizzare, il pensiero individuale è socialmente controllato:
«Ogni società stabilisce i confini tra ciò che è pensabile e ciò che non
lo è» (Douglas 1996, p. 20), esattamente ciò che capita con la percezione del rischio e del pericolo.
32
Si pensi ad esempio a quel lavoratore che si trova oggi un aumento del salario,
senza aver mai partecipato alle lotte sindacali o al movimento operaio; oppure alla
disponibilità di utilizzare l’impianto fognario o la rete viaria di una città anche da parte di chi non ha pagato le tasse necessarie a produrre, nel tempo, questi beni.
151
Se non vi è alcuna decisione esente da rischi in modo garantito,
occorre abbandonare la speranza che si possa passare dal rischio alla sicurezza esclusivamente aumentando la ricerca e il sapere scientifico, così come la speranza che si possano prevenire dei disastri, o
mitigare i danni post-impatto, migliorando esclusivamente i dispositivi tecnici di controllo. L’esperienza pratica insegna piuttosto il contrario: quanto più si sa, tanto più si sa che non si sa e tanto più si forma una consapevolezza del rischio. Quanto più complessa diventa la
costruzione del calcolo, tante più sfaccettature si scoprono, in riferimento alle quali c’è incertezza sul futuro e quindi rischio. Occorre
allora correggere in modo sostanziale la precedente definizione di rischio (4): il rischio (R) non è dato dalla relazione fra il danno (D) associato a un evento e le probabilità (P) che l’evento ha di verificarsi,
ma è dato dalla relazione fra la percezione della gravità del danno (Pd)
associato a un evento (che perciò si può definire «evento pericoloso»), e la percezione della probabilità (Ppr) che l’evento ha di verificarsi (v. schema 10):
Schema 10
R=
D
Pr
R=
Pd
Ppr
COSTRUZIONE
SOCIO-CULTURALE
La determinazione complessiva del rischio si attua dunque attraverso due fasi:
a) la determinazione della percezione sociale che un dato evento
costituisca un pericolo;
b) la determinazione della percezione sociale delle probabilità che
quel dato evento pericoloso si verifichi davvero.
I punti a) e b) sono variabili trans-culturali e si prestano a un’analisi eminentemente antropologica. Possono determinarsi cioè molteplici percezioni sociali differenti del fatto che un dato evento sia effettivamente pericoloso e delle probabilità che esso si verifichi. Queste razionalità multiple danno luogo a scelte che orientano comportamenti concreti di accettazione o non accettazione del rischio, di ac152
cettazione o non accettazione di interventi concreti, di progetti di
sviluppo economico-sociale, di aiuto esterno nelle emergenze di
massa ecc., e dunque sono fattori essenziali per valutare la vulnerabilità sociale di una comunità, in rapporto a quella fisica e al tipo di
evento disastroso considerato.
Per il paradigma realista (quello della risk analysis) il rischio è oggettivo e quantificabile. La sua entità si puà misurare in termini statistici non ambigui. Gli assiomi di base sono: il rischio (la percentuale
di rischio e la sua accettabilità) è conoscibile e quantificabile dalle
scienze naturali; il rischio può essere ridotto utilizzando apposite strategie di prevenzione e intervento derivate dall’ingegneria (approccio
tecnocentrico); gli «esperti» possiedono la conoscenza corretta necessaria e sufficiente per gestire queste variabili. Se la popolazione (o
sottogruppi sociali di essa) ha una differente percezione del rischio è
perché non è abbastanza preparata o informata, si trova vittima di una
visione distorta, errata e irrazionale. Debora Lupton ha espresso con
grande chiarezza questa posizione teorica:
Le discussioni sul rischio di queste discipline tecnico-scientifiche tendono a ruotare intorno ai seguenti problemi: con quanta precisione un rischio sia stato identificato e calcolato; quanto un rischio sia grave dal
punto di vista dei suoi possibili effetti; quanto accurata sia la scienza utilizzata per misurare e stimare il rischio in questione; e quanto soddisfacenti siano i modelli causali e predittivi costruiti per comprendere perché
i rischi si producano e le persone reagiscano ad essi in certi modi (Lupton 2003, p. 94).
Per il paradigma costruzionista (le teorie socio-culturali del rischio) la definizione di rischio dipende invece da fattori completamente soggettivi dei singoli e dei gruppi sociali che si trovano a confrontarsi con esso. Il rischio è esclusivamente un prodotto mentale,
una modalità di categorizzare gli eventi, dipendente unicamente dai
processi di mediazione socio-culturale che l’hanno generata. Secondo questo approccio, la costruzione è radicale: non esistono rischi in
sé, esistono solo convenzioni sociali su cosa sia un rischio o cosa non
lo sia. Mediante sofisticati processi istituzionlizzati, le nostre percezioni e rappresentazioni individuali sono inevitabilmente plasmate
dalle regole sociali da cui siamo agiti.
Il fenomeno che in un contesto storico o culturale particolare appare
come un pericolo o un hazard può non essere considerato tale in un con153
testo diverso, e nel nostro ragionare sui saperi e le interpretazioni del rischio ne dovremmo tenere conto [...] la serie di oggetti che un modello di
attribuzione causale può legare al danno è potenzialmente illimitata: qualunque realtà può essere definita come rischiosa (Lupton 2003, pp. 36-37).
Il passaggio da una visione realista a una costruzionista trasforma
radicalmente lo stuto epistemologico del concetto di rischio. Per il
realismo non esiste una chiara distinzione fra rischio e pericolo. Tutta l’analisi si muove sul piano della realtà materiale e delle conseguenze concrete dei danni che si potrebbero evitare, il rischio è un
problema tecnico (approccio classico della modernità): è la dimensione tecnocentrica del risk management (autoreferenziale, improntato al principio di gestione razionalista del rischio).
Per il costruzionismo, al contrario, il termine rischio definisce
una percezione soggettiva, una rappresentazione sociale diffusa (fenomeno di studio per gli antropologi). Se da un lato (realismo) si
parla di un oggetto naturale, dall’altro (costruzionismo) si parla di
un oggetto sociale. Analogamente a quanto abbiamo visto per la definizione di disastro in rapporto alle due impostazioni, tecnocentrica e socio-antropologica, le strategie di controllo e gestione del rischio non si riducono più a un fatto esclusivamente tecnico, ma diventano un negoziato sociale.
A questo punto delineiamo la posizione di Mary Douglas, per così dire intermedia, ma probabilmente più efficace delle altre due
(realismo e costruzionismo), che possiamo definire realismo critico,
o anche costruzionismo debole. Scrive Douglas:
biamo è sempre mediata da processi sociali e culturali (Lupton 2003, p.
46, corsivo mio).
Il concetto di sicurezza non si riferisce a un dato completamente
oggettivo, ma vi è sempre una componente di finzione sociale (costruzione per l’incompletezza). Si può studiare che cosa viene consensualmente trattato come sicuro nella comunicazione sociale e
quanto queste finzioni siano stabili in caso di esperienze contrarie
(how safe is safe enough?)33. Se non c’è nessuna decisione esente da
rischi in modo garantito, occorre abbandonare la speranza che si
possa passare dal rischio alla sicurezza aumentando la ricerca e il sapere. L’incompletezza è ineliminabile.
Il problema della definizione sociale dei criteri di accettabilità dei
rischi determina quindi direttamente la vulnerabilità di un sistema
sociale rispetto a certi tipi di disastro. Come dimostrano le ricerche
di Paolo Vineis, questo problema è il più complesso fra quelli con-
Ciò che le società farebbero è solo selezionare alcuni pericoli come degni di particolare attenzione. Sono i pericoli che, per ragioni interne alla
loro cultura e dati i loro valori e interessi, esse definiscono «rischi». Il rischio, cioè, non sarebbe che l’interpretazione e la risposta socialmente costruita a un pericolo reale e oggettivo, anche se la conoscenza che ne ab-
33 Negli anni Ottanta Mary Douglas ha elaborato un modello schematico – noto come «modello griglia/gruppo» (o «modello Wildavsky-Douglas») – che tenta
di descrivere le caratteristiche di alcune forme di razionalità, o «cosmologie» (4 per
la precisione), a partire dal posizionamento sociale delle persone, definito dall’incrocio di due coordinate (le variabili da mappare): ovvero la quantità di comportamenti rigidamente prescritti e istituzionalizzati, e l’intensità della forza dei legami di gruppo (o del senso di identità individuale). Ciscuna razionalità che scaturisce dal modello (razionalità procedurale o gerarchica, autosufficiente, fatalista e critica) produce a sua volta un ben preciso «mito» della natura: una rappresentazione della fragilità o della resistenza degli ecosistemi rispetto alle azioni di intervento
antropico (questi 4 miti della natura – che può essere benigna, capricciosa, perversa-tollerante, oppure effimera – vengono in genere raffigurati con una pallina posta in 4 differenti posizioni nell’arco di una parabola). Questa schematizzazione,
pur avendo il merito di mostrare un indispensabile tentativo di connessione fra precise variabili sociali e rappresentazioni del mondo, risulta, a mio avviso, non solo
irrimediabilmente invecchiata rispetto a studi più recenti, ma soprattutto eccessivamente rigida e riduzionista. Ha scarsa o nulla applicabilità in contesti etnografici, riduce la complessità sociale a due sole variabili e non tiene conto del mutamento
su almeno due fronti principali: la modificazione nel tempo di ciascuna forma di
razionalità, pur restando nel «quadrante» in cui è posizionata, e la modificazione
nel tempo dell’atteggiamento individuale, giacché un attore sociale può benissimo
passare nel corso della propria vita da un «quadrante» a un altro, e quindi modificare la propria concezione della natura e dei comportamenti più razionali da tenere in caso di pericolo. Il modello «griglia/gruppo» è presentato in diverse formulazioni, si vedano ad esempio quelle contenute nei seguenti riferimenti: Douglas
1996, pp. 63-98 e 147-168; Lupton 2003, pp. 56-63; Marinelli 1993, pp. 106-115;
Schwarz, Thompson 1993, pp. 40-63. Per una revisione fortemente critica si veda
ad esempio l’articolo dell’antropologa svedese Åsa Boholm (1996).
154
155
Si noti che il problema non verte sulla realtà dei pericoli. In entrambi i casi, mondo moderno e mondo premoderno [i «primitivi» dello schema 6, gli «altri» dello schema 7], i pericoli sono orribilmente reali. Questo discorso non riguarda la realtà dei pericoli, ma come essi vengano ad
assumere un significato politico, e questo è un punto che non potrà mai
essere sottolineato abbastanza (Douglas 1996, p. 120).
E Lupton chiarisce:
seguiti alla crisi del modello causale classico (epistemologia realista):
in esso si incrociano questioni scientifiche con questioni di natura
decisionale, politica ed etica perché in tutte le società, siano esse
«primitive» oppure «moderne» (distinzione che dunque perde di significato), gli individui trasferiscono sempre gli aspetti più importanti del loro processo decisionale alle istituzioni in cui vivono.
«In ogni luogo e in ogni tempo l’universo viene interpretato in
termini di etica e di politica» (Douglas 1996, p. 15): fra i «primitivi»
come da noi, all’interno di qualunque tipo di organizzazione ogni disgrazia (o disastro) di una certa gravità suscita sempre una serie di
interrogativi sulle responsabilità. Questi interrogativi non sono mai
posti a caso. «Tanto più credibili sembreranno le risposte, quanto
più rafforzeranno le preoccupazioni dei membri per l’organizzazione in cui vivono» (Douglas 1996, p. 68). Anche nelle nostre società
complesse riaffiora il profondo legame fra rischio e istituzioni. I disastri (naturali o tecnologici) si intrecciano con la micropolitica delle
istituzioni. I processi di attribuzione di colpa rafforzano il modello
dell’organizzazione e ne sono effettivamente parte integrante. Come
ha sostenuto Mary Douglas, le cosiddette società premoderne hanno convissuto per secoli con una concezione fortemente politicizzata della natura, dominata dal fato e da entità soprannaturali. Lo sviluppo della scienza ha consentito invece alla società moderna l’assunzione di una posizione di osservazione privilegiata secondo cui la
natura è moralmente neutrale. Ma la rinuncia a invocare un nesso
d’imputazione fra disastri naturali e peccati umani non comporta
un’automatica fissazione di criteri scientifici oggettivi per identificare e trattare i rischi. La percezione del rischio e la valutazione dei
«fatti» sono processi legittimati da pratiche sociali e pertanto posseggono una loro razionalità anche quando contrastano con le valutazioni tecniche.
Qual è dunque la caratteristica fondamentale dell’approccio antropologico al rischio? L’antropologia del rischio tende a mettere in
evidenza e a criticare il fatto che spesso la ragione tecnocentrica è insensibile alle ragioni degli ambienti socio-culturali degli individui,
perché tende a osservare un fenomeno in astratto, non immerso in
un preciso contesto socio-culturale. Lo sguardo antropologico consiste precisamente in questa opera di immersione. Gli sviluppi di
prospettive socio-antropologiche nello studio del rischio hanno consentito la transizione da un’accettabilità definitiva dei rischi sulla ba156
se di criteri puramente statistici a un’idea di accettabilità basata sulla percezione (Vineis 1990). Ai fini dello studio del rapporto rischibenefici – essenziale per stabilire la vulnerabilità sociale di una comunità di fronte a un grave pericolo – l’approccio antropologico
consente di arrivare: a) a un’idea meno ingenua e più interattiva degli atteggiamenti della comunità; b) al riconoscimento degli aspetti
culturali e non solo scientifici degli episodi di esposizione al rischio;
c) a una visione smaliziata verso i progetti di modellizzazione matematica rigida nel controllo dei rischi.
Rispetto alla risk analysis, ma anche rispetto alla più convenzionale sociologia del rischio, l’importanza e la specificità antropologica per lo studio del rischio consistono nella lunga tradizione di ricerche che solo l’antropologia può vantare in merito a differenti forme di razionalità, entro orizzonti locali di senso, rispetto a problemi
interpretativi complessi legati alla comprensione dei sistemi nativi di
significato (l’antropolgia come disciplina scientifica si costruisce
esattamente su questi problemi); e consistono anche nell’aver sviluppato un metodo di analisi originale come l’osservazione partecipante, che, basandosi su una lunga permanenza nella comunità, su
interviste e colloqui profondi, sulla condivisione progressiva delle
esperienze e delle pratiche sociali locali, risulta essere l’unico veramente efficace per incorporare nell’analisi tutto il peso storico-culturale che il contesto ha nel modellare la percezione del rischio.
Epilogo
Nemici svelati?
Al termine di questo percorso, nel quale abbiamo cercato di descrivere come si possono concettualizzare gli aspetti socio-culturali di
un disastro, e di conseguenza da quali punti di vista una disciplina
come l’antropologia può contribuire all’analisi dei fenomeni estremi
e dei contesti di emergenza di massa, ci troviamo di fronte alla doverosa constatazione che il nemico svelato, il nemico non più «invisibile» (per riprendere la definizione dell’inquinamento radioattivo per i pastori saami), non è purtroppo ancora il nemico battuto.
Anche se il primo passo per batterlo, forse il passo più importante,
è comprenderne le caratteristiche, la fisionomia, la storia e l’identità,
i punti deboli: una prima essenziale operazione di consapevolezza
critica.
Come più volte abbiamo mostrato nel corso del libro, i nostri nemici invisibili non sono tanto la radioattività o l’impercettibilità sensoriale di molti agenti chimici inquinanti, ma sono costituiti da quei
fenomeni socio-culturali che ancora non conosciamo a fondo, dalle
modalità talvolta errate o incomplete con le quali costruiamo le nozioni di pericolo e di disastro, dalle variabili essenziali che ancora
tendiamo a trascurare. Per quanto riguarda lo studio degli eventi
estremi, i nostri meccanismi di produzione di conoscenza su quegli
stessi eventi possono diventare, se non proprio una fonte di pericolo, per lo meno una fonte di rischio. Questo libro non ha quindi la
pretesa di battere il nemico, ma almeno quella di contribuire a svelarlo, orientando la propria analisi su zone lasciate in ombra da altri
tipi di analisi, e tentando di problematizzare concetti e fenomeni
troppo affrettatamente assunti come scontati o autoevidenti.
1) Il primo problema è quello del concetto di disastro. Abbiamo
sottolineato a più riprese la necessità di elaborare una definizione di
disastro che da un lato tenga conto della particolare prospettiva an158
tropologica che si vuole adottare, e dall’altro concettualizzi alcune
caratteristiche dell’evento critico generando una sorta di tipologia,
che può essere basata: sugli aspetti morfologici (come si manifesta
l’evento, qual è la tempistica d’impatto – disastri lenti e silenziosi,
oppure disastri repentini e deflagranti); sul tipo di danni prodotti;
sulle caratteristiche specifiche delle fasi in cui lo si potrebbe scomporre (prima/durante/dopo l’impatto con l’agente distruttivo); sulle cause scatenanti (disastri man-made o disastri natural; tenendo
conto della parziale inadeguatezza di questa dicotomia, come illustrato ad esempio dalla tesi dell’Antropocene di Crutzen).
2) Un altro tema affiorato più volte nei paragrafi precedenti è
quello dei saperi locali e del loro rapporto con le logiche istituzionali. Si tratta di studiare i nessi fisici, materiali, simbolici e valoriali
che una comunità umana stabilisce con il proprio ambiente secondo
lo schema 11:
Schema 11
TECNOLOGIA
SOCIETÀ
DISASTRO
AMBIENTE
TECNOLOGIA
A seconda del tipo di evento critico, una comunità può disporre
di categorie concettuali adeguate per affrontarlo (ad esempio gli isolani delle Andamane per i frequenti maremoti); oppure al contrario
può rimanere completamente disorientata (ad esempio i Saami di
fronte alla radioattività). Entro questo ambito problematico – e cioè
di come i sistemi nativi di significato si attivino per comprendere il
disastro – possiamo evidenziare dei temi più specifici di grande rilevanza: invisibilità percettiva/cognitiva e stili cognitivi; stili cognitivi
e ruolo delle pratiche sociali; saperi ecologici nativi e concetti di «natura» – natura «buona»/«cattiva» –; cosmologie e credenze, processi di attribuzione di colpa e influenza del credo religioso diffuso con
la colonizzazione; concetti nativi di disastro (fine cosmica, apocalissi ecc.); concetti nativi di morte, e in generale dispositivi simbolici
159
per dare senso al male (teorie native della causalità, stregoneria, nessi fra pericolo/colpa/peccato).
3) Un terzo punto è costituito dal problema di studiare il rapporto fra teorie native su quanto è accaduto e teorie fisiche ufficiali,
vale a dire in che rapporto sta la razionalità sociale – soggettiva, parziale, culturalmente costruita e basata su percezioni – con la razionalità scientifica, che si vorrebbe oggettiva, asettica, neutrale e basata su numeri. L’ambito di analisi della razionalità sociale comprende fra gli altri i seguenti temi: conflitto fra minimalisti e massimalisti, dispute sui dati e gli effetti del disastro, uso politico del pericolo; strategie di cover-up delle informazioni (ad esempio quello messo in atto dalle autorità nel caso di Černobyl’: anche, ma non solo,
mediante la delimitazione e restrizione ufficiale della zona dell’incidente come zona «not for press»); gestione istituzionale dell’emergenza; ruolo svolto dai mass media nella circolazione delle informazioni e nella costruzione di un’immagine dell’evento. Nell’ambito
dell’analisi della razionalità scientifica vi è il problema della crisi della visione deterministica della scienza, della fiducia cieca nelle procedure, della svolta impressa dalla logica probabilistica, e degli effetti sul contesto locale del tipo di sapere scientifico che viene esportato, ad esempio, nei progetti di cooperazione allo sviluppo.
4) I punti 2 e 3 sono essenziali per studiare le dinamiche dei provvedimenti concreti nella gestione delle emergenze di massa.
5) Questo punto riguarda l’importanza dell’analisi storica e socio-economica del contesto in cui è avvenuto il disastro per comprendere l’influenza di tutti i fattori culturali illustrati nei punti 1, 2,
3, 4: a) sulla percezione socialmente differenziata del rischio; b) sulle condizioni fisiche e sociali di vulnerabilità; c) sulle operazioni di
coping (dall’evacuazione al sostegno etnopsichiatrico nei casi di sindromi da stress post-traumatico).
Infine, abbiamo messo in evidenza a più riprese nel corso del volume come i gruppi sociali coinvolti in qualche genere di disastro
possano assumere atteggiamenti orientati da una sorta di «ottundimento» oppure da una sorta di «lungimiranza». In molti contesti socio-culturali il nesso uomo-luogo dà origine al cosiddetto paradosso
delle catastrofi che genera una forma di razionalità cognitiva per la
quale la percezione del rischio è in stretto rapporto con il rifiuto di
abbandonare il proprio luogo natio. Fra il rischio di incorrere in una
catastrofe e il rischio della de-culturazione avviata da un processo di
trasferimento in altre zone, alcuni gruppi sociali scelgono il primo
piuttosto che il secondo. Questa tendenza ad assumere un atteggiamento «ottuso», ovvero apparentemente contrario alla razionalità
tecnocentrica ufficiale, non è sempre presente e diffuso ovunque. In
altri contesti socio-culturali la percezione locale del rischio è invece
frammentata, variegata, molteplice (come ad esempio nel caso della
comunità di Love Canal). Alcuni gruppi possono adottare un atteggiamento «lungimirante» e perfettamente razionale, addirittura più
razionale e previdente della stessa razionalità tecnocentrica (come ad
esempio nel caso degli insediamenti andamanesi nel Golfo del Bengala).
Le opposte tendenze all’«ottundimento» e alla «lungimiranza»
possono caratterizzare società differenti, anche geograficamente
molto lontane fra loro, oppure possono comparire in momenti diversi nell’arco della storia di una medesima società. E naturalmente
una comunità, o un gruppo sociale, che manifesti un marcato atteggiamento lungimirante (alta percezione del rischio) rispetto a un determinato pericolo può allo stesso tempo mostrarsi «ottusa» (bassa
percezione del rischio) nei confronti di un altro genere di pericolo.
Le ricerche antropologiche ed etnografiche lungo le direzioni che
nei vari capitoli abbiamo indicato sono ancora in gran parte tutte da
fare. Quindi molti esempi concreti e studi di caso – da affrontare in
futuro – potranno illustrare meglio l’efficacia o l’inadeguatezza di
metodi d’indagine e strategie di analisi, e potranno maggiormente
chiarire alcuni rilevanti nessi teorici, se non evidenziarne di nuovi.
Ribadire molto chiaramente il rapporto fra approccio tecnocentrico e approccio socio-antropologico, nei termini di un’efficace integrazione piuttosto che in quelli di una sterile e desueta opposizione, resta a mio avviso essenziale. Da un certo punto di vista è lo stesso vecchio problema del rapporto fra «natura» e «cultura». Amalia
Signorelli, parlando di catastrofi, ha affermato:
160
161
Una città vittima di un terremoto può darsi che rappresenti ciò che
c’è di più tragico e di più manifesto nella forma particolare di opposizione e di interdipendenza tra natura e cultura. [...] La catastrofe rende l’opposizione radicale: la loro dialettica, la mediazione tra natura e cultura,
sembra impossibile, e allo stesso tempo mai le si è percepite così drammaticamente necessarie. Può darsi che stia qui, in questa tragica contraddizione, l’essenza stessa della catastrofe (Signorelli 1992, p. 149)1.
1
Cit. in E. Marcorè, Abitare a Nocera Umbra dopo il terremoto del 1997, tesi di
Ma come sappiamo la dicotomia natura/cultura è essa stessa una
costruzione sociale variabile, culturalmente e storicamente prodotta, e contemporaneamente «naturalizzata», assunta come dato di
realtà. Un atteggiamento attento a non indulgere verso impostazioni iperculturalizzanti che sminuiscano o smaterializzino del tutto
l’importanza dei fenomeni fisici concreti (che nei disastri, come abbiamo visto, sono centrali) non deve cadere nell’errore opposto di
abbandonarsi alla rischiosa convinzione che la sola modellistica tecnocentrica e quantitativista possa catturare e rappresentare la complessità dei fenomeni. Per questo la linea del realismo critico (etichetta che preferisco rispetto a quella di costruzionismo debole), suggerita da Mary Douglas, mi sembra un atteggiamento teorico alquanto promettente. In merito all’integrazione fra saperi Luciano
Gallino ha sviluppato considerazioni estremamente stimolanti. Egli
utilizza il concetto di ignoranza soprattuto rispetto a ciò che la scienza non sa, in particolare riguardo agli effetti concreti delle applicazioni tecnologiche. L’ignoranza tecnico-scientifica, che Gallino propone di chiamare per brevità tecno-ignoranza, designa non ciò che il
grande pubblico ignora in merito alla tecnologia e alla scienza ma, al
contrario, ciò che gli addetti ai lavori (ricercatori, scienziati, tecnici,
esperti) per primi non sanno, al meglio delle loro collettive conoscenze professionali. Questo genere di ignoranza abbraccia tanto il
passato – il caso in cui quel che non si conosce è già accaduto – quanto il futuro: in questo caso quel che non si conosce deve ancora accadere.
Gallino fa osservare che la partecipazione democratica alla valutazione della tecnologia non si traduce semplicemente in un miglioramento delle comunicazione al pubblico dei risultati delle ricerche
svolte dagli esperti.
comprende l’utilità e le conseguenze, gli esperti e i politici debbono sobbarcarsi l’onere di comunicare a esso con maggior chiarezza i termini reali della questione.
Per contro l’approccio partecipativo si fonda sul presupposto che il
pubblico, qualora gli sia dato modo di discutere ed esprimersi in forme e
luoghi appropriati, sia atto a orientare gli esperti verso ciò che non sanno
– l’area della tecno-ignoranza specifica – o non sanno nemmeno di non
sapere – la tecno-ignoranza a-specifica. In tal modo la partecipazione
contribuisce ad arricchire, complessificare e rendere cognitivamente più
robusta la valutazione, conforme a quanto indicato sopra, oltre che socialmente legittimata (Gallino 2007, p. 27, corsivi miei).
Nell’epoca attuale – che Beck definisce della post-modernità
(2001) – alle dinamiche e ai conflitti sociali di una società «distributrice di ricchezza» si intrecciano i problemi e le paure di una società
«distributrice di rischio». Con una fondamentale differenza però:
che nei molteplici tentativi utopistici o ideologici di creare il migliore dei mondi possibili, la ricchezza è stata sempre distribuita in modo fortemente diseguale. Il rischio al contrario sta diventando l’unico «bene» sociale che viene distribuito a ognuno in modo effettivamente democratico:
prima o poi i rischi della modernizzazione colpiscono anche chi li produce o trae profitto da essi. Contengono un effetto boomerang che fa saltare lo schema di classe e la dimensione nazionale. I disastri ecologici e le
radiazioni atomiche ignorano i confini delle nazioni. [...] Le ricchezze si
possono possedere, dai rischi si può solo essere colpiti; essi ci vengono,
per così dire, ascritti dalla civiltà (Beck 2001, pp. 30-31).
laurea non pubblicata, Università di Roma La Sapienza, relatore prof. A. Sobrero,
correlatore prof. A. Simonicca, a.a. 2004-2005, p. 34.
Qui si innesta la riflessione di Hans Jonas sull’esigenza delle cosiddette nuove etiche. La tecnologia contemporanea, come capacità
di agire sul mondo, ha conferito agli esseri umani un potere di manipolazione della realtà i cui limiti essi stessi ignorano. Questo tipo
di tecnologia, per certi versi senz’altro irrinunciabile e benefica, produce tuttavia degli effetti collaterali (ad esempio nel caso dei disastri) la cui portata su scala spaziale (estensione geografica del danno
a partire dal luogo del disastro) e su scala temporale (estensione del
danno nel futuro, fra le generazioni, a partire dal momento del disastro) sono in larga misura imprevedibili e incontrollabili. Per Jonas
risulta allora indispensabile passare da un’etica situazionale, «del qui
e ora», entro cui si inquadrava ad esempio la vita delle società pre-
162
163
L’approccio comunicativo si fonda sul presupposto che gli unici depositari del sapere utilizzabile per valutare una tecnologia siano gli esperti (tecnici, accademici, ricercatori, scienziati ecc.) o i politici (i responsabili del policymaking tecnologico) da essi informati. Dato che il pubblico è considerato per definizione ignorante, non sotto il profilo epistemologico bensì nel senso ordinario del termine, e motivato da tale ignoranza può opporre resistenza alla diffusione di una tecnologia perché non ne
industriali o di interesse etnografico, a un’«etica della responsabilità» che dovrebbe guidare le scelte nella società contemporanea globalizzata (Jonas 1990).
La scrittrice ucraina Svetlana Aleksievic nel libro Preghiera per
Černobyl’, in cui ha raccolto le testimonianze dei sopravvissuti a
quell’evento epocale, ribadisce con una grande densità etnografica
l’importanza del tema di Jonas:
A interessarmi [erano] le impressioni, i sentimenti delle persone che
hanno toccato con mano l’ignoto. Il mistero. Černobyl’ è un enigma che
dobbiamo ancora decifrare. È forse un compito per il XXI secolo. [...]
Per tre anni ho viaggiato e fatto domande: a dipendenti della centrale,
scienziati, ex funzionari di partito, medici, soldati, a donne e uomini che
hanno dovuto abbandonare le loro case, a donne e uomini che continuano a vivere nella zona proibita. [...] Černobyl’ è il principale contenuto
del loro mondo. Ha avvelenato ogni cosa che hanno dentro, e anche attorno, e non solo la terra e l’acqua. Tutto il loro tempo. [...] Queste donne e questi uomini sono stati i primi [...] a vedere ciò che noi possiamo
solo supporre. Ciò che rimane comunque un mistero per tutti. [...] Più di
una volta ho avuto l’impressione che in realtà io stessi annotando il futuro (Aleksievic 2002, p. 8).
In questo difficile compito di annotare il futuro, definendo i principi di una nuova etica della responsabilità, penso che anche una disciplina come l’antropologia culturale abbia qualcosa di significativo da dire.
Riferimenti bibliografici
Aleksievic S. 2002, Preghiera per Černobyl’. Cronaca del futuro, Edizioni
e/o, Roma (ed. or. Černobil’skaja molitva, Ostošje, Moskva 1997).
Alexander D. 1991a, Natural disasters: a framework for research and teaching, in «Disasters», n. 3, pp. 209-227.
Alexander D. 1991b, Calamità naturali e rischi associati: sviluppo del campo nel mondo anglofono e valutazione del suo potenziale scientifico, in
Botta 1991, pp. 107-122.
Alexander D. 1993, Il tempo e lo spazio nello studio dei disastri, in Botta
1993, pp. 23-40.
Alexander D. 1997, The study of natural disasters, 1977-1997: some reflections on a changing field of knowledge, in «Disasters», n. 21 (4), pp. 284304.
Alexander D. 2000, Confronting Catastrophe, Oxford University Press,
Oxford.
Almagià R. 1907, Studi geografici sulle frane in Italia, in «Memorie della
Società Geografica Italiana», vol. XIII.
Almagià R. 1910, Studi geografici sulle frane in Italia, in «Memorie della
Società Geografica Italiana», vol. XIV.
Angioni G. 1986, Il sapere della mano, Sellerio, Palermo.
Appadurai A. 2001, Modernità in polvere, Meltemi, Roma (ed. or. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, University of
Minnesota Press, Minneapolis-London 1996).
Appadurai A. 2005, Sicuri da morire, Meltemi, Roma.
Århen I. 1994, Det samiska rummet, in «Årjel-sæmiek», n. 3, pp. 117-122.
Arnol’d V.I. 1990, Teoria delle catastrofi, Bollati Boringhieri, Torino (ed.
or. Teorija Katastrof, Znanie, Moskva 1981).
Augé M., Herzlich C. 1986, Il senso del male, il Saggiatore, Milano (ed.
or. Le sens du mal, editions des archives contemporaines, Paris 1984).
Augendre M. 2004, Le risque naturel devenu symbiose? Les volcans actifs
d’Hokkaido, Japon, in «Géomorphologie: rélief, processus, environment», n. 2, pp. 101-116.
165
Axia V. 2006, Emergenza e psicologia. Mente umana, pericolo e sopravvivenza, il Mulino, Bologna.
Bachelard G. 1975, La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari (ed. or.
La poétique de l’espace, Presses Universitaires de France, Paris 1957).
Baker G., Chapman D.W. 1962, Man and Society in Disaster, Basic Books,
New York.
Bankoff G. 2001, Rendering the world unsafe: «vulnerability» as Western
discourse, in «Disasters», n. 25, pp. 19-35.
Bankoff G. 2003, Cultures of Disasters. Society and Natural Hazard in the
Philippines, Routledge, London.
Bankoff G., Frerks G., Hilhorst D. (a cura di) 2004, Mapping Vulnerability. Disasters, Development and People, Earthscan, London.
Barillari S. (a cura di) 2007, Catastrofi. I disastri naturali raccontati dai
grandi reporter, minimum fax, Roma.
Barkun M. 1974, Disaster and the Millenium, Yale University Press, New
Haven.
Barkun M. 1977, Disaster in history, in «Mass Emergencies», n. 2 (4), pp.
219-231.
Barnard A. 2002, Storia del pensiero antropologico, il Mulino, Bologna
(ed. or. History and Theory in Anthropology, Cambridge University
Press, Cambridge 2000).
Barthes R. 1974, Parigi è stata inondata, Einaudi, Torino (ed. or. Mythologies, Seuil, Paris 1957).
Barthes R. 2002, L’ultimo degli scrittori felici, in Id., Saggi critici, Einaudi, Torino, pp. 82-90 (ed. or. Essais critiques, Seuil, Paris 1964, la Prefazione a cui mi riferisco è stata pubblicata nel 1958).
Barton A.H. 1969, Communities in Disaster. A Sociological Analysis of
Collective Stress Situations, Doubleday, Garden City, N.Y.
Bauman Z. 1999, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna.
Beck U. 1995, Ecological Enlightenment. Essays on the Politics of the Risk Society, trad. dal tedesco di M.A. Ritter, Humanities Press, Atlantic
Highlands (ed. or. Politik in der Risikogesellschaft. Essays und Analysen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991).
Beck U. 2001, La società del rischio. Verso una nuova modernità, Carocci, Roma (ed. or. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986).
Bell F.G. 2005, Geologia ambientale. Teoria e pratica, Zanichelli, Milano
(ed. or. Environmental Geology. Principles and Practice, Blackwell,
Oxford 1998).
Beneduce R., Rudinesco E. (a cura di) 2005, Antropologia della cura, Bollati Boringhieri, Torino.
Berger P.L., Luckmann T. 1966, The Social Construction of Reality, Doubleday, Garden City, N.Y.
Bernardi U. 2004, Per una valutazione globale dell’ambiente, in Regione
Veneto, Carta di Asiago, Giunta Regionale, Venezia, pp. 13-21.
Berque A. 1976, Le Japon, gestion de l’espace et changement social, Flammarion, Paris.
Bettin G. 2004, Il clima fuori dai gangheri, Nottetempo, Roma.
Bianchi E. 1987, Comportamento e percezione dello spazio ambientale.
Dalla behavioral revolution al paradigma umanistico, in G. Corna Pellegrini (a cura di), Aspetti e problemi della geografia, Marzorati, Settimo Milanese, vol. I, pp. 543-598.
Bianchi E. 1992, La soggettività ambientale in geografia. Tradizione o innovazione?, in G. Corna Pellegrini, E. Bianchi (a cura di), Varietà delle geografie, Cisalpino, Milano, pp. 71-86.
Bianchi E. 1993a, Uomo, rischio, natura: considerazioni intorno allo stato
presente della ricerca, in Botta 1993, pp. 241-260.
Bianchi E. 1993b, How safe is safe enough, introduzione a Schwarz,
Thompson 1993, pp. 11-36.
Boccali G., Milanetti G. 1997, Bene e male nell’induismo, in Raveri 1997,
pp. 93-117.
Boholm Å. 1996, Risk perception and social anthropology: critique of cultural theory, in «Ethnos», n. 61, pp. 64-84.
Boschi E., Bordieri F. 1998, Terremoti d’Italia. Il rischio sismico, l’allarme degli scienziati, l’indifferenza del potere, Baldini & Castoldi, Milano.
Botta G. 1987, Calamità naturali e studi geografici, in G. Corna Pellegrini (a cura di), Aspetti e problemi della geografia, Marzorati, Settimo Milanese, vol. I, pp. 679-723.
Botta G. (a cura di) 1991, Prodigi, paure, ragione. Eventi naturali oggi,
Guerini, Milano.
Botta G. (a cura di) 1993, Eventi naturali oggi. La geografia e le altre discipline, Cisalpino, Milano.
Bourdieu P. 1992, Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino (ed. or. Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Seuil,
Paris 1992).
Burton I., Kates R.W., White G.F. 1978, The Environment as Hazard,
Oxford University Press, New York.
Calame C., Kilani M. et al. (a cura di) 1999, La fabrication de l’humaine
dans les cultures et en anthropologie, Peyote, Lausanne.
Camus A. 1989, La peste, Bompiani, Milano (ed. or. La peste, Gallimard,
Paris 1947).
Caplan P. (a cura di) 2000, Risk Revisited, Pluto Press, London.
Castel R. 2004, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Einaudi, Torino (L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé?, Seuil, Paris
2003).
166
167
Castelli C., Sbattella F. 2003, Psicologia dei disastri. Interventi relazionali
in contesti di emergenza, Carocci, Roma.
Centemeri L. 2006, Ritorno a Seveso. Il danno ambientale, il suo riconoscimento, la sua riparazione, Bruno Mondadori, Milano.
Cheng Y., Kam-ling T., Chen F. (a cura di) 1988, The Great Tangshan
Earthquake of 1976. An Anatomy of Disaster, Pergamon, Oxford.
Chohan T.R. et al. 1994, Bhopal, the Inside Story, Aspex Press, New
York.
Cieraad I. 1999, At Home. An Anthropology of Domestic Space, Syracuse
University Press, Syracuse, N.Y.
Cirese A.M. 1966, L’antropologia culturale e lo studio delle tradizioni popolari intese come dislivelli interni delle società superiori, in «De Homine», n. 17, pp. 239-247.
Cirese A.M. 1971, Cultura egemonica e culture subalterne, Palumbo, Palermo.
Cohen A. 1985, The Symbolic Construction of Community, Routledge,
London.
Cohn N. 1999, Cosmos, Chaos and The World to Come, Yale University
Press, New Haven (1ª ed. 1993).
Colajanni A. 1994, Problemi di antropologia dei processi di sviluppo,
I.S.S.C.O., Varese.
Colajanni A. 2007, Introduzione alla ricerca antropologica. Lo studio del
cambiamento culturale, Edizioni Nuova Cultura, Roma.
Corna Pellegrini G. (a cura di) 1988, Roberto Almagià e la geografia italiana nella prima metà del secolo. Una rassegna scientifica e una antologia di scritti, Unicopli, Milano.
Cozzi D., Nigris D. 1996, Gesti di cura, Colibrì, Paderno Dugnano.
Crocker C. 1969, Men’s house associates among eastern Bororo, in
«Southwestern Journal of Anthropology», n. 25, pp. 611-645.
Crutzen P.J. 2005, Benvenuti nell’Antropocene!, Mondadori, Milano.
Cuisenier J. 1991, La maison rustique. Logique sociale et composition architecturale, Presses Universitaires de France, Paris.
Dam Bo 1950, Les Populations montagnards de Sud indochinois, Lyon.
Dean M. 1999, Risk, calculable and incalculable, in Lupton 1999, pp. 131160.
De Marchi F., Ellena A., Catarinussi B. (a cura di) 1987, Nuovo Dizionario di Sociologia, San Paolo, Milano.
De Martino E. 1952, Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito
achilpa delle origini, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni»,
XXIII, pp. 52-66.
De Martino E. 1977, Le fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Eianudi, Torino.
Dematteis G. 1993, Le mappe invisibili dell’evento, in Botta 1993, pp. 1323.
Di Sopra L. 1984, La vulnerabilità sistemica come dimensione generatrice
del rischio, in Di Sopra, Pelanda 1984, pp. 15-61.
Di Sopra L., Pelanda C. (a cura di) 1984, Teoria della vulnerabilità, Franco Angeli, Milano.
Doninger W. 2002, Le origini del male nella mitologia indù, Adelphi, Milano (ed. or. The Origins of Evil in Hindu Mythology, University of California Press, Berkeley 1976).
Douglas M. 1982, Essays in Sociology of Perception, Routledge, London.
Douglas M. 1985, Risk Acceptability According to The Social Sciences,
Russel Sage Foundation, London.
Douglas M. 1990, Come pensano le istituzioni, il Mulino, Bologna (ed. or.
How Institutions Think, Syracuse University Press, Syracuse, N.Y.,
1986).
Douglas M. 1993, Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, il Mulino, Bologna (ed. or. Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, Penguin Books, Harmondsworth 1970, 1ª ed. 1966).
Douglas M. 1996, Rischio e colpa, il Mulino, Bologna (ed. or. Risk and
Blame, Routledge, London 1992).
Douglas M., Wildavsky A. 1982, Risk and Culture, University of California Press, Berkeley.
Dournes J. 1970, Recherches sur le haut Champa, in «France-Asie», n.
201, pp. 143-162.
Dournes J. 1978, La toupie incestueuse, in «L’Homme», XV (3-4), pp. 3153.
Drabek T.N. 1965, Human System Responses to Disaster. An Inventory of
Sociological Finding, Springer, New York.
Dupuy J.-P. 2006, Piccola metafisica degli tsunami. Male e responsabilità
nelle catastrofi del nostro tempo, Donzelli, Roma (ed. or. Petite métaphysique des tsunamis, Seuil, Paris 1995).
Dynes R.R. 1974, Organized Behavior in Disasters, Disaster Research
Center, Ohio State University, Columbus.
Ekeland I. 1999, A caso. La sorte, la scienza, il mondo, Bollati Boringhieri, Torino (ed. or. Au hasard, Seuil, Paris 1991).
Evans G.W. (a cura di) 1982, Environmental Stress, Cambridge University Press, Cambridge.
Evans-Pritchard E.E. 2002, Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande,
Raffaello Cortina, Milano (ed. or. Witchcraft, Oracles and Magic among
the Azande, Clarendon Press, Oxford 1937).
Fabian S.M. 1992, Space-Time of the Bororo of Brasil, University of Florida, Gainesville.
168
169
Favole A. 2003, Resti di umanità. Vita sociale del corpo dopo la morte, Laterza, Roma-Bari.
Favole A., Ligi G., Viazzo P.P. 2004, Luoghi dei vivi, luoghi dei morti.
Spazi e politiche della morte, numero monografico di «La Ricerca Folklorica», n. 49.
Ferrarotti F. 1999, L’ultima lezione. Critica della sociologia contemporanea, Laterza, Roma-Bari.
Fichten J.M. 1989, When toxic chemicals pollute residential environments:
the cultural meanings of home and homeownership, in «Human Organization», vol. 48, n. 4, pp. 313-324.
Filippi G.G. 2005, Mrtyu: Concept of Death in Indian Traditions,
Printworld, New Delhi (2a ed. rivisitata).
Firth R. 1959, Social Change in Tikopia. Re-Study of a Polynesian Community after a Generation, Allen & Unwin, London.
Firth R. 1976, Noi, Tikopia, Laterza, Roma-Bari (ed. or. We, the Tikopia,
Beacon Press, Boston 1963).
Fjellström P. 1985, Samernas samhälle i tradition och nutid, Norstedt,
Stockholm.
Fortescue M. 1988, Eskimo Orientation Systems, numero monografico
della serie Meddelelser om Grønland, «Man & Society», 11.
Foucault M. 1965, Madness and Civilisation, trad. parziale inglese di R.
Howard, Mentor Books, New York (ed. or. Folie et déraison. Histoire
de la folie à l’âge classique, Plon, Paris 1961; trad. it. Storia della follia,
Rizzoli, Milano 1963).
Foucault M. 1988, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Rizzoli, Milano (ed. or. Les mots et les choses. Une archéologie des
sciences humaines, Gallimard, Paris 1966).
Freeberne M. 1962, Natural calamities in China 1949-1961, in «Pacific
Viewpoint», n. 3, pp. 33-72.
Fritz C.E., Marks E.S. 1954, The NORC studies in human behavior in disaster, in «Journal of Social Issues», n. 10, pp. 26-41.
Gallino L. 2007, Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici, Einaudi, Torino.
Galzigna M. 2006, Il mondo della mente. Per una epistemologia della cura, Marsilio, Venezia.
García-Acosta V. 1995, Desastres «naturales»: un nuevo campo de estudio
en México, in «Inventario Antropológico. Anuario de la Revista Alteridades», Departamento de Antropología, UAM-I, México, pp. 77-92.
García-Acosta V. (a cura di) 1996, Historia y desastres en America latina,
La Red, Ciesas, Mexico City, 2 voll.
García-Acosta V. 1997, Las ciencias sociales y el studio de los desastres, in
«Umbral XXI», n. 24, pp. 8-13.
Garita N., Nowalski J. (a cura di) 1996, Del desastre al desarrollo humano sostenible en Centroamérica, CIDH/BID, San José.
Garza Salinas M., Velázquez D.R. 1998, Los desastres en México. Una perspectiva multidisciplinaria, Universitad Iberoamericana, Mexico City.
Geertz C. 1988, Antropologia interpretativa, il Mulino, Bologna (ed. or.
The Interpretation of Culture, Basic Books, New York 1973).
Geertz H. 1963, Indonesian Culture and Communities, in R.T. McVey (a
cura di), Indonesia, HRAF Press, New Haven.
Geipel R. 1979, Friuli. Aspetti sociogeografici di una catastrofe sismica,
Franco Angeli, Milano (ed. or. Friaul. Sozialgeographische Aspekteeiner
Erdbebenkatastrophe, Münchener Geographische Hefte nr. 40, Verlag
Michael Lassleben, Regensburg 1977).
Gevaert J. 1989, Il problema dell’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, Elle Di Ci Leumann, Torino.
Giap Parini E. 2006, Sapere scientifico e modernità, Carocci, Roma.
Giglioli P.P. 1990, Introduzione all’edizione italiana, in Douglas 1990, pp.
9-21.
Gordon Levine A. 1982, Love Canal: Science, Politics and People, Lexington Books, Lanham.
Gould P. 1990, Fire in the Rain. The Democratic Consequence of Chernobyl, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Gusman A. 2004, Antropologia dell’olfatto, Laterza, Roma-Bari.
Hacking I. 1987, L’emergenza della probabilità, il Saggiatore, Milano (ed.
or. The Emergence of Probability, Cambridge University Press, Cambridge 1975).
Hacking I. 1994, Il caso domato. Il declino del determinismo, un ideale che
ha dominato la cultura occidentale per secoli, il Saggiatore, Milano (ed. or.
The Taming of Chance, Cambridge University Press, Cambridge 1990).
Hagget P. 1975, Geography. A Modern Synthesis, Harper & Row, New
York.
Hannerz U. 2001, La diversità culturale, il Mulino, Bologna (ed. or. Transnational Connections. Culture, People, Places, Routledge, New York
1996).
Häring H. 2001, Il male nel mondo. Potenza o impotenza di Dio, Queriniana, Brescia (ed. or. Das Böse in der Welt. Gottes Macht oder Ohnmacht?, Wissenschafliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1999).
Hewitt K. (a cura di) 1983, Interpretations of Calamity, The Risk & Hazards Series 1, Allen & Unwin, Boston.
Hillier B., Hanson J. 1984, The Social Logic of Space, Cambridge University Press, Cambridge.
Hoffman S.M., Oliver-Smith A. (a cura di) 1999, The Angry Earth. Disaster in Anthropological Perspective, Routledge, London.
Hoffman S.M., Oliver-Smith A. (a cura di) 2002, Catastrophe and Cultu-
170
171
re. The Anthropology of Disaster, School of American Research Press,
Santa Fe.
Hori H. 1968, Folk Religion in Japan. Continuity and Change, Chicago
University Press, Chicago.
Ikeya H. 2002, Introduction to Sabo Works, Sabo Technical Centre,
Tokyo.
Ingold T. 2000, The Perception of the Environment. Essays on Livelihood,
Dwelling and Skill, Routledge, London.
Ingold T., Kurttila T. 2000, Perceiving the environment in Finnish Lapland, in «Body and Society», vol. 6 (3-4), pp. 183-196.
Israel P.E. 1985, Dalla «jibaria» al «centro shuar». Modernizzazione dello
spazio domestico nell’Amazzonia ecuadoriana, in «La Ricerca Folklorica», n. 11, pp. 53-60.
Iwata T., Hatayama K., Kawase H. et al. 1995, Array observation of aftershocks of the 1995 Hyogo-Ken Nambu earthquake at Higashinada
Ward, Kobe City, in «Journal of Natural Disasters Science», n. 16, pp.
41-48.
Jasanoff S. 1994, Learning From Disaster. Risk Management after Bhopal,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Jedlowski P. 1989, Memoria, esperienza e modernità, Franco Angeli, Milano.
Jonas F. 1970, Storia della sociologia, Laterza, Bari (ed. or. Geschichte der
Soziologie, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1968-1969, 4 voll.).
Jonas H. 1990, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino (ed. or. Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag,
Frankfurt am Main 1979).
Kakhandiki A., Shah H. 1998, Understanding time variation of risk: crucial implications for megacities worldwide, in «Applied Geography», n.
18, pp. 47-53.
Klein N. 2007, Shock Economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri, Rizzoli, Milano (ed. or. The Shock Doctrine, Metropolitan Books, New
York 2007).
Knight J. 1995, Tourism as stranger. Explaining tourism in rural Japan, in
«Social Anthropology», n. 3, pp. 219-234.
Kostenko L. 1994, Intarsi, Piovan, Abano Terme 1994 (ed. or. Inkrustazij, Dnipro, Kyjiv 1989).
Kuhn T. 1978, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Come mutano le
idee della scienza, Einaudi, Torino (ed. or. The Structure of Scientific Revolution, The University of Chicago Press, Chicago 1962).
La Cecla F. 1988, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma-Bari.
Lai F. 1996, Il mutamento culturale. Strutture e pratiche sociali dell’antropologia contemporanea, Cuec, Cagliari.
Lanternari V. 1974, Movimenti religiosi di libertà e salvezza dei popoli op-
pressi, Feltrinelli, Milano 1974.
Lawrence D., Low S. 1990, The built environment and spatial form, in
«Annual Review of Anthropology», n. 19, pp. 453-505.
Lévi-Strauss C. 1964, Il pensiero selvaggio, il Saggiatore, Milano 1964 (ed.
or. La pensée sauvage, Plon, Paris 1962).
Lévy-Bruhl L. 1971, La mentalità primitiva, Einaudi, Torino (ed. or. La
mentalité primitive, Presses Universitaires de France, Paris 1922).
Ligi G. 2002, Le fonti che non parlano: ipotesi per un’etnografia del paesaggio in Lapponia, in «La Ricerca Folklorica», n. 45, pp. 71-79.
Ligi G. 2003, La casa saami. Antropologia dello spazio domestico in Lapponia, Il Segnalibro, Torino.
Ligi G. 2004, I Saami e l’Europa: tratti di un’identità frammentata, in
«Quaderni di Lingue e Letterature Straniere - Università di Genova»,
n. 13, pp. 221-236.
Ligi G. 2007 (a cura di), I saperi del fare, numero monografico di «Molimo. Quaderni di Antropologia culturale e Etnomusicologia», Cuem,
Università Statale di Milano, n. 3.
Lombardi M. 1993, Sociologia delle emergenze. Aspetti e problematiche recenti, in Botta 1993, pp. 133-141.
Low S. 1986, Spatializing culture: the social production and social construction of public space in Costa Rica, in «American Ethnologist», n.
23, pp. 861-879.
Luhmann N. 1996, Sociologia del rischio, Bruno Mondadori, Milano (ed.
or. Soziologie des Risikos, Walter de Gruyter, Berlin 1991).
Lupton D. (a cura di) 1999, Risk and Sociocultural Theory. New Directions and Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge.
Lupton D. 2003, Il rischio. Percezione, simboli, culture, il Mulino, Bologna (ed. or. Risk, Routledge, London 1999).
Macías J.M. 1992, Significado de la vulnerabilidad sociale frente a los desastres, in «Revista Mexicana de Sociología», n. 4, pp. 3-12.
Magris C. 1997, Microcosmi, Garzanti, Milano.
Malinowski B. 1973, Argonauti del Pacifico Occidentale, Newton Compton, Roma (ed. or. Argonauts of Western Pacific, Routledge & Kegan
Paul, London 1922).
Marinelli A. 1993, La costruzione del rischio. Modelli e paradigmi interpretativi nelle scienze sociali, Franco Angeli, Milano.
Marples D. 1988, The Social Impact of the Chernobyl’ Disaster, Macmillan, London.
Martindale D. 1968, Tipologia e storia della teoria sociologica, il Mulino,
Bologna (ed. or. The Nature and Types of Sociological Theory, Routledge
& Kegan Paul, London 1961).
Masel Walters L., Wilkins L., Walker T. (a cura di) 1989, Bad Tidings.
Communication and Catastrophe, Erlbaum Associates, Hillsdale.
172
173
Maskrey A. 1989, Disaster Mitigation. A Community Based Approach,
Oxfam, Oxford.
Maso S. 2003, Rischio, Cafoscarina, Venezia.
Massey D., Jess P. 2005, Luoghi, culture e globalizzazione, Utet, Torino
(ed. or. A Place in the World? Places, Cultures and Globalization, The
Open University, Oxford 1995).
Mattozzi I. 2003, Per una storia di Longarone nel Novecento, in M. Reberschak (a cura di), Il grande Vajont, Cierre, Verona 2003.
Maturana H.R., Varela F.J. 1985, Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia (ed. or. Autopoiesis and Cognition, Reidel, Dordrecht 1980).
McLuckie B.F.M. 1975, Centralization and natural disaster response: a
preliminary hypothesis and interpretation, in «Mass Emergencies», n. 1,
pp. 1-9.
Meadows D.L., Meadows D.H. (a cura di) 1975, I limiti dello sviluppo:
verso un equilibrio globale, Mondadori, Milano (ed. or. The Limits of
Growth, New American Library, New York 1972).
Medvedev G. 1991, Chernobyl’. Tutta la verità sulla tragedia nucleare, SugarCo, Milano (ed. or. La vérité su Tchernobyl, Albin Michel, Paris
1980).
Oliver-Smith A. 1982, Here there is life: the social and cultural dynamics
of successful resistence to resettlement in post-disaster Peru, in A. Hansen, A. Oliver-Smith (a cura di), Involuntary Migration and Resettlement. The Problems and Responses of Dislocated People, Westview,
Boulder, pp. 85-104.
Oliver-Smith A. 1986a, The Martyred City. Death and Rebirth in the Andes, University of Mexico Press, Albuquerque.
Oliver-Smith A. (a cura di) 1986b, Natural Disasters and Cultural Responses, Coll. William & Mary, Williamsburg.
Oliver-Smith A. 1992, Disaster and development, in «Environment Urban
Issues», n. 20, pp. 1-12.
Oliver-Smith A. 1994, Peru’s five hundred year earthquake: vulnerability
in historical context, in A. Varley (a cura di), Disasters, Development and
Environment, Wiley, London, pp. 3-48.
Oliver-Smith A. 1996, Anthropological research on hazards and disasters,
in «Annual Review of Anthropology», n. 25, pp. 303-328.
Oliver-Smith A. 1999, Lima, Perù: underdevelopment and vulnerability in
the city of the kings, in J.K. Mitchell (a cura di), Crucibles of Hazard:
Megacities and Disasters in Transition, United Nations University
Press, Tokyo.
Oliver-Smith A., Parker J.W. 1992, A Decade of Initiatives for Safer Housing in Jamaica, Basic Health Manage, Silver Springs.
Olson M. 1983, La logica dell’azione collettiva, Feltrinelli, Milano (ed. or.
The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups,
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1965).
Paine R. 1982, Chernobyl’ reaches Norway: the accident, science, and the
threat to cultural knowledge, in «Public Understanding of Science», n.
1, pp. 261-280.
Paine R. 1987, Accidents, ideologies and routine. «Chernobyl’» over
Norway, in «Anthropology Today», n. 2, pp. 7-10.
Passi M. 2003, Vajont senza fine, Baldini & Castoldi, Milano.
Pelletier P. 1991, L’anastrophe japonaise, in «Revue géographique de
Lyon», n. 66, pp. 223-230.
Pelletier P. 2000, Le mythe du manque d’espace au Japon, in Id. (a cura
di), L’archipel accaparé, EHESS, Paris.
Perry W.R., Hirose H. 1991, Volcano Management in The United States
and Japan, Jai Press, London.
Petryna A. 2002, Life Exposed. Biological Citizens after Chernobyl, Princeton University Press, Princeton.
Petterson P. 1989, Reporting Chernobyl’: Cutting The Government Fog to
Cover The Nuclear Cloud, in Masel Walters, Wilkins, Walker 1989, pp.
131-147.
Placanica A. 1985, Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento,
Einaudi, Torino.
Placanica A. 1993, Storia dell’inquietudine, Donzelli, Roma.
Portinaro P.P. 2002, voce «Colpa», in Id. (a cura di), I concetti del male,
Einaudi, Torino, pp. 53-68.
Preston R. 1994, Area di contagio. Una storia vera, Rizzoli, Milano (ed. or.
The Hot Zone. A Terrifying Story, Anchor, New York 1994).
Prigogine I. 1997, La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura, Bollati Boringhieri, Torino (ed. or. La fin des certitudes. Temps,
chaos et les lois de la nature, Odile Jacob, Paris 1996).
Prince S.H. 1920, Catastrophe and Social Change. Based upon a Sociological Study of the Halifax Disaster, Columbia University Press, New York.
Quaranta I. 2006, Corpo, potere e malattia. Antropologia e AIDS nei Gressfields del Camerun, Meltemi, Roma.
Quarantelli E.L. (a cura di) 1978, Disasters. Theory and Research, Sage
Publications, Beverly Hills.
Quarantelli E.L. (a cura di) 1995, What is a disaster?, in «International
Journal of Mass Emergencies and Disasters», vol. 13, n. 3, pp. 221-229.
Quarantelli E.L. (a cura di) 1998, What is a Disaster? Perspectives on the
Question, Routledge, London.
Rapoport A. 1976 (a cura di), The Mutual Interaction of People and Their
Built Environment. A Cross-Cultural Perspective, The Hague, Paris.
Raveri M. 1989, Itinerari del sacro. L’esperienza religiosa giapponese,
Cafoscarina, Venezia.
174
175
Raveri M. (a cura di) 1997, Del bene e del male. Tradizioni religiose a confronto, Marsilio, Venezia.
Reader I. 1990, Religion in Contemporary Japan, University of Hawai’i
Press, Honolulu.
Reddy S.G. 1996, Claims to expert knowledge and the subversion of democracy: the triumph of risk over uncertainty, in «Economy and Society», vol. 25, n. 2, pp. 222-254.
Remotti F. 1990, Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia, Bollati Boringhieri, Torino.
Remotti F. 1993, Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e del
potere, Bollati Boringhieri, Torino.
Remotti F. 1994, Tesi per una prospettiva antropo-poietica, Introduzione a
S. Allovio, A. Favole (a cura di), Fucine rituali, Il Segnalibro, Torino.
Remotti (a cura di) 1999, Forme di umanità. Progetti incompleti e cantieri sempre aperti, Paravia Scriptorium, Torino.
Remotti F. 2002, voce «Maleficio», in P.P. Portinaro (a cura di), I concetti del male, Einaudi, Torino, pp. 147-158.
Rosaldo R. 2001, Il dolore e la rabbia di un cacciatore di teste, in Id., Cultura e verità. Rifare l’analisi sociale, Meltemi, Roma, pp. 37-63 (ed. or.
Culture and Truth, Bacon Press, Boston 1989).
Sandars N.K. (a cura di) 1986, L’epopea di Gilgamesh, Adelphi, Milano
(ed. or. The Epic of Gilgamesh, Penguin Books, Harmondsworth 1960).
Scaglione F. 1999, Tra Černobyl’ e Černobyl’, in AA.VV., Quel che resta del
mondo, Baldini & Castoldi, Milano.
Scarduelli P. 1992, Lo specchio del cosmo. Il simbolismo spaziale nelle culture dell’Indonesia, Il Segnalibro, Torino.
Schmink M. 1982, Land conflicts in Amazzonia, in «American Anthropologist», n. 9, pp. 341-357.
Schwarz M., Thompson M. 1993, Il rischio tecnologico. Differenze culturali e azione politica, Guerini, Milano (ed. or. Divided We Stand. Redefining Politics, Technology and Social Choice, Harvester Wheatsheaf,
New York 1990).
Severi C. (a cura di) 2000, Antropologia e psicologia. Interazioni complesse
e rappresentazioni mentali, numero monografico di «Etnosistemi», n. 7.
Shrader-Frechette K.S. 1991, Risk and Rationality, University of California Press, Berkeley.
Signorelli A. 1992, Catastrophes naturelles et réponses culturelles, in «Terrain», n. 19, pp. 147-158.
Simonicca A. 1997, Antropologia del turismo, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
Sofsky W. 2005, Rischio e sicurezza, Einaudi, Torino (ed. or. Das Prinzip
Sicherheit, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2005).
Sorokin P.A. 1942, Man and Society in Calamity, E.P.Dutton & Co., New
York.
Sorokin P.A. 1965, La mobilità sociale, Edizioni di Comunità, Milano (ed.
or. Social Mobility, Harper & Brothers, New York-London 1927).
Steinberg T. 2000, Acts of God. The Unnatural History of Natural Disasters in America, Oxford University Press, Oxford.
Stephens S. 2002, Bounding Uncertainty. The Post-Černobyl’ Culture of
Radiation Protection Experts, in Hoffman, Oliver-Smith 2002, pp. 91111.
Stocking G.W. Jr. 1999, Antropologia dell’età vittoriana, Ei Editori, Roma (ed. or. Victorian Anthropology, The Free Press, New York 1987).
Sturloni G. 2006, Le mele di Černobyl’ sono buone. Mezzo secolo di rischio
tecnologico, Sironi, Milano.
Svensson T.G. 1978, Culture communication and Saami ethnic awareness,
in «Etnos», n. 43, pp. 214-236.
Tagliapietra A. 2004, Sulla catastrofe. L’illuminismo e la filosofia del disastro, Bruno Mondadori, Milano.
Tessarin N. 1994, Disastro e ricostruzione sociale. Il senso di appartenenza alla comunità, in Vendramini 1994, pp. 2-29.
Thom R. 1980, Stabilità strutturale e morfogenesi, Einaudi, Torino (ed.
or. Stabilité structurelle et morphogénèse, W.A. Benjamin, Reading,
Mass., 1972).
Torry W. 1978, Natural disasters, social structure and change in traditional societies, in «Journal of Asian and African Studies», XIII (3-4), pp.
167-183.
Torry W. 1979a, Anthropology and disaster research, in «Disasters», n. 3
(1), pp. 43-52.
Torry W. 1979b, Anthropological studies in hazardous environments: past trends and new horizons, in «Current Anthropology», vol. 20, n. 3,
pp. 517-540.
Torry W. 1979c, Hazards, Hazes and Holes: a Critique of the Environment
as Hazard and General Reflections on Disaster Research, in «Canadian
Geographer», n. 4, pp. 368-383.
Torry W. 1986, Drought and the government village emergency food distribution system in India, in «Human Organization», n. 45, pp. 11-23.
Tozzi M. 2005, Dal terremoto di Lisbona allo tsunami del Sudest asiatico:
250 anni di lotta tra l’uomo e la natura, Rizzoli, Milano.
Trentini M. 2006, Rischio e società, Carocci, Roma.
Tuan H.-F. 1979, Thought and landscape: the eye and the mind’s eye, in
W.D. Meining (a cura di), The Interpretation of Ordinary Landscapes,
Oxford University Press, Oxford.
Turner B.A., Pidgeon F. 2001, Disastri. Dinamiche organizzative e re-
176
177
sponsabilità umane, Ed. di Comunità, Torino (ed. or. Man-made Disasters, Butterworth-Heinemann, London 1997).
Vaillant G.C. 1992, La civiltà azteca, Einaudi, Torino (ed. or. Aztecs of
Mexico, Doubleday, Garden City, N.Y., 1941).
Vallerani F. 2004, La perdita della bellezza. Paesaggio veneto e racconti del
disagio, in F. Vallerani, M. Varotto (a cura di), Il grigio oltre le siepi.
Geografie smarrite e racconti del disagio in Veneto, Nuova Dimensione,
Portogruaro, pp. 159-183.
Vaughan D. 1996, The Challenger Launch Decision: Risky Technology,
Culture and Deviance at NASA, University of Chicago Press, Chicago.
Vendramini F. 1994, Disastro e ricostruzione nell’area del Vajont, Castaldi, Feltre.
Vineis P. 1990, Modelli di rischio. Epidemiologia e causalità, Einaudi, Torino.
Vineis P. 2002, voce «Malattia», in P.P. Portinaro (a cura di), I concetti
del male, Einaudi, Torino, pp. 132-147.
Voget F.W. 1984, Mutamento sociale e culturale: acculturazione e antropologia applicata, in Id., Storia dell’etnologia contemporanea, Laterza,
Roma-Bari, pp. 253-340 (ed. or. A History of Ethnology, Holt, Reinehart & Winston, New York 1975).
Vygotskij L. 1973, Pensiero e linguaggio, Giunti, Firenze (ed. or. Thought
and Language, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1962).
Wallace A.F.C. 1956a, Human Behavior in Extreme Situations, National
Academy of Science, Washington, D.C.
Wallace A.F.C. 1956b, Tornado in Worcester, National Academy of
Science, Washington, D.C.
Wallace A.F.C 1956c, Revitalization Movements, in «American Anthropologist», n. 58, pp. 204-281.
Weber E. 1999, Apocalypses, Prophecies, Cults and Millennial Beliefs
Through the Ages, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Western K.A. 1972, The Epidemiology of Natural and Man-made Disasters. The Present State of The Art, Academic Diploma in Tropical Public Health dissertation, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, London.
White G.F. 1942, Human Adjustment to Floods. A Geographical Approach to The Flood Problem in The United States, Research Paper 29, University of Chicago, Dept. of Geography, Chicago.
White G.F. 1964, Choice of Adjustment to Floods, Research Paper 93,
University of Chicago, Dept. of Geography, Chicago.
White G.F. 1974, Natural Hazards. Local, National, Global, Oxford University Press, New York.
White G.F. 1985, Perception, in R.W. Kates, J.H. Ausbel, M. Berberian
(a cura di), Climate Impact Assessment, Wiley, New York.
178
Winch P. 1987, Trying to Make Sense, Blackwell, Oxford.
Winchester S. 2004, Krakatoa. Biografia del vulcano che ha cambiato la
storia, Longanesi, Milano (ed. or. Krakatoa. The Day the World Exploded: 27 August 1883, Viking, London 2003).
Zaman M.Q. 1986, The role of social relations in the response to riverbank
erosion hazards and population resettlement in Bangladesh, in OliverSmith 1986b, pp. 117-200.
Zaman M.Q. 1989, The social and political context of adjustment to riverbank erosion hazard and population resettlement in Bangladesh, in «Human Organization», n. 14, pp. 196-205.
Zaman M.Q. 1991, The displaced poor and resettlements policies in Bangladesh, in «Disasters», n. 15, pp. 117-125.
Zorzi L. 2000, Taccuini Saami, Todaro Editore, Lugano.
Indici
Indice dei nomi
Bertolaso, G., 93n.
Bettin, G., 90n.
Bianchi, E., 28 e n, 29n, 36n, 38n, 141.
Bichat, M.F.X., 144.
Blackford, M.E., 12.
Boccali, G., 112n.
Boholm, Å., 155n.
Bordieri, F., 11.
Boschi, E., 10-11.
Botta, G., 45.
Bourdieu, P., 78n.
Brait, L., 12.
Burton, I., 32, 38n, 40.
Agostino d’Ippona, 107, 116, 118.
Aleksievic, S., 164.
Alexander, D., 13, 14n, 24n, 28n, 29n,
34n, 96-97, 99, 103-104, 105 n.
Allovio, S., XI.
Almagià, R., 44, 45 e n, 46-48, 76.
Angelini, C. 113n.
Angioni, G., 64.
Apfjell, A. 70-72.
Apfjell, G., 65, 70-73.
Appadurai, A., IX, 51n.
Århen, I., 64n.
Arnol’d, V.I., 42n.
Augé, M., 110.
Augendre, M., 101-103.
Axia, V., 83n.
Calame, C., 7.
Camus, A., 116-117.
Cancani, A., 11.
Caplan, P., X, 141n.
Carr, P., 60n.
Carson, R., 132n.
Castel, R., IX.
Castelli, C., 33, 83n.
Catarinussi, B., 17n.
Centemeri, L., 133.
Chapman, D.W., 30n.
Chen, F., 25n.
Cheng, Y., 25n.
Chohan, T.R., 14.
Cieraad, I., 53n.
Cirese, A.M., 69.
Cohen, A., 7, 39n.
Cohn, N., 113n.
Colajanni, A., 96n.
Comte, A., 20.
Corbin, A., 66.
Bacchelli, R., 121n.
Bachelard, G., 53.
Baker, G., 30n.
Bankoff, G., 96, 105n.
Baratta, M., 11.
Barillari, S., 109.
Barkun, M., 31-32.
Barthes, R., 108, 120.
Barton, A.H., 30 e n, 31-32.
Bauman, Z., IX.
Bayes, T., 137.
Beck, U., 66-67, 108, 163.
Bell, F.G., 99.
Beneduce, R., 83n.
Berger, P.L., 7.
Bernardi, U., 52.
Bernoulli, J., 137, 147.
Berque, A., 102.
183
Corna Pellegrini, G., 45.
Cozzi, D., 83n.
Croce, B., 115.
Crocker, C., 85.
Crutzen, P.J., 90 e n, 159.
Cuisenier, J., 77.
Foucault, M., 41 e n, 44, 71.
Frazer, J., 130.
Freeberne, M., 25n.
Frerks, G., 105n.
Fritz, C.E., 29-30 e n.
Fujita, T.T., 11.
Dalla Vedova, G., 45.
Dam Bo, 114n.
Dean, M., 6.
De Marchi, B., 134.
De Marchi, F., 17n.
De Martino, E., VII, 51-52, 77-79, 82,
129.
Dematteis, G., 106.
De Moivre, A., 136.
De Villa, V., 81.
Dias, A., 115-116.
Di Sopra, L., 101n.
Doninger, W., 112n.
Douglas, M., XI, 28, 32, 117, 121 e n,
124, 125 e n, 126, 129-131, 135 e
n., 144, 148-149, 150n, 151, 154,
155n, 156, 162.
Drabek, T.N., 40.
Dupuy, J.-P., 119.
Durant, W., 88.
Durkheim, E., 20, 124n, 141, 151.
Dynes, R.R., 30n, 32.
Gallino, L., 162-163.
Galzigna, M., 83n.
García-Acosta, V., 43n, 84n.
Garita, N., 84n.
Garza Salinas, M., 84n.
Gaski, H., 73n.
Geertz, C., 6n, 8, 48.
Geertz, H., 86-87.
Geipel, R., 29n.
Geremia, E., 25n.
Gevaert, J., 117n.
Giammatteo, C., 93n.
Giddins, F.H., 20, 21 e n.
Giglioli, P., 150n, 151.
Gogol’, N.V., 108n.
Gould, P., 25.
Gusman, A., 62n.
Ekeland, I., 90n.
Ellena, A., 17n.
Epicuro, 118.
Evans, G.W., 39n.
Evans-Pritchard, E.E., 125 e n, 126,
129-130, 140, 149.
Fabian, S.M., 85.
Favole, A., 82n.
Feltri, V., 88.
Ferrarotti, F., 3.
Fichten, J.M., 53-55.
Filippi, G.G., 112n.
Filoramo, G., 117n.
Firth, R., 23 e n, 24n.
Fishhoff, B., 39n.
Fjellström, P., 70n.
Fortescue, M., 56n.
184
Iwata, T., 12.
Marcorè, E., 79n, 161n.
Marinelli, A., 139n, 155n.
Marks, E.S., 29, 30n.
Martindale, D., 20n.
Martinelli, R., 47n.
Maskrey, A., 84.
Maso, S., 136.
Massey, D., 51n.
Mattozzi, I., 80n, 81n.
Maturana, H.R., 7.
Mauss, M., 124n, 141.
McLuckie, B.F.M., 27.
Meadows, D.H., 133n.
Meadows, D.L., 133n.
Mercalli, G., 11.
Milanetti, G., 112n.
Monesi, P., 88n.
Mordiglia, P., 88n.
Moseley, M., 43n.
Muchembled, R., 66n.
Jasanoff, S., 14.
Jass, P., 51n.
Jedlowski, P., 78.
Johnson, K.M., 14.
Jonas, F., 20 e n.
Jonas, H., 163-164.
Kakhandiki, A., 84.
Kam-ling, T., 25n.
Kates, R.W., 38n, 40.
Kawase, H., 12.
Kilani, M., 7n.
Klein, N., 90.
Knight, F., 137.
Knight, J., 102.
Koch, R., 143n.
Konstantinenko, K., 25n.
Kostenko, L., 108.
Kuhn, T., 141.
Kurttila, T., 64.
Haas, J.E., 32.
Hacking, I., 90n, 137n.
Hagget, P., 39n.
Hannerz, U., 87.
Hanson, J., 53n.
Häring, H., 116n.
Hatayama, K., 12.
Hemingway, E., 109 e n.
Henle, F.G.J., 143n.
Henriksen, G., 60 e n, 62, 65, 67-68,
70, 72.
Herzlich, C., 110.
Hewitt, K., 32, 40, 41 e n, 42, 99n.
Hilhorst, D., 105n.
Hillier, B., 53n.
Hirose, H., 101.
Hoffman, S.M., 4, 43n.
Hori, H., 101.
Husserl, E., 78.
La Cecla, F., 86n.
Lai, F., 96n.
Lanternari, V., 113n.
Laplace, P.-S. de, 107.
Lattanzio, 118.
Lawrence, D., 48n.
Leibniz, G.W. von, 118 e n.
Leopardi, G., 75.
Lerner, G., 88n.
Levine, G., 142n.
Lévi-Strauss, C., 63-64.
Lévy-Bruhl, L., 123, 124n, 130.
Ligi, G., 12, 25n, 48n, 57, 64 e n, 82n,
150n.
Lombardi, M., 14.
Love, W., 142.
Low, S.M., 48n, 49.
Luckmann, T., 7.
Luhmann, N., 136.
Lupton, D., IX-X, 6, 66n, 139n, 141n,
153-154, 155 e n.
Ikeya, H., 101.
Ingold, T., 51, 62n, 64.
Israel, P.E., 86n.
Macías, J.M., 84n.
Magris, C., 51.
Malinowski, B., 24n, 50, 124n.
Neher, A., vii.
Nigris, D., 83n.
Nowalski, J., 84n.
Oliver Smith, A., 4, 28 e n, 42 e n, 43
e n, 45, 76-77, 85n, 95, 97-98.
Olson, M., 150-151.
Paine, R., 43n, 71.
Paolo di Tarso, 118n.
Parker, J.W., 85n.
Pascal, B., 78n, 147.
Pelletier, P., 102-103.
Perry, W.R., 101.
Pidgeon, F., 19, 34n.
Placanica, A., 119n.
Polo, M., 86 e n, 87.
Portinaro, P.P., 117n.
Pradella, G., 80.
Preston, R., 15.
Prigogine, I., 90n.
Prince, S.H., 20, 21n, 22-23, 26 e n,
27-28, 95.
Qian Gang, 25n.
Quaranta, I., 127-128.
185
Quarantelli, E.L., 7, 16, 17n, 28 e n,
32-33, 34e n, 36-37.
Radcliffe-Brown, A., 125n.
Rapoport, A., 48n.
Ravera, M., 117n.
Raveri, M., 101.
Reader, I., 101.
Reddy, S.G., 137.
Remotti, F., 4, 7, 48-49, 109-110.
Renberg, T., 60, 62.
Richelieu, A.-J. du Plessis duca di,
136.
Richter, C., 11.
Ronchi, G., 86n.
Ronchi, L., 88n.
Rosaldo, R., 109.
Roudinesco, E., 83n.
Rousseau, J.-J., 120 e n, 121-122.
Samonà, G., 81.
Sandars, N.K., 112.
Savater, F., 89n.
Sbattella, F., 33, 83n.
Scarduelli, P., 86.
Schmink, M., 95.
Schwarz, M., 121n, 149.
Severi, C., 83n, 155n.
Shah, H., 84.
Shrader-Frechette, K.S., 141n.
Signorelli, A., 46n, 161.
Simeoni, V., 150n.
Simonicca, A., 79n, 87, 162n.
Slovic, P., 39n.
Small, A.W., 21n.
Sobrero, A., 79n, 162n.
Sorokin, P., 26 e n, 27-29.
Spencer, H., 20.
Steinberg, T., 90.
Stocking, G.W., 124n.
Sturloni, G., 134n.
Sumner, W.G., 21n.
Svensson, T.G., 57n.
Indice del volume
Tagliapietra, A., 119-120.
Tessarin, N., 81.
Thom, R., 42n.
Thompson, M., 121 e n, 149, 155n.
Tommaso d’Aquino, 116.
Torry, W., 17n, 28, 40, 84, 94.
Tozzi, M., IX, 8, 88, 91, 92 e n, 93.
Trentini, M., 139n, 140.
Tuan, H.-F., 50.
Turner, B.A., 19, 34n.
Turton, D., 97.
Tylor, E.B., 130.
Utsi, P., 73.
Vaillant, G.C., 114.
Vallerani, F., 52-53.
van Loon, J., 66.
Varela, F.J., 7.
Velázquez, D.R., 84n.
Vendramini, F., 81.
Viazzo, P.P., 82n.
Vineis, P., 142n, 143, 144 e n, 145,
149 e n, 155, 157.
Voget, F.W., 96n.
Voltaire (pseud. di F.-M. Arouet),
119-120, 121n, 122.
Vygotskij, L., 63.
Wallace, A., 28 e n.
Weber, E., 113n.
Wenger, D., 16, 17n, 32n, 33-34, 3637.
Western, K.A., 3, 9.
White, G.F., 28, 37 e n, 38 e n, 39 e
n, 40, 132n.
Wildavsky, A., 121 e n, 155n.
Williams, R., 51n.
Wilson, E.O., 90n.
Winch, P., 8.
Winchester, S., 88n.
Zaman, M.Q., 94.
Zorzi, L., 58n, 70n, 73n.
Premessa
IX
1. Concetti di disastro
3
1. Problemi di ricerca e definizioni, p. 3 - 2. Nozioni tecnocentriche e nozioni socio-antropologiche, p. 9 - 3. Il disastro di
Halifax, p. 19 - 4. Che cos’è un disastro? Le molte anime di un
dibattito interdisciplinare, p. 27 - 5. Le coordinate sociali di un
disastro, p. 32 - 6. La Scuola ecologica di Boulder, p. 37
2. Un mondo fragile
44
1. «Tuguri da trogloditi» e il paradosso delle catastrofi, p. 44 2. Temi di antropologia dello spazio e del paesaggio per lo studio dei disastri, p. 48 - 3. Microcosmi e disastri, p. 51 - 4. Case, paesaggi e vulnerabilità: l’esperienza dei Saami, p. 55 - 5. Il
disastro ambientale di Brurskanken in Lapponia, p. 58 - 6. La
debole ragione dei numeri, p. 65
3. Storicizzare la vulnerabilità
75
1. Rifare il mondo, p. 75 - 2. Il sole di movimento, p. 83 - 3.
«L’acqua coi denti»: saperi nativi, vulnerabilità, sviluppo, p.
86 - 4. Disastri e mutamento sociale, p. 94 - 5. Percezioni locali
di rischio e vulnerabilità, p. 99
4. La costruzione culturale del rischio
1. Comprendere il male, p. 107 - 2. Astrologie e disastrologie:
rappresentazioni native della catastrofe, p. 110 - 3. Il problema di Giobbe e il terremoto di Lisbona, p. 115 - 4. La teoria
forense del pericolo, p. 121 - 5. «Non nel mio cortile!», p. 131
- 6. Il concetto di rischio e i limiti della «risk analysis», p. 135
- 7. Il disastro di Love Canal: la natura sociale della razionalità,
p. 141 - 8. La percezione del rischio fra costruzionismi e realismo critico, p. 149
187
107
Epilogo. Nemici svelati?
158
Riferimenti bibliografici
165
Indice dei nomi
183