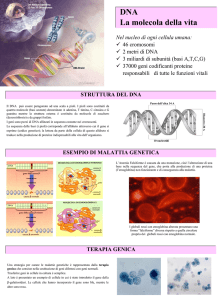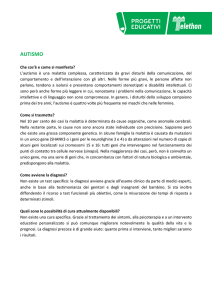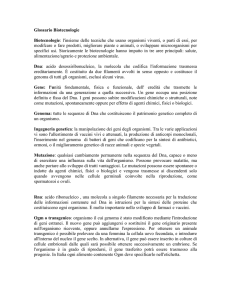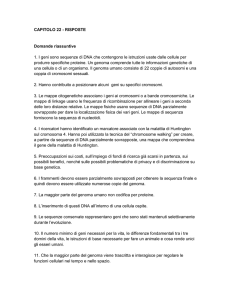Storia della scienza
per le lauree triennali
Prof. Giuliano Pancaldi
2011-12
Modulo 14
“Il secolo del gene” 6.
Conclusioni:
A che cosa serve parlare di geni
Dissenso e consenso nella scienza:
John Maynard Smith critica Evelyn Fox Keller
dal manifesto di una conferenza su
Biotechnology: innovation, opportunity, and commercialization
(Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, October 23, 2003)
“Dopo decenni di disinformazione, le rettifiche faticano a farsi strada”.
Per i geni, osserva Evelyn Fox Keller, nell’immaginario collettivo sta succedendo quello
che è successo per i dinosauri come il Tyrannosaurus rex:
Per molti decenni il Tyrannosaurus è stato presentato come un animale potente,
aggressivo e veloce, come appariva in questa ricostruzione esposta al Museo di Storia
Naturale di New York dal 1915 fino al 1992 (a sinistra), o in quest’altra rappresentazione
popolare (a destra):
(l’immagine a destra è tratta da: http://www.courtesy.nl/tac/images/cardslarge/55401.htm)
Nel 1992, alla luce di nuovi studi, la vecchia ricostruzione dello stesso animale è stata
sostituita con una nuova ricostruzione che lo rappresenta come molto meno potente,
meno aggressivo e meno veloce, più o meno così:
Eppure, in una scena famosa di Jurassic Park (1993) il regista Steven Spielberg (che
peraltro si era documentato molto bene sulla storia dei dinosauri coinvolgendo i biologi!)
per andare incontro alle aspettative del pubblico ha rappresentato il Tyrannosaurus rex
alla vecchia maniera, come un animale aggressivo, potente e veloce. Ci vorrà ancora
molto tempo per cambiare la reputazione accumulatasi in quasi un secolo a proposito di
quel vecchio animale.
Così ci vorrà del tempo per capire un’altra ―imprecisione‖ dello stesso film, che riguarda
in questo caso le biotecnologie: come sappiamo, non è possibile clonare un dinosauro a
partire soltanto dal suo DNA (vedi quanto si è detto nel Modulo 12 a proposito della
pecora Dolly, clonata nel 1996).
Per i geni sta avvenendo la stessa cosa:
―L’immagine dei geni quali agenti causali chiari e distinti, costituenti la base di tutti
gli aspetti della vita di un organismo, è talmente radicata nel pensiero comune e
scientifico che buone intenzioni, zelo o critica concettuale non basteranno a
estirparla‖ (Evelyn Fox Keller, p. 106).
Per capire fino in fondo perché si continua a parlare dei geni alla vecchia maniera,
nonostante le molte correzioni rese necessarie dalle ricerche biologiche, secondo Evelyn
Fox Keller bisogna ricordare almeno “tre funzioni”che il “parlare di geni” sembra
soddisfare:
1.
In primo luogo il linguaggio della scienza accoglie anch’esso, come il linguaggio
comune, un certo grado di ―imprecisione linguistica‖. Questa imprecisione è spesso
necessaria per favorire l’esplorazione di fenomeni che sono ancora poco conosciuti, mal
definiti, indeterminati e che interessano potenzialmente più esperti con competenze
diverse, che usano linguaggi diversi.
2.
Inoltre, la scoperta delle tecniche del DNA ricombinante dagli anni Settanta ha
rafforzato tra esperti e non esperti la convinzione che, se modificando la sequenza dei
nucleotidi nel DNA si induce una nuova o rafforzata produzione di certe proteine, queste
modifiche – attribuite ai ―geni‖ – dimostrerebbero il potere causale dei geni.
3.
Infine, ed è questa una delle conclusioni più importanti del libro di Evelyn Fox Keller:
negli ultimi decenni natura, scienziati, ricerca di laboratorio, finanziamenti,
industria biotech, mercato e pubblico interagiscono sempre più strettamente nella
ricerca biologica.
―Per concludere – osserva Evelyn Fox Keller – occorre citare un'ultima
funzione del parlare di geni: parlare di geni come strumento di persuasione.
Mai nella storia del gene il termine ha avuto la forza che ha ora
nell'immaginario collettivo, e quindi mai il parlare di geni ha avuto un tale
potere di persuasione, cioè retorico. Invocare i geni si è dimostrato efficace
non solo nel procurare fondi e promuovere programmi di ricerca, ma anche (e
forse soprattutto) nel propagandare i prodotti di un'industria biotech in rapida
espansione. Le nuove partnership tra scienza e commercio, create ogni
giorno dalle promesse della genomica, uniscono la genetica al mercato con
un legame saldo e stretto, senza precedenti negli annali della ricerca
fondamentale in biologia. Più il legame si stringe e più i ricercatori
investono nel potere retorico di un linguaggio tanto efficace.
Questi sono legami ovvi, meno ovvi sono i modi in cui l'efficacia intesa
come strumento di persuasione rafforza il valore apparente del gene in contesti
più direttamente sperimentali, e viceversa. Risonanze tra questi diversi effetti
rendono estremamente difficile rinunciare a parlare di gene, in laboratorio
come sul mercato. Si potrebbe dire che il reciproco rafforzamento è proprio
quello che rende la terminologia della pratica scientifica un fattore di
autoequilibrio, almeno a breve.
A lungo termine il linguaggio evolve, si sa, nella scienza come dappertutto,
sempre e comunque; altrimenti la conoscenza del mondo naturale non potrebbe
progredire. Se qui richiamo l'attenzione sulla conservazione del parlare di geni,
il libro si è concentrato soprattutto sui lati negativi che ne richiedono la
trasformazione. È appropriato che io concluda ricordando l'impeto per il
cambiamento che abbiamo visto risultare dagli sviluppi delle pratiche di
ricerca, e forse più clamorosamente dal recente confronto tra geni e progressi
della genomica molecolare. Come sempre, le controspinte che operano per
destabilizzare un dato insieme di termini e concetti emergono da quello che si
potrebbe descrivere semplicemente come l'incontro incessante della scienza
con il mondo reale, dalle inadeguatezze accumulate nel lessico esistente
quando viene confrontato con nuovi esiti sperimentali. E questo, ho sostenuto,
è stato il caso del gene.‖ (Evelyn Fox Keller, pag. 113).
Anziché ―demonizzare‖ questo stato di cose, d’altra parte, Evelyn Fox Keller sembra
pensare che la scienza può contare su una buona dose di ―potere autocorrettivo”;
almeno tutte le volte che alla ricerca degli esperti si accompagna il tipo di
consapevolezza che deriva dalla presenza di un pubblico bene informato sul lavoro
degli esperti.
Piuttosto che sulla denuncia, dunque, Evelyn Fox Keller sembra insistere sul fatto che i
cambiamenti da lei auspicati nel modo di concepire i geni e la genetica saranno
presto o tardi imposti dai risultati delle ricerche di laboratorio e dalla
consapevolezza che gli esperti e il pubblico matureranno a proposito degli usi e degli
abusi del “parlare di geni”, attraverso riflessioni come quelle condotte nel suo libro.
Il libro si chiude infatti con queste affermazioni improntate – ci sembra – a un ottimismo
―vigile‖:
―Da quale parte mi schiero dovrebbe essere ormai chiaro; i geni hanno
conosciuto nel secolo scorso un'avanzata trionfale e hanno ispirato progressi
impareggiabili e strabilianti nella conoscenza dei sistemi viventi. Ci hanno
portati sull'orlo di una nuova era della biologia, che promette progressi ancora
più strabilianti.
Ma questi progressi stessi avranno bisogno dell'introduzione di altri concetti,
altri termini e altri modi di pensare l'organizzazione biologica, e inevitabilmente
allenteranno la presa pluridecennale dei geni sull'immaginario dei biologi.
Spero che tali nuovi concetti e modi di pensare operino presto per allentare
la presa ancora più potente che i geni hanno avuto di recente
sull'immaginario collettivo. Se … il termine gene è davvero diventato
d'intralcio per la conoscenza della biologia, lo è diventato forse ancora di
più per la comprensione del lettore comune, fuorviandolo più spesso di
quanto lo informi.
Di conseguenza, le speranze e le ansie popolari sono spesso rivolte al
bersaglio sbagliato [nei confronti per esempio dell’”ingegneria genetica” o dei
cibi geneticamente modificati ecc.], e diventano controproducenti per una
discussione efficace sui provvedimenti pubblici anche quando sono in ballo
questioni reali e urgenti.
Nei momenti di massimo ottimismo posso perfino immaginare la
possibilità che nuovi concetti aprano un campo produttivo in cui scienziati e
non addetti ai lavori possano pensare e agire di concerto per sviluppare
misure che siano al contempo politicamente e scientificamente realistiche‖.
(Evelyn Fox Keller, pag.116)
Da quando il libro di Evelyn Fox Keller è stato pubblicato (2000 nell’edizione
americana) ha attirato consensi e critiche tra i biologi e tra coloro che sono interessati a
comprendere gli sviluppi recenti della biologia e le loro implicazioni sociali.
In mezzo a critiche e ripensamenti, stimolati in parte proprio da questo libro, sembra farsi
strada negli ultimi anni anche tra i biologi la convinzione che - per usare uno slogan
efficace – “non siamo fatti di soli geni”.
E questa, in un certo senso, potrebbe essere la conclusione principale di questo corso.
Ma forse è ancora più importante, per concludere, richiamare l’attenzione
sull’interazione di punti di vista diversi che è sempre in atto tra gli scienziati, a
differenza dell’immagine che ci danno della scienza i manuali che abbiamo studiato a
scuola e spesso, purtroppo, anche la divulgazione scientifica.
Per osservare all’opera questa interazione di punti di vista diversi nella scienza che si
fa (a differenza della scienza ―compiuta‖, come viene presentata dai manuali e da certa
divulgazione) può essere utile leggere una delle recensioni critiche più importanti del
libro della Fox Keller. E’ stata scritta da John Maynard Smith (1920-2004), uno dei
maggiori protagonisti del ―secolo del gene‖ discusso da Evelyn Fox Keller nel suo libro,
ed è riprodotta qui di seguito.
Consenso e dissenso si mescolano in questa recensione che dà un’idea molto concreta
di come punti di vista diversi, spesso legati alle diverse generazioni di appartenenza,
interagiscono in una comunità di esperti che si interroga sui problemi fondamentali della
disciplina.
La recensione ci aiuta a capire anche potenzialità e limiti di quel carattere
autocorrettivo della scienza in cui sembrano credere tanto Evelyn Fox Keller che il suo
critico John Maynard Smith.
Un’ultima riflessione con riferimento a quello che abbiamo chiamato qualche volta il
“secondo obiettivo” del corso e cioè l’importanza che il pubblico dei non esperti (come
noi) si tenga informato sulla ricerca scientifica in corso:
Il confronto di idee tra biologi di cui stiamo parlando è stato affidato da Evelyn Fox
Keller a un libro rivolto a un pubblico vasto, e da John Maynard Smith a una recensione
scritta per una ―rivista di cultura‖ rivolta ai non esperti (la New York Review of Books,
vedi sotto). A quanto pare, se scrivono libri e recensioni come queste rivolte a un
pubblico generico, gli scienziati e gli esperti hanno bisogno di coinvolgerci nella loro
impresa, almeno quanto noi abbiamo bisogno di capirla.
Le conseguenze dell’impresa scientifica, in ogni caso, sono troppo importanti e diffuse su
scala planetaria per essere lasciate al solo giudizio degli eperti. Su questo punto, in
definitiva, sembrano d’accordo anche gli esperti: ricordate la frase di Richard Feynman
che abbiamo proposto come motto di questo corso? Diceva così:
“Dalla scienza dovete imparare che si deve dubitare degli esperti.
In effetti si potrebbe dire che scienza è credere nell’ignoranza degli esperti.”
______________
La recensione del libro di Evelyn Fox Keller che segue è tratta dalla New York Review of
Books, nella traduzione italiana apparsa su La rivista dei libri nell’aprile del 2001. Per
informazioni sull’autore, John Maynard Smith, si può vedere l’enciclopedia online Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Smith.
Il DNA dello Stregatto
di JOHN MAYNARD SMITH
Recensione di:
EVELYN FOX KELLER, The Century of the Gene
Cambridge, Harvard University Press, 2000
1.
Nel 1900, tre biologi riscoprirono separatamente le leggi di Mendel, secondo cui le caratteristiche
degli organismi sono determinate da unità ereditarie presenti singolarmente in gameti, spermatozoi e
uova, e quindi in forma duplice nell'uovo fecondato. Esse varavano di fatto la teoria atomistica
dell'ereditarietà. Il termine "genetica" fu introdotto da William Bateson nel 1906 e la parola gene,
con riferimento alle unità ereditarie, da Wilhelm Johannsen nel 1909. Nel 1930, attraverso gli studi
sulla Drosophila, il moscerino della frutta, Thomas Hunt Morgan e i suoi colleghi dimostravano che
i geni sono disposti in ordine lineare lungo i cromosomi.
Nel 1953, James Watson e Francis Crick disvelavano la struttura del DNA, la materia di cui il gene è
composto, ipotizzando di qui la presenza di un dispositivo che ai geni consentisse di trasmettere
informazioni genetiche e di moltiplicarsi. Altre scoperte seguivano quindi in rapida successione: i
geni producono i propri effetti determinando la sequenza di aminoacidi nelle proteine; per tale
operazione essi si servono di un "codice" di specificazione aminoacidica attraverso un terzetto di
basi nel DNA; esiste un processo per mezzo del quale i geni regolano reciprocamente la propria
attività. Negli ultimi vent'anni le nostre conoscenze sul ruolo svolto dai geni nello sviluppo di
animali e piante si sono immensamente accresciute. A metà febbraio [del 2001]sono state pubblicate
le prime sequenze complete del genoma umano.
Alla base del libro di Evelyn Fox Keller vi è la celebrazione e la critica di questa storia. Docente di
storia e filosofia della scienza all'MIT, Keller accoglie con entusiasmo i nuovi lumi gettati sulla
natura della vita e allo stesso tempo ne attacca le (a suo dire) ipersemplificazioni. Più oltre, in questo
articolo, discuterò alcune sue conclusioni; dovrò pertanto cominciare sottolineando gli indiscutibili
requisiti che l'autorizzano a formularle. Keller ha una conoscenza mirabile delle recenti ricerche di
genetica molecolare — indubbiamente più estese e particolareggiate delle mie — e sulla storia della
genetica molto ha letto. Mi ha fatto enorme piacere ritrovare nelle sue pagine il nome di biologi che
esercitarono un'influenza su di me all'inizio della mia carriera di ricercatore, ma il cui lavoro credevo
ormai dimenticato. Tanto sulla storia che sullo stato attuale della disciplina l'autrice ha poi avuto
modo di riflettere accuratamente. Le nostre divergenze non sono di quelle derivanti da esperimenti o
osservazioni specifiche; riguardano invece una prospettiva differente sulla strategia migliore da
adottare di fronte alle complessità degli organismi viventi. Lo so che il mondo è complicato, ma io
vado sempre in cerca di spiegazioni semplici della complessità. Per Keller, gli organismi viventi
funzionano soltanto perché complessi; semplificarli significa tagliarne fuori la parte essenziale.
Al libro si può accostare anche chi non abbia competenze di genetica molecolare. Non è tuttavia il
testo che scriverei se volessi rivolgermi a un pubblico di non addetti; nel qual caso, un bel po' di
complicazioni le lascerei fuori. Possibilità ovviamente esclusa da Keller, per la quale le
complicazioni sono l'essenza stessa del problema. La lettura del libro, pertanto, può richiedere qua e
là un notevole impegno, ma ne vale la pena. È lodevolmente breve, ma se lo si capisce, molto si sarà
imparato sulla biologia contemporanea.
Vengo quindi alla natura del mio disaccordo. Per farlo parleremo di moltiplicazione dei geni. Facevo
notare sopra come la struttura del DNA proposta da Watson e Crick ne lasciasse già intendere le
possibili modalità. Il loro articolo si chiude con una celeberrima frase: «Non è sfuggito alla nostra
attenzione che lo specifico accoppiamento da noi postulato suggerisce immediatamente un possibile
meccanismo riproduttivo del materiale geneticoª. Come risaputo, essi hanno dimostrato che il DNA
consiste di due filamenti complementari, ciascuno dei quali costituito da una stringa di quattro
diversi elementi chimici, o basi: adenina, citosina, guanina e timina (in breve A, C, G, T). Nell'elica
a filamento doppio, la C di un filamento è sempre abbinata alla G dell'altro, e lo stesso vale per A e
T. Tale struttura suggerisce allo stesso tempo un meccanismo di moltiplicazione. I due filamenti si
separano, e ciascuno di essi funge da modello nella sintesi di un nuovo filamento complementare. La
sequenza, e quindi l'informazione, è preservata dall'accoppiamento delle basi complementari. Per
ragioni di affinità chimica, C si abbina con G, e A con T. A farla breve, questo è quanto.
Purtroppo, la vita vera è più complicata. Se le cose fossero solo questione di affinità chimica — C
per G, e A per T — una base "erronea" ci scapperebbe spesso; la frequenza di errore sarebbe
perlomeno di uno su cento. Un genoma esteso, diciamo con un miliardo di basi, non avrebbe
pertanto alcuna possibilità di moltiplicarsi; gli errori si accumulerebbero a un tasso vertiginoso. In
pratica, il processo viene eseguito dagli enzimi, vale a dire da proteine in grado di compiere reazioni
chimiche con maggior rapidità e precisione. Ma le cose sono ancora più complesse. Dopo il primo
abbinamento a mediazione enzimatica, la frequenza di errore resta di uno su mille. Vi sono allora
due ulteriori stadi di verifica e di correzione, opportunamente chiamati proof-reading e mismatchrepair (letteralmente: "correzione di bozze" e "riparazione abbinamenti errati").
Tale processo trifasico è dettagliatamente illustrato da Keller, la quale sottolinea l'assurdità del
concetto di "autoriproduzione" del DNA. Esso si riproduce infatti grazie a tutto un manipolo di
enzimi. Ma se in assenza di enzimi il DNA non è in grado di riprodursi, è ugualmente vero che senza
il DNA, o senza l'intero meccanismo della sintesi proteica che col DNA ha inizio, gli enzimi non
esisterebbero. Pertanto l'ereditarietà, che comporta la generazione del simile dal simile, non dipende
unicamente dall'abbinamento complementare delle basi, ma da un complesso sistema dinamico che
coinvolge sia il DNA sia le proteine. In tale contesto Keller elogia un'osservazione di Max Delbrück,
ex fisico e pioniere della biologia molecolare. Questi fece notare come un sistema di reazioni
chimiche incrociate e inibenti potesse condurre non solo a uno, ma a molteplici stati stazionari.
Lo stesso Delbrück non considerava questo modello dei "molteplici assetti stazionari" alla stregua di
una spiegazione globale dell'ereditarietà, ma piuttosto come una spiegazione dell'"ereditarietà
cellulare", ovvero del fatto che le cellule di un certo tipo — come fibroblasti e linfociti — danno
origine, all'atto di scindersi, ad altre cellule di tipo analogo. La posizione di Keller non mi è del tutto
chiara. Le sue propensioni, a ogni modo, vanno all'idea di un'ereditarietà che dipenda non solo dalla
riproduzione dei geni, ma anche dalla stabilità dei sistemi dinamici. Trattando delle origini della vita,
sulle orme del fisico Freeman Dyson, ella sottolinea il possibile ruolo decisivo assolto dai sistemi
metabolici autonomi (self-maintaining), mancanti inizialmente di molecole in grado di riprodursi.
L'idea che i sistemi dinamici stabili rivestano una parte di rilievo nell'ereditarietà ricorre spesso;
ricordo che da studente ne rimasi sconcertato. Perché l'evoluzione sia possibile, c'è bisogno di un
sistema ereditario che permetta la costante riproduzione di un numero infinitamente vasto di strutture
differenti; e non credo che un sistema dipendente dagli assetti stazionari alternativi di un sistema
dinamico potrebbe consentirlo. Dalle attuali conoscenze sulla riproduzione del DNA ricaverei
personalmente tutt'altra morale. È ciò che Francis Crick notoriamente definì «il dogma
centrale della biologia molecolare» — vale a dire che le informazioni possono passare da acido
nucleico (DNA e RNA) ad acido nucleico, e da acido nucleico a proteine, ma non da proteine ad
acido nucleico. E intendeva questo. Se, in una generazione di cellule riproduttive, un solo nucleotide
— cioè un singolo componente dell'acido nucleico — di una molecola di DNA si modifica, tale
alterazione sarà trasmessa al DNA delle generazioni future ed è passibile di mutare un aminoacido
all'interno di una proteina; viceversa, l'alterazione di un aminoacido, se anche avesse conseguenze
sulla riproduzione del DNA, non darebbe luogo a nuove generazioni di proteine col medesimo
aminoacido modificato. I mutamenti sono ereditari nel DNA, ma non nelle proteine (e più
esattamente nella loro sequenza aminoacidica). Benché a riguardo Crick parli di "dogma", la
cosa appare quanto mai vera, forse la sola autentica verità universale condivisa da noi biologi.
Ciò spiega perché i genetisti prendano sul serio il DNA. La sua importanza per l'evoluzione è
evidente.
Una cosa, comunque, è chiara. L'attuale processo di riproduzione del DNA è decisamente troppo
complesso per essere stato una caratteristica delle prime creature viventi. Com'erano dunque fatte? E
più in particolare, come siamo arrivati alla generazione del simile dal simile? Senza tale trasmissione
ereditaria, non si darebbe alcuna evoluzione. Keller preferisce l'ipotesi di Freeman Dyson secondo
cui la vita ebbe origine attraverso una simbiosi tra un sistema metabolico autonomo con proteine e
una popolazione di molecole a riproduzione caotica, probabilmente acidi nucleici. Personalmente,
preferisco l'idea che le prime cose dotate di vita — vale a dire le prime entità con assetto ereditario, e
quindi in grado di evolversi — fossero molecole, forse di RNA (simili a quelle del DNA ma a
filamento unico), che fungevano sia da riproduttori caotici che da enzimi primordiali; l'ipotesi si
trova avvalorata dal fatto che catalizzatori di RNA, analoghi agli enzimi, sono presenti negli
organismi attuali. Alla possibile evoluzione di questo sistema primitivo in un sistema a base di DNA
e proteine, io e il mio collega Eörs Szathmáry abbiamo dedicato uno studio.1 Si tratta
inevitabilmente di congetture, ma che ritengo tuttavia più assennate rispetto a un sistema ereditario
fondato su assetti stabili alternativi di un sistema dinamico.
La sostanziale differenza fra Keller e il sottoscritto è il valore assoluto da lei accordato alla
complessità dinamica. Per me, viceversa, l'idea cruciale è quella suggerita per la prima volta
dalla struttura del DNA di Watson e Crick — vale a dire che l'ereditarietà dipende
dall'affinità chimica tra G e C e tra A e T. Osservava Leslie Orgel che nell'esercizio di risalire alle
origini della vita, i caratteri vanno perduti uno a uno, fino a ritrovarsi con un abbinamento di basi
omologhe, come il sorriso sul volto dello Stregatto.
Un altro punto su cui Keller, a mio avviso, complica inutilmente le cose riguarda
l'interrogativo: che cosa fanno i geni? La risposta semplice, prefigurata dalla locuzione "un
gene, un enzima" proposta da Beadle e Tatum nel 1941, è che un gene traccia il codice di una
proteina. Attraverso un ormai assodato meccanismo, differenti terzetti di basi nel DNA
specificano differenti aminoacidi. Il DNA che trasmette le informazioni contiene altresì
sequenze che significano "cominciare a convertire qui" e "fine della proteina". Purtroppo (per
me ma non per Keller) vi sono molte complicazioni. In questa sede posso prenderne in
considerazione solo due. La prima è che tra i geni veri e propri si trovano ampie distese di DNA che
non vengono convertite in proteine. Una piccola parte di esso ha assolto funzioni regolatrici, ma il
resto no. La maggior parte di noi tende a considerare questo DNA come una sorta di "spazzatura",
ma esso potrebbe ricoprire funzioni che ci sono ignote. La seconda è che i geni codificatori
possiedono delle sequenze intercalanti — dette "introni" — che vengono escisse prima della
conversione della trascrizione del gene in mRNA.
È ovvio che di tali complicazioni debba essere consapevole chiunque lavori con l'acido
desossiribonucleico. Non mancano affascinanti interrogativi anche sulle cause originarie della
presenza di questo DNA in eccesso. Ma in pratica, nella sequenza del genoma di organismi semplici
come il moscerino della frutta o il verme nematode, è possibile identificare la maggior parte dei
"geni" codificatori delle proteine, e dedurre di qui la sequenza aminoacidica delle proteine cui il
codice si riferisce. Più difficile è identificare tutti i geni codificatori di proteine nel genoma umano a
causa della ben più vasta proporzione di DNA privo di funzione codificante. La maggioranza dei
biologi ammette per altro che la parte di genoma umano che conta consiste prevalentemente di geni
codificatori. Pure, Keller individua una difficoltà nel definire sul piano funzionale il gene come
un tratto di DNA incaricato del codice proteico. Capirei la difficoltà qualora si volesse far
assurgere tale definizione a dettato filosofico valido per tutti i geni (ne esistono infatti alcuni che
tracciano il codice di molecole funzionali di RNA —functional RNA molecules — e non di proteine),
ma mi pare che i biologi non debbano darsene troppa pena. E a leggere le osservazioni di Keller,
nell'ultimo capitolo, sulle abitudini lessicali dei biologi, penso sia d'accordo anche lei.
2.
Mi trovo in sintonia con gran parte dei rilievi di Keller sullo sviluppo. Il problema classico, che
risale perlomeno a August Weismann, è il seguente: com'è accaduto che le cellule di parti diverse del
corpo di un animale sono differenti fra loro? Weismann pensava che differenti geni — che lui
chiamava "id" — fossero destinati a differenti cellule, cosicché le cellule, diciamo, del fegato
ricevessero soltanto i geni necessari al fegato. Oggi invece sappiamo che, per costituzionale
caratteristica, tutte le cellule ricevono l'assortimento completo dei geni, ma nelle varie cellule sono
attivi geni diversi in tempi diversi. Come si verifica ciò? Keller illustra il passo cruciale in vista di
una risposta, contenuto in uno studio pubblicato nel 1961 da due biologi francesi, François Jacob e
Jacques Monod. Essi scoprirono di fatto l'esistenza di geni "regolatori", responsabili di secernere una
proteina che agisce da interruttore nei confronti di un secondo tipo di gene, legandosi a una specifica
sequenza di DNA che, stando ai due ricercatori, è prossima al gene regolato. Il loro studio verteva su
un batterio, ma è oggi risaputo che in animali e piante l'attività di ogni gene "funzionale" subisce
l'influenza, positiva o negativa, di vari geni regolatori.
Questa scoperta, in analogia coi programmi di computer, destinata da allora a grande fortuna,
indusse Jacob e Monod a parlare di programma genetico. Keller non ha niente da ridire sull'analogia
tra regolazione dello sviluppo e programma informatico, ma critica la locuzione "programma
genetico" in quanto ben più che i soli geni sono coinvolti nel processo (a esempio le proteine
regolatrici, chiamate in causa nei messaggi inviati da una cellula all'altra). Per quanto mi riguarda,
temo che l'espressione possa comunicare un'idea del processo molto più semplice di quel che non
sia. I programmi che scrivo consistono in una sequenza lineare di istruzioni con un inizio e una fine;
nello sviluppo molti messaggi interagenti sono trasmessi simultaneamente. Oggi gli ultimi ritrovati
in fatto di programmi informatici si avvicinano sempre più alla complessità dei programmi evolutivi,
il che rende forse antiquata la mia preoccupazione.
Un secondo problema che mi dà da pensare da cinquant'anni, e che certo occupa anche Keller, è
quello della geometria. Com'è che i geni giusti si accendono e spengono nei posti giusti? In qualche
caso abbiamo la risposta. Nell'uovo del moscerino della frutta, a esempio, la concentrazione di una
proteina detta "bicoid" è regolata da un gradiente. Questo entra in azione quando l'uovo è ancora
nell'ovaia, poiché la femmina introduce a un polo dell'uovo la molecola di RNA col codice "bicoid".
I gradienti più adatti in un'ottica evolutiva si presentano per la maggior parte durante lo sviluppo. Ho
scelto per altro l'esempio del "bicoid", perché bene illustra un punto che Keller tiene molto a
sottolineare: in un uovo c'è molto più che un mucchio di geni. Il variare della concentrazione della
proteina "bicoid" funge allora da segnale di accensione per diversi geni situati lungo l'asse anteroposteriore dell'uovo.
La creazione di un siffatto gradiente di concentrazione per propagazione è un processo dinamico
piuttosto semplice. Ce ne possono essere di più interessanti. È difficile guardare una zebra senza
pensare che le strisce rappresentino la reazione a un'onda stazionaria, cioè a una serie regolare di
picchi e ventri di concentrazione di una qualche sostanza chimica; è assurdo credere che ogni striscia
sia originata dall'attivazione di un gene diverso, e ancor più assurdo ritenere che il medesimo gene
risponda positivamente a molte concentrazioni diverse della stessa sostanza scatenante e
negativamente a tutti i valori intermedi. Si dà il caso che l'idea che un processo dinamico potesse
generare un'onda stazionaria venisse suggerita quasi mezzo secolo fa da un matematico, Alan
Turing.
Nocciolo di tutta la faccenda è che, nel corso dello sviluppo, i geni vengono accesi o spenti da altri
geni, così che geni diversi risultano attivi in diverse parti del corpo. Ciò richiede la diffusione di
proteine regolatrici, e di più complessi processi dinamici, di cui Keller pone in rilievo la
straordinaria efficienza. A dispetto di eventi fortuiti e di fluttuazioni ambientali, l'esito finale dello
sviluppo in membri diversi di una data specie è rimarchevolmente uniforme. Com'è possibile? La
spiegazione, osserva Keller, può risiedere in parte nella sovrabbondanza di molti geni regolatori. Il
fatto è venuto alla luce in modo alquanto inopinato. Un genetista evolutivo si imbatterà
ripetutamente in un gene di topo la cui struttura allude a un possibile suo ruolo nello sviluppo. Con
l'ausilio delle tecniche moderne, il gene può essere "eliminato" o reso inattivo. Ma sul topo, con
frustrazione dello scienziato, spesso non risulta alcuna conseguenza.
Ciò suggerisce l'ipotesi della ridondanza — cioè che svariati geni siano disponibili per svolgere lo
stesso lavoro. In ingegneria questo avrebbe perfettamente senso: un componente essenziale deve
sempre avere un ricambio in caso di guasto. Ma applicare l'immagine in biologia cozza contro una
difficoltà. Un gene schiettamente sovrannumerario ha ben poche probabilità di essere "prescelto"
quale componente del processo di selezione naturale; vale a dire che il suo esserci riguarderebbe
soltanto la sopravvivenza del suo possessore nel raro caso di inattività del "collega". È tutt'altro che
facile pertanto immaginare come un processo di selezione naturale possa preservare il gene
ridondante da una continua minaccia di mutazione. Penso che la difficoltà possa essere aggirata, ma
nell'ipotizzare la presenza di geni sovrabbondanti è comunque il caso di essere cauti.
Sarà ormai chiaro che il controllo dello sviluppo è qualcosa di molto complicato. Per dirla con
Sidney Brenner, biologo a Cambridge, «la risposta vera dev'essere sicuramente nel dettaglio». C'è
comunque motivo di sperare che i dettagli, per quanto numerosi, siano comprensibili. Gli organismi
che vediamo sono il prodotto di una selezione naturale. Molto spesso, l'adattamento evolutivo
richiede che un organo muti mentre un altro rimane inalterato o muta in una direzione diversa.
L'evoluzione dell'uomo, a esempio, ha richiesto la mutazione indipendente di braccia e gambe. La
selezione naturale, pertanto, prediligerà spesso geni che agiscono a livello locale. Il risultato sarà un
programma evolutivo di tipo modulare: a ciascun organo i suoi geni specifici. Risulta dunque,
nell'evoluzione dei vertebrati in particolare, che i geni regolatori siano stati duplicati e che le due
copie abbiano in seguito acquisito funzioni diverse.
Keller accosta i programmi evolutivi all'opera di varie équipe di scienziati informatici occupati
nell'elaborazione di programmi "robusti", la cui affidabilità di prestazioni prescinda dal loro essere
composti di componenti inaffidabili, non uniformemente collegati. Non ho le competenze per
valutare questa analogia — i miei programmi saltano in aria se solo metto una virgola al posto di un
punto. Ma dalla crescente cooperazione tra biologi e scienziati del computer ricavo comunque buoni
auspici.
E tra gli esiti di questa cooperazione ve n'è uno, non affrontato da Keller, che mi ha sempre
affascinato molto. Gli studiosi dell'informatica cercano di venire a capo di ardui problemi di
controllo attraverso un processo analogo alla selezione naturale. Un insieme di programmi per
risolvere un problema specifico può evolversi attraverso la "mutazione" (alterazioni fortuite del
programma), la "ricombinazione" (assemblando insieme i pezzi dei programmi migliori,
analogamente al sesso) e la "selezione" di quei programmi che garantiscano le soluzioni migliori,
quali genitori della generazione successiva. Mi gingillai con quest'idea per la prima volta nel 1944
mettendo a punto — a mano — un programma per il Fox and Geese, un semplice gioco da tavolo.
All'incirca nello stesso periodo Donald Michie, che doveva diventare in seguito mio amico e collega,
creò un programma per giocare a tris, con risultati migliori dei miei (ma il suo gioco era più
semplice). Molta strada è stata fatta, da allora. Ma credo che sia ancora troppo presto per dire se un
tale approccio, fondato sulla selezione tra algoritmi genetici antagonisti, si rivelerà più efficace di
altri metodi risolutori. Sarebbe bello, poi, se gli scienziati informatici potessero dire a noi biologi
qualcosa di nuovo sulla natura degli algoritmi ad alto rendimento.
Che dire, infine, del genoma umano? Che informazioni può fornire la pubblicazione della sua mappa
completa? All'inizio molto poche, e mi riesce difficile credere che qualche biologo abbia mai
pensato il contrario. La mappa sarà di ardua interpretazione per due semplici ragioni. Prima:
supponiamo di identificare un gene che tracci il codice di una proteina dall'ignota catena
aminoacidica. Al momento, non siamo in grado di dire in che modo tale stringa lineare di aminoacidi
"collasserà" per dar luogo a una struttura tridimensionale, né cosa farà dopo. Non c'è nulla di
misterioso. La maggior parte delle proteine, poste in condizioni adeguate, si attorciglierà per conto
proprio: è una semplice questione di forze chimiche. L'inghippo è che le equazioni per ogni singola
proteina sono troppo numerose per essere risolte. Noi non possiamo far altro che pronosticare il tipo
di assetto di una sequenza in base alla sua somiglianza con una sequenza già osservata e di cui
conosciamo la piegatura. C'è poi una seconda, ancor più grave difficoltà. Come ho già avuto modo di
dire, lo sviluppo implica una complessa interazione tra geni regolatori e geni funzionali. Dalla
semplice mappa di un genoma non siamo in grado di inferire chi regola chi, né in che modo. È come
piccarsi di imparare l'ungherese armati di grammatica e dizionario, entrambi scritti in ungherese. Le
informazioni sono tutte lì, ma non siamo in grado di leggerle.
Questo non vuol dire che il genoma umano sia inutile. In esso la ricerca futura avrà uno strumento di
inestimabile valore. Si consideri a esempio la schizofrenia, fenomeno notoriamente di ardua
interpretazione: questa non è causata da mutazioni in un singolo locus e, per la maggior parte dei
pazienti, vi è una concomitanza di cause ambientali e di predisposizioni genetiche. La conoscenza
del completo genoma umano è un prezioso, probabilmente essenziale aiuto per identificare i loci del
gene — sicuramente più d'uno e forse parecchi — in cui le mutazioni possono contribuire a una
predisposizione. Con questi dati, ogni singolo paziente sarà presto in grado di scoprire se siano
presenti delle mutazioni, e di che tipo. E poi? Domanda molto più difficile, almeno per me. Ma se
guardiamo ai passi avanti compiuti negli ultimi cinquant'anni, riesce difficile credere che non si
troverà una soluzione. Il problema, naturalmente, è che ogni risposta a una questione scientifica
coinciderà con un nuovo dilemma etico. La mia opinione — e Keller, credo, sarà d'accordo — è che
il genoma umano, di per sé, non ci dirà nulla (se non che è molto complicato, e questo già lo
sapevamo) ma sarà d'aiuto nelle diverse ricerche settoriali.
Da questo mio articolo risulterà l'ammirazione che nutro per la vastità di conoscenze di Keller e per
la sua abilità nel trasmetterle. Ritengo stimolanti le sue idee, ma le conclusioni mi trovano talora in
disaccordo. Può darsi che la storia si incarichi di appianare alcune di queste divergenze, in buona
sostanza vertenti sul tipo più fecondo di spiegazione scientifica. Io mi considero un riduzionista —
ma per un amico biologo, Lewis Wolpert, non sono che un olista confusionario. Vado in cerca
di modelli semplici del mondo di cui possa comprendere gli effetti. Se per questo deve andar
sacrificato qualche dettaglio, pazienza. Il mio vademecum di teoresi scientifica è
un'osservazione fatta da Pete Richerson e Robert Boyd: «Quando hai sostituito un mondo che
non capisci con il modello di un mondo che non capisci non sei avanzato di un passo». Per
Keller, viceversa, la condotta di un organismo vivente dipende dalla sua complessità:
ignorando quest'ultima, non se ne capirà mai nulla. Se si parte ignorando, o infilando sotto il
tappeto, quelli che si considerano dettagli, si finirà per gettare via il bambino e tenere l'acqua
sporca. Personalmente, ho la sensazione che la scienza richieda entrambi gli approcci. Nel
secolo scorso, i genetisti hanno avuto la tendenza al riduzionismo, sia pur con qualche
eccezione — è il caso di Barbara McClintock e C.H. Waddington. Della voce di Keller, dunque,
abbiamo bisogno.
(Traduzione di Alessio Catania)
JOHN MAYNARD SMITH (1920-2004) era professore emerito di Biologia presso l'Università del
Sussex ed è stato autore, tra l'altro, di Le nuove frontiere della biologia (Laterza, 1988). Insieme con
Eörs Szathmáry ha pubblicato The Major Transition in Evolution (W.H. Freeman, 1997).
______