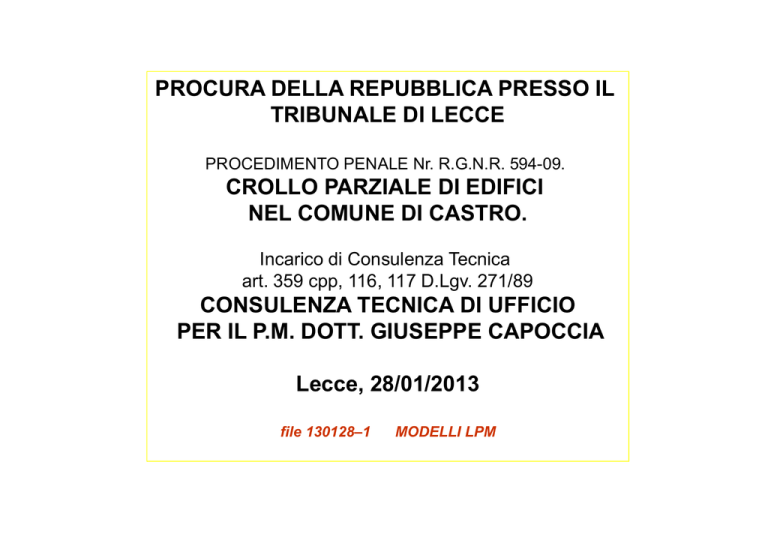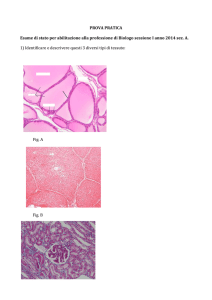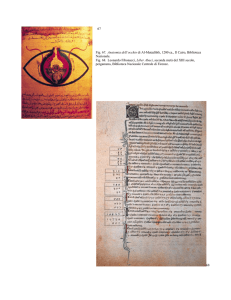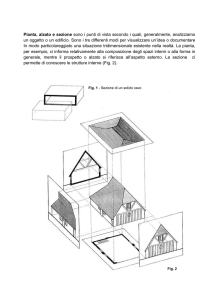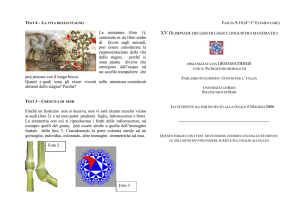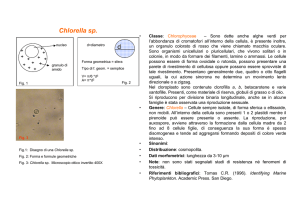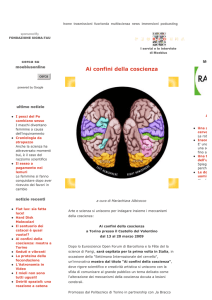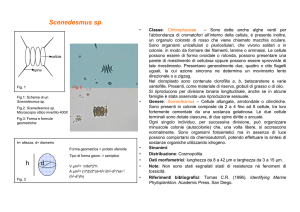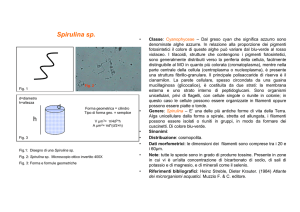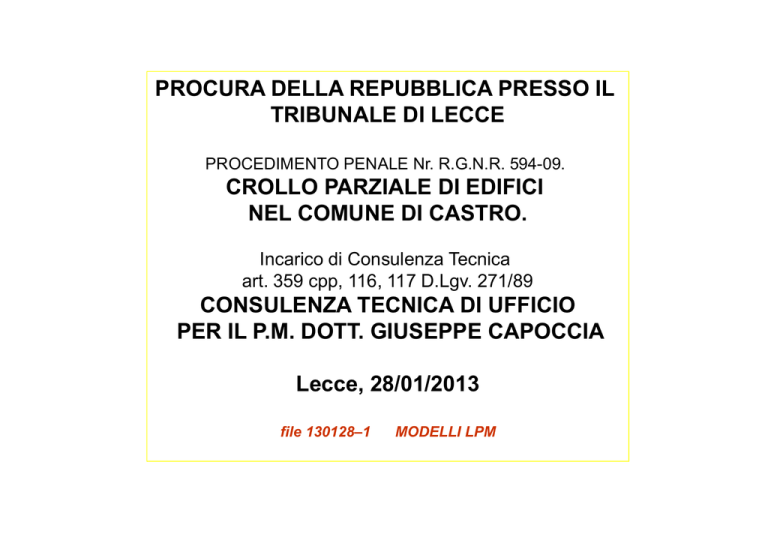
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI LECCE
PROCEDIMENTO PENALE Nr. R.G.N.R. 594-09.
CROLLO PARZIALE DI EDIFICI
NEL COMUNE DI CASTRO.
Incarico di Consulenza Tecnica
art. 359 cpp, 116, 117 D.Lgv. 271/89
CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
PER IL P.M. DOTT. GIUSEPPE CAPOCCIA
Lecce, 28/01/2013
file 130128–1
MODELLI LPM
1.1.6
Caratteristiche prestazionali
2
RICOSTRUZIONE DELL’EVENTO.
SINTOMI PREMONITORI E CINEMATICA DEL CROLLO
Nella originaria condizione di equilibrio (rappresentata con lo
schema A-0 nel par. 6) i carichi all’epoca agenti gravanti sui
locali/grotta (Fersini; Pasticceria; Sport Pesca Mare) (rappresentati
esclusivamente dal peso proprio del banco di calcarenite che ne
costituiva la copertura) disponevano di numerosi percorsi per
raggiungere il terreno di fondazione. Nel par. 6 della presente
relazione, al quale si rimanda, si sono indicati quelli principali, in una
sommaria ma significativa schematizzazione del complesso scenario
del reale comportamento della struttura:
A -1,2 : comportamento trasversale a volta a botte, ad archi multipli;
B – 1 : comportamento longitudinale ad arco rampante;
B - 2: comportamento longitudinale, ad arco;
B – 3: comportamento longitudinale a volta trave;
B – 4: comportamento , longitudinale ad aggetto/sbalzo;
C: comportamento finale longitudinale/trasversale (diagonale) ad
arco/aggetto.
Fig. 1.1.6-1 – Comportamento A-0. La figura rappresenta schematicamente in pianta, con riferimento, a solo
titolo di esempio, alla struttura della Pasticceria, la condizione iniziale nella quale erano attivati sia il
comportamento longitudinale (nel piano verticale ortogonale alla facciata degli edifici), sia il comportamento
trasversale (nel piano perpendicolare al precedente, e pertanto parallelo alla facciata degli edifici). Naturalmente
la realtà era più complessa. Il comportamento risultante potrebbe definirsi “a grotta”: una sorta sistema a volta
“misto”, risultante dalla sovrapposizione dei singoli modelli proposti qui di seguito separatamente proprio al
fine di mettere in luce distintamente quei “percorsi dei carichi” che i differenti interventi dell’uomo[1]
hanno danneggiato, o addirittura eliminato.
Fig. 1.1.6-2 – Comportamento A-1 . E’ il comportamento trasversale rappresentato da un sistema multiplo di
volte a botte con generatrice ad arco più o meno ribassato. Per un riscontro della conformazione ad arco si
vedano anche le figg. 1.1.7-b1) e 1.1.7.5-a2)-29.
Le spinte orizzontali fra volte contigue (lungo le generatrici “interne”: 2 e 3 in figura) risultano fra loro contrapposte
e tendono a farsi equilibrio. Al contrario le spinte orizzontali di estremità (H1 ed H4) dovevano trovare equilibrio la
prima nello sperone di calcarenite di estremità (fig. 1.1.6-7) e la seconda nel corpo dell’edificio contiguo (Speran
Bar). La capacità di equilibrare tale spinta da parte di questo edificio era stata tuttavia compromessa
dall’intervento di demolizione della muratura di confine fra Speran Bar e Fersini: si veda il par. 1.1.7.5-b1).
Fig. 1.1.6-2bis – Comportamento A-2. La figura ripropone il
comportamento della figura precedente tracciato sulla facciata
esterna dell’edificio.
La utilizzazione di locali scavati in grotta entro le pareti che delimitano le ‘lame’
che discendono verso la costa adriatica non è certo un fenomeno raro in Puglia.
Fig. 1.1.7.6-c)-24. Nelle figg. 1.1.7.6-c) 25, 26 e 27 è rappresentata la attuale
situazione.
Fig. 1.1.7.6-c)-24. Nelle figg. 1.1.7.6-c) 25, 26 e 27 è rappresentata la attuale situazione.
Fig. 1.1.6-3 – Comportamento B-1. Molto schematicamente la figura rappresenta un modello di comportamento
ad arco rampante (semiarco), che presuppone la integrità della sezione di vincolo alla parete di calcarenite di
fondo dei locali. Si noti che questo modello non è applicabile al caso del locale Pasticceria: si veda la fig. 1.1.6-7,
che mostra una superficie piana verticale, che fa pensare ad una soluzione di continuità fra masso di copertura
del locale e parete di fondo. Un modello possibile del locale Psticceria è rappresentato nella successiva fig. 1.1.64.
Questo modello di comportamento presuppone una azione spingente sulla facciata (H’), che potrebbe essere
all’origine della espulsione dei portali in c.a., i cui elementi sono stati rinvenuti durale la rimozione delle macerie
(1.1.7.5b e 1.1.1.1). La aliquota H’’ di tale spinta orizzontale ortogonale alla facciata potrebbe essere stata
inizialmente trasferita alla parete di fondo di calcarenite dal masso di copertura, che tuttavia sarebbe stato di
conseguenza sollecitato a trazione. L’eventuale interruzione di tale percorso di trazione potrebbe a sua volta
essere stata all’origine della suddetta espulsione dei portali.
Fig. 1.1.6-4 – Comportamento B-2. La figura mostra una ipotesi di comportamento
longitudinale ad arco ‘completo’ nelle condizioni estreme in cui il contatto del banco di
calcarenite di copertura con la parete di calcarenite di fondo si è perso in tutta la parte
superiore ed è limitato alla sola estremità inferiore. Potrebbe essere un modello
rappresentativo della condizione della copertura del locale Pasticceria. Si noti che il
modello propone il caso in cui il percorso ad arco prosegue senza deviazioni all’interno
del masso verticale di fondo. In questa situazione estrema (che non richiede la presenza
di un tirante inferiore nel banco di copertura), tuttavia, la spinta orizzontale H nel punto B
preme con la massima intensità sulla parete verticale esterna di facciata.
Fig. 1.1.6-5 – Comportamento B-3. Il modello di figura propone un
comportamento spaziale complesso, longitudinale/trasversale. Si notino gli
archi principali ‘disegnati’ sulla superficie cilindrica e gli archi secondari (lungo
le curve direttrici) che portano i carichi sugli archi principali. Il modello si presta
a fornire una interpretazione del comportamento di insieme di ciascun locale
nella configurazione conseguente all’allargamento dei portali sulla facciata. Il
modello schematizza tale configurazione assumendo al limite una
‘concentrazione’ dei flussi verticali nei quattro piedritti verticali.
Fig. 1.1.6-6 – Comportamento B-4. Si
veda la figura successiva. I modelli qui
proposti rappresentano un
comportamento “a sbalzo” caratteristico
di un masso di spessore notevole rispetto
alla luce (arco a sbalzo), e/o di un masso
a strati con giunti orizzontali tipici di una
muratura ad aggetto. Si noti che in
entrambi i modelli è indispensabile una
adeguata resistenza a trazione lungo
itinerari orizzontali. La caduta di blocchi
che, distaccandosi, sagomano il tipico
profilo a gradini, è conseguenza del vano
tentativo degli strati sottostanti di
‘appendersi’ al percorso dell’arco per
raggiungere il vincolo (il banco di roccia
ancora integro).
Fig. 1.1.6-7 e 8 – Comportamento
C . Si noti lo sperone di calcarenite
a sinistra della foto di fig. 7: è
l’unico emerso dopo la rimozione
delle macerie. Insieme alla parete di
fondo del banco di calcarenite ha
rappresentato
presumibilmente
l’estrema risorsa di resistenza del
complesso, non solo resistendo alle
spinte orizzontali (H1 nella fig.
1.1.6-2), ma anche attivando il
modello di comportamento “finale”,
longitudinale/trasversale
di
fig.
1.1.6-8 (modello “C”). Lungo questo
piano obliquo sembra essersi
sviluppato un comportamento ad
arco/aggetto a sbalzo.
1.Cinematica del crollo.
Fig. 2-1 – Il blocco che precipitando ha impresso una
spinta al telaio a confine fra Fersini e Speran Bar ed
ha fatto crollare la volta di copertura in muratura di
quest’ultimo.
Fig. 2-2 – Il blocco che precipitando ha impresso
una spinta al telaio a confine fra Fersini e Speran
Bar ed ha fatto crollare la volta di copertura in
muratura di quest’ultimo