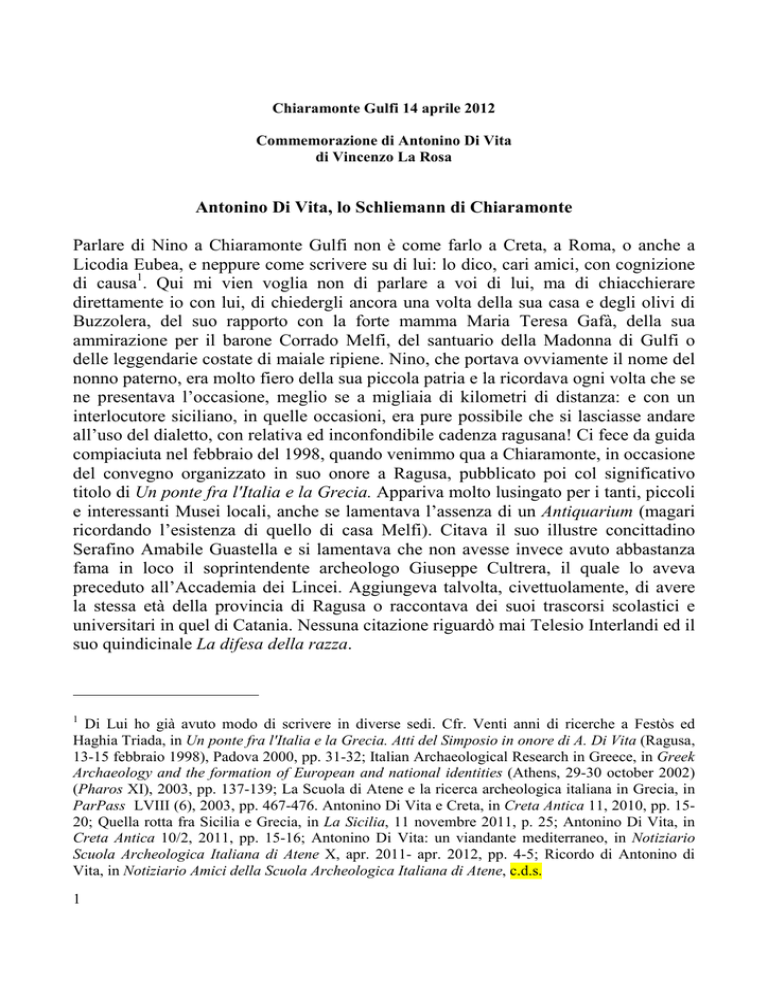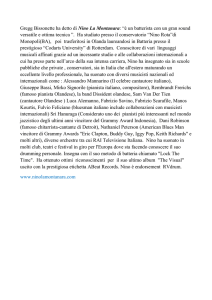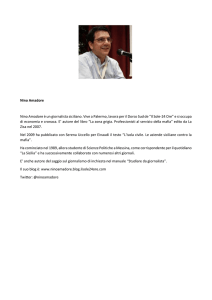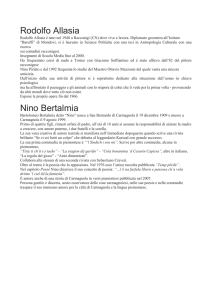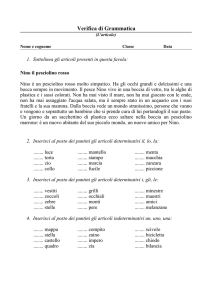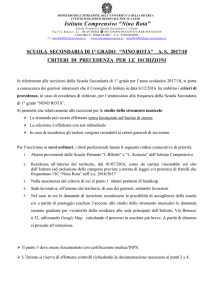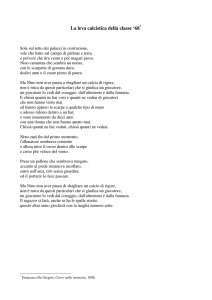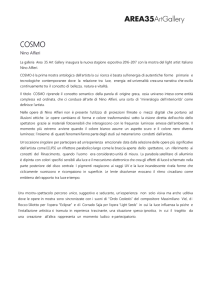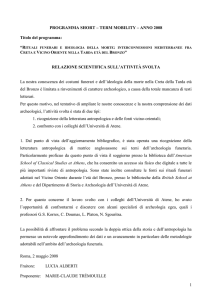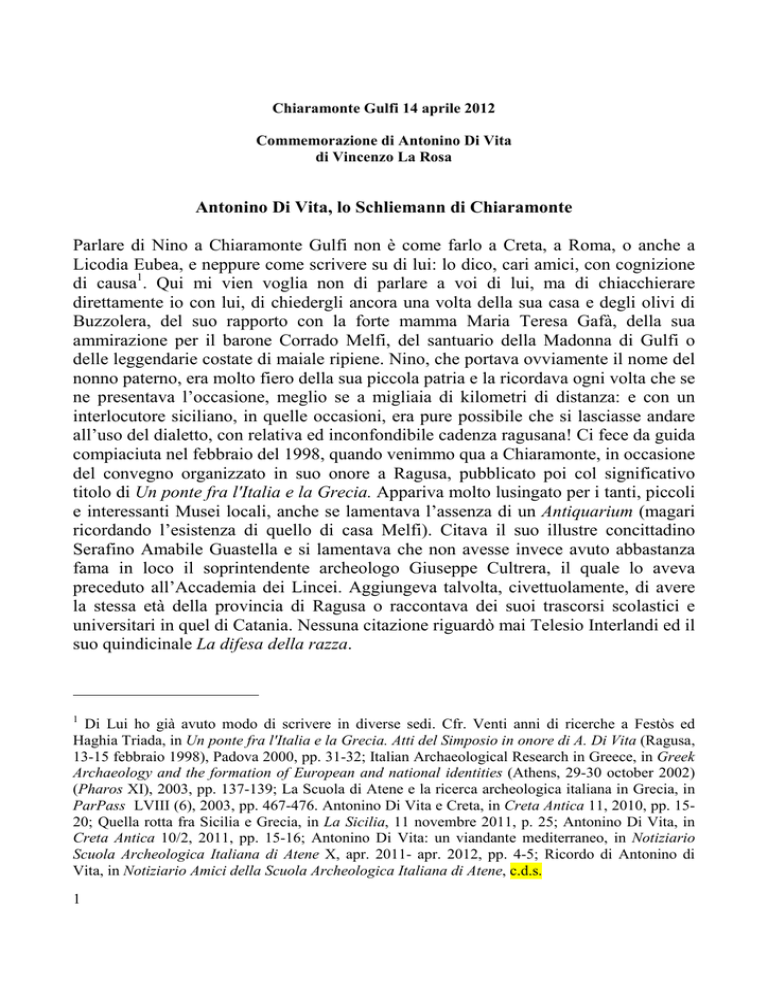
Chiaramonte Gulfi 14 aprile 2012
Commemorazione di Antonino Di Vita
di Vincenzo La Rosa
Antonino Di Vita, lo Schliemann di Chiaramonte
Parlare di Nino a Chiaramonte Gulfi non è come farlo a Creta, a Roma, o anche a
Licodia Eubea, e neppure come scrivere su di lui: lo dico, cari amici, con cognizione
di causa1. Qui mi vien voglia non di parlare a voi di lui, ma di chiacchierare
direttamente io con lui, di chiedergli ancora una volta della sua casa e degli olivi di
Buzzolera, del suo rapporto con la forte mamma Maria Teresa Gafà, della sua
ammirazione per il barone Corrado Melfi, del santuario della Madonna di Gulfi o
delle leggendarie costate di maiale ripiene. Nino, che portava ovviamente il nome del
nonno paterno, era molto fiero della sua piccola patria e la ricordava ogni volta che se
ne presentava l’occasione, meglio se a migliaia di kilometri di distanza: e con un
interlocutore siciliano, in quelle occasioni, era pure possibile che si lasciasse andare
all’uso del dialetto, con relativa ed inconfondibile cadenza ragusana! Ci fece da guida
compiaciuta nel febbraio del 1998, quando venimmo qua a Chiaramonte, in occasione
del convegno organizzato in suo onore a Ragusa, pubblicato poi col significativo
titolo di Un ponte fra l'Italia e la Grecia. Appariva molto lusingato per i tanti, piccoli
e interessanti Musei locali, anche se lamentava l’assenza di un Antiquarium (magari
ricordando l’esistenza di quello di casa Melfi). Citava il suo illustre concittadino
Serafino Amabile Guastella e si lamentava che non avesse invece avuto abbastanza
fama in loco il soprintendente archeologo Giuseppe Cultrera, il quale lo aveva
preceduto all’Accademia dei Lincei. Aggiungeva talvolta, civettuolamente, di avere
la stessa età della provincia di Ragusa o raccontava dei suoi trascorsi scolastici e
universitari in quel di Catania. Nessuna citazione riguardò mai Telesio Interlandi ed il
suo quindicinale La difesa della razza.
1
Di Lui ho già avuto modo di scrivere in diverse sedi. Cfr. Venti anni di ricerche a Festòs ed
Haghia Triada, in Un ponte fra l'Italia e la Grecia. Atti del Simposio in onore di A. Di Vita (Ragusa,
13-15 febbraio 1998), Padova 2000, pp. 31-32; Italian Archaeological Research in Greece, in Greek
Archaeology and the formation of European and national identities (Athens, 29-30 october 2002)
(Pharos XI), 2003, pp. 137-139; La Scuola di Atene e la ricerca archeologica italiana in Grecia, in
ParPass LVIII (6), 2003, pp. 467-476. Antonino Di Vita e Creta, in Creta Antica 11, 2010, pp. 1520; Quella rotta fra Sicilia e Grecia, in La Sicilia, 11 novembre 2011, p. 25; Antonino Di Vita, in
Creta Antica 10/2, 2011, pp. 15-16; Antonino Di Vita: un viandante mediterraneo, in Notiziario
Scuola Archeologica Italiana di Atene X, apr. 2011- apr. 2012, pp. 4-5; Ricordo di Antonino di
Vita, in Notiziario Amici della Scuola Archeologica Italiana di Atene, c.d.s.
1
L’uomo Nino, più che lo scienziato, vorrei insomma proporvi, memore dei quasi sette
lustri di gratificante collaborazione, ivi compresi gli esaltanti anni, fianco a fianco,
del soggiorno ateniese: cercando di dare quanto più possibile a lui la parola,
integrando il discorso con ricordi di vita vissuta. Di quest’opportunità non posso che
ringraziare gli organizzatori dell’incontro odierno.
Io credo che Nino si fosse reso conto abbastanza presto che questo luogo di nascita
era risultato determinante per le scelte della sua vita. Luogo di nascita nel quale,
vivendo la famiglia a Catania, egli trascorreva, con la mamma e i nonni materni (e
poi anche con la sorella Teresa), solo i mesi estivi, da giugno a settembre. E
ricordava ancora che “le capre arrivavano sul piazzale di San Filippo, erano munte là
per là e ti davano il latte appena munto”. Il freudiano mito della ricerca delle origini,
il forte legame con la madre, l’aspirazione a realizzare i sogni infantili (come chiave
per il raggiungimento della felicità), devono aver avuto per lui, come per molti di noi,
un peso determinante. Lascio allo stesso Nino la parola, tratta da uno dei nastri che
egli andava riempiendo per un progetto di autobiografia, nastri che Maria Antonietta
ha amorevolmente sbobinato e trascritto e che in qualche caso egli mi fece il grande
onore di offrirmi come primizia. Non riuscì a rileggere e risistemare tutto, avendo
iniziato dal capitolo più avventuroso e pittoresco, quello delle esperienze libiche. Le
citazioni che vi proporrò, con l’immediatezza del parlato, risultano ancor più toccanti.
L’affermazione più esplicita a proposito di quanto sopra affermato circa il mito delle
origini, riguarda il sito di Scornavacche, di proprietà del nonno materno. “Mio nonno
era un uomo che si occupava attivamente della sua proprietà. Andava da una parte
all’altra -aveva proprietà da Vittoria a Chiaramonte, passando per Comiso e Pedalino.
Erano di una grande famiglia nobile i Gafà, venuti probabilmente a suo tempo dalla
Polonia, perché tutti i miei cugini di secondo nome si chiamavano Stanislao di Dio, e
poi Pietro e Matteo, tutti nomi polacchi. […] Mio nonno aveva trovato una necropoli
greca negli anni ’30. Era molto suggestiva questa proprietà, si chiamava
Scornavacche, dove poi io ho scavato: non ho mai potuto trovare il nome antico,
quindi ancora oggi è conosciuta nella letteratura scientifica con il nome di
Scornavacche. Dalla strada, per arrivarvi, era tutto un bosco di sugheri, con una
sabbia profonda come se fossimo stati nel deserto: e si andava con i carretti a passo
d’uomo perché si sprofondava nella sabbia. Mio nonno aveva disboscato questi
sughereti per farne vigneti (la nostra maggiore produzione d’uva veniva da questa
proprietà, anche se l’uva migliore in assoluto veniva da Vittoria, con la quale si
faceva il vino vecchio). Nello scavare queste fosse per i vigneti aveva trovato una
serie di tombe, delle quali non si era conservato quasi nulla dei materiali perché i
contadini appena trovavano un vaso lo spaccavano per vedere se c’erano monete. Mio
nonno era riuscito a salvare qualche piccolo vaso, una piccola anfora figurata, delle
lekythoi, che erano nella nostra casa di campagna, quella di Lasènia, la casa
principale vicino all’aeroporto di Comiso, una grande casa con immense botti, con i
trappeti, con i cortili, con la sala di ricevimento separata dal resto della casa,
particolarmente lussuosa e mattonata (mentre le altre camere avevano mattoni di
2
pece). Qui si ricevevano gli ospiti senza farli dunque entrare nel resto della casa. […].
Per ritornare agli scavi di mio nonno a Scornavacche, chiedevo sempre notizie degli
oggetti ritrovati quando andavo con lui, e lì mi rimescolavo nella sabbia. Venivano
fuori delle selci, delle piccole terracotte, fra cui anche una matrice in terracotta molto
bella che ho poi regalato al Museo che ho fatto a Ragusa e che ho messo nel
frontespizio del volume sui miei lavori siciliani. Quando chiedevo notizie di queste
‘antichità’ mi rispondevano sempre: «Queste cose le conosce il barone Pace», il
famoso Biagio Pace che aveva le proprietà vicino alle nostre e che era amico dei miei
nonni. Ogni volta il rimando era a questo mitico professor Pace”. Ed il piccolo Nino,
rapito da tali ‘miracolosi’ rinvenimenti, andava da solo a cercare fra la sabbia,
paradossale preludio, se si vuole, alle vastità dei deserti libici della sua maturità. “Il
mio desiderio di diventare archeologo è nato da Scornavacche”. Più esplicito di così,
insomma, è difficile immaginare.
Nino frequenta le scuole dei salesiani a Catania e si sposta con la famiglia a Napoli
(dove il padre impiegato di banca era stato trasferito) dal 1936 al 1941. Rientrando
quindi nella città etnea riesce a completare gli studi al liceo salesiano Don Bosco,
dove il suo professore di Storia dell’arte era un archeologo -dice Nino- che insegnava
all’Università. Confesso, per quanto abbia cercato di documentarmi presso l’Archivio
Storico dell’Ateneo, di non essere riuscito ad individuare il docente. È quindi
verosimile che il rapporto non sia stato con l’Università catanese; gli archivi di quel
Liceo, nonostante la disponibilità del Direttore, non sono stati finora in grado di
soddisfare la nostra curiosità. La pregressa vocazione archeologica del giovane Nino,
in ogni caso, si nutrì di nuova linfa. Dal diploma di maturità apprendiamo di una
specifica eccellenza (valutazione 9/10) sia in Storia che in Storia dell’Arte, ma anche
in Chimica, per non dire dell’Educazione fisica. Meritò otto in Latino e Filosofia e
pure in Cultura militare, e 7 in Italiano e Greco. Al termine degli studi superiori egli
si trovò a dover persuadere i parenti della bontà della sua scelta archeologica.
“Quando espressi questo desiderio nel 1943 -non ho mai fatto gli esami di licenza
liceale perché la città fu bombardata e ad aprile fummo tutti promossi- dovevo
iscrivermi a poco più di sedici anni all’università e nessuno dei miei capiva perché
volessi fare archeologia. Nessuno in famiglia aveva mai fatto l’archeologo. La mia
nonna paterna diceva che la fortuna dei Di Vita l’avevano fatta tre generazioni di
notai, nella famiglia materna non c’era stato mai nessun professore. Si poteva capire
se avessi voluto fare il professore di liceo, ma l’archeologo era una cosa talmente
strana! Ero indeciso: sono andato a pagare le tasse per Giurisprudenza, e all’ultimo
minuto non l’ho fatta; presentai la domanda per Medicina e all’ultimo minuto non
l’ho fatta, perché avevo scoperto che i più asini della mia classe si erano iscritti tutti a
Medicina. E mi sono iscritto a Lettere l’ultimo giorno in cui era possibile iscriversi, e
soltanto per fare archeologia. Con la patetica comprensione di tutto il clan famigliare,
che voleva invece che facessi almeno ingegneria, dato che, come scriveva mio zio
prigioniero degli Americani, nel mondo moderno quello che valeva erano le scienze
tecniche. Immaginarsi come fosse lontana da me l’idea di fare Ingegneria! E anche
3
l’idea di fare il notaio a Licodia, devo dire la verità, non mi attraeva moltissimo. La
mia risposta fu: «visto che ci sono state tre generazioni di notai, io ora posso fare
l’archeologo». Davvero tosto e coraggioso, questo giovane! E dobbiamo forse
aggiungere - ma questa fu una confessione ad personam- che Nino aveva addirittura
voglia di iscriversi a Palermo perché lì insegnava un archeologo piuttosto conosciuto,
Silvio Ferri, che però stava per essere trasferito a Pisa, mentre a Catania non era
ancora rientrato Guido Libertini, andato nel 1939 a dirigere la Scuola di Atene e
passato poi a Budapest, e lì rimasto fino all’8 settembre del 1943, ricominciando poi
ad insegnare nell’ateneo catanese proprio dal 1944-45.
La figura chiamata a sostituire idealmente il nonno, per nobilitare e affinare i bisogni
dell’animo del giovane liceale Nino non può che essere stata il barone Corrado Melfi
di S. Giovanni, suo lontano parente acquisito, il quale aveva scavato in lungo e in
largo nell’agro chiaramontano e dato alle stampe, così come il suo metodo e la sua
cultura glielo consentivano, i risultati di quelle esplorazioni. “Il barone Corrado
Melfi, io l’ho conosciuto -ci dice Nino- altissimo, con grandi favoriti, che si faceva
accompagnare da un servitore nella casa avita di Chiaramonte. Aveva formato
un’importante collezione, aveva scritto molto (tutti i suoi scritti erano conservati da
mio zio Vito Melfi, notaio a Chiaramonte). La collezione era stata poi comprata nel
1920 da Paolo Orsi per il museo di Siracusa, soprattutto perché comprendeva un
vetro bellissimo, intatto della provincia renana, con raffigurazioni di caccia, databile
al IV sec. d.C. La mia tesi (quella di laurea, aggiungiamo noi) consistette
nell’ordinare scientificamente le scoperte del barone Melfi”. A lui Nino dedicherà,
nel 1991, la riedizione dell’appena citata fiasca, trovata dal barone Melfi nella
necropoli del Carbonaro, riedizione realizzata in elegante brochure a cura del
Comune di Chiaramonte Gulfi. “Legami affettivi, organici - scriveva egli in quella
occasione- mi legano a Chiaramonte, al cui lontano passato -Gulfi, Acrille, Akrillaiho dedicato i miei primi lavori di apprendista-archeologo”. E facendo cenno ai
pioneristici lavori di scavo che avevano portato anche alla scoperta del vetro, così
continua: “Scavi eseguiti sul finire del secolo scorso e all’inizio del nostro, non
metodici, eppure in qualche misura ‘disciplinati’, grazie all’interesse costante, attivo,
di un uomo cui Chiaramonte deve se i resti del suo passato non sono andati
completamente dispersi. È il barone Corrado Melfi di S. Giovanni che intendo qui
ricordare e riproporre all’attenzione dei suoi concittadini, vuoi distratti vuoi distanti
nel tempo e negli interessi: senza la pluridecennale opera di raccoglitore attento,
perseguita con tenace passione da questo studioso locale, notevolissimo, fra i non
pochi che la antica Contea di Modica produsse nel secolo scorso, non avremmo avuto
conservato, fra l’altro, lo splendido vetro tardo-antico che qui, grazie agli attuali
reggitori della cosa pubblica chiaramontana, si ripubblica con un nuovo -e questa
volta decente- corredo fotografico”.
La carriera accademica di Nino fu senz’altro brillante, come mi è capitato di accertare
presso l’archivio storico dell’Ateneo catanese. Dei venti esami sostenuti, 13 furono
superati con lode ed i rimanenti con 30/30, con un bel 26/30 anche nella sempre
4
perigliosa prova di latino scritto. Dei suoi docenti universitari solo uno, per esplicita
ammissione dell’interessato, esercitò su di lui un’autentica influenza. Sentiamolo,
dunque: “Il mio incontro fatale a Catania, quando ero studente del II anno, fu quello
con Santo Mazzarino, uno dei più grandi storici che l’Italia abbia mai avuto.
Giovanissimo, circa trenta anni, rientrò a Catania, ed io imparai tutto da lui. Mi
nominò suo assistente volontario, facevo il II anno di università, ma per lui potevo
fare anche il suo assistente. Da lui ho imparato tutto, come si studia, quale è la
ricerca, che dovevo imparare il tedesco se volevo continuare a fare archeologia […].
Sono dunque arrivato all’archeologia dalla storia antica e se ho imparato un metodo,
questo lo devo a Santo Mazzarino, il quale fu naturalmente molto deluso quando dissi
che non avrei continuato a fare storia antica ma volevo fare archeologia”. E bisogna
forse aggiungere che lo studente Di Vita aveva addirittura approntato le dispense
ufficiali al corso del prof. Mazzarino. E questi, incontrandolo parecchi anni dopo a
Roma , gli avrebbe detto: «Se tu avessi fatto storia antica a quest’ora saresti già
professore ordinario. In archeologia è più difficile». “ In effetti era così -chiosa Nino, ma ho fatto la carriera che volevo”.
Ho già potuto ricostruire in dettaglio il cursus studiorum del giovane, compresi i corsi
monografici dei professori più vicini ai suoi interessi, per meglio capire come
possano aver forgiato la sua personalità di studioso: penso ai due corsi Archeologia
(che Nino aveva potuto biennalizzare solo perché aveva scelto la tesi in quella
disciplina) e a quello di Antichità greche e romane tenuti tutti da G. Libertini; ai due
corsi di S. Mazzarino (Storia romana e Storia orientale antica); a quello di Storia
greca di P.E. Arias, allora Soprintendente alle antichità della Calabria, chiamato a
supplire il Libertini che era andato ad Atene e poi a Budapest; e forse anche a quello
di Archeologia cristiana tenuto per incarico dal grande storico dell’Arte medievale e
moderna S. Bottari. Devo purtroppo confessare che al momento l’unica
documentazione mancante è proprio quella relativa ai corsi di Santo Mazzarino!
L’argomento della tesi di laurea lo aveva proposto, con una prassi decisamente poco
accademica, lo stesso candidato al prof. Libertini, non potendo assolutamente
prevedere che un giorno sarebbe toccato proprio a lui ripetere l’exploit della direzione
alla Scuola di Atene e propiziare addirittura la pubblicazione dello scavo di
Pallantion in Arcadia, che Libertini non era stato in grado di realizzare per la brusca
interruzione del suo mandato. Nell’Annuario della Scuola Archeologica Italiana di
Atene del 1990-91, nel quale per un’imprevedibile coincidenza Nino aveva dovuto
contemporaneamente ricordare l’appena scomparso suo predecessore Doro Levi ed il
vecchio maestro catanese, così scriveva. “E non è un caso che proprio in questo
volume in cui ricordo la figura di Doro Levi, abbia voluto inserire il frutto del lavoro
di Guido Libertini a Pallantion, Una maniera per riunire in un simbolico, grato
abbraccio i due miei predecessori nella direzione della Scuola: all’uno, e
all’indimenticabile Santo Mazzarino che mi fu maestro ed ancor più mentore, devo i
primi passi verso l’archeologia nell’Ateneo catanese, all’altro la scoperta
dell’Universo greco”. C’era, se volete, il riassunto di una precisa parabola delle
5
vicende umane e scientifiche di Nino: dalla Sicilia greca dell’infanzia all’Ellademadrepatria della maturità.
Ma torniamo alla scelta dell’argomento della tesi di laurea, Ricerche archeologiche
nel territorio di Chiaramonte Gulfi (che pubblicherà con lo stesso titolo,
opportunamente emendata, nell’Archivio Storico per la Sicilia Orientale del 1953).
“Feci la tesi su Chiaramonte Gulfi, -è ancora Nino che parla- il mio paese, che era il
paese medievale sorto sopra il paese siculo, greco, romano, bizantino che si chiamava
in antico Acrille e che gli Arabi chiamarono poi Gulfi. Il paese medievale fondato da
Manfredi Chiaramonte alla fine del 1200, poi distrutto nella guerra del Vespro, era in
alto; sotto, in basso, c’erano i resti della città antica. Tutti i materiali provenienti dal
sito antico li aveva raccolti e conservati il padre di un mio cugino, il barone Corrado
Melfi di Sangiovanni”.
Queste parole, pronunciate al registratore appena un anno fa ripropongono, in
maniera direi quasi commovente, le due pagine introduttive della tesi di laurea,
anch’essa da me consultata nell’Archivio Catanese. “Il presente studio vuole essere
(esordisce Nino) - e sia lontana da me ogni vana retorica- un atto di devozione e di
affetto verso il mio piccolo borgo natale, Chiaramonte Gulfi”. Citando, fra i suoi figli
più illustri il barone Melfi, S.A. Guastella, il Padre Samuele Nicosia, egli esplicita il
suo progetto di revisione e armonizzazione dei tanti dati procacciati dal Melfi in più
di mezzo secolo di attività, per contribuire alla formazione della carta topografica del
territorio. E così conclude: “Ed ora, in uno con l’augurio che presto torni a rifiorire
nei cuori di questa nostra gente di Sicilia, in un rinnovellato clima di pace, il
sentimento del buono e del bello da cui gli studi dell’antichità -purtroppo sì poco
compresi oggi- non vanno disgiunti, rivolgo il mio deferente pensiero a tutti i
Professori che in questi quattro anni di Università hanno contribuito alla mia
formazione culturale e spirituale e mi hanno avviato alla vita”.
La scelta dell’argomento palesava dunque, in aggiunta alla grossa componente
affettiva (fatta di luoghi e di parenti), un esplicito disegno, che è utile ribadire:
riprendere, cioè, le tante ricerche del barone Melfi, sistematizzarle scientificamente,
confermare, col necessario rigore metodologico, l’identificazione del centro greco nel
territorio chiaramontano. Disegno, ça va sans dire, perfettamente realizzato.
Nino concluderà i suoi studi universitari il 1 luglio del 1947, ancora neanche
ventunenne, con un bel 110, lode e dignità di stampa. La meta successiva, a quel
punto, non poteva che essere la Scuola Nazionale di Archeologia a Roma, l’unico
corso di specializzazione allora attivo in Italia. “Feci il concorso per entrare alla
Scuola di specializzazione di Roma. Non vinsi la borsa di studio, ma fui ammesso e
mi sono ritrovato con dei grandi Maestri, fra cui uno soprattutto, giovane, entusiasta,
favoloso trascinatore, Massimo Pallottino”. Il ben noto fondatore -aggiungiamo-,
della moderna scienza etruscologica in Italia, dotato -secondo Nino- di “una vivacità
di comunicazione straordinaria oltre che di una cultura incredibile”. Otto, allora,
erano gli allievi del I anno ed otto quelli del II.
6
Dei suoi insegnanti alla Scuola di Roma (oltre al citato Massimo Pallottino, Giulio
Quirino Giglioli, Margherita Guarducci, Pietro Romanelli, Pietro Barocelli, Giuseppe
Lugli, Gaspare Oliverio, che era il direttore, ed altri ancora) Nino ci ha lasciato degli
efficaci cammei relativi alla loro indole, al rapporto con gli studenti, alla loro cultura,
al loro modo di intendere la scienza e la vita, notazioni tutte assai utili anche per
discorsi più propriamente storiografici. Vi propongo solo un piccolo esempio, che
oggi diremmo di ‘costume’, concernente una figura titanica della nostra antichistica:
“Un altro insegnamento che a Catania non avevo avuto era Epigrafia greca, tenuto a
Roma da Margherita Guarducci, una donna assai rigida che aborriva gli uomini
(anche se poi prese un assistente maschio) e alla quale le ragazze si presentavano
all’esame senza rossetto, con vesti dalle maniche lunghe”. Tutto assolutamente vero,
come potrebbero testimoniare intere generazioni di specializzandi.
Alla Scuola di Roma il Nostro ha anche il suo primo contatto con l’Africa, seguendo
le lezioni di Archeologia delle province romane, tenute da Pietro Romanelli, il primo
soprintendente in Tripolitania, terra che poi diventerà uno dei luoghi dell’anima di
Nino. Di questa intensa e proficua esperienza romana egli ricordava anche tanti
gustosissimi episodi, che avevano per protagonisti dei suoi colleghi, futuri mostri
sacri dell’archeologia italiana. Quanti hanno avuto il piacere di sentirne qualcuno
dalla sua viva voce sanno della grande facondia di Nino, affabulatore nato, capace di
gesticolare al punto giusto o di infiorare il tutto con eleganza (“arcifantastico” era, in
questi casi, uno dei suoi aggettivi preferiti), insomma di avvincere l’uditorio.
Anni davvero intensi, il 1948 e 1949, per lui, deciso a sfruttare al massimo le
incomparabili occasioni scientifiche offertegli dalle biblioteche e dai Musei di Roma.
Lunghe ore di studio, soprattutto a notte inoltrata, con il rischio sempre in agguato
che il suo compagno di stanza, Sandro Stucchi, disturbato dalla luce, gli rompesse la
lampadina con un bastone. Ma anche con qualche sano svago, per un giovane amante
della vita, estroverso, galante, cosmopolita. Sentiamolo: “A proposito degli amici
stranieri, con i Belgi siamo riusciti ad organizzare in una tavernetta una serata da
ballo, cui partecipò anche Pallottino, che diede prova della sua bravura. I Belgi
avevano una loro accademia ed io ero molto amico del Direttore della Scuola: ogni
sera, dopo le 8, andavo a ballare con loro e tornavo alle 2 di notte attraverso Villa
Borghese, allora frequentabile, dopo aver accompagnato a casa le tre figlie (una era
Nenette) del professor De Vicher”.
E fu proprio il valente ballerino Pallottino -certo non per questa occasionale
performance- che lo fece suo assistente volontario, prima ancora che conseguisse il
diploma. A quel punto, tuttavia, Nino concepì per un momento l’idea di poter
rientrare in Sicilia: il suo vecchio maestro G. Libertini aveva bandito a Catania un
posto di assistente ordinario ed egli pensava di avere le carte in regola per aspirarci.
Agli orali di quella prova concorsuale, per difficoltà di calendario, il Nostro non ebbe
neanche la possibilità di presentarsi: me lo raccontò in dettaglio e senza alcun
rimpianto durante un pomeriggio cretese, visto che io mi trovavo ad operare proprio
in quella sede universitaria, sotto la direzione di colui che aveva poi vinto il concorso.
7
Di lì a poco, nell’aprile del 1950, con l’arrivo in Grecia come allievo della Scuola
Archeologica Italiana di Atene, si sarebbe aperta per Nino una prospettiva rivelatasi
poi decisiva. Con questa nuova esperienza egli contava, fra l’altro, di completare la
sua ricerca per la tesi di specializzazione.
“Il primo ad arrivare ad Atene, via Catania -perché allora c’era una nave italiana del
Loyd di Trieste che faceva Catania, Atene, Cipro, fino ad Alessandria d’Egitto- fui io.
Viaggiai per due giorni; per la prima volta avevo preso una nave dove si ballava
anche (ricordo un ballo, lo spiroù, che si faceva andando su e giù)”. Nino -si è già
capito- aveva una passionaccia per il ballo, e in un’estate cretese lo costringemmo
addirittura ad accennare a questo sconosciutissimo spiroù . “ Il 16 aprile arrivai a
vedere per la prima volta -e fu una cosa incredibile, oggi non più possibile- dal mare
l’acropoli di Atene. Era bellissimo anche vedere il Pireo dalla nave: era come
ripiombare nel V secolo, perché l’impianto del Pireo era esattamente quello che era
stato allora. […] Appena sbarcato finii in uno di quegli immensi taxi americani che
allora circolavano ad Atene. E percorrendo Leoforos Singrou continuava a vedersi
l’acropoli. Non dimenticherò mai quella mattina […]. Così arrivai poco prima delle
mie due compagne e mi ritrovai nella bellissima sede della Scuola, il principesco
palazzo di Leoforos Amalias 58, oggi della Fondazione Onassis. Io ebbi una camera
che guardava da un lato l’Olympieion, e dall’altro lato, dalla terrazza, vedevo
l’acropoli. Era per me un mondo completamente nuovo, meraviglioso, era quello che
avevo sognato per tanti anni”. Leggendo queste frasi di Nino, un brivido ha percorso
la mia schiena: era proprio la mia stessa camera di quindici anni dopo!
Il soggiorno greco fece registrare un grave contrattempo, legato ad un’infezione
intestinale, da lui contratta accettando da un’ospitale famigliola del quartiere della
Plaka, grasse interiora di agnello alla brace. La febbre che ne seguì e la conseguente
spossatezza gli resero amaro il viaggio di istruzione con il Direttore nel Peloponneso,
dove patì addirittura una peritonite. Da Olimpia fu precipitosamente costretto a
rientrare ad Atene e quindi a Catania, dove rimase tutto il mese di agosto e parte di
settembre. “Restai tutto il mese di agosto con il ghiaccio sulla pancia; mi operarono
poi di appendicite, ma la febbre mi tornò perché non si trattava di appendicite ma di
un’infezione intestinale. Per fortuna proprio allora arrivava a Catania l’aureomicina, e
con una settimana di cure ed una di montagna, sono guarito. Così sono tornato in
Grecia, ed ho fatto il resto del giro della Grecia due mesi dopo le mie compagne, che
avevano nel frattempo partecipato allo scavo con Doro Levi a Creta. Io rimasi in
Grecia per recuperare i mesi perduti fino al gennaio-febbraio del 1951”.
In splendida solitudine Nino viene inviato a Rodi, per studiare la scultura ellenistica e
conclude il suo soggiorno greco con un viaggio a Mikonos e a Delo. “Durante tutta la
settimana che sono stato a Delo c’era un vento pazzesco: ho visto Delo accucciato a
terra, prendendo appunti mentre vedevo i monumenti. Il vento era terribile e fu un
vero miracolo che non restassi lì per sempre. Il penultimo giorno del mio soggiorno,
essendosi il vento calmato, uscii a visitare le case. Avevo visto in una di queste case
un capitello molto interessante che volevo fotografare: avanzavo, avanzavo con la
8
macchina in mano e mi sono fermato esattamente sull’orlo di una di quelle cisterne
che stavano sotto gli atri delle case, ma il pavimento era completamente sprofondato
e sparito e la cisterna era piena d’acqua. Acqua che restava ad un paio di metri dal
bordo e dunque se vi fossi caduto dentro non avrei avuto scampo e nessuno mi
avrebbe mai cercato lì. Fu un vero e proprio miracolo se mi fermai proprio ad un
passo dal cadervi dentro”. C’è un ultimo episodio del periodo di alunnato ad Atene
che mi piace ricordare, sapendo quanto Nino ne fosse rimasto coinvolto: una puntata
a Florina, nella Grecia del Nord, per riportare avventurosamente in Italia i resti di un
cugino di suo madre, Tommaso Berretta, un ufficiale caduto durante la guerra italogreca, che da giovane cadetto di carriera gli aveva insegnato a tirare di scherma qui a
Chiaramonte. A quel valoroso tenente, se non mi inganno, è oggi intitolata una strada
di questo Comune.
Nell’estate del 1951 Nino conseguirà il diploma di specializzazione alla Scuola di
Roma con il massimo dei voti e comincerà a chiedersi come e dove trovare il …
posto fisso (diremmo oggi). Pensò di tornare in Sicilia, cercando magari una qualche
assunzione temporanea presso una Soprintendenza, non escludendo forse a priori di
tentare anche un concorso nelle Scuole, dal momento che nel maggio del 1953 chiese
all’Università di Catania un certificato di laurea a questo scopo (magari per tacitare i
suoi). Nel frattempo aveva vinto una borsa di studio per la Francia, dove trascorse
solo due dei nove mesi possibili e riuscì anche ad andare in Inghilterra. Il ritorno
nella nostra isola gli appare a quel punto inevitabile, con un sofferto giro da
elemosinante dinanzi alle tante chiese archeologiche. “Sono sceso a Siracusa, dove ho
trovato come Soprintendente Luigi Bernabò Brea, bravissimo, […], che non mi
amava molto perché nel lontano 1946, quando studiavo proprio nella Biblioteca Orsi
di Siracusa, una volta che ero andato via in gran fretta, non avevo rimesso a posto dei
libri: e questa era stata una mancanza che non aveva mai dimenticato. Mi ricevette
nella sua bellissima casa sul porto grande di Siracusa e mi chiese cosa avessi fatto
come lavoro di diploma. Io molto orgogliosamente dissi che avevo studiato le
sculture di Rodi e Coo di età ellenistica. Mi disse: «Ah, bellissimo, bellissimo, ma sa,
in questa Soprintendenza le sculture di Rodi e Coo non le troveremo mai. Quindi di
lei non ho proprio bisogno». E questo fu il mio primo impatto per la ricerca di un
posto. Allora mi sono recato ad Agrigento: era ancora esattamente come l’aveva
descritta Pirandello: un piccolo centro appollaiato su alte colline, con i magnifici
templi persi nella pianura, con una strada che non era neanche asfaltata. La
Soprintendenza era tutta concentrata in una piccola struttura con un unico grande
camerone. Chiesi del Soprintendente e mi dissero che era ai templi. Sono allora sceso
ai templi ed ho trovato Pietro Griffo, che era stato l’ultimo allievo della Scuola
Archeologica di Atene prima della guerra, con Guido Libertini. Egli mi disse: «Lo
vedi, figlio mio, in che desolazione io vivo. Non c’è un libro, non c’è un uomo, non
c’è niente, ci sono solo questi magnifici templi. Se vuoi venire a darmi una mano
vieni pure, ma sappi che qui non c’è proprio niente». Il che era assolutamente vero.
Dopo essere stato due anni a Roma, uno ad Atene con biblioteche internazionali a
9
disposizione, con centinaia di migliaia di libri, andare ad Agrigento dove non c’era un
libro, non c’era alcuna possibilità di studiare, di pubblicare, mi causò un forte
avvilimento. Per cui ho lasciato il povero Griffo solo nella Soprintendenza e sono
andato a Palermo. La Soprintendente era la signora Iole Bovio Marconi, molto brava,
preistorica, la quale da poco aveva come assistente Vincenzo Tusa, venuto a Palermo
da Bologna. Mi sono rivolto a lei per sapere se c’era qualche possibilità di lavorare.
Mi disse: «Lei ha un ottimo curriculum, ma sa, io scavo a Selinunte, Tusa scava a
Solunto e a lei cosa resta?». Replicai: «Signora Marconi, ma c’è tutta Himera da
scavare!». Aggiunse: «Sì. Ma se scaviamo anche Himera che cosa resta agli
archeologi futuri? Niente». Neanche lei aveva dunque un posto per me. Però mi disse:
«Guardi che c’è il professore Adriani all’Università, il quale ha un assistente che è un
semplice professore di scuola media, niente affatto interessato all’archeologia, e che
va cercando un bravissimo assistente perché vuole tornare ad Alessandria d’Egitto
[…] a finire una serie di lavori»”. Ma Adriani stava in quel momento a Roma, e così
Nino tornò lì da dove era partito. “Adriani quando vide il mio lavoro di diploma, da
grande studioso del mondo ellenistico quale era, mi ha subito preso. Per cui mi sono
ritrovato a dover rinunciare a sette mesi di borsa di studio in Francia ed a prendere
dal 1 novembre servizio a Palermo”.
Il capoluogo siciliano vuol dire insegnamento universitario, per sostituire Adriani, ma
soprattutto saggi di scavo a Selinunte. E mi pare davvero suggestiva l’ipotesi
dell’amico Nicola Bonacasa che gli strati punici di quella colonia possano avere in
qualche modo ispirato le scelte africane di Nino. Il giovanissimo professore si pone il
problema del rapporto fra attività didattica e ricerca sul terreno e si interroga
sull’allora imperante dicotomia fra Archeologia (quella dei Soprintendenti) e storia
dell’arte antica (quella dei professori universitari). “Quando sono entrato nel campo
dell’archeologia, era la storia dell’arte -alla maniera winckelmanniana- che noi
studiavamo, soprattutto scultura. Tutto questo cambiò proprio negli anni in cui io
studiavo a Roma, e negli anni successivi per merito anche di Ranuccio Bianchi
Bandinelli e della Fondazione Gramsci” […]. “Questo cambiamento ha portato nel
corso degli anni ad un eccesso opposto: è giusto che si studino le arti minori, i
prodotti di artigianato, le anfore da trasporto e i materiali di uso quotidiano, ma non si
può tralasciare la storia dell’arte: oggi si pubblicano libri infiniti con migliaia di
frammenti ceramici e si dà meno importanza alla storia dell’arte con le sue grandi
sculture, le grandi produzioni pittoriche, lo studio dei grandi complessi monumentali
come Pompei ed Ercolano. Trovare il giusto equilibrio tra l’una e l’altra cosa è
l’archeologia del futuro. In questa ottica nuova il mio desiderio era quello di
scavare”. Prende forma, dunque, con un’invidiabile lucidità di prospettive,
l’archeologo militante Antonino Di Vita, fine lettore di strati ed episodi, naturalmente
portato a storicizzarne i dati, in contesti sempre più ampi, ma non muore
“l’archeologo di biblioteca” -per usare una sua categoria classificatoria. E sarà
proprio la ricerca di una tale sintesi che, tanti anni dopo, spingerà l’osannato Rettore
dell’Università di Macerata a tornare ad Atene da Direttore, incarico da lui
10
fortemente voluto, con una scelta sulla quale parecchi colleghi allora si interrogarono
a lungo. È lo stesso Nino a fugare ogni dubbio: “La Scuola di Atene mi dava le due
possibilità: da un lato di insegnare storia dell’arte agli allievi, dall’altro praticare con
gli stessi allievi lo scavo nella maniera più attuale e più scientifica possibile […].
Questo significava quindi essere indipendente ed avere a disposizione le due cose
essenziali: gli allievi mi rendevano vivo e giovane perché mi obbligavano ad
aggiornarmi continuamente, e lo scavo mi rendeva felice perché riuscivo a costruire
una serie di tasselli che, come mi aveva insegnato Mazzarino, andavano poi a formare
la storia”.
Ma torniamo al filo conduttore biografico. L’esperienza palermitana si protrasse fino
al 1955, quando Adriani fece ritorno da Alessandria. Nino decise allora che doveva
provare con le Soprintendenze e, avendo il diritto di scegliere la sede come primo
vincitore al concorso di Ispettore, optò per Siracusa, dopo che il suo conterraneo B.
Pace gli aveva sconsigliato di rimanere a Roma e di scegliere invece, per fare
l’archeologo militante, la città aretusea oppure Taranto. Il cuore disse Siracusa e nello
stesso 1955 Nino approdò in una Soprintendenza che aveva competenze territoriali su
mezza Sicilia, fino a Messina e ad Enna. E fu, per lui, una bella rivalsa, al cospetto
del Soprintendente! “Bernabò Brea questa volta non poteva non accogliermi visto che
ero stato il primo al concorso ed avevo diritto a scegliere la sede, ma non fu molto
contento del mio arrivo a Siracusa: mi diede quindi la provincia negletta dagli inizi
del ‘900, quando se ne era occupato Orsi, Ragusa. Ma per me fu molto importante
perché la famiglia di mia madre era di Chiaramonte, un paese della provincia di
Ragusa, famiglia che aveva molte amicizie nella stessa Ragusa. Quando Bernabò mi
disse che non mi avrebbe dato né un soldo né un uomo, io accettai lo stesso perché i
soldi me li sarei procurato da solo a Ragusa. Con i fondi di un cantiere-scuola, nel
1956 aprivo i miei primi scavi a Ragusa nella necropoli di Rito. Di lì aprii poi lo
scavo delle tombe sicule di Castiglione, lo scavo del centro greco di Scornavacche, lo
scavo soprattutto di Camarina. Qui andammo a fare la ricognizione con Giulio
Schmidt sulla base della foto aerea, perché il sito era rimasto completamente
abbandonato dagli anni dell’Orsi, cioè dagli inizi del ‘900”. Lo Schmidt –
aggiungiamo noi- era allora un colonnello (poi un generale) dell’Esercito attivo
presso l’Istituto Geografico Militare, pioniere negli studi di aerofotografia applicata
all’archeologia. “Con i materiali provenienti da tutti questi scavi -continua Ninopotei poi ottenere di fare un museo nell’edificio al centro della Ragusa Superiore.[…]
Volli che allora fosse un museo nazionale, poi diventato regionale, come tutti i musei
della Sicilia”.
Adesso il novello Schliemann aveva compiutamente realizzato il suo sogno
d’infanzia: il tedesco quello di riportare alla luce le rovine di Troia, così ben
disegnata sul libro regalatogli dal padre da sembrare reale, il Chiaramontano di far
riemergere e parlare quelle antichità di Scornavacche che, ai tempi del nonno, erano
solo muti fantasmi della mente. Ed io, in qualche occasione di conviviale
11
spensieratezza, davanti a tali racconti, mi trovai ad apostrofarlo ‘Nino
scornavacchino’.
Al Museo di Ragusa volle bene come a un figlio (del resto era sua esclusiva creatura),
e gli piaceva ricordare gli amici che lo avevano finanziariamente aiutato a realizzare
l’impresa. “Fu Ragusa a supplire con una sottoscrizione, resa pubblica e
propagandata dagli amici giornalisti, Lino Blundo (ed il suo “Ragusa Sera”), Vittorio
Perrone ed il giovanissimo Giovanni Pluchino. Sottoscrissero tutti gli Enti pubblici e
tanti privati fra i quali, per non ricordare che qualche nome, il Comm. Gianbattista
Cartia e la sua Banca Popolare, l’Ing. Cesare Zipelli e l’A.B.C.D., Filippo Garofalo e
l’ E.P.T., il notaio Riccardo Sulsenti, il prof. Vincenzo Boscarino, la professoressa
Margherita Nicosia Margani, il dott. Francesco Pisana, lo scultore Carmelo Cappello,
il carissimo Salvatore Lo Presti, fotografo, ed altri che si costituirono in Associazione
“Amici del Museo”, il cui unico scopo fu quello di far rientrare nel panorama
dell’archeologia siciliana la provincia di Ragusa e di dare a Ragusa un museo degno
di questo nome. È con gratitudine di conterraneo e di archeologo che il mio pensiero
corre a quelle Istituzioni e a quegli Amici, molti dei quali non sono più tra noi, ma
soprattutto a quella singolare figura di studioso di profonda e diversificata ricchezza
culturale, di entusiasta della sua terra, che era ed è Filippo Garofalo, personaggio
emblematico ed epigono di una tradizione culturale non gridata ma di altissimo
livello, tutt’altro che provinciale, ricca di curiosità, enciclopedica, la quale costituisce
a buon diritto l’orgoglio dell’antica, “contadina” contea di Modica. Dal
cinquecentesco Gianbattista Odierna, alla famosa scuola medica di Tommaso
Campailla fra ‘600 e ‘700, a Saverio Scrofani giurista, economista, esploratore
erudito nella Sicilia del primo ‘800, a Serafino Amabile Guastella letterato ed
etnologo, a Raffaele Solarino, medico e filologo, a Filippo Garofalo (avo del nostro
amico) storiografo dell’antica e moderna Ragusa”.
Il Museo si potrà aprire al pubblico solo nel giugno del 1961, quando, come vedremo,
Nino era già andato via dalla Sicilia; pur di completarlo, negli ultimi due anni, egli si
era fatto assegnare, come presidente di commissione per gli esami di Stato, proprio
nella città iblea.
Gli anni ragusani risulteranno capitali per la sua carriera. Lasciamo, ancora una volta,
dire a lui. “Questi cinque anni furono di un’importanza eccezionale, fruttuosissimi, e
potei impiantare per la prima volta -e questo mi ha legato per sempre a Ragusa- un
centro fisso di ricerca archeologica; ho dato la base per quella che è poi diventata la
Soprintendenza di Ragusa, ed i materiali degli scavi che prima erano portati a
Siracusa da allora sono restati a Ragusa. […] Quindi sono sempre rimasto legato a
quell’area, non solo perché sono stati i miei primi scavi, ma perché furono talmente
ampli, dal mondo greco arcaico fino all’epoca cristiana e bizantina di Acrille-Gulfi,
da consentirmi un’esperienza a tutto campo, che mi ha dato la spinta per poter
continuare a fare l’archeologo”. Ed ancora: “Col più grande rimpianto, ma con la
soddisfazione di lasciare un presidio ormai indistruttibile, mi allontanavo dalla mia
terra, da scavi, da amici le cui immagini ho sempre portato con me. E quante volte
12
guardando le stelle nel deserto della Libia, o camminando negli altopiani senza fine
del sud algerino, o percorrendo le strade impervie di Creta non sono ritornato col
pensiero a quella mia prima, intensa, emozionante esperienza di ‘archeologo da
campo’! Lieto di sapere che l’opera da me solo iniziata veniva accresciuta e, in più
punti, portata a compimento, prima dalla competenza e dalla fervida metodica attività
di Paola Pelagatti, poi dal lavoro e dalla presenza finalmente continua di un
archeologo tutto per Ragusa, quella di Giovanni Di Stefano”.
Il fanciullino sognatore di Scornavacche attaccato alla giacca del nonno, è diventato
dunque un vero archeologo militante proprio nelle contrade del ragusano, che lo
segnarono nella mente e nel cuore.
L’archeologo militante va tuttavia di pari passo con lo studioso, che ha voglia anche
di insegnare. Nel 1958 arrivò infatti la libera docenza in Archeologia e storia dell’arte
greca e romana e l’anno dopo, l’opportunità di un incarico di insegnamento
all’Università di Perugia, dopo che egli aveva deciso di non sfidare la bora di Trieste.
Fu quindi necessario chiedere il trasferimento da Siracusa, con conseguente ritorno a
Roma nell’ottobre, ed assegnazione al Museo di Villa Giulia, con Soprintendente
Renato Bartoccini, il quale era ancora impegnato in Libia nello scavo del porto di
Leptis e dell’area attorno al foro severiano. “Da lì -ci dice Nino- cominciò poi la mia
avventura africana”. Il ritorno a Roma segnò anche l’inizio di una nuova esperienza,
decisamente fuori dalla norma. Come Ispettore avrebbe dovuto occuparsi del
territorio falisco e di Civita Castellana, ma il Soprintendente pensò bene di affiliarlo,
essendo ancora poco noto nell’ambiente romano, ad una squadra speciale della
Guardia Finanza attiva contro il contrabbando delle opere d’arte, squadra presso la
quale lavorò Nino dal novembre del 1959 al settembre del 1962. “Mi sono presentato
in via dell’Olmata e lì mi dissero: «Lei da oggi in poi è il signor Piacere». «Che
significa -chiesi- signor Piacere?» Risposero: «Intanto il suo servizio presso di noi è
assolutamente segreto, e non lo devono sapere neanche i membri della sua famiglia.
Poi quando la presenteremo, come nostro esperto, lei dovrà dire sempre Piacere: gli
altri diranno il loro cognome e lei dirà Piacere» E così per due anni io fui il signor
Piacere!”. Dettagli come questi, a sentirli raccontare direttamente da Nino, con il suo
senso dell’humour e la sua calibrata teatralità, significava non resistere alla sua
contagiosa allegria.
Terminate a questo punto le avventure del Signor Piacere, il Mediterraneo per Nino
si fa più piccolo: egli lascia l’Italia e si trasferisce a Tripoli in qualità di consigliere
del governo libico per le antichità della Tripolitania, “al fine di aiutare l’opera del
giovane Department of Antiquities e di tutelare una tradizione italiana cinquantennale
di scavi, ricerche e studi nelle antiche città greche, fenicio-puniche e romane della ex
colonia”. Era stato proprio il suo Soprintendente Bartoccini a convincerlo al gran
passo. “Poiché tra i suoi funzionari ero l’unico che avesse un incarico universitario,
mi chiese di prendere io quel posto. La proposta era allettante ma le remore ad
accettare erano tante sia perché mi ero sempre occupato di grecità e non conoscevo la
Libia che era per me un mondo del tutto nuovo, sia perché mi stavo sposando, e da
13
poco docente universitario, avevo tutto l’interesse a restare tra Roma e Perugia. […]
Fu una decisione molto difficile e sofferta quella di lasciare l’Italia per un’avventura
nel mondo libico (una delegazione libica […] era venuta a trovarmi a Roma), però ho
creduto di fare il mio dovere di italiano nell’accettare. E così è stato che il 18
novembre 1962, comandato come addetto all’Ambasciata di Tripoli, mi sono
ritrovato ufficialmente consigliere del governo libico per le antichità della
Tripolitania”.
I tre anni filati d’Africa lasceranno un segno altrettanto profondo che quelli siciliani.
La Libia, insomma, sarà per sempre, come la Trinacria. Tornato in Italia, Nino
deciderà infatti di continuare a dirigere annualmente missioni libiche di studio e di
restauro fino all’ultimo e si preoccuperà addirittura di istituire borse di studio per il
perfezionamento proprio di funzionari libici presso la Scuola di Atene.
“Dopo il mio rientro in Italia nel 1965 sono tornato in Libia ogni anno -tranne l’estate
del 1986 (quando mi fu proibito dal nostro Ministero degli Esteri per via dei missili
libici su Lampedusa)- sempre a capo delle missioni delle Università in cui insegnavo
[…]. Sono tornato ma in una posizione un po’ diversa da quella dei colleghi operanti
in Libia, giacché sono stato sempre considerato dagli amici libici -sia pure
nell’avvicendarsi delle generazioni- come l’antico direttore scientifico del
Dipartimento alle antichità”.
Degli usi e costumi della Libia, oltre che dei suoi incomparabili monumenti, Nino fu
osservatore attento e si trovò testimone in loco di eventi capitali, come l’avvento di
Gheddafi al potere nel settembre del 1969. Le sue narrazioni sulla caccia alle gazzelle
nel deserto libico, o sui musulmani bevitori clandestini di alcolici, pronti a disfarsi del
corpo del reato nascondendolo sotto il suo letto, ma anche l'ascesa ad una
spelacchiata cima di un deserto australiano, i claustrofobici contorcimenti negli spazi
lillipuziani di una camera d'albergo tradizionale in Giappone, le tragicomiche
peripezie fra ambasciatori, addetti diplomatici e agenti segreti, le giovanili baldanze
tersicoree, i poco gratificanti trascorsi di mancato industriale della plastica, nella
Ragusa dei tardi anni '50, con una fantomatica Sicilplast, il suo acchiappare gli aerei
per la coda, o il perdere la nave a Brindisi, per fare il pieno di dolcini in un convento
di monache del Tavoliere pugliese... . Erano tutti, per quanti hanno avuto il piacere di
ascoltarli, autentici pezzi di bravura. Ed in questi suoi viaggi verbali, il continente
nero aveva davvero un posto di rilievo: la prova estrema del suo mal d’Africa sta
infatti nell’arco dei Severi di Leptis e nel mausoleo di Sabratha, realizzati in
bassorilievo, per suo espresso volere, sull’urna cineraria.
Rientrando nel 1965 dalla Libia, Nino decide di non tornare più al Museo di Villa
Giulia, ma di farsi assegnare alla Soprintendenza archeologica di Firenze, non solo
perché la sua prima moglie, che lo aveva seguito in Libia per un anno e che lì gli
aveva dato il primo figlio, era stata assegnata all’Istituto francese della città toscana,
ma perché il capo di quella Soprintendenza era il siciliano Giacomo Caputo, l’ultimo
dei Soprintendenti italiani della Libia, il quale gli concesse quindi di continuare ad
occuparsi dei suoi debiti scientifici libici. Nascono così anche altri progetti ed
14
imprese africane in Tunisia a Cartagine ed in Algeria (una presso Tipasa e un’altra
vicino Timgad).
Il 4 novembre del 1966, giorno della terribile alluvione, Nino era a Firenze e fu tra i
primi ad entrare nel piano terreno del Museo archeologico dopo il cataclisma. Le sue
narrazioni -ricordo- riuscivano a dare da un lato l’idea tragica del disastro, e dall’altro
la grande forza di volontà e il fervore per riportare in vita il Museo.
Il 1968 è un anno di svolta nella carriera di Nino: idoneo al concorso universitario di
prima fascia, viene chiamato all’Università di Macerata. Fu un evento per
l’archeologia siciliana: i tre idonei, tutti isolani, si chiamavano Giovanni Rizza,
ragusano di Monterosso Almo docente a Catania, Nicola Bonacasa trapanese
trapiantato a Palermo, Antonino Di Vita, giramondo chiaramontano. Costui,
professore ordinario, Preside, Rettore, sempre ed in rapida successione
nell’Università di Macerata, da subito segnalatosi, oltre che per la sua sapienza, per le
grandi capacità organizzative. Nei tre anni di rettorato, riuscì, fra l’altro, “a
comperare e a sistemare il palazzo per la Facoltà di Lettere, a realizzare il Collegio
femminile e la residenza per i professori, a potenziare il collegio maschile”. E lo
avevano tanto apprezzato, i politici marchigiani, che gli avevano proposto di farlo
senatore: ma Nino ebbe per fortuna la forza di resistere a quelle sirene... .
Del suo riapprodo ateniese nel 1977 e dei motivi di quella scelta si è già detto. Per
parlare adeguatamente dei quasi ventiquattro anni della sua Direzione faremmo tardi
ed io sarei travolto dai tanti ricordi legati al lunghissimo periodo della nostra
collaborazione prima cretese e poi ateniese, fino a quello della vice-direzione dal
1993 al 1999. Cercherò quindi di essere telegrafico, anche perché ho avuto modo di
trattare questo specifico aspetto in altra sede.
Metterei al primo posto, fra le idee portanti del nuovo Direttore, quella di una vera e
propria rifondazione della Scuola, fino a quel momento semplice corso di
perfezionamento di durata annuale, concluso dal formulario di un attestato, non
sempre tenuto nel debito conto o addirittura ignorato per le valutazioni concorsuali in
patria. Nino cercò fin da subito di raddoppiare, almeno per gli alunni più meritevoli,
la durata della borsa e studiò un nuovo ordinamento con un corso di studi triennali,
cinque diversi curricula, un consiglio scientifico di una diecina di membri, corsi di
lezione, esami annuali, tesi di specializzazione finale, rilascio del diploma (per il
quale coinvolse all’inizio il calligrafo dell’Università di Macerata). Mettendo a frutto
anche la sua esperienza di Rettore, riuscì in un arco di tempo relativamente breve per
i tempi della politica italiana, a fare approvare la nuova legge (nel marzo del 1987),
che rendeva la Scuola di Atene, grazie anche al prestigio goduto dal Direttore, la più
appetibile per i giovani laureati italiani in cerca di una specializzazione archeologica.
Alla Scuola veniva adesso riconosciuta la personalità giuridica di ente di diritto
pubblico, con un suo Consiglio di amministrazione. L’abilità di Nino nel districarsi
fra i labirinti della burocrazia, avrebbe fatto il resto, anche per ovviare alla scarsità
dei fondi disponibili. Grazie ad un’oculata politica di bilancio, la Scuola fu
15
finalmente in grado di vivere, piuttosto che di sopravvivere, come le era
costantemente capitato nel corso della sua lunga storia.
La seconda linea guida della Direzione Di Vita fu senz’altro quella di pagare i debiti
scientifici ereditati, non solo dalla Scuola, ma pure dalla Missione Cretese o dalla
Soprintendenza ai Monumenti e agli scavi del Dodecaneso, grazie anche alla scelta
mirata degli argomenti per le tesi di diploma degli allievi.
La terza idea portante era che per ottenere dei validi risultati scientifici bisognasse
disporre di adeguate strutture: l’ampliamento della sede di Atene, la nuova
costruzione di quella di Gortina (con annessi magazzini), il rifacimento di quella di
Festòs (con la ristrutturazione del complesso dei magazzini), il restauro e la riapertura
della casa di Poliochni, i lunghi, delicati e costosi restauri della casa di Iraklion
acquistata da Federico Halbherr negli anni ’20 del secolo scorso, sono fra le gemme
più significative della corona del Di Vita Direttore.
Di pari passo al pagamento dei debiti scientifici doveva andare anche il
consolidamento della presenza italiana in tutti i campi di scavo tradizionali, a Creta e
a Lemno. Saggiamente Nino evitò, quindi, di concentrare, le attività in un unico
cantiere, come era accaduto nei decenni precedenti a causa della scarsità dei fondi.
Scelse per sé Gortina di Creta, dove seppe mettere insieme un gruppo di lavoro di
altissimo livello, con un’invidiabile ed invidiata serie di pubblicazioni, rilevante per
qualità e quantità. Dall’estate del 1978 alla sua ultima del 2011, quello a Gortina
divenne per lui un appuntamento ineludibile con i tanti collaboratori. Mi sovviene
una sola eccezione, quella del 1985, quando al ritorno da un viaggio in Australia,
dove si era recato per un convegno, i medici gli consigliarono di riposarsi un poco.
Ricordo ancora la cartolina che mi inviò, a Creta, dal centro di quel lontano
continente. Sono corso a rispolverarla per questa occasione: “Caro Enzo, vedi dove
mi ha spinto il cercare (virtute e) conoscenza? Al centro dell’Australia, dove […]
siamo alla ricerca di pitture aborigene e di meraviglie della natura quale quella che ti
invio. A te ed i tuoi ‘Haghiatriadini’ il mio pensiero costante e un grande abbraccio
(Manoli compreso). Nino”.
Consentitemi, amici, qualche chiosa a queste poche frasi, illuminanti per chi sappia
leggere fra le righe. La citazione dantesca del ‘virtute e conoscenza’ sa anche essere
autoironica, dal momento che il primo dei due termini , ‘virtute’ viene inserito fra
parentesi. Il Convegno e la relazione scientifica non bastano a soddisfare l’autore: la
sua smisurata ‘sete’ gli impone di cercare altro, natura compresa, incurante della
fatica fisica. Seppure così lontano, il Direttore non riesce a dimenticare quelli che
stanno a Creta (in questo caso coloro che scavano con me ad H. Triada) ed evidenzia
il suo pensiero anche graficamente, sottolineando la parola ‘costante’. Nel ricordo
vanno accomunati proprio tutti, anche l’umile custode greco della Scuola, Manolis.
Capite, adesso, perché io conservi religiosamente da 17 anni quella cartolina …
Nino rimase come Direttore ad Atene fino al settembre del 2000, ma continuò la sua
prodigiosa attività, occupandosi ancora di Libia, di Creta e di Sicilia, partecipando a
Convegni o tenendo conferenze in giro per l’Italia e l’Europa, fin quasi all’ultimo
16
mese di vita. Non mancava, annualmente, i tre appuntamenti del cuore, anche se
quello siciliano era, per necessità di cose, in genere limitato ad alcuni giorni di
ottobre, in coincidenza con la raccolta delle olive nella sua Buzzolera. In Libia Nino
si recava di solito in autunno o in primavera; ad Atene e Creta trascorreva i due mesi
estivi, facendosi ovunque apprezzare per la signorilità dei modi, la grande umanità, la
disponibilità senza riserve verso quanti a lui si rivolgevano.
Mi rendo conto di essermi lasciato andare un po’ troppo, inseguendo vicende e
ricordi, dimenticando la mia paludata condizione che mi avrebbe imposto, invece di
inseguire soltanto l’uomo, valutazioni e apprezzamenti sullo scienziato Antonino Di
Vita. Ma in questo secondo caso, non avrei saputo davvero da dove cominciare.
Un cursus honorum, il suo, decisamente invidiabile, come risulta dalle tappe
essenziali qui solo richiamate, con riconoscimenti accademici e non solo, dall’Italia,
alla Grecia, alla Francia, fino a quelli di socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, o
di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana. Una produzione
scientifica, la sua, assai vasta, con oltre 380 titoli, fra volumi e articoli. Un acuto
archeologo militante (convertitosi rapidamente alla New Archaeology), fu Nino, ma
anche un fine storico dell’arte greca e romana, con una notevole institutio filologicoletteraria; un maturo storiografo; un grande organizzatore di Istituzioni e di cultura,
un entusiasta e carismatico catalizzatore di energie giovanili, con pochissimi
confronti nel mondo accademico nazionale ed internazionale. Uno studioso che si era
mosso in una prospettiva compiutamente mediterranea, con tre poli di interesse
specifico: Sicilia, Libia, Creta e Grecia in genere (dal Dodecanneso a Lemno),
nell’ordine in cui avevano preso corpo. Uno studioso, capace di affrontare temi e
problemi per un arco di tempo di uno spettro straordinariamente largo: dal greco
arcaico al protobizantino et ultra , lungo un sentiero battuto davvero ecisamente da
pochi.
Nel 2010 aveva dato alle stampe, dopo tre anni di intenso lavoro, il volume Gortina
di Creta. Quindi secoli di vita urbana, presentato con grande successo all’Accademia
dei Lincei (e l’amico Nicola Bonacasa fu anche allora uno degli oratori), sintesi di
una presenza ultratrentennale sul sito, prova di grande acume e profonda dottrina. E
quel Comune, facendolo cittadino onorario, gli aveva anche intitolato una strada. Il
locale Museo Archeologico gli aveva da tempo dedicato la città del padre Benedetto,
dove le sue ceneri riposano, Licodia Eubea. Una via Antonino Di Vita ed un’epigrafe
dedicatoria esistono da stamani anche a Chiaramonte.
L’ultima fatica scientifica di Nino, alla quale egli attendeva con immutato zelo,
destreggiandosi fra ricoveri e cicli di chemioterapia, era segnata dalla prospettiva di
un ritorno alle origini, quelle origini e quegli ambiti che avevano deciso della sua vita
di studioso. Aveva infatti quasi ultimato, insieme con Maria Antonietta, lo studio
della necropoli di contrada Rito a Ragusa, suo scavo giovanile, proprio perché non
voleva lasciare debiti scientifici. Sarà lei adesso, che gli è stata vicina con un amore e
una dedizione esemplari, a curarne l’edizione e penso che in quell’occasione avremo
tutti il destro di rivederci nella vicina Ragusa. Mi auguro che Maria Antonietta riesca
17
anche a completare quel ricordato disegno sull’autobiografia, disegno al quale Nino
si era davvero affezionato; ne parlammo a lungo nella sua ultima stagione cretese,
quando ricevette la croce di S. Paolo e S. Tito, massima onorificenza della Chiesa
Ortodossa di quell’isola, prima che le telefonate con l’ospedale romano si facessero
giornaliere e la voce spezzata di Maria Antonietta, di Sergio o di Gianmarco, mi
riempissero di indicibile malinconia, acuita dall’incolmabile lontananza. Ero a
Retymno, lo scorso 22 ottobre, e quando l’indomani i presidenti di Sezione al
Convegno Internazionale di Studi Cretesi diedero la ferale notizia, un prolungato
brusio si levò nelle diverse sale.
Consentitemi per concludere, cari amici, di dare ancora una volta la parola a Nino,
saccheggiando una sua pregevole pagina di ego-histoire, pubblicata nel primo
numero dell’Archivio Storico Ibleo del 1995. “Nel tardo pomeriggio di uno dei giorni
in cui lavoravo alla necropoli di Castiglione, nell’aprile del 1951 (vi ero arrivato dalla
scoperta presso un ciabattino di Comiso, di materiale scavato di fresco, segnalatomi
da Biagio Pace, il quale era stato mio correlatore a Roma alla tesi di specializzazione
pochi mesi prima) rinvenimmo una piccola grotticella funeraria assolutamente
inviolata. Spostato il masso che la chiudeva vi entrai per primo ed il sole del tramonto
infilava una lingua di luce discreta nella tomba, piccola e adatta alla personcina che
conteneva. Si trattava di una bambina di 6-7 anni, il cui scheletro il calcare aveva
conservato quasi intatto durante più di 25 secoli. E come se quel numero infinito
d’anni non fosse passato, ora mi riallacciavo al momento della deposizione. E, solo,
nel silenzio del meriggio, li ho rivisti, i genitori della bimba, portare nel sudario il
piccolo corpo e ho toccato con mano la loro disperazione ed il loro amore.
All’anulare della mano sinistra essi avevano lasciato un anellino di bronzo, povero
ornamento dei pochi anni vissuti, presso la coscia sinistra avevano deposto un fuso,
certo pieno di lana, a testimonianza di una femminilità non raggiunta sulla terra, ma
che, speravano, la loro bimba avrebbe raggiunto nell’al di là; e presso l’ingresso,
avevano deposto una grossa lucerna piena d’olio, perché alla loro creatura non
mancasse la luce nella nuova casa dell’eternità. Era come se per un istante, essi che
uscivano ed io che entravo, ci fossimo incontrati; e non mi restò che richiudere con
cura la tomba e lasciare la piccola continuare a dormire il suo sonno eterno. Certo
avremo perso qualche elemento utile per conoscere di che morbo era mancata,
qualche dato paleo nutrizionale, ma mi sembrava poca cosa rispetto allo sconvolgere
quel piccolo ordinato mucchio di ossa per portarlo in laboratorio. La scienza non
avrebbe sofferto molto; i “suoi” genitori certo di più se avessi fatto il mio dovere
tecnologico fino in fondo”. E qui Nino continuava con un secondo esempio, che
ometto per brevità, relativo al fuoco volontariamente appiccato ad una torre dai
Camarinesi, con il prezioso contenuto di orzo e frumento, per non consegnarsi agli
invasori cartaginesi, e l’incendio “era lì a dimostrare la disperazione, la fuga,
l’esilio”.
“Sulla montagna sicula il pianto rassegnato di una famiglia- egli concludeva- a
Camarina la tragedia senza speranza di una città intera: all’uno avvenimento e
18
all’altro eravamo pervenuti grazie ad una precisa metodica di scavo ma, poi, essi
erano entrati dentro di noi e ce ne facevano partecipi. Per sempre”.
Cosa mai potrei io aggiungere a siffatte espressioni? Fredda polvere del tempo e caldi
battiti del cuore, storia remota e vita vissuta, chirurgica ricostruzione di strati e
commossa pietà. Questo era l’archeologo Antonino Di Vita. Un viandante
mediterraneo sorridente e irrequieto. Un grande animo, capace come pochi di cercare
nel passato anzitutto la verifica alla sua condizione di uomo. Un grande uomo,
cittadino del mondo, ma rimasto, nel profondo, sempre chiaramontano. Dovete
esserne fieri.
19