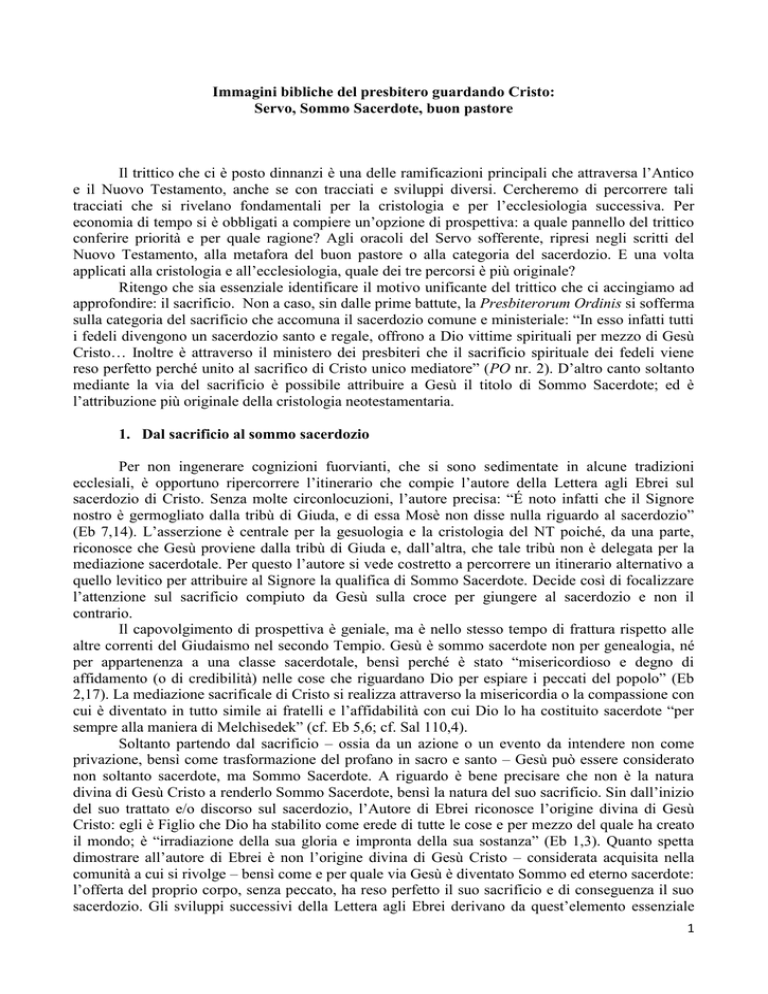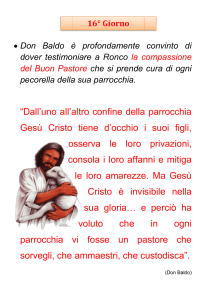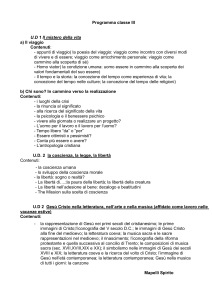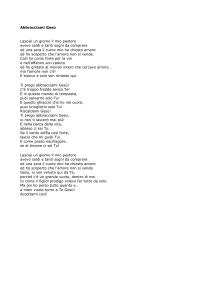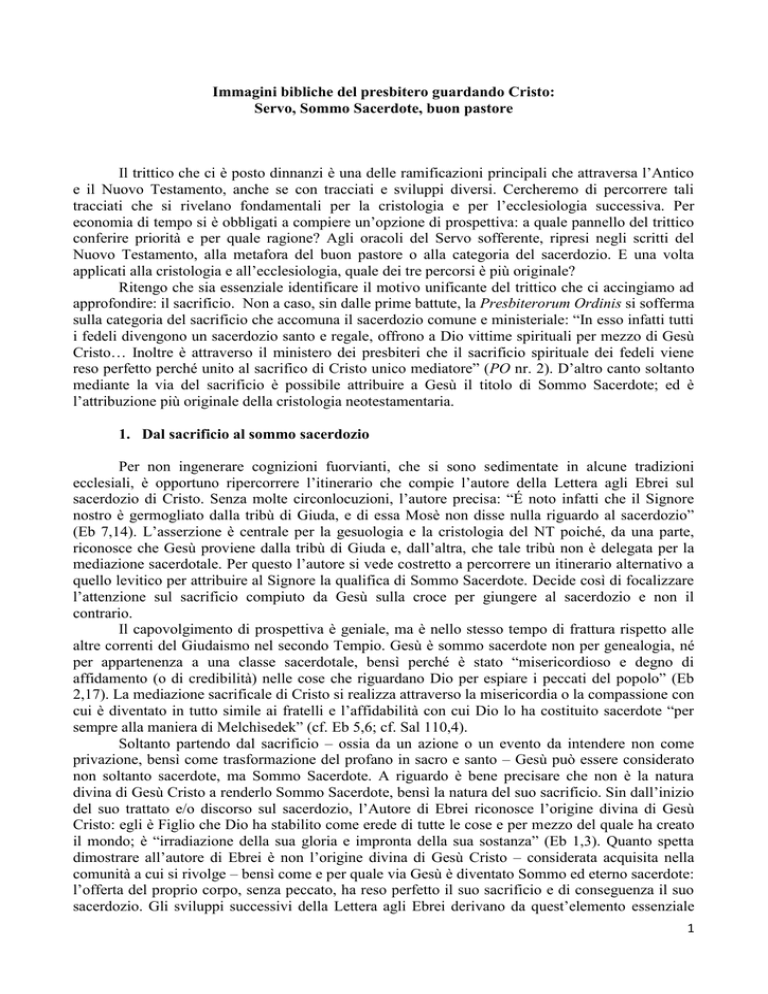
Immagini bibliche del presbitero guardando Cristo:
Servo, Sommo Sacerdote, buon pastore
Il trittico che ci è posto dinnanzi è una delle ramificazioni principali che attraversa l’Antico
e il Nuovo Testamento, anche se con tracciati e sviluppi diversi. Cercheremo di percorrere tali
tracciati che si rivelano fondamentali per la cristologia e per l’ecclesiologia successiva. Per
economia di tempo si è obbligati a compiere un’opzione di prospettiva: a quale pannello del trittico
conferire priorità e per quale ragione? Agli oracoli del Servo sofferente, ripresi negli scritti del
Nuovo Testamento, alla metafora del buon pastore o alla categoria del sacerdozio. E una volta
applicati alla cristologia e all’ecclesiologia, quale dei tre percorsi è più originale?
Ritengo che sia essenziale identificare il motivo unificante del trittico che ci accingiamo ad
approfondire: il sacrificio. Non a caso, sin dalle prime battute, la Presbiterorum Ordinis si sofferma
sulla categoria del sacrificio che accomuna il sacerdozio comune e ministeriale: “In esso infatti tutti
i fedeli divengono un sacerdozio santo e regale, offrono a Dio vittime spirituali per mezzo di Gesù
Cristo… Inoltre è attraverso il ministero dei presbiteri che il sacrificio spirituale dei fedeli viene
reso perfetto perché unito al sacrifico di Cristo unico mediatore” (PO nr. 2). D’altro canto soltanto
mediante la via del sacrificio è possibile attribuire a Gesù il titolo di Sommo Sacerdote; ed è
l’attribuzione più originale della cristologia neotestamentaria.
1. Dal sacrificio al sommo sacerdozio
Per non ingenerare cognizioni fuorvianti, che si sono sedimentate in alcune tradizioni
ecclesiali, è opportuno ripercorrere l’itinerario che compie l’autore della Lettera agli Ebrei sul
sacerdozio di Cristo. Senza molte circonlocuzioni, l’autore precisa: “É noto infatti che il Signore
nostro è germogliato dalla tribù di Giuda, e di essa Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio”
(Eb 7,14). L’asserzione è centrale per la gesuologia e la cristologia del NT poiché, da una parte,
riconosce che Gesù proviene dalla tribù di Giuda e, dall’altra, che tale tribù non è delegata per la
mediazione sacerdotale. Per questo l’autore si vede costretto a percorrere un itinerario alternativo a
quello levitico per attribuire al Signore la qualifica di Sommo Sacerdote. Decide così di focalizzare
l’attenzione sul sacrificio compiuto da Gesù sulla croce per giungere al sacerdozio e non il
contrario.
Il capovolgimento di prospettiva è geniale, ma è nello stesso tempo di frattura rispetto alle
altre correnti del Giudaismo nel secondo Tempio. Gesù è sommo sacerdote non per genealogia, né
per appartenenza a una classe sacerdotale, bensì perché è stato “misericordioso e degno di
affidamento (o di credibilità) nelle cose che riguardano Dio per espiare i peccati del popolo” (Eb
2,17). La mediazione sacrificale di Cristo si realizza attraverso la misericordia o la compassione con
cui è diventato in tutto simile ai fratelli e l’affidabilità con cui Dio lo ha costituito sacerdote “per
sempre alla maniera di Melchìsedek” (cf. Eb 5,6; cf. Sal 110,4).
Soltanto partendo dal sacrificio – ossia da un azione o un evento da intendere non come
privazione, bensì come trasformazione del profano in sacro e santo – Gesù può essere considerato
non soltanto sacerdote, ma Sommo Sacerdote. A riguardo è bene precisare che non è la natura
divina di Gesù Cristo a renderlo Sommo Sacerdote, bensì la natura del suo sacrificio. Sin dall’inizio
del suo trattato e/o discorso sul sacerdozio, l’Autore di Ebrei riconosce l’origine divina di Gesù
Cristo: egli è Figlio che Dio ha stabilito come erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha creato
il mondo; è “irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza” (Eb 1,3). Quanto spetta
dimostrare all’autore di Ebrei è non l’origine divina di Gesù Cristo – considerata acquisita nella
comunità a cui si rivolge – bensì come e per quale via Gesù è diventato Sommo ed eterno sacerdote:
l’offerta del proprio corpo, senza peccato, ha reso perfetto il suo sacrificio e di conseguenza il suo
sacerdozio. Gli sviluppi successivi della Lettera agli Ebrei derivano da quest’elemento essenziale
1
del sacrificio di Cristo in vista del sacerdozio. Il sacerdozio di Cristo si è realizzato una volta per
sempre, stabilendo con il suo sacrificio di mediazione la comunione tra Dio e gli esseri umani, e
perdura anche nel tempo della Chiesa, sino alla fine della storia.
Fra le conseguenze più essenziali per i cammini successivi della Chiesa da segnalare, contro
dolorosi e pericolosi fraintendimenti, è centrale riconoscere da una parte la sincronia della
comunione e della mediazione nel sacerdozio di Cristo, dall’altra la distinzione ecclesiale tra il
sacerdozio comune e quello ministeriale. Poiché non c’è sacerdozio se non c’è mediazione per il
sacrificio, come precisa più volte l’autore di Ebrei, il sacrificio di Cristo è perfetto poiché nel
momento in cui realizza la mediazione compie la comunione, senza alcuna soluzione di continuità.
Trasferito nell’ecclesiologia, la comunione per la fede e il battesimo si realizza con la mediazione
sacerdotale. Non c’è comunione senza mediazione e il contrario, altrimenti da una parte si cade in
forme religiose di superstizione, dall’altra in espressioni di clericalismo settario.
La prima grande visione dell’Apocalisse rende chiara l’idea sull’interdipendenza tra le due
espressioni dell’unico sacerdozio di Cristo. In Ap 5,1-14 si assiste alla visione del leone della tribù
di Giuda, identificato poi come agnello sgozzato, dei quattro esseri viventi e dei ventiquattro anziani
che lo adorano con il canto nuovo. La prima parte del canto parte nuovamente dal sacrificio
dell’agnello immolato e per questo ritenuto degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, di
riscattare per Dio con il suo sangue chiunque, sino a costituire un regno e sacerdoti.
Nella simbologia dell’Apocalisse, i quattro esseri viventi esprimono l’universalità spaziale
del mondo e i ventiquattro anziani non sono i dodici apostoli raddoppiati, bensì richiamano le
ventiquattro classi sacerdotali elencate in 1Cro 24,7-18 (cf. in seguito Ne 12,1-7). La visione si
chiude con l’amen dei quattro esseri viventi e la prostrazione dei ventiquattro anziani.
Nell’adorazione dell’agnello non c’è un sacerdozio che predomina sull’altro, ma si realizza quella
sincronia per cui il sacrificio di Cristo è perfetto perché la comunione si realizza con la mediazione.
2. Servo, “come agnello condotto al macello”
Uno dei carmi più noti nel Giudaismo del secondo Tempio è del Servo sofferente, esaltato in
Is 52,13–53,12. La figura altamente simbolica del Servo è descritta, tra l’altro, come agnello
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Passiamo così dal rapporto tra il
sacrificio e il sacerdozio a quello tra l’agnello e il servo. La ripresa di alcuni tratti del Servo si
verifica già durante la passione, quando secondo la redazione di Lc 22,37 Gesù si appropria
dell’oracolo di Is 53,7: “É stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti” (Lc
22,37).
Tuttavia già a livello gesuano è verosimile che negli ultimi momenti sua vita terrena, Gesù
abbia riletto la sua vicenda nella prospettiva del Servo che conferisce significato alle sue parole
durante la cena di addio. La proposizione di Mc 14,14, con cui Gesù ricorda che “questo è il mio
sangue dell’alleanza, versato per molti” si colloca nella stessa traiettoria di Is 53,7, al punto che il
passo parallelo di Mt 26,28 aggiunge “per la remissione dei peccati”. In tal modo Matteo esplicita il
rapporto tra il sangue dell’alleanza e la sua finalità favorevole “per molti”, che corrisponde a “per
tutti”, senza escludere alcuno. Se Gesù può affermare di essere servo è perché ha fatto della sua vita
una pro-esistenza universale; e in questo tratto il servo è, nello stesso tempo, agnello. Consapevole
di tale corrispondenza, l’evangelista Giovanni preferisce presentare sin dall’inizio del suo scritto
Gesù come “agnello di Dio che toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29). Nel linguaggio semitico
talya’ è, nello stesso tempo, l’agnello e il servo per cui è stato semplice equiparare il servo
all’agnello e il contrario.
La stessa ripresa si verifica in At 8,32-33 quando Filippo evangelizza il sovrintendente della
regina Candace interpretando in chiave cristologica l’oracolo di Is 53,7-8: “Ti prego di quale
persona il profeta dice questo?” (At 8,34). Il travaso ecclesiale del servizio per la comunità
cristiana si verifica con il dibattito tra i discepoli durante la cena di addio, secondo la redazione
lucana: “E nacque tra loro anche una discussione: chi fosse da considerare più grande… Eppure io
2
sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,24-27). Significativo è il trasferimento del dibattito
operato da Luca: mentre Marco e Matteo lo riportano durante la vita pubblica di Gesù (cf. Mt
10,42-45; Mt 20,25-27), Luca preferisce raccontarlo durante la cena di addio e relazionarlo
all’istituzione eucaristica. Dunque voluto è il contrasto operato da Luca: quando Gesù sta per offrire
il suo sangue “per voi” (secondo la formulazione di Lc 22,20), i discepoli discutono su chi sia il
migliore tra loro.
L’impatto ecclesiale è notevole: l’istituzione eucaristica, intesa come sacrificio per molti e
per voi, è fraintesa quando è concepita nell’ottica del potere e non del servizio per gli altri. Se la
categoria del sacerdozio pone il risalto la funzione della mediazione nella comunione, quella del
servo accentua la prospettiva del dono di sé per gli altri e, per questo, in condizione di costituire “un
sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo” (1Pt 2,5).
3. Il pastore grande delle pecore
Torniamo alla Lettera agli Ebrei e rileggiamo la benedizione finale di questo sublime
discorso o trattato sul sacerdozio di Gesù Cristo: “Il Dio della pace, che a ricondotto dai morti il
Pastore grande delle pecore in virtù del sangue di un’alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi
renda perfetti in ogni bene…” (Eb 13,20). Ci troviamo all’apice di una traiettoria secolare che
attraversa l’Antico e il Nuovo Testamento con la metafora del pastore e le sue pecore. La metafora è
già nota ed è approfondita dal profeta Ezechiele con il discorso contro i pastori d’Israele (Ez 34,131). In situazioni di crisi religiosa e politica, Israele si attende il pastore capace di governare il suo
popolo senza curare i propri interessi ma quelli del gregge.
La fonte Q dei detti di Gesù riporta la famosa parabola della pecora perduta (cf. Lc 15,4-7) o
smarrita (Mt 18,12-14): una delle parabole più originali di Gesù. Le due redazioni sinottiche
esprimono due situazioni diverse sull’impatto della parabola: quella di Gesù che accoglie e mangia
con i peccatori (cf. Lc 15,1-3) e quella del discorso sulla Chiesa (cf. Mt 18,1-35). La versione
lucana della parabola si caratterizza per il paradosso: tratta di un pastore che lascia novantanove
pecore non nell’ovile, ma nel deserto, e si pone alla ricerca della pecora perduta da lui e non da se
stessa. Sul pastore grava la responsabilità di cercare chi ha perduto contro quanti s’illudono di
essere al sicuro, mentre si trovano in condizione di pericolo come per chi è nel deserto.
Il paradosso dell’azione pastorale di Gesù prosegue con l’impatto ecclesiale della stessa
parabola raccontata nel vangelo di Matteo. Questa volta si tratta della pecora che si smarrisce e del
pastore che decide di cercarla, con la speranza di poterla trovare. Alla comunità matteana e a ogni
comunità cristiana è affidata la conclusione perentoria della parabola: “Così è volontà del Padre
vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda” (Mt 18,14). Spetta alla Chiesa
cercare chi si smarrisce poiché il Padre vuole che neanche uno dei piccoli vada perduto.
Per attutire il contenuto paradossale della parabola sulla pecora perduta e smarrita, l’apocrifo
Vangelo di Tommaso riporta una versione diversa della parabola: “Gesù dice: Il regno è simile a un
pastore che ha cento pecore. Una, la più grande, si smarrì. Egli lasciò le novantanove e cercò
quell’una fino a quando la trovò. Dopo che si era affaticato disse alla pecora: Ti amo più delle
novantanove” (nr. 107). Si comprende bene che la redazione successiva della parabola cerca una
ragione plausibile per renderla comprensibile e la trova nella predilezione per la pecora smarrita.
Tuttavia si tratta di una rilettura che impoverisce la parabola, retta piuttosto sul paradossale modo di
agire di Gesù affidato alla comunità dei credenti.
La traiettoria della metafora perviene al suo approdo con il discorso sul buon pastore,
riportato in Gv 10,1-21: Gesù è nello stesso tempo la porta delle pecore che assicura la
sopravvivenza del gregge e il pastore bello e buono che dona la vita per le pecore. Torna così la
prospettiva del sacrificio o della trasformazione di quanto è profano in sacro e santo: il pastore si
differenzia dal mercenario e dai ladri perché offre la sua vita per le pecore e non perché assolve a un
ruolo diverso. Se il vangelo di Giovanni si è introdotto con la metafora dell’agnello che toglie il
3
peccato del mondo (cf. Gv 1,29) è perché, senza essere agnello, Gesù non può dirsi neanche
pastore.
Nella congiuntura tra l’agnello per il sacrificio e il pastore si comprende la ragione per cui
l’autore della Lettera agli Ebrei può chiudere il suo trattato soffermandosi sul Pastore grande delle
pecore. Il Risorto può dirsi tale non perché è Figlio di Dio, né perché è irradiazione della sua
sostanza, ma perché suo è il sangue versato per la nuova alleanza.
4. Conclusione
Si è abituati a trattare del trittico su Gesù Cristo servo, sommo sacerdote e pastore in modo
isolato o autonomo: il sacerdote è diverso dal pastore e dal servo. In realtà la triplice traiettoria su
cui ci siamo attardati è accomunata dal processo che dal sacrificio giunge al sacerdozio, al servo e al
pastore. Non è la natura che identifica Gesù come sommo sacerdote, servo e pastore, bensì la
relazione con quanti dona la vita per sempre. Nella prospettiva delineata il sacrificio, che accomuna
le tre attribuzioni bibliche, corrisponde non alla privazione di qualcosa, bensì al dono di sé per gli
altri. Se quanto abbiamo approfondito è condiviso, la dimensione sacerdotale della Chiesa non è
separata da quella pastorale e ministeriale o del servizio, ma le comprende in modo endemico. Gesù
è pastore grande delle pecore perché offrendo se stesso per loro è diventato sommo ed eterno
sacerdote. Il che significa che la dimensione pastorale non è opzionale, ma è strutturale rispetto a
quella sacerdotale: l’una e l’altra stanno e cadono insieme.
Desidero chiudere con il discorso di addio di Paolo agli anziani di Efeso a Mileto, secondo
la narrazione degli Atti degli apostoli; sintetizza e unifica, in modo esemplare, il trittico che
abbiamo approfondito: “Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge nel quale lo Spirito, quello santo,
vi ha messi come episcopi della chiesa di Dio, che si è acquistato con il suo sangue” (At 20,28). Si
tratta di una delle proposizioni più originali sulla pneumatologia nel Nuovo Testamento, che ha
creato difficoltà già per gli amanuensi dei codici neotestamentari. Con un’ardita e unica metafora il
Paolo degli Atti sostiene che lo Spirito è il proprietario del gregge che si è acquistato donando se
stesso per la Chiesa. Naturalmente non si può sostenere che lo Spirito abbia un sangue da versare,
ma la metafora intende sottolineare la dedizione dello Spirito per la Chiesa o per il gregge che non è
di altri se non suo.
Il sacrificio che motiva e fonda il sacerdozio di Cristo è stato possibile perché, come precisa
nuovamente la Lettera agli Ebrei, “egli mosso dallo Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a
Dio” (Eb 9,14). Se il sacrificio accomuna le tre dimensioni della cristologia neotestamentaria che
abbiamo evidenziato, chi lo rende perfetto o pienamente gradito a Dio è lo Spirito a cui la Chiesa
appartiene e da cui è affidata a ogni pastore.
d. Antonio Pitta
Pontificia Università Lateranense
Roma
4