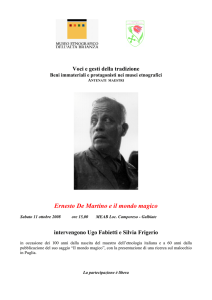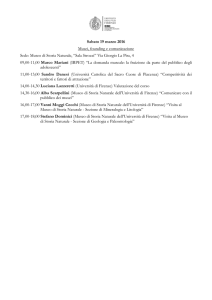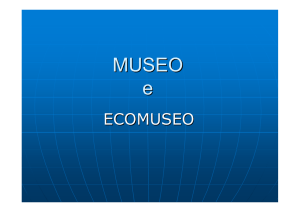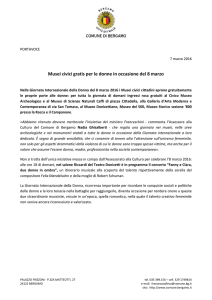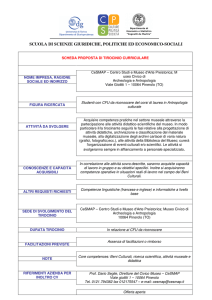I
#25/26
ANTROPOLOGIA MUSEALE ETNOGRAFIA PATRIMONI CULTURE VISIVE
?????????????????????????
????????????
quadrimestrale|anno 9|numero 25/26|autunno 2010|, 15,00|ISSN 1971-4815
Spedizione in A.P.D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1-DCB-BO
In caso di mancato recapito inviare a Imola UDR per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”
II
Antropologia Museale
Rivista quadrimestrale della Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici
Anno 9, Numero 25/26, autunno 2010
www.amrivista.org
Direttore: Vincenzo Padiglione
Redazione: Pietro Clemente, Vito Lattanzi,
Sandra Ferracuti, Rosa Anna Di Lella, Nadia Truglia, Francesco Staffa
Hanno collaborato a questo numero: ????????????????????????????.
Progetto grafico: Hstudio - www.hgrafica.com
Direttore responsabile: Peppino Pelliconi
Stampa: Tipografia Moderna (Ra)
Abbonamento annuo (3 numeri)
Italia: 15,00 euro
Una copia: 6 euro - arretrati il doppio. Chi volesse sottoscrivere l’abbonamento o richiedere, con l’invio al proprio
domicilio, numeri arretrati, dovrà effettuare un versamento sul c/c postale n. 18195404 intestato a Editrice La
Mandragora
I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati esclusivamente per l’invio della pubblicazione e
non vengono ceduti a terzi per alcun motivo
Le fotografie ed i testi, anche se non pubblicati, non vengono restituiti
Proprietà: Editrice La Mandragora S.r.l.
Via Selice, 92 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 642747 - Fax 0542 647314
E-mail: [email protected]
L’Editrice La Mandragora srl è iscritta al Registro Operatori di Comunicazione al n. 5446 dal 30 novembre 2001
Registrazione Tribunale di Bologna n. 7225 del 14 giugno 2002
Associato all’USPI: Unione Stampa Periodica Italiana
Recapiti della redazione:
c/o Insegnamento di Antropologia Culturale - Facoltà di Psicologia 2
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Via dei Marsi, 78 - 00185 Roma
Tel. 06 49917627
E-mail: [email protected]
Notizie e corrispondenze: [email protected] - [email protected] - [email protected]
Nelle copertine: ????????????????????????????????????????
www.amrivista.org
[MISSIONE MUSEI DEA] [DOSSIER PATRIMONIO INTANGIBILE/
TRADIZIONI] [IL FUTURO DEI MUSEI ETNOGRAFICI: INTERVISTA
A CUISENIER] [LA BIENNALE DELL’AFRICA] [QUAI BRANLY
SOTTO ESAME] [MUSEO DELLA COLTELLERIA DI MANIAGO] [ICOM
INTERNAZIONALE: INTERVISTA A JALLA] [UN MUSEO MOLTO
GIAPPONESE]
Agamennone, Altin, Apolito, Breda, Cestelli Guidi, Clemente, Cristofano,
Cuisenier, de Sanctis Ricciardone, Del Vecchio, Faeta, Ferracuti, Fini, Lattanzi,
Marazzi, Padiglione, Portelli, Putti
1
1
#18
ETNOGRAFIA PATRIMONI CULTURE VISIVE
[VALORIZZARE LE TRADIZIONI: INTERVISTA AD APOLITO E
CLEMENTE] [CULTURE NATIVE IN DIGITALE: UN PROGETTO
CANADESE E UNA BANCA DATI BRASILIANA] [MUSEO PITRÈ:
DOCUMENTI DALL’ARCHIVIO COCCHIARA] [GALLERIA: MUSEO DEL
BRIGANTAGGIO DI CELLERE] [MUSÉOBAR: IL CAFFÈ DEGLI ITALIANI
IN SAVOIA] [CORPI-MUSEO DALLA MILANO TATTOO CONVENTION]
[ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA: UN AVVIO
DI DIBATTITO] [BENI IMMATERIALI NELLA CONVENZIONE UNESCO]
[FORMAZIONE UNIVERSITARIA PER I MUSEALI DEA]
Apolito, Caruso, Clemente, D’Amato, Faulhaber, Gri, Lattanzi, Mariotti,
Padiglione, Remotti, Rossi, Truglia, Zingari
quadrimestrale|anno 5|numero 17|autunno 2007|, 6,00
quadrimestrale|anno 6|numero 18|inverno 2007-2008|, 6,00
Spedizione in A.P.D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1-DCB-BO
In caso di mancato recapito inviare a Imola UDR per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”
Spedizione in A.P.D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1-DCB-BO
In caso di mancato recapito inviare a Imola UDR per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”
#19 #20/2
ANTROPOLOGIA MUSEALE ETNOGRAFIA PATRIMONI CULTURE VISIVEANTROPOLOGIA MUSEALE ETNOGRAFIA PATRIMONI C
)!,%
In collaborazione con l’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna
#22 #23/24
ANTROPOLOGIA MUSEALE ETNOGRAFIA PATRIMONI CULTURE VISIVE
[ETNOGRAFIE DEL CONTEMPORANEO: PRATICHE E TEMI DEGLI ANTROPOLOGI]
[UN MUSEO PER LA MISSIONE ETNOLOGICA ITALIANA IN GHANA]
[MASCHERE E MUSEI: CONTESTI IN QUESTIONE] [CHE FINE HA
FATTO L’IMPERO BRITANNICO?] [GALLERIA LA MARQUE JEUNE AL
MEN] [REPATRIATION DI RESTI UMANI] [ETNOGRAFIA DELL’ABITARE:
LUOGHI CHE RACCONTANO] [MUSEO DELL’OCCHIALE] [MUSEI,
SILENZI E SCRITTURA] [MUSEUM FRICTIONS]
Clemente, Cristofano, Da Deppo, Dalai Emiliani, De Rossi, Fasulo, Ferracuti,
Giorgi, Gonseth, Jallà, Kezich, Maltese, Muzzopappa, Padiglione, Pavanello,
Poppi, Prayer, Sturani
[MISSIONE MUSEO ETNOLOGICO: INTERVISTA AD ANNE-M
BOUTTIAUX] [INTERCULTURA NEI MUSEI] [PATRIMONIO A
PLURALE] [MOSTRE COLLABORATIVE: LINGUA CONTRO LI
SAPERCI FARE] [DIDATTICA MUSEALE] [MUSEI E CULTUR
[OLU OGUIBE ARTISTA ETNOGRAFO] [ISTITUTO CENTRALE
LA DEMOETNOANTROPOLOGIA: UN PRIMO RISULTATO] [M
MEMORIE: REPORTAGE DALLA BOSNIA] [ELLIS ISLAND: IM
TURISTI] [UN RICORDO DI ERNESTO DE MARTINO]
Ascoltare (Clemente), Autorizzare (Malighetti), Comunicare (Apolito), Confrontarsi
(Lattanzi), Contestualizzare (Padiglione), Filmare (Ragazzi), Fotografare (Faeta), Guardare
(Grasseni), Intervistare (Zingari), Narrare (Sobrero), Patrimonializzare (Palumbo), Registrare
(Portelli), Restare (Teti), Ritornare (Imbriani), Schedare (Federico), Scoprire (Fabietti),
Shadowing (La Cecla), Viaggiare (Puccini)
quadrimestrale|anno 7|numero 19|estate 2008|, 6,00|ISSN 1971-4815
quadrimestrale|anno 7|numero 20/21|autunno/inverno 2008|, 6,00|IS
Spedizione in A.P.D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/04 n. 46) art.
In caso di mancato recapito inviare a Imola UDR per la restituzione al mittente prev
[LÉVI-STRAUSS PER ME: DENSI RICORDI, TESTIMONIANZE E ANALISI]
[INTERVISTA A REMOTTI E FABIETTI] [FIELDWORK A PANDORA]
[GALLERIA: MUSEOGRAFIA NATIVA ALLA BIENNALE] [IL PROFILO DEL
DEMOETNOANTROPOLOGO] [INSTALLAZIONE ETNOGRAFICA]
[ANTROPOLOGIA DELLE COSE CHE CAPITANO] [RICORDI: ANTONINO
UCCELLO] [L’ANNO DEI MEZZADRI] [IL CORPO POSTORGANICO]
Angioni, Bargna, Cannada Bartoli, Broccolini, Canevacci, Carosso, Cirese,
Clemente, De Palma, de Sanctis Ricciardone, Dei, Fabietti, Faeta, Ferracuti,
Frasca, Guido, Herzfeld, Ikejezie, Jones, Kezich, Lai, Lattanzi, Lutzu, Mantoani,
Marazzi, Mariotti, Meloni, Mithlo, Niola, Njami, Padiglione, Palumbo, Pennino,
Pizza, Putti, Ragazzi, Remotti, Sobrero, Teti, Tiragallo, Truglia, Tucci, Vereni
Bodo, Bouttiaux, Brambilla Ranise, Carosso, Casalino, Contini, Cos
Cristofano, Delgado Corral, De Palma, Di Lella, Faedda, Lattanzi, L
Mangiapane, Mascheroni, Millones, Padiglione, Paini, Pecci, Perin,
Prayer, San Martin, Staffa, Tucci, Turci
Spedizione in A.P.D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1-DCB-BO
In caso di mancato recapito inviare a Imola UDR per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”
1
.5-
%2/
#17
1
30%#
1
quadrimestrale|anno 8|numero 22|speciale 2009|, 15,00
Spedizione in A.P.D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1-DCB-BO
In caso di mancato recapito inviare a Imola UDR per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”
quadrimestrale|anno 8|numero 23/24|autunno-inverno 2009|, 12,00|ISSN 1971-4815
Spedizione in A.P.D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1-DCB-BO
In caso di mancato recapito inviare a Imola UDR per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”
soglia
sommario
editoriale
pag.
VI Essere contemporanei. Musei, patrimonio, antropologia
Direttivo Simbdea
pag.
VII Matera città dell’antropologia e capitale europea della cultura nel 2019
Ferdinando Mirizzi
pag.
VIII
pag.
VIII Sandra Ferracuti - Vito Lattanzi
ESSERE CONTEMPORANEI: TEMI IN DISCUSSIONE
presentazione
pag.
IX Patrimonio, comunità e turismo
Alessandro Simonicca (sintesi della discussione a cura di Letizia Pelegrini)
pag.
XII Tradizioni del contemporaneo
Paolo Apolito (sintesi della discussione a cura di Michele Iannuzzi)
pag.
XV Liste UNESCO e politiche del patrimonio
Luciana Mariotti (sintesi della discussione a cura di Mariaclaudia Cristofano)
pag.
XVI La cultura materiale nel contemporaneo
Fabio Dei (sintesi della discussione a cura di Angela Cicirelli)
pag.
XX Lavoro, impresa, mobilità
Cristina Papa (sintesi della discussione a cura di
pag.
XXVI Arte contemporanea e critica culturale
Roberta Cafuri (sintesi della discussione a cura di Elisabetta Frasca)
pag.
XXIX Patrimoni e culture migranti
Anna Maria Pecci (sintesi della discussione a cura di Martina Cultrone)
pag.
XXXII Sostenibilità culturale e biodiversità
Daniela Perco (con un contributo di Maria Gabriella Da Re)
pag.
galleria
XXXIX “Oggi, nel corso della vita. Riti di passaggio”: mostra collettiva di installazioni
etnografiche del contemporaneo
pag.
pag.
XXXIX Pietro Clemente e Vincenzo Padiglione
XL Installazioni di:
Ars Videndi; Alessandra Broccolini; Elisa Bellato, Antonella De Nisco, Anna Paini; Giuditta Barduzzi,
Francesca Bazzanti, Federica Caponnetto; Giulia Bevilacqua; Ciriaca Coretti, Mariana Malvaso,
Stefania Martinese, Amalia Trivisani; Marco D’Aureli; Elena De Sabbata, Gian Paolo Gri, Stefano
Morandini; Paolo De Simonia, Michele Mucci; Rosa Anna Di Lella; Sandra Ferracuti; Tiziana Gentili,
Maria Lisa Platania, Angelica Grieco; Costanza Lanzara, Gabriella Lerario; Museo degli Usi e
Costumi della Gente di Romagna; Museo Ettore Guatelli; Anna Maria Pecci, Gianluigi Mangiapane,
Andrea Perin; Sam Pezza; Massimo Pirovano; Silvia Settimi; Nadia Truglia; ABYTHOS e altri
pag.
mostra
LI “Sguardi da lontano. Frammenti etnografici dell’Umbria contadina nelle
immagini di Paul Scheuermeier e di Ugo Pellis (1924-1939)”
pag.
LI Uno sguardo da lontano
Mario Turci
pag.
LII Un’esperienza didattica
Francesco Farabi
pag.
LIII Giovani “etnografi sperimentali”
pag.
LIII Alessandra Broccolini - Piero Vereni.
pag.
LVI I musei si raccontano
Antonella Iacovino - Mario Turci
pag.
poster
evidenza
LVIII Finalmente ratificato il profilo professionale di demoetnoantropologo
Vito Lattanzi
pag.
LIX Carta nazionale del restauro e patrimonio demoetnoantropologico
Vito Lattanzi
pag.
LXI Nasce SinbdeaLab
Angela Cicirelli e Ciriaca Coretti
VI
editoriale
essere contemporanei.
Musei, patrimonio, antropologia
Nella difficile vita politica e sociale dell’Italia d’oggi e nel dramma della marginalità di ogni iniziativa culturale, la Società
Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtno Antropologici (SIMBDEA) ha voluto lanciare una iniziativa che – nella modestia delle nostre forze e della capacità di mobilitazione – chiamasse a riflettere antropologi, gente dei musei e della
cultura popolare, giovani, sull’Essere contemporanei, per rispondere come studiosi e comunicatori di cultura e museo
alle domande del presente. Lo abbiamo fatto con l’intenzione di fare ‘congresso’, nel senso di mettere insieme, far incontrare le diverse componenti di una comunità ampia, non solo disciplinare, dispersa, ma sempre attiva nella società
civile. Avremmo voluto avere testimonianze anche più larghe della società civile italiana, del volontariato, delle associazioni dei vari settori, dalla biodiversità ai consumi sostenibili, ma per questa occasione abbiamo privilegiato il dialogo
con le associazioni dei musei, con la rete italiana della cultura popolare, con varie istituzioni regionali.
Con-gresso, come cum-gredi, muoversi insieme, rispondere a una chiamata comune e incontrarsi. Anche per questo
abbiamo voluto proporre, intorno alle sessioni di discussione, formazione e aggiornamento, che sono al centro del
Congresso, e che affrontano i temi del contemporaneo nello specifico del patrimonio, delle tradizioni, del turismo,
della valorizzazione, delle convenzioni UNESCO e altro, una iniziativa assai articolata, con poster, installazioni, centri
di informazione istituzionale, mostre e l’evento della ‘fanta-antropologia’, il bar camp. Il congresso è stato una prima
verifica dell’immaginazione, della fantasia, del coraggio dell’antropologia e della museografia nell’affrontare il presente e il futuro anche con nuovi linguaggi, forme di comunicazione sperimentali.
Le lezioni ‘performance’ di fanta-antropologia hanno provato a disegnare uno scenario futuro del nostro lavoro nella
società che il mondo globale sta velocemente mutando. Antropologi che pensano al nostro mondo e alle nostre ricerche nella società del 2049, tra la tragedia che si disegna nel presente del mondo in guerra e disastro ambientale
e le speranze e le catastrofi che si disegnano per il futuro, si sono chiesti: che ne sarà degli ‘angoli di mondo’, come
saranno allora? che ne sarà dei nostri musei, fragili presidi di una frontiera tra passato e futuro, tra diversità e unificazione neoliberale del mondo? L’antropologia italiana che, finora, non ha dedicato molte pagine né all’uso dei telefoni cellulari, né alla guerra, né al ruolo della Lega Nord nella società attuale, a Matera ha dimostrato di saper guardare anche al presente con grinta.
I giovani che escono dalla Università, dai corsi di dottorato e dalla Scuola di Specializzazione, o che si avvicinano ai nostri musei, sono stati gli ospiti d’onore del congresso: il tesoro vivente, il ‘patrimonio’ sono loro, se sapremo aiutarli a
non disperderlo. Sentiamo che è tempo di forti alleanze per un uso partecipativo e democratico dei nostri saperi nella
società civile, e che è tempo di forti prese di posizione per cambiare una forza di inerzia negativa che ci colpisce, nell’Università come nella Società civile. Alla fine totale delle risorse per la ricerca pura nel settore demoetnoantropologico, alla
continua riduzione dei nostri insegnamenti in una Università dissanguata da tagli di risorse che non hanno a che fare
con il merito e la conoscenza, ma solo con il bilancio, fa eco la costante riduzione delle risorse degli enti locali e delle
regioni, e il dato evidente è che la cultura è il primo settore a subire tagli. L’invito a venire a Matera è stato animato
dalla convinzione che l’unico modo di reagire a questo stato di cose sia guardare avanti, guardarsi intorno, ‘sortirne insieme’, fare congresso. Abbiamo quindi raccolto risorse limitate per organizzare e favorire la partecipazione dei giovani
e abbiamo contato sull’abitudine al volontariato e sulla passione intellettuale, morale e civile della nostra comunità.
Il direttivo SIMBDEA
VII
Matera città dell’antropologia
e capitale europea della cultura nel 2019
Matera è già stata capitale: capitale e «simbolo delle
città contadine», come scrisse Riccardo Musatti nel
presentare le ragioni alla base dello studio della
Commissione coordinata da Friedrich Friedmann e istituita nel 1951 dall’UNNRA-Casas in collaborazione con
l’INU, di cui era allora vice presidente Adriano Olivetti.
Lo ha ricordato Eugenio Imbriani nel suo intervento alla
Tavola Rotonda su “Matera città dell’antropologia e
capitale europea della cultura nel 2019”, che si è svolta
il 2 ottobre nella sede di Palazzo Lanfranchi, all’interno
del congresso della SIMBDEA sul tema “Essere contemporanei. Musei, patrimonio, antropologia”. Era stato
soprattutto Carlo Levi con il Cristo si è fermato a Eboli
a diffondere l’idea di “Matera capitale contadina del
Sud”, di simbolo cioè di un mondo rurale segnato da
miseria, oppressione, emarginazione che rivendicava il
suo riscatto attraverso processi di liberazione ed emancipazione sociale e politica. Si può dire che di lì sia partita la progressiva definizione dell’immagine di Matera
come uno dei luoghi fondativi dell’antropologia italiana: il suo costituirsi e affermarsi nelle coscienze del
secondo dopoguerra come «metropoli dei cavernicoli»,
secondo l’espressione ancora di Musatti, procedeva infatti di pari passo con un ormai insopprimibile bisogno
di conoscenza di quel mondo contadino rimasto a
lungo ai margini della storia e che allora, come aveva
scritto Ernesto de Martino nel suo noto saggio pubblicato in «Società» del settembre 1949, premeva per entrarvi. Era dunque in quella stagione esaltante per l’antropologia, e le scienze sociali in genere, rappresentata
dagli anni del secondo dopoguerra che Matera, mentre i Sassi si svuotavano e i loro abitanti erano trasferiti
nei villaggi rurali e nei nuovi rioni urbani previsti dal
piano regolatore redatto da Luigi Piccinato, diventava
da “capitale contadina” una “città dell’antropologia”,
profondamente legata ai nomi di Levi e Scotellaro, di
Friedmann e de Martino, di Tentori e Bronzini, a intellettuali e a testi cioè che hanno scritto e costituito pagine importanti nel processo di rifondazione delle
scienze etnoantropologiche italiane sul piano tanto
concettuale quanto metodologico.
Matera fu in quegli anni oggetto e teatro di dibattiti
accesi sui temi del meridionalismo e del riscatto delle
classi subalterne, come è testimoniato dal convegno
svoltosi il 6 febbraio 1955, dedicato a Rocco Scotellaro
da poco scomparso, che vide protagonisti, tra gli altri,
Vincenzo Milillo, Carlo Levi, Franco Fortini, Renato
Panzieri, Luigi Anderlini, Carlo Muscetta, Mario Alicata,
Gianni Bosio e Alberto Mario Cirese. E non è certo un
caso che Pietro Clemente citasse tale incontro nel suo
intervento di apertura del congresso, la sera del 29 settembre, come uno degli eventi fondativi della percezione di Matera come luogo evocativo dell’orizzonte
segnato dalle esperienze e dagli studi antropologici in
Italia.
Abbiamo voluto rimarcare tutto ciò nella Tavola
Rotonda del 2 ottobre per comunicare alla città il senso
che essa ha per la comunità degli antropologi e per fornire elementi utili per dare senso e vigore alla candidatura di Matera a capitale europea della cultura nel
2019. In questo quadro si sono collocati anche gli interventi dei relatori non antropologi invitati nell’occasione a dialogare con Paolo Apolito, Florence Pizzorni
e il citato Eugenio Imbriani. Mi riferisco a Raffaello de
Ruggieri, fondatore con altri dello storico Circolo “La
Scaletta” e ora presidente della Fondazione Zétema, di
Marta Ragozzino, soprintendente per i BSAE della
Basilicata, e di Antonio Nicoletti, rappresentante
dell’Associazione Matera2019. Tutti e tre hanno dato
un contributo concreto alla discussione, ricordando il
primo le esperienze condotte dagli anni Sessanta in poi
per la valorizzazione dei Sassi e dell’intero territorio
materano come patrimonio culturale e quale luogo
esemplificativo della vita dell’uomo nella sua continuità
storica; ricostruendo la seconda l’attenzione manifestata nei confronti dei beni di interesse DEA da parte
della Soprintendenza regionale con sede a Matera fin
dagli anni della sua istituzione, attenzione che ha avuto
il suo apice nella mostra dedicata nel 2003 alle collezioni e ai musei etnografici lucani e allestita negli spazi
di Palazzo Lanfranchi; illustrando il terzo le ragioni che
hanno ispirato la nascita dell’Associazione contestualmente alla elaborazione della proposta della candidatura della città per il 2019.
Sulla base di quanto ascoltato e facendo tesoro di
esperienze precedenti, come quella che ha portato
Marsiglia alla designazione di capitale della cultura per
il 2013, nei loro interventi Florence Pizzorni e Paolo
Apolito hanno evidenziato come il successo della candidatura di Matera a capitale europea della cultura
debba passare attraverso la valorizzazione delle sue debolezze e dei suoi aspetti apparentemente negativi.
Così, ad esempio, Apolito ha invitato a considerare
come un valore elementi come la marginalità geografica di Matera e la lentezza che la caratterizza, come
anche altre città del Sud, se la si confronta con la dinamicità e la velocità della vita in altre aree urbane, specie del Nord del Paese. Concludendo con l’invito a
prendere in considerazione la possibilità di organizzare,
tra le iniziative inseribili in un ipotetico programma per
la promozione della candidatura, un grande festival
della cultura popolare e dell’antropologia fondato
sull’incontro tra società e culture di varie parti del pianeta. E, in tale prospettiva, troverebbe opportuna collocazione anche un’altra dimensione che, specie nell’ultimo decennio, Matera ha cercato di darsi nel panorama nazionale: quella di città della pace e dei diritti
umani.
D’altra parte, Matera ha già ampiamente dimostrato la
sua capacità di volgere in positivo ciò che era motivo
ed espressione di negatività, se è vero che proprio per
i Sassi, scandalo etnografico e vergogna nazionale negli anni Cinquanta del ’900, essa è stata dichiarata nel
1993, primo sito del Mezzogiorno d’Italia, patrimonio
dell’Unesco, trasformando un luogo precario di abitazioni malsane in grotta in uno “straordinario” ecosistema urbano e in un luogo evocativo della lunga vicenda umana dal paleolitico a oggi e facendone, inoltre, la scenografia ideale per ambientazioni cinematografiche di varia natura. Con il rischio, però, da cui oggi
la comunità materana deve guardarsi, che si producano forme di autocompiacimento estetico e che si accentuino gli usi scenografici della città in funzione di un
turismo sempre più di massa e di un uso acritico dei
suoi spazi, dimenticandone i significati storici e sociali
che li hanno caratterizzati nel tempo.
Ferdinando Mirizzi
VIII
Sandra Ferracuti - Vito Lattanzi
presentazione
essere contemporanei: temi in discussione
L’organizzazione in otto sessioni del primo Congresso Nazionale della Società Italiana per la Museografia e i Beni
Demoetnoantropologici, ha avuto come principio di ispirazione la volontà di rappresentare nel modo più ampio possibile, a nove anni dalla costituzione dell’associazione, i temi di discussione che nell’ultimo decennio hanno accompagnato la ricerca e il dibattito professionale dell’antropologia museale italiana.
Se si tiene conto che questo decennio ha visto operare con continuità la rivista AM e che sulle sue pagine si possono
ripercorrere le fasi salienti di crescita e di sviluppo di un rapporto sempre più stretto, nonché fertile di riflessioni teoriche, tra musei, antropologia e patrimoni, si può forse comprendere la difficoltà di strutturare l’articolazione di un
primo dibattito congressuale tenendo conto dei diversi filoni di interesse e senza sottovalutare le aspettative dei potenziali partecipanti.
Il consiglio direttivo della Simbdea ha svolto sulle questioni organizzative del Congresso una istruttoria preliminare
alla quale sono stati chiamati a partecipare, quasi come in un comitato scientifico, Paolo Apolito, Berardino Palumbo,
Cristina Papa, Gabriella Da Re, Alessandro Simonicca e Fabio Dei. Insieme a loro si è cominciato a ragionare sui temi
del contemporaneo per poter anzitutto trovare una rosa di problematiche e alcuni punti di riferimento teorici ai quali
ancorare le scelte dell’impianto concettuale del congresso.
Il titolo scelto successivamente per il congresso, da un lato, ci ha aiutato a circoscrivere il taglio da dare alle sessioni,
individuando in alcune parole di stringente attualità la chiave di volta dell’impresa affidataci, dall’altro, ci ha costretto
a un lavoro di selezione e proposta delicato e complesso, che ha trovato forma nella articolazione delle otto sessioni
di cui sinteticamente si rende conto in questa sede.
Per dare alle sessioni centralità nella struttura del congresso abbiamo deciso di rinunciare alla presentazione di relazioni in seduta plenaria su temi di carattere generale, optando invece per una piena valorizzazione di momenti paralleli di discussione, articolati in una forma più seminariale. Ciascuna sessione aveva dunque bisogno di un suo coordinatore, scelto in base a competenze riferibili alla tematica specifica. Agli otto presentatori della tematica è stata
richiesta un’introduzione capace di indicare topiche e prospettive cui riferire il dibattito e la richiesta pubblica di interventi è stata accompagnata da un invito a coordinarsi con il responsabile della singola sessione, in modo da arrivare ad un programma più orientato verso la reale possibilità di confronto e di dibattito sui diversi temi. Solo in fase
di riorganizzazione degli interventi nelle singole sessioni ad ogni coordinatore è stato affiancato un primo discussant,
in modo da assicurare uno svolgimento il più possibile completo dal punto di vista del confronto. Ogni sessione infine è stata seguita da un rapporteur che avrebbe poi riferito in seduta plenari dei risultati dei lavori.
Quanti abbiano partecipato al congresso di Matera e seguito le sessioni possono senz’altro valutare la funzionalità
di questo modello organizzativo, purtroppo non rappresentabile nelle poche pagine a disposizione nella nostra rivista, dove abbiamo potuto riportare soltanto gli interventi introduttivi dei coordinatori di sessione e le sintesi dei rapporteur.
Il nostro giudizio, che su questa formula ha deciso di investire molto, è tutto sommato positivo. Anche se l’adesione
all’appello di partecipare alle varie sessioni è stata molto condizionata dai titoli delle sessioni stesse, a volte di grande
attrazione ma troppo generali rispetto alla specificità di alcuni altri temi (si pensi alla concorrenza tra turismo e biodiversità o tra politiche Unesco e problematiche del lavoro), questo incontro ha rappresentato per noi una preziosa
occasione di scambio e confronto con un ampio ed eterogeneo gruppo di compagni di strada. Da un lato, abbiamo
potuto avere nuova conferma della varietà e dell’intensità dei progetti di ricerca e degli impegni professionali dei nostri colleghi, dall’altro rinnovare l’impegno a riflettere criticamente sui nostri percorsi e sperimentare nuove chiavi di
lettura delle nostre pratiche. Le sintesi che sono il risultato del generoso sforzo dei rapporteur di condensare la vitalità dei nostri incontri, se non possono ovviamente esaurire le tematiche, le aree di intervento ed nodi critici discussi
dai loro protagonisti, diventano qui anche un invito ad ulteriori percorsi di condivisione.
IX
PATRIMONIO, COMUNITÀ E TURISMO
Introduce Alessandro Simonicca
primo discussant Ferdinando Mirizzi
La sessione di lavoro vuole affrontare l’ampio quadro delle
articolazioni contemporanee della cultura, viste da una triplice convergente prospettiva: la messa in valore patrimoniale, la significatività dei criteri di appartenenza, le modalità della fruizione. A tal fine, il nesso costituito dai territori attraversati dal patrimonio, dalla comunità e dal turismo riesce a rendere al meglio le diverse anime di un processo attuale, di cui vale la pena precisare molteplicità costitutiva e specifica coniugazione storico-istituzionale.
Il patrimonio è termine oramai acquisito dalla discussione (interdisciplinare) internazionale che tende sempre
più a indicare il modo in cui la dimensione del passato riappare in ri/rappresentazioni attuali, lungo una vastissima serie di settori che spaziano dai beni immateriali,
alle performance, ai monumenti, alle pratiche storicoculturali, alle nuove etnicità, alle risorse naturali, alle biodiversità, ai prodotti tipici territoriali, alle storie di vita
delle “località”, ai “contesti a sistema” di cui i parchi e
gli ecomusei risultano le gemmazioni più note. La vastità
dei campi interessati, la pluralità delle esperienze, la varietà delle azioni impegnate rendono assai complessa la
stessa classificazione delle “varianti” patrimoniali, ma
sottolineano al tempo stesso la necessità di pensare in
maniera più “fluida” la trasmissione e la riappropriazione del passato da parte del presente. È nel rapporto
fra passato e presente infatti che si incunea la forza e la
prassi categoriale del “patrimonio”, ove l’aspetto più importante è la fine (o per lo meno la crisi) della convinzione circa tendenze uniformi del “moderno” e l’acquisizione consapevole della presenza di nuovi trend, di cui
la pluralizzazione delle forme di vita e dei contesti istituzionali è una delle prime evidenze.
Se sino agli anni Settanta del Novecento vigeva ancora
la forza attrattiva degli Stati e si faceva sentire intatta la
storia della cultura dal punto di vista delle costituzioni
nazionali che – per così dire – incarnavano, più o meno
romanticamente, manifestazioni particolari dello spirito
della modernità (id est, della cultura egemone euroamericana), il periodo successivo risulta caratterizzato, per
grandi linee, da generali tendenze, ancora in atto e ancora lungi dall’avere raggiunto pieno sviluppo, quali il
postfordismo, la de-industrializzazione, la globalizzazione, la delocalizzazione, la frammentazione regionale,
la nascita di nuovi essenzialismi etnologici, l’universalizzazione planetaria del mercato.
La categoria di “comunità” entra a questo di livello di
analisi in tutta la sua ridondanza. Ovviamente, non si
tratta più di comunità che reclamano ambiti di vita autonoma e autosufficiente a livello materiale e ideale. Da
questo punto di vista, l’accezione di Gemeinschaft alla
Tönnies (in astratta opposizione a Gesellschaft) è scientificamente inadeguata a descrivere l’attuale stato del
mondo. Oggi, non si possono più opporre i due termini,
tanto meno conferire loro una specifica separatezza,
giacché i principi sintetici che presiedono alla produzione
e riproduzione sociale e simbolica di gruppi/formazioni/
società escludono in maniera sempre più forte le logiche
che oppongono seccamente “tradizione” a “modernità”. Sia le leggi economiche del mercato, sia le dinamiche della trasmissione mediale di immagini/concetti/
pratiche tendono a rendere più omogenee le processualità dell’ecumene (come si esprime Ulf Hannerz). Risulta
anzi sempre più sensato asserire che il rapporto fra il tradizionale e il moderno non sia da considerare come la
descrizione di due epoche temporalmente diverse e in
successione, quanto una relazione logica: è il presente a
produrre il tradizionale, come modo di pensare il passato
e le sue storie; e il tradizionale diviene così una forma
narrativa del passato, coniugato in una delle sue molteplici storie di vita.
Tradizionale e moderno, così come comunità e società,
più che sintetiche categorie descrittive divengono rappresentazioni analitiche della realtà, in quanto appresa
da un singolare punto di vista o da una particolare prospettiva.
La comunità/le comunità della contemporaneità, quindi,
più che mondi vitali organicamente autonomi, sono le
emergenze insorgenti dall’incontro fra tendenze della
globalizzazione e idiosincratici contesti vitali. La sincresi
dell’incontro detiene elementi sia della vita previa di una
località sia elementi portati da altrove, e tali elementi
sono rappresentati e vissuti secondo il senso che il presente conferisce alla cosiddetta “tradizione”. Il taglio, lo
scenario e la prospettiva che ne risultano agiscono in termini di interpretazione, rifiutano la logica monolitica
della monogenesi culturale, e ripercorrono le complesse
e contraddittorie sequenze che i plurimi attori locali
hanno del loro territorio e del corrispettivo spazio di vita.
È questo il senso della diffusa tesi odierna di una “produzione della località”, e in questo senso tale produzione si distingue per essere tutta permeata da pluralità
di interpretazioni di immagini del passato, e perciò conflittuale. Comunità, quindi, di plurimi attori conflittual-
X
mente schierati, e perciò comunità attesa e voluta, certo,
ma, anche e continuamente, contestata, negoziata,
spesso in bilico.
Il terzo momento del trinomio è il turismo. Se intendiamo
per turismo il processo complesso di dislocazione e trasferimento di persone, immagini e pratiche, allora cogliamo
il movimento del farsi della contemporaneità nelle linee
modulari del “tempo libero”. Qui le coordinate precipue,
quelle del viaggio, di continuo colgono soggetti e gruppi
di soggetti intenti a costruire e ricostruire siti/comunità/località da un lato, e soggetti che ne fruiscono in maniera
tipologicamente differenziata dall’altro.
Il movimento della costruzione dei “luoghi” entro le processualità della differenziazione si oppone ai trend di
omogeneizzazione della globalizzazione per formare
“frammenti” diversi di singolarità spaziali, non raramente incomparabili, a diversi livelli di consapevolezza
dei singoli e dei gruppi. Le autorappresentazioni che le
località operano su se stesse spingono verso la potenziale valorizzazione di tutte le risorse (culturali, naturali,
storiche) e, al contempo, alla selezione di alcune di esse
da leggere come insieme di tratti capaci di distinguere
un luogo dall’altro, con esiti diversi, dalla armonizzazione alla sincope.
È per queste ragioni che risulta assai importante vedere
come, nella (sia pur parziale) eclissi delle tendenze nazional-statali, alla costruzione di una “storia della cultura”
omogenea e narrata secondo schemi di progressiva
enunciazione unitaria, gli spazi sociali e umani si differenzino per scelta di materiali, contesti umani, sequenze
storiche ed optino per regimi di interpretazione locale
decisamente autocentrata. Dal punto di vista (per lo
meno) conoscitivo, si tratta di vedere come alla orizzontalizzazione delle potenzialità territoriali nella loro più
ampia versione corrisponda una culturalizzazione della
loro messa in valore, interpretazione ed esposizione; e
come a tale complesso processo partecipino gruppi, lobbies e settori della vita pubblica interessati a farsi parte
egemone del processo, individuando tanto privilegi di
status rappresentativo, quanto fonti e giacimenti di
estrazione di reddito e ricchezza. Senza il segmento della
esposizione e messa in vendita della fruizione delle risorse il circuito di produzione della località rischia di divenire o puro circuito semiotico esibitivo oppure vuoto
eruditismo particolaristico di storia patria.
Su questo crocicchio di movimenti e convergenze si installa lo studio antropologico dei fatti sociali contemporanei, attento a delimitare etnograficamente un campo
fin troppo esteso di temi e processi, nonché impegnato
a sviluppare più affinati strumenti di analisi della realtà.
E proprio su questo ultimo aspetto vale la pena di indicare sin da ora due momenti cruciali delle nuove esigenze di studio e di azione: una più consapevole etnografia delle articolazioni odierne della cultura nell’ambito
del territorio, e una maturata capacità di cogliere l’inestricabile nesso fra valorizzazione dei territori e sviluppo
locale, entro cui anche le analisi, le ricerche e i progetti
di parte antropologica fanno oramai parte, divenendo al
tempo stesso (come sosteneva a suo tempo Claude LéviStrauss per l’etnologia) soggetto e oggetto di analisi
(Alessandro Simonicca).
Sintesi della discussione
I tre grandi temi relativi alla sessione di discussione,
Patrimonio, Comunità e Turismo, sono stati analizzati
alla luce del più attuale fenomeno di globalizzazione
dell’economia e delle diverse esperienze culturali locali.
Le diverse relazioni hanno messo in evidenza come la di-
XI
mensione del passato, fatto di storia, personaggi, cultura
immateriale, prodotti tipici, riappaia in ri-rappresentazioni attuali.
A fare da filo conduttore a questa sessione la logica di
mercato secondo la quale tradizione e moderno non
sono più considerate epoche distinte, ma in relazione logica tra loro. Il presente produce il tradizionale e lo fa in
funzione dell’economia e del turismo.
Ma in che modo?
Prendiamo in considerazione i numerosi esempi relativi
al “prodotto tipico”. Acciughe di Monterosso, vino delle
Cinque Terre, per citarne alcuni, In questi prodotti le comunità locali si riconoscono in maniera preponderante.
Contro una tendenza che punta alla globalizzazione dei
mercati, l’operazione di marketing, proposta dagli Enti
Locali, consiste nel preservare, valorizzare e garantire la
tipicità di questi prodotti che si potrebbero definire
“della nonna” . L’autenticità conferisce a questi un valore aggiunto di genuinità e di radicamento nel territorio, rendendoli particolarmente appetibili agli occhi del
turista, disposto a pagare alte cifre per un prodotto che
un tempo faceva parte della tradizione povera contadina.
L’economia gioca un ruolo importante anche nel processo di patrimonializzazione di pratiche lavorative ormai
abbandonate. È il caso della mattanza nell’isola di
Favignana, dove, anche se ormai abbandonata da più di
mezzo secolo, questa pratica oggi si è trasformata in
performance e in elemento di attrazione turistica.
A fini turistici, si fanno spettacolarizzanti, anche le pratiche religiose. A Scicli, in provincia di Ragusa, la
Processione del Cristo Risorto, perde quasi la sua carica
di ufficialità ecclesiastica per diventare uno show al
quale la comunità, che in questa festa si identifica, non
vede l’ora di assistere.
Il tradizionale fa branding. E anche i costumi che, insieme con gli oggetti della cultura del contadino, sono
esposti sempre più numerosi nelle vetrine dei negozi.
L’oggetto della cultura materiale perde il proprio significato e il suo ruolo nella costruzione della memoria culturale, per essere inglobato nella logica di mercato.
Elementi di promozione del territorio diventano anche le
vecchie strutture, come le cantine ipogee di Chiaromonte,
utilizzate in maniera intensiva tra ‘700 e ‘900 e dopo abbandonate, vengono oggi ri-trasformate per la creazione
di percorsi turistici enogastronomici.
In funzione del turismo viene anche recuperato il patrimonio orale e materiale. A partire dalla creazione di un
museo o di un parco si cerca di dare un senso di identità
alle popolazioni locali e allo stesso tempo se ne fa un volano dell’economia.
L’antropologia, attraverso l’attività di parchi ed ecomusei ha sollecitato diverse forme di valorizzazione dei saperi e delle pratiche “tradizionali” e contribuito alla definizione di nuovi modello di sviluppo locale sostenibili.
Gli ecomusei puntando alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, hanno creato
“mappe di comunità” che si fanno strumenti importanti
per fare emergere le vocazioni dei luoghi e delle comunità che in esse agiscono.
Concorrono alla creazione dell’identità locale anche i
parchi letterari. Attraverso la letteratura illustrano l’evoluzione della comunità e si fanno promotori della valorizzazione dell’ambiente, della storia e delle tradizioni di
chi quel luogo abita.
Il nesso ricerca di identità/turismo si fa stretto. Ed è compito dell’antropologo individuare il processo politico economico che sta dietro al marketing.
Il patrimonio testimone della storia, della terra e
dell’uomo, delle pratiche, delle visioni del mondo, dei
rapporti sociali, delle concezioni estetiche, delle evoluzioni tecniche, insieme con la tradizione orale si fa
espressione delle identità culturali delle collettività
umane ed anche risorsa del turismo (a cura di Letizia
Pellegrini).
Hanno partecipato: Matteo Aria (Università di Verona),
Giancarlo Baronti (Direttore della Scuola di
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici Università di Perugia), Elisa Bellato (Museo
etnografico della provincia di Belluno), Andrea Benassi
(IsIAO - Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente, Roma), Maria Consiglia Rosaria Binetti
(Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici della Puglia), Francesco Bravin
(Ricercatore indipendente), Marinella
Carosso (Università di Milano-Bicocca), Eleonora
Cassinelli (Ricercatrice indipendente),
Alessandro Cocchieri (Museo delle paludi pontine Pontinia), Antonio Conte (Università
della Basilicata), Alessandro D’Amato (Ricercatore indipendente), Ilaria d’Auria (Laboratoire
d’Anthropologie des Mondes Contemporains, Université
Libre de Bruxelles), Alessia Fiorillo
(Università di Perugia), Michela Forgione (Docente a contratto - Università di Napoli Federico
II), Francesco Foschino (Ricercatore indipendente),
Bogdan Iancu (Dottorando Università
XII
SNSPA, Bucarest - ricercatore, Museo del Contadino
Romeno di Bucarest), Franco Lai (Università
di Sassari), Luciano Ledda (Scuola di Specializzazione in
Beni DemoetnoantropologiciUniversità di Perugia), Alessandro Lutri (Università di
Catania), Claudia Marchesoni (Istituto
Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut), Francesca
Mariotti (Dottoranda - Università
di Siena), Vintila Mihailescu (Direttore del Dipartimento
di Antropologia, SNSPA, Bucarest),
Teodora Mocan (Università di Perugia), Elena Negro
(Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano
Nord - Ricercatrice indipendente), Gaetano Pennino
(Università di Palermo), Federico
Scarpelli (Anthropolis), Ilaria Elisea Scerrato (IsIAO Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
- Roma), Monica Stroe (Dottoranda - SNSPA Bucarest),
Francesca Romana Uccella (Càtedra M. Àngels Anglada
de Patrimoni Literari - Universitat de Girona e Universitat
de Barcelona)
TRADIZIONI DEL CONTEMPORANEO
Introduce Paolo Apolito
primo discussant Vincenzo Padiglione
1. Io penso che sia chiaro a voi come a me che l’espressione “tradizioni del contemporaneo” proposta dagli organizzatori del Congresso sia poco più o poco meno che
una provocazione intellettuale. Alla quale è giusto rispondere assecondandola. Perché il senso comune direbbe che le tradizioni siano nella contemporaneità, non
della contemporaneità (come il “cristiano” dei padri
della Chiesa, nel mondo non del mondo). Ma il senso comune inganna, come quando noi diciamo che il sole tramonta sull’orizzonte e sappiamo che non è vero. Ecco,
dire che le tradizioni siano del passato è un po’ come
dire che il sole sorge e poi tramonta. Un mix di percezione distorta dalla trappola del linguaggio e di gioco retorico della comunicazione. Dunque tradizioni della contemporaneità per prima cosa spinge a rompere questo
arcano del senso comune. Dove sono collocate le tradizioni? Davvero funziona ancora questo spartiacque e
spartivento che separa e taglia le tradizioni dalla modernità (magari con aggettivazione: regressiva/progressiva)?
È chiaro a noi tutti, se riflettiamo sulle nostre esperienze
di ricerca, ma già solo sulla nostra vita ordinaria, che non
è così più, se mai lo sia stato. Questo è l’approccio che
vorrei suggerire: il sole non sorge, né tramonta. Si tratta
di una trappola linguistica del senso comune. A suo
modo utile, ma non per capire i fenomeni astronomici,
bensì per classificare in un modo riconoscibile e condiviso le esperienze percettive. Le tradizioni non stanno là
e la contemporaneità qua. Si tratta di una trappola semantico-storica del senso comune. Allora propongo un
mutamento del linguaggio con cui ne parliamo. A cominciare dal campo metaforico oggi prevalente, che le
assimila ai beni patrimoniali: monumenti e opere del
passato, da conservare, salvaguardare e valorizzare (di
cui non a caso ci chiediamo come conservare-salvaguardare-valorizzare la testimonianza del passato per trasportarle nel futuro). Non ho ostilità preconcetta verso
questo campo metaforico, tutt’altro, ma secondo me ha
il limite di favorire l’enfasi della temporalizzazione: la tradizione è passato che rimane nel presente e ambisce al
futuro. Sarà pure vero talvolta, ma ciò che mi disturba è
l’eccesso di questa enfatizzazione, che costringe a pensare le tradizioni quasi esclusivamente dentro l’asse temporale. In esso le tradizioni sono meri rapporti tra temporalità (sopravivenze o slittamenti o divaricazioni). Di
conseguenza, il contemporaneo appare come un coacervo che accoglie temporalità diverse e le tradizioni nel
contemporaneo sono sempre testimoni di se stesse
come altro dal contemporaneo. Altro di cui noi cerchiamo le tracce, le origini, il senso. Se come propongo
riduciamo l’enfasi della determinazione temporale, la
temporalità delle tradizioni si indebolisce come problema: c’è ma non è il più il focus. A questo punto vorrei provare a introdurre un altro tipo di campo metaforico. Da prendere come gioco riflessivo. Prima però vorrei ricordare che le tradizioni:
sono mobili. Come l’albero del mito Achilpa ricordato da
De Martino, si spostano, insieme al “popolo” che le trascina con sé in giro per il deserto. Le stesse località sono
mobili, pur se territoriarlmente fisse. L’universo antropologico è in continuo movimento.
Si trasformano. Ogni fissità è bandita. Mutano come i
panorami geo-antropici. Etnometodologicamente, sono
gli attori sociali a ricostruire di volta in volta un’”essenza”, nominandola e facendola.
Si mimetizzano dietro una maschera perenne. Pur mutando incessantemente, fanno in modo di sembrare agli
attori immutabili.
Sono collage. Non sistema. Accostamento di colori, materiali, geometrie, superfici. (il senso non è nelle profondità del sistema, è nel gioco degli accostamenti)
Sono azioni. Discorsive, relazionali, istituzionali, politiche: un bel giorno un gruppo di persone decise di
fare….
XIII
2. Vengo al campo metaforico che qui propongo:
Gramsci diceva delle tradizioni: “coacervo indigesto”.
Ripartiamo dall’aggettivo “indigesto”. Esso richiama il
senso del gusto, dunque suggerisce la metafora del “gusto”. Sulla scia di Gramsci introduco un campo metaforico alternativo: le tradizioni appartengono al gusto.
Hanno un sapore, in genere sapido, talvolta forte, mai
sciapito. Il gusto condiviso è quasi tutto ciò che accomuna coloro che gustano le tradizioni. Ogni relazione
sociale specifica delle tradizioni è di gusto. Ogni potere
sociale che interviene nelle tradizioni interviene nel gusto. Con il gusto si modifica la sensorialità impegnata: le
tradizioni-patrimonio hanno come senso prevalente la
vista e questa schiaccia tutti i suoi oggetti (non è ciò che
lamentano i custodi delle tradizioni quando denunciano
la spettacolarizzazione delle tradizioni?). Il senso del gusto invece articola i suoi elementi (non li schiaccia), li sincronizza (non li diacronizza), è stabile, fa comunità.
Dunque è una metafora adeguata, ha ragione Gramsci.
Ma diversamente da lui, sostengo che il coacervo è assolutamente digeribile dagli attori sociali (forse indigesto
alla conoscenza?). Nelle azioni relative al gusto, c’è disponibilità a inserire nuovi elementi nel piatto noto e
consolidato, a escluderne di vecchi, a sostituire, aggiungere, valutare i miglioramenti o i peggioramenti, a
estendere l’ambito del gusto o il consesso dei convitati.
Come nel gusto, così nelle tradizioni, è praticamente impossibile una genealogia completa ed esauriente di tutti
gli elementi, perché ogni elemento è esso stesso collage,
dunque appare isolato, ma non lo è (solo da questa prospettiva di isolamento artificiale è possibile una lettura
simbolica). Questo gusto non è sistematico, anche se c’è
una logica degli accostamenti, ma questa logica è locale,
degli attori e delle loro relazioni, non del sistema che
parlerebbe attraverso gli attori.
Abbiamo bisogno di usare determinazioni temporali in
relazione al gusto? Per niente. Per apprezzare un buon
piatto non c’è bisogno di farne genealogia (o filologia),
cioè altro dal gusto. La cucina non esclude la temporalità, tutt’altro. Le ricette hanno una storia. Ma il riconoscimento in termini di gusto ne prescinde. Gli attori che
mangiano non pensano alla storia. Un piatto che ha una
storia, ma non è di gusto, è semplicemente rifiutato. Per
mangiare non c’è altro che un menù e una comunità.
Il gusto permette di richiamare e attribuire un nuovo
ruolo a un tema centrale nelle tradizioni: la memoria.
Con essa torna la temporalità, ma ridefinita. Il gusto libera la memoria dalla servitù del passato, nel senso letterale di “serva” del passato. La memoria non è passato
che torna ma è sempre attività contemporanea. La sua
qualità specifica non sta nel restaurare il passato, attualizzarlo, riportarlo in vita, ma nell’attribuire l’emozione
della temporalità alla vita. Essa fa sentire la superficie del
presente come se avesse una profondità di tempo sociale e individuale. Non appartiene alla filologia ma alla
psicologia. Certo, dato il suo forte peso psicologico-culturale, essa da attività privata o dialogico-comunitaria si
trasforma in azione politica. Ecco, nel gusto, la memoria
è ben viva, ben presente, ma ha minori implicazioni politiche, minore peso patrimoniale.
Anche il gusto è politico, ovviamente. Ma qui la politica
è meno cifrata, più trasparente e dunque più leggera. Il
gusto è al tempo stesso collettivo e individuale: esso è
normativo, risponde a regole, ma ogni individuo le applica secondo adattamenti ad hoc. Dunque con tale metafora non sarà più prevalente un’immagine di comunità
compatta nella tradizione. Perché da subito si saprà che
vi sono vari adattamenti individuali ad hoc su un terreno
dialogico collettivo. Con essa il ricercatore sarà automaticamente portato a individuare le sensorialità-sensibilità
differenziate nella pratica di una certa tradizione; sarà
spinto a una etnografia profonda imposta dalla differenza abissale tra un libro di ricette (la tradizione è così
e colì) e un menù cotto e mangiato (gli usi specifici e differenziali).
In conclusione, “le tradizioni” è un’espressione che essenzializza giochi di gusto, collage di sapori che gli attori
sociali operano nelle loro relazioni.
Che ne facciamo allora della patrimonializzazione? Ci riavviciniamo a essa alleggeriti del peso del passato, con
la levità della cucina usata per godere della nostra socialità. (Paolo Apolito)
Sintesi della discussione
Il tema della sessione è stato introdotto da Paolo Apolito
che, considerando l’espressione “tradizioni del contemporaneo” come una provocazione intellettuale offerta ai
partecipanti dagli organizzatori del congresso, ha sostenuto la necessità di abbassare l’enfasi eccessiva posta
sull’asse temporale nell’approccio riflessivo alla tradizione. Apolito ha proposto un mutamento nel linguaggio con il quale parliamo di tradizione, invitandoci ad
uscire dall’orizzonte metaforico prevalente, che assimila
le tradizioni ai beni patrimoniali, per entrare nel campo
metaforico del gusto. Il senso del gusto, a differenza di
quello della vista, sincronizza infatti gli elementi e non
necessita di determinazioni temporali. “Certo – dice
Apolito – le ricette hanno una loro storia, ma un piatto
che ha una storia ma non è di gusto è semplicemente rifiutato.” La metafora del gusto, in relazione alle tradizioni, apre, dunque, per Apolito nuove opportunità per
lo studio delle tradizioni; “permette di inglobare il passato ma non li schiaccia nel passato”. In tale prospettiva
sostiene Apolito, si potrà e si dovrà guardare in modo
differente anche alla patrimonializzazione.
Vincenzo Padiglione ha accettato il nuovo campo metaforico proposto da Apolito poiché a suo avviso permette
di evitare il rischio di un ancoramento dello sguardo su
posizioni antiquarie e passatiste e permette di scongiurare derive allocentristiche. Padiglione ha poi cercato di
riflettere alla luce del contributo offerto da Apolito, sul
valore e sul significato della patrimonializzazione in un
orizzonte contemporaneo in cui le tradizioni sono sempre più delle performance che sottintendono la multisensorialità e vanno dunque necessariamente verso l’immaterialità del saper fare.
Si sono susseguiti poi vari interventi che hanno dato testimonianza di studi delle tradizioni del contemporaneo.
Angelo Cannata e Margherita Ramunno, ricercatori indipendenti, hanno portato la testimonianza della loro ricerca sui sistemi di pesca tradizionale a Taranto, com-
XIV
missionata dal Centro Ittico Tarantino S.p.a., offrendo
una prova di quanto vivo sia l’interesse per lo studio
delle tradizioni anche fuori dall’ambiente accademico.
Elisa Galli, del CISAI dell’Università di Siena, ha comunicato la sua esperienza di ricerca etnografica presso la popolazione amazzonica dei Quichua dell’Ecuador testimoniando come il termine tradizione assuma un valore particolare tra quelle popolazioni che si sentono dirette discendenti delle popolazioni precolombiane e ci ha offerto il caso della pratica sciamanica svolta oggi nelle
città ecuadoregne tra passato e contemporaneità.
Lia Giancristofaro, dell’Università di Chieti, ci ha comunicato la sua particolare esperienza di etnografia nel contemporaneo parlandoci del suo impegno come responsabile di una rubrica dedicata alla tradizione per la trasmissione Buongiorno regione della Regione Abruzzo. La
professoressa, che in questa rubrica tuttora attiva propone ogni mattina un proverbio abruzzese, ritiene si sia
attivato con i telespettatori, che hanno manifestato
grande interesse, un meccanismo di “riflessività e ridistribuzione” della tradizione. Attraverso il network telematico sul quale ha invitato a concentrare l’attenzione per
lo studio delle tradizioni nel contemporaneo.
Rosalba Negri, del Museo Etnografico dell’Alta Brianza,
ha presentato una ricerca sui teli da strada realizzati ed
sposti dagli amici degli sposi nel corso del rituale matrimoniale; un uso recente che interroga sul farsi della tradizione e sul valore attuale del rito matrimoniale.
Alessandro Testa, dottorando dell’Università di Messina,
ha fornito testimonianza della sua ricerca in corso sul
Carnevale di Castelnuovo al Volturno, ponendo attenzione particolare sul valore della patrimonializzazione di
fronte ad un caso di revival.
Maria Adelaide Cuozzo, docente di Arte moderna e contemporanea presso l’Università di Basilicata, ha portato
un contributo originale alla discussione parlandoci del
ruolo della tradizione nell’arte, tra i modelli alti e il popolare, memoria che costruisce e memoria che distrugge.
In conclusione Padiglione ha posto l’attenzione sulla varietà interna del fare ricerca ma ha constatato quanto sia
stato poco abbracciata dagli intervenuti la proposta di
Apolito a “diminuire l’enfasi sulla temporalità” e ha letto
negli inteventi la necessità di porsi interrogativi nuovi di
fronte alla tradizione.
Apolito ha concluso sottolineando non solo la necessità
di fare ricerca, ma anche quella di comunicarla efficacemente, di sapersi fare ascoltare e di saper mutare atteggiamenti per meglio leggere la tradizione nel contemporaneo.
Ne è seguito un ricco e appassionato dibattito in cui tra
gli altri sono intervenuti, in relazione alle proposte di
Apolito Gabriella Da Re e Vito Lattanzi sull’opportunità
o meno di mantenere o mettere da parte un approccio
filologico nella ricerca sulle tradizioni . in conclusione
una provocazione di Dino Palumbo: “è ancora il caso di
parlare di Tradizione? Non sarebbe meglio parlare di
Canone? E, più in generale, non sarebbe meglio liberarsi
del peso di alcuni concetti?”. Certamente è emersa, da
questa sessione di discussione, la necessità di riflessione
e di dialogo sul tema della tradizione nel e del contemporaneo (a cura di Michele Iannuzzi).
Hanno partecipato: Paolo Apolito (Università di Roma
Tre), Angelo Cannata (Ricercatore indipendente Taranto), Maria Adelaide Cuozzo (Università della
XV
Basilicata), Elisa Galli (CISAI - Università di Siena), Lia
Giancristofaro (Università di Chieti “G. D’Annunzio”),
Alessandra Guigoni (Università di Sassari), Luca
Mancini (Dottorando - Università “Sapienza” di Roma),
Rosalba Negri (Museo Etnografico
dell’Alta Brianza), Domenico Nisi (Archeologo e collaboratore del Museo Tridentino di
Scienze Naturali di Trento), Margherita Ramunno
(Ricercatrice indipendente), Alessandro Testa (Dottorando
- Università di Messina), Ileana Tozzi (Museo dei Beni
Ecclesiastici Diocesi di Rieti), Marta Villa (Dottoranda - Università di
Milano-Bicocca)
LISTE UNESCO E POLITICHE DEL PATRIMONIO
Introduce Luciana Mariotti
primo discussant: Pietro Clemente
La presentazione di questa sezione del convegno riprende tutte le problematiche – con risvolto antropologico – che – nell’arco di almeno due anni – e in più occasioni sono state poste all’attenzione del pubblico, più
o meno esperto. Innanzi tutto, la nozione di patrimonio
culturale intangibile o immateriale – a seconda della lingua in traduzione. Questa nozione fonda un nuovo paradigma culturale. Essa, infatti, introduce un modello riflessivo particolare: gli elementi del patrimonio culturale
immateriale – in Italia diremmo “beni culturali, perché di
fatto sono già stati individuati e per una buona parte
censiti, con le diverse tipologie di scheda che dal 1978
impegna l’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione, – vengono ora riconosciuti dai protagonisti e/o dagli attori degli stessi beni culturali del patrimonio intangibile come risorse identitarie, prescindibili.
Il testo stesso della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale del 2003 fa riferimento
a queste risorse attraverso la nozione di comunità.
L’utilizzazione del patrimonio culturale, quale sostegno a
processi identitari nell’ambito delle Convenzioni UNESCO
è un carattere inedito. Collegate a questa tipologia di risorse, come conseguenza inevitabile, c’è lo slancio degli
Stati parte ad utilizzare la Liste del patrimonio culturale
intangibile che l’UNESCO mette a disposizione attraverso il suo strumento legale (la Convenzione).
L’identificazione delle risorse identitarie, e quindi la definizione della Lista, coincide con la creazione e la definizione identitaria stessa dello Stato nazionale.1 Sono gli
Stati parte, quindi, ad assumere identità.
Il nuovo modello riflessivo ingenera, dunque, un processo diffuso di patrimonializzazione; la stessa scelta di
proporre un bene immateriale alla valutazione per l’iscrizione nelle Liste fa cambiare senso e significato a quel
bene che – di fatto – diventa elemento o bene patrimoniale, e quindi strumento per il riconoscimento identitario.
Il modello che si va costruendo scardina le forme classiche di expertise e mette in discussione i modi e gli stessi
ruoli definiti dal trattamento degli oggetti patrimoniali.
Questo processo, inoltre, all’interno della stessa
Convenzione, prevede l’assegnazione di un ruolo peculiare ai cosiddetti inventari del patrimonio immateriale.
La realizzazione degli inventari è il compito più evidente
dello Stato parte. Il criterio R5 assegna alla presenza o
meno di inventariazione nazionale la funzione di ostacolo alla stessa proposta di candidatura. L’inventariazionebasata su precise competenze scientifiche – è considerata la misura di salvaguardia principale per proteggere
dal rischio di sparizione il bene del patrimonio. Il processo inventariale rafforza la patrimonializzazione
dell’elemento sottoposto in candidatura, rafforzando
anche la salvaguardia: se l’elemento si sottopone a candidatura e se viene inventariato, la salvaguardia sarà assicurata e l’UNESCO chiede allo Stato parte il monitoraggio frequente dell’elemento sottoposto in candidatura e
inventariato, almeno ogni sei anni a partire dalla data
della ratifica della Convenzione. L’inventariazione diventa così – nell’ambito del fenomeno patrimoniale –
strumento per creare gli elementi del patrimonio immateriale, piuttosto che solo strumento di registrazione,
uno strumento capace anche di identificare e/o creare
comunità.2
La rappresentatività di un elemento del patrimonio culturale immateriale è strettamente collegata alla comunità, cioè ai protagonisti, agli esecutori dell’elemento
così come appare nel cap.2.2 della Convenzione 2003,
a coloro che si identi-ficano con l’elemento stesso.
Pertanto un’altra caratteristica della comunità è la nozione di partecipazione: addirittura sono le comunità che
– essendo state coinvolte nei processi di candidatura –
devono rilasciare, per mandare avanti le procedure
d’iscrizione, il modello di consenso informato. Tanto
“comunità” quanto “partecipazione” restano, tuttavia,
termini e concetti indefiniti e pertanto sottoposti alle interpretazioni soggettive. La nozione di partecipazione
viene spesso interpretata come osservazione partecipante. In questo caso, l’inventario si avvale del coinvolgimento degli etnologi, i quali diventano intermediari tra
la comunità e l’istituzione; in altri casi, partecipazione
viene intesa come democrazia partecipata e così la comunità diventa primariamente comunità patrimoniale,
dove persone di diversa estrazione e provenienza si
prendono cura della salvaguardia di un elemento del patrimonio immateriale. E in questo caso la localizzazione
geografica dell’elemento, che pure viene chiesta nella
redazione del dossier di candidatura, perde di senso. Ma
partecipazione può essere anche letta come estesa a
tutti coloro che fanno parte di una comunità e/o di un
gruppo e che materialmente eseguono tutte le procedure per realizzare l’evento, la prassi, per trasmetterlo
alle generazioni future .
Restano quindi aperti i caratteri centrali e antropologicamente rilevanti di cui la Convenzione del 2003 si avvale,
ivi incluso l’ulteriore concetto di rivitalizzazione, collegabile e/o da collegare con i processi identitari “nazionali”.
L’occasione del seminario e- in particolare della sezione
dedicata alla o alle Liste Unesco- si preannuncia interessante proprio perché presenta riflessioni concrete sui
questi quesiti. Un’indicazione, una linea comune di intendimento è opportuna non certo per risolvere i problemi che quotidianamente si pongono, ma – ancora
una volta – per definire una guida, un percorso, una
strada italiana all’applicazione della Convenzione del
2003 (Luciana Mariotti).
XVI
Sintesi della discussione
La sessione ha costituito un momento di aggiornamento
e discussione sulle recenti riflessioni in merito alle politiche patrimoniali UNESCO, con particolare riferimento
alla Convezione sulla salvaguardia del patrimonio immateriale (2003). È emersa in tutta la sua complessità la
questione della catalogazione del patrimonio immateriale così come prescritta dalla Convenzione UNESCO
che, a partire dal 2007 – anno della sua ratifica da parte
dell’Italia – ha coinvolto anche l’Istituto Centrale del
Catalogo e della Documentazione, dando avvio a specifiche campagne di catalogazione dei beni immateriali attraverso l’impiego delle schede di catalogo BDI. Definita
come “Giano Bifronte” dell’antropologia, quest’ultima
se da un lato traduce lo sforzo di una parte dell’universo
disciplinare DEA a essere ammesso nel contesto del
Ministero, dall’altro è valutata – in misura maggiore rispetto a schede di catalogo afferenti a sfere disciplinari
sorelle – come uno strumento fortemente riduttivo della
complessità del “bene”, incapace di rendere tutta la ricchezza che la ricerca etnografica è in grado di far emergere, ivi comprese le zone d’ombra e di conflitto.
Sebbene determini un’opportunità di ricerca, la scheda
BDI pone il problema della “non restituzione” dell’indagine, poiché essa una volta prodotta rimane negli archivi
dell’ICCD; secondo alcuni la scheda BDI rimanderebbe
così a un concetto di censimento più “tecnocratico” e
“bancario” (inteso come mero prelevamento di beni da
parte di esperti) piuttosto che “condiviso”3.
Un ulteriore aspetto messo in luce nel corso della sessione rimanda al forte ruolo giocato dalle istituzioni politiche nelle fasi di selezione e presentazione dei beni da
candidare nelle liste UNESCO; è emerso come i ricercatori antropologi potrebbero utilmente guidare le istituzioni in queste scelte coinvolgendo la cittadinanza, includendo tutte le voci che compongono il concetto complesso – e sempre più problematico – di comunità. Le relazioni hanno infine messo in luce il rilievo sempre maggiore attribuito alla nozione di “comunità patrimoniale”,
che si afferma a partire dalla Convenzione di Faro del
20054. La comunità patrimoniale è definita come un
gruppo di persone, non necessariamente identificabile
con un territorio delimitato, in grado di compiere scelte
autonome sul proprio patrimonio e di farsi protagonista
delle politiche patrimoniali, così come delle operazioni di
ricerca e auto-documentazione. Queste ultime riflessioni, che hanno fortemente alimentato i recenti dibattiti
in merito alle politiche UNESCO di salvaguardia del patrimonio, determinano l’apertura a una rinnovata ipotesi
democratica – sebbene piuttosto ideale – di gestione dal
basso del patrimonio culturale (a cura di Mariaclaudia
Cristofano)
Hanno partecipato: Katia Ballacchino (Dottore di
Ricerca - Università “Sapienza” di Roma), Francesco
Bravin (Ricercatore indipendente), Alessandra Broccolini
(Università “Sapienza” di Roma),
Marinella Carosso (Università di Milano-Bicocca), Felice
Ceparano (Presidente Extra Moenia),
Domenico Copertino (Università di Milano-Bicocca),
Grazia Lapenna (Cultore della materia in
discipline DEA - Università “Sapienza” di Roma),
Alessandro Lutri (Università di Catania), Renata
Meazza (Archivio di Etnografia e Storia Sociale - Direzione
Generale Cultura - Regione
Lombardia), Emiliano Migliorini (Etnomusicologo - ass.
EOLO, Etnolaboratorio per il Patrimonio
Culturale Immateriale), Rosario Perricone (Direttore del
Museo internazionale delle marionette
Antonio Pasqualino - Palermo), Tommaso Rotundo
(Cultore della materia in discipline DEA Università “Sapienza” di Roma), Paola Elisabetta Simeoni
(Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali), Luisa Vietri (Dottoranda - Universitat
Autònoma de Barcelona), Valentina Zingari (Università di
Siena), Lia Zola (Università di Padova).
LA CULTURA MATERIALE NEL CONTEMPORANEO
Introduce Fabio Dei
primo discussant Mario Turci
“Nuovi studi di cultura materiale”: è l’espressione che si
trova spesso usata per riferirsi a una consistente letteratura degli ultimi 10-15 anni che ha proposto una sorta
di “boom” della cultura materiale. Da ambito settoriale
e ultraspecialistico, quest’ultima si è trovata al centro di
molte imprese etnografiche e della “grande” teoria antropologica. È giustificato quell’aggettivo – “nuovi” –
che sembra tracciare una cesura netta rispetto al passato? Che cosa distingue la fase attuale da quella che
potremmo chiamare classica?
La mia generazione, formata all’antropologia a cavallo
fra anni ’70 e ’80, si era incontrata con la cultura materiale attraverso la grande opera di Leroi-Gourhan. Opera
di ampio respiro e di grande fascino, che vedeva nei
modi di “venire a patti con la materia” il cuore del concetto antropologico di cultura e la molla dell’evoluzione
umana; paventando al tempo stesso gli effetti degenerativi di uno sviluppo tecnologico che esteriorizza integralmente le funzioni produttive e priva la gran parte degli individui di un rapporto manuale con la realtà empirica. L’impostazione di Leroi-Gourhan dava centralità
agli aspetti ergonomici e di storia della tecnica; pensava
la cultura materiale soprattutto in termini di processi di
produzione di manufatti; e naturalmente portava a privilegiare l’interesse per gli oggetti autentici di produzione
artigianale e tradizionale – ad esempio, per quanto riguarda il quadro italiano, gli attrezzi del lavoro contadino o artigianale. C’è di più: nelle letture di quegli anni,
il “venire a patti con la materia” si combinava talvolta
con una ontologia materialista – Il gesto e la parola più
L’ideologia tedesca, diciamo: non solo per stabilire il primato antropologico delle tecniche produttive, ma per
costituire questo campo come il nocciolo duro di una conoscenza oggettiva, non costretta a passare dalle vaghezze soggettive dei discorsi e delle credenze e neppure dalla metafisica delle strutture dello spirito umano.
Se era possibile costruire un’antropologia come scienza
esatta, ciò poteva avvenire solo a partire dalla cultura
materiale, dalla dura opacità di oggetti che potevano esser misurati, pesati, studiati nelle loro capacità statiche e
meccaniche, nelle loro potenzialità di aderenza alla mor-
XVII
XVIII
fologia del corpo umano e a quella del mondo naturale,
e così via.
Si potrà allora capire, se non certo giustificare, il tiepido
interesse che alcuni di noi avevano provato per questo
campo: specialmente quelli che si erano infatuati dell’antropologa interpretativa e che lavoravano a progetti di
etnografia del “contemporaneo” (penso, negli anni ’90,
all’esperienza della rivista Ossimori). La cultura materiale
si faceva sotto, semmai, attraverso l’interesse per la museografia. Ma anche quella era una museografia che
aspirava ad emanciparsi da un approccio di tecnologia
culturale – qualche volta persino ad emanciparsi dagli
oggetti, almeno da quelli canonici, per inseguire quel
terzo principio della meraviglia teorizzato da Pietro
Clemente.
Eppure, a partire da quegli stessi anni, nel dibattito internazionale l’attenzione per il “mondo delle cose” si stava
ampliando in direzioni molto diverse, e proprio in relazione agli obiettivi di una antropologia del “contemporaneo” – cioè delle moderne società occidentali basate
sulla produzione industriale, sul consumo di massa e su
flussi di comunicazione globale. Ciò ha significato necessariamente spostare l’attenzione dalla produzione al
consumo, e dagli oggetti autentici e artigianali a quelli
ordinari della vita quotidiana. Nelle società contemporanee, la maggior parte delle persone è circondata costantemente da una grande quantità di oggetti che non ha
prodotto direttamente, e anzi le cui modalità di produzione ignora completamente. Per alcuni settori delle
scienze sociali ciò non può che condurre ad alienazione
e perdita di rapporto con la realtà – da cui tutta una letteratura apocalittica sulla degenerazione antropologica
dell’homo consumens, da Baudrillard a Bauman. Altri si
sono invece chiesti che cosa significano tutti quegli oggetti. In che modo acquisiscono, mantengono o cambiano “valore”? In che modo incorporano le relazioni
sociali? In che rapporti stanno con le biografie degli individui? In che misura costituiscono il supporto di una
cosmologia e di sistemi di valori e categorie culturali?
La distinzione di Bourdieu, Il mondo delle cose di
Douglas e Isherwood, La vita sociale delle cose a cura di
Appadurai sono tra i libri che hanno aperto prospettive
di questo tipo. Libri che rinunciano a pensare alle cose
materiali come alla solida base dell’oggettività antropologica per esporle al pericoloso dominio del significato e
dell’interpretazione. Dalla loro influenza sono risultati
programmi di ricerca decisamente solidi. Non è questa la
sede per una rassegna bibliografica: si possono però almeno ricordare i numerosi lavori sulla cultura materiale
all’interno della Mission du Patrimoine Ethnologique
francese, e in ambito anglosassone, fra gli altri, gli eclettici studi di Daniel Miller. Un’intera agenda tematica è
emersa, e sarebbe interessante ricostruirne una visione
d’insieme. Fra gli altri, il tema della “carriera” degli oggetti ha avuto grande fortuna – a seguito del famoso
saggio di Igor Kopytoff (1986) sulla biografia culturale
degli oggetti e sulla loro possibilità di transitare in ruoli
sociali diversi e in diverse sfere di valore. Tra l’altro su
questo versante si è operata una felice sinergia con la
tradizione degli studi antropologici sul dono e sui rapporti tra dono, merce e beni inalienabili (si veda l’opera
di A. Weiner e i contributi raccolti in Myers 2001, dove
si sviluppano ulteriori collegamenti con l’antropologia
dell’arte). Una ulteriore dimensione di analisi della cultura materiale riguarda il suo rapporto con la memoria:
la questione delle reliquie, degli oggetti d’affezione e più
in generale degli oggetti che in ambito sia pubblico sia
privato incorporano forme di memoria culturale. Ma soprattutto, i “nuovi” studi di cultura materiale rimandano
al grande campo del consumo, terreno cruciale di un’antropologia della contemporaneità – e forse, io azzarderei, per l’antropologia contemporanea tout court (è stato
Miller a sostenere, non senza alcune buone ragioni, che
il consumo è oggi per gli antropologi ciò che la parentela è stato nella fase classica della disciplina).
Occorre anche segnalare che attorno alla cultura materiale c’è stata negli ultimi anni una ripresa di dialogo tra
antropologia e altre discipline. Non solo la storia culturale e la sociologia, rispetto alle quali i confini non sono
sempre facili da tracciare; ma anche l’archeologia, l’economia, la semiologia. Quest’ultima ad esempio ha sviluppato tempestivamente – anche in Italia – l’interesse
per il “senso” degli oggetti tecnici e ordinari, lavorando
più sistematicamente di noi sulle “biografie degli oggetti” e sviluppando a fondo l’idea di attribuire alle cose
una certa dose di agency sociale. Su questo punto ha
esercitato grande influenza l‘epistemologia di Bruno
Latour, che ha suggerito l’esaurimento del progetto moderno di separare radicalmente le “costituzioni” delle
cose e delle persone, e la prevalenza nel mondo contemporaneo di “ibridi”, cioè di soggetti agenti che sono un
intreccio inscindibile di persone e oggetti tecnici (nel
senso in cui, ad esempio, un uomo con un telefonino è
qualcosa di diverso da un uomo più un telefonino; si vedano fra l’altro Marrone – Landowski 2002; Mattozzi
2006; Mattozzi et al. 2009).
La museografia etnografica italiana si trova oggi in ottima posizione per rispondere a queste sollecitazioni –
come dimostra ad esempio l’articolo di Mario Turci su
AM/22 (2009). Più attardata è forse la ricerca. Qui prevale ancora un interesse per gli oggetti “tradizionali”,
assimilabili a una qualche nozione di patrimonio culturale da salvaguardare e proteggere. Interesse del tutto
legittimo, naturalmente, che si unisce spesso a forme di
documentazione e trattamento assai raffinate: e che tuttavia oscura il potenziale interesse per gli oggetti ordinari della vita quotidiana. Le culture alimentari e della
moda; gli arredi e gli oggetti della casa; il rapporto con
le tecnologie e i modi di “venire a patti con la materia”
che ancora, nonostante tutto, percorrono la vita quotidiana; il ruolo degli oggetti nella costruzione della memoria culturale; l’esperienza del “fare la spesa” e le implicazioni cosmologiche e sociologiche del sistema delle
merci; le trasformazioni del paesaggio e della percezione
culturale degli oggetti e dei patrimoni naturali. Questi e
altri temi sono talvolta oggetto di attenzione etnografica, ma in modi frammentati, senza un progetto d’insieme. Percepirne la possibile unità e sistematicità a partire da una rinnovata nozione di cultura materiale può
essere un passo importante; e spero che il nostro convegno aiuti a verificarlo. (Fabio Dei)
XIX
Riferimenti bibliografici
Appadurai, A., a cura (1986), The Social Life of Things.
Commodities in a Cultural Perspective, Cambridge,
Cambridge University Press
Bourdieu, P. (2001) La Distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino
Douglas, M. – Isherwood, B. (1984), Il mondo delle cose.
Oggetti, valori, consumo, Bologna, Il Mulino
Marrone, G. – Landowski, E., a cura (2002), La società degli oggetti, Roma, Meltemi
Kopytoff, I. (1986) “The Cultural Biography of Things.
Commoditization as Process”, in A. Appadurai, a
cura, The Social Life of Things. Commodities in a
Cultural Perspective, Cambridge, Cambridge
University Press, pp. 64-92.
Mattozzi, A., a cura (2006), Il senso degli oggetti tecnici,
Roma, Meltemi
Mattozzi, A. - et al., a cura (2009) Biografie di oggetti,
storie di cose, Milano, Bruno Mondadori
Myers, R., a cura (2001) The Empire of Things: Regimes
of Value and Material Culture, Santa Fe, School of
American Research Press
Turci, M. (2009), Cultura Materiale, in «Antropologia
Museale», n. 22, pp. 27-29
Sintesi della discussione
La sessione di discussione ha avuto come tema principale l’analisi degli studi antropologici sulla cultura materiale nel contemporaneo. Fabio Dei ha introdotto l’argomento ripercorrendo le diverse fasi storiche degli studi
antropologici sulla cultura materiale, in particolare in
Italia, a partire dagli antropologi formatisi a cavallo degli
anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo influenzati
dalla grande opera di Leroi-Gourhan. L’approccio alla
cultura materiale, in quel periodo dava centralità agli
aspetti ergonomici degli oggetti e alla storia della tecnica, privilegiando l’autenticità dei prodotti artigianali.
Già da quegli anni, però, l’attenzione per il “mondo
delle cose” si stava ampliando. L’interesse per la museografia, rinunciando a costruire un’antropologia come
scienza esatta, infatti, aspirava ad emanciparsi da un approccio di tecnologia culturale orientandosi sul significato e sull’interpretazione delle cose materiali.
Negli ultimi quindici anni circa, gli studi antropologici
hanno aggiunto ulteriori prospettive che rimandano al
tema della “carriera” dell’oggetto, oltre all’interesse per
gli oggetti d’affezione e più in generale per gli oggetti
che in ambito sia pubblico sia privato incorporano forme
di memoria culturale.
Nella fase attuale, invece, gli antropologi possono definire “nuovi” gli studi sulla cultura materiale e cosa distingue la fase attuale da quella che si potrebbe definire
classica?
Secondo Dei, per giustificare l’aggettivo – “nuovi” – l’attenzione etnografica dovrebbe far convergere le sue ricerche sulla contemporaneità. La museografia etnografica italiana si trova in ottima posizione in merito alla rinnovata nozione di cultura materiale, ma non si può dire
la stessa cosa della ricerca antropologica. Dal suo punto
di vista, l’interesse per gli oggetti tradizionali, da salvaguardare e valorizzare, deve lasciare spazio all’interesse
per il “senso” degli oggetti seriali e ordinari della vita
quotidiana. Bisogna far ricerca e interpretare, in modo
unitario e sistematico, la trasformazione del paesaggio,
la percezione culturale delle cose, nonché il rapporto
con la tecnologia e i modi contemporanei di “venire a
patti con la materia”.
Il dibattito, di conseguenza, è stato impostato per dare
risposta al quesito posto da Fabio Dei. Gli antropologi intervenuti, in riferimento alle personali esperienze lavorative e di studio, hanno esposto i loro “nuovi” studi sulla
cultura materiale nel contemporaneo.
Mario Turci si è basato, inizialmente, sulla sua attuale ricerca legata all’allestimento del Museo della Tessitura di
Isili, ponendo l’attenzione proprio sulla definizione del
museo. La scelta del nome non è stata cosa semplice per
gli studiosi coinvolti, i quali si sono chiesti se era più opportuno che il museo fosse chiamato “del Telaio”, “del
Tessuto” o “delle Tessitrici”, proprio per le diverse traiettorie legate all’espressione “cultura materiale”. In seguito, Mario Turci, partendo dallo studio del collezionismo di oggetti in relazione, anche, a una ricca letteratura antropologica contemporanea sull’analisi della collezione del collezionista, si è interrogato sul limite
dell’oggetto e sull’“esseità” delle cose.
Il secondo intervento sulla antropologia della modernità
industriale ha visto come portavoce Paola Atzeni. Tramite
il racconto della sua esperienza di ricercatrice e studiosa
delle attività legate al Museo del Carbone di Carbonia,
nonché come curatrice dell’allestimento della Lampisteria
nella miniera di Serbariu, ha evidenziando la sua attività
conoscitiva svolta sulle miniere e sull’oggetto “lampada”
come simbolo fondamentale della vita dei minatori.
Inoltre, il suo lavoro mira a porre l’attenzione non solo
all’oggetto finito, ma anche alla materia prima necessaria per produrlo. Paola Atzeni, infine, ha sottolineato la
necessità di un dialogo multidisciplinare che possa produrre paesaggi sicuri e realtà bonificate a tutela di molti
lavoratori contemporanei.
L’intervento di Elisa Bellato, invece, ha posto l’accento
sulla situazione dei musei contemporanei che tendono a
togliere centralità agli oggetti, sempre meno numerosi,
perché si pone sempre più attenzione ai supporti comunicativi. Se gli oggetti diventano degli accessori all’interno dei musei saranno sempre più estromessi da questi luoghi per finire nei depositi, negando l’esistenza dei
musei delle cose. Si otterranno sempre più, in questo
modo, depositi visitabili come i mercatini domenicali,
dove gli oggetti hanno un valore di mercato da portare
a casa per costruire privati ambiti memoriali. La studiosa
ha concluso asserendo che oltre all’incremento delle
professionalità museali è necessario mirare alla trasformazione dei musei in macchine produttive di eventi culturali per riportare l’attenzione sugli oggetti degli allestimenti museali
Alberto Caoci ha mostrato la sua ricerca sull’indagine
delle competenze matematiche delle tessitrici di Isili,
constatando come alcune nuove procedure si siano dovute integrare con i sistemi tradizionali. Elaborando il
concetto dell’etnomatematica, lo studio delle pratiche
matematiche dei gruppi socioculturali, Alberto Caoci ha
precisato come il processo della conoscenza matematica
XX
e delle competenze tecniche delle tessitrici si realizzi in
famiglia e non seguendo studi scolastici, mettendo in
evidenza il rapporto delle donne con il telaio inteso
come modo di stare al mondo.
Giovanni Fornaro ha risposto al quesito partendo dal
presupposto che anche nella musica c’è un fattore oggettuale che è rappresentato dagli strumenti musicali, in
particolare da quelli auto-costruiti, o realizzati su commissione, a volte strumenti ibridi integrati con altri oggetti. Elencando vari artisti sperimentali, i loro approcci
innovativi e le loro modalità creative degli strumenti,
Fornaro ha sottolineato come nell’etnomusicologia postmoderna ci sia una continua sperimentazione della cultura materiale e ha posto l’attenzione sulla necessità di
verificare ed osservare i nuovi processi tecnico-virtuali
delle esperienze oggetto di studio etnografico, per poter
poi rispondere sulla materialità o immaterialità del
suono.
Pietro Meloni ha presentato, invece, la sua ricerca riguardante l’utilizzo degli oggetti nel contemporaneo. Il suo
studio, infatti, si è basato sull’osservazione della costruzione dello spazio domestico odierno come luogo in cui
rilevare la vita o la morte sociale degli oggetti. Lo studioso ha poi approfondito i temi chiave della ricerca
come l’analisi del rapporto tra gli oggetti e gli uomini e
l’osservazione dell’uso delle cose che permette di attribuirne un valore di mercato, ma anche un “senso” alla
materia.
Infine, Felice Tiragallo, ha discusso sulle abilità visive
delle tessitrici in Sardegna e sullo sviluppo, anche nella
contemporaneità, delle pratiche ecologiche tradizionali
legate alla percezione del colore e alle procedure per la
produzione dei tessuti colorati. Dall’esposizione di Felice
Tiragallo è evidente che pur trattandosi di procedure e
pratiche popolari, l’ideologia di fondo è quella di fare
esperimenti con ciò che la natura offre, accettando qualsiasi tipo di risultato, idea che permette di definire questo tipo di attività eco-contemporanea (a cura di Angela
Cicirelli)
Hanno partecipato: Matteo Aria (Università di Verona),
Paola Atzeni (Università di Cagliari), Elisa Bellato (Museo
Etnografico della Provincia di Belluno), Silvia Bernardi
(Università di Pisa), Alberto
Caoci (Università di Cagliari), Cinzia Ciardiello (Università
di Pisa), Giovanni Fornaro
(Dottorando - Università di Roma “Tor Vergata”), Vito
Lattanzi (Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi
Pigorini”) Pietro Meloni (Università di Siena), Felice
Tiragallo (Università di Cagliari), Luca Villa (Ricercatore
indipendente)
LAVORO, IMPRESA, MOBILITÀ
Introduce Cristina Papa
primo discussant Paolo Piquereddu
L’invito a Matera di Simbdea ci porta a riflettere sulla
contemporaneità evocando il presente del mondo in
guerra e il disastro ambientale ma anche le speranze e le
catastrofi del futuro a partire dai temi prioritari della tradizione, del patrimonio, della valorizzazione.
Nell’accogliere l’invito credo necessario sottolineare
un’altra questione decisiva nella contemporaneità e per
il futuro, che è al centro del nostro workshop, quella
della crisi di un sistema economico che sempre più si
mostra – e non episodica e congiunturale –, tanto da venire chiamata Grande recessione e che investe il lavoro,
XXI
le forme che esso assume e i rapporti di produzione e di
circolazione delle risorse. La crisi economica ha anche
mostrato come la crescita produttiva illimitata con relativo aumento squilibrato dei consumi e dell’uso delle risorse a favore solo di una parte della popolazione (anche
nelle aree più ricche del pianeta), non è più a lungo sostenibile nel futuro. Per portare due soli esempi: secondo
l’istituto centrale di statistica Usa Pnel 2009 il tasso degli
americani poveri ha raggiunto il 14,3%, includendo 43.6
milioni di persone, in pratica quasi un americano ogni
sette e il rapporto Caritas 2010 per l’Italia individua l’esistenza di 9 milioni di persone sotto la soglia di povertà,
quasi un italiano su sei. Si tratta di questioni di ampia
portata che vanno ben oltre i limiti del nostro lavoro. Per
questo vorrei limitarmi a suggerire alcune riflessioni che
potrebbero orientare la nostra discussione in risposta
all’intreccio tra i temi oggetto del convegno e quelli del
nostro workshop.
1. La crisi economica degli ultimi anni ha accentuato un
processo già in atto da decenni di frammentazione produttiva post fordista dell’impresa che si traduce in molteplici forme di delocalizzazione (in uno stesso paese o
in più paesi, di parti della produzione o della sua totalità, di catene di subappalto…) favorita anche dalla rivoluzione informatica che consente la trasmissione di
informazioni in tempo reale da un capo all’altro del
mondo. Si è parlato di questo fenomeno con differenti
espressioni in relazione a differenti contesti: di “produzione a rete” (Agostinelli 1997), di “fabbrichizzazione
del territorio”(Becattini 1987) per descrivere la costituzione dei distretti industriali in Italia, di “gazebisti” in riferimento soprattutto alla prima fase della delocalizzazione italiana in Romania quando la fabbrica si spostava “dentro un tir” (Sacchetto 2007: 135), o di “fabbrica sociale generalizzata” (Vasapollo 2007: 186) per
indicare i fenomeni di precarizzazione del lavoro e di
produzione di lavori atipici legati al postfordismo con
conseguente rottura della unità di classe dei lavoratori.
Questo fenomeno si combina con processi opposti di
gerarchizzazione e di controllo (creazione di gruppi,
holdings, multinazionali) e con il crescente potere di organismi sovranazionali formalmente di tipo tecnico ma
in realtà politicamente orientati (FMI, Banca mondiale,
WTO). La globalizzazione dei mercati, della produzione
e dei capitali che si è venuta accentuando progressivamente ha di fatto prodotto il disancoraggio dell’impresa da un singolo territorio, con la rottura dei rapporti molteplici non solo economici ma anche sociali,
culturali e politici tra territorio e impresa e della loro reciproca identificazione, ma anche con la frequente separazione tra lavoratori impegnati nella produzione,
proprietari e management e con la fine delle “economie di vicinato”. Questo fenomeno è stato decisivo
nell’indebolire il potere contrattuale dei lavoratori e
delle istituzioni locali nei confronti della direzione e
della proprietà dell’impresa, che nel caso delle grandi
imprese multinazionali ha perso i connotati di identificazione personale e familiare. Analogamente ridotta è
l’influenza dei singoli stati nazionali sulle scelte imprenditoriali. Come sostiene Ulrich Beck “gli stati soggiacciono sempre più a un controllo esterno da parte delle
élites finanziarie ex territorializzate che non è più possibile localizzare nel mondo delle reti elettroniche. Il
loro interesse per un Paese, interesse che non è più legato alla loro origine nazionale, può fiorire con la
stessa rapidità con la quale può anche venir meno”
(Beck 2010: 182).
Accade anche che i grandi gruppi che si rafforzano grazie
agli incentivi e ai contributi dello stato tendano ad allentare sempre di più i rapporti con lo stato nazionale d’origine fino ad uscirne. Questo riguarda l’Italia ma riguarda
anche altri paesi. Beck ricorda come ad esempio la
Siemens dopo aver ricevuto miliardi dallo stato tedesco
negli ultimi 50 anni, destinati allo sviluppo dell’energia
nucleare, si è emancipata dalla Germania. Analogamente
l’Inghilterra, prima nazione ad industrializzarsi, oggi ha
pochissime imprese a carattere industriale mentre ha sviluppato soprattutto il settore finanziario internazionale,
commerciale e immobiliare.
Le trasformazioni delle imprese sono tali e tanto rapide
che diventa difficile identificare un’impresa per un lungo
periodo perché subisce una ristrutturazione costante che
produce non solo spostamenti nello spazio, ma anche
modificazioni nelle produzioni, nella forma giuridica,
nella denominazione, nella proprietà, e anche come conseguenza insicurezza e instabilità nel lavoro.
Come gli antropologi si confrontano con i temi al centro
di questo convegno della tradizione, del patrimonio e
della valorizzazione? Lo studio dei saperi tecnici, del patrimonio, dei saper fare e della loro trasmissione è stato
centrale nell’analisi dell’impresa soprattutto in Francia in
cui negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso sono
fioriti numerosi studi che hanno sottolineato la relazione
tra sviluppo industriale e tradizione tecnica e artigiana
soprattutto in alcuni settori. Una linea di studi che si situava sulla scia di una tradizione affermatisi un secolo
prima chiamata “folklore dei mestieri e delle tecniche”
che aveva avuto ampio sviluppo a partire dalle raccolte
di Sébillot (1890,1894) e Boutmy (1883) rinnovata attraverso le prospettive di una etnologia delle società contemporanee attente ai fenomeni di patrimonializzazione
e di sviluppo locale.
In che misura e in quali contesti nel quadro più sopra delineato si può ancora parlare di saperi tecnici locali e
della loro trasmissione e valorizzazione produttiva?
Quando il distretto industriale, costruito intorno a saper
fare e risorse locali tende a diventare una nebulosa e a
dilatarsi a livello globale, come si trasformano i sistemi di
relazione, di produzione e trasmissione della conoscenza
al suo interno? Se stiamo assistendo alla perdita dei patrimoni tecnici del lavoro territoriali e di rottura delle comunità di pratica, in che misura al contrario la globalizzazione e la mobilità costituiscono un terreno di ibridazioni e confronto di saperi tecnici e più in generale di saperi e pratiche del lavoro anche tenendo conto del largo
fenomeno dell’imprenditorialità migrante?5
Gli effetti della globalizzazione sul lavoro, anche nei paesi europei dove i lavoratori avevano ottenuto ampie garanzie e tutele, incide sulla crisi del sindacato e su una parallela diminuzione del potere d’acquisto dei salari6 e di
quelle garanzie e tutele, diventate diritti, che oggi vengono messi in crisi da una politica industriale di globaliz-
XXII
zazione al ribasso. Essa appare inevitabile e tende ad avvicinare le condizioni di lavoro dei paesi europei sindacalizzati a quelli dei paesi emergenti con bassi salari e tutele
scarse o assenti, come il recente esempio italiano dell’accordo separato della Fiat a Pomigliano prima, e la disdetta dell’accordo nazionale della Federmeccanica poi
hanno dimostrato. Noi antropologi dovremmo domandarci perché con difficoltà ci misuriamo con i processi che
riguardano i patrimoni culturali immateriali (pratiche, sistemi di valori e di relazioni) che hanno una valenza sociale e politica oltre che tecnico-economica, tra cui sono
rilevanti i diritti conquistati dalle lotte del movimento
operaio nel Novecento dal diritto di sciopero, a quello alle
pause e alla sicurezza, alla contrattazione collettiva.
Riflettendo sul fatto che la nostra disattenzione verso il
processo di depatrimonializzazione di quelli, che fino a
qualche decennio fa erano considerati patrimoni da conservare gelosamente, implica la distrazione dello sguardo
da un fenomeno di portata epocale, con gravi conseguenze per tutti .
2. Un fenomeno solo apparentemente opposto a quello
della delocalizzazione produttiva e della globalizzazione
dei mercati è quello della labellizzazione del territorio,
che anzi rappresenta un tratto caratteristico del nuovo
capitalismo globalizzato, a cui non sfuggono neppure i
territori più marginali. Esso si fonda sulla costruzione
della territorialità dei prodotti e delle risorse che viene
definita con un sempre più significativo ricorso immaginifico alle loro valenze culturali e sociali.
Più o meno in rapporto con le singole produzioni culturali materiali o immateriali locali le amministrazioni locali
e diversi stakeholders tendono a costruire un marketing
territoriale sostenibile (Caroli 2006) che contempla tra i
fattori di “offerta” territoriale anche la cultura locale con
una particolare accentuazione dei tratti di quella che è
stata chiamata di volta in volta fiction economy
(Carmagnola 2006), soft economy (Cianciullo - Realacci
2005), economia dell’immateriale (Goldfinger 1996), in
cui l’immaginario rappresenta la nuova forma-merce e di
cui in Italia la Fondazione Symbola si è fatta promotrice.
È in atto una competizione territoriale generalizzata, che
utilizza anche risorse culturali, e in alcuni casi principalmente risorse culturali, per accaparrasi investimenti di
capitali che naturalmente una volta acquisiti producono
in questi stessi territori una dipendenza. Essa è comprensibile all’interno di una prospettiva di sistema mondiale
che avevano già messo in evidenza qualche decennio fa
Wallerstein (1978,1982,1995) ed altri e che antropologi
contemporanei come Friedman (2000), Friedman,
Randeira (2004), sia pure dopo averla rivisitata, rivalorizzano a partire dalla necessità di comprendere la globalizzazione nei suoi meccanismi. Viene sottolineato come
l’attacco alle posizioni di Wallerstein, portato da orientamenti postmodernisti e postcoloniali che mettono in evidenza gli aspetti liberatori della globalizzazione e i suoi
caratteri più propriamente culturali, debba essere visto
come una parte dell’analisi di un sistema mondiale che
coincide con un campo contraddittorio in cui i differenti
ambiti da quello individuale a quelli macroeconomici si
influenzano mutualmente, piuttosto che come una alternativa che vi si oppone. Anche il destino di una specifica
area (il modo in cui circola la ricchezza e come viene accumulata) può essere compresa solo in una prospettiva
relazionale e tenendo conto del modo con cui essa è legata all’arena più larga dei processi economici e di potere complessivi. Si è venuta costituendo quella che Beck
chiama “società mondiale della prestazione, nella quale
le disuguaglianze globali tra Paesi, stati e regioni sono
determinati in base a “principi di prestazione” misurabili
con criteri economici secondo la massima ciascun paese
è l’artefice della propria infelicità. In questo modo agli
Stati alle regioni povere così come a quelli ricchi viene attribuita una posizione nella gerarchia della società mondiale in forza dell’immagine che danno di sé o che gli altri si fanno di essi”(Beck 2010: 157).
Nella contemporaneità questa competizione globale è
ben presente ai vari attori locali che agiscono consapevolmente nel quadro di una lotta tra i territori per la loro
classificazione all’interno di differenti gerarchie a seconda dei contesti di riferimento, utilizzando vari strumenti da quelli della comunicazione a quelli delle modalità di presentazione e predisposizione dell’offerta territoriale ai suoi potenziali acquirenti/fruitori.
Si è dunque di fronte ad una pratica consapevole rivolta
alla commodification non di un singolo prodotto ma di
un territorio inteso nel suo complesso come luogo di integrazione di risorse umane, competenze, infrastrutture,
servizi, ivi compresi tratti culturali locali che vengono patrimonializzati, il quale si propone all’esterno come destinatario di localizzazione di risorse.
Molti sono i temi di particolare interesse rispetto a questo
fenomeno per gli antropologi tra cui: come la cultura locale nei suoi aspetti patrimoniali o la produzione di immagini che la evocano contribuisce a creare il contesto territoriale e il suo valore? In che misura la valorizzazione territoriale per gli attori locali rappresenta una attivazione
non solo di motivazioni utilitarie ma anche la mobilizzazione di sentimenti identitari, memorie, relazioni? Che
ruolo gioca la cultura locale nella valorizzazione turistica
del territorio e quali sono le forma della sua costruzione?
3. Riflettendo sul futuro: dopo un breve periodo alla
fine del secolo scorso in cui gli antropologi e gli osservatori economico-sociali più in generale avevano evidenziato gli aspetti progressivi e democratici della globalizzazione visto come contesto per un’espansione dei
diritti e un accesso alle risorse più ampio per tutti, due
momenti critici a diversi livelli a livello della violenza collettiva con l’attacco a New York alle Torri gemelle
dell’11 settembre 2001 e a livello economico con quella
che ormai viene ormai chiamata la Grande recessione,
iniziata nel 2007 e non ancora terminata, ci hanno sollecitato a ripensare il futuro come il luogo di una indispensabile rottura con il presente. Per limitarci soltanto
alla seconda questione, che non è tuttavia isolata dalla
prima, si vengono via via elaborando riflessioni, il cui comune denominatore è quello di evidenziare l’intreccio
tra l’economico e le altre dimensioni (sociale, culturale
e politico) che l’ideologia neoliberista tende ad occultare per affermare l’autonomia del mercato e delle
“leggi” economiche. Antropologi come Gudeman
(2008, 2009, 2010) o studiosi di scienze politiche come
Goldsmith7 (2010) sia pure da differenti punti di vista
XXIII
sottolineano la necessità di individuare nuove forme di
produzione e nuovi modelli di imprenditorialità. Una
particolare attenzione è riservata alla imprenditorialità
sociale e comunitaria. E nella prospettiva del patrimonio
e della tradizione potremmo domandarci in che misura
le nuove imprese pubblico privato o del privato sociale
facciano tesoro di patrimoni di pratiche e competenze
come la cultura della cooperazione, del volontariato,
dell’economia informale comunitaria, dell’economia familiare elaborati in periodi precedenti. La vocazione
comparativa dell’antropologia infine può essere utilmente messa in campo su quell’ampia area differenziata al suo interno che in varie parti del mondo produce nuove forme di economia? Gudeman risponde di
sì quando si domanda retoricamente se “La distruzione
dell’economia attraverso la concentrazione dei profitti e
l’outsourcing è il nostro futuro oppure dobbiamo combinare le esperienze del capitalismo, del socialismo e
delle economie etnografiche in modi nuovi per sostenere le relazioni sociali,il benessere individuale e condizioni di vita dignitose?“ (Gudeman 2010). Poiché il capitalismo è un sistema economico storicamente situato,
che ha mostrato tuttavia una grande capacità di adattamento in aree geografiche e contesti politici e storici differenti, tanto che in Italia si parla ormai di quarto capitalismo (Colli 2002), quali segnali possiamo cogliere e
quali terreni dobbiamo esplorare per immaginare la trasformazione anche attraverso queste nuove forme e le
loro potenzialità nel futuro? Più che cercare il campo etnografico in un “terzo spazio” come spazio autonomo
nuovo e qualitativamente diverso credo che dovremmo
cercare connessioni parziali che si producono in zone di
incontro e di frizione (Tsing 2005; Clifford 1999) attraverso le quali persone, idee e rappresentazioni che ob-
bediscono a logiche diverse “sono interconnesse ma
mai totalmente simmetriche o pienamente
integrate”(Arce - Long 2005: 84). Esperienze come
quelle del microcredito, dei gruppi di acquisto solidale,
delle communities in school, del cohausing, dell’agricoltura urbana, costituiscono esperienze contemporanee
che rompono schemi precostituiti, e che nella loro diversità sono accomunate dall’esigenza di trovare nuove soluzioni, ma che non sono slegate da forme più tradizionali di produrre e consumare. Riflettere su queste connessioni credo costituisca una delle sfide di una antropologia del contemporaneo capace di esplorare il futuro
(Cristina Papa).
Riferimenti bibliografici
Agostinelli, M. (1997), Tempo e spazio nell’impresa
postfordista, Roma, Manifestolibri
Arce, A. – Long, N. (2005), “Riconfigurare la modernità
e sviluppo da una prospettiva antropologica”, in R.
Malighetti R., a cura, Oltre lo sviluppo. Le prospettive dell’antropologia, Roma, Meltemi, pp.72-87
Becattini, G., a cura (1987), Mercato e forze locali. Il distretto industriale, Bologna, Il Mulino
Beck, U. (2010 (2002)), Potere e contropotere nell’età
globale, trad. dal tedesco, Bari, Laterza
Boissevain, J. – Hodeir, C. et al. (1992) Les entreprises
ethniques aux Pays –Bas, in «Revue européenne des
migrations internationales», vol. 8, n.1, pp. 97-106
Boutmy, E. (1883), Dictionnaire de l’argot des typographes suiviu d’un choix de coquilles typographique
curieuses ou célèbres, Paris, Marpon et Flammarion
Bruno, A.S. – Zalc, C., a cura (2006) Petites entreprises
et petits entrepreneurs étrangers en France, 19e-
XXIV
20e siècles: actes des journées d’études des 23 et 24
octobre 2003, Parigi, Publibook
Carmagnola, F. (2006) Il consumo delle immagini: estetica e beni simbolici nella fiction economy, Milano,
Bruno Mondadori
Caroli, M. (2006), Il marketing territoriale. Strategie per la
competitività sostenibile del territorio, Milano, Angeli
Cianciullo, A. – Realacci, E. (2005), Soft economy,
Milano, Rizzoli
Clifford, J. (1999), Strade. Viaggio e traduzione alla fine
del secolo ventesimo, Torino, Bollati Boringhieri
Colli, A. (2002), Il quarto capitalismo. Un profilo italiano,
Venezia, Marsilio
Flot-Fresnoza, A. – Pécoud, A. (2007) Immigration et entreprenariat. Les Philippins à Paris, in «Revue européenne des migrations internationales», vol. 23, pp.
199-216
Friedman, J. (2000), Globalization, class and culture in
global systems, in «Journal of world systems research», vol.VI, n. 3, autunno- inverno, pp. 636-656
Friedman, J. - Randeira, S. (2004), Worlds on the move:
globalization, migration and cultural security,
London, Tauris
Gallino, L. (2010), Sindacato. La difficile difesa del lavoratore globale, in «La Repubblica», 14 ottobre
2010, p. 40
Gudeman, S. (2009), Hoarding wealth: when vice becomes virtue, in «Anthropology today», vol 25, n. 2,
pp. 25-26
Gudeman, S. (2010), Creative destruction: efficiency or
collapse? in http:// www. re-public.gr/en/?p=1471
Goldfinger, C. (1996), L’utile e il futile. Per un’economia
dell’immateriale, Torino, Utet
Goldsmith, S. – Georges, G. – Burke, T. (2010), The
Power of Social Innovation. How Civic Entrepreneurs
Ignite Community Networks for Good, San Francisco,
Wiley & Sons
Jones, T.P. – Hodeir, C. et al. (1992), Ressources etniques et égalité des chances:les entreprises indopakistanaises en Grande-Bretagne et au Canada, in
«Revue européenne des migrations internationales», vol. 8, n. 1, pp.107-126
Peraldi, M. (2002), Migranti imprenditori. Il caso francese, in «Impresa e Stato», aprile-giugno, n. 59, pp.
34-36,
Peraldi, M. (2005), Marsiglia Bazar del Mediterraneo,
Messina, Mesogea
Sacchetto, D. (2007), “Isolani dell’arcipelago”, in F.
Gambino – D. Sacchetto, a cura, Un arcipelago produttivo. Migranti e imprenditori tra Italia e Romania,
Roma, Carocci, pp. 133-170
Tsing, A.L. (2005), Friction. An Ethnography of Global
Connection, Princeton, Princeton university press
Wallerstein, I. (1978, 1982, 1995), Il sistema mondiale
dell’economia moderna, 3 voll., Bologna, Il Mulino
Sintesi della discussione
Temi centrali della sessione di discussione sono la valorizzazione economica e del lavoro in rapporto alla contemporaneità ed ai temi della tradizione. Ai temi della lavoro e dell’impresa si affianca quello della mobilità colle-
gata alla deterritorializzazione dell’impresa e del lavoro
in relazione all’apertura dei mercati.
Cristina Papa, nella sua introduzione, sottolinea il progressivo disancoraggio dell’impresa rispetto al territorio
e l’affievolirsi delle relazioni sociali costruite nella prima
metà del ‘900 tra territorio e impresa. Il disancoraggio
territoriale coinvolge le piccole e medie imprese che vengono assorbite dal mercato globale ma nello stesso
tempo anche le grandi imprese multinazionali che si disancorano dal territorio di origine. Ne consegue un cambiamento nella struttura stessa delle aziende.
Partendo dal presupposto che il rapporto dell’impresa
con il proprio territorio tende a sfumare ed a produrre
dei cambiamenti, Cristina Papa introduce i temi chiave
della discussione:
– saperi e trasmissione dei saperi tecnici locali;
– marketizzazione del territorio, intesa come valorizzazione delle proprie risorse culturali e culturalizzazione del territorio.
I primi interventi, a cura di Simone Ghezzi e Bogdan
Iancu affrontano la questione del saper fare e della trasmissione generazionale dei saperi tecnici locali.
L’intervento di Simone Ghezzi si fonda nello specifico
sulle ricerche da lui condotte tra i distretti economici
della Brianza nei settori della meccanica e del mobilio.
In particolare Ghezzi mette in luce alcuni aspetti che
caratterizzano l’economia dell’impresa in quest’area e
la trasmissione dell’impresa stessa, ponendo l’attenzione su alcuni punti tra cui la divisione sociale dei
ruoli basata sul genere all’interno delle imprese e la
promozione delle imprese artigianali all’interno delle
scuole conseguentemente all’incapacità da parte delle
imprese stesse di attrarre autonomamente forza lavoro
locale.
L’intervento di Bogdan Iancu, dal titolo I Vetrai senza
XXV
Frontiere. La vita sociale delle finestre della Romania, è
basato sulla ricerca da lui condotta sulla produzione
della finestra termoisolante, simbolo di una più ampia ristrutturazione economica avvenuta negli ultimi decenni
in Romania. La ricerca di Iancu fondata sullo studio della
Cooperativa di vetrai analizza in particolare la trasmissione dei saperi tecnici all’interno di un quadro economico in cui emerge la difficoltà da parte degli anziani del
gruppo di adeguarsi alle nuove produzioni imparando
dai più giovani. Come nell’intervento di Ghezzi, emerge
anche qui l’importanza della parentela in un’economia
fondata sul management familiare.
Segue l’intervento di Paolo Piquereddu che, riflettendo
sulla trasmissione dei saperi, e analizzando l’attuale situazione della pastorizia in Sardegna, sottolinea come sia evidente il paradosso tra disastro economico in cui l’attuale
mondo pastorale versa e l’idealizzazione dello stesso presentato attraverso iniziative di valorizzazione e promozione. Più in generale, Piquereddu si chiede come riuscire
a conciliare in un’ottica di promozione globale di un territorio quella che è l’attività dell’antropologo e nello stesso
tempo l’attività reale e quotidiana del mondo pastorale, riflettendo sulla mancanza, da parte degli antropologi, di
una certa capacità di interagire in maniera produttiva nelle
politiche di sviluppo territoriale e sulla necessità di trovare
nuove forme di interazione con i protagonisti del territorio.
Gli interventi di Chiara Cipollari, Franco Lai e Alessia
Fiorillo affrontano invece i temi del marketing territoriale
costruito dal basso e il ruolo dell’immagine nella costruzione e culturalizzazione di un luogo.
La ricerca di Chiara Cipollari prende in esame una forma
di turismo rurale sviluppatasi nei primi anni ’90, con l’arrivo dei primi fondi europei destinati al turismo, in alcuni
villaggi rurali della Romania, al confine con l’Ucraina.
Premesso che nelle retoriche identitarie degli stessi studiosi rumeni alcune zone rurali della Romania, tra cui
quella studiata, erano già state definite la culla dell’identità rumena e immaginate all’interno di un tempo universale, la Cipollari sottolinea come queste specificità
sono entrate oggi a far parte delle retoriche contemporanee, contribuendo allo sviluppo di un turismo rurale
che oltre ad essere attività economica è anche forma di
improvvisazione che viene messa in scena e proposta ai
turisti. Chiara Cipollari analizza i temi degli sguardi, interni ed esterni, che costituiscono l’appetibilità dei luoghi e la produzione del segno turistico agli sguardi collegato, mettendo in risalto come le immagini giochino un
ruolo fondamentale in questo contesto.
Sul tema del marketing territoriale costruito dal basso interviene anche Franco Lai con la sua ricerca dal titolo I beni
culturali come merce del capitalismo del nuovo millennio.
Riferendosi a quelle che Wallerstein definisce periferie e
semi-periferie del mondo, Franco Lai individua in zone
come la Sardegna, la Corsica, il sud della Spagna e il sud
Italia, le periferie e semi-periferie dell’Europa, sottolineando come l’unico modo che questi paesi abbiano di garantire un dignitoso livello di vita sia quello di puntare sullo
sviluppo economico collegato alle esperienze locali e territoriali; gli stessi progetti leader dell’Unione Europea tendono infatti negli ultimi 15-18 anni a finanziare la piccola
e media impresa su base locale. C’è un quadro normativo
favorevole a promuovere un’idea di località legata alla cultura ed alle competenze tecniche e saperi di tipo locale.
Riprendendo i termini di “localizzazione” (Roland
Robertson) e di “cibo geografico” (Massimo Montanari),
Lai nota come il turismo si faccia veicolo della commercializzazione, non solo dell’immagine turistica ma anche dei
prodotti locali, legati alla storia del territorio. Sul tema del
rapporto tra immagine e territorio, Lai riporta alcuni
esempi pubblicitari ed alcuni frames del film Basilicata coast to coast (2010), di Rocco Papaleo, notando come le immagini e sempre più spesso il cinema contribuiscano non
poco a forgiare ed a trainare l’immagine della località.
All’intervento di Franco Lai si ricollega quello di Alessia
Fiorillo che mostrando un micro progetto di marketing
territoriale dal titolo Terre di Siena, messo in opera dalla
provincia di Siena, focalizza il suo intervento sull’articolazione tra merce e patrimonio nella “degustazione culturalizzata”. Il contesto in cui questo progetto nasce è
un contesto che a livello globale riconosce il turismo culturale attraverso le politiche Unesco che negli anni ’90
definiscono le leggi dei marchi europei e attraverso la
definizione in quegli stessi anni della legge per la costruzione delle Strade del vino. Il degustatore diventa in questa campagna promozionale di marketing il consumatore futuro e la tradizione si assoggetta sempre più
spesso alle logiche di mercato. Alessia Fiorillo sottolinea
come in questo contesto due processi vengono messi in
atto, da un lato la patrimonializzazione del cibo, su cui
ci si dovrebbe interrogare e dall’altra la mercificazione
dell’atto alimentare, notando come le degustazioni e le
politiche di marketing ad esse collegate sono di fatto
pensate per essere costruite come processi di produzione di merci immateriali ma in realtà vengono assoggettate a logiche di mercato che non vedono in essi un
profitto immediato. Paolo Piquereddu riflettendo sulle ricerche di Chiara Cipollari e Alessia Fiorillo, nota come sia
i diretti protagonisti che i fruitori delle iniziative siano
quasi in balia delle politiche turistiche e come, sia evidente il contrasto tra la debolezza economica di alcuni
luoghi e le operazioni di marketing adottate.
Invita a riflettere sul ruolo dell’antropologo e sulla necessità di una “certa etica” della professione riguardo al
rapporto serio ed onesto con i protagonisti ed alla garanzia di una certa serietà anche nella comunicazione.
Interviene Franco Lai che, in accordo con Piquereddu,
sottolinea la necessità di “dirigere il turismo e non esserne governati”; il marketing territoriale è un’operazione economica molto delicata, il cui rischio è quello di
creare un mondo estremamente caratterizzato.
Conclude Cristina Papa che pone l’accento sulla perdita
e la frammentazione della produzione a favore della costruzione dell’immagine e della culturalizzazione dei prodotti, invitando a riflettere sull’antinomia tra produzione
e consumo e tra marketing e scambio, dove lo scambio
e il consumo assumono oggi un’importanza maggiore rispetto alla produzione (a cura di Ciriaca Coretti).
Hanno partecipato: Chiara Cipollari (Università di
Perugia), Alessia Fiorillo (Università di Perugia), Simone
Ghezzi (Università di Milano-Bicocca), Bogdan Iancu
(Dottorando Università SNSPA, Bucarest – ricercatore,
XXVI
Museo del Contadino Romeno di Bucarest), Franco Lai
(Università di Sassari), Veronica Redini (Università di
Perugia).
ARTE CONTEMPORANEA E CRITICA CULTURALE
Introduce Roberta Cafuri
primo discussant Sandra Ferracuti
Sul versante della critica culturale, antropologia culturale
e arte contemporanea hanno condiviso la revisione di
metodi e presupposti, in particolare sul ruolo del soggetto, sullo statuto di autore e sul conseguente slittamento dei confini del campo di ricerca e disciplinare
dell’artista e dell’etnografo. Le provocazioni giunte dal
mondo museale e artistico si sono intrecciate con le
spinte a riconsiderare gli sguardi degli etnografi sugli oggetti di studio:8 questi, trasformatisi in soggetti nel
mondo post coloniale, se vestono i panni dell’artista,
sono oggi considerati portatori di una voce critica sulla
propria cultura e società più interessante di quella
dell’antropologo o del curatore di mostre.
Dall’Autore agli autori. Nella pratica sul campo, denominata etnografia, l’antropologia culturale ha unito la
scrittura all’osservazione dei meccanismi con cui funzionano le società. Gli appunti personali e le interviste – oltre alla lettura dei libri e alle fotografie o ai video filmati
– sono i materiali a partire dai quali gli antropologi ‘riscrivono’ la realtà osservata. Olu Oguibe, un artista nato in
Nigeria che vive e lavora a New York, ha mostrato come
l’impiego di alcune tecniche narrative combinate tra loro
possa originare false realtà, ma che risultano al lettore
verosimili. In Ethnographia, una serie di opere create tra
il 1997 e 1999,9 una donna Asante del Ghana, in un ritratto dai colori ocra e neri di una foto ingiallita dal
tempo; un ragazzo Igbo della Nigeria, con la fronte dipinta con segni colorati, e una donna di colore sud africana, in una foto bianco e nero, sono i volti sovrapposti
alle pagine di appunti scritti a mano. Tra i segni non si
coglie un discorso lineare, ma solo alcune parole ingrandite ad arte dall’artista. Una didascalia restituisce la realtà evocata da quei frammenti: «donne di colore, che
un tempo si sono sposate con asiatici provenienti dal
continente indiano, vivono in una condizione di emarginazione nelle pianure circostanti Natal e all’estremo
capo orientale del Sud Africa. Esse sono disprezzate e alcune sono state convertite al Cristianesimo», viene spiegato per esempio in Colored woman I.10 L’espressione
malinconica del volto e lo sguardo velato di tristezza
della donna sembrano suffragare quanto descritto, unitamente alla pipa appoggiata alle pagine scritte a mano,
la quale conferisce autorevolezza scientifica agli appunti.
In realtà quelle donne non sono mai esistite: così la frattura tra la realtà e la sua rappresentazione, mediante la
scrittura etnografica, è raffigurata da Olu Oguibe
(Enwezor - Oguibe 1999). Ciò ci rinvia allo statuto
dell’autore nella rappresentazione delle diversità culturali.
Già nel 1969 Michel Foucault aveva tenuto una conferenza, divenuta celebre, dal titolo Che cos’è un autore?
(Foucault 1969).11 Molti vi lessero la profezia della morte
del soggetto, mentre essa sanciva un’acquisizione comune alle scienze sociali e umane del Novecento.
Nell’analisi delle relazioni di potere che s’instaurano anche nelle prassi discorsive, Foucault evidenziava che l’autore era un prodotto ideologico: un principio funzionale
attraverso il quale, nella nostra cultura, si limita, si
esclude, si sceglie tra una serie di significati presenti in
ogni linguaggio, dal testo all’immagine, per limitarne la
libera circolazione, composizione e ricomposizione, interpretazione e manipolazione soggettiva da parte del
destinatario della comunicazione (Foucault 1979). La riconsiderazione del ruolo sociale e politico dell’autore
mise allora in luce l’eclissi cui erano stati sottoposti i collaboratori sul campo degli antropologi, assenti nei loro
scritti sia come fonti delle informazioni sia come interpreti e traduttori delle loro diverse appartenenze culturali e sociali. Questa omissione, peraltro, era venuta
meno in un lavoro di Johannes Fabian: un artista figurativo, Tshibumba Kanda Matulu, era stato invitato negli
anni Settanta da Fabian a collaborare nello studio e
nell’interpretazione della storia dell’ex Zaire, con quadri
descritti dall’autore stesso in Remembering of the past
(Fabian 2000). L’arte contemporanea era perciò già
comparsa all’orizzonte dell’antropologia culturale agli
inizi degli anni Ottanta, ma solo recentemente la natura
dialogica del metodo antropologico si è manifestata in
una collaborazione con gli artisti che (Schneider - Wright
2006), come notano Howard Morphy e Morgan Perkins
in Anthropology of art, nelle loro sperimentazioni presentano concezioni alternative dell’arte e del sapere culturale (Morphy – Perkins 2006: 21).
L’artista etnografo. In un saggio intitolato L’artista
come etnografo, il critico d’arte americano Hal Foster
evidenziava come l’arte fosse entrata in quell’arena della
critica culturale in cui l’altro veniva re-inserito per mettere in discussione le visioni dell’Occidente (Foster 2006).
Politiche museali in chiave multiculturale si sono spinte a
dedicare interi spazi nei musei agli artisti, presentati
come produttori di una critica culturale quasi più ‘autentica’ di quella dello sguardo del curatore delle mostre o
dell’antropologo (Cafuri 2008). Esattamente il contrario
avveniva in Art, identity, boundaries, in cui Oguibe rileggeva l’intervista del critico d’arte africana Thomas
McEvilley a Bakari Ouattara, artista della Costa d’Avorio
che viveva a New York e aveva esposto alla Biennale di
Venezia del 1994. La conversazione era stata condotta
con uno stile della comunicazione, che rinviava a un’evidente gerarchia: da un lato un soggetto che non dialogava, ma investigava un altro essere umano, riconducendolo a un oggetto, da cui doveva emanare una fascinazione esotica. Le domande concernenti la famiglia d’origine, la formazione scolastica ed estetica, la lingua e le
pratiche religiose in uso nella propria collettività africana,
che magari comportassero qualche sacrificio umano,
confinavano Ouattara a fare da mero contorno alle sue
opere. L’artista non aveva potuto esplicitare le sue interpretazioni e attribuire i suoi significati alle proprie opere.
Così l’uso del linguaggio si era trasformato in una forma
di libido domini, cioè in un modo di articolare e ridefinire
se stessi come author-ity (Oguibe 2004:13). D’altronde
Roland Barthes aveva messo in luce proprio la correlazione tra l’attribuzione di un testo (in questo caso
un’opera figurativa) a un autore, operazione che ne fissa
XXVII
i significati e delimita le possibili interpretazioni, e la legittimità del ruolo di critico dall’altra, perché quest’ultimo si attribuisce così l’insostituibile funzione di scoprire
l’autore, spiegandone le opere (Barthes 1977: 147).12
La creatività è invece un modo per imporre il controllo
non sugli altri, ma su se stessi: attraverso l’abilità e la libertà compositiva, l’artista si sottrae al potere delle definizioni di un altro diverso da se stesso. La firma originale,
l’autonomia, l’articolazione del sé sono tuttavia territori
ancora oggi contestati, in cui l’artista contemporaneo si
trova a sviluppare strategie di sopravvivenza tra meccanismi di regolazione e sorveglianza delle relazioni asimmetriche in società, economie dell’arte, pratiche del desiderio e del consumo diverse fra loro (Oguibe 2004: 15).
Alcuni artisti, calandosi in questo ruolo di soggetto “altro”, riscrivono le rappresentazioni esistenti, sia del passato sia del presente della loro cultura, e nel far questo
esplorano pratiche di lavoro sul campo, quali la raccolta
di documenti e la trascrizione di testimonianze, che fondano anche il metodo scientifico dell’antropologia culturale. Un esempio è la ricerca di Romuald Hazoumé sui significati dei segni di Fa, un’antica geomanzia diffusa nei
paesi del Golfo di Guinea, i cui esiti sono visibili in una
parte della sua produzione pittorica (Cafuri 2005). Uno
scambio fecondo tra arte e antropologia è avvenuto anche tra il musicista Ludovico Einaudi e i testi di Ernesto
De Martino e di Gilbert Rouget, su musica e trance nella
taranta salentina (Einaudi 2010: 39). Einaudi ha riletto le
etnografie su antichi fenomeni rituali per ripresentare,
nella chiave della performance o del festival, musiche
con suoni ‘tradizionali’ ed elettronici.13 Per rendere ‘contemporaneo’, cioè “accessibile, attuale e vivo” (Einaudi
2010: 39) quel sapere musicale, il musicista ha cercato
un rapporto con forme più recenti di riti collettivi, come
i raduni giovanili moderni in cui migliaia di persone si abbandonano a canti, danze e musiche, nutriti da suoni
elettronici e minimalismo.
Tra diffusione ed esclusione. La musica ha una peculiarità, rispetto all’arte figurativa: il suo consumo non è
limitato agli spazi museali o alle gallerie, frontiere di rado
solcate da chi non ha “il capitale culturale necessario
nemmeno per varcare la soglia di un museo”, come
scrive Anna Lisa Tota (1999: 157). Il testo musicale è
meno elitario, sia per la sua diffusione capillare anche
per esempio nel Web su You Tube, sia perché più suscettibile all’ibridazione. La sua riproduzione può avvenire
nelle esecuzioni dei gruppi musicali giovanili spontanei o
secondo i movimenti delle bacchette nelle mani dei maestri d’orchestra, senza mettere in gioco l’autenticità,
come criterio del giudizio estetico (Goodman 1976).
L’arte diffusa dai media tecnologici si presenta dunque
come un campo per rivedere i meccanismi di esclusione:
la sua diffusione avviene infatti, almeno potenzialmente,
presso classi sociali disparate. Come nota Dominique
Berthet (2002:7-8), il ricorso continuo nelle installazioni
artistiche contemporanee all’ibridazione e alla mescolanza tra pittura, fotografia, scultura, video, musica, architettura, teatro, danza può essere letto come una
nuova manifestazione di resistenza: comune a molti artisti di ogni nazionalità, esso esprimerebbe il tentativo di
rinnovare le pratiche, di allargare gli orizzonti e di elabo-
rare nuovi significati, trasgredendo i limiti posti tra generi e categorie.
La sfida dell’arte multimediale è affrontare mutamenti di
portata strutturale, che investono le regole del gioco tra
i ruoli di artista e consumatore. Dopo l’avvento di ipertesti e interattività, il ruolo passivo dell’uno e quello attivo
dell’altro sono stati apparentemente archiviati. Internet,
videogiochi e portatili hanno creato una generazione di
produttori e diffusori di contenuti, che ha sostituito i
consumatori passivi, come ha svelato Clay Shirky (2010).
Tale processo si colora di una personalizzazione dell’esperienza estetica. Un esempio proviene dall’e-book. Alice
in wonderland di Lewis Carrol ha una versione concepita
per l’iPad, che va ben al di là degli ipertesti. Ogni immagine, prelevata dall’edizione originale, è stata resa sensibile alla forza di gravità, cioè reagisce se viene toccata
con un dito, scossa o inclinata (Du Sautoy 2010: 24).
Come il consumo diventa esperienza interattiva singolare? I fruitori guidano Alice nel mondo delle meraviglie
in modi diversi: a seconda di come inclinano l’iPad, il
Bruco fuma diversamente il narghilé o il corpo di Alice si
ingigantisce o si restringe.14
L’e-book con le sue applicazioni costituisce un terreno
d’incontro tra arte e discipline scientifiche, come l’antropologia culturale. L’artista mi sembra simile all’antropologo: è consapevole che ogni rilettura implica un tradimento, che traghetta saperi articolati, propri di altre realtà e tempi della storia, in uno spazio-tempo estraneo.
Lo sconfinamento dal campo di ricerca è infatti insito
nella ri-scrittura delle conoscenze acquisite, anche se
all’artista è concessa una libertà creativa che il sapere
scientifico antropologico ha più sperimentato nelle derive interpretative dei dati che non nelle forme possibili
della comunicazione tecnologica. A quando un iPad per
comunicare le ricerche etnografiche? (Roberta Cafuri).
Riferimenti bibliografici
Barthes, R. (1977), “The death of the author”, in Image
Music Text, Glasgow, Fontana-Collins.
Berthet, D., a cura (2002), Vers une esthétique du métissage?, Paris, L’Harmattan.
Cafuri, R. (2005), L’arte della migrazione, Torino,
Trauben.
Cafuri, R. (2008), Riconoscere la diversità, Pavia,
Altravista.
Clifford, J. (2000), I frutti puri impazziscono. Etnografia,
letteratura e arte nel secolo XX, Torino, Bollati
Boringhieri, [ed. orig. 1988].
Clifford, J. – Marcus, G. E., a cura (1997) Scrivere le culture, Roma, Meltemi [ed. orig. 1986];
Du Sautoy, M. (2010), Il magico iPad nel paese di Alice,
in «Il Sole 24 ore», 22 agosto: 229, p. 24.
Einaudi, L. (2010), Immersione nella taranta, in «Il Sole
24 ore», 209, p. 39
Enwezor, O., a cura (1999) Mirror’s edge, Umea,
BildMuseet.
Enwezor, O. – Oguibe, O, a cura (1999), Reading the
contemporary African art from theory to the marketplace, London-Cambridge, Institute of
International visual arts-MIT press
Fabian, J. (2000), Il tempo e gli altri, Napoli, L’ancora; ed.
XXVIII
or. 1983, Time and the other, New York, Columbia
University Press
Foster, H. (2006), “L’artista come etnografo”, in Il ritorno
del reale. L’avanguardia alla fine del Novecento,
Milano, Postmedia Books, pp. 175-210 [ed. orig.
1996].
Foucault, M. (1969) Qu’est-ce que c’est un auteur?, in
«Bulletin de la Société française de philosophie», 63,
p. 3.
Foucault, M. (1979), “What is an Author?”, in J. V.
Harari, a cura, Textual Strategies: Perspectives in
Post-Structuralist Criticism, Ithaca, NY, Cornell
University Press, p. 159
Goodman, N. (1976), L’esperienza estetica: rappresentazioni e simboli, Milano, Il Saggiatore; ed. or. 1968,
Language of art, New York, Bobbs-Merrill.
Heinec, N. – Edelman, B. (2002), L’art en conflit, Paris,
éd. La découverte: p. 13
Morphy, H. – Perkins, M. (2006), Anthropology of art,
Oxford, Blackwell
Oguibe, O. (2004), “Art, identity, boundaries” in The culture game, Minneapolis, University of Minnesota
Press
Schneider, A. – Wright, C., a cura (2006) Contemporary
Art and Anthropology, Oxford and New York, Berg
Shirky, C. (2010), Cognitive surplus, creativity and generosity in a connected age, New York, Penguin Press
Tota, A. L. (1999), Dal museo tradizionale al museo mediale, Roma, Carocci.
Sintesi della discussione
Gli interrogativi principali affrontati nella sessione di lavoro sull’arte contemporanea e la critica culturale sono
stati i seguenti: qual’é il rapporto tra arte contemporanea e museografia? E tra arte contemporanea ed etnografia? Cosa le avvicina? Qual é il campo d’interazione
tra le due discipline? Cosa hanno in comune l’artista e
l’antropologo? Con quali definizioni operano e che uso
ne fanno?
È ormai un dato condiviso nella critica antropologica e
artistica, almeno a partire dagli studi di Clifford (1988),
Marcus e Myers (1995), Marcus&Fisher (1999) e Foster
(1996) che l’arte contemporanea e l’antropologia, abbiano molti temi e pratiche in comune.
Molti artisti contemporanei si fanno ‘etnografi’, andando ad indagare e storicizzare le collezioni museali, le
rappresentazioni dell’altro, gli stereotipi, le narrazioni
coloniali, lo statuto dell’opera d’arte nella società contemporanea, la stessa pratica di ricerca etnografica, temi
complessi della tradizione antropologica che entrano nel
lessico dell’arte contemporanea per essere utilizzati
come strumenti creativi di critica culturale, tant’é che in
alcuni casi si parla addirittura di un’arte antropologica.
A partire dalla mescolanza del fare artistico e antropologico, gli interventi presentati in questa sede – si é parlato
soprattutto di arti (pittura, scultura, arte della performance e in parte di architettura, delle arti cosiddette tradizionali ma anche della moda) hanno messo in luce
come nella pratica ci siano artisti che studiano collezioni
di arte africana e di arte europea; artisti che vanno sul
terreno e collaborano con l’antropologo per girare un video, o documentare una festa, una processione, un rito;
antropologi che collaborano con la comunità e con i suoi
artisti per fornire interpretazioni condivise dei saperi relativi a una pratica artistica considerata ‘tradizionale’
come la tessitura; artisti che interrogano lo statuto, il va-
XXIX
lore e la funzione dell’opera d’arte come unicum da conservare e da salvaguardare. Così è nell’opera di Christian
Boltanski che, in una sua recente installazione,
Personnes15, utilizza stracci e indumenti che poi la gente
può portare via, venendo così a mancare la presenza e
l’esposizione dell’opera stessa, sovvertendo le classificazioni ‘materiale-immateriale,’ ‘tangibile-intangibile’,
aspetti su cui gli antropologi riflettono da tempo e che
incontrano continuamente, mescolati e sovrapposti,
nella pratica etnografica.
Sebbene le due discipline siano accomunate da medesime tematiche, gli interventi presentati hanno evidenziato come le figure e i compiti dell’artista e dell’antropologo restino diversi.
Da un lato l’arte contemporanea fornisce all’antropologia un altro punto di vista sugli eventi, grazie all’effetto
dirompente, immediato –di sintesi potremmo dire– che
l’opera d’arte genera nel sovvertire e ‘rompere’ le distinzioni (anche quelle interne alla disciplina), attraverso la
maggiore libertà con cui l’artista –rispetto all’antropologo– esplora e ricerca alcuni temi comuni, quali l’identità, l’ibridazione, l’alterità, il paesaggio e le migrazioni,
per dirne alcuni. Dall’altro c’é anche il rischio dell’effetto
boomerang, che potrebbe anche compromettere la ricerca e la credibilità dell’antropologo, qualora egli utilizzi
espressamente l’opera o la performance artistica come
strumenti di ricerca sul campo. Inoltre, l’arte contemporanea, pur con la sua carica dirompente, ha una doppia
veste, in quanto, sebbene metta in discussione criteri e
canoni artistici stabiliti, legittima, allo stesso tempo, un
‘sistema’ contemporaneo ‘dell’arte’ che permette l’inclusione di alcuni artisti e l’esclusione di altri, i quali per motivi storici – la presenza marginale, fino a qualche tempo
fa delle arti indigene, all’interno del canone artistico dominante, per citare un esempio – e contingenti, legati
anche a strategie di mercato, che non é possibile trattare
in questa sede, non entrano nei circuiti internazionali. La
definizione di contemporaneo é essa stessa problematica, in quanto pone uno scarto temporale. Ci si é quindi
interrogati su come declinare la nozione di contemporaneo, e soprattutto sui suoi possibili usi. L’invito é stato
quello di non limitarsi solo ad interrogarci sulle categorie
di arte e/o di estetica con cui noi operiamo ma soprattutto sugli usi che gli artisti, che gli antropologi studiano,
fanno di queste definizioni. L’attenzione per l’uso e per
i significati contestuali e particolari delle pratiche artistiche, su cui l’antropologia, in senso anti-universalista, indaga, ha portato anche a rivolgere l’attenzione allo spazio e ai contesti in cui gli antropologi operano. Se l’arte
e l’antropologia sono forme di leggere la realtà contemporanea, come possono essere letti gli spazi e i contesti
della pratica e del fare artistico e antropologico?
Prendendo spunto dall’architettura del paesaggio e
dall’architettura si é proposto di guardare allo spazio
come eredità del moderno, di ciò che la modernità ha lasciato dietro di sé, interpretandolo alla stregua di scarto,
residuo (Koohlaas 2006), o seguendo la metafora della
terra-giardino di Clément (2008), che é allo stesso
tempo un sistema chiuso, osservabile, e uno spazio incolto, indeciso, in quanto non connotato in particolare
da alcuna funzione, che però diventa anche spazio di ri-
generazione e di incontro tra i vari saperi della contemporaneità (a cura di Elisabetta Frasca).
Riferimenti bibliografici
Clément, G. (2008) Il giardiniere planetario, a cura di C.
Serra, Milano, 22 Publishing
Clifford, J. (1988), The predicament of Culture: Twenthy
Century Ethnography, Literature and Art. Cambridge
(MA), Harvard University Press,.
Foster, H. (1996) “The Artist as Ethnographer” in The
Return of the Real. Cambridge (MA), The MIT Press
Koolhaas, R. (2006) Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano, a cura di G. Mastrigli,
Macerata, Quodlibet
Marcus, G.E. - Meyers, F.R. (1995) The Traffic in Culture:
Refiguring Art and Anthropology. Berkeley (CA),
University of California Press
Marcus, G.E. - Fisher, M.M.J. (1999) Anthropology as a
cultural critique: An experimental moment in the
Human Sciences, Chicago (IL), University of Chicago
Press
Hanno partecipato: Ivan Bargna (Università di MilanoBicocca), Alessandra Brivio (Università di Milano-Bicocca),
Marinella Carosso (Università di Milano-Bicocca), Maria
Luisa Ciminelli (Università Ca’ Foscari Venezia), Elena
Corradini (Università di Modena e Reggio Emilia), Fabio
Dei (Università di Pisa), M. Gabriella Lerario (museologa
specialista in storia dell’arte contemporanea), Valentina,
Lusini (Università di Siena), Francesco Marano (Università
della Basilicata), Daniela Nasi (Università di Modena e
Reggio Emilia), Elisa Orlando (Università di Modena e
Reggio Emilia), Francesco Ronzon (Accademia di Belle
Arti di Verona), Silvia Rossi (Università di Modena e
Reggio Emilia), Mario Turci (Fondazione Museo Ettore
Guatelli), Sara Uboldi (Università di Modena e Reggio
Emilia), Luca Villa (Ricercatore indipendente)
PATRIMONI E CULTURE MIGRANTI
Introduce Anna Maria Pecci
primo discussant Vito Lattanzi
La prospettiva critica e riflessiva maturata, su scala nazionale e internazionale, nell’ambito dell’antropologia
applicata a patrimoni e musei guida i lavori della sessione “Patrimoni e culture migranti”. I termini del confronto sono da ricondurre ad un orizzonte teorico profilato da due decenni abbondanti di ragionamenti ed
esperienze, sviluppati principalmente da un’antropologia culturale sensibile e attenta alle poetiche e politiche
della rappresentazione culturale, dalla museologia collaborativa e dalle plurali accezioni della Nuova
Museologia. Lo spazio della discussione risulterà pertanto inscritto nella consapevolezza della prospettiva
eurocentrica che ha plasmato assunti e pratiche museali (Kreps, 2003); nella contestualizzazione storica, sociale e politica del principio di autorità dei musei; nella
processualità, dialogica e negoziale, dei patrimoni culturali e nella prospettiva partecipata e collaborativa
(Phillips, 2003; Lattanzi, 2008) che ha aperto il campo
della rappresentazione culturale ad una pluralità di voci
portatrici di nuovi sguardi sul patrimonio, musealizzato
XXX
e non. Il nesso tra patrimonializzazione e museografia,
sostenuto dalla centralità della loro funzione mediatrice
(Padiglione, 1997-1998 e 2008), costituirà l’asse portante del dibattito: “terreni di contesa” politico-culturale e arene di significati plurali, patrimoni e musei verranno trattati a partire dal rapporto che individui ed entità collettive instaurano con essi, interrogandone gli
usi sociali in atto nelle società contemporanee.
Nell’articolazione, qui prospettata, con i movimenti migratori, il patrimonio verrà analizzato nel suo ruolo, duplice e bifronte, di prodotto e risorsa, oggetto e soggetto di pratiche sociali e di strategie discorsive essenzialiste e processuali. Le culture migranti verranno intese in
un’ampia accezione che, basata sul comune denominatore della deterritorializzazione (Appadurai, 2001), si riferisce a comunità, associazioni e singoli individui impegnati in scenari che coincidono con ambiti istituzionali –
specialmente museali – oppure ne travalicano i confini,
posizionandosi in territori urbani o rurali e in contesti attraversati da flussi migratori transnazionali. Attori e/o destinatari di processi di patrimonializzazione multisituati e
ramificati oltre le istituzioni, i/le migranti si rapportano
anche ad altri soggetti o agenti sociali (professionisti ed
esperti, volontari, cittadini in generale) in dinamiche che,
pur finalizzate alla costruzione di “zone di contatto”
(Clifford, 1999) e/o allo sviluppo del territorio (De
Varine, 2005), sono chiamate a misurarsi con potenziali
conflitti e con le tensioni e frizioni (Karp et al., 2006) poste nell’interfaccia tra locale e globale.
Affronteremo quindi la relazione tra migranti e patrimoni nel museo – spazio democratico di formazione
della cittadinanza con funzioni di responsabilità terri-
toriale (Dell’Orso, 2009) – e sul territorio tout court, sia
esso di appartenenza o di riferimento. In entrambi i
casi, seppure con differenti modalità e gradi di portata
sociale, politica e culturale, i patrimoni materiali e immateriali, trasmessi e inscritti nel presente, si rivelano
agenti attivi della vita contemporanea: ricontestualizzati socialmente e culturalmente, prendono altre
forme, acquisiscono nuovi usi e cambiano di senso.
Trasformarli è un modo per marcare una appropriazione o riappropriazione, procedere ad una traduzione
che, collocata nello spazio liminare dell’esperienza migrante (Bhabha, 2001), comporta la produzione di
nuove differenze che “derivano da processi di traslazione di repertori culturali e pratiche sociali sia nel contesto di partenza che in quello di arrivo” (Sciarrone,
2006, p. 23).
Le tematiche in discussione spaziano dal patrimonio
quale fattore di sviluppo e rigenerazione del territorio
alle politiche locali e regionali in materia di musei e inclusione culturale; dalla (ri)appropriazione e restituzione
di patrimoni altri all’utilizzo delle tecnologie e dei new
media negli ambiti della rappresentazione e dell’accessibilità culturale. Mediante la presentazione di pratiche
istituzionali – in via di realizzazione o già portate a termine – e di ricerche sul campo in fieri o concluse, i contenuti della sessione offriranno una lettura prismatica –
per contesti di applicazione, prospettive teoriche e tagli
metodologici – tanto del carattere processuale e negoziale del patrimonio, sia “vetrinizzato” che soggettivo,
quanto della funzione connettiva del museo (Clemente,
2006).
Ai fini della discussione, la sessione privilegerà lo
XXXI
sguardo che vede le culture migranti contemporaneamente produttrici e consumatrici di significati, operanti
sul territorio – in dinamiche di rifunzionalizzazione della
cultura materiale e immateriale; di (ri)strutturazione della
memoria collettiva; di patrimonializzazione della migrazione stessa – e in museo, in azioni di educazione e mediazione interculturale e/o di collaborazione e interpretazione multivocale, nuova frontiera, almeno per quanto
attiene al contesto italiano, della valorizzazione dei patrimoni che si appella, da un lato, ad un ripensamento
delle pratiche museali (dalla conservazione all’esposizione) in termini di funzioni o “mezzi” per raggiungere
il fine dell’interculturalità e, dall’altro, ad un rinnovamento delle professionalità.
A coloro che prenderanno parte alla sessione avanziamo
alcuni punti di attenzione che si richiamano al contributo
diversificato – per strategie e strumenti – che la competenza antropologica può apportare in contesti, istituzionali e non, demoetnoantropologici o di altra matrice disciplinare. In particolare, proponiamo di interrogarci su
alcuni nodi problematici emersi dagli esiti di recenti
esperienze italiane condotte nel campo d’azione in cui
patrimoni, musei e migranti si rapportano all’interculturalità (Pecci, 2009):
– come attuare pratiche di rappresentazione culturale
e valorizzazione dei patrimoni, non tanto di ordine
celebrativo o compensatorio quanto pluralista
(Sandell, 2004), che non si limitino alla settorializzazione delle funzioni educative ed espositive, ma interessino le intere istituzioni nello sviluppare un orientamento programmatico che abbia un impatto strategico anche sulla loro missione e visione;
– come favorire un’inclusione culturale che non risulti
associata strettamente o esclusivamente ad azioni di
audience development (es. outreach, accesso, educazione) ma trovi attuazione in più ampi processi di
mediazione, partecipazione, collaborazione e empowerment culturale che conducono ad una assunzione piena e consapevole di responsabilità sociale in
nome di una Nuova cittadinanza (Maggi, 2005) che
superi la dicotomia tra “vecchi” e “nuovi” cittadini;
e soprattutto
– come sostenere e incoraggiare la partecipazione dei/
delle migranti (destinatari e/o attori di progetto) nelle
occasioni di disseminazione e confronto teorico e intellettuale che, sulla base della nostra esperienza, testimoniano di una loro presenza solitamente sparuta
se non completamente irrilevante. A nostro avviso è
giunto il momento di assumere tale aspetto come un
indicatore cruciale della “bontà”, non soltanto metodologica ma anche etica, delle nostre pratiche, per
evitare il rischio che antropologi e antropologhe, in
queste sedi, tornino ad agire “gli altri”, parlando di
e per loro.
Per concludere, qui abbiamo soltanto anticipato alcune
questioni le quali, nel corso della sessione, ci attendiamo
si arricchiscano di una più dettagliata e puntuale articolazione così come di ulteriori spunti di riflessione e dibattito. Il graduale e costante lavoro antropologico che, ne-
gli ultimi anni, ha portato ad interrogare i processi di patrimonializzazione su varia scala (locale, regionale, nazionale e internazionale) troverà infatti all’interno di
“Patrimoni e culture migranti” uno spazio di presentazione, confronto e aggiornamento. I limiti di tempo e le
finalità dell’incontro non consentiranno beninteso di
procedere ad un “inventario” o ad una sintesi delle ricerche sul campo e delle pratiche istituzionali, ma ci offriranno l’opportunità di mettere l’accento su alcune problematiche e di introdurre considerazioni che, è nostro
auspicio, invece di esaurirsi con il termine dei lavori, da
questi ultimi possano trarre stimoli per successivi sviluppi
e future nuove direzioni. (Anna Maria Pecci)
Riferimenti bibliografici
Appadurai, A. (2001), Modernità in polvere. Dimensioni
culturali della globalizzazione, Roma, Meltemi.
Bhabha, H. K. (2001), I luoghi della cultura, Roma,
Meltemi.
Clemente, P. (2006), Antropologi tra museo e patrimonio, in «Antropologia (Annuario) », n. 7 “Il patrimonio culturale”, pp. 154-173.
Clifford, J. (1999), Strade. Viaggio e traduzione alla fine
del secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri.
Dall’Orso, S. (2009), Musei e territorio. Una scommessa
italiana, Milano, Electa Mondadori.
De Varine, H. (2005), Le radici del futuro. Il patrimonio
culturale al servizio dello sviluppo locale, Bologna,
CLUEB.
Karp, Ivan et al., a cura (2006), Museum frictions. Public
cultures/Global transformations, Durham, Duke
University Press.
Kreps, C. F. (2003), Liberating culture. Cross-cultural
perspectives on museums, curation and heritage
preservation, London and New York, Routledge.
Lattanzi, V. (2008), “Patrimonio/Musei/Pratiche collaborative”, in «Antropologia Museale», n. 20/21: 1621.
Maggi, M. (2005), “Verso una Nuova cittadinanza?”, in
M. Maggi, a cura, Museo e cittadinanza. Condividere
il patrimonio culturale per promuovere la partecipazione e la formazione civica, Quaderni di Ricerca
108, IRES - Istituto di Ricerche Economico Sociali del
Piemonte, Torino, pp. 9-13.
Padiglione, V. (1997-1998), L’effetto cornice. Le mediazioni del patrimonio e la competenza antropologica,
in «Etnoantropologia», n. 6/7, pp. 137-154.
Padiglione, V. (2008), Editoriale. Museografia del contemporaneo, in «Antropologia Museale», n. 19, pp.
6-7.
Pecci, A. M., a cura (2009), Patrimoni in migrazione.
Accessibilità, partecipazione, mediazione nei musei,
Milano, FrancoAngeli.
Phillips, R. (2003), “Community collaboration in exhibitions: introduction”, in L. Peers and A. K. Brown, a
cura, Museums and source communities, London
and New York, Routledge, pp. 155-170.
Sandell, R. (2004), Strategie espositive nei musei e promozione dell’uguaglianza, in «Economia della
Cultura», n. 4 “Cultura e inclusione sociale”, pp.
539-546.
XXXII
Sciarrone, R. (2006), Come rondini in volo o come orsi
nella foresta? Migranti, stranieri, altri, in «Meridiana.
Rivista di storia e scienze sociali», n. 56 “Migranti”,
pp. 9-32.
Sintesi della discussione
La sessione di discussione si è aperta con la presentazione di alcune etnografie del territorio che ci hanno
mostrato come il sapere di una cultura migrante può diventare una risorsa. In primo luogo essa può essere promotrice dello sviluppo economico del territorio: comunità migranti riunite in associazioni, in molte città italiane, sono state in grado di avviare piccole imprese economiche, capaci di promuovere l’economia non solo nei
paesi d’accoglienza ma anche nei paesi d’origine, da cui
importano materie prime, oggetti di uso quotidiano e
d’artigianato. Inoltre la patrimonializzazione di una cultura migrante può diventare uno strumento di riconoscimento e d’integrazione identitaria: la partecipazione
delle comunità diasporiche a festival e ad iniziative simili,
favorisce una conoscenza più ravvicinata dei migranti da
parte delle comunità locali. Alcuni interventi inoltre rivelano che i musei, soprattutto quelli etnografici, siano divenuti un luogo privilegiato per l’integrazione. In tal
modo l’istituzione museale, promuovendo la costruzione
di una nuova cittadinanza multiculturale, rivitalizza e rilancia la propria missione: i musei diventano così spazi
aperti alla negoziazione, dove alle comunità diasporiche
presenti sul territorio è richiesta la partecipazione per la
costruzione condivisa di nuovi significati dei musei e degli oggetti che raccolgono e tutelano. L’allestimento diviene una pratica collaborativa che molto spesso, attraverso la restituzione di storie biografiche dei membri
delle comunità migranti, permette agli oggetti in mostra
di amplificare la loro funzione evocativa. La collaborazione tra il museo e i migranti diviene uno strumento in
grado di negoziare il significato degli oggetti che, per
quanto riguarda i musei etnografici, sono portatori di
una storia da sanare, essendo nella maggior parte dei
casi testimonianze delle usurpazioni del colonialismo.
Infine alcuni degli intervenuti hanno fornito linee guida
affinché le pratiche collaborative siano continuative nel
tempo e non siano frutto di una concezione ingenua del
multiculturalismo. In primo luogo il partenariato deve essere aperto a tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio, diversificati per specificità e competenze. In secondo luogo deve essere favorita la partecipazione delle
comunità migranti a tutte le fasi del progetto. Infine è
preferibile, nell’individuazione dei rappresentanti delle
comunità diasporiche, rivolgersi al mondo dell’associazionismo che, essendo costituito da organizzazioni parastatali, è coinvolto nella promozione di una politica culturale che sia d’integrazione e di educazione alle differenze (a cura di Martina Cultrone).
Hanno partecipato: Marina Berardi (Laureata in
Discipline Etnoantropologiche - Università “Sapienza” di
Roma), Alessandro Cocchieri (Museo delle paludi pontine - Pontinia), Noemi Del Vecchio (Laureata in Discipline
Etnoantropologiche – Università “Sapienza” di Roma),
Annamaria Fantauzzi (Università di Torino - EHESS
Parigi), Lia Giancristofaro (Università di Chieti “G.
D’Annunzio”), Gianluigi Mangiapane (Museo di
Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino),
Silvia Mascheroni (Commissione tematica “Educazione e
mediazione” - ICOM Italia), Alessandra Montanera (storico dell’arte, Fondazione Museo del Territorio Biellese),
Emanuela Panajia (Ricercatrice indipendente), Fabio
Pettirino (Antropologo), Andrea Ravenda (Università di
Perugia), Patrizia Schettino (Dottoranda - Università della
Svizzera italiana), Angela Trevisin (Museo Civico
Montebelluna), Angela Verrastro (Dottoranda - EPHE,
Sorbonne, Paris)
SOSTENIBILITÀ CULTURALE E BIODIVERSITÀ
Introduce Daniela Perco
primo discussant Gabriella Da Re
Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2010 “Anno
Internazionale della Biodiversità”: un’occasione importante non solo per riflettere su questioni di grande portata, ma anche per cercare di delineare strategie adeguate e realizzabili nei diversi contesti locali.
Nell’ambito delle azioni promosse per conservare la biodiversità e per favorire il ripristino degli ecosistemi, è
stata riconosciuta la necessità di tutelare e valorizzare il
patrimonio di saperi e pratiche locali sulla natura, come
stabilito nel 1992 dalla “Convenzione per la diversità
biologica” (CDB). Ogni paese membro dovrebbe: “nel
quadro della sua legislazione nazionale, rispettare, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le
pratiche delle comunità indigene e locali che incarnano
stili di vita tradizionali determinanti per la conservazione
e l’uso sostenibile della biodiversità e favorire la loro ampia applicazione con l’approvazione e la partecipazione
dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche e
incoraggiare la distribuzione equa dei benefici derivanti
dall’utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche”16.
Queste affermazioni appaiono particolarmente rilevanti,
poiché presuppongono l’inclusione delle attività umane
tradizionali nei dispositivi di conservazione della biodiversità e chiamano in campo gli antropologi. Si attribuisce alle popolazioni locali il ruolo di soggetti attivi, riconosciuti dal diritto internazionale, e al loro “traditional lifestyle” un peso determinante per preservare la biodiversità in maniera sostenibile.
Oltre a sancire il diritto sovrano degli Stati membri sugli
elementi della loro biodiversità, che non è più considerata bene comune e dunque facilmente depredabile, la
Convenzione definisce la questione del valore economico del patrimonio di saperi e pratiche sulla natura e
l’opportunità di un’equa distribuzione dei vantaggi legati alla loro utilizzazione17.
L’applicazione dei principi contenuti nella Convenzione
per la Diversità Biologica ha avuto nel corso degli anni
esiti positivi, conferendo ai saperi locali sulla natura una
rilevanza globale. Come scrive Laurence Tubiana: “Le
comunità autoctone e locali hanno così trovato, nei circuiti internazionali, uno spazio per negoziare la difesa
dei loro modi di vita, dei loro saperi e dei loro diritti sullo
spazio come condizione del loro contributo al bene comune e allo sviluppo sostenibile. Esse hanno riconfigu-
XXXIII
rato alcuni interessi collettivi globali. Così, la protezione
della biodiversità passa anche attraverso quella dei modi
di vita indissolubilmente legati agli ecosistemi, che sono
stati destabilizzati dal modello di sviluppo dominante”
(Tubiana 2005: 7-8)18.
Le questioni individuate nella Convenzione per la
Diversità Biologica e nei documenti che ne sono derivati,
come il “Trattato Internazionale sulle risorse fitogenetiche19, sono state oggetto di un vivace dibattito tra gli
studiosi di Antropologia ambientale, ambito disciplinare
che si configura sempre più come terreno di riflessione
critica della contemporaneità .
L’antropologo che studia le dinamiche uomo-natura non
può esimersi dal prendere posizione nei confronti di decisioni importanti relative alla governance dell’ambiente,
al ruolo spesso conflittuale dei diversi attori sociali a cui
è affidata la tutela del mondo animale e vegetale selvaggio e addomesticato, o di quelli che detengono i diritti
sulle risorse ambientali (pensiamo alla controversa questione dell’acqua)21. Non può ignorare le dinamiche di
potere a livello locale, nazionale e globale e nemmeno il
peso che i suoi studi possono avere sulle strategie di pianificazione territoriale. Come scrive Sandro Piermattei:
“Si rende necessario e urgente, per chi pratica la disciplina, il confronto con complesse questioni etiche e “deontologiche” riguardanti il ruolo e il coinvolgimento politico dell’antropologo, nonché i rapporti di potere e le
forme di disuguaglianza, spesso di portata translocale,
che interessano i contesti locali e le formazioni socio-culturali, sempre storicamente contingenti, che definiscono
i modi di pensare la “natura” e di agire in essa”
(Piermattei 2007: 9). Questioni etiche e deontologiche
emerse ad esempio nell’esperienza francese della
“Mission du patrimoine ethnologique” (a partire dal
1979), che ha visto il coinvolgimento diretto degli antropologi nelle politiche di patrimonializzazione, di gestione
culturale del territorio e nei progetti di sviluppo rurale22.
L’antropologia, anche attraverso l’attività dei musei etnografici e degli ecomusei, ha di fatto sollecitato diverse
forme di valorizzazione dei saperi e delle pratiche “tradizionali” e contribuito alla definizione di nuovi modelli di
sviluppo locale sostenibile.
In Italia, le iniziative sulla biodiversità si sono moltiplicate
in questi ultimi anni, anche in relazione a progetti di ampio respiro come Natura 2000. Si vanno consolidando, in
diverse regioni italiane, interessanti sperimentazioni che
riguardano gli ecomusei e le aree protette, quali strumenti a disposizione delle comunità locali per affrontare
in modo efficace i problemi connessi con la conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, attraverso un approccio trasversale, che consideri l’interdipendenza delle diverse attività nello spazio23.
In questo percorso politico e culturale, in cui il territorio
è concepito come sistema di valori e di relazioni, le realtà
locali si fanno interpreti attive delle problematiche legate
alla gestione delle risorse, rivendicando una partecipazione diretta alle politiche territoriali. Alcune reti ecomuseali hanno sperimentato l’adozione delle “mappe di comunità” (Parish Maps), come strumenti importanti per
far emergere le vocazioni dei luoghi e delle comunità
che in essi agiscono. In relazione ad alcune esperienze
dell’associazione inglese Common Ground24, Sue
Clifford scrive:
“Un frutteto rappresenta bene la complessità culturale.
La perdita di un frutteto non costituisce semplicemente
un danno per il paesaggio o per l’economia locale. È la
XXXIV
XXXV
perdita di molte delle cose attraverso le quali la cultura è
riuscita ad arricchirci. Un vecchio frutteto è un bosco, da
un punto di vista formale, e ospita una rete molto complessa di vita e di elementi naturali così come una grande
ricchezza culturale. Significa diverse varietà di frutta caratteristiche del luogo, ciascuna con la sua storia:
usanze, canzoni, brindisi, ricette, sidri di mele, di pere o
“brandy” di ciliegie appartenenti a quel luogo soltanto.
Le feste e il lavoro, faticoso ma collettivo, rafforzano
oggi la saggezza di generazioni che hanno speso anni a
potare e innestare, occupandosi e imparando a distinguere pendenze, suoli e stagioni, metodi di conservazione e di utilizzo-analogamente a quanto avviene
nell’Europa continentale con gli uliveti, i sughereti, i vigneti e i frutteti.
Il lavoro che Common Ground continua a svolgere per
promuovere l’importanza dei frutteti, sta aiutando le
persone a radicare la biodiversità nella cultura e nei luoghi, rivelandosi come una delle molte possibili strade
verso la sostenibilità.
Se vogliamo far crescere i processi sostenibili, gli abitanti
devono essere appoggiati e incentivati nel coinvolgimento descrittivo e dimostrativo del luogo cui appartengono possono portare conoscenze e devono essere incoraggiati a farlo. Orgoglio, motivazione e senso di comunità hanno molto a che fare con l’identità e la continuità della storia” (Clifford 2006).
In questo processo/progetto ampio di condivisione, partecipazione, radicamento ai luoghi e nelle strategie di
conservazione/valorizzazione della biodiversità, che
ruolo possono avere i musei etnografici?
La ridefinizione, in questi ultimi anni, della missione dei
musei etnografici, che vede un progressivo spostamento
della centralità delle attività di raccolta, studio, tutela dei
beni materiali verso un’interpretazione sociale della realtà e un rafforzamento dei legami con il territorio, va di
pari passo con l’affermazione del concetto di patrimonio. Rispetto ai “beni” DEA, questo significa un intreccio
dinamico tra il concetto ecologico di paesaggio (in cui
natura e cultura dialogano costantemente) e il concetto
antropologico di cultura25.
In tale prospettiva lo sguardo, attraverso i musei e la
loro capacità di rappresentazione, del rapporto uomonatura diventa centrale, così come l’esercizio della ricerca etnografica in quanto pratica capace di cogliere
le interazioni sociali negli ambiti territoriali circoscritti
dei musei etnografici. I quali musei, quando funzionano, riescono ad attivare una rete di relazioni forti e
continuative con il territorio in cui si inseriscono e con
le comunità che lo abitano, e dunque con una varietà
di attori sociali, che il museo può contribuire a mettere
in contatto reciproco.
Nel settore specifico della biodiversità, intesa in senso
ampio, il museo può creare un circuito virtuoso tra i saperi degli antropologi e il saper fare dei custodi della diversità genetica, le conoscenze tecniche e filosofiche degli agricoltori biologici, le competenze professionali degli agronomi, le progettualità istituzionali degli enti pubblici e quelle delle associazioni locali o internazionali
come Slow Food. Il museo etnografico è infatti uno spazio di mediazione, non neutrale, come d’altronde non è
neutrale qualsiasi pratica conoscitiva e di restituzione/
rappresentazione.
Cristina Papa individua nei musei del territorio e nei musei etnografici il luoghi in cui: “Potrebbe essere ben rappresentata e resa accessibile la straordinaria ricchezza
dei saperi e delle tecniche locali con cui l’uomo organizza, manipola, orienta il proprio mondo naturale anche a partire dalla propria natura interna che ne rappresenta il vincolo primario. Il Museo del territorio- scrive la
studiosa- in questa prospettiva si costituisce come il contesto privilegiato in cui l’antropologia può interagire dialetticamente e utilmente con alcune diffuse posizioni
ambientaliste del nostro paese” (Papa 2000: 5). La prospettiva di un museo in grado di rappresentare uno
sguardo diverso sul rapporto uomo-natura, proponendosi come luogo di mediazione tra il sapere scientifico e
quello locale (generalmente ignorato dagli ambientalisti), indica una delle strade possibili da percorrere.
Gli strumenti, le pratiche e i saperi locali legati alle attività
primarie (agricoltura, allevamento, silvicoltura, pesca), che
hanno consentito alle comunità di operare selezioni sul
mondo vegetale ed animale creando nuova biodiversità,
sono spesso al centro delle rappresentazioni nei musei etnografici italiani. Tuttavia, in queste realtà museali, spesso
nate ad opera di collezionisti “spontanei” o di ricercatori
locali, la presenza degli antropologi risulta alquanto rarefatta. Lo studio e l’interpretazione delle strategie di adattamento all’ambiente locale, nonché l’ideazione di percorsi espositivi adeguati e di forme di mediazione culturale territoriale rimangono dei desiderata.
Interessante è il progetto a cui ha collaborato il Museo
Etnografico-Preistorico Pigorini di Roma: “(Agri)culture(s). Quand l’agriculture démasque la culture” del
Museo Etnografico-Preistorico Pigorini di Roma, riferito a
contesti extra-europei, attraverso il quale si è cercato di
ricomporre “il legame spesso perduto tra produttore e
prodotto, tra prodotto agricolo e insieme di conoscenze
tradizionali e innovazioni locali, rafforzando l’autostima
e il capitale sociale delle comunità rurali povere, promuovendo le culture a partire dalle colture”26. Più limitata e riferita a un contesto locale è stata la collaborazione del Museo etnografico della provincia di Belluno e
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ad alcune iniziative sulla biodiversità all’interno del territorio del Parco,
in particolare al progetto “Antropizzazione di un territorio: la biodiversità coltivata”27. Il progetto è stato ideato
dal Museo (nel 1999) e promosso dal Parco grazie a finanziamenti comunitari, in collaborazione con il locale
Istituto di Stato per l’Agricoltura. L’équipe di ricerca,
composta da numerosi agronomi, un botanico, una disegnatrice naturalistica e due antropologhe, ha intrapreso un’indagine sul campo volta a censire le varietà locali di mele e di pere e a documentare i saperi dei contadini “custodi” della biodiversità, in quello specifico
contesto pre-alpino. Saperi “in movimento” frutto di
scambi e di negoziazioni in un territorio fortemente interessato dall’emigrazione.
Alla stesura di schede agronomiche delle varietà individuate, che sono state fotografate e disegnate, è seguito
il prelievo di marze finalizzato alla creazione di un
campo-catalogo presso l’Istituto di Stato per l’Agricol-
XXXVI
tura e in un altro sito in quota all’interno del Parco. Le
informazioni raccolte dalle antropologhe (Nadia Breda e
Barbara De Luca) sono state incrociate con quelle reperite dagli agronomi e inserite in una banca dati, mentre
gli esiti della ricerca sono stati pubblicati in un volume
(AAVV 2005). Il Museo ha dedicato successivamente una
sezione espositiva permanente alla biodiversità coltivata,
partendo dai materiali (informazioni, immagini, disegni,
oggetti, testimonianze orali) raccolti nella ricerca. Nel
corso del tempo vi è stata una significativa ricaduta sul
territorio, con la valorizzazione e il nuovo impianto di alcune delle varietà individuate da parte dei contadini “custodi” della biodiversità e da altri agricoltori locali, nonché la vendita di mele e pere “biodiverse” in occasione
di fiere agricole o di feste dedicate.
Il Museo etnografico ha dunque favorito, in collaborazione con altre istituzioni, la conservazione e la valorizzazione di alcune risorse genetiche agrarie “in situ” e del
patrimonio di saperi ad esse legato, avviando il ripristino,
seppur parziale, di un paesaggio culturale e colturale
che, fino all’immediato dopoguerra, assegnava agli alberi da frutto uno spazio significativo. Il Museo continua, attraverso gli strumenti che gli sono propri (l’allestimento, la didattica museale, i seminari, le conferenze) a
essere un luogo di incontro e di riflessione sui temi della
biodiversità. (a cura di Daniela Perco)
Riferimenti bibliografici
AAVV (2005) Biodiversità coltivata nel Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi. Indagini agronomiche ed etnobotaniche sulle varietà dell’agricoltura tradizionale,
Feltre.
Breda, N., a cura (2005), Antropologia dell’acqua, in «La
Ricerca Folklorica», n. 51.
Bressan, M. - Magliaretta, L. - Pino, S. (2003), Cereali del
Veneto. Le varietà di frumento tenero e mais della
tradizione veneta, Venezia
Clifford, S. (2006) Il valore dei luoghi, in S. Clifford, M.
Maggi, D. Murtas, Genius loci. Perché quando e
come realizzare una mappa di comunità, Torino,
Strumentires 10.
Daccò, G. (2001), Le mappe smisurate degli ecomusei, in
«Nuova Museologia», n. 4.
Di Vito, A. (2007) Patrimoni contesi. Fra antropologia teorica e antropologia applicata, in «Etnoantropologie»,
1, pp-111-118
Fabre, D. (2000) “L’ethnologie devant le monument historique”, in Domestiquer l’histoire. Etnologie des
monuments historique, Parigi.
Gozzer, M.M. (2004) Voci dal territorio. Guida agli ecomusei del Trentino, Firenze-Trento.
Grasseni, C., a cura (2010), Eco-museologie. Pratiche e
interpretazioni del patrimonio locale, Rimini.
Lattanzi, V. (1999) “Per un’antropologia del museo contemporaneo”, in Antropologia museale, a cura di M.
Turci, «La Ricerca Folklorica», n. 39, pp. 29-40.
Palumbo, B. (2003) L’Unesco e il campanile. Antropologia,
politica e beni culturali in Sicilia orientale, Roma
Palumbo, B. (2009) Patrimonializzare, in «Antropologia
museale», 8, n. 22.
Papa, C. (2000), Presentazione, in C. Papa, a cura,
Antropologia dell’ambiente, in «La Ricerca
Folklorica», n. 41, p. 5.
Piermattei, S. (2007) Antropologia ambientale e paesaggio agrario; Perugia.
Maggi, M. (2001), Il valore del territorio: primo rapporto
sugli ecomusei in Piemonte, Torino
Maggi, M. - Falletti, V. (2001), Gli ecomusei: che cosa
sono, che cosa possono diventare, Torino
Micou, G. (2003) Sciences sociales et biodiversité: des
problématiques nouvelles pour un context nouveau,
in «Natures Sciences Sociétés», n. 11, pp. 421-431
Tubiana, L. (2005) “Les savoirs naturalistes locaux, une
question globale”, in Biodiversité et savoirs naturalistes locaux en France, Nancy.
Warren, D. M. (2004) The Role of Indigenous Knowldege
Systems in Facilitating Sustainable Approach to
Development, in G. Ortalli e G. Sanga, a cura, Saperi
naturalistici. Nature Knowledge, Atti del convegno
internazionale di studio, Venezia-New York-Oxford
UN CONTRIBUTO DI MARIA GABRIELLA DA RE
Il lato oscuro della biodiversità: la black list. È stato questo utente italiano di facebook che mi ha invogliato ad
occuparmi di biodiversità per il Congresso nazionale
2010 di SIMBDEA:
“... gli “alieni”- cita l’utente- possono sottrarre spazio
alle specie autoctone, spingendole verso l’estinzione, e
modificare gli equilibri ambientali. Questo accade
quando trovano un ambiente favorevole e senza nemici
naturali: nel qual caso tendono a moltiplicarsi con un
ritmo che fa impallidire i conigli e a diventare invasivi. In
sostanza spazzano via il resto e riducono la biodiversità”,
“Razzisti ?– dice l’utente facebook, facendo dell’ironia –
No, ambientalisti”.
Egli infatti cita un brano dal sito ambientalista
ERMESAMBIENTE, segnalando con una battuta fulminante una inquietante risonanza tra linguaggio usato da
ecologisti e biologi nel definire le cosiddette specie
aliene invasive (in riferimento a piante e animali) e il linguaggio xenofobo antiimmigrati negli USA e in Europa.
Il mio intervento non vuole sminuire i problemi reali né
l’importanza della biodiversità così come li ha illustrati
Daniela Perco. Tuttavia già da tempo biologi, naturalisti
ed epistemologi stanno segnalando l’abbandono, da
parte degli stessi scienziati e dei documenti ufficiali degli
stati, di un linguaggio neutro e l’assunzione di un linguaggio ‘invasionista’ e di metafore belliche quando si
parla delle specie aliene invasive, di cui alcuni centri di ricerca hanno provveduto a fare un elenco (“100 of the
World’s Worst Invasive Alien Species”), la “Black List”, di
contro alla “Red List” delle specie minacciate.
Da un documento ufficiale del Ministero dell’Ambiente
italiano prendiamo la definizione delle ormai note con
l’acronimo AIS: “Sono definite invasive, quelle specie alloctone la cui introduzione o diffusione minaccia la biodiversità, o può causare danni alla salute umana o avere
serie conseguenze socio-economiche”. L’analisi dei rischi viene affrontata in un capitolo intitolato “Minacce”.
Per rilevare ed “eradicare” tali specie “indesidate” si
propone l’istituzione di un sottosegretariato nazionale.
Molto interessante anche il glossario nel quale è ben evi-
XXXVII
dente il carattere storico-politico della definizioni delle
varie tipologie di specie (alloctone, alloctone invasive,
autoctone, para-autoctone).
Il biologo americano M.A.Davis in un saggio del 2006 ricostruisce la genesi di tale linguaggio invasionista, oltre
che enfatico e iperbolico, facendolo risalire al 1958 al
classico libro di Charles Elton (L’ecologia delle invasioni
di animali e piante), il quale negli anni sessanta trova pochi seguaci, mentre la sua affermazione (“drammatica”,
dice Davis) avviene durante gli anni 80.
Davis auspica il ritorno a una terminologia più neutra,
come quella usata nel 1964 in un famoso simposio di
Scienze biologiche (Asilomar, California), durante il quale
si usarono parole neutre, come “Introduced Species”,
“Colonisers”, “New Species”, “New resident”, “geografical spread”.
Elton ha introdotto parole come “exotics”, “aliens”, “invasions” “harmful new species”. Tali parole tuttavia
hanno avuto successo scientifico e mediatico solo dopo
vent’anni. Perché?
Una risposta articolata viene data nel 2001 dalla biologa,
epistemologa,
femminista
americana,
Banu
Subramamiam, la quale rileva una serie di parallelismi
“stringenti” tra la retorica relativa alle piante e gli animali ‘stranieri’ e quella relativa ai popoli stranieri. Anzi
afferma, in certo senso rovesciando la narrazione tutta
interna alle scienze di M.A. Davis, che “la retorica xenofoba relativa agli immigrati si è estesa a piante e animali”
(p. 135). Dunque il linguaggio usato nella invasion biology deriva da quello usato nei discorsi xenofobi enti-immigrato negli USA e in Europa. Le specie native sono viste come vittime povere e indifese, incapaci di competere di fronte all’aggressività delle specie aliene. Seguono
poi lamentazioni nostalgiche verso le foreste native distrutte, la scomparsa della natura pura, incontaminata,
intatta, libera da invasioni straniere.
Non è la prima volta che questo accade. Il panico per
l’invasione dei germi si diffuse negli USA agli inizi del XX
secolo in concomitanza con le grandi immigrazioni
dall’Europa di gruppi difficilmente assimilabili.
Analogamente alla fine del XX secolo si è sviluppato un
linguaggio iperbolico sulle specie aliene in risposta alle
nuove immigrazioni da Asia, Africa, America latina.
Immigrati e stranieri, prodotti del “globale” sono percepiti come la causa del problemi del “locale”.
Uno dei problemi più interessanti da notare in questo dibattito è la definizione e la individuazione delle specie
native. Ad esempio, nel documento del nostro Ministero
dell’Ambiente più che di biologia si parla con un linguaggio e una retorica storico-politica che fanno riferimento agli stati nazionali e ai loro confini, alla complessità della storia e alle strategie belliche che si devono
mettere in campo per respingere i nemici al di là dei confini statuali italiani.
Altri esempi (Isole Palau, Hawaii) mostrano in modo ancora più evidente che la bio-logica invasionista ha a che
vedere non tanto con pericoli reali, ma con la paura di
danni economici derivanti dal mutamento dello stile di
vita locale, sulla specificità e unicità del quale si fonda il
successo nel mercato turistico globale. Dunque tutte le
specie aliene diventano pericolose perché mutano l’iden-
tità degli ecosistemi locali, la native biodiversity, pensata
come statica e astorica.
L’alternativa alle metafore militariste è la promozione di
finalità conservative realistiche in un contesto multiculturale. Lo dice Brendon M.H. Larson. Antropologo? No,
ambientalista.
Riferimenti bibliografici
Davis, M.A. (2006) “Invasion biology 1958-2005: the
pursuit of science and conservation”, in M.W.
Cadotte et Alii, a cura, Conceptual ecology and invasion biology, London, Springer.
Helmreich, S. (2005) How scientists think; about ‘natives’, for exemple. A problem of taxonomy among
biologists of alien species in Hawaii, in «Journal
Royal Anthropological Institute (N.S.)», n. 11.
Larson, B.M.H. (2005), “The war of the roses: demilitarizing invasion biology”, in Frontiers in Ecology and
the Environment, 3 (9).
Ministero dell’Ambiente, Italia, “L’impatto delle specie
aliene sugli ecosistemi: proposte di gestione”, www.
minambiente.it
Subramamiam, B. (2009) “The Aliens Have Landed!
Reflections on the Retoric of Biological Invasions”,
M. Wyer et Al., a cura, Women, Science and
Technology, New York and London, Routledge (I ed.
2001).
Note
1 - Sul tema delle Liste e della loro importanza definitoria cfr:
Goody, J. (1990) “La Lista”, in L’addomesticamento del
pensiero selvaggio, Franco Angeli, 89-116.
2 - In questa linea si colloca la Convenzione Europea di Faro
che ratifica l’identificazione di comunità patrimoniali, cfr. Faro
Convention, 2005.
3 - Hugues de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio
culturale al servizio dello sviluppo locale, CLUEB, Bologna
2005, pp.31-49.
4 - Council of Europe Framework Convention on the Value of
Cultural Heritage for Society, Faro, 27 ottobre 2005.
5 - Il tema è stato affrontato ampiamente, per quanto
riguarda l’Europa in numerosi articoli apparsi nella “Revue
européenne des migrations internationales”. Si segnala il
volume 8, n.1 del 1992 dedicato al tema Entrepreneurs entre
deux mondes, dove numerosi sono gli articoli sul fenomeno in
ambito europeo. Tra gli altri si segnalano: Boissevain - Hodeir
1992 e Jones – Hodeir et al. 1992. Per quanto riguarda la
Francia si vedano Bruno - Zalc 2006; Flot-Fresnoza - Pécoud
2007; Peraldi 2002 e 2005.
6 - Di particolare efficacia a questo proposito è l’esempio
portato da Gallino (2010) in riferimento a un prodotto
relativamente semplice come potrebbe essere un piccolo
elettrodomestico di cucina
“Le 50-60 parti di cui è composto sono fabbricate in una
dozzina di siti posti in dieci paesi diversi e controllati da
multinazionali che hanno sede altrove. In ciascun sito gli
addetti appartengono a molte nazionalità diverse.
L’assemblaggio finale dell’apparecchio può avvenire in uno
stabilimento sito in Umbria o in Puglia, per mano di lavoratori
italiani, nigeriani, moldavi, magrebini: Essi fanno capo, pur
lavorando insieme, a cinque o sei aziende differenti;inoltre tra
XXXVIII
di essi si contano una dozzina di tipi di contratti di lavoro
diversi. La loro produttività dipende da componenti fabbricati
a Taiwan o nel Kerala e dalla puntualità di viaggio di innumeri
aerei, navi container, tir e furgoncini, sui quali quei
componenti hanno viaggiato per 30000 chilometri. In
presenza di un simile modo di produrre, per il sindacato
“rappresentare gli interessi” dei lavoratori non è diventata
soltanto una fatica erculea: non si capisce nemmeno che cosa
voglia dire. Che è precisamente il risultato che gli architetti
della globalizzazione volevano ottenere”(p. 40)
7 - Stephen Goldsmith, già sindaco di Indianapolis, ora
vicesindaco di New York è uno studioso di scienze politiche e
amministrazione pubblica che dirige un dipartimento
dell’Università di Harvard. La sfida che cerca di vincere nella
sua pratica politica e rispetto alla quale ha raggiunto dei
risultati è quella di gestire in modo innovativo i servizi sociali
mobilitando le risorse private, del volontariato e sollecitando
una “mobilitazione civica” che vigili sulla qualità dei servizi.
8 - Si vedano Clifford - Marcus 1997 e Clifford 2000.
9 - Si tratta di una serie di opere esposta nel 2001 nella
mostra Mirror’s edge, curata da Okwui Enwezor al Castello di
Rivoli, sede del Museo d’arte contemporanea di Torino, che
colpisce al cuore proprio uno dei meccanismi con cui
l’antropologia culturale ‘costruisce’ i suoi oggetti di studio.
Ethnographia è un sito interattivo e un CD-rom.
10 - Le opere in discussione sono visibili nel catalogo della
mostra curata da Enwezor (1999) alle pagine 108-109.
11 - Il saggio, pubblicato anche in Harari 1979, è citato come
pietra miliare nel mondo dell’arte in Heinec - Edelman 2002 e
in Tota 1999: 23.
12 - Ne parla Tota, 1999: 22-23.
13 - Nel Salento dal 13 al 28 agosto si svolge nel Salento un
festival musicale, dal 1998 consacrato al recupero e alla
valorizzazione della pizzica. Il 28 agosto 2010 il festival si è
chiuso con un concerto diretto da Ludovico Einaudi, con la
partecipazione anche di Dulces Pontes, Savina Yannatou,
Mercan Dede e i Sud Sound System (www.lanottedellataranta.
it), a Melpignano, in provincia di Lecce.
14 - www.atomicantelope.it
15 - Installazione presentata originariamente al Grand Palais di
Parigi per l’edizione di Monumenta 2010.
16 - Il capitolo 8 della Convenzione è dedicato alla
“Conservazione “in situ” della biodiversità”. Questo
protocollo d’intesa, adottato a Nairobi in Kenya, il 22 maggio
1992, è stato aperto alla firma dei Paesi durante l’Earth
Summit di Rio de Janeiro nel giugno 1992. L’Italia ha ratificato
la Convenzione nel 1994, con la legge 124. I principi della
Convenzione sono stati ripresi e definiti nella Conferenza
dell’Aia nell’aprile del 2002.
17 - Per rendere meno vincolante tale asserzione per gli Stati
membri aderenti alla Convenzione, è stata introdotta, come si
arguisce dal testo, la precisazione che l’applicazione delle
disposizioni del comma j dell’art. 8 della Convenzione deve
sottostare alle leggi nazionali di ciascun Stato.
18 - Si vedano anche, nello stesso volume, l’Introduction
générale di S. Louafi e B. Roussel e l’articolo di J. Weber, Pour
un accès aux avantages du partage, pp. 9-10. Sullo stesso
tema si rimanda a Warren 2004.
19 - Adottato dalla conferenza FAO nel 1983, il Trattato è
stato ratificato dal Parlamento Italiano nell’aprile 2004
“Gazzetta ufficiale” n. 95 (2004).
20 - Cfr. ad esempio: Micou 2003, Papa 2000:5.
21 - Si veda ad esempio: Breda 2005.
22 - Cfr. Fabre 2000. Antonietta Di Vito afferma a tal
proposito: “benché l’antropologia che si è occupata di
patrimoni si sia spesso configurata di fatto come una
antropologia applicata, per esempio per le decisioni che è
chiamata a prendere a stretto contatto di gomito con gli
amministratori locali, raramente le riflessioni elaborate
dall’antropologia applicata sono state citate o anche
implicitamente utilizzate” (2007: 111-118).
23 - La letteratura sul tema è molto vasta. Per l’Italia
segnaliamo almeno: Maggi - Falletti 2001; Daccò 2001; Maggi
2001; Gozzer 2004.
24 - “Common Ground” è un’associazione nata in Gran
Bretagna, tra il 1982 e il 1983, per volontà di Roger Deakin,
Angela King e Sue Clifford con lo scopo di diffondere il
concetto di Local Distinctiveness, secondo il quale ogni luogo
ha caratteristiche che lo rendono unico e irripetibile.
L’individuazione delle peculiarità territoriali aiuta le comunità
locali a condividere la propria conoscenza e il proprio bagaglio
culturale e ad agire concretamente sui luoghi. Cfr. www.
commonground.org.uk/ e Grasseni 2010.
25 - Si veda Lattanzi 1999. Per una lettura critica dei processi
di patrimonializzazione si rimanda a Palumbo 2003 e 2009 e
ai saggi di P. Clemente, B. Palumbo, D. Poulot nel numero
dedicato al patrimonio culturale della rivista “Antropologia”,
6, n. 7 (2006).
26 - Il progetto si realizza nell’ambito dell’Anno Internazionale
della Biodiversità 2010, in collaborazione con il MUM - Musée
International du Carnaval et du Masque di Binche (Belgio). È
finanziato da ACRA (Associazione di Cooperazione Rurale in
Africa e America Latina) con fondi IFAD (Fonds International
pour le Développement Agricole des Nations Unies Programma “Agro biodiversity, cultures and local
development”) ed è parte del programma «Leveraging the
intangible patrimony content of agriculture for improving
livelihoods of small farmers and migrants».
27 - Cfr. AA.VV 2006. La ricerca ha preso in considerazione
anche una varietà di fagioli e di fava e un paio di piante
spontanee utilizzate nell’alimentazione. Il Museo etnografico
della provincia di Belluno ha inoltre collaborato a un progetto
di recupero di varietà locali di mais per la conservazione ex
situ delle sementi (Istituto di genetica di Lonigo), una delle
quali, il mais “sponcio”, è stata valorizzata come prodotto
peculiare del territorio (cfr. Bressan – Magliaretta – Pino
2003). Un altro settore di ricerca è stato quello delle rose
antiche, con l’individuazione e l’impianto nel giardino del
museo di circa 150 varietà di rose reperite nel territorio
provinciale, attualmente affidate alle cure degli studenti e dei
docenti dell’Istituto di Stato per l’Agricoltura di Feltre.
28 - Nell’ambito del progetto pluriennale “Montagne di cibo.
La cucina veneta tra storia e memoria” è stata riservata una
particolare attenzione ad alcune tematiche legate alla
biodiversità. Il Museo ha avviato ad esempio una significativa
collaborazione con i pastori transumanti e con le istituzioni
preposte alla valorizzazione delle razze ovine autoctone,
nonché con gli apicoltori locali che, all’interno delle strategie
di promozione del Miele delle Dolomiti (marchio DOP), hanno
proposto e realizzato l’installazione nelle adiacenze del Museo
di un apiario scuola.
XXXIX
galleria
oggi, nel corso della vita:
riti di passaggio
Mostra collettiva di installazioni etnografiche
Sala delle Arcate - Palazzo Lanfranchi
Chiesa di Santa Maria degli Armenis
Matera 29 settembre - 2 ottobre 2010
Sismografo dei sommovimenti culturali in atto. Rivelatore all’interno della comunità degli antropologi di attitudini
non convenzionali alla conoscenza e alla comunicazione. Esercizio di interpretazione etnografica e di trasposizione
visuale perspicua, oltre le logiche della scrittura testuale. Addestramento al saper fare espositivo, alle concrezioni dei
linguaggi contemporanei, alle frizioni tra le estetiche egemoni e quelle suggerite – per noi antropologi, imposte –
dalle tematiche e dai mondi locali. Sperimentazione volta a praticare intime, pertinenti, connessioni tra conoscere e
allestire, documentare e rappresentare, descrivere ed evocare.
Tutto questo e tanto altro è stata la collettiva di installazioni etnografiche che, nei giorni del congresso di Matera, ha
inteso onorare il centenario della pubblicazione del classico e ancora seminale libro di Van Gennep Riti di passaggio
(1909). L’obiettivo ambizioso era di mettere a problema il luogo comune che colloca i riti di passaggio e di iniziazione in mondi primitivi e tradizionali, mostrando l’attuale effervescenza di pratiche rituali, giovanili e non, nella nostra società postindustriale e offrendo loro suggestive expografie, ovvero densi frammenti di forme contemporanee
di vita in grado di comunicare sguardi inediti, ad un tempo intimi ed de familiarizzanti.
Ci sembra che la prova sia stata largamente superata, soprattutto se si considera l’assoluta novità della proposta.
Diciamolo pure, è andata molto bene. Grazie soprattutto ad un impegno, nella direzione della ricerca e della creatività culturale, che tanti colleghi, in buona parte giovani, hanno voluto regalare all’iniziativa e condividere tra di loro,
con noi e con i visitatori.
AM pubblica in Galleria le immagini e i testi degli autori delle installazioni. Chiaramente sono assenti, in quanto largamente irriproducibili, performances, video e dispositivi multimediali che in alcuni casi caratterizzavano gli artefatti
esposti. E purtroppo potrà essere solo evocata la vivace socialità che gli etnoallestitori, spesso venuti con amici o famiglie al seguito, hanno impresso alla mostra, dagli inizi sino alla chiusura, contagiando con il loro umore anche visitatori e i soci di SimbdeaLab, generose presenze verso i quali tutti abbiamo desiderato esprimere un sentito ringraziamento (in particolare all’indomita figura del nostro angelo custode Ciriaca Coretti).
Nel complesso va segnalata la capacità che la mostra ha palesato di dialogare con i luoghi offerti dalla Soprintendenza
e dalla Città di Matera sapendone interpretare individualità, confini e potenzialità. La felicità comunicata è stata tale
che ci ha spinti ad immaginare, con tanta presunzione, che le nostre installazioni fossero proprio ciò che quei luoghi
da tempo attendevano. Un’inedita significazione, un’esplosiva diversità di temi, colori, linguaggi. E soprattutto: ironia, defamiliarizzazione, denuncia, curiosità, storie di vita, ricordi condivisi... tutte risorse del nostro fare etnografico
finalmente dislocate a puntino per rinnovare l’esperienza dei visitatori.
a cura di Pietro Clemente e Vincenzo Padiglione
XL
Ars Videndi
Collettivo di ricerca dell’Università di Siena: Francesco
Bogani, Maria Novella Carniani, Paola Paluzzi, Riccardo
Putti, Silvia Serrotti; inoltre contributi video di Jacopo
Braghini, Sara Camilli, Cecilia Luzi, Letizia Nardi.
In limine
Parkour, flamenco, videoclip, manga, youtube, pratiche
di blues,cataphiles,camionisti, artisti . Elementi frammentari e scomposti di una pluralità:
Alabama, Prato, autobhan, Siviglia, Roma, Frejus,
Mugello, Parigi. Un insieme di etnografie visive focalizzate sul corpo come fonte ed espressione di
performances culturali, fenomenologie liminoidi, processi di destrutturazione e ristrutturazione di ruoli, identità e relazioni.
Pratiche e immaginari della contemporaneità intessuti in
un montaggio per condensazione di ritmi, di frammenti,
di sequenze ripetute si dispongono in una trama reticolare di flussi visuali. Immagini e sonorità proiettate in
flusso ciclico che instaura una ripetizione in cui le differenze producono differenze nel senso e nello sguardo.
L’installazione è costituita da una proiezione video, sabbie colorate, elementi plastici, ambiente sonoro spazializzato
w
Alessandra Broccolini
Sapienza Università di Roma
Tra Italia e Pakistan: viaggiare, sposarsi, divorziare
Abbigliamenti di passaggio
L’istallazione vuole ricostruire alcuni passaggi personali
di vita e di viaggio entro la cultura pakistana contrassegnati dalla scoperta di forme di abbigliamento non occidentale. Un primo viaggio in Pakistan, un matrimonio,
un figlio, un secondo viaggio, un divorzio, dieci anni di
vita. Nel mezzo l’adozione per scelta o per gioco, per
forza o per amore, di forme di abbigliamento diverse,
dallo salwar kameez, colorato abito tradizionale pakistano, al burqa, distante forma di mascheramento totale. Vissuto ora come gioco-mascheramento, ora come
vincolo-costrizione, la scelta o la necessità di indossare
un abito pakistano ha accompagnato scelte di vita difficili intorno alle quali il confronto con un’alterità culturale
è diventata parte del vissuto personale e di pratiche quotidiane di negoziazione di senso della diversità.
L’istallazione ruota intorno ad un oggetto-contenitore,
la valigia, simbolo per eccellenza del viaggio, ma anche
della pratica domestica del riporre, del conservare ciò
che nelle estetiche e nelle pratiche quotidiane non sappiamo più dove collocare.
Valigie, abiti tradizionali pakistani (salwar kameez,
burqa), abiti occidentali, pagine di diari di viaggio, fotografie, oggetti di vita quotidiana
XLI
Elisa Bellato - Università di Verona
Antonella De Nisco - artista, Reggio Emilia,
Anna Paini - Università di Verona
SaliScendi Gira.
Riti di passaggio: l’esame di maturità
Per fare qualcosa di interdisciplinare non basta
scegliere un ‘soggetto’ e raccogliervi attorno due
o tre scienze. L’interdisciplinarietà consiste nel creare un nuovo oggetto che non appartiene a nessuno. (Roland Barthes 1994)
La proposta espressiva nasce dall’incontro e dalla contaminazione tra linguaggi e sensibilità dell’arte e dell’antropologia tramite una sperimentazione che non è più
solo installazione artistica né narrazione etnografica.
Le prove di maturità che concludono il quinquennio
delle superiori costituiscono molto di più di una semplice
verifica di fine percorso scolastico. Sono una delle pratiche giovanili di passaggio dalla dimensione di classe collettiva all’entrata nel mondo come esperienza individuale. Una soglia che scandisce questa fase della vita
giovanile, sottolineando un cambiamento di soggettività/identità in bilico fra fragilità e risorse interiori.
Intuiamo solo in parte i riti personali delle e dei protagonisti, che spesso rimangono intimi e segreti, e che assumono modalità diverse tra ragazzi e ragazze. Tramite
una serie di frammenti-fonti (diari, foto, messaggi) vorremmo suggerire alcuni elementi che contribuiscono a
rendere l’esame di maturità una prova rituale.
Una carta geografica, elemento sempre presente nelle
nostre aule scolastiche – fotografata e stampata su rete
trasparente –, sospesa come soglia/finestra sul mondo.
Due banchi con tracce di prove di maturità del 2010
(terze prove, tesine, schede di valutazione). SaliScendi
Gira: lasciarsi trasportare da sguardi-immagini-paroleoggetti-sensazioni, creare effetti di flash-back, percepire
connessioni.
Materiali: Stampa digitale su rete, banchi scolastici, foto,
diari, materiali cartacei, amuleti
Visitatori e visitatrici siete invitati a lasciare un commento
scritto su di un post-it prima di posizionarlo sulla cartina;
i contributi andranno a formare il diario della mostra.
w
Giuditta Barduzzi, Francesca Bazzanti,
Federica Caponnetto
Università degli Studi di Firenze
“Il fuori dentro e il dentro fuori. Riti di passaggio
nella storia di una sposina in manicomio”
Questo allestimento mette in scena la narrazione di uno
psichiatra che rievoca frammenti del passato all’interno
del manicomio fiorentino di San Salvi, luogo in cui si è
svolta la nostra ricerca sul campo. L’istituzione manicomiale si presenta come uno scenario denso di significati
e simbologie legate all’uso e alla percezione dello spazio,
che incidono fortemente sui riti di passaggio rintracciabili nelle storie dei pazienti. Come la storia di una giovane sposa, internata a San Salvi per una grave depressione negli anni ‘70, momento in cui si avvia un nuovo
approccio alla malattia mentale. La “sposina” guarirà
grazie alla disponibilità del marito nell’acconsentire alle
“pazze” richieste dello psichiatra. Il medico, ideando
un’inconsueta terapia, consegnerà alla coppia la chiave
della cella annullando il significato della reclusione e
chiudendo fuori il manicomio.
Filmato audio-video con immagini del San Salvi, racconto della “storia della sposina” tratta dalla nostra intervista allo psichiatra, chiavi.
Vestito da sposa su camicia di forza.
Camicia femminile e giacca maschile.
Velo da sposa su cui sono fissate le pagine della trascrizione dell’intervista allo psichiatra.
XLII
Giulia Bevilacqua
EtnoMuseo Monti Lepini & Associazione Culturale Progetto Lepini
Arco degli Sposi
Assecondare la tendenza al cambiamento
In molti paesi dell’area Lepina, in particolare nel paese di
Roccagorga(LT), tutt’oggi viene praticato un rituale legato al matrimonio. Il rituale è quello dell’attraversamento, da parte dei futuri sposi, di un arco floreale, realizzato con piante di mirto (arbusto sempreverde tipico
della vegetazione mediterranea), localmente chiamato
mortella, e fiori, l’ “Arco di Mortella”. Questo rituale, seguendo la divisione che Van Gennep fa dei riti di passaggio, può essere definito un rito di separazione. Nel corso
degli anni l’insieme codificato di gesti compiuti nel rituale, in questo caso l’attraversamento di un arco, resta
immutato nel tempo quello che cambia sono lo status di
chi costruisce l’arco (da autocostruzione fatta da parenti
e amici a dipendenza dal mercato attraverso il commissionare gli addobbi nuziali alla fioraia) e i materiali che
costituiscono l’arco (mirto e fiori ma anche felci, foglie di
palme, orchidee, rose, carta colorata, organza, nastri.).
In questo modo il vecchio oggetto rituale viene vestito a
nuovo, cioè viene rielaborato in un cultura estetica contemporanea. Come sarà l’arco tra 30 anni, e tra 40 anni?
Quali saranno i materiali usati per costruirlo? Questa installazione è rivolta all’immaginario, proiettando nel futuro l’oggetto rituale.
Fili elettrici, fili telefonici, tubi rigidi ad incastro, tubo
flessibile, cemento, filo di ferro, elastici colorati, cornici
digitali, prolunga, carta rigida
w
Ciriaca Coretti, Mariana Malvaso,
Stefania Martinese, Amalia Trivisani
(SimbdeaLab - Società Cooperativa di Servizi per la
Museografia e i Beni Demoetnoantropologici) per conto
di: MEAM - Museo Etnografico dell’Alta Murgia di
Altamura (BA)
Il Sogno della Sposa.
Il carattere sociale ed economico del matrimonio
tra tradizione e compromesso
La proposta è il risultato di una ricerca condotta attraverso l’osservazione diretta delle pratiche matrimoniali in
uso al giorno d’oggi. In particolare sono stati esaminati
alcuni matrimoni che si sono svolti durante i mesi estivi
nelle zone di Altamura e Matera e da cui sono stati ricavati i documenti fotografici della ricerca. L’installazione
indaga la dinamica dei rituali caratterizzata dalla volontà
di modernizzazione, che si manifesta sia nei comportamenti economici che in quelli rituali e la partecipazione
della collettività coinvolta nelle dinamiche di celebrazione. Riti e tradizioni vengono riprese e reinterpretate a
seconda delle contaminazioni sociali, dei desideri degli
sposi e della comunità interessata, sebbene i valori morali rimangano per lo più gli stessi. Alle “dinamiche riduttive” vengono affiancate alcune pratiche rituali che si
vanno invece affermando nella contemporaneità. Uno
spazio aperto in cui i visitatori potranno interagire con gli
elementi a disposizione.
Utilizzo di foto e oggetti augurali legati alla contemporaneità del rito; un “vin d’honneur” composto da spumante, bicchieri e confetti nuziali; un album fotografico
con le foto realizzate durante la ricerca, relative ad alcune tra le pratiche matrimoniali più diffuse nella società
contemporanea: l’addobbamento dell’automobile degli
sposi, il bouquet della sposa, gli ornamenti floreali, il
pranzo nuziale ed altre pratiche tradizionali di consumo;
una postazione multimediale in cui attraverso il gioco
Dream Day Wedding i visitatori potranno realizzare il
matrimonio perfetto; riviste specializzate, depliants pubblicitari, biglietti da visita e materiali promozionali riguardanti l’organizzazione di un matrimonio.
XLIII
Marco D’Aureli
Museo del brigantaggio di Cellere & Museo della terra di
Latera
Il Bebyparty
Il baby party sembra prendere piede in Europa. Si tratta
di una pratica culturale proveniente dagli Stati Uniti e dal
Canada che ha il carattere del rito di passaggio svolto
nell’imminenza del parto. È una festa a sorpresa a partecipazione esclusivamente femminile nel corso della
quale, oltre a momenti di convivialità, trovano spazio
prove a carattere ludico-competitivo che gravitano attorno a quello che sarà lo status della genitrice.
Quest’ultima è chiamata a misurarsi, sotto l’occhio attento delle amiche e delle donne delle sua famiglia, al
tempo stesso attrici partecipanti e dispensatrici di consigli, in attività che di lì a poco diventeranno di routine,
come il cambio del pannolino.
Tra i giochi che hanno luogo nel corso del babyparty
(meglio conosciuto nei luoghi di provenienza come babyshower) c’è quello che consiste nell’indovinare il contenuto di pannolini chiusi annusandone l’odore, indovinare la circonferenza della pancione, individuare gli ingredienti utilizzati nella preparazione di alcune pappe,
scoprire il nome del bambino (facendo una lista di quelli
auspicabili e di quelli decisamente da scartare), assumere
un impegno a favore della madre e del nascituro da portare a compimento nel corso dell’anno a venire. Alla fine
delle prove arriva il momento in cui la futura mamma,
assieme al padre del bambino, apre i regali ricevuti dalle
partecipanti alla festa e che erano compresi in una lista
di desideri stilata preventivamente.
La scena ricostruisce il contesto di un babyparty che si è
svolto nell’estate del 2010 in Germania (Oederan,
Sassonia centrale), dove il babyparty è arrivato assieme
al bagaglio di esperienze accumulate da una ragazza tedesca, Susy, vissuta negli USA per diversi mesi. E già,
nella piccola città, sono previsti altri babyparty.
Stoviglie in plastica e ceramica, scatole regalo, pannolini,
cartelloni, abiti da neonato, vasetti di pappa per neonati,
il tortolino (un assemblaggio di pannolini che ha l’aspetto
di una torta), libretto fotografico dell’evento contenente
le immagini riprese in occasione del babyparty rappresentato, palloncini.
w
Elena De Sabbata, Gian Paolo Gri,
Stefano Morandini
Università degli Studi di Udine - Dipartimento EST;
Museo Cjase Cocèl - Fagagna (UD), Coscritti della Valle
del Lago
W la classe.
Diventare uomini e donne - Coscritti in Friuli
«Classe», l’insieme dei nati nello stesso anno: una configurazione che nel tempo, da burocratica qual era, ha assunto valenze culturali complesse, entrando di prepotenza fra i riti di passaggio, offrendo confini a forme
identitarie specifiche, interne alla comunità di villaggio.
La classe si è associata alla visita di leva e la visita di leva
è stata assunta a livello popolare come prova di selezione delle attitudini fisiche e sessuali, finendo col diventare prova e tappa fondamentale per l’ingresso dei giovani nell’età adulta. La coscrizione, così, è stato uno dei
fattori di intersezione più importanti fra la struttura sociale e rituale della comunità e l’istituzione militare.
Oggi, l’abolizione della leva obbligatoria non è riuscita
ancora a indebolire la «coscienza di classe» (che Marx ci
perdoni!). Come mai questa tenuta?
Gli usi di coscrizione rimandano a forme rituali antiche,
connesse con l’organizzazione e le funzioni delle «compagnie» dei giovani scapoli, spesso sostituendole; rinviano anche al complesso (e ancora poco indagato)
“folklore militare”. Dalla vita militare (ma vale anche l’inverso) la tradizione ha assunto terminologie, strutture
simboliche, repertori musicali, ideologie, forme di autorappresentazione (la «fotografia di classe»), accessori
identitari.
L’installazione combina aspetti degli usi di coscrizione
tradizionali ma contemporanei (innalzamento dell’albero
e delle bandiere di ‘classe’, passaggio di consegne a
Capodanno o per il primo di Maggio, corredi simbolici –
‘cappelli fioriti’ in particolare –, nuova presenza femminile, mutamento delle «scritture esposte» dai muri
all’asfalto delle strade e infine alle pagine di Facebook)
con richiami visivi e sonori al passato. La finalità: suggerire l’intreccio delle linee di lunga durata con quelle
dell’innovazione. Per questo la tradizione dura.
Carta, cartone, nylon, gesso, stoffa, sale, foglie di verza,
frasche, lardo, uova, farina
XLIV
Paolo De Simonia, Michele Mucci
Docenti scardinati dell’Università di Firenze
Tu si’ in the Dark: autobioradiografia
To See In The Dark: titolo di una mostra di Benedetta
Bonichi centrata sulla radiografia quale medium unico e
universale “per leggere la realtà”.
Da cui il mio Tu si’: dialettale e autobio, interpretato in
videoinstallazione da Michele Mucci.
Contemporaneità dei riti di passaggio, non solo canonici, organizzata nella sequenza di una storia personale:
proiettando immagini e parole sulla radiografia del mio
bacino. Universalità della struttura ossea e individualità
dei ‘casi della vita’. Fino all’ultimo rito: la radiografia annuncia la morte dei corpi viventi quanto la fotografia ricorda l’esistenza dei corpi scomparsi
Videoproiezione infine come distanza e ostensione, tra
memoria e sua rappresentazione museale estratta/separata dalla vita di primo grado. Con Ortel: “indagare il
soggetto presente in funzione del suo precedente vissuto”. Ma anche, formalmente, il “vedere nel buio” di
ogni liminalità anche prima di Agamben. E mascariando
il tutto con il principe Antonio de Curtis.
Videoinstallazione
w
Rosa Anna Di Lella
Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici. Collaborazione all’allestimento di Ugo Giansiracusa
L’albero delle scarpe passate
Scarpe usate, consumate e poi abbandonate, buttate.
Scarpe che non si possono indossare e non si possono
gettare.
Passi, età, passaggi.
Cresciamo e le scarpe crescono con noi, ci accompagnano. Testimoni dei cambiamenti del nostro corpo.
Raccontano quello che siamo stati, le fasi della nostra
vita, evocano ricordi, nuclei di affettività, eventi. Ci separiamo da esse e insieme abbandoniamo il tempo che ci
ha visto indossarle: dismettendole e riponendole le confiniamo negli strati della nostra memoria.
E sull’albero spuntato, pendono, si accumulano – insieme alle scarpe – come frutti o fiori evanescenti e provvisori, i frammenti dei nostri racconti, brevi narrazioni sui
nostri passi e nostri passaggi.
Un ultimo viaggio. Una fine che origina un nuovo inizio.
Un rito intimo di separazione. Un rituale non codificato.
Aggregante. Virale.
L’installazione trae suggestione dalla pratica in espansione dello shoefiti o dello shoetree che consiste nel lanciare un paio di scarpe unite dai lacci sui fili della corrente o su un albero.
Scarpe, tubi di pvc, legno, rete metallica, colla.
Si ringraziano Valeria Agiato, Chiara Coccorese, Egidio
Cossa, Elvira De Sanctis, Antonietta Piliego, Ugo
Giansiracusa, Maria D’Addetta, Letizia Pellegrino,
Loretana Salvadei, Angelica Racanati per aver donato le
loro scarpe.
XLV
Sandra Ferracuti
Università La Sapienza Roma e Simbdea
Passaggi delicati:
liminalità urbane - Maputo, agosto 2010
La parte superiore dell’installazione è una “girandola” in
filo di paglia intrecciato, costruita sul modello di un oggetto di produzione anonima acquistato al mercato
dell’artigianato di Maputo (Mozambico). Da questa
struttura sono fatti pendere, con dello spago, lo stesso
oggetto e due ad esso simili e sempre prodotti con l’intreccio di essenze naturali (il primo raffigurante scene di
musica e ballo in ambito rurale ed il secondo la nascita
di Cristo).
Oltre ai tre oggetti prodotti per il commercio con i turisti, e che rimandano immagini di una vita rurale pacificata ed assimilata, dalla stessa struttura sono fatti pendere anche documenti di ricerca etnografica a Maputo
(2006-2010): estratti da note di campo, brani di interviste e dialoghi informali, articoli di giornali locali e fotografie. Tali documenti sono stati selezionati sulla base
della loro capacità di rendere visibili elementi cruciali del
contesto urbano in cui i cittadini shangana di Maputo
(gli stessi che sono autori degli oggetti di artigianato attraverso i quali mettono in scena elementi della propria
identità) affrontano i riti di passaggio di tradizione
tsonga e quelli che fanno seguito al contatto ed all’adesione alle due grandi religioni monoteiste o alle nuove
chiese evangeliche. I documenti rimandano a ritualità sovrapposte, tempi liminali forzatamente ‘allungati’, passaggi complessi e, a volte, addirittura negati, nella difficile e costosa integrazione delle multiple appartenenze
culturali dei loro protagonisti: tra ideologie di “sviluppo”
improntate sul modello occidentale, sentite fedi monoteistiche e rispetto delle regole dettate dalla propria genealogia.
La parte inferiore dell’installazione riproduce sinteticamente il contesto di lavoro del curandeiro, il “medico
tradizionale”: sul pavimento una stuoia; da un lato, una
sedia posta di fronte ad un tavolino basso ricoperto da
una capulana “del sole” – taglio di tessuto wax print
usato per facilitare la comunicazione con deuses e defunti-; sul tavolino, alcuni strumenti dei procedimenti rituali del curandeiro: bastoncini di incenso, barattoli di
vetro riciclati contenenti essenze naturali frammentate o
tritate; ossicini, sassi, monete e conchiglie – usati dal curandeiro per la comunicazione con i defunti.
La centralità data al contesto di lavoro del curandeiro,
piuttosto che a quelli della celebrazione di altre ritualità,
pur vissuti, vuole rispecchiare la centralità che i cittadini
shangana di Maputo sembrano tenacemente accordare
alle regole dettate dalla propria genealogia, rispetto a
quelle di origine extra-Africana, anche nell’ambito della
‘risoluzione’ dei delicati passaggi tra identità sociali. Il
curandeiro-nyamassoro, dotato della capacità e delle
competenze necessarie a comunicare con i defunti, è
sceneggiatore immancabile di ogni procedura legata al
rispetto delle volontà dei propri antenati, altrove invisibili
ma sempre sentiti come agenti nella vita quotidiana dei
discendenti, nonché registi delle operazioni necessarie al
loro positivo superamento dei delicati momenti di transito tra identità sociali.
Cruciale collaboratore alla fase più recente della mia ricerca a Maputo (agosto-settembre 2010) – cui molti dei
documenti qui presentati fanno riferimento – è lo scultore Samson Makamo. Da me contattato nell’ambito di
un mio progetto di ricerca sui mondi estetici locali,
Makamo, infatti, è anche curandeiro e mi ha generosamente ed eloquentemente concesso un ingresso a visioni del mondo tanto sentite e diffuse quanto spesso
inespresse. Grazie a lui, ho potuto anche rileggere in
maniera maggiormente “densa” documenti provenienti
da fasi di ricerca precedenti, nonché identificare uno dei
punti di vista cruciali sulla condizione ‘di confine’ degli
artisti di Maputo (contesti attivi delle loro pratiche ed
identità artistiche sono tanto il sistema e la cultura
dell’arte internazionale quanto quelli locali): quello della
conciliazione delle proprie attività artistiche con il rispetto delle regole dettate dagli antenati e dalla propria
comunità locale.
Filo di paglia, spago, tre oggetti artigianali di produzione
anonima, stampe su carta di fotografie e testo, circa 10
barattoli vetro per conserve vuoti, bastoncini di incenso,
1 capulana “del sole”, ossicini, sassi, conchiglie, una moneta locale, un tavolino rettangolare basso, una sedia di
legno o plastica, una stuoia in fibra naturale.
XLVI
Tiziana Gentili, Maria Lisa Platania, Angelica Grieco
Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici e Università degli Studi di Firenze
Specchi d’acqua
2000: iniziai la fase “dark”, stavo malissimo con me
stessa, non mi accettavo per quella che ero, mi sentivo
bene solo se mi vestivo di nero e pensavo che in quel
modo nessuno mi avrebbe notato.
1992: Settembre, il mio primo giorno di scuola, classe
1°A, secondo banco a sinistra, ricordo la soddisfazione
provata quando riuscii a scrivere il nome sul quaderno.
2003 Aprile, arriva una lettera “Intercultura la informa
che è stato selezionato per lo scambio annuale nelle
Fiandre”, fu uno shock, ma me l’ero cercata e dovevo
sorridere.
“Specchi d’acqua” mette in scena scritture autobiografiche di ragazzi e ragazze tra i 24 e i 26 anni d’età, brevi
racconti d’iniziazione al sapere e di passioni sportive, di
viaggi desiderati e temuti, di disagi interiori e trasformazioni del corpo, specchi che ci restituiscono visioni fugaci
dei riti di passaggio nella società contemporanea.
Stoffa e maglie in cotone, gommapiuma, jeans, pantaloni combat in poliestere, pennarelli.
w
Costanza Lanzara, Gabriella Lerario
Università degli Studi di Firenze
Divano e divano:
viaggio d’iniziazione globale nel terzo millennio
Protagonista della scena è il divano, simbolo della pratica
globale del couchsurfing: rete mondiale che crea una comunità intorno a “un divano” animato da esperienze di
viaggio e ospitalità, al di fuori dei canali commerciali.
La ricerca etnografica ha esplorato principalmente il
web: i membri della comunità si presentano, si incontrano e si raccontano sul terreno virtuale, di cui il divano
costituisce il luogo reale.
L’installazione ha l’intento di rappresentare ciò che a
pieno titolo può definirsi un cerimoniale profano della
contemporaneità. Il visitatore, sedendosi sul divano,
viene accolto da voci e immagini per “viaggiare” nelle
tre fasi del rito di passaggio. Testimonianza su testimonianza: dalla materialità dell’azione presente alla virtualità di una geografia comunitaria e interculturale che
ognuno ricostruisce personalmente.
L’installazione si lega al territorio in cui è ospitata, importante centro della produzione di divani.
Divano multimediale.
XLVII
Met - Museo degli Usi e Costumi della Gente
di Romagna - Mario Turci
Santarcangelo di Romagna
L’ investimento (l’immateriale)
Aspettative, Rischio, Desiderio, Prova, Valutazione,
Famiglia, Intimità, Tempo
Viaggio d’affezione.
Atti spazio temporali del passaggio
Esiste un prima e un dopo del primo viaggio d’affezione? Quel viaggio fatto con il/la proprio/a ragazzo/a,
può considerarsi quale atto spazio-temporale a valenza
simbolica, che determina quella “prima volta del viaggio” capace di cambiare nei viaggiatori e negli “informati dei fatti” un cambiamento, grande o minimo, di
prospettiva?
Le cose (Il materiale)
Tendina canadese, camice, bagaglio, occhiali, pantaloni,
magliette, scarpe, slip, portafoglio, biglietti, cappelli, forcine, fazzoletti, calzini, collant, spazzolini, dentifricio, cerotti, aspirina, pigiama, boxer, canottiere.
L’intimità e prossimità stretta dei “ragazzi in viaggio, soli
per la prima volta” coinvolgendo, progetto, spostamento, tempo condiviso del notturno, vicinanza del
corpo, autorizzazione ricevuta (spesso), gestione delle risorse disponibili, condivisione di piccole o grandi ansie,
rischio, possono configurarsi quali componenti esistenziali capaci di determinarsi un “tessuto” rituale del passaggio. In tal senso spazio e tempo (dimensioni di
senso), corpo e aspettative (campo rituale), cose e bagaglio (interstizi simbolici) possono essere pensati come
elementi sostanziali per una etnografia del “primo viaggio”?
La tendina canadese “da due posti” in capo d’abiti, oggetti e accessori utili al viaggio di due giovani identificati
dalla scelta stessa di abiti, oggetti, accessori, tende sintetizzare, attraverso l’esposizione delle materialità degli
interstizi simbolici (le cose che nel viaggio si insinuano
fra corpo e possibilità).
“Viaggio d’affezione” nasce anche dalla consapevolezza
che nel contemporaneo molta parte degli atti relativi a
riti di passaggio sono polverizzati in micro formalizzazioni che, seppur mantenendo il carattere del “poi sarà
diverso” non si realizzano in vere e proprie performance
rituali. Inoltre in molti di questi la comunità non partecipa attivamente al controllo della “legittimità” degli
atti, ma delega alla famiglia ogni valutazione, autorizzazione, controllo e censura.
w
MEG - Museo Ettore Guatelli - Mario Turci
Ozzano Taro di Collecchio - Parma
Atti alimentari del passaggio
La birra
Perché un rapporto fra lattine e scolabottiglie?
Un’installazione che non nasce da una ricerca svolta, ma
da un progetto: una lettura del contemporaneo materiale
a partire dalla ricerca di Ettore Guatelli. Guatelli utilizzò gli
scolabottiglie quali testimoni etnografici e al contempo
supporti espositivi per piccole installazioni (lattine, corni,
teste di manichino, cappelli, abiti, ecc.). L’azione del “testimone che sorregge la scena” è assunto quale ipotesi
d’indagine per una scrittura etnografica il cui grado di riflessività è dell’oggetto stesso. Sostanzialmente questa è
l’esperienza dell’opera-museo di Ettore Guatelli.
Una dimensione del mondo giovanile in cui l’assunzione
di alcolici (birra) può contenere particelle del passaggio,
dalla famiglia al gruppo?
Il consumo della birra, legato ad ambienti/ritrovo o a
spazi/situazione improvvisati, non si associa a quello domestico perché la differenza è data non solo dalla qualità e natura del gruppo (famiglia / amici), ma anche
dall’assenza, nel caso della famiglia, della dimensione
dello scambio. In famiglia il consumo di birra non attiene
allo scambio in quanto i linguaggi che sostengono il consumo non sono indirizzati alla negoziazione di un dentro/fuori il gruppo. Il “consumo vistoso e partecipato”,
lo scambio della bottiglia, il consumo in bottiglia e/o in
bicchiere, la scelta della marca, le qualità di un consumo
di genere, sono i caratteri che hanno indirizzato l’installazione.
Investimento (l’immateriale)
Ebbrezza, Scambio, Inclusione, Distinzione, Prova,
Aspettative
Le cose (il materiale)
Cassa contenitore, 2.000 lattine anonime (non marcate
e fornite da CIAL Consorzio Italiano per il riciclaggio dell’
alluminio), lattine da birra marcate, scolabottiglie.
Gli atti alimentari del consumo di birra sono assunti
nell’installazione quali “sostanze” partecipanti al progressivo passaggio adolescenziale dal dentro (famiglia) al
fuori (gruppo). La birra come elemento del passaggio capace di sintetizzarne il rapporto inclusione/distinzione.
La birra e il suo “supporto” funzionale quale plastica
ostensiva del desiderio di appartenenza.i
XLVIII
Anna Maria Pecci
In collaborazione con Gianluigi Mangiapane e Andrea
Perin Immagine coordinata e Progetto grafico: Space on
Sail
Verginità, di ritorno
Attorno ad un letto nuziale sfatto, che porta ancora traccia simbolica della “prima notte”, si svolge il discorso/
percorso dedicato alla revirgination. Un sempre più diffuso processo incorporativo di (ri)costruzione, trasformazione e legittimazione che mostra il corpo femminile impegnato e coinvolto in pratiche normative di identificazione, personalizzazione e distinzione.
Risultato del dialogo fra corpo individuale e corpo sociale, la revirgination può essere considerata un progetto
caratterizzato da una flessibilità e da una molteplicità di
“scritture” e “narrazioni” del sé che chiamano in causa
l’innovazione tecnologica. Un impiego della tecnologia,
tuttavia, che non si presenta soltanto sotto forma di intervento chirurgico, ma che appare contenuto anche
nella cosmesi e in specifici prodotti di consumo reperibili
nei grandi magazzini o in e-shops.
Il nostro sguardo propone di leggere la revirgination
come processo corporeo dinamico e atto di risignificazione simbolica e fisica che attribuiscono un rinnovato
valore identitario alla verginità, qui reinterpretata in termini di “messa a norma” e “messa in scena” del corpo
attraverso un ritorno ad una ritualità che assume moda-
lità espressive, individuali e/o collettive, tecnologicamente aggiornate e mediaticamente influenzate.
L’installazione si presenta come ipotesi sperimentale per
una futura indagine etnografica che assume le fasi del
rito del passaggio – separazione, margine, ri-aggregazione – non solo come stadi (interpretativi) della revirgination ma anche come strumento rappresentativo.
Viene pertanto evocato un viaggio che, a partire dagli
expôts della separazione (due valigie e un catalogo di turismo medico), attraversa il margine della revirgination
(un beauty case in cui collassa il confine tra biomedicina
e cosmesi) per condurre al matrimonio ri-aggregante
(raccontato da un album fotografico “problematico”).
La giustapposizione, volutamente parziale, di frammenti
di testi saggistici, narrativi e artistici a testimonianze di
vari attori del rito – raccolte principalmente in Internet,
spazio d’incontro etnografico e di produzione di significato – si associa, in risonanza o disgiunzione, a immagini
e oggetti, non meri elementi di decoro ma significanti
essi stessi. La trasversalità dei contesti di rappresentazione della revirgination si traduce infine in un discorso
polisemico che intende interrogare il senso critico dei visitatori e delle visitatrici.
w
Sam Pezza
“Antropologie possibili” Uniroma6
Gioventù eroica
Assaporare la subnatura
Ormai da alcuni anni la vita dorata che gli adulti attribuivano
ai giovani sembra essersi dissolta. Al suo posto va diffondendosi, anche in strati sociali benestanti, l’immagine di una gioventù esposta a molti, troppi rischi, disorientata rispetto ai
valori, ai saperi e alle forme del convivere, rallentata nel portare avanti il proprio percorso biografico: “una generazione
senza futuro”, si dice. Catastrofismo, di certo. Però dalla
contemporaneità italiana emerge, come stranezza culturale,
un sovrappiù di accanimento rituale nei confronti dei giovani. Tra le pieghe della cronaca e dell’immaginario, tra le testimonianze etnografiche e la documentazioni di fiction, fumetti, cinema, letteratura, ecc, risalta la rappresentazione di
un giovane come un eroe offeso nell’agonismo rituale (la
strage del sabato sera; il suicidio prima causa di morte tra i
giovani, un quarto dei giovani disoccupati, …), sacrificato
ma non mortificato. La sua storia racconta di ferite inguaribili e di grandiose imprese e traccia continue commistioni,
oscillando dal genere patetico a quello epico, dall’autocommiserazione al melodramma e alla parodia.
Nelle maschere oggi in commercio ad uso dei ludi giovanili è
difficile trovare personificazioni di angeli, fatine e animali.
Netta è la prevalenza di soggetti partecipi della subnatura:
un mondo di presenze notturne, infere, demoniache, bestiali, imprigionate in abissi; un regno di morti non pacificati,
di fantasmi inquieti che dal sogno trapassano nelle nostre
vite; un conglomerato di pericolosi marginali che dai confini
dell’universo del creato sembrano “farvi vivi” con il solo
obiettivo di terrorizzarci e di convincerci che la vita è null’altro che incubo. Se la maschera offre un’alternativa esistenziale seppure temporanea, una sospensione mitico rituale
del presente storico (la ben nota destorificazione de Martino),
c’è da chiedersi in che modo i tipi di volti da indossare sopra
il proprio volto ci parlano dei mondi con cui, seppure in
modo immaginario, siamo in relazione. Quali ragioni possiamo cogliere in maschere espressionistiche che, debitrici
dalla letteratura e cinematografia gotica, innescano narrative
paranoiche e suggeriscono incorporazioni, mimesi interne
alla “cultura del terrore” (cfr. M. Taussig), aggredire gli altri
in risposta alla immaginata possibilità di subire aggressione?
Convocare il terrore per imporre dipendenza, secondo la pedagogia antica? Esplorare in forme protette la problematicità
dell’esperienza moderna? Percepire dal di dentro l’inferno
delle relazioni capitalistiche anche a costo di correre il rischio
di non poterne fuggire ovvero abituarsi a convivere con il terrore prodotto dall’ordine sociale attuale? Aggiungere le vostre interpretazioni scrivendole sui i post it messi a disposizione, entreranno nel catalogo. Non dimenticate di dare il
giusto credito all’ironia che pervade le rappresentazioni e il
loro uso
Un filo rosso, stampelle anni 30 in dotazione ad un convento, eroi dei cartoon
Maschere di lattice dagli anni 80 in poi con all’interno volti
composti da palle di quotidiani
XLIX
Massimo Pirovano
Museo Etnografico dell’Alta Brianza
Oggi sposi. Teli da strada, scritti per gli sposi.
Tracce effimere di un rito recente
Con una ricognizione su alcune pratiche profane del matrimonio documentate in Brianza, l’istallazione si concentra sui teli scritti che vengono appesi da parte di
amici e parenti dei prossimi coniugi sui muri e per le
strade, nei giorni immediatamente precedenti il matrimonio. I contenuti di queste scritte presentano annunci
con una funzione prevalentemente referenziale, ma più
spesso riportano pronostici ironici o richieste rivolte agli
sposi, in riferimento al cibo, al sesso e ai prossimi rapporti di parentela di uno dei due coniugi, in cui le allusioni, le rime e le espressioni dialettali hanno una presenza ricorrente, come nei canti rituali della tradizione.
L’accostamento tra documenti ascoltati e teli visti e letti
sollecita il visitatore ad operare un confronto tra elementi, motivi, funzioni che ritornano nei tempo o che
compaiono oggi.
Teli, con un dvd che presenta fotografie e testi proiettati.
Canti rituali della tradizione raccolti in Brianza montati
per l’ascolto durante la proiezione.
w
Silvia Settimi
Sapienza Università di Roma
18 anni. Uno zaino da riempire
Retro-Scena. Esperienza svoltasi su un doppio versante
didattico e di ricerca, condotta in una classe di ventuno
ragazze, frequentanti il terzo anno del Liceo delle
Scienze Sociali di Velletri (RM). Il lavoro sul campo, iniziato nel mese di marzo e ad oggi ancora attivo, indaga
su due tematiche di diverso interesse antropologico, tra
di esse implicitamente connesse: la cultura materiale del
mondo giovanile e il compimento dei diciotto anni come
rito di passaggio nell’età contemporanea.
L’installazione insedia vuoti con improbabili rivoluzioni
materiche, reclama lo stupore e l’acume di occhi posti
dietro una lente d’ingrandimento. Ingombranti presenze, artificialmente estese, a proporre caricaturali riproduzioni che risultino provocazione per sguardi minimizzanti e patine troppo leggere. Spalle accoglienti per
corpi temporaneamente protagonisti di un’accresciuta
realtà, non monumentalistica, non perentoria.
Esposizione di molteplici storie come tappe di un percorso fermato con l’intento di restituire una visione
densa sulla dimensione dell’essere donna e dell’esserlo
in una specifica età, non per ricostruire destini ma momenti dell’essere. Scorribande interiori per sogni e memorie, negoziate presenze per apparenze e sembianze:
vissute, immaginate, vestite, tutte in egual modo evocate.
Zaino (gomma piuma e tessuto di cotone bicolore base
70x60 cm - h 150 cm circa). Proposto e pensato come
contenitore da riempire prima di partire per un luogo
viaggio, selezionando oggetti essenziali alla propria persona, lo zaino è diventato metafora di vita, simbolo del
sé, forma del pensiero e immagine del viaggio.
Rivista (stampe a colori plastificate 90 x 60 cm circa)
L’interpretazione dei testi prodotti, su entrambi i temi di
ricerca, ha evidenziato elementi che ben potevano essere restituiti attraverso il genere mediatico scelto. La dimensione femminile, la specifica fascia d’età, l’importanza attribuita ai legami familiari e amicali, il tema del
viaggio, nel loro ricorrere, hanno aperto lo sguardo su
dinamiche ascrivibili allo specifico mondo indagato, le
stesse che appaiono all’interno delle riviste per ragazze.
L’analisi di queste ha convinto a poter sfruttare tale cornice, forzandone i contenuti, spesso evidentemente ad
hoc costruiti, al fine di dar vita ad un prodotto che fosse
esclusivo frutto di collaborazione e costruzione tra ricercatore e soggetti coinvolti.
L
Nadia Truglia
Università di Messina
Tatuaggio: passaggio avvenuto
o passaggio inibito?
Il tatuaggio è sempre stato associato dagli etnologi ai cosiddetti riti di passaggio delle culture extra-europee.
Tuttavia, a chi si interessa al tatuaggio nelle culture occidentali contemporanee, non sfugge quanto forte sia,
anche qui, anche ora, la dimensione ritualistica e la vocazione di demarcatore del passaggio di questa ormai
diffusissima pratica corporea.
Le testimonianze etnografiche, qui evocate per frammenti, raccontano di tatuaggi fatti in occasione della
morte di qualcuno, della nascita di un figlio, dell’inizio o
della fine di un amore, del superamento di una prova
difficile ecc.
Il tatuaggio segnala tutto questo, ma non solo questo.
In linea con i valori e i modelli culturali dominanti legati
alla centralità di un corpo sano, giovane, bello… è possibile che il tatuaggio (e altre forme di decorazione permanente del corpo) si presti quale strumento di inibizione nel passaggio a fasi vitali oggi squalificate, nascoste, rimosse: la vecchiaia e la morte. Ecco allora che il tatuaggio cambia di segno per farsi strumento di riverbero
del presente, di riattualizzazione infinita della giovinezza
e delle sue concordate (culturalmente) virtù come il coraggio, la ribellione, la ricercatezza estetica.
Tatuaggio per cambiare, per migliorarsi, per evolversi
dunque, ma anche per non invecchiare, per non soffrire,
per non morire.
Una bara per provocare e invitare allo spaesamento; materiali di ricerca per riflettere e darsi strumenti interpretativi; oggetti del quotidiano “tatuaggistico” per evocare
un mondo troppo denso per essere banalizzato e per immaginare sensazioni (visive-olfattive-tattili) prese in prestito da chi sceglie di vivere ancor più corporalmente la
propria esistenza.
w
ABYTHOS, MondiVivo, Pittoresco Italiano, Marco
Mazzoni - Lucia Girardino - Gabriella Lerario, Clara
Gallini, Valentina Cei, Luca Villa, …
Che scatole? Di idee, ne hanno piene
Sono giunti ai curatori della mostra molti progetti di installazioni etnografiche che, pur interessanti dal punto di
vista dell’immaginazione antropologica, non presentavano tracce di una ricerca etnografica compiuta o in
corso ovvero mostravano incertezza dal punto di vista
espositivo.
Abbiamo ritenuto opportuno far conoscere alcune di
queste proposte invitando gli autori a lasciarne una testimonianza (testuale, iconografica, oggettuale) all’interno
di una scatola dal colore e dalle dimensione preferite.
Tutte le scatole, contenenti progetti che necessitano di
essere perfezionati, sono state collocata in mostra, apribili e consultabili dai visitatori curiosi.
LI
la mostra
sguardi da lontano
Frammenti etnografici dell’Umbria contadina nelle
immagini di Paul Scheuermeier e di Ugo Pellis (1924
- 1939)”
A cura degli allievi della Scuola di Specializzazione
in Beni Demoetnoantropologici dell’Università di
Perugia (I ciclo).
La mostra è stata ideata e realizzata dagli allievi del
primo ciclo della Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici della Università degli Studi di
Perugia (direttore prof. Giancarlo Baronti) (in convenzione con le università di Firenze e di Siena). Il progetto
di mostra è scaturito nell’ambito dell’insegnamento di
“Antropologia Museale” che ho tenuto per l’anno accademico 2009/2010.
La scuola si è data come obiettivo la realizzazione di una
sorta di “elaborato di sintesi” capace di attraversare, attraverso quanto studiato e recepito dagli allievi, tutti gli
insegnamenti dei due anni e quindi inteso come una
delle espressioni di verifica dei risultati dell’ intero ciclo.
Il laboratorio di Antropologia Museale ha visto lo sviluppo di tre fasi di lavoro, quella della discussione,
dell’analisi della documentazione e del progetto, quella
della produzione, vera e propria da parte di alcuni studenti sotto la guida di Daniele Parbuono, dei supporti e
delle strutture expografiche ed infine quella del primo allestimento a Castiglione del lago (Perugia) all’interno del
Palazzo della Corgna (estate 2010).
L’esposizione propone uno sguardo non convenzionale
nei confronti del mondo rurale tradizionale della regione
Umbria, utilizzando come materiale di partenza alcune
immagini realizzate in questo territorio tra le due guerre
da due ricercatori in campo linguistico che hanno anche
documentato alcuni aspetti della cultura materiale attraverso campagne di rilevazione fotografica professionale
e mirata: Paul Scheuermeier nel quadro delle inchieste
per l’Atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e della
Svizzera meridionale (AIS) e Ugo Pellis per l’ Atlante
Linguistico Italiano (ALI).
Il nocciolo, l’idea concettuale della mostra, scaturita
dalla discussione nei giorni dell’insegnamento, è riassumibile nell’obiettivo di rendere evidenti i tre piani, autonomi e coincidenti, di una pratica dello sguardo capace
di realizzare una rete interpretativa fra documenti esposti (lo sguardo di Pellis e di Scheuermeier) e visitatore (lo
sguardo del pubblico), attraverso la mediazione di una
possibile scrittura etnografica espositiva (gli specializzandi progettisti ed il loro sguardo).
In relazione alla chiarezza di obiettivi la sfida è stata nel
riuscire a individuare quelle forme expografiche capaci di
restituire in pieno la riflessione etnografica. Di certo la
necessità di non farsi intimidire dal limite delle risorse disponibili si è presentata come stimolo per la ricerca di soluzioni “pratiche” e quindi sintetiche.
Altro risultato di rilievo è stato nella prova e riuscita di un
rapporto concreto fra Scuola di Specializzazione ed enti
territoriali, fra “riflessioni in aula” e e le sfide delle contingenze politico-amministrative.
Sguardi da lontano è stato un primo esperimento laboratoriale di sintesi che la Scuola intende offrire, anche
in futuro, agli allievi al termine del secondo anno di
specializzazione. A questa esposizione ne seguiranno
altre anche se per ora siamo e saremo impegnati a rispondere alle molte richieste di circuitazione dell’esposizione che a Matera ha raccolto consensi e applausi
sinceri.
Mario Turci
LII
Francesco Farabi - Scuola di Specializzazione in Beni demoetnoantropologici
la mostra
un’esperienza didattica
Il progetto della mostra “Sguardi da Lontano. Frammenti
etnografici dell’Umbria contadina nelle immagini di Paul
Scheuermeier e di Ugo Pellis (1924-1939)” non è solo un
atto di prova sul campo delle professionalità che la Scuola
di Specializzazione in Beni demoetnoantropologici si propone di formare, ma un’esperienza, un laboratorio, una
fucina.
Sotto la guida del prof. Mario Turci e del Direttore prof.
Giancarlo Baronti ci siamo divisi in due gruppi che per due
giorni di lezione si sono occupati uno della selezione delle
foto e dei criteri di suddivisione delle stesse, l’altro della
scelta espositiva. Quindi un piccolo gruppo stabile di studenti umbri si è occupato della realizzazione materiale
della mostra, mentre i compagni lontani gestivano la preparazione dei testi.
L’impianto espositivo focalizza l’attenzione sugli “sguardi”
e ne analizza in modo critico il senso. Le due stanze in cui
si articola la mostra, nascono da due diverse direzioni interpretative.
La prima, più analitica, chiede allo spettatore di osservare
le foto da differenti prospettive: una immediata, diretta rispetto all’immagine e l’altra mediata da un filtro simbolico, rappresentato da “spioncini” appesi a mezz’aria, sintesi dello sguardo etnografico che permette di focalizzare
l’attenzione su dettagli impossibili da afferrare nell’insieme. In questo continuo scambio tra “particolare” e
“contesto” si colloca l’antropologo moderno, che riconosce la sua posizione ambigua: troppo “lontana” da ciò
che osserva e allo stesso tempo forzatamente “vicina”
nell’interpretazione.
Il “destino” di inafferrabilità di questa posizione è rappresentato, dal totem centrale, che contiene le macchine fotografiche usate dai due ricercatori; segno di uno sguardo
che, al suo “grado zero”, torna ad essere l’obbiettivo di
una “macchina”.
La seconda stanza raccoglie questa riflessione e la porta
su un piano più emotivo: cosa resta infatti delle persone
immortalate in queste foto? Non hanno nome, non
hanno una storia conoscibile, sono frammenti sfocati di
uomini e donne, di cui non possiamo che afferrare pochi
dettagli. Per questo le foto sono state simbolicamente distrutte, infrante e appese al soffitto. Da esse sono stati
sottratti gli oggetti tangibili, quali unici segni e ombre
dell’umano rappresentato. Di questo “umano”, dopo la
distruzione, non restano che frammenti muti.
La chiusura simbolica del percorso è contenuta nel tentativo di ritrovare questa umanità dispersa attraverso la ricomposizione degli sguardi e l’esplosione dell’obbiettivo
della macchina fotografica nel quale erano “imprigionati”.
Il racconto della mostra è prima di tutto il racconto di un
processo di creazione. Ogni oggetto presente in essa è il
risultato di un atto di plasmazione dei modesti materiali a
disposizione, ottenuto attraverso il lavoro manuale, artigianale. Non è casuale il fatto che durante questa espe-
rienza sia io che Daniele Parbuono, tutor della Scuola di
Specializzazione, abbiamo sovente impiegato il termine di
“Antropologia Artigiana”, con l’obiettivo di descrivere
una antropologia dell’atto pratico, calata nei contesti, in
relazione con le condizioni reali di realizzabilità dei progetti. Reperire i materiali, modellare con il corpo, trasformare l’immagine – ma anche il legno, il ferro, la corda –
in “pratica del dire”, in “grammatica espositiva” da costruire nell’interpretazione, in questo contesto, diventa
esperienza concretizzata nel pensare la grafica, nel segare, nel martellare, nel cucire, nell’appendere corde, nel
fare nodi. Nella “cassetta degli attrezzi dell’antropologo”
di cui parla Foucault, si possono trovare anche la sega, il
martello e il cacciavite.
Se l’interpretazione emerge anche dal plasmare, dal comporre o ricomporre il materiale “grezzo”, allora ha necessariamente a che fare con il corpo che la produce: in questo senso si può pensare l’interpretazione come “tecnica
del corpo”.
Francesco Farabi
LIII
Alessandra Broccolini e Piero Vereni
poster
giovani
etnografi sperimentali
L’antropologia (anche quella italiana) non sembra esimersi dal godimento della crisi. Abbiamo iniziato a studiarla per passione, attorno alla metà degli anni Ottanta,
e subito si sono premuniti di informarci che si trattava di
una disciplina costretta a ripensarsi profondamente. Ben
presto arrivò anche in Italia la (traduzione della) svolta
linguistica e tutti (ok, quasi tutti) dovemmo prendere
atto della natura costitutiva dello stato di crisi.
Dopo un quarto di secolo, non è ben chiaro da che parte
abbia portato quella condizione cronica, ma nell’insieme
la disciplina, con le sue molteplici e divergenti articolazioni sembra in buona salute, semmai soffocata dalla ristrettezza dei finanziamenti e dal disinteresse delle istituzioni, ma non ci pare che la produzione etnografica e la
riflessione antropologica siano carenti di vitalità, né cariche dei sintomi di una perdurante crisi. Forse la crisi, che
non può essere perenne, pena la perdita di senso, è stata
metabolizzata in un quadro di costante “sperimentazione”. È dentro questa parola un po’ magica e un po’
superficiale che abbiamo lanciato la proposta dei poster
da esporre durante il Convegno.
Inaugurata il 30 settembre 2010 nella Sala ex-Bookshop
del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della
Basilicata in Palazzo Lanfranchi, la sezione di poster
“Etnografie sperimentali” aperta a giovani antropologi
ha visto la partecipazione di 25 poster dedicati a ricerche
svolte o in corso. Pensando a un bilancio, si può dire che
la partecipazione delle “prime linee” dell’antropologia
italiana è stata buona; e il momento positivo di incontro
tra studiosi ancora in fase di formazione, provenienti da
diversi atenei italiani c’è stato.
Come strumento di comunicazione visivo-testuale delle
proprie ricerche il poster non è molto usato nel nostro
paese, tanto più nelle discipline umanistiche. Anzi diciamo che è ancora un oggetto oscuro (ma non del desiderio) legato ai modelli della comunicazione scientifica
(soprattutto in medicina) che ancora nel nostro paese
gode di uno statuto di “oggettività” miracolistico.
Proporlo ai giovani antropologi e pensare di dedicare a
queste giovani opere di “bricolage” un momento di incontro è stata forse una sfida dall’incerto risultato.
Inizialmente infatti la risposta degli aspiranti è stata
scarsa. Se ripercorriamo l’iter di selezione che ha portato
al gruppo finale di “etnografi sperimentali”, bisogna
ammettere che fino alle ultime settimane precedenti
all’inaugurazione del congresso ha regnato un certo
sconcerto. Forse ancora non perfettamente a loro agio
con uno strumento di comunicazione più visivo che testuale, i giovani autori che avevano aderito al bando, a
parte alcune eccezioni, ci rivolgevano, disorientati, le più
disparate domande su cosa significasse esattamente fare
un poster, come si dovesse confezionare; e i risultati non
sempre sono stati adeguati in termini comunicativi.
Alcuni poster sono arrivati privi di qualsiasi indicazione
testuale; altri privi di qualsiasi collocazione etnografica.
Un poster è arrivato alla selezione addirittura confezionato in più pagine di un Power Point, come se si trattasse di un articolo, o di una lezione universitaria, segno
di una dipendenza nei confronti del testo che non ancora si trova a proprio agio con la comunicazione visiva
sintetica, come invece è quella del poster.
In seguito, motus in fine velocior, la strada è stata trovata da quasi tutti gli autori che ci hanno inviato i loro
lavori non nascondendo la soddisfazione per aver realizzato in una opera densa e comunicativa dalle dimensioni
ridotte (70 × 100 erano le misure), un oggetto-feticcio
che facesse da biglietto da visita alla propria ricerca. Un
oggetto del quale affezionarsi, da accudire, da migliorare.
Il giorno dell’allestimento la novità dell’evento era abbastanza palpabile; non si trattava di sedersi e partecipare
ad un consueto seminario; bensì di un diverso mettersi
in mostra (anche fisicamente presenziando al proprio lavoro). Gli allestimenti sono stati effettuati su grandi ra-
LIV
strelliere di legno disposte lungo il perimetro della sala
che potevano contenere due poster ciascuno. Chiuso al
centro da un bel plastico di Matera e privo di sedie, il
percorso dei poster obbligava il visitatore più interessato
a girare in tondo incrociando i curiosi che venivano in
senso inverso o ad affiancarsi a quelli che percorrevano
il proprio senso di marcia. Collocandosi al centro della
sala si riceveva, invece, il colpo d’occhio – colorato ed
eterogeneo – dell’insieme dei poster, ma si perdevano i
dettagli. L’inaugurazione ha visto una buona partecipazione di pubblico (nelle nostre discipline vedere una piccola folla è sempre un piacere) che si è protratta anche
dopo i tempi brevi dell’evento permettendo ad autori e
visitatori di scambiarsi idee, conoscere il lavoro degli altri, trovare analogie, campi e interessi comuni. Ancora
più significativa è stata nel corso dell’inaugurazione la
“presentazione di sé” che, dopo le parole di benvenuto
dei curatori, alcuni autori hanno fatto davanti ai loro poster e che ha generato una sorta di piccolo pellegrinaggio da un poster all’altro. Un breve momento rituale
“del contemporaneo” che ha solennizzato la visibilità di
alcuni lavori.
I temi trattati sono stati i più diversi, e danno conto della
proliferazione tematica della nostra disciplina, ma si possono raggruppare attorno ad alcuni filoni consistenti,
declinati in forme spesso originali.
Uno dei temi più evidenti è la riflessione metateorica sui
MUSEI. Se Antonella Iacovino ci presenta un accurato
spoglio dei musei DEA in Basilicata, due poster ci conducono in Ghana a riflettere sul ruolo della museografia etnografica. Mariaclaudia Cristofano indaga nel suo lavoro la concezione dei capi Nzema, che proiettano sul
museo della storia e della cultura Nzema di Fort
Apollonia un’ambizione forte, ponendolo come luogo
della verità, un archivio che consentirà al potere di essere
gestito con maggior equità. Il luogo in cui sapere e potere si uniscono in una sorta di foucaultismo cosciente.
Stefano Maltese propone invece un progetto per inserire nel medesimo museo anche la lunga presenza della
Missione Etnologica Italiana in Ghana, facendo così etnografia sulla potenziale museificazione di una lunga
esperienza etnografica. Il gioco meta-etnografico è perseguito con assoluta dedizione da Federica De Rossi,
che nel suo poster sul museo etnografico di Neuchâtel
segue la concezione e l’allestimento di una mostra etnografando gli etnografi che riflettono sulla rappresentazione dell’etnografia. Grazia Lapenna ci riporta in Italia
analizzando il senso di un’istituzione ultracentenaria
come il Museo Nazionale di Antropologia e Etnologia di
Firenze. L’antropologa ne riconosce il linguaggio ormai
vetusto e, con un poster tra i più riusciti sotto la veste
grafica, si rende conto che il MNAE, dopo tutto, altro
non è che “una grande sfida che attende di scendere in
campo”.
Un altro gruppo riconoscibile di poster intende invece
proporre squarci etnografici di quelle che potremmo
chiamare NUOVE IDENTITÀ, vale a dire soggetti che per la
prima volta o in modo sostanzialmente nuovo diventano
oggetto di una rappresentazione etnografica. Il nucleo
teorico di questo approccio è condensato in maniera
esemplare da Sara Balestra nel suo poster sulle badanti,
in cui sintetizza una poetica dell’etnografia già pienamente matura: “Quando un fenomeno può essere descritto a grandi linee è opportuno tornare a scendere nei
particolari per non rischiare di non saperne più cogliere
la complessità e dunque i significati concreti, le trasformazioni e le eccezioni”. Lisa Platania offre un esempio
particolarmente evidente di questa attenzione etnografica per soggetti “eccentrici” nel suo poster dedicato alle
donne maltrattate, mentre Walter Nania e Mirna Cola
si interessano delle dimensioni sociali e culturali di due
sindromi, rispettivamente la sindrome di affaticamento
cronico e la sindrome di Asperger. Allontanandosi
dall’antropologia medica ma restando ben dentro il filone indicato, Tommaso Rotundo pone l’attenzione su
un soggetto collettivo emergente, vale a dire quella che
lui stesso definisce nel suo poster “la tribù di Slow
Food”.
Il caso di Slow Food mette in evidenza un altro tema che
ricorre sottotraccia in questi poster, vale a dire il rapporto uomo/ambiente e l’utilizzo dello spazio, che potremmo condensare come ETNOGRAFIA DELL’ECOLOGIA. La tendopoli di Piazza d’Armi a L’Aquila studiata da Giulia Lo
Giudice offre l’occasione per ripensare alla relazione tra
spazio pubblico e spazio domestico fino al ribaltamento
del senso comune: “La vita nel campo si svolgeva per la
maggior parte all’aperto: del resto lo spazio della tenda
non offriva grandi comfort o motivi per rimanere al suo
interno”. Ilaria Verratti, nella sua etnografia di un’oasi
marocchina ci racconta anche la poesia del rapporto con
l’acqua e l’ambiguità costante tra recupero tradizionale
e sviluppo modernista. Mariolina Ciccone, con il suo lavoro sulle pratiche di riutilizzo tra alcuni rom di Roma, riesce a sollevare molte questioni teoriche (il consumo, la
mercificazione, lo spreco, l’emarginazione sociale, l’immigrazione) e lo fa “semplicemente” raccontando come
due rom Khorakhanè vivono il loro lavoro di riciclatori di
rifiuti.
Proprio questo lavoro sui rom in Italia apre lo spazio per
un ulteriore tematica, presente in lavori di diversa impostazione, ma tutti orientati a considerare l’etnografia in
senso “classico”, non tanto (o non più solo) come una
metodologia di ricerca, ma anche come uno sguardo rivolto a un SOGGETTO ALTRO/LONTANO, raggiunto attraverso la
distanza del viaggio dell’etnografo. Così Mirinda Ashley
Karshan parte dall’Italia assieme a due gatekeepers rom
per andare in Romania, per vedere come si riciclano le
merci recuperate dall’Italia. Paolo Grassi affronta un
tema che sembra un po’ in ribasso almeno tra gli studiosi
italiani, dopo aver dato forse il meglio di sé negli anni
Novanta, vale a dire l’antropologia dei confini, studiando
una baraccopoli dominicana e il confine con la città che
la contiene. Deborah Nadal studia il processo di sedentarizzazione dei Birhar dell’Orissa, e Irene Miracca presenta l’identità in esilio dei palestinesi in Siria, e lo sforzo
consapevole di tenere viva la trasmissione delle loro cultura. L’etnografia di Emilio Giaccio sulla ricostruzione
della memoria della strage dei soldati italiani della
Divisione Acqui da parte dell’esercito tedesco dopo l’8
settembre appartiene a questo filone solo in parte, dato
che l’antropologo certo lascia la quotidianità della sua
LV
vita italiana, ma lo fa per conoscere la sorte di altri italiani.
In questo senso, il lavoro appena indicato è anche parte
di un altro gruppo, dedicato invece a studiare L’ALTRO VICINO, il dislivello interno di cultura, potremmo ancora
dire. Fortuna Sorbino propone un’interessante etnografia degli uffici della Provincia di Napoli, con un approccio fortemente anti-essenzialista, che vede nell’istituzione non un soggetto autocompiuto ma “un processo sempre in divenire”, mentre Francesco Bravin
studia il rapporto tra modernità e tradizione a
Monterosso, pregiata località nelle Cinque Terre. In questo filone di antropologia at home o near home si sviluppa quasi necessariamente un’attenzione notevole per
il RITUALE e il suo rapporto con l’IDENTITÀ E LA TRADIZIONE.
Roberto Milleddu e Laura Delussu studiano entrambi
il canto sardo, prestando attenzione a temi solo in parte
sovrapposti. Il primo nella sua ricerca studia, oltre alla
tradizione, le esigenze di innovazione sentite dagli stessi
cantori, mentre nella ricerca della seconda è interessante
l’intreccio odierno tra oralità e scrittura: i cantori ricercano “il testo antico, sulla base del quale i cantori contemporanei procedono all’emendamento dei testi ereditati dalle precedenti generazioni e alla ripresa di brani di
repertorio a lungo marginalizzati e dimenticati”. Nel lavoro di Marta Villa nelle Alpi Orientali si studiano riti in
cui il bene e il male si contrappongono come tradizione
e modernità: “rappresentanti della modernità sono stagnini, spazzacamini, vetrai, orologiai, cacciatori... lavori
praticati da stranieri girovaghi e per questo temuti e associati al diavolo come le streghe”. Il poster di Silvia
Taloni e Stefania De Pascale è dedicato alla festa della
Madonna del Monte di Marta, ma la ricerca, solo in apparenza dedicata a un tema consueto, è declinata secondo due prospettive di indagine originali, vale a dire
una lettura di gender della festa e l’evidenziazione delle
continua reinvenzione della stessa, anche attraverso la ricercata innovazione degli abbigliamenti “tradizionali”.
Proprio il tema del vestiario ci permette di fare riferimento al lavoro certamente più sperimentale e provocatorio, vale a dire il progetto Abito vuoto, di Abythos,
che è insieme rituale, performance e ricerca etnografica.
Con una proposta come questa, è difficile dire se si è ancora pienamente in territorio etnografico o se non si è
invece debordato verso nuove mete conoscitive. Ma l’invito a travalicare i confini e a vedere che c’era dall’altra
parte era proprio una delle intenzioni principali di questa
sessione poster.
Per tracciare un bilancio sembra di poter dire che, non limitata ai soli momenti congressuali, quella del poster,
per i contenuti sintetici e comunicativi che presenta, potrebbe diventare una forma semi-permanente di allestimento delle ricerche, anche in contesti generalmente
noti per la sobrietà (per non dire squallore) delle loro
strutture architettoniche, come sono le università.
Queste “etnografie sperimentali” ci hanno fatto immaginare una università in cui aule e corridoi siano riempiti
di lavori creativi, colorati, ma anche rigorosi e dove studenti, aspiranti etnografi o antropologi (ma anche ovviamente di altre discipline) possano esercitarsi in libertà.
Un delirio di ottimismo ci porta a vedere studenti che godono nel trafficare intorno ai loro Power Point per allestire il risultato del loro lavoro, immaginiamo sfide
“all’ultimo poster”, “concorsi di poster”, “poster-istallazioni”, nuove correnti delle scienze sociali che nascono
intorno alla socializzazione delle proprie idee intorno ad
un poster. Si, socializziamo i poster e produciamo cultura.
Ma anche questa forse è Fantantropologia.
LVI
poster
i musei si raccontano
“I musei si raccontano”: sezione di poster dei musei
etnografici italiani (svolta presso la Mediateca
Provinciale di Matera) a cura di Angela Cicirelli
(SimbdeaLab), Antonella Iacovino (Specializzanda,
Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici,
Università di Perugia) e Mario Turci (Direttore del Museo
“Ettore Guatelli” e del Museo degli Usi e Costumi della
Gente di Romagna)
Sono stati 49 i musei che si sono raccontati attraverso la
grafica del poster. L’obiettivo dell’iniziativa era quello di
promuovere la conoscenza e la valorizzazione del ricco e
variegato patrimonio museale italiano di interesse demoetnoantropologico. Il risultato raggiunto ha evidenziato
sia l’interesse a partecipare al congresso, sia la qualità
dell’investimento nella ricerca grafica dei poster.
Colpisce come ognuno dei 49 musei non abbia spedito
il proprio poster “per esserci in ogni caso”, ma abbia curato con particolare attenzione i testi brevi di presentazione, la scelta delle immagini e complessivamente uno
stile capace di narrare graficamente il museo e la sua ragion d’essere.
L’esposizione ha presentato uno spaccato minimo dello
stato della museografia etnografica in Italia. Se il quadro
generale dei musei d’interesse etnografico registra un
continuo aumento nella quantità, se i temi della qualità
gestionale ed espositiva sta toccando, almeno in termini
problematici, anche il piccolo museo, rimane sospeso il
chiarimento su quel rapporto fra ricerca etnografica e
scrittura museale che qualifica il museo, piccolo o
grande, come etnografico.
Molti dei musei che qualificheremo come DEA sono
ascrivibili alla storia dell’agricoltura, alla storia della tecnologia, oppure ai musei ergologici o di “storia delle tradizioni”, ma di storia. Richiedere ai musei di riflettere ed
esplicitare la propria missione può presentarsi come quel
piano di riflessione per lo sviluppo di chiarimento su cosa
possa significare fare etnografia con il museo.
I 49 poster presentano, seppur variegata per intento locale o tematico, una volontà di chiarimento dei propri
obiettivi, di quel “perché esisto”, che definisce il museo
come “servizio ad uno scopo”, od opera autoreferenziale mirata a soddisfare principalmente la visibilità di chi
lo ha realizzato.
Il museo etnografico nel contemporaneo è chiamato a
chiarire se voglia essere protagonista del suo tempo o
raccolta di prove dell’esistenza del passato, se inclusivo e
dialogante o congelato nelle stanze di una esposizione
data, se interessato all’etnografia ed al suo rapporto con
quella dimensione della ricerca che si basa sulla partecipazione sociale alla narrazione museale.
Ognuno con il proprio carattere i 49 hanno indicato che
innanzitutto sia necessario trovare un proprio modo di
stare al mondo, un proprio modo di comunicare e di cercare consenso sociale. Dimostrano, fra le righe, che ormai
è giunto il tempo per definire la contemporaneità del museo etnografico non tanto in relazione al patrimonio raccolto e gestito, ma principalmente sul suo modo di “stare
nel suo tempo” in maniera socialmente significativa.
Albano di Lucania (Pz), Museo interattivo del Giocattolo
Povero e del Gioco di strada
Altamura (Ba), Museo Etnografico dell’Alta Murgia,
Aquilonia (Av), Museo Etnografico “Beniamino Tartaglia”
Bassiano (Lt), Museo delle scritture “Aldo Manuzio”
Bellino (Cn), Museo del Tempo e delle Meridiane
Bosio (Al), Ecomuseo Cascina Moglioni
Buonconvento (Si), Museo della Mezzadria Senese
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte
Calimera (Le), Casa-museo della Civiltà Contadina e
della Cultura Grika
Cellere (Vt), Museo del Brigantaggio
Cervia (Ra), Museo del Sale
Cesiomaggiore (Bl), Museo Etnografico della Provincia di
Belluno
LVII
Fagagna (Ud), Museo di Cjase Cocèl
Galbiate (Lc), Museo Etnografico dell’Alta Brianza
Genova, Museo Castello D’Albertis
Genzano di Roma (Lt), Museo dell’Infiorata
Isili (Ca), Museo per l’Arte del Rame e del Tessuto
Itri (Lt), Museo del Brigantaggio
Latera (Vt), Museo della Terra
Latronico (Pz), Mostra Permanente del Puntino ad ago
Latronico (Pz), Museo del Termalismo
Macra (Cn), Punto Museale I Bottai
Matera, Museo Laboratorio della Civiltà Contadina e dei
Mestieri Scomparsi
Matera, Storica Casa Grotta di Vico Solitario
Monte Porzio Catone (Rm), Museo Diffuso del Vino
Montescaglioso (Mt), Museo dell’Arte Contadina
Montescudo (Rn), Museo Etnografico di Valliano
Ozzano Taro (Pr), Fondazione Museo “Ettore Guatelli”
Perugia, Collezione Etnografica “Gerardo Bamonte”
Pescarolo (Cr), Museo del Lino
Petroio (Si), Museo della Terracotta
Poggio Berni (Rn), Museo Mulino Sapignoli
Rapolano Terme (Si), Museo della Grancia
Roccagorga (Lt), EtnoMuseo Monti Lepini
Roma, Associazione Amici del Museo Nazionale
Preistorico Etnografico “L. Pigorini”
Sammichele di Bari (Ba), Museo della Civiltà Contadina
“Dino Bianco”
San Benedetto Po (Mn), Museo Civico Polironiano
San Giovanni d’Asso (Si), Museo del Tartufo
San Michele all’Adige (Tn), Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina
San Paolo Albanese (Pz), Museo della Cultura Arbëreshe
Santarcangelo di Romagna (Rn), Museo degli Usi e
Costumi della Gente di Romagna
Scicli (Rg), Museo Archeologico ed Antropologico di
Chiafura
Sezze (Lt), Museo Etnografico del Giocattolo
Taranto, Museo etnografico “Alfredo Majorano”
Torgiano (Pg), Museo del Vino
Torgiano (Pg), Museo dell’Olivo e dell’Olio
Udine, Museo Etnografico del Friuli
Vetralla (Vt), Museo della città e del territorio
Vinadio (Cn), Forte di Vinadio-Montagna in Movimento
LVIII
Vito Lattanzi
in evidenza
finalmente ratificato il profilo
professionale di demoetnoantropologo
La lunga battaglia per il riconoscimento della professionalità dei demoetnoantropologi nel Ministero per i beni
e le attività culturali – di cui abbiamo sempre dato notizia sulle pagine di questa rivista – si è finalmente chiusa
con un primo successo. Tra i profili appartenenti alla III
area funzionale che si riferiscono ai “Servizi tecnicoscientifici per la tutela, per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio”, al n. 6 è rubricata
la figura del Funzionario Demoetnoantropologo.
A questo primo successo dovrà ora far seguito l’impegno per la definizione del ruolo dei demoetnoantropologi nelle piante organiche del Ministero, cioè nei musei
nazionali e nelle soprintendenze territoriali, in modo da
assicurare ai futuri funzionari del settore Dea il legittimo
diritto al reclutamento tramite pubblici concorsi specialistici.
Inoltre bisognerà insistere per ottenere la revisione del
regolamento dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia in ordine alla sua direzione dirigenziale, imputata a uno storico dell’arte e non a un demoetnoantropologo.
Riteniamo utile pubblicare qui di seguito la declaratoria
del profilo professionale così come è stata approvata
nella contrattazione di Ministero:
“Il funzionario demoetnoantropologo svolge le prestazioni professionali proprie di tale figura, nell’ambito degli adempimenti previsti dalla normativa di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale demoetnoantropologico materiale e immateriale e delle attività culturali ad esso attinenti e dalle disposizioni di
legge relative all’organizzazione dell’Amministrazione.
Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina attività di vari settori; svolge attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per l’elevato livello
professionale, collabora ad attività specialistiche.
Individua e identifica la natura, la provenienza, le caratteristiche e la rilevanza storico-culturale dei beni demoetnoantropologici materiali ed immateriali attinenti al
patrimonio culturale demoetnoantropologico; svolge indagini e ricognizioni etnografiche nel territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo; cura la valorizzazione e
la promozione del patrimonio culturale demoetnoantropologico, con particolare attenzione alle tematiche proprie delle società multietniche e multiculturali dentro e
fuori il territorio italiano; effettua la vigilanza sui beni demoetnoantropologico ed esamina progetti di manutenzione, di salvaguardia, di restauro, di ricerca presentati
da terzi, verificandone, anche in collaborazione con altre
professionalità, la congruità e la corretta esecuzione dei
relativi lavori; cura l’inventariazione, la catalogazione e la
documentazione – anche con supporto dei mezzi audiovisivi e informatici – di beni materiali e immateriali attinenti al patrimonio culturale demoetnoantropologico;
cura l’ordinamento e la gestione di musei e di sezioni di
musei demoetnoantropologici nazionali, europei ed extraeuropei dentro e fuori il territorio italiano; svolge attività di ricerca scientifica, studia e predispone strumenti
di programmazione, organizzazione e tutela del patrimonio culturale demoetnoantropologico, nonché metodologie e tecnologie relative a: rilevamento, documentazione e registrazione del patrimonio demoetnoantropologico, anche in riferimento al patrimonio culturale etnomusicale e narrativo di tradizione orale; conservazione,
manutenzione, consolidamento e restauro del patrimonio culturale demoetnoantropologico materiale anche in
collaborazione con diverse professionalità disciplinari;
promuove, programma, organizza e coordina manifestazioni sul patrimonio culturale demoetnoantropologico
materiale e immateriale, ivi inclusi eventi espositivi, convegni e seminari, con finalità scientifiche e divulgative;
partecipa, nel settore di competenza, ad attività connesse con prestazioni speciali attribuite all’Amministrazione nell’ambito di servizi generali, quali quelli connessi
all’attività di protezione civile; svolge le funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro; progetta e realizza
programmi educativi riferiti ai beni di competenza e i
materiali didattici ad essi attinenti, svolgendo anche attività didattica, formativa e di comunicazione relativa ai
contenuti e agli strumenti professionali specifici; dirige i
servizi educativi o la sezione didattica dei musei; controlla i contenuti culturali e scientifici delle attività educative svolte dai concessionari; cura attività editoriali e
redige pubblicazioni e testi scientifici e divulgativi, nonché i cataloghi degli eventi espositivi relativi al patrimonio culturale demoetnoantropologico”.
I Requisiti necessari e indispensabili per conseguire il profilo sono i seguenti: diploma di laurea magistrale (o di
vecchio ordinamento) coerente con la professionalità e
diploma di scuola di specializzazione o dottorato di ricerca, in materie attinenti al profilo professionale, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
[Dal Mibac]
LIX
Vito Lattanzi
in evidenza
carta nazionale del restauro
e patrimonio demoetnoantropologico
Nel mese di ottobre scorso Marisa Dalai Emiliani,
Presidente del Comitato tecnico-scientifico per i beni
storici, artistici ed etnoantropologici, ci ha informato
dell’intenzione da parte del Mibac di aggiornare la
Carta del Restauro del 1972. Sempre attenta e vicina
al nostro settore professionale e scientifico Marisa
Dalai ci ha opportunamente segnalato che nella versione della Carta di quarant’anni fa non si fa menzione del patrimonio demoetnoantropologico e
dunque ci ha invitato a produrre un primo sintetico
promemoria delle questioni connesse al trattamento
dei beni materiali e immateriali del settore di nostra
competenza con riferimento alla bozza di aggiornamento prodotta da una commissione ministeriale.
Il dato positivo registrabile nella bozza ministeriale in discussione è anzitutto lo spostamento dell’attenzione
“dall’opera d’arte prestigiosa ed eccezionale ‘per espressione figurativa’, al manufatto comune come artefatto
prodotto della cultura materiale”. Richiamando la centralità nella nozione di bene culturale quale “testimonianza materiale avente valore di civiltà” consegnataci
dalla Commissione Franceschini, si libera infatti implicitamente il riconoscimento disciplinare del restauro demoetnoantropologico.
Del resto, il fatto che le Soprintendenze abbiano inserito
nelle proprie competenze la categoria dei beni demoetnoantropologici solo dal 1998, e che ancora non possano contare su specialisti competenti per il settore, impegna a dare indicazioni puntuali in tema di restauro di
beni etnografici. Infatti, come è stato osservato, “in ambito etnografico sembrano permanere aree di terra
franca, spazi operativi, strategici e inevitabilmente anche
teorici, liberi da ogni regola o riferimenti codificati” (E.
Bellato e I. Da Deppo, Conservazione e restauro del patrimonio etnografico materiale, in http://www.regione.
veneto.it/newsletterBeniCulturali).
Il bene culturale materiale, d’altra parte, non appartiene
a una disciplina particolare se non nel momento in cui
questa lo riconosce come motivo d’interesse al quale applicare le proprie categorie. Ogni definizione d’ambito
disciplinare si presenta come una costruzione strettamente relativa ai caratteri del valore documentario che
ogni disciplina privilegia.
L’oggetto etnografico ha sicuramente uno statuto differente dagli oggetti e dai documenti che per il loro valore
artistico, funzionale o formale ricadono nell’interesse di
ambiti disciplinari diversi dall’antropologia. Esso non ha
senso in sé e per sé, ma guadagna significato in quanto
testimonianza della “cultura materiale” di una data collettività (l’oggetto è espressione di relazioni) e per il fatto
che condensa “pratiche e saperi (sia nella realizzazione
come nell’uso) che sono espressione di una biografia che
l’associa ad una località/comunità e a un individuo/
gruppo” (M.Turci, “La conservazione dell’oggetto in etnografia fra inalterabilità e ripristino. Una questione di
leggibilità, ma per chi e per cosa?”, in Conservazione e
restauro nei musei etnografici Lombardi, Atti del convegno di Pescarolo, 24 aprile 2010, a cura di Fabrizio
Merisi, in corso di pubbl.).
Gli oggetti etnografici non possono essere trattati dunque come cose inerti, ma occorre tener sempre conto
della loro natura simbolica, nel senso che hanno una relazione con la vita delle persone che abitano il contesto
dove sono stati prelevati.
Se l’approccio etnografico privilegia la biografia degli
oggetti, cioè il loro valore “testimoniale”, va da sé che
anche gli interventi di conservazione e di restauro, o più
correttamente di manutenzione, mantengano la leggibilità di quella “testimonialità”, cioè rispettino le modifiche, le manutenzioni, i segni d’usura o di riutilizzo, le
vernici parziali o integrali, le asportazioni, gli inserimenti,
ecc., che fanno la vita stessa dell’oggetto e dunque la
sua propria “unicità”. Non si tratta di riportare l’oggetto
alla “purezza” del suo stato compositivo originario
(forma, colore, ecc.), ma di restituire all’oggetto la sua
biografia sociale (Turci, cit.).
È in questa prospettiva che acquista pregnanza il passaggio contenuto nel documento di aggiornamento della
Carta dove si afferma che “all’esaltazione del valore artistico e al riconoscimento estetico d’eccellenza” di un
bene culturale si sia oggi sostituito “il valore documentario storico-antropologico dell’opera come prodotto
dalle società che si sono succedute nel tempo”, un’affermazione che tra l’altro accoglie pienamente il senso di
processualità che le scienze sociali e storiche, e l’antropologia in particolare, assegnano alla nozione di patrimonio culturale.
Una diretta conseguenza della specificità dell’approccio
etnografico anche nel campo del restauro è che se in
ogni artefatto si condensano sia strumentalità sia espressività e saperi, ogni oggetto materiale, in quanto tratto
di cultura, implica una sua dimensione immateriale.
Sottovalutare questo aspetto significa precludersi la pos-
LX
sibilità di salvaguardare, nella manutenzione degli oggetti, la “voce” implicita nella loro “testimonialità”.
Per questo piace ai demoetnoantropologi parlare di “restauro dialogico”, una pratica che implica il coinvolgimento diretto delle comunità locali o native nelle azioni
di salvaguardia, in modo da mediare gli interventi di conservazione o di manutenzione e restituire agli oggetti la
loro forza simbolica (Cfr. P. Clemente, “Il restauro come
artigianato dialogico”, in Conservazione e restauro nei
musei etnografici Lombardi, cit.).
Nel caso degli oggetti rituali, per esempio, in molti musei etnografici stranieri questo coinvolgimento permette
di non trascurarne la carica “spirituale” e la funzione
“sacrale”.
Alcune recenti esperienze straniere (penso al lavoro dei
conservatori del National Museum of American Indian di
Washington) si sono rivelate estrememente fertili, sia sul
piano della collaborazione istituzionale attivata sia su
quello delle soluzioni conservative adottate (rimozione e
rifacimento di parti danneggiate dei reperti con relativa
ritualizzazione delle nuove manifatture native). Le schede
conservative stesse si sono arricchite di dati etnografici
rilevanti sui processi di rifacimento, ripristino di parti
mancanti o di ricomposizione, e la dimensione immateriale dell’oggetto è così entrata di fatto a far parte del
patrimonio culturale custodito nel museo (cfr. M.
Kaminitz: Conservation and the local voice, relazione
presentata al workshop internazionale RIME: “Object
Categories: From First Encounters to Modern Practices”,
Leiden, 23-24 ottobre 2009).
Parlare di beni immateriali e del loro essere naturalmente
oggetto di una carta del restauro moderno, non ha però
solo a che fare con queste pratiche di salvaguardia partecipata, del tutto tipiche dell’attenzione specifica rivolta
agli oggetti dalle competenze demoetnoantropologiche.
Nel caso delle tradizioni orali o delle forme di espressività
popolari non si può infatti tacere dell’importanza della
conservazione e manutenzione dei supporti sui quali
sono registrate quelle tradizioni e quelle performance.
Un discorso di tipo più sperimentale può tuttavia riguardare la possibilità di applicare la categoria del restauro al
bene immateriale così come è inteso nelle raccomandazioni UNESCO e nelle convenzioni che si sono succedute
dal 1989 ad oggi, cioè dalla pubblicazione della prima
Recommendation on the Safeguarding of Traditional
Culture and Folklore (in Preserving and revitalising our
Intangible Heritage, www.unesco.org/culture/heritage)
cui hanno fatto seguito i documenti internazionali
espressamente espressamente citati della bozza di aggiornamento della Carta, e cioè:
la Convenzione Europea sul paesaggio (2000)
la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003)
la Convenzione UNESCO per la protezione e promozione
delle diversità culturali (2005).
A questo proposito è forse proprio l’articolo 29 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, intitolato
Conservazione, ad aprire possibilità di sperimentazione
di pratiche inedite: “La conservazione del patrimonio
culturale è assicurata mediante la coerente, coordinata e
programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”.
Quando si parla di beni immateriali il senso comune induce a interpretare alla lettera quella che A. M. Cirese ha
definito “volatilità”, cioè il loro valore effimero e non ripetibile. Per cui tutelare, salvaguardare, conservare,
sembrerebbero azioni inapplicabili a tale categoria di
beni. Come ci avverte P. Clemente, “mica si conserva la
vita, non è mica come un quadro, non è mica come un
mobile, come una casa”.
Al di là del senso comune, bisognerebbe tuttavia riflettere “sulla ricchezza delle forme della diversità espressiva
e pensarla non solo in rapporto con la libertà di parola o
di arte, ma con la libertà di far vivere un dialetto parlato
da 25 persone, o una forma di rappresentazione” minoritaria tipo il Maggio toscano (Clemente, cit.).
Tornando alle proposte di aggiornamento della Carta, è
dunque del tutto condivisibile sia “l’allargamento dell’attenzione dall’oggetto puntuale emergente (il
Monumento) al suo contesto di appartenenza e di riferimento e quindi al territorio storico col quale l’opera
interagisce”, sia il porre “l’accento sulla progettualità e
sulle caratteristiche qualitative dell’intervento”, soprattutto con riferimento alle considerazioni svolte in questa
breve e non esaustiva nota.
E decisamente opportuno appare il suggerimento di sostituire “espressioni figurative delle culture popolari”
con “prodotti delle culture popolari”, anche se, a voler
essere più puntuali sarebbe senz’altro più corretto dire:
“prodotti delle culture di interesse demoetnoantropologico”, in modo da includere anche i prodotti delle culture extraeuropee.
LXI
Angela Cicirelli e Ciriaca Coretti
in evidenza
è nata SimbdeaLab
SimbdeaLab è una Società Cooperativa idealmente e concretamente collegata alla SIMBDEA, la Società Italiana per la
Museografia e i Beni Demoetnoantropologici, della cui consulenza scientifica ufficialmente si avvale. Istituita nel 2010,
essa non ha scopo di lucro e opera nel campo della museografia e, più in generale, delle discipline demoetnoantropologiche applicate ai patrimoni culturali, materiali e immateriali. SimbdeaLab ha sede legale nella città di Matera ed è attiva principalmente in Puglia e Basilicata.
L’idea di costituire una cooperativa nasce da un percorso di
studi comune alla maggior parte dei soci che hanno deciso
così di mettere in pratica i saperi acquisiti durante la propria
formazione universitaria e di ufficializzare le proprie competenze in campo lavorativo attraverso la forma giuridica della
Cooperativa al fine di valutare le eventuali opportunità di lavoro nel campo dei beni DEA.
Al nucleo originario, composto da alcuni studenti dell’Università degli studi della Basilicata che hanno avuto, grazie a
uno stage formativo, l’occasione di partecipare insieme al riallestimento del Museo Etnografico dell’Alta Murgia di
Altamura, sotto la guida di Ferdinando Mirizzi, si sono aggiunte professionalità già consolidate nel mondo del lavoro.
La cooperativa può vantare infatti la presenza di competenze
specifiche nei settori della ricerca etnografica, della storia
delle tradizioni popolari e della cultura materiale, dell’etnomusicologia e dei patrimoni immateriali, oltre che nel campo
dell’editoria scientifica, della grafica e della comunicazione
visiva. I soci della cooperativa hanno inoltre individualmente
diverse collaborazioni e docenze sia con soggetti pubblici
che privati, attività di studio e ricerca in Italia e all’estero, e
hanno inoltre all’attivo pubblicazioni su riviste specializzate e
monografie di carattere antropologico.
SimbdeaLab si propone come luogo di riflessione sui beni
DEA, sui musei e sugli ecomusei quale fenomeni d’espressione, d’incontro, di produzione culturale, di comunicazione,
di educazione e di tutto quanto tende alla conoscenza, alla
tutela e alla valorizzazione. Essa intende offrire servizi di consulenza scientifica nel campo dell’antropologia museale e
dei patrimoni culturali con particolare riferimento all’archiviazione e alla catalogazione di beni demoetnoantropologici,
alla formazione, all’educazione interculturale e alla didattica
museale.
Tra i primi incarichi che hanno visto protagonista SimbdeaLab,
particolarmente significativa è stata la partecipazione all’organizzazione del congresso della Simbdea sul tema Essere
Contemporanei. Musei, patrimonio, antropologia, che soprattutto ha dato la possibilità ai soci della cooperativa di
ampliare le proprie competenze e instaurare nuovi rapporti
di tipo umano e professionale.
In aggiunta ai compiti di tipo strettamente organizzativo,
SimbdeaLab ha partecipato attivamente ad alcune tra le iniziative previste dal congresso, tra cui la Mostra di installazioni etnografiche del contemporaneo, a cui essa ha contribuito con una installazione dal titolo Il sogno della Sposa. Il
carattere sociale ed economico del matrimonio tra tradizione
e compromesso, e la sezione I Musei si raccontano, con i poster relativi al Museo Etnografico dell’Alta Murgia e quello
relativo al Museo del Termalismo di Latronico, per il cui allestimento la cooperativa ha ricevuto dall’Amministrazione
Comunale un formale incarico.
Tra le altre iniziative condotte, si può citare anche la collaborazione, nell’attività di segreteria e promozione, con l’associazione culturale Altrosud ai fini dell’iniziativa di presentazione del progetto per l’istituzione dell’Archivio Sonoro
Basilicata, che è destinato a raccogliere documenti rappresentativi delle tradizioni musicali lucane, facilitandone la consultazione a studiosi, appassionati e musicisti. Sono inoltre in
corso le partnership con i gruppi informali DEAlab nell’ambito del progetto Adottiamo il Museo e Donne delle vie del
Pane, candidati al bando di concorso Principi Attivi 2010
bandito dalla Regione Puglia.
www.simbdealab.net SOCI FONDATORI: Angela Cicirelli,
Giuseppe Colonna, Ciriaca Coretti, Sandra Ferracuti, Andrea
Giordano, Antonella Iacovino, Michele Iannuzzi, Mariana
Malvaso, Stefania Martinese, Vita Picerno, Vita Santoro,
Maria Simone, Maria Carmela Stella, Amalia Rosa Trivisani.