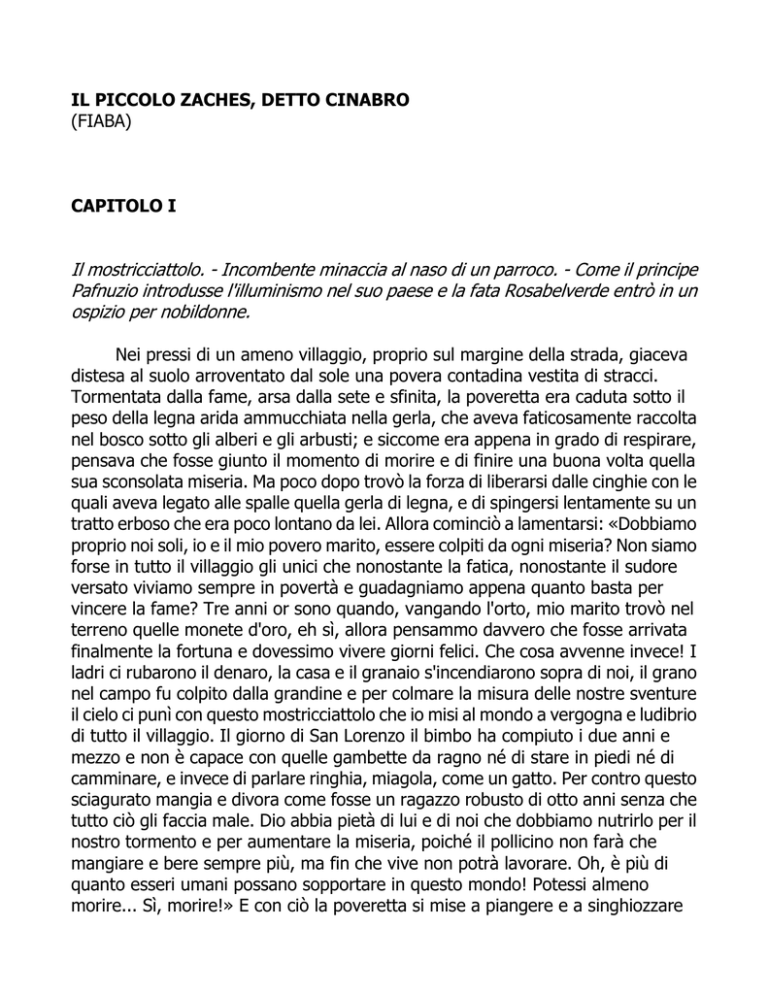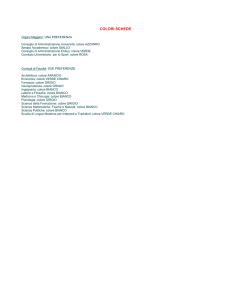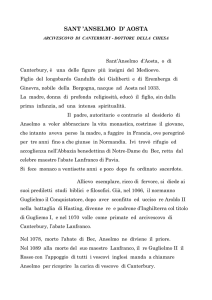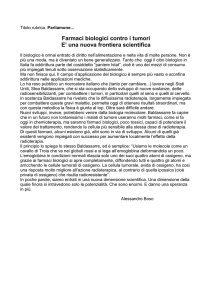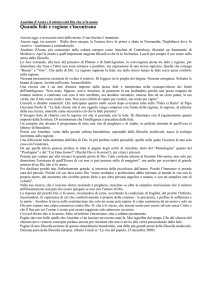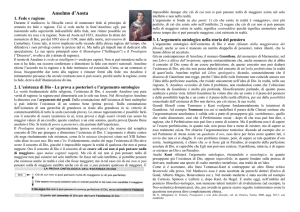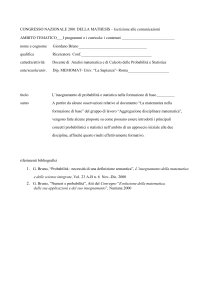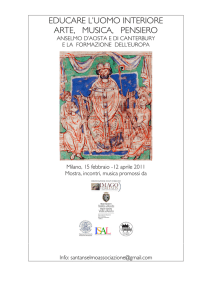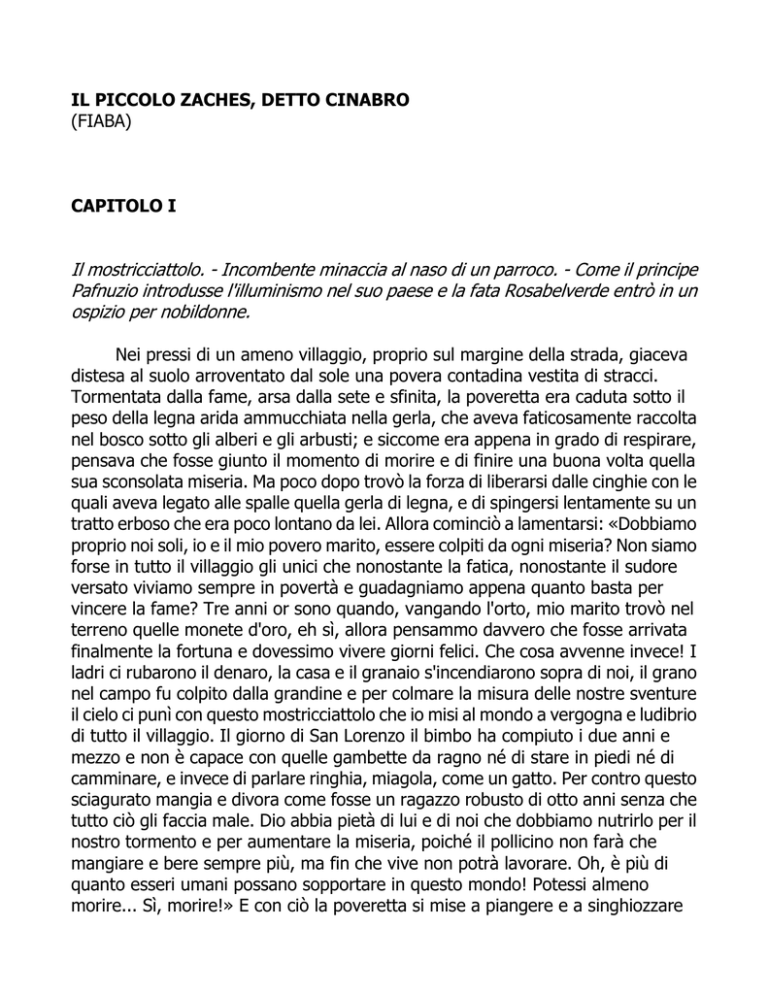
IL PICCOLO ZACHES, DETTO CINABRO
(FIABA)
CAPITOLO I
Il mostricciattolo. - Incombente minaccia al naso di un parroco. - Come il principe
Pafnuzio introdusse l'illuminismo nel suo paese e la fata Rosabelverde entrò in un
ospizio per nobildonne.
Nei pressi di un ameno villaggio, proprio sul margine della strada, giaceva
distesa al suolo arroventato dal sole una povera contadina vestita di stracci.
Tormentata dalla fame, arsa dalla sete e sfinita, la poveretta era caduta sotto il
peso della legna arida ammucchiata nella gerla, che aveva faticosamente raccolta
nel bosco sotto gli alberi e gli arbusti; e siccome era appena in grado di respirare,
pensava che fosse giunto il momento di morire e di finire una buona volta quella
sua sconsolata miseria. Ma poco dopo trovò la forza di liberarsi dalle cinghie con le
quali aveva legato alle spalle quella gerla di legna, e di spingersi lentamente su un
tratto erboso che era poco lontano da lei. Allora cominciò a lamentarsi: «Dobbiamo
proprio noi soli, io e il mio povero marito, essere colpiti da ogni miseria? Non siamo
forse in tutto il villaggio gli unici che nonostante la fatica, nonostante il sudore
versato viviamo sempre in povertà e guadagniamo appena quanto basta per
vincere la fame? Tre anni or sono quando, vangando l'orto, mio marito trovò nel
terreno quelle monete d'oro, eh sì, allora pensammo davvero che fosse arrivata
finalmente la fortuna e dovessimo vivere giorni felici. Che cosa avvenne invece! I
ladri ci rubarono il denaro, la casa e il granaio s'incendiarono sopra di noi, il grano
nel campo fu colpito dalla grandine e per colmare la misura delle nostre sventure
il cielo ci punì con questo mostricciattolo che io misi al mondo a vergogna e ludibrio
di tutto il villaggio. Il giorno di San Lorenzo il bimbo ha compiuto i due anni e
mezzo e non è capace con quelle gambette da ragno né di stare in piedi né di
camminare, e invece di parlare ringhia, miagola, come un gatto. Per contro questo
sciagurato mangia e divora come fosse un ragazzo robusto di otto anni senza che
tutto ciò gli faccia male. Dio abbia pietà di lui e di noi che dobbiamo nutrirlo per il
nostro tormento e per aumentare la miseria, poiché il pollicino non farà che
mangiare e bere sempre più, ma fin che vive non potrà lavorare. Oh, è più di
quanto esseri umani possano sopportare in questo mondo! Potessi almeno
morire... Sì, morire!» E con ciò la poveretta si mise a piangere e a singhiozzare
finché sopraffatta dal dolore e priva di forze si addormentò.
Era giusto che la donna si lagnasse del ributtante mostricciattolo che aveva
messo al mondo due anni e mezzo prima. Infatti quello che alla prima occhiata si
poteva benissimo prendere per un pezzo di legno stranamente bitorzoluto era un
bimbo deforme, alto appena due spanne, il quale, uscito strisciando dalla gerla
nella quale era stato messo per traverso, si avvoltolava ora miagolando nell'erba.
La sua testa era affondata tra le spalle, al posto della schiena aveva
un'escrescenza simile a una zucca e immediatamente sotto il petto gli pendevano
due gambette sottili come verghe di nocciolo di maniera che nell'insieme pareva
un ramolaccio spaccato in due. Del viso un occhio debole non avrebbe potuto
scoprire gran che, ma guardando con maggiore attenzione si vedeva un nasone
appuntito che sbucava da un groviglio di capelli neri e un paio di occhietti scuri
scintillanti i quali, tra quei lineamenti da vecchio e rugosi, sembrava che
rivelassero un piccolo gnomo.
Mentre, come abbiamo detto, la donna vinta dalla pena si era addormentata
profondamente e il figlioletto le si era avvicinato strisciando, avvenne che passasse
di lì la signorina Rosabella, una dama del vicino ospizio, che ritornava da una
passeggiata. Quella si fermò e, siccome era di indole pia e caritatevole, si
commosse alla vista di tanta miseria. «Oh cielo che ami la giustizia,» cominciò a
dire, «quanto dolore e quanta miseria ci sono ancora su questa terra! Questa
povera infelice, so bene che non possiede altro che la vita, lavora al di là delle sue
forze ed è caduta qui per la fame e il dolore. Come sento anch'io proprio ora la mia
povertà e impotenza! Potessi almeno aiutarla come vorrei! Ma ciò che mi è ancora
rimasto, i pochi doni che il destino avverso non ha potuto togliermi o distruggere
li voglio usare con energia e fedeltà per combattere il dolore. Il denaro, se anche
ne potessi disporre, non ti gioverebbe affatto, povera donna, ma forse
peggiorerebbe perfino le tue condizioni. A te e a tuo marito non è toccata la
ricchezza, e chi non possiede la ricchezza si vede sfuggire dalla tasca anche le
monete d'oro senza che sappia come; egli non ha che grandi dispiaceri e quanto
più denaro trova tanto più povero diventa. Ma più della povertà, più della miseria
so che il tuo cuore è tormentato dall'aver partorito questa bestiola che ti si attacca
addosso come un peso maligno, e tu lo dovrai portare per tutta la vita. Grande,
bello, forte, intelligente: tutto ciò questo bimbo non potrà diventare, ma chissà che
non si possa sostenerlo in qualche altro modo.» Così dicendo la giovane si sedette
sull'erba e prese il piccolo in grembo. Il brutto gnomo si oppose, s'impuntò, ringhiò
e fece per morderle un dito, ma lei lo calmò: «Buono, buono, maggiolino!» E gli
passò la mano leggera e carezzevole sulla testa dalla fronte alla nuca. A quelle
carezze i capelli arruffati del piccolo si lisciarono finché con una bella scriminatura
gli scesero in graziosi e morbidi riccioli sulle spalle e sulla schiena a zucca. Il bimbo
si era calmato del tutto e infine addormentato. Rosabella lo depose adagio accanto
alla madre nell'erba, lo spruzzò con un'acqua spiritosa dalla boccetta dei sali che
aveva cavato dalla tasca e sì allontanò a passi veloci.
Poco dopo la donna svegliandosi si sentì meravigliosamente ristorata e in
forze. Le pareva di aver fatto un pasto generoso e di aver bevuto un buon sorso di
vino. «Oh guarda,» esclamò, «quanta consolazione, quanto buonumore mi ha
dato questo poco di sonno. Ma il sole sta già scendendo dietro i monti e bisogna
correre a casa.» Così dicendo fece per prendere la gerla, ma non vi trovò il
bambino che in quello stesso momento si alzava dall'erba e piagnucolava. Sua
madre si volse e unendo le mani dallo stupore esclamò: «Zaches, piccolo Zaches,
chi ti ha pettinato così bene in questo frattempo? Piccolo Zaches, come ti
starebbero bene questi riccioli se tu non fossi così brutto e ripugnante! Ma vieni,
vieni, qua nella gerla!» Fece per prenderlo e metterlo di traverso sopra la legna,
ma il piccolo si mise a scalciare, fece un ghigno a sua madre e miagolò, ma in
maniera comprensibile: «No, non voglio!»
«Zaches! piccolo Zaches!» gridò la donna fuori di sé. «Chi ti ha insegnato a
parlare in questo frattempo? Be', se sei così ben pettinato, se parli con tanto
garbo, saprai anche camminare!» La donna si mise la gerla sulle spalle, il piccolo
le si attaccò al grembiule e così si avviarono verso il villaggio.
Dovevano passare davanti alla casa del parroco, ed ecco che il pastore col
suo figliolo minore, un bellissimo bambino di tre anni, dai riccioli d'oro, si trovava
appunto sulla soglia. Quando vide arrivare la donna con la pesante gerla della
legna e col piccolo Zaches aggrappato al grembiule, le andò incontro: «Buona
sera, Lisetta, come state? Vedo che avete un carico troppo pesante, non potete
quasi camminare, venite un po' qua, riposate su questa panca davanti alla mia
porta, la mia domestica vi porterà da bere.»
La donna non se lo fece dire due volte, depose la legna e stava per aprir
bocca ed esporre al reverendo tutta la sua miseria e desolazione, allorché il piccolo
Zaches al rapido volgersi della madre perdette l'equilibrio e andò a cadere davanti
ai piedi del pastore. Questi si chinò subito e sollevò il bimbo dicendo: «Oh, Lisetta,
avete proprio un bambino bellissimo e tanto carino! Possedere un bimbo così bello
e meraviglioso è una vera benedizione del cielo.» E presolo tra le braccia lo andava
accarezzando e pareva non si accorgesse nemmeno che lo sgarbato pollicino
ringhiava e miagolava cercando persino di mordere il naso al reverendo.
La donna stava sbalordita davanti al pastore e imbarazzata lo guardava con
tanto d'occhi. «Oh, signor pastore,» cominciò infine con voce piagnucolosa, «un
uomo di Dio come lei non vorrà certo farsi beffe di una povera donna che il cielo,
chissà perché, ha voluto punire con questo brutto mostricciattolo.»
«Che dite?» replicò il pastore in tono grave. «Che sciocchezze andate
dicendo, buona donna? Beffe... mostricciattolo... punizione del cielo... Non
capisco, so soltanto che dovete essere cieca se non amate con tutto il cuore il
vostro bel fanciullino. Dammi un bacio, pupetto bello!»
Il parroco accarezzò il piccolo, ma Zaches ringhiò: «No, non voglio!» E di
nuovo fece per acchiappare il naso del pastore.
«Oh che bestia!» esclamò Lisetta spaventata, ma in quel momento il
bambino del parroco cominciò a dire: «Come sei buono, caro babbo, tratti così
bene i bambini che certo ti devono voler bene tutti.»
«Avete sentito?» disse il pastore mentre gli occhi gli luccicavano dalla gioia.
«Ascoltatelo, Lisetta, il vostro piccolo Zaches, cui non volete bene. Vedo già che
per quanto sia bello e intelligente non saprete mai che farvene di questo bimbo.
Date retta, lasciatelo a me, è un bimbo di buone speranze, penserò io ad allevarlo
e educarlo. Povera come siete non potrà esservi che di peso, a me invece farà
piacere tirarlo su come il figliolo mio.»
Dallo stupore Lisetta non poteva raccapezzarsi e non faceva che dire: «Ma
caro signor pastore, caro signor pastore, dice proprio sul serio, vuole proprio
prenderselo questo mostricciattolo e educarlo e liberarmi da questo peso?» Ma
quanto più la donna faceva notare la ripugnante bruttezza della sua creatura, il
pastore asseriva con sempre maggior fervore che nella sua folle cecità lei non
meritava quella benedizione del cielo, non era degna del dono di un bimbo così
meraviglioso, finché andò in collera e preso in braccio il piccolo Zaches entrò in
casa e sbarrò la porta.
La povera Lisetta restò come impietrita davanti a quella porta senza riuscire
a rendersi conto di quanto era accaduto. «Vorrei capire,» disse quasi tra sé, «che
cosa ha preso il nostro reverendo, sembra proprio innamorato del mio Zaches e
considera questo stupidello un ragazzino grazioso e intelligente. Be', Dio l'aiuti, il
brav'uomo, mi ha levato un peso dalle spalle e se l'è caricato sulle proprie. Veda lui
come cavarsela. Uh, come si è fatta leggera la mia gerla ora che non c'è più il
piccolo Zaches e con lui la mia più grave preoccupazione!» E così dicendo Lisetta,
con la gerla sulle spalle, proseguì allegra e contenta il suo cammino.
Se in questo momento potessi ancora rinunciare a parlarne, tu benevolo,
lettore, immagineresti certamente che la storia di Rosabella, la dama dell'ospizio
che soleva anche chiamarsi Rosabelverde, deve avere un significato particolare.
Se infatti il piccolo Zaches venne considerato dal buon parroco un bimbo bello e
intelligente e accolto subito per suo, lo si dovette al misterioso effetto delle carezze
di lei su quella testolina. Ma, caro lettore, nonostante il tuo eccellente acume,
potresti fare ipotesi sbagliate o addirittura, con grave danno della storia, saltare
molte pagine per saperne subito di più sul conto della mistica dama: perciò sarà
certamente meglio che ti racconti subito tutto quello che so di questa degna
persona.
La signorina Rosabella era di statura alta, nobile, maestosa e aveva un
carattere piuttosto superbo e imperioso. Il suo viso, benché lo si dovesse definire
bello e perfetto, faceva, specialmente quando come al solito guardava davanti a sé
con grave serietà, un'impressione strana, quasi inquietante, e ciò dipendeva
soprattutto da un tratto particolarmente strano tra le sopracciglia, così strano che
veniva fatto di chiedersi se una gentildonna possa davvero portarlo in fronte così.
D'altro canto il suo sguardo, specialmente al tempo delle rose quando il cielo era
sereno, mostrava tanta grazia e benevolenza che ognuno si sentiva prendere da
un dolce irresistibile incanto. Quando io ebbi il piacere di vederla per la prima e
ultima volta era, a guardarla, nel più alto e compiuto fiore degli anni, all'apice
supremo della svolta, e pensai che mi era toccata la grande fortuna di vedere la
nobildonna appunto a quell'altezza e di rimanere, dirò così, sbalordito della sua
bellezza meravigliosa che ben presto non avrei più potuto scorgere. Ma ero in
errore. I più anziani del villaggio mi assicurarono di aver conosciuto la signorina fin
da quando avevano raggiunto l'età della ragione e di non averla mai vista diversa,
né più vecchia né più giovane, né più brutta né più bella. Sembrava dunque che il
tempo non avesse alcun potere su di lei, e questo poteva già essere motivo di
stupore. Ma c'eran anche altre cose delle quali ognuno, a pensarvi seriamente,
doveva stupirsi altrettanto, anzi non uscire affatto dalla stupefazione nella quale
sarebbe venuto a trovarsi. Anzitutto nella signorina appariva chiaramente una
parentela coi fiori dei quali portava il nome. Infatti nessuno al mondo era capace
di coltivare rose centifoglie altrettanto splendide quanto le sue; non solo, ma
persino dallo stecco più arido che lei ficcava nel terreno quei fiori sbocciavano con
estrema abbondanza e magnificenza. Poi era certo che durante le sue solitarie
passeggiate nel bosco conversava chiaramente con voci strane che pareva
venissero dagli alberi, dai cespugli, dalle sorgenti e dai ruscelli. Anzi, un giovane
cacciatore l'aveva ascoltata una volta mentre stava in una fitta boscaglia e intorno
a lei volavano singolari uccelli dalle penne lucenti e colorate che non si trovavano
in quel paese, e la accarezzavano, e col loro canto allegro e col cinguettio pareva
le raccontassero ogni sorta di cose gaie delle quali lei rideva ed era felice. Perciò
quando era entrata nell'ospizio, Rosabella aveva attirato l'attenzione di tutta la
gente del luogo. L'ordine di accoglierla nell'ospizio delle nobildonne era venuto dal
Principe. Il barone Pretestato di Lunachiara, padrone del podere nelle cui vicinanze
sorgeva l'ospizio da lui amministrato, non aveva potuto fare obiezioni benché
fosse tormentato dai dubbi più assillanti. Infatti i suoi sforzi di cercare negli elenchi
araldici e nelle cronache la famiglia Rosabelverde erano stati vani. Per questa
ragione dubitava giustamente che fosse lecito accogliere nell'ospizio quella
signorina che non era in grado di presentare un albero genealogico di trentadue
antenati, sicché alla fine, con le lacrime agli occhi, la pregò sconsolato di mutare
per carità almeno il nome, di non chiamarsi Rosabelverde, ma soltanto Rosabella
che era almeno un nome un po' ragionevole e poteva avere un antenato. Lei non
ebbe nulla in contrario.
Può darsi che la stizza dell'offeso Pretestato si sfogasse in questo modo
contro l'ignara signorina e desse la prima spinta alla maldicenza che si andò
sempre più diffondendo nel villaggio. A quelle magiche conversazioni nel bosco,
che poi non avevano alcuna consistenza, si aggiunsero infatti molte circostanze
sospette che passarono di bocca in bocca e misero in luce ambigua la vera
personalità della signorina. Mamma Anna, la moglie del sindaco, affermò
audacemente che quando la signorina starnutiva forte dalla finestra, il latte di tutto
il villaggio inacidiva. Appena questo fatto ebbe conferma ne avvenne un altro,
spaventevole. Michele, il figlio del maestro, aveva rubato nella cucina dell'ospizio
delle patate arrosto e la signorina l'aveva colto sul fatto non senza sorridere e
minacciarlo con un dito: allora il ragazzo era rimasto con la bocca aperta come se
ci tenesse di continuo una patata arrosto rovente, sicché da quel giorno dovette
portare un cappello con la visiera molto sporgente perché la pioggia non gli
entrasse nella bocca. Dopo qualche tempo parve accertato che la signorina era
capace di scongiurare il fuoco e l'acqua, di adunare le tempeste e le nuvole cariche
di grandine, di intrecciare tricomi, ecc. e nessuno mise in dubbio il racconto del
pecoraio che a mezzanotte pretendeva di aver visto con brividi di orrore la
signorina passare veloce per l'aria cavalcando una scopa tirata da un enorme
cervovolante tra le cui corna lingueggiavano fiammelle azzurre!
Ne seguì un trambusto generale, tutti davano addosso alla strega e i giudici
del villaggio deliberarono niente meno che bisognava prendere la signorina
dall'ospizio e gettarla nel fiume affinché sostenesse l'usata prova della stregoneria.
Il barone Pretestato lasciava fare e sorridendo diceva tra sé: «È la sorte degli
ingenui senza antenati, quando non discendono da famiglie come quella dei
Lunachiara.»
La signorina, informata di quel minaccioso andazzo, si rifugiò nella residenza
e poco dopo il barone ricevette un ordine sovrano dal Principe del paese col quale
gli si notificava che le streghe non esistono e gli si impartiva l'ordine di chiudere
nella torre i giudici per la loro impertinente smania di voler vedere come sapesse
nuotare una nobildonna, e di avvertire i contadini e le loro donne che non
dovevano pensar male della signorina Rosabella a scanso di sensibili pene
corporali. Essi si ravvidero per timore delle punizioni minacciate e da quel
momento pensarono bene della signorina. Cosa che per entrambi, per il villaggio e
per Rosabella, ebbe le più profittevoli conseguenze.
Nel gabinetto ministeriale del Principe si sapeva benissimo che la signorina
Rosabella non era altri che la famosa fata Rosabelverde, celebre in tutto il mondo.
Ecco come stavano le cose.
In tutto il vasto mondo non vi era certo un paese più ameno del piccolo
principato in cui si trovava il podere del barone Pretestato di Lunachiara, in cui
abitava la signorina Rosabella, in cui insomma avvenne tutto ciò che, mio caro
lettore, sto precisamente per raccontarti.
Circondata da alte montagne, quella contrada con i verdi boschi profumati,
coi prati fioriti, coi fiumi scroscianti e con le allegre fontane mormoranti
assomigliava, tanto più che non c'erano città ma soltanto piacevoli villaggi e qua e
là singoli palazzi, a un giardino meraviglioso dove gli abitanti passeggiavano come
per diporto, liberi da tutti i pesi della vita. Ognuno sapeva che il paese era
governato dal principe Demetrio, ma nessuno si accorgeva minimamente del
governo e tutti ne erano molto soddisfatti. Coloro che amavano la piena libertà
nelle loro azioni, una bella regione, un clima amabile, non potevano scegliere
soggiorno migliore di quello citato, e così avvenne che tra altri vi si erano stabilite
anche diverse ottime fate, di quelle buone che, come è noto, tengono soprattutto
al calore e alla libertà. A loro era da attribuirsi se in quasi tutti i villaggi, e
specialmente nei boschi, avvenivano molto spesso i più piacevoli miracoli e se
ognuno, circondato dall'estasi e dalla gioia di quei miracoli, credeva nei prodigi e,
senza rendersene conto, appunto per ciò era sempre un cittadino allegro e quindi
buono. Le buone fate, che di loro libera iniziativa si erano perfettamente insediate
alla ginnistana, avrebbero procurato volentieri all'ottimo Demetrio una vita
perpetua; ma questo non era in loro potere. Demetrio morì e nel governo gli
successe il giovane Pafnuzio. Costui fin da quando era vivo il padre aveva provato
un tacito rovello interiore perché, secondo lui, il popolo e lo stato erano trascurati
e abbandonati in modo deplorevole. Decise pertanto di regnare e nominò
immediatamente primo ministro del regno il suo cameriere Andrea, il quale una
volta, quando aveva dimenticato il borsellino nell'osteria al di là dei monti, gli
aveva prestato sei ducati cavandolo così da un grande impiccio. «Io voglio
regnare, mio caro!» gli disse Pafnuzio.
Andrea lesse negli occhi del padrone i pensieri che gli si agitavano dentro, gli
si gettò ai piedi e disse solennemente: «Sire, la grande ora è sonata! Con voi sta
sorgendo dal caos notturno un regno luminoso. Ecco, Sire, il vostro più fedele
vassallo che nel cuore e nella gola ha le mille voci del povero popolo infelice. Sire,
introducete l'illuminismo!»
Pafnuzio si sentì tutto scosso dal sublime pensiero dell'illuminismo. Fece
alzare il ministro, se lo strinse impetuosamente al petto e balbettò singhiozzando:
«Andrea... ministro mio... io ti devo sei ducati... più ancora, la mia felicità, il mio
regno! Oh, mio fedele intelligente servitore!» E subito stava per far stampare a
grandi lettere un manifesto e per farlo affiggere a tutte le cantonate avvertendo
che da quel momento si era introdotto l'illuminismo e tutti avevano l'obbligo di
osservarlo.
«Ottimo sire,» esclamò invece Andrea. «No, così non va.»
«E come va allora, mio caro?» domandò Pafnuzio prendendo il ministro per
un occhiello della giubba e tirandoselo dietro nella residenza della quale chiuse la
porta.
«Vede,» cominciò Andrea quando si fu accomodato su uno sgabellino
davanti al suo sovrano, «vede, mio signore, l'effetto del suo ordine sovrano a
proposito dell'illuminismo potrebbe essere forse sconciamente compromesso, se
non vi aggiungiamo una misura che potrà sembrare crudele, ma è suggerita dalla
prudenza. Prima che si proceda con l'illuminismo, prima cioè che abbattiamo i
boschi, rendiamo navigabile il fiume, coltiviamo le patate, miglioriamo le scuole dei
villaggi, piantiamo pioppi e robinie, facciamo cantare ai giovani i canti della
mattina e della sera a due voci, tracciamo strade e inoculiamo il vaccino, è
necessario espellere dallo stato tutte le persone di sentimenti pericolosi, tutti
coloro che non ascoltano la ragione e traviano il popolo con ogni sorta di
stupidaggini. Lei, ottimo principe, ha letto le ‹Mille e una notte›: so infatti che la
buon'anima del suo Serenissimo signor padre, cui il cielo voglia concedere pace e
riposo nella tomba, amava siffatti libri fatali e li metteva in mano a lei quando
giocava ancora col cavalluccio e consumava ciambelle dorate. Ebbene, mio
sovrano, da quel libro così astruso lei conoscerà certamente le così dette fate, ma
non immagina che parecchie di queste pericolose persone si sono stabilite nel suo
amato paese, proprio qui nei pressi del palazzo e ne combinano di cotte e di
crude.»
«Come? Che cosa mi vieni a dire, Andrea? Fate... qui nel mio paese?»
esclamò il principe impallidendo e appoggiandosi alla spalliera della seggiola.
«Calma, mio signore,» riprese Andrea, «possiamo starcene calmi se ci
moviamo con prudenza contro quelle nemiche dell'illuminismo. Proprio così,
nemiche dell'illuminismo le chiamo, perché soltanto loro, abusando della bontà del
suo defunto padre, soltanto loro sono colpevoli delle fitte tenebre che oscurano il
nostro diletto stato. Sono loro a esercitare il pericoloso traffico del meraviglioso, e
col nome di poesia non si peritano di diffondere un segreto veleno che rende la
gente assolutamente incapace di mettersi al servizio dell'illuminismo. E poi hanno
consuetudini così insopportabili e contrarie al regolamento della polizia che
soltanto per questo non dovrebbero essere tollerate in nessuno stato civilizzato.
Così, per esempio, quelle spudorate hanno l'impertinenza di andare a passeggio
per l'aria, quando gliene viene il capriccio, trainate da colombe, da cigni e perfino
cavalli alati. Ora io mi domando, mio signore, mette conto di studiare e introdurre
una sagace imposta sui consumi quando nello stato abbiamo persone capaci di
lanciare, pur che vogliano, merci non daziate nel camino di qualsiasi cittadino
sventato? Perciò, mio signore, non appena si annunci l'illuminismo, fuori le fate! La
polizia circondi i loro palazzi, sequestri le loro merci pericolose e le scacci come
vagabondi nella loro patria che, come lei saprà dalle ‹Mille e una notte›, è la piccola
contrada del Ginnistan.»
«Ci sono comunicazioni postali con quel paese, Andrea?» domandò il
principe.
«In questo momento no,» rispose Andrea, «ma una volta introdotto
l'illuminismo vi si potrà forse istituire utilmente un servizio giornaliero.»
«Però, Andrea,» soggiunse il principe, «non si dirà che i nostri provvedimenti
contro le fate sono crudeli? Il popolo viziato non si metterà a mormorare?»
«Anche per questo so un rimedio. Non manderemo tutte le fate al Ginnistan,
ma ne terremo qui alcune, privandole però di tutti i mezzi che possano nuocere
all'illuminismo e d'altro canto applicando tutte le misure che le possano
trasformare in utili membri dello stato illuminato. Qualora non volessero contrarre
seri matrimoni, le faremo esercitare sotto rigorosa sorveglianza qualche mestiere
utile, come fare le calze per l'esercito in tempo di guerra o qualche altra cosa. Badi
bene, mio signore, quando le fate staranno in mezzo al popolo esso ben presto
non ci crederà più, che è la cosa migliore. E così tutte le eventuali mormorazioni
cesseranno da sé. In quanto poi agli attrezzi delle fate essi verranno incamerati dal
tesoro sovrano, le colombe e i cigni diverranno un ottimo arrosto nella cucina del
principe, coi cavalli alati si potrà fare qualche tentativo di addomesticarli e di ridurli
a bestie utili tagliando loro le ali e chiudendoli nelle scuderie che spero saranno
introdotte insieme con l'illuminismo.»
Pafnuzio accettò con grande soddisfazione tutte le proposte del ministro e
già il giorno seguente le deliberazioni vennero attuate.
L'editto riguardante l'introduzione dell'illuminismo faceva bella mostra di sé
a tutte le cantonate e la polizia irruppe contemporaneamente nei palazzi delle fate,
sequestrò tutta la loro proprietà e le fece prigioniere.
Sa il cielo come fu che la fata Rosabelverde fosse l'unica fra tutte ad aver
sentore dell'introduzione dell'illuminismo alcune ore prima e a sfruttare quei
momenti per liberare i suoi cigni e mettere da parte i rosai magici ed altri oggetti
preziosi. Sapeva anche di essere tra le prescelte a rimanere nel paese, decisione
alla quale, sia pure a malincuore, si adattò.
In genere né Pafnuzio né Andrea riuscivano a capire perché le fate che
venivano deportate al Ginnistan manifestassero una gioia esagerata e andassero
assicurando che non tenevano affatto a quegli averi che erano costrette ad
abbandonare. «Sta' a vedere,» osservò Pafnuzio indignato, «che il Ginnistan è uno
stato molto più bello del mio e tutte se ne ridono del mio editto e del mio
illuminismo che adesso dovrà prosperare!»
Il geografo del regno insieme con lo storico furono incaricati di fare un'ampia
relazione su quel paese. Entrambi riferirono concordemente che il Ginnistan era un
paese miserabile, senza civiltà, senza illuminismo, senza erudizione, senza acacie
e vaccino, tanto che in realtà non esisteva nemmeno. Ora a un uomo o a tutto un
paese non può capitare niente di peggio che di non esistere.
Pafnuzio si sentì rassicurato.
Quando il bel boschetto fiorito nel quale sorgeva il palazzo abbandonato
dalla fata Rosabelverde fu abbattuto e quando Pafnuzio stesso ebbe inoculato il
vaccino a tutti i bifolchi del vicino villaggio, la fata fece la posta al principe nel
bosco attraverso il quale egli doveva ritornare al castello insieme col suo ministro.
Con una quantità di discorsi, ma soprattutto con alcuni trucchi inquietanti che ella
aveva salvato dalla polizia lo mise talmente alle strette da indurlo a pregarla per
amor del cielo di accontentarsi di un posto nell'unico e perciò migliore ospizio di
nobildonne che ci fosse nel paese, dove senza curarsi dell'editto sovrano poteva
fare a volontà il bello e il brutto tempo.
La fata accettò la proposta ed entrò in questo modo nell'ospizio dove, come
abbiamo già narrato, si chiamò signorina Rosabelverde, ma poi, alle insistenti
preghiere del barone Pretestato di Lunachiara, signorina Rosabella.
CAPITOLO II
Della ignota popolazione che il dotto Tolomeo Filadelfo scoprì durante i suoi viaggi.
- L'università di Kerepes. - Come allo studente Fabiano arrivò in testa un paio di
stivaloni e il professore Mosce Terpin invitò al tè lo studente Baldassarre.
Le lettere confidenziali che il celebre erudito Tolomeo Filadelfo scrisse
durante i viaggi in lontani paesi al suo amico Rufino contengono, questo strano
passo:
«Tu sai, mio caro Rufino, che in questo mondo non temo e aborro nulla più
dei cocenti raggi del sole durante il giorno, i quali consumano le mie forze fisiche
e stancano e infiacchiscono talmente il mio spirito che tutti i pensieri mi
s'intrecciano in un quadro confuso e io mi sforzo invano di afferrare nella mia
mente una qualsiasi immagine precisa. Perciò in questa torrida stagione riposo di
solito durante il giorno e proseguo il viaggio di notte. Così anche la notte scorsa mi
trovai appunto in viaggio. Il mio vetturino nella fitta tenebra aveva smarrito la via
retta e comoda e senza volere aveva infilato la strada maestra. Nonostante però gli
urti e le scosse che mi sballottavano nella carrozza provocandomi sulla testa tanti
bernoccoli da farla rassomigliare a un sacco pieno di noci, non mi svegliai dal
sonno profondo che mi aveva preso prima di essere scaraventato da un violento
scossone fuori della carrozza sulla dura terra. Il sole mi splendeva in faccia e al di
là della barriera che trovai proprio davanti a me scorsi le alte torri di una cospicua
città. Il vetturino non faceva che lagnarsi perché non solo il timone ma anche una
delle ruote posteriori si era spezzata contro il macigno che stava nel mezzo della
strada, e di me pareva non si curasse né punto né poco. Io a mia volta, come si
addice a un saggio, trattenni la collera e mi limitai a fargli notare dolcemente che
era un dannato villanzone e doveva pur considerare che Tolomeo Filadelfo, il più
celebre dotto dell'epoca, aveva battuto in terra il deretano, e poteva lasciar
perdere ruota e timone. Tu conosci, caro Rufino, il potere che esercito sul cuore
umano: infatti il vetturino smise immediatamente di lamentarsi e, aiutato
dall'esattore del villaggio, davanti al cui casello era accaduto l'incidente, mi rimise
in piedi. Per fortuna non avevo riportato danni sensibili e fui in grado di proseguire
lentamente per la strada, mentre il vetturino si trascinava dietro con grande fatica
la carrozza infortunata.
«Poco lontano dalla porta della città che avevo visto nell'azzurra lontananza
incontrammo una folla di persone dall'aria così curiosa e dall'abito così originale
che mi fregai gli occhi per capire se ero veramente desto o un sogno matto e
burlone non mi avesse trasportato in un favoloso e strano paese. Quelle persone
che giustamente potevo considerare abitanti della città dalla cui porta li vedevo
uscire portavano i calzoni lunghi molto larghi, dal taglio giapponese, di stoffa fine,
velluto liscio, velluto a costoline, panno pregiato, e credo anche tela a ricami
colorati, con abbondanti guarnizioni di galloni, nastri, alamari, e gonnelline da
bambini che coprivano appena il ventre, per lo più di colore chiarissimo; pochi
soltanto erano vestiti di nero. I loro capelli spettinati ricadevano incolti sulle spalle
e sulla schiena, e uno strano berrettino copriva la testa. Alcuni avevano il collo
scoperto alla maniera dei turchi e dei greci moderni, altri invece portavano intorno
al collo e al petto un pezzo di tela bianca, quasi simile a un colletto di camicia
come, caro Rufino, avrai certamente visto nei ritratti dei nostri antenati. Benché
tutte quelle persone sembrassero molto giovani, il loro linguaggio era basso e
rude, i loro gesti goffi, e qualcuno aveva un'ombreggiatura sotto il naso come se
portasse i baffetti. Dalla tasca posteriore dei gonnellini sporgeva in taluni una
lunga canna dalla quale spenzolavano grandi nappe di seta. Altri avevano estratto
quella canna e a uno dei capi vi avevano applicato una testa di strana forma,
piccola, grande, qualche volta grandissima, dalla quale soffiando attraverso un
cannello appuntito riuscivano a far salire abilmente nuvole di vapore artificiale.
Altri tenevano in mano una spada larga scintillante quasi volessero muovere
contro il nemico; altri ancora portavano a tracolla o saldati sulla schiena piccoli
recipienti di cuoio o di latta. Puoi figurarti, caro Rufino, che, come cerco di
arricchire la mia erudizione osservando accuratamente ogni nuovo fenomeno, mi
fermai e fissai lo sguardo su quella strana gente. Quelli allora mi si affollarono
intorno gridando a gran voce: filisteo, filisteo! e scoppiando in grandi risate.
Questo m'indispettì poiché dimmi tu, diletto Rufino, può darsi per un grande
scienziato qualcosa di più mortificante che essere preso per un individuo di quel
popolo che molti millenni or sono fu abbattuto con una mascella d'asino? Io mi
contenni con la dignità che mi è innata e rivolsi la parola alla gente che avevo
intorno. Speravo, eh sì, di trovarmi in uno stato di gente civile e minacciai che mi
sarei rivolto alla polizia e ai tribunali per denunciare il torto che mi era fatto. Tutti
si misero a brontolare; e anche quelli che fino a quel momento non avevano
ancora mandato fumo estrassero l'apposito utensile e cominciarono a soffiarmi in
faccia dense nuvole di vapore che, come potei notare, puzzavano in modo
insopportabile e mi annebbiarono la mente. Poi lanciarono contro di me una specie
di maledizione della quale, caro Rufino, non voglio ripetere le parole, tanto erano
orrende che ci posso pensare soltanto con un brivido. Alla fine mi piantarono lì con
sonore risate di scherno e a me parve di sentir echeggiare nell'aria la parola
frustino.
«Il mio vetturino che aveva udito tutto e visto tutto si torse le mani dicendo:
Oh, caro padrone, dopo quanto è accaduto non entri per amor del cielo in questa
città! Nemmeno un cane, come si suol dire, accetterebbe da lei un pezzo di pane,
senza dire della minaccia di essere preso a bast... Non lasciai finire quel
brav'uomo, ma mi avviai con la maggior velocità consentitami verso il prossimo
villaggio. Nella solitaria cameretta dell'unica locanda del villaggio sto ora
scrivendoti tutte queste cose. Caro Rufino, fin dove mi sarà possibile cercherò
notizie intorno alla gente barbara che popola quella città. Intorno ai suoi usi e
costumi, alla sua lingua ecc., ho già appreso parecchi particolari curiosi che ti
riferirò fedelmente ecc. ecc.»
Come vedi, mio amato lettore, si può essere un grande scienziato e non
conoscere aspetti molto comuni della vita e immergersi nei più buffi sogni a
proposito di cose che tutti sanno. Tolomeo Filadelfo aveva studiato e non
conosceva neanche gli studenti, non sapeva nemmeno di trovarsi nel villaggio di
San Giacomo che, come è noto, sorge nei pressi della celebre Università di
Kerepes, allorché descriveva all'amico un avvenimento che nella sua testa si era
trasformato nella più curiosa avventura. Il buon Tolomeo si era spaventato
incontrando studenti che allegri e di buon umore andavano a spasso. Quale
spavento l'avrebbe preso se fosse arrivato un'ora prima a Kerepes e la sorte
l'avesse condotto davanti alla casa di Mosce Terpin, professore di storia naturale!
Centinaia di studenti uscendo come una fiumana da quella casa lo avrebbero
circondato disputando rumorosamente, e a quella confusione, a quel trambusto
altri sogni ancora più curiosi gli sarebbero passati per la mente.
I corsi di Mosce Terpin erano i più frequentati a Kerepes. Come abbiamo
detto, egli era professore di storia naturale, spiegava come piove e tuona e
lampeggia, perché di giorno splende il sole e di notte la luna, come e perché l'erba
cresce, ecc. in modo che anche un bambino avrebbe capito. Aveva condensato
tutta la natura in un piccolo grazioso compendio per poterla maneggiare
comodamente a volontà e ricavarne la risposta a qualsiasi domanda come da un
cassetto. Aveva anzitutto acquistato fama quando dopo numerosi esperimenti di
fisica era riuscito felicemente a scoprire che la tenebra proviene soprattutto dalla
mancanza di luce. Questo e il fatto di saper trasformare con grande abilità quegli
esperimenti di fisica in graziosi giuochi di mano o magari in divertenti ciurmerie gli
procuravano quell'incredibile affluenza.
Siccome tu, benevolo lettore, distingui uno studente molto meglio del
famoso scienziato Tolomeo Filadelfo, siccome non sei informato della sua
sognante timidezza, permetti ora che ti conduca davanti alla casa del professor
Terpin nel momento in cui termina la lezione. Uno degli studenti che escono di
corsa attira subito la tua attenzione. Tu vedi un giovanotto di bell'aspetto sui
ventitré-ventiquattro anni dai cui occhi scuri e luminosi trapela con eloquenza uno
spirito vivace e geniale. Il suo sguardo sembrerebbe quasi audace se la trasognata
tristezza che si legge sul viso pallido non coprisse come un velo quei lampi ardenti.
La sua giacca di panno nero e pregiato, guarnita di velluto, ha un taglio che ricorda
l'antica foggia tedesca con la quale ben si accordano il grazioso e candido colletto
di pizzo e il berretto di velluto posato sui bei riccioli castani. Questa foggia gli sta
particolarmente bene perché, a giudicare da tutta la persona, dal suo garbo nel
passo e dal portamento, dai lineamenti espressivi sembra davvero che appartenga
a un passato bello e costumato, e non vien certo fatto di pensare all'affettazione
che vediamo dappertutto nella meschina scimmiottatura di modelli male intesi
secondo altrettanto malintese esigenze del giorno d'oggi. Questo giovane che,
amato lettore, tanto ti piace alla prima occhiata non è altri che lo studente
Baldassarre, figlio di gente per bene e benestante, bravo, intelligente, assiduo, del
quale, lettore mio, conto di raccontarti molte cose nella curiosa storia che ho
intrapreso a scrivere.
Serio, immerso nei suoi pensieri come era suo costume, Baldassarre usciva
dal corso del professor Terpin e andava verso il portone per recarsi non già alla
sala di scherma, bensì nel grazioso boschetto che si trova a qualche centinaio di
passi da Kerepes. Il suo amico Fabiano, un bel ragazzo di aspetto gaio e di
altrettale carattere, gli corse dietro e lo raggiunse proprio sulla soglia.
«Baldassarre!» chiamò Fabiano. «Come? Vuoi andare di nuovo nel bosco e
aggirarti laggiù solo soletto come un filisteo malinconico, mentre ragazzi in gamba
si esercitano valorosamente nella nobile arte della scherma? Fammi il piacere,
Baldassarre, smettila una buona volta con coteste mattane inquietanti e riprendi a
ridere gaio e allegro come eri una volta. Vieni, andiamo a tentare un paio di assalti
e poi se vuoi proprio andartene, verrò anch'io con te.»
«Le tue intenzioni sono buone,» rispose Baldassarre, «lo so, Fabiano, e
perciò non me la voglio prendere con te se mi corri dietro e mi stai alle calcagna
come un ossesso, privandomi di piaceri dei quali non hai un'idea. Vedi, tu sei di
quelli che quando vedono uno che passeggia solitario lo prendono per matto e
malinconico e vogliono trattarlo e curarlo a modo loro, come quel cortigiano fece
col principe Amleto, il quale sentendo che quell'omino assicurava di non saper
sonare il flauto gli diede poi una memorabile lezione. A te, caro Fabiano, la voglio
risparmiare ma d'altro canto vorrei proprio pregarti di cercare un altro compagno
per la tua nobile scherma con spada e fioretto e di lasciarmi andare tranquillo per
la mia strada.»
«No, no,» esclamò Fabiano ridendo, «caro amico, così non mi scappi! Se non
vuoi venire con me alla scherma verrò io con te nel bosco. Un amico fedele ha il
dovere di portare il sereno nella tua tristezza. Vieni pure, caro Baldassarre, se non
puoi fare altrimenti.» Così dicendo prese l'amico a braccetto e si allontanò con lui
a gran passi.
Baldassarre strinse i denti corrucciato e si chiuse nel suo cupo silenzio,
mentre Fabiano gli andava raccontando ogni sorta di cose allegre. Tra queste
c'erano anche molte sciocchezze, come avviene quando si dicono cose allegre
senza interruzione.
Quando arrivarono finalmente nell'ombra fresca del bosco olezzante dove i
cespugli sussurravano nostalgici sospiri, le meravigliose melodie dei ruscelli
gorgoglianti e il canto dei volatili silvestri si diffondevano suscitando l'eco che
rispondeva loro dai monti, Baldassarre si fermò all'improvviso e allargando le
braccia quasi volesse abbracciare amorosamente alberi e cespugli, esclamò: «Oh,
adesso mi sento bene di nuovo! Quale benessere indescrivibile!»
Fabiano lo guardò un po' sbalordito come chi non riesce a capire le parole
dell'altro e non sa come le debba giudicare.
Baldassarre gli prese una mano e disse estatico: «Fratello mio, non è vero
che anche a te si apre il cuore e ora anche tu comprendi il beato mistero della
solitudine?»
«Veramente non ti capisco bene,» ribatté Fabiano, «ma se vuoi dire che una
passeggiata in questo bosco ti fa bene, sono senz'altro del tuo parere. Non vado
forse anch'io volentieri a passeggio, specialmente in buona compagnia, quando si
possono svolgere conversazioni ragionevoli e istruttive? È un vero piacere, per
esempio, fare una scampagnata col nostro professor Terpin. Quello conosce ogni
pianta, ogni erba e ne sa il nome, sa a quale classe attribuirla, è pratico dei venti
e del tempo...»
«Basta!» gridò Baldassarre. «Smetti, ti prego! Tu tocchi un tasto che mi
farebbe impazzire se non vi fosse alcun modo di evadere. Il modo in cui il
professore parla della natura mi schianta il cuore, anzi mi sento prendere da un
pauroso orrore come se vedessi quel pazzo che credendosi re e sovrano nella sua
fatua stupidaggine accarezza una bambola di stoppa fatta da lui immaginando di
abbracciare la sua sposa regale. I suoi così detti esperimenti mi sembrano una
vergognosa derisione dell'ente supremo il cui respiro ci alita incontro nella natura
e, in fondo al cuore, suscita le più sacre intuizioni. Spesso mi viene la tentazione di
fracassargli le provette, le fiale, tutte le sue carabattole, se non pensassi che la
scimmia non cessa di giocare col fuoco finché non si brucia le dita. Vedi, Fabiano,
questi sono i sentimenti che mi angosciano, che mi stringono il cuore alle lezioni di
Terpin, e capisco che allora io ti possa sembrare più triste e misantropo che mai.
Allora ho l'impressione che le case mi crollino addosso e un tremore indescrivibile
mi spinge a uscire dalla città. Qui invece la mia mente trova una calma dolce e
serena. Coricato sulle verdi zolle erbose alzo lo sguardo alla vasta azzurrità del
cielo, mentre sopra di me e sopra il bosco esultante passano le nuvole d'oro come
sogni stupendi di un mondo lontano, tutto gioia e beatitudine. Fabiano mio, allora
dal mio petto si leva uno spirito meraviglioso e io mi accorgo che dice parole
misteriose agli arbusti, agli alberi, alle onde del torrente, e non saprei descrivere la
voluttà che tutto mi pervade insieme a un'ansietà soave e mesta.»
«Ahi, ahi,» cominciò Fabiano, «ecco la vecchia canzone della tristezza e della
voluttà, con gli alberi e coi torrenti che parlano. Tutte le tue poesie riboccano di
cose simili che suonano passabilmente all'orecchio e si possono anche accettare
con vantaggio se non vi si cercasse nulla. Ma dimmi un po', mio malinconico
sognatore, se le lezioni di Mosce Terpin ti offendono e indispettiscono veramente,
perché mai corri ad ascoltarle? Perché non ne marini nessuna, e te ne stai là a
sentire muto e immobile a occhi chiusi come uno che sta sognando?»
«Non, chiedermelo!» disse Baldassarre abbassando lo sguardo. «Non farmi
questa domanda, caro amico. Un potere ignoto mi trascina ogni giorno in casa di
Terpin. Mi rendo conto del tormento che mi aspetta eppure non so resistere, c'è un
oscuro destino che mi travolge.»
«Ah, ah,» scoppiò a ridere Fabiano, «come è poetico, come è mistico e bello!
Il potere ignoto che ti trascina in casa di Mosce Terpin sta negli occhi azzurri della
bella Candida! Sappiamo tutti da un pezzo che sei innamorato cotto della graziosa
figliola del professore, e perciò tutti scusiamo le tue fantasie, la tua mattia. Così
sono sempre gli innamorati. Tu sei al primo stadio del mal d'amore e negli ultimi
anni della tua adolescenza devi adattarti alle strane buffonate dalle quali noi, io
con molti altri, siamo già passati, grazie al cielo, quando andavamo a scuola, senza
un pubblico di spettatori. Se non che, mio caro...»
Intanto Fabiano aveva preso di nuovo l'amico a braccetto e si era
incamminato. Così stavano uscendo dal folto e prendevano la strada che
attraversava il bosco. In quella Fabiano scorse in lontananza un cavallo senza
cavaliere che si avvicinava al trotto entro una nuvola di polvere. «Guarda,
guarda!» disse interrompendo il suo discorso, «dev'essere un dannato ronzino che
ha buttato di sella il cavaliere e preso poi la fuga: dobbiamo catturarlo e cercare
poi nel bosco il cavaliere.» Così dicendo si mise in mezzo alla strada.
Quando il cavallo fu più vicino parve che sui due fianchi dondolassero su e
giù due stivaloni da cavallerizzo, mentre qualcosa di nero si moveva e agitava sulla
sella. A un passo da Fabiano si udì uno stridulo prrr prrr e nel medesimo istante gli
volò intorno alla testa un paio di stivaloni, mentre uno strano cosino nero gli
ruzzolava tra i piedi. Il grande destriero si fermò di botto e allungando il collo
cominciò ad annusare il minuscolo padroncino che si avvoltolava nella polvere e in
fine si rizzò faticosamente sulle gambe. La testa del nanerottolo era affondata tra
le spalle, e con una gobba davanti e una di dietro, col busto greve e le gambette
da ragno sembrava una mela infilata su una forchetta dopo che qualcuno vi avesse
intagliato una grinta. Vedendo quel mostricciattolo in piedi davanti a sé Fabiano
scoppiò a ridere rumorosamente. Il piccolo invece si calcò sugli occhi il berrettino
che aveva raccolto da terra, e con arroganza, trapassando Fabiano con occhiate
furibonde, domandò con voce aspra e rauca: «È questa la strada per Kerepes?»
«Sì, signore,» rispose Baldassarre in tono serio e indulgente porgendo al
piccolo gli stivali che aveva raccattati. Tutti gli sforzi di quest'ultimo per infilarli
furono vani; gli andavano l'uno sull'altro ed egli si avvoltolava nella sabbia
borbottando. Baldassarre prese gli stivaloni, li mise dritti, sollevò dolcemente il
piccolo e calandolo con altrettanto garbo gli fece infilare i piedini in quelle custodie
troppo larghe e pesanti. Puntando una mano sul fianco, portandosi l'altra al
berretto, il piccolo disse con sussiego: «Grazie, signore,» e afferrò le briglie del
cavallo. Tutti i tentativi per raggiungere le staffe o arrampicarsi su quel bestione
non approdarono a nulla. Baldassarre, sempre serio e indulgente, intervenne e
sollevò il piccolo fino alle staffe. Questi prese certamente uno slancio eccessivo
poiché nel momento in cui raggiunse la sella si trovò per terra dall'altra parte.
«Troppa foga, carissimo monsieur!» disse Fabiano scoppiando in una nuova
risata.
«Monsieur un corno!» gridò il piccolo inviperito, mentre si scuoteva la
polvere dal vestito. «Sono uno studente, e se lo è anche lei, la sua maniera
codarda di ridermi in faccia è un affronto. La sfido a duello per domani a Kerepes.»
«Lampi e tuoni,» esclamò Fabiano continuando a ridere. «Ecco un ragazzo in
gamba, non gli manca il coraggio e sa le usanze studentesche.» Con queste parole
lo sollevò nonostante che scalciasse e si schermisse e lo mise sul cavallo che col
padroncino in groppa partì subito al trotto nitrendo allegramente. Fabiano si
teneva i fianchi per non soffocare dalle risa.
«È crudele,» commentò Baldassarre, «beffarsi di un uomo che la natura ha
conciato così orrendamente come quel piccolo cavaliere. Se è davvero uno
studente ti dovrai battere con lui, e alla pistola, anche se è contro le norme
accademiche, perché non saprebbe reggere né un fioretto né una spada.»
«Come la prendi sul serio, caro amico, e in che tono sinistro! Non mi è mai
passato per la mente di farmi beffe di un mostro. Ma spiegami tu: è lecito che un
simile pollicino cartilaginoso monti su un cavallo oltre il cui collo non riesce a
guardare? È lecito che infili i piedini in quegli stivaloni così maledettamente larghi?
Può portare una giubba rossa così attillata con cento alamari e nappe e mettersi
quel curioso berretto di velluto? Può prendere arie così arroganti e superbe? Può
esprimersi con voce così barbara e rauca? Gli è lecito tutto ciò, domando, senza
che se ne debba giustamente ridere?... Ma ora devo tornare in città, voglio vedere
il fracasso che susciterà questo studente su tanto destriero. Tanto, con te non si
viene a capo di nulla oggi. Addio!» E Fabiano attraversò il bosco ritornando di filato
in città.
Baldassarre abbandonò la strada maestra e s'inoltrò tra i cespugli più fitti
dove si sedette su un po' di musco, preso, anzi sopraffatto dai più amari
sentimenti. Poteva ben darsi che amasse davvero la dolce Candida, ma aveva
nascosto a tutti, perfino a se stesso, quell'amore come un profondo delicato
segreto nell'intimo del suo cuore. Ora udendo Fabiano che ne parlava apertamente
e con tanta leggerezza ebbe l'impressione che mani rozze strappassero
sfacciatamente il velo dalla sacra immagine che egli non aveva osato toccare,
come se la santa stessa dovesse prendersela con lui in eterno. Le parole di Fabiano
gli sembravano un abominevole dileggio di tutto il suo essere, dei suoi sogni più
dolci.
«Dunque,» disse al culmine della stizza, «dunque, Fabiano, mi prendi per un
bellimbusto innamorato, per uno sciocco che corre alle lezioni di Terpin per poter
stare almeno un'ora sotto il medesimo tetto della bella Candida, per un matto che
si ritira solitario nel bosco a escogitare miseri versi all'amata e a scriverli ancor più
miseramente, e sciupa gli alberi incidendo stupide cifre nella liscia corteccia, e alla
presenza della fanciulla non sa dire una parola sensata, ma non fa che sospirare e
fare smorfie piagnucolose come se soffrisse di convulsioni, e porta sul petto nudo
fiori appassiti sul seno di lei o addirittura un guanto da lei perduto, e insomma
combina mille stupidaggini puerili. E per questo, Fabiano, mi dai la baia, per
questo forse mi deridono tutti i giovanotti, per questo sono forse oggetto di beffe
insieme con tutto il mio mondo interiore. E la soave... amabile... bellissima
Candida...»
Pronunciando questo nome sentì quasi una pugnalata rovente attraversargli
il cuore. Ahimè, in quel momento una voce interna gli sussurrò chiaramente che,
sì, andava in casa di Mosce Terpin proprio per Candida, e scriveva versi per la
donna amata, e incideva il suo nome nei tronchi, e alla sua presenza ammutoliva,
sospirava, gemeva, e portava sul petto fiori appassiti da lei posseduti, e infine
commetteva realmente tutte le sciocchezze che Fabiano gli poteva rimproverare.
Soltanto ora si accorse che amava Candida in modo ineffabile, ma vide a un tempo
che l'amore più puro e fervido assume stranamente nella vita forme un po' fatue,
a causa della profonda ironia che la natura ha inserito in tutte le azioni umane. Qui
poteva anche aver ragione, ma certo aveva torto di andare tanto in collera per
questo. Perduti i sogni che di solito lo avvolgevano, udito nelle voci del bosco quasi
uno scherno, ritornò di corsa in città.
«Signor Baldassarre, mon cher Baldassarre!» si sentì chiamare: alzò lo
sguardo e si fermò incantato vedendo venire incontro Mosce Terpin che teneva a
braccetto la figlia Candida. Questa salutò il giovane, irrigidito come una statua, con
la serena amichevole disinvoltura che le era propria.
«Baldassarre, mon cher Baldassarre,» disse il professore, «lei è proprio il più
diligente, il più caro dei miei ascoltatori. Oh carissimo, vedo che lei ama la natura
con tutte le sue meraviglie come me che ne sono follemente innamorato!... Sarà
andato certo a erborizzare nel nostro boschetto... Ha trovato qualcosa di buono?...
Vediamo un po' di conoscerci meglio, venga a trovarmi... sarà sempre il
benvenuto. Possiamo fare esperimenti insieme. Ha già visto la mia pompa
pneumatica?... Ecco, mon cher, domani sera riunisco in casa mia un gruppo di
amici che consumeranno tè con panini imburrati e si divertiranno a conversare
allegramente... Venga ad aumentare il gruppo con la sua egregia persona... Potrà
conoscere un giovane molto simpatico che mi è stato raccomandato in modo
particolare... Bon soir, mon cher... Buona sera, carissimo... Au revoir...
arrivederci!... Verrà certo domani alla lezione, vero? Adieu, mon cher.» E senza
aspettare la risposta di Baldassarre il professore se ne andò con sua figlia.
Nel suo sbalordimento il giovane non aveva osato alzare gli occhi, ma lo
sguardo di Candida gli ardeva nel petto, il respiro di lei lo faceva tremare con intimi
e dolcissimi brividi.
Libero dalla stizza seguì con lo sguardo entusiasta la bella Candida finché la
vide scomparire sotto la pergola. Poi ritornò lentamente nel bosco per poter
sognare meglio che mai.
CAPITOLO III
Come Fabiano non seppe che cosa dire. - Candida e le giovani che non debbono
mangiar pesce. - Il tè letterario di Mosce Terpin. - Il giovane principe.
Mentre infilava la scorciatoia del bosco, Fabiano pensava di poter prevenire
quello strano nanerottolo che era trottato via prima di lui. Ma sbagliava perché
uscendo di tra gli arbusti vide che lontano lontano un altro, ma formoso, cavaliere
si era aggiunto al piccolo ed entrambi entravano dalla porta di Kerepes. «Uhm,»
disse Fabiano tra sé, «se quello schiaccianoci è arrivato prima di me con
quell'enorme cavallo, giungo però abbastanza in tempo per assistere allo
spettacolo del suo arrivo. Se quello strano coso è davvero uno studente, gli
indicheranno la locanda del Cavallo alato, e quando egli si fermerà con lo strillante
prrr prrr e butterà all'aria gli stivaloni e se stesso, facendo l'arrogante alle risate dei
giovanotti, ebbene la farsa non mancherà.»
Giunto in città, Fabiano contava di incontrare per le vie, per la strada del
Cavallo alato, tutte facce ridenti. Niente di tutto questo. La gente passava seria e
tranquilla. Altrettanto seri passeggiavano alcuni universitari nella piazzetta davanti
alla locanda, intenti a discorrere tra loro. Fabiano, convinto che il piccolo doveva
essere arrivato là, notò gettando uno sguardo attraverso il portone della locanda
che in quel momento il cavallo ben riconoscibile del nano era condotto alla stalla.
Si rivolse ora al primo dei suoi conoscenti e gli domandò se aveva visto arrivare al
trotto un nano molto curioso. L'interrogato non ne sapeva nulla, come nulla
sapevano gli altri ai quali Fabiano raccontò quanto gli era capitato con quel
pollicino che pretendeva di essere uno studente. Tutti risero ma assicurarono che
un coso di quel genere non era certo arrivato. Vero è che dieci minuti prima erano
scesi alla locanda del Cavallo alato due bei cavalieri su magnifici cavalli.
«Uno di quelli stava forse in sella al cavallo che in questo momento hanno
condotto alla stalla?» domandò Fabiano.
«Sì, certo,» rispose uno di loro. «Quel cavaliere era di statura un po' piccola,
ma ben fatto, aveva un viso piacente e i più bei capelli ricciuti che si possano
immaginare. Doveva anche essere cavaliere esperto perché scese da cavallo con
uno slancio, con una agilità, con una grazia da far invidia al primo stalliere del
nostro sovrano.»
«E non perdette gli stivaloni, non ruzzolò ai vostri piedi?»
«Mai più,» risposero tutti insieme. «Dio guardi! Che ti passa per la mente,
fratello? Un cavaliere di quella forza!»
Fabiano non seppe che cosa dire. Vedendo poi arrivare Baldassarre lo investì
e prese a riferirgli come il nano che avevano visto fuori porta ruzzolare da cavallo
fosse arrivato un momento prima e tutti lo considerassero un bell'uomo, di
grazioso aspetto e un eccellente cavalcatore.
«Vedi,» disse Baldassarre serio e tranquillo, «vedi dunque, caro Fabiano,
che non tutti si mettono a beffeggiare spietatamente un infelice, conciato male
dalla natura...»
«Ma, Dio buono,» lo interruppe Fabiano, «qui non si tratta di beffe e
crudeltà, si tratta soltanto di vedere se un nano alto tre spanne, non dissimile da
un ramolaccio, si possa definire bello e grazioso.»
Baldassarre dovette confermare le parole di Fabiano intorno alla statura e
all'aspetto del minuscolo studente. Gli altri invece assicurarono che il piccolo
cavaliere era un uomo bello e grazioso, mentre Fabiano e Baldassarre andavano
ripetendo di non aver mai visto un pollicino più ripugnante. Non potendo venire a
un accordo tutti si separarono stupefatti.
Scese la sera e gli amici si recarono insieme a casa loro. In quella Baldassarre
si lasciò sfuggire, nemmeno lui sapeva come, di aver incontrato il professore
Mosce Terpin, il quale l'aveva invitato per la sera seguente.
«Oh, beato te,» disse Fabiano, «sei proprio fortunato! Avrai occasione di
vedere la tua bella, di ascoltare la graziosa Candida e parlare con lei.»
Baldassarre, ancora vivamente offeso, si staccò da Fabiano e fece per
allontanarsi. Ma poi cambiò idea, ristette e vincendo energicamente il proprio
dispetto osservò: «Avrai anche ragione, caro fratello, di considerarmi uno sciocco
innamorato. Forse lo sono davvero. Ma questa stoltezza è una ferita profonda e
dolorosa che porto nell'animo e, toccata incautamente, potrebbe per il dolore
violento spingermi a qualunque follia. Perciò, fratello mio, se mi vuoi bene
veramente, non pronunciare mai più il nome di Candida!»
«Ecco,» replicò Fabiano, «ecco, caro amico, di nuovo prendi la cosa sul
tragico. D'altro canto nelle tue condizioni non ci si può attendere altro. Ma per non
venire a un odioso litigio ti prometto che il nome di Candida non uscirà dalle mie
labbra prima che tu stesso non me ne dia l'occasione. Oggi però mi permetto di
dirti ancora che prevedo un mucchio di noie in conseguenza del tuo
innamoramento. Candida è una ragazzina molto bella, ma non s'intona affatto al
tuo carattere sognante e melanconico. Quando la conoscerai meglio, la sua natura
serena e disinvolta ti sembrerà priva di quella poesia che non riesci a trovare in
nessun luogo. Ti perderai in un mondo di sogni strani e tutto andrà a finire a
catafascio con tremende pene immaginarie e grande disperazione. D'altro canto
anch'io sono invitato come te per domani dal professore che ci divertirà con
bellissimi esperimenti. Buona notte dunque, sognatore favoloso. Dormi se sei
capace di dormire prima di una giornata così importante!»
E così Fabiano lasciò l'amico immerso in profondi pensieri. Probabilmente
prevedeva, non senza motivo, momenti patetici e episodi infelici che potevano
nascere tra Candida e Baldassarre perché l'indole e il carattere di entrambi
potevano esserne la causa.
Candida, tutti lo dovevano ammettere, era una magnifica ragazza dagli occhi
luminosi che colpivano il cuore, dalle labbra rosee un po' carnose. Non saprei dire
se i suoi splendidi capelli, che soleva acconciare in trecce bizzarre e fantastiche,
fossero piuttosto biondi o bruni; l'ho dimenticato. Ricordo soltanto molto bene una
loro strana qualità: quanto più si guardavano tanto più diventavano scuri. Alta e
snella di statura, agile di movimenti, la ragazza, specie in ambienti gioviali, era la
grazia in persona, e a tanto fascino fisico si dimenticava volentieri che le mani e i
piedi avrebbero potuto essere un po' più piccoli e graziosi. Candida però aveva
letto il «Guglielmo Meister» di Goethe, le poesie di Schiller e «L'anello magico» di
Fouqué dimenticando quasi tutto il contenuto di queste opere; sonava
passabilmente il pianoforte, talvolta vi accompagnava persino il proprio canto;
ballava le più recenti gavotte e quadriglie e scriveva le liste del bucato con scrittura
sottile e leggibile. Volendo proprio criticare qualche cosa nella cara fanciulla,
bisogna dire che aveva la voce un po' troppo bassa, si stringeva troppo il corsetto,
gioiva troppo a lungo d'un cappello nuovo e consumava col tè troppi dolci. Vero è
che poeti esaltati trovavano anche molte altre cose da ridire nella bella Candida,
ma che cosa non pretendono costoro? Anzitutto criticano che una signorina si
esalti come una sonnambula di tutto ciò che essi lasciano trapelare, che sospiri
profondamente, che strabuzzi gli occhi, cada all'occasione in un breve deliquio o
magari diventi temporaneamente cieca, che è il grado supremo della più femminile
femminilità. La signorina deve poi cantare le canzoni del poeta secondo la melodia
che le sgorga dal cuore, ma immediatamente ammalarsene ed eventualmente
comporre versi a sua volta, ma vergognarsi se lo si viene a sapere, anche se lei
stessa consegna quei versi al poeta, scritti con tratto gentile su carta molto
profumata, ed egli poi a sua volta si ammala dall'entusiasmo (e non gli si può dar
torto). Ci sono poeti ascetici che vanno anche oltre e, contrari a ogni delicatezza
femminile, sono del parere che una fanciulla non dovrebbe ridere, mangiare e bere
e agghindarsi seguendo la moda. Costoro somigliano quasi a San Gerolamo il
quale vieta alle giovani di portare orecchini e di mangiar pesce. Secondo le
disposizioni del santo devono cibarsi soltanto di un po' di erba condita, aver
sempre fame senza sentirla, portare abiti rozzi e mal cuciti che ne nascondano la
persona, ma scegliere soprattutto una compagna che sia seria, pallida, triste e un
po' sudicia!
Candida era una creatura perfettamente serena e disinvolta cui nulla piaceva
quanto una conversazione che si svolgesse sulle ali leggere e aeree del più
innocente umorismo. Le piaceva ridere cordialmente di tutte le cose buffe, non
sospirava mai tranne quando la pioggia le guastava un'attesa passeggiata o,
nonostante ogni precauzione, una frittella le deturpava lo scialle nuovo. Ma, se
c'era davvero una ragione, ne trapelava un sentimento profondo e fervido che non
degenerava mai in scipito sentimentalismo, sicché la ragazza poteva andare
benissimo per me e per te, caro lettore, che non apparteniamo agli esaltati. Ma
poteva darsi che con Baldassarre le cose andassero diversamente. Presto però
dovremo pur vedere fino a qual punto le profezie del prosaico Fabiano fossero
giuste o sbagliate.
Che Baldassarre a causa dell'inquietudine, della sua indescrivibile dolce
ansietà non abbia potuto dormire tutta quella notte, è più che ovvio. Tutto
compreso dell'immagine della fanciulla amata si sedette a tavolino e scrisse un
discreto numero di versi garbati e armoniosi che descrivevano il suo stato d'animo
in un mistico racconto dell'amore tra l'usignolo e la rosa purpurea. Era sua
intenzione di portarli con sé al tè letterario di Mosce Terpin e di andare con essi
all'assalto del cuore indifeso di Candida, quando e come fosse possibile.
Fabiano abbozzò un sorriso allorché, secondo le intese, arrivò
all'appuntamento per prendere l'amico Baldassarre e lo trovò in ghingheri più di
quanto non fosse mai stato: si era messo un colletto dentellato coi più fini merletti
di Bruxelles e una giacca corta di velluto rasato dalle maniche con gli spacchi.
Portava stivaletti francesi dai tacchi alti e sottili e dalle frange d'argento, un
cappello inglese di castoro finissimo e guanti danesi. Così era vestito tutto alla
tedesca e l'abito gli stava appuntino, tanto più che si era fatto arricciare i capelli e
pettinare la barbetta.
Baldassarre si sentì tremare il cuore dalla gioia quando in casa di Terpin,
Candida gli andò incontro, nell'antica foggia delle ragazze tedesche, gentile, con
tutto il garbo degli sguardi e delle parole, come tutti l'avevano sempre vista.
«Gentilissima signorina!» sospirò Baldassarre dall'intimo, mentre Candida, la dolce
Candida gli porgeva di persona una tazza di tè fumante, e guardandolo con gli
occhi luminosi diceva: «Qui c'è rum e maraschino, biscotti e pan di segala, caro
signor Baldassarre, si serva a volontà!»
Ma invece di badare al rum e al maraschino, al biscotto o al pan di segala e
meno ancora di servirsi, Baldassarre nel suo entusiasmo non seppe staccare lo
sguardo, velato dalla dolorosa malinconia del più fervido amore, dalla dolce
fanciulla e andò in cerca delle parole che potessero esprimere dal profondo tutto
ciò che sentiva. In quella però il professore di estetica, un omaccione alto e
vigoroso, lo afferrò con mano robusta alle spalle, lo voltò facendogli versare più tè
di quanto non fosse consentito dalla decenza ed esclamò con voce tonante: «Caro
Luca Kranach, non ingozzi codesta acqua volgare, si rovinerà il suo stomaco
tedesco! Di là, nell'altra stanza, il nostro valoroso Mosce ha allineato una batteria
di magnifiche bottiglie del più nobile vino del Reno: andiamo a farle ballare!» e
trascinò via l'infelice giovanotto.
Dalla stanza attigua però venne loro incontro il professor Mosce, tenendo per
mano un curioso omarino e dicendo a gran voce: «Ecco, signore e signori, vi
presento un giovane dotato delle più rare qualità, al quale non sarà difficile
conquistare la vostra benevolenza, la vostra stima. È il signor Cinabro, arrivato
soltanto ieri nella nostra Università per studiare giurisprudenza.»
Fabiano e Baldassarre riconobbero alla prima occhiata il mostricciattolo che
era venuto loro incontro fuori porta cadendo poi da cavallo.
«Guarda,» mormorò Fabiano a Baldassarre, «dovrò dunque sfidare questo
mostro alla cerbottana o alla lesina da calzolaio? Certo non posso ricorrere ad altre
armi contro questo terribile avversario.»
«Vergogna,» ribatté Baldassarre. «Non ti vergogni di farti beffe d'un povero
sciancato? che, come hai udito, possiede le più rare qualità e compensa col valore
intellettuale quei pregi fisici che la natura gli ha negato.» Poi si rivolse al piccolo e
disse: «Spero, egregio signor Cinabro, che la sua caduta da cavallo non abbia
lasciato brutte conseguenze.»
Cinabro, appoggiandosi a un bastoncello che si era messo dietro, si sollevò
sulla punta dei piedi in modo da arrivare quasi alla cintola di Baldassarre, reclinò la
testa e lanciando occhiate furibonde disse con voce bassa e straziante: «Signore,
non so a che cosa alluda, non capisco... caduto da cavallo? Io cadere da cavallo?
Probabilmente lei non sa che sono il miglior cavaliere che esista, che non cado mai
da cavallo, che ho fatto la campagna da volontario nei corazzieri e a ufficiali e
soldati ho insegnato a cavalcare nel maneggio! Caduto da cavallo... Io cadere da
cavallo?» Stava per voltarsi di scatto quando il bastoncino al quale era appoggiato
scivolò via ed egli capitombolò davanti ai piedi di Baldassarre. Questi si chinò per
aiutarlo ad alzarsi e senza volere gli toccò la testa. Allora il piccolo mandò un urlo
che empì la sala facendo balzare in piedi tutti gli ospiti spaventati. Circondando
Baldassarre si domandarono in gran confusione perché Cinabro avesse gridato a
quel modo. «Non se ne abbia a male, caro signor Baldassarre,» disse il professor
Terpin, «ma il suo è stato uno scherzo un po' strano. Deve aver voluto farci
credere che qualcuno abbia pestato la coda a un gatto.»
«Gatto... gatto... via il gatto!» disse una signora debole di nervi cadendo
svenuta, e gridando «Gatto... gatto» alcuni vecchi signori che soffrivano della
medesima idiosincrasia, fuggirono all'aperto.
Candida che aveva versato sulla donna svenuta tutti i sali della sua boccetta,
sussurrò a Baldassarre: «Ma, caro signor Baldassarre, quali malanni va
combinando col suo brutto e stridulo miagolio?»
Lui non sapeva in che mondo si trovasse. Tutto acceso in viso dal dispetto e
dalla vergogna era incapace di proferir parola, incapace di dire che non era stato
lui, ma il piccolo signor Cinabro a miagolare così orribilmente.
Il professor Terpin vedendo il grave imbarazzo del giovane gli si avvicinò
gentilmente: «Via via, caro signor Baldassarre, stia calmo e tranquillo. Ho visto
tutto. Chinandosi a terra e saltellando a quattro zampe lei ha imitato benissimo un
gatto malmenato. A me piacciono di solito simili giuochi zoologici, ma qui, a un tè
letterario...»
«Egregio professore,» sbottò Baldassarre, «non sono stato io...»
«Sta bene, sta bene,» lo interruppe il professore, mentre Candida si
avvicinava. «Senti,» le disse Terpin, «consolami questo ottimo Baldassarre, è tutto
confuso della disgrazia che è capitata.»
Alla buona Candida il povero Baldassarre che le stava dinnanzi confuso e con
gli occhi bassi faceva veramente pena. Gli strinse la mano e bisbigliò con un
grazioso sorriso: «Sono però ben buffi costoro con quella gran paura dei gatti.»
Baldassarre si portò le mani di Candida alle labbra mentre lei lo guardava con
quegli occhi celesti e profondi. A lui parve di toccare il cielo col dito e non pensò più
a Cinabro né al miagolio. Passata la confusione la calma fu ristabilita. La signora
debole di nervi era seduta davanti al tè e si rimpinzava di biscotti inzuppati nel rum
assicurando che questi confortavano lo spirito minacciato da poteri ostili, di modo
che all'improvviso spavento succedeva una nostalgica speranza. Anche i due
signori anziani che di fuori si erano visti davvero capitare fra le gambe un gatto in
fuga ritornarono più tranquilli e come molti altri si sedettero al tavolo da giuoco.
Baldassarre, Fabiano, il professore di estetica e alcuni giovani andarono a
sedersi in mezzo alle donne. Intanto Cinabro aveva accostato un panchetto e con
esso era salito sul divano: ora stava seduto tra due donne e mandava intorno
occhiate lampeggianti d'orgoglio.
A Baldassarre sembrò giunto il momento buono di tirar fuori la poesia
dell'amore tra l'usignolo e la rosa purpurea. Col dovuto pudore che usa tra i giovani
poeti disse che, se non temeva di dare fastidio e disturbo, se poteva sperare nella
benevola indulgenza della rispettabile compagnia avrebbe osato leggere una
poesia, il più recente prodotto della sua musa.
Siccome le signore avevano già discusso abbastanza di tutte le novità del
luogo, siccome le ragazze avevano parlato, come era doveroso, dell'ultimo ballo in
casa del presidente e si erano perfino messe d'accordo sulla forma normale dei
cappelli più recenti, siccome gli uomini non potevano far conto di ricevere altri cibi
e bevande prima di due ore, Baldassarre fu unanimemente invitato a non privare
la compagnia di quello squisito godimento.
Egli trasse quindi il manoscritto, steso con gran cura, e cominciò a leggere.
La propria opera che effettivamente era sgorgata con vigore e piena di vita da un
vero animo di poeta lo andò entusiasmando sempre più. Il modo di recitare,
quanto mai appassionato, rivelava l'intima fiamma del cuore. Egli tremava tutto
perché il sommesso sospiro delle donne e non poche esclamazioni degli uomini:
«Splendido... bellissimo... divino...» lo persuadevano che tutti erano trascinati da
quella poesia.
Quando ebbe terminato tutti esclamarono: «Che poesia! Che pensieri!...
quanta fantasia!... Che bei versi!... Quale armonia!... Grazie, grazie, ottimo signor
Cinabro, di questo divino godimento!»
«Come? Cosa?» gridò Baldassarre. Ma nessuno gli diede retta, tutti si
precipitarono su Cinabro che sopra il sofà si gonfiava come un tacchino e
gracchiava con voce antipatica: «Prego, prego... Hanno dovuto accontentarsi... È
una inezia che io ho scritto la notte scorsa in tutta fretta.»
Ma il professore di estetica esclamò: «Bravissimo... divino Cinabro! Ecco,
amico mio, dopo di me sei il più grande poeta di questa terra. Vieni, anima bella,
che ti stringa al petto!» E così dicendo lo sollevò dal divano e si mise ad
accarezzarlo e a baciarlo.
Cinabro, invece, si comportava da vero maleducato. Tamburellava con le
gambette sulla gran pancia del professore e gracidava: «Lasciami... lasciami
andare... mi fai male, bada che ti cavo gli occhi... ti mordo il naso!»
«Ma no, no, caro amico,» replicò il professore deponendolo sul divano, «non
tanta modestia!»
Anche Terpin si era alzato dal tavolo da giuoco ed era andato a stringere le
manine di Cinabro. Ora diceva con grande serietà: «Molto bene, giovanotto. Non
troppo, anzi non abbastanza mi hanno parlato del suo genio...»
«Chi di voi,» intervenne ancora l'esteta con grande entusiasmo, «chi di voi,
ragazze, vuol premiare con un bacio la poesia del grande Cinabro che esprime il
profondo sentimento del più puro amore?»
Candida si alzò subito, si avvicinò con le guance accese all'omino,
s'inginocchiò e lo baciò sulle labbra laide e paonazze.
«Sì, sì, Cinabro,» gridò ora Baldassarre come preso da improvvisa follia, «sì,
divino Cinabro, hai scritto tu la bella poesia dell'usignolo e della rosa purpurea, a te
spetta il magnifico dono che hai ricevuto!» E preso Fabiano per un braccio lo
trascinò nella stanza attigua e lo pregò: «Fammi il piacere e guardami bene negli
occhi: poi dimmi sinceramente e chiaramente se sono lo studente Baldassarre o
magari un altro, se tu sei davvero Fabiano, se siamo nella casa di Mosce Terpin, se
stiamo sognando, se siamo istupiditi... tirami il naso o scrollami tutto perché mi
svegli da questa maledetta malia!»
Fabiano rispose: «Possibile che tu, faccia il matto così per pura gelosia, se
Candida ha baciato il piccolo? Anche tu devi riconoscere che la poesia che ha letto
è proprio eccellente.»
«Fabiano,» disse Baldassarre col più profondo stupore, «che cosa dici mai?»
«Ma sì,» continuò Fabiano, «la poesia del piccolo era bellissima e dico che il
bacio di Candida era meritato. In genere penso che quell'omino nasconda cose che
valgono più di una bella figura. Ma perfino nell'aspetto mi sembra ora meno
ripugnante di quanto non fosse da principio. Alla lettura della poesia l'interno
entusiasmo abbelliva i suoi lineamenti al punto da farmelo sembrare un giovane
ben fatto, anche se riusciva a malapena a superare l'orlo del tavolino. Dimentica la
tua inutile gelosia e fatti amico del poeta da poeta!»
«Come?» esclamò Baldassarre furibondo. «Anche amico devo farmi di quel
mostro maledetto che vorrei strangolare con queste mani?»
«Dunque,» concluse Fabiano, «non vuoi assolutamente mettere giudizio,
ma ritorniamo ora nella sala dove ci deve essere qualche novità perché odo grandi
applausi.»
Baldassarre seguì macchinalmente l'amico. Quando entrarono nella sala il
professor Terpin stava solo nel mezzo e teneva ancora in mano gli strumenti coi
quali doveva aver fatto qualche esperimento di fisica. La sua faccia rivelava un
grande stupore, mentre tutta la compagnia si era radunata intorno al piccolo
Cinabro che appoggiato al bastoncino si reggeva sulla punta dei piedi e raccoglieva
con viso superbo gli applausi che scoppiavano da tutte le parti. Tutti si volsero poi
al professore il quale fece un altro giuoco molto scherzoso. Alla fine tutti
circondarono di nuovo il nano esclamando: «Magnifico, caro signor Cinabro!»
Infine lui stesso, Mosce Terpin, gli si accostò gridando dieci volte più forte degli
altri: «Magnifico, splendido, caro signor Cinabro!»
Nella compagnia c'era anche il giovane principe Gregorio che era iscritto
all'Università. Era un uomo di bellissimo aspetto e di un comportamento così nobile
e spontaneo che l'augusta origine, la consuetudine di frequentare nobili circoli si
manifestavano chiaramente.
Questo principe Gregorio non si staccava da Cinabro e ne faceva i più ampi
elogi dichiarandolo il più grande poeta, il più abile fisico. Il gruppo formato da quei
due era certo singolare. Contro la splendida figura di Gregorio spiccava il
minuscolo omino che col naso all'aria riusciva appena a reggersi sulle gambette.
Tutte le donne li guardavano, ma non tanto il principe, quanto il piccolo che
sollevandosi sulla punta dei piedi continuava a oscillare in su e in giù come un
diavoletto cartesiano.
Terpin si avvicinò a Baldassarre e disse: «Che ne dice del mio protetto, del
mio caro Cinabro? Deve avere molte virtù nascoste e ora che lo guardo da vicino
immagino la sua vera natura. Il predicatore che lo ha allevato e raccomandato a
me parla della sua origine in tono molto misterioso. Osservi però le sue nobili
maniere, il suo comportamento disinvolto e signorile. Deve essere certo di sangue
principesco, forse addirittura figlio d'un re!»
In quel momento vennero ad annunciare che la tavola era apparecchiata.
Cinabro sgambettò verso Candida, le prese una mano con piglio maldestro e si
avviò con lei verso la sala da pranzo.
Tremante di collera il povero Baldassarre corse a casa nella notte buia, sotto
la pioggia e nel vento impetuoso.
CAPITOLO IV
Come il violinista italiano Sbiocca minacciò di gettare Cinabro nel contrabbasso e il
cancelliere Pulcher non poté arrivare agli esteri. - Di guardie daziarie e di miracoli
trattenuti per uso interno. - Baldassarre incantato dal pomo di un bastone.
Seduto su un prominente sasso muscoso nella solitudine del bosco,
Baldassarre guardava pensieroso sotto di sé dove un ruscello spumeggiante
scorreva precipitoso tra blocchi di roccia e un groviglio di sterpi. Nuvole scure
s'incalzavano nel cielo e scendevano dietro ai monti; il fruscio degli alberi e delle
acque risonava come un cupo mugolio nel quale stridevano uccelli rapaci che dal
folto tenebroso salivano nell'ampio cielo e rincorrevano la nuvolaglia fuggente.
Baldassarre aveva l'impressione di percepire nelle meravigliose voci della
foresta il lamento disperato della natura come se egli stesso dovesse affondare in
quel lamento e tutto l'essere suo fosse soltanto un senso di profondissimo e
indicibile dolore. Il cuore gli stava per scoppiare dalla tristezza e mentre dagli occhi
gli scendevano frequenti le lacrime, pareva che gli spiriti del torrente silvano
salissero verso di lui e tendessero le misere braccia per attirarlo sul fondo
dell'acqua gelida.
Ed ecco da lontano attraversò l'aria un gaio squillare di corni che entrandogli
nel petto suscitò in lui una consolante nostalgia e una dolce speranza. Si guardò
intorno mentre i corni continuavano a squillare, le ombre verdi del bosco non gli
parvero più così tristi, il frusciare del vento, il mormorio dei cespugli non più così
lamentevole.
Balzando in piedi e guardando lontano con gli occhi lucenti cominciò a dire:
«No, non è scomparsa ogni speranza. È fin troppo certo che qualche tetro mistero,
qualche maligna stregoneria è venuta a turbare la mia vita, ma io spezzerò
l'incantesimo, dovesse costarmi la vita. Quando trascinato e sopraffatto dal
sentimento che mi voleva spezzare il cuore confessai finalmente alla dolce Candida
il mio amore, non lessi forse nei suoi sguardi, non sentii nella sua stretta di mano
la mia felicità? Ma non appena quel maledetto mostro si fa vedere, tutto l'amore è
per lui. In lui, in quel dannato mostricciattolo si affisano gli occhi di Candida, i
nostalgici sospiri le escono dal petto quando quel gaglioffo le si avvicina o magari
le tocca una mano. Ci deve essere sotto qualche mistero, e se credessi nelle
sciocche fiabe per bambini, direi che quel giovane è stregato e, come si suol dire,
ammalia la gente. Non è forse incredibile che tutti si facciano beffe e ridano di
quell'omino deforme e brutto e poi appena si presenta lo proclamino il più
intelligente, il più dotto, persino il più bel studente che ci sia tra noi? Ma che dico?
Non capita quasi anche a me, non sembra talvolta anche a me che Cinabro sia
bello e intelligente? Soltanto alla presenza di Candida l'incantesimo non ha alcun
potere su di me, Cinabro è e rimane un mostricciattolo scemo e detestabile.
Eppure, oppongo resistenza al potere nemico e dentro di me c'è un oscuro
presentimento che qualche fatto inatteso mi metterà in mano l'arma contro
l'essere maligno!»
Baldassarre si avviò per ritornare a Kerepes. Camminando sotto la volta degli
alberi notò sulla strada una carrozza carica di bagagli, dalla quale una persona gli
faceva cenni amichevoli con un fazzoletto bianco. Si avvicinò e riconobbe Vincenzo
Sbiocca, il famoso virtuoso di violino che egli stimava moltissimo per l'espressione
con cui sonava, e dal quale prendeva lezione ormai da due anni. «Sono lieto,»
disse Sbiocca scendendo dalla carrozza, «lieto, mio caro Baldassarre, eletto amico
e discepolo, d'incontrarla ancora qui per poterla salutare con tutta cordialità.»
«Come?» disse Baldassarre. «Signor Sbiocca, non vorrà mica abbandonare
Kerepes, dove tutti la stimano ed onorano e nessuno la vorrebbe veder partire?»
«Sì, sì,» rispose Sbiocca mentre vampe di collera gli salivano al viso,
«abbandono un luogo dove la gente è impazzita. Par di essere in un grande
manicomio. Ieri, signor Baldassarre, lei non è venuto al mio concerto, è andato
fuori città, altrimenti avrebbe potuto assistermi contro un pubblico folle che mi ha
sconfitto.»
«Che cosa è successo mai?»
«Ecco,» continuò Sbiocca, «suono il più difficile concerto di Viotti. È il mio
orgoglio, la mia gioia. Lei lo ha sentito e ne è sempre rimasto entusiasta. Ieri,
posso ben dire, ero particolarmente in forma, di buon umore, con lo spirito alato.
Nessun violinista del mondo, neanche lo stesso Viotti, lo avrebbe eseguito così.
Quando arrivo alla fine gli applausi scoppiano furiosi, con furore, dico, come mi
aspettavo. Il mio violino sotto il braccio mi presento a ringraziare cortesemente.
Ma che cosa mi tocca di vedere, di ascoltare! Tutti senza badare a me si accalcano
in un angolo della sala e gridano: ‹Bravo, bravissimo, divino Cinabro! Quale
espressione, quale abilità!› Io corro là attraverso la folla, ed ecco un ometto
deforme, alto un palmo, che gracchia e ciangola con voce odiosa: ‹Oh, prego,
prego; ho sonato secondo le mie forze, ma è vero che sono il migliore violinista
d'Europa e di tutti gli altri continenti conosciuti.› ‹Corpo del diavolo!› mi metto a
gridare. ‹Chi ha sonato? Io o questo lombrico?› E mentre il piccolo continua a
blaterare: ‹Per carità, per carità,› faccio per lanciarmi addosso a lui con tutta la
diteggiatura. Ma gli altri mi sono addosso e vengono cianciando di invidia e
gelosia. Intanto uno grida: ‹Che composizione!› E tutti gli fanno eco a una voce:
‹Quale composizione! Divino Cinabro, compositore sublime.› Più adirato di prima
grido a mia volta: ‹Ma siete tutti matti? Il concerto era di Viotti e io l'ho sonato, io
il celebre Vincenzo Sbiocca!› Tutti mi afferrano, parlano di follia italiana, di
avvenimenti strani, e mi spingono con la forza in una stanza vicina, mi trattano da
malato, da pazzo. Poco dopo arriva di corsa la signora Bragazzi e cade svenuta. Le
era capitata la stessa disgrazia. Era appena arrivata alla fine della sua aria, allorché
la sala rintronò di ‹Bravo, bravissimo Cinabro!› Tutti gridavano che non c'era al
mondo una cantante pari a Cinabro, il quale continuava a gracidare: ‹Oh, prego,
prego...› La Bragazzi è febbricitante e ci lascerà la pelle, io mi metto in salvo
fuggendo quel pubblico impazzito. Stia bene, caro signor Baldassarre. Se per caso
vede il signorino Cinabro gli dica per favore che non si faccia vedere in nessun
concerto alla mia presenza. Altrimenti lo prendo per quelle sue gambine di
coleottero e lo scaravento attraverso l'effe nel contrabbasso dove potrà sonare e
cantare fin che vive a volontà. Addio, mio caro Baldassarre, e non abbandoni il
violino!» Così dicendo Vincenzo Sbiocca abbracciò Baldassarre impietrito dallo
stupore e montò nella carrozza che partì velocemente.
«Non ho forse ragione,» disse Baldassarre tra sé, «se quel coso stravagante,
quel Cinabro è stregato e ammalia la gente?»
In quel momento un giovane gli passò davanti di corsa, pallido e stralunato.
Gli si leggevano in viso la follia e la disperazione. Baldassarre rimase scosso perché
gli parve di ravvisare in quel giovane uno dei suoi amici. Perciò lo rincorse e dopo
venti o trenta passi vide il cancelliere Pulcher che, fermatosi sotto un grande
albero, aveva alzato gli occhi al cielo e diceva: «No, non posso sopportare questa
vergogna. Tutte le mie speranze sono fallite... Davanti a me non c'è che la
tomba... Addio vita, addio mondo, speranza, addio, mia diletta...»
Ed estratta una pistola il disgraziato se la puntò alla tempia.
Baldassarre gli fu addosso veloce come un lampo, gli tolse di mano la pistola
e gridò: «Pulcher, per carità, che cosa fai ?»
Per qualche minuto il cancelliere non poté raccapezzarsi. Era caduto sull'erba
quasi privo di sensi, Baldassarre gli si era seduto vicino e faceva del suo meglio per
consolarlo, pur ignorando la causa di tanta disperazione. Cento volte gli domandò
quale tremenda sciagura lo avesse colpito per suscitare in lui la nera idea del
suicidio. Pulcher trasse un profondo sospiro e cominciò: «Caro amico Baldassarre,
tu conosci le mie condizioni precarie, sai che ho puntato tutte le mie speranze sul
posto di segretario ora vacante presso il ministro degli esteri, tu sai con quanto
zelo, con quanta diligenza mi ci sono preparato. Avevo presentato i compiti che
con mia grande gioia incontrarono la completa approvazione del ministro. Puoi
immaginare con quanta fiducia mi presentai questa mattina agli orali. Nell'aula
trovai un individuo minuscolo, deforme, che probabilmente conosci, il signor
Cinabro. Il consigliere di legazione che era nella commissione esaminatrice mi
venne incontro gentilmente e mi disse che anche il signor Cinabro aspirava a
quello stesso posto, perciò ci avrebbe interrogati tutti e due. Poi mi sussurrò
all'orecchio: ‹Lei non ha nulla da temere da questo concorrente, mio caro
cancelliere, i lavori presentati dal piccolo Cinabro sono miserabili.› All'esame non
lasciai senza risposta nemmeno una interrogazione del consigliere. Cinabro invece
non sapeva nulla, assolutamente nulla, invece di rispondere ciancicava roba
impercettibile che nessuno capiva, un paio di volte agitando sgarbatamente le
gambette cadde dal seggiolone sicché fui costretto a sollevarlo. Il mio cuore
tremava dal piacere; gli sguardi cortesi che il consigliere gettava all'omino li
prendevo per amara ironia. Terminato l'esame non ti so dire il mio spavento, mi
parve che una folgore improvvisa mi sprofondasse parecchie tese sotto terra
perché il consigliere abbracciò quel coso dicendo: ‹Quale erudizione, quale
intelligenza, quanto acume!› E poi a me: ‹Cancelliere Pulcher, lei mi ha deluso
molto, non sa proprio niente. E, non se ne abbia a male, il modo in cui ha creduto
di poter sostenere l'esame, è contro ogni buon costume, contro ogni decenza. Non
è stato neanche capace di rimanere sulla sedia, è caduto e il signor Cinabro ha
dovuto tirarla su. Le persone diplomatiche debbono essere serie e presenti a se
stesse. La saluto, signor cancelliere.› Tutto mi pareva ancora inverosimile. Mi feci
coraggio e andai dal ministro. Quello mi mandò a dire che non era la maniera di
andarlo a seccare con la mia visita dopo la prova che avevo dato all'esame: sapeva
già tutto. Il posto per il quale avevo concorso era già assegnato al signor Cinabro.
Ecco in che modo un potere infernale mi ha tolto ogni speranza. Perciò rinuncio
spontaneamente alla vita, ormai in preda a una tenebrosa fatalità. Lasciami!»
«Mai più!» esclamò Baldassarre. «Prima mi devi ascoltare.» E gli raccontò
tutto quanto sapeva di Cinabro fin dal suo primo apparire davanti a Kerepes, e ciò
che gli era capitato nella casa di Mosce Terpin, e ciò che aveva saputo un momento
prima dal violinista Sbiocca. «È fin troppo evidente,» soggiunse, «che sotto tutte le
gesta di quel mostro sciagurato c'è qualcosa di misterioso, ma credi pure, mio caro
Pulcher, se abbiamo a che fare con un incantesimo infernale, bisogna affrontarlo
con animo risoluto, la vittoria è sicura, purché non manchi il coraggio. Perciò non
ci dobbiamo accasciare né prendere decisioni affrettate. Vediamo di muovere
insieme contro quel piccolo stregone.»
«Stregone, sì, stregone!» esclamò l'altro con grande foga. «Tale è senza
dubbio, uno stregone maledetto. Ma, Baldassarre, fratello mio, stiamo forse
sognando? Stregonerie, incantesimi: non sono forse finiti da un pezzo? Pafnuzio
Magno non ha forse introdotto l'illuminismo parecchi anni fa? Non ha espulso dal
paese queste inconcepibili follie? È forse rientrato nel paese quel maledetto
contrabbando? Cospetto, dobbiamo denunciarlo subito alla polizia e alle guardie
daziarie! Però, però, soltanto la pazzia della gente, o, temo quasi, un'enorme
corruzione ci ha messi in questi impicci. Dicono che quel dannato Cinabro è
immensamente ricco. Ultimamente si era fermato davanti alla zecca e la gente
additandolo andava dicendo: ‹Guardate il bel babbino! Quello è padrone di tutto
l'oro che si conia lì dentro.›»
«Zitto,» interloquì Baldassarre, «zitto, amico mio! Quello non la spunta con
l'oro, ma sotto ci dev'esser qualcos'altro. È vero che il principe Pafnuzio introdusse
l'illuminismo a vantaggio del suo popolo, per i suoi discendenti, ma qualcosa di
meraviglioso, di inesplicabile è rimasto ancora. Voglio dire che alcuni bei miracoli si
sono conservati, così per uso interno. Da misere sementi nascono ancora, per
esempio, alberi altissimi e stupendi e perfino i più svariati frutti e cereali dei quali
ci rimpinziamo. Anzi, ai fiori variopinti e agli insetti si permette di ornare le foglie e
le ali di colori brillanti e persino le più strane scritture che nessuno sa se siano a
olio, a tempera o ad acquerello, non c'è barba di calligrafo che sappia leggere e
meno ancora copiare quell'elegante corsivo. Vedi, cancelliere, dentro di me
avvengono talvolta cose strane. Depongo la pipa; passeggio per la stanza in su e
in giù e una strana voce mi sussurra che io stesso sono un miracolo, perché dentro
di me lavora il mago Microcosmo che mi suggerisce ogni sorta di tiri birboni. Allora
però scappo e vado a guardare la natura e capisco tutto ciò che mi dicono i fiori e
le acque, e mi pare di essere in paradiso.»
«Devi avere la febbre,» suggerì Pulcher, ma Baldassarre senza badare a lui
tese le braccia verso l'orizzonte come fosse soggiogato da una struggente
nostalgia. E disse: «Non senti? Ascolta questa musica divina che empie il bosco al
soffio del vento della sera! Senti che le sorgenti cantano con voce più forte? E gli
arbusti e i fiori vi intonano le loro belle voci?»
Pulcher stette tutto orecchi per ascoltare la musica indicata da Baldassarre.
«Infatti,» cominciò poi, «nel bosco si sentono i suoni più belli, più allettanti che io
abbia udito nella mia vita, e mi accarezzano l'anima. Ma non è il vento della sera,
non gli arbusti, non sono i fiori a cantare così, mi sembra piuttosto che qualcuno in
lontananza strofini le campane più basse di una armonica.»
Aveva ragione Pulcher: gli accordi sonori sempre più forti e sempre più vicini
assomigliavano realmente ai suoni di una armonica di vetro, la cui potenza però
doveva essere inaudita. Mentre proseguivano per la loro strada, i due amici si
trovarono davanti a uno spettacolo così fantastico che dallo stupore si fermarono
di botto. Poco lontano da loro un uomo viaggiava lentamente attraverso il bosco,
vestito quasi alla foggia cinese, salvo che portava in testa un berretto gonfio
ornato di lunghe penne. Il cocchio sembrava una conchiglia aperta di cristallo
bianco e le due grandi ruote parevano della stessa materia. Quando giravano ne
venivano quei suoni stupendi che gli amici avevano già udito da lontano. Due
unicorni bianchi come la neve, con finimenti d'oro, trainavano il cocchio sul quale
al posto del conducente c'era un fagiano argentato che reggeva col becco le redini
dorate. Dietro stava un grande coleottero d'oro che agitando le elitre luccicanti
pareva facesse fresco a quello strano individuo dentro la conchiglia. Passando
davanti ai due forestieri li salutò con un cenno cortese. Dal pomo della lunga canna
che egli teneva in mano uscì in quel momento un raggio che colpì Baldassarre
facendogli sentire una fitta bruciante in mezzo al petto, alla quale reagì con un
sospiro doloroso.
L'uomo lo guardò e sorrise ancora più cortese di prima. Quando il cocchio
magico scomparve nella macchia e ancora si udiva l'eco dolce dei suoni,
Baldassarre fuori di sé dalla gioia e dall'estasi abbracciò l'amico esclamando:
«Cancelliere, siamo salvi. Quello infrangerà il maledetto incanto di Cinabro!»
«Non so,» replicò Pulcher, «non so dire che cosa sento in questo istante:
sogno? sono desto? Certo è che un ignoto senso di voluttà mi pervade e nel mio
spirito ritornano il conforto e la speranza.»
CAPITOLO V
Come il Principe Barsanufo fece colazione con allodole di Lipsia e liquore d'oro di
Danzica, ebbe i calzoni di casimir macchiati di burro e promosse il segretario
Cinabro a speciale consigliere segreto. - I libri illustrati del dottor Prospero Alpano.
- Come un portiere morse un dito allo studente Fabiano e questi portò uno
strascico per cui fu beffeggiato. - La fuga di Baldassarre.
Non possiamo oramai nascondere che il ministro degli esteri, presso il quale
Cinabro era addetto come segretario segreto, discendeva da quel barone
Pretestato di Lunachiara che aveva cercato invano l'albero genealogico della fata
Rosabelverde negli elenchi araldici e nelle cronache. Si chiamava esattamente
come il suo avo, Pretestato di Lunachiara, ed era di una cultura raffinata, di
consuetudini piacevolissime, non scambiava mai il mio col tuo, scriveva il suo
nome con lettere francesi e sempre con calligrafia leggibile e talvolta lavorava
addirittura personalmente, specie quando faceva brutto tempo. Il principe
Barsanufo, un successore del grande Pafnuzio, gli voleva un gran bene perché
sapeva rispondere a qualsiasi domanda, giocava con lui ai birilli nelle ore di svago,
era esperto di finanze e sapeva ballare la gavotta meglio di qualunque altro.
Ora avvenne che il barone Pretestato di Lunachiara avesse invitato il principe
ad una colazione di allodole di Lipsia con un bicchierino di aureo liquore di Danzica.
Arrivato in casa di Lunachiara il principe trovò in anticamera, tra altri graditi
diplomatici, il piccolo Cinabro che sorretto dal solito bastone lo guardò con gli
occhietti scintillanti e senza curarsi di lui si mise in bocca un'allodola arrosto che
aveva sgraffignato dalla tavola. Appena lo vide il principe gli sorrise con
benevolenza e disse al ministro: «Lunachiara, che bell'omino intelligente vedo in
casa sua! È certamente quello stesso che scrive egregiamente e in ottimo stile le
relazioni che lei mi manda da qualche tempo, non è vero?»
«Certo, mio signore,» rispose Lunachiara. «La sorte ha mandato nel mio
ufficio il più spiritoso, il più abile lavoratore. Cinabro si chiama, e io raccomando
questo giovane alla sua grazia e benevolenza, mio ottimo principe. È qui soltanto
da pochi giorni.»
«E appunto perciò,» disse un bel giovane che si era avvicinato, «appunto
perciò Vostra Eccellenza mi permetterà di osservare che il mio piccolo collega non
ha scritto ancora nulla. Le relazioni che hanno avuto la fortuna di essere notate da
voi, mio serenissimo principe, con tanto compiacimento, sono opera mia.»
«Lei cosa vuole?» lo investì il principe seccato. Intanto Cinabro si era
accostato al principe e mangiando l'allodola biascicava con avido appetito.
Il giovane era stato veramente l'autore di quei rapporti, ma il principe lo
redarguì: «Che cosa vuole lei, se non ha neanche toccato la penna? E le pare
decente mangiare qui addosso a me le allodole arrosto e macchiarmi di burro i
nuovi calzoni di casimir e biascicare così? Ne sono seccato. Tutto ciò prova
abbastanza quanto lei sia inetto alla carriera diplomatica. Se ne vada a casa e non
si faccia più vedere, a meno che non voglia portarmi uno smacchiatore per i miei
calzoni. Allora potrò essere più benigno.» E a Cinabro: «Giovani come lei, caro
Cinabro, fanno onore allo stato e meritano di essere onorati; la nomino speciale
consigliere segreto.»
«Mille grazie,» disse Cinabro con voce aspra mentre inghiottiva l'ultimo
boccone e con le manine si forbiva la bocca, «farò tutto come si deve.»
«La fiducia nelle proprie forze,» sentenziò il principe alzando la voce, «è un
indizio di quella intima energia che un degno uomo di stato deve possedere.»
Dopo queste parole il principe prese con viva soddisfazione un bicchierino di
liquore di Danzica che il ministro gli porgeva.
Il nuovo consigliere dovette accomodarsi tra il principe e il ministro.
Consumò un numero incredibile di allodole, bevve Malaga e liquore d'oro
borbottando fra i denti e agitando manine e gambette, dato che riusciva a
sporgere soltanto la punta del naso sul piano della tavola.
Terminata la colazione il principe e il ministro esclamarono insieme: «È una
creatura angelica, questo speciale consigliere segreto!»
«Hai un'aria così allegra,» disse Fabiano all'amico Baldassarre, «una luce
particolare negli occhi. Sei felice? Ahimè, Baldassarre, tu forse stai facendo un bel
sogno, ma ti devo svegliare, è mio dovere di amico.»
«Che c'è, che cosa è successo?» domandò Baldassarre costernato.
«Te lo devo proprio dire,» proseguì Fabiano. «Fatti coraggio, amico mio.
Pensa che nessun infortunio colpisce forse più dolorosamente di questo, ma è
anche più facile da superare. Candida...»
«Per carità!» gridò l'altro atterrito, «Candida... che ne è di Candida?... È
forse morta?»
«Calma, calma, amico mio!» continuò Fabiano. «Non è morta, ma per te è
come se lo fosse. Devi sapere che il piccolo Cinabro è diventato speciale
consigliere segreto e, si può dire, promesso alla bella Candida che, Dio sa perché,
dicono innamoratissima di lui.» A questo punto Fabiano credeva che l'amico
sarebbe esploso in smanie disperate e in veementi maledizioni. Rispose invece con
un tranquillo sorriso: «Se non è che questo, non c'è infortunio che mi possa
rattristare.»
«Non ami più Candida?» domandò Fabiano stupefatto.
«Sì, amo quella creatura celeste,» rispose Baldassarre, «quella bellissima
fanciulla, con tutto il fervore, con l'esaltazione che può accendere il cuore d'un
giovane. E so, oh se lo so, che Candida mi riama, salvo che una dannata malia la
tiene avvinta, ma spezzerò presto le catene dello stregone, distruggerò il mostro
che seduce quella poveretta.» E raccontò ampiamente all'amico l'incontro con
quell'uomo strano nel bosco e con il suo ancora più strano veicolo. Concluse col
dire che non appena era stato colpito dal raggio magico, scattato dal pomo del
bastone, gli era balenato il pensiero che Cinabro non era se non uno stregoncello
il cui potere doveva essere distrutto da quello strano individuo.
Quando l'amico ebbe finito, Fabiano gli parlò così: «Senti, Baldassarre, come
puoi credere a tali follie? L'uomo che hai preso per un mago non è che il dottor
Prospero Alpano che abita una villa poco lontano dalla città. Vero è che di lui si
dicono le cose più meravigliose sicché verrebbe fatto di prenderlo quasi per un
secondo Cagliostro, ma la colpa è tutta sua. Gli piace circondarsi di mistiche
tenebre, di assumere la parvenza di uomo esperto dei più profondi misteri della
natura, capace di comandare a forze ignote e di concepire le più bizzarre trovate.
Il suo cocchio, per esempio, è così strano che una persona dotata, come te, di
vivace fantasia può essere trascinata a considerare tutto ciò un fenomeno preso
da una fiaba fantastica. Stammi a sentire! La sua vettura ha l'aspetto di una
conchiglia ed è tutta argentata, tra le ruote è applicato un organismo che appena
il veicolo si muove suona da solo. Quello che hai preso per un fagiano argentato
era certamente il suo fantino vestito di bianco, come devi aver preso gli spicchi del
parasole aperto per elitre di un coleottero dorato. I due cavallini bianchi portano
grandi corna applicate perché l'insieme sia più fiabesco. È vero d'altronde che il
dottor Alpano porta una bella canna d'india con un magnifico cristallo per pomo,
dei cui incredibili effetti molto si parla o meglio si mente: dicono infatti che l'occhio
può appena tollerare il lampo di quel cristallo; se il dottore lo copre con un velo
leggero e uno lo guarda fisso, dicono che l'immagine della persona alla quale si
pensa intensamente gli appare come in uno specchio concavo.»
«È vero,» lo interruppe Baldassarre. «E cosa si dice? E che altro si va dicendo
del dottor Alpano?»
«Oh, non pretendere che mi dilunghi su quelle frottole. Sai bene che
esistono ancora persone fantasiose capaci di credere, contro il lume della ragione,
nei cosiddetti miracoli delle insulse fiabe da bambini.»
«Ti confesso,» soggiunse Baldassarre, «che sono costretto a mettere anche
me nel numero di quelle persone fantasiose, prive del lume della ragione. Il legno
argentato non è un cristallo splendido e trasparente, un organino non suona come
un'armonica di vetro, un fagiano non è un fantino, né il parasole un coleottero
d'oro. Delle due l'una: o il mago che ho incontrato non è il dottore Prospero Alpano
di cui mi parli, o il dottore è realmente in possesso dei più straordinari segreti.»
«Per guarirti dei tuoi sogni fantastici la cosa migliore sarà che ti conduca
difilato dal dottor Alpano. Così tu stesso toccherai con mano che il dottore è un
comune medico e non va per niente a spasso con unicorni, fagiani argentati e
coleotteri d'oro.»
Mentre gli occhi gli brillavano, Baldassarre replicò: «Caro amico, tu stesso
esprimi il mio più intimo desiderio. Mettiamoci subito in cammino!»
Poco dopo erano davanti al cancello del parco al cui centro sorgeva la villa
del dottor Alpano.
«E ora come si fa a entrare?» domandò Fabiano.
«Direi di bussare,» rispose Baldassarre afferrando il picchiotto di metallo che
pendeva accanto alla serratura. Appena lo sollevò si udì un mormorio sotterraneo
come di tuoni lontani che si spegnessero nel più profondo abisso. Il cancello si
aperse, essi entrarono e si avviarono per un largo viale in fondo al quale sorgeva
la villa.
«Ti par di sentire qui,» domandò Fabiano, «qualcosa di straordinario, di
magico?»
«Direi,» rispose Baldassarre, «che il modo in cui il cancello si aprì non sia dei
più comuni, e poi mi pare proprio che tutto sia meraviglioso. Ti sembra che nel
nostro paese ci siano alberi così belli come in questo parco? Direi anzi che qualche
albero e qualche arbusto con quei tronchi lucenti e le foglie di smeraldo siano di un
paese straniero e sconosciuto.»
Fabiano notò due rane di insolita grandezza che fin dal cancello li avevano
seguiti saltellando al loro fianco. «Bel parco, questo,» esclamò Fabiano, «con simili
bestiacce!» e si chinò a prendere un sasso per gettarlo contro le rane, ma tutte e
due si rifugiarono nella macchia e lo guardarono con occhi umani e lucenti.
«Aspetta me!» disse Fabiano mirando e lanciando il sasso. In quell'istante una
brutta donnetta seduta sul margine del viale gracidò: «Villano! Perché colpire
persone oneste costrette a guadagnare un po' di pane col duro lavoro in questo
giardino!»
«Vieni, vieni, andiamo,» mormorò Baldassarre spaventato perché si era
accorto che la rana si era trasformata in quella vecchietta. Un'occhiata ai cespugli
lo avvertì che l'altra rana, diventata un ometto, stava strappando erbacce.
Davanti alla villa si stendeva un bel tratto di prato dove pascolavano i due
unicorni, mentre nell'aria risonavano i più armoniosi accordi.
«Hai visto? Senti?» domandò Baldassarre.
«Non vedo altro che due cavallini bianchi che brucano l'erba e i suoni che
udiamo provengono probabilmente da arpe eolie.»
La magnifica e semplice architettura della villa, modesta e di un sol piano,
entusiasmò Baldassarre, il quale tirò il campanello dopo di che la porta si aprì e gli
amici si trovarono davanti a un grande uccello simile allo struzzo, tutto luccicante
d'oro, che faceva da portiere.
«Guarda un po' che buffa livrea!» osservò Fabiano. «Se dopo vorremo dare
la mancia a costui, avrà la mano per mettersela nel taschino?» Così dicendo si
rivolse allo struzzo, lo prese per la peluria lucente che alla gola sotto al becco
formava quasi un collarino e disse: «Delizioso amico, ci annunci al dottore!»
Lo struzzo disse soltanto: «Quirr» e morse Fabiano a un dito.
«Accidenti!» gridò Fabiano. «Sta' a vedere che costui è veramente un
diavolo di uccello!»
In quel momento si aprì una porta interna e il dottore andò incontro agli
amici. Era un omino sottile, pallido. Portava un berretto di velluto di sotto al quale
fluivano i capelli in lunghe ciocche, e un lungo talare indiano, guarnito non si
capiva se di pelliccia a colori o di un lustro piumaggio di uccello. Il viso rivelava
calma e bonarietà, soltanto era strano che chi lo guardava da vicino e gli fissava gli
occhi addosso aveva l'impressione che dentro al viso avesse un altro viso più
piccolo come dentro a una custodia di vetro.
«Signori,» cominciò a parlare Prospero Alpano a voce bassa e un po'
stiracchiata, con un bel sorriso, «vi ho visti dalla finestra, ma sapevo già che
sareste venuti da me, almeno lei, caro signor Baldassarre. Seguitemi, per favore.»
Alpano li condusse in una stanza alta e rotonda, coperta intorno intorno da
tendine, celesti. La luce scendeva da una finestra della cupola e gettava i suoi
raggi su un tavolino di marmo lucido, sorretto da una sfinge, nel mezzo della
stanza. Intorno non vi era nient'altro di notevole.
«In che vi posso servire?» domandò Alpano.
Baldassarre raccolse i suoi pensieri, raccontò quanto era successo col piccolo
Cinabro fin dalla sua comparsa a Kerepes e conchiuse assicurando che gli era
balenata la convinzione di trovare in lui, Prospero Alpano, il mago benefico capace
di troncare l'abietta e orrenda stregoneria di Cinabro.
Il dottore si immerse in pensieri profondi e non rispose. Infine, dopo qualche
minuto cominciò con viso serio e voce rauca: «Dopo tutto quanto mi ha
raccontato, Baldassarre, non c'è dubbio che il piccolo Cinabro è un essere
misterioso. Ma anzitutto è necessario conoscere il nemico che si vuol combattere,
sapere la causa della quale si vuol distruggere l'effetto. Possiamo supporre che il
piccolo Cinabro non sia che un Radicino. Vedremo subito.»
Alpano tirò uno dei cordoni di seta che intorno pendevano dal soffitto della
stanza. Una tendina si aprì scoprendo grandi volumi in folio con le legature dorate,
e una graziosa leggerissima scala di legno di cedro si srotolò dall'alto. Alpano vi salì
e prese dal palchetto più alto uno di quei libroni, poi lo pose sulla tavola di marmo,
dopo averlo accuratamente spolverato con un gran ciuffo di lucenti penne di
pavone. «Quest'opera,» spiegò, «tratta dei Radicini, qui sono raffigurati tutti,
forse vi troverete il vostro nemico Cinabro, e allora sarà nelle nostre mani.»
Appena aprì il libro, i due amici vi scorsero una quantità di rami ben
alluminati che rappresentavano i più strani e deformi gnomi atteggiati alle più
fantastiche smorfie che si potessero immaginare. Non appena poi Prospero
toccava uno di quei fogli, l'omino ne balzava vivo e si metteva a saltellare
buffamente sopra la tavola, a schioccare con le dita e a fare con le gambine storte
bellissimi sgambetti e piroette cantando: «Quirr quapp, pirr papp» finché Prospero
li prendeva per la testa e li posava di nuovo sul libro dove si lisciavano e si
appiattivano, diventando figure.
In questo modo esaminarono tutte le figure del volume, ma ogni qualvolta
Baldassarre stava per dire: «Eccolo, è lui, Cinabro!» guardava meglio e doveva con
suo grande rammarico riconoscere che il rispettivo gnomo non era affatto Cinabro.
«Molto strano,» commentò Alpano quando giunse in fondo al libro. «Ma
chissà,» continuò, «può darsi che Cinabro sia uno Spirito della terra. Vediamo un
po'.» E con rara agilità risalì la scaletta di cedro, tolse un altro librone, lo spolverò
attentamente e depostolo sulla tavola lo aprì dicendo: «Questo volume tratta degli
Spiriti della terra, qui potremo forse acciuffare Cinabro.»
Gli amici videro un'altra quantità di incisioni in rame che rappresentavano
orribili gnomi color marrone. E come Prospero li toccava si mettevano a
piagnucolare e uscivano pesantemente avvoltolandosi e gemendo sulla tavola
finché il dottore li comprimeva di nuovo nel libro. Ma nemmeno tra questi
Baldassarre poté trovare Cinabro.
«Strano, molto strano,» mormorò il dottore immergendosi di nuovo nei suoi
pensieri. «Il re dei coleotteri,» proseguì poi, «non può essere, perché so di certo
che è occupato altrove; nemmeno può essere il maresciallo dei ragni, poiché
questi è, sì, brutto ma abile e intelligente, e vive del proprio lavoro senza arrogarsi
l'opera altrui... Strano, molto strano.»
Di nuovo tacque alcuni minuti e intanto si udivano molte voci che ora
risonavano staccate, ora formavano armoniosi accordi.
«Caro dottore, lei ha qui continuamente musiche molto belle,» osservò
Fabiano, ma Prospero non badava affatto a lui, guardava soltanto Baldassarre,
stendendo le braccia verso di lui e agitando i polpastrelli come se lo aspergesse
con gocciole invisibili. Infine gli prese le mani e disse con gravità cortese:
«Soltanto la più pura consonanza del principio psichico entro la legge del dualismo
favorisce l'opera che sto per intraprendere. Seguitemi.»
I due amici seguirono il dottore attraverso alcune stanze che tranne alcuni
animali occupati a leggere, scrivere, dipingere e danzare non contenevano niente
di straordinario, finché si aprirono due battenti e gli amici si trovarono davanti a
una grossa tenda, dietro alla quale Prospero Alpano scomparve lasciandoli al buio.
Quando la tenda si spostò frusciando, videro una sala di forma ovale nella quale
era diffuso un magico chiaro-scuro. Osservando le pareti sembrava che lo sguardo
si perdesse in infiniti boschetti verdi e prati fioriti con ruscelli e fonti gorgoglianti.
Un misterioso e ignoto aroma saliva e scendeva a ondate e pareva trasportasse i
dolci suoni dell'armonica. Prospero comparve tutto vestito di bianco come un
brahmino e pose nel mezzo della sala un grande e rotondo specchio di cristallo sul
quale stese un velo.
«Venga, Baldassarre,» disse con voce cupa e solenne, «si metta davanti a
questo specchio, rivolga tutto il suo pensiero a Candida, cerchi di volere con tutta
la sua forza che essa le appaia nel momento che ora esiste nel tempo e nello
spazio!»
Baldassarre eseguì l'invito, mentre Prospero si metteva dietro di lui e
descriveva gran cerchi con tutte e due le mani. Dopo pochi secondi uscì dallo
specchio un vapore azzurrognolo e Candida, la dolce Candida comparve con la sua
bella figura e nel suo pieno vigore. Sennonché accanto a lei era seduto il
detestabile Cinabro che le stringeva le mani e la baciava. E Candida teneva stretto
quel mostro con un braccio e lo accarezzava! Baldassarre fu sul punto di lanciare
un grido, ma Alpano lo afferrò per le spalle in modo che il grido rimase soffocato
nel petto.
«Calma, calma, Baldassarre!» mormorò il professore. «Prenda questa canna
e meni colpi contro il piccolo, ma senza spostarsi.»
Baldassarre obbedì e con grande piacere vide il nano che si torceva, cadeva
e si avvoltolava per terra. Nel suo furore fece un balzo avanti, ma l'immagine si
sciolse in nebbia e vapore, mentre Prospero tirava indietro violentemente il folle
giovane esclamando: «Fermo! Se infrange lo specchio magico siamo tutti perduti.
Ritorniamo ora alla luce!»
Per ordine del dottore gli amici lasciarono la sala ed entrarono in un'attigua
stanza rischiarata.
«Ringraziamo il cielo,» disse Fabiano con un profondo respiro, «se siamo
usciti da quella sala incantata. Quell'aria greve mi aveva quasi schiacciato il cuore,
senza dire di quei trucchi insulsi che mi sono profondamente odiosi.»
Baldassarre stava per replicare allorché Prospero entrò.
«Ormai è certo,» disse, «che il deforme Cinabro non è né un Radicino né uno
Spirito della terra, bensì un uomo comune. Abbiamo però a che fare con un potere
magico segreto che finora non sono riuscito a identificare e appunto perciò non
posso ancora intervenire. Venga presto a trovarmi, Baldassarre, e vedremo il da
farsi. Arrivederci.»
«Dunque,» cominciò Fabiano mettendosi davanti al dottore, «lei, dottore,
sarebbe un mago e con tutta la sua magia non è capace di schiacciare quel piccolo
miserabile Cinabro! Posso dirle che con tutte le sue colorite immagini, con le
pupattole e con gli specchi magici, con tutte le sue carabattole la considero un vero
perfetto ciarlatano? Baldassarre è innamorato e scrive poesie: a lui può darla ad
intendere come vuole, ma a me non me la fa. Sono un uomo illuminato e non
riconosco i miracoli.»
«Faccia come crede,» ribatté Alpano ridendo di gusto più di quanto si poteva
aspettarsi dato il suo carattere. «Se non sono un mago dispongo però di graziose
trovate.»
«Sì, prese dalla Magia di Viegleb o da qualche altra parte!» esclamò Fabiano.
«Il nostro professor Mosce Terpin le può fare da maestro e lei non deve
paragonarsi con lui, perché quel brav'uomo ci fa vedere sempre che tutto procede
per vie naturali e non si circonda di tanto mistero come lei, caro dottore. La
riverisco.»
«Oh, via,» osservò il dottore, «non vorrà mica andarsene così in rotte!» E
così dicendo gli passò alcune volte la mano sulle braccia dalle spalle al polso.
Fabiano sentì qualche cosa di strano e domandò angosciato: «Che cosa fa,
dottore?»
«Andate pure, signori,» disse Prospero. «Lei, Baldassarre, spero di rivederla
presto. Non ci vorrà molto a trovare il rimedio.»
«Non speri di ricevere la mancia, caro amico,» disse Fabiano sull'uscio al
portiere giallo-dorato prendendolo per il collarino. Anche questa volta il portiere
disse soltanto «quirr» e di nuovo morse un dito a Fabiano.
«Che bestia!» gridò questi andando via di corsa.
Le due rane non fecero a meno di accompagnare gentilmente i due amici
fino al cancello che si aprì e richiuse con un tuono cupo.
«Non capisco perché,» disse Baldassarre quando furono sulla strada
maestra, «tu abbia indossato una giacca così curiosa con tanto di falde e con le
maniche tanto corte.»
Con suo grande stupore Fabiano vide che la sua giacchettina era allungata
dietro fino al suolo, mentre le maniche di solito abbastanza lunghe si erano ritirate
fino al gomito.
«Oh, diavolo, che cosa è questo?» domandò tirando le maniche e
assestando le spalle. Raggiunse anche l'effetto, ma quando entrarono in città le
maniche si accorciarono di nuovo e le falde si allungarono di modo che, per quanto
egli tirasse e si contorcesse, le maniche salivano fino alle spalle mettendo a nudo
le braccia e uno strascico sempre più lungo lo seguiva. Tutti i passanti si
fermavano e ridevano di cuore; i monelli calpestavano a dozzine lo strascico
facendo cadere Fabiano, il quale rialzandosi vedeva che lo strascico non era affatto
stracciato, ma se mai più lungo di prima. Le risate e le grida diventarono sempre
più fragorose, finché Fabiano quasi impazzito si rifugiò in un portone aperto. E
tosto lo strascico scomparve.
Baldassarre non ebbe neanche il tempo di meravigliarsi a lungo
dell'incantesimo che aveva colpito Fabiano, perché il cancelliere Pulcher lo prese
per un braccio, lo trascinò in una stradina remota e disse: «Possibile che tu non ti
sia già allontanato e ti faccia vedere ancora qui, mentre l'usciere è alle tue
calcagna col mandato di cattura!»
«Come? Che cosa mi vieni a dire?» domandò Baldassarre stupefatto.
«La tua folle gelosia,» spiegò il cancelliere, «ti ha trascinato al punto da
renderti colpevole di violazione di domicilio: sei entrato da nemico nella casa di
Terpin, hai aggredito Cinabro al fianco della fidanzata, hai quasi accoppato il
pollicino deforme a furia di botte.»
«Fammi il piacere,» obiettò Baldassarre, «se tutto il giorno non sono stato a
Kerepes! Tutte vili menzogne.»
«Zitto, zitto,» lo interruppe Pulcher. «La pazza idea di Fabiano di indossare
uno strascico ora ti salva. Nessuno bada a te. Evita il vergognoso arresto, al
rimanente penseremo poi. Tu non devi ritornare in casa tua. Dammi le chiavi, ti
manderò quanto ti occorre. Fila a San Giacomo!»
Il cancelliere trascinò Baldassarre per vicoli nascosti, lo fece uscire dalla città
verso San Giacomo dove il celebre scienziato Tolomeo Filadelfo stava scrivendo il
memorabile volume sulla ignota popolazione degli studenti.
CAPITOLO VI
Come Cinabro, speciale consigliere segreto, fu pettinato nel suo giardino, e
nell'erba fece un bagno di rugiada. - L'ordine della tigre a macchie verdi. - Felice
idea d'un sarto di teatro. - Come la signorina Rosabella si versò addosso il caffè e
Prospero Alpano la assicurò della propria amicizia.
Il professore Mosce Terpin sfavillava dalla gioia. «Poteva mai capitarmi,»
disse tra sé, «un caso più fortunato dell'arrivo di quell'eminente consigliere segreto
in casa mia? Ora sposa mia figlia, diventa mio genero, per merito suo ottengo i
favori dell'ottimo principe Barsanufo e salgo la scala sulla quale si arrampica il mio
delizioso Cinabrino. Vero è che io stesso qualche volta non riesco a capire come
quella fanciulla possa essere tanto innamorata di quel piccino. Di solito Candida
apprezza più la bellezza esteriore che tutte le particolari doti intellettuali, e talvolta
quando guardo quell'omino speciale non direi che sia proprio bello, anzi piuttosto
bossu... zitto però: i muri possono ascoltare... È il beniamino del principe, salirà
sempre più in alto, più in alto ed è mio genero!»
Mosce aveva ragione, Candida manifestava le più schiette simpatie per il
piccolo e quando qualcuno, non ancora sedotto dalle stregonerie di Cinabro,
faceva capire che in realtà il consigliere speciale era un coso deforme, si metteva
subito a parlare dei capelli meravigliosi che la natura gli aveva donato.
Ma quando Candida si esprimeva così, nessuno sorrideva maligno come il
cancelliere Pulcher. Questi seguiva Cinabro dappertutto, assistito fedelmente dal
segretario Adriano, quel giovane che la magia di Cinabro aveva quasi scacciato
dall'ufficio del ministro e poi aveva riconquistato la benevolenza del principe con
l'eccellente smacchiatore che gli aveva recato.
Cinabro, lo speciale consigliere segreto, abitava una bella casa con un
giardino ancora più bello che nel mezzo aveva uno spiazzo circondato da fitti
cespugli dove fiorivano le più splendide rose. Si era notato che ogni nove giorni
Cinabro si alzava silenzioso all'alba, e per quanto gli dispiacesse, si vestiva senza
l'aiuto del domestico, scendeva nel giardino e scompariva fra i cespugli che
circondavano quello spiazzo.
Pulcher e Adriano sospettando qualche mistero, una notte, dopo nove giorni
dall'ultima visita di Cinabro, scalarono il muro del giardino e osarono nascondersi
tra quei cespugli. Era appena spuntata l'alba allorché videro arrivare il piccolino
sbuffando e starnutendo perché nell'attraversare una aiuola di fiori gli steli bagnati
di rugiada gli sfioravano il naso.
Quando arrivò vicino alle rose il loro profumo si fece molto intenso e un
venticello sonoro mosse i cespugli. Una bella donna velata, con le ali alle spalle,
scese in volo, si sedette sulla sedia elegante che stava in mezzo alle rose e
mormorando «Vieni, bambino mio» prese il piccolo Cinabro sulle ginocchia e passò
un pettine d'oro nei lunghi capelli che gli scendevano sulle spalle. Il nano dovette
sentire un gran bene perché ammiccava con gli occhietti, si stirava le gambine,
ronfava e faceva le fusa quasi come un gatto. Dopo aver continuato così per
cinque minuti la bellissima donna passò ancora un dito sulla scriminatura del
piccolo Cinabro dove Pulcher e Adriano notarono una striscia sottile lucente e color
fuoco. La donna disse: «Addio, piccino mio! Sii prudente, sii saggio più che puoi.»
Cinabro replicò: «Addio, mammina, saggio sono abbastanza, non occorre
che tu me lo ripeta tante volte.»
La donna si alzò lentamente e scomparve nell'aria.
Pulcher e Adriano erano lì impietriti dallo stupore. Ma mentre Cinabro stava
per allontanarsi, il cancelliere sbucò esclamando: «Buon giorno, signor consigliere
speciale. Oh, come si è fatto pettinare bene!»
Cinabro si guardò intorno e scorgendo il cancelliere fece per scappare di
corsa. Ma, maldestro e deboluccio di gambe come era, inciampò e cadde nell'erba
alta che si richiuse sopra di lui immergendolo in un bagno di rugiada. Pulcher
accorse, lo aiutò a tirarsi su, ma Cinabro lo investì: «Signore, chi le ha permesso di
entrare nel mio giardino? Vada all'inferno!» E saltellando corse in casa più presto
che poté.
Pulcher riferì il fatto a Baldassarre e gli promise di raddoppiare la sua
sorveglianza. Cinabro in seguito a quell'incidente rimase sconsolato, si fece
portare a letto dove gemeva e sospirava sicché la notizia della sua malattia
improvvisa giunse presto alle orecchie del ministro Lunachiara e del principe
Barsanufo. Questi mandò immediatamente al piccolo beniamino il proprio medico
particolare.
«Egregio speciale consigliere segreto,» disse il medico tastandogli il polso,
«lei si sacrifica per lo stato. Ora si è ammalato per la troppa fatica, il pensiero
continuo ha causato le sue indicibili sofferenze. Ha una faccia molto pallida e
smunta, ma la sua riverita testa arde terribilmente. Non sarà un'encefalite?
Possibile che una cosa simile sia causata dal bene dello stato? Mi pare impossibile.
Permetta!»
Il medico doveva aver visto sul capo di Cinabro quella striscia rossa che gli
avevano scoperto Pulcher e Adriano. Dopo aver tentato alcuni gesti magnetici da
lontano, aver soffiato più volte sul malato facendolo miagolare e trillare, stava ora
per passargli la mano sulla testa e involontariamente gliela toccò. Cinabro saltò su
schiumante di rabbia e con la manina ossuta diede al medico chino sopra di lui uno
schiaffo così solenne da farne riecheggiare la stanza.
«Cosa vuole?» gridò Cinabro. «Che mi viene a vellicare la testa? Non sono
affatto malato, sono sano sanissimo, mi alzo subito e mi faccio portare alla seduta
del ministro. E lei vada al diavolo!»
Il medico scappò spaventato. Ma quando raccontò ogni cosa a Barsanufo
questi esclamò estatico: «Quanto zelo per il servizio dello stato! Quale dignità,
quale nobile comportamento, vero?, questo Cinabro!»
«Egregio consigliere speciale,» disse il ministro Pretestato di Lunachiara al
piccolo Cinabro, «che bellezza sia venuto alla seduta nonostante la malattia. Per le
importanti trattative con la corte di Kakatuck ho steso un memoriale, l'ho steso io
stesso e prego lei di presentarlo al principe, perché il suo modo di porgere ne
aumenta l'importanza e così il principe vedrà che l'autore sono io.» Ora, il
memoriale col quale Pretestato voleva fare bella figura era stato compilato da
Adriano.
Il ministro si recò con Cinabro dal principe. Questi trasse dalla tasca il
memoriale datogli dal ministro e cominciò a leggere. Ma siccome la lettura era
confusa e Cinabro non faceva che borbottare frasi incomprensibili, il ministro gli
tolse il foglio dalle mani e lesse. Il principe andò in estasi e diede la sua
approvazione dicendo continuamente: «Bello... bene... ben detto... magnifico...
giusto!»
Appena il ministro ebbe finito, il principe si avvicinò a Cinabro, lo sollevò, lo
strinse al cuore esattamente nel punto in cui brillava la stella della tigre pezzata di
verde e con le lacrime agli occhi balbettava e singhiozzava: «Che uomo!... Che
ingegno!... Quanto amore!... È troppo, troppo!»
Poi più calmo: «Cinabro, la nomino ministro. Rimanga fedele alla patria e
continui ad essere un bravo servitore dei Barsanufi che la stimano, la amano.» E
rivolgendosi con disgusto al ministro: «Da qualche tempo ho notato, caro barone
di Lunachiara, che le sue forze si affievoliscono. Le farà bene un po' di riposo nelle
sue terre. Addio!»
Il ministro si allontanò mormorando fra i denti parole incomprensibili e
lanciando occhiate di fuoco a Cinabro, il quale puntellato sul bastoncino si alzava
sulla punta dei piedi e guardava in giro sfrontato e superbo.
«Mio caro Cinabro,» disse ora il principe, «devo onorare subito i suoi meriti.
Riceva dalle mie mani l'ordine della tigre pezzata di verde!»
E fece per infilargli il nastro dell'onorificenza che si era fatto porgere
rapidamente dal camerlengo; ma la disgraziata figura di Cinabro fece sì che il
nastro non gli si potesse adattare e ora salisse, ora spenzolasse in modo
inopportuno. In questa come in ogni altra cosa che riguardasse il bene dello stato
il principe era molto preciso. Il simbolo della tigre assicurato al nastro doveva stare
fra l'osso iliaco e il coccige, in senso obliquo, tre sedicesimi di pollice più su del
coccige. E non si riusciva a farcelo stare. Tutti i tentativi del camerlengo e dei tre
paggi del principe stesso furono vani. Il perfido nastro scivolava di qua e di là
finché Cinabro seccato si mise a gracidare: «Che state a smanettarmi addosso,
lasciate che questa scempiaggine spenzoli come vuole, ormai sono ministro e tale
rimango!»
Il principe montando in collera sbottò a dire: «Che stanno a fare i consiglieri
dell'ordine, se i nastri richiedono tanti accorgimenti contrari al mio volere? Un po'
di pazienza, mio caro ministro Cinabro! Tra un poco queste cose cambieranno.»
Ora per volontà del principe si dovette convocare il consiglio dell'ordine cui si
aggiunsero due filosofi e un naturalista di passaggio che veniva dal Polo Nord, per
discutere il modo migliore di assestare al ministro Cinabro il nastro della tigre
pezzata di verde. Perché raccogliessero le energie necessarie a quell'importante
discussione fu ordinato a tutti i membri dell'assemblea di non pensare negli otto
giorni precedenti; perché potessero farlo meglio pur rimanendo attivi al servizio
dello stato dovevano occuparsi della contabilità. Le strade davanti al palazzo dove
i consiglieri dell'ordine, i filosofi e il naturalista dovevano tenere le sedute furono
coperte con un alto strato di paglia affinché il rumore dei veicoli non disturbasse
quei sapienti, e per lo stesso motivo non bisognava battere i tamburi né sonare,
anzi nemmeno parlare a voce alta nei pressi del palazzo. Dentro, tutti
camminavano con grosse scarpe di feltro e si intendevano a gesti.
Le sedute erano durate ormai sette giorni dalla prima mattina a tarda sera e
ancora non si era arrivati a una decisione. Il principe, impaziente, mandava a
chiedere notizie e a un certo momento avvertì che in nome del diavolo dovevano
trovare finalmente qualcosa di buono. Ma tutto fu inutile.
Il naturalista aveva studiato il più possibile la persona di Cinabro, aveva
misurato l'altezza e la larghezza della sporgenza dorsale e presentato al consiglio
i suoi calcoli precisi. E fu lui finalmente a proporre che si interpellasse il sarto del
teatro. La proposta, per quanto potesse sembrare strana, fu accettata con voto
unanime date le angustie e la paura che assillavano tutti i presenti.
Il sarto del teatro, certo Kees, era un uomo estremamente abile e furbo.
Quando apprese il caso difficile e scorse i calcoli del naturalista trovò subito la
maniera di assestare a dovere il nastro dell'ordine. Bisognava applicare sul petto e
sulla schiena un certo numero di bottoni e attaccare a questi il nastro. La prova
riuscì egregiamente.
Il principe rimase soddisfatto e approvò la proposta del consiglio di
suddividere l'ordine della tigre in diverse classi secondo il numero dei bottoni coi
quali era conferito, per esempio ordine della tigre pezzata con due bottoni, con tre
bottoni, ecc. Come onorificenza particolare alla quale nessun altro poteva arrivare
il ministro Cinabro ricevette l'ordine con venti bottoni di brillanti, perché la strana
forma del suo corpo richiedeva proprio venti bottoni.
Anche il sarto ebbe l'ordine della tigre con due bottoni d'oro e siccome il
principe, nonostante la felice trovata, lo considerava un pessimo sarto e non
voleva farsi vestire da lui, lo nominò suo grande costumiere segreto.
Dalla finestra della villa il dottor Prospero Alpano stava guardando
pensieroso il suo parco. Aveva lavorato tutta la notte per stendere l'oroscopo di
Baldassarre ed aveva trovato parecchi riferimenti al piccolo Cinabro. Il fatto più
importante però gli sembrava quello che era avvenuto nel giardino alla presenza di
Adriano e Pulcher. Prospero stava per chiamare i suoi unicorni affinché venissero
con la conchiglia dovendo egli recarsi a San Giacomo, allorché una carrozza arrivò
con fragore e si fermò davanti al cancello. Si trattava della dama Rosabella che
veniva dall'ospizio per parlare col dottore.
«È la benvenuta,» disse Prospero e la dama entrò. Portava un lungo vestito
nero ed era avvolta in un velo come una matrona. Il dottore preso da uno strano
presentimento afferrò la sua canna e fece cadere sulla dama i raggi scintillanti del
pomo. Allora parve che intorno a lei guizzassero lampi fruscianti e lei stessa si
presentò in abito bianco trasparente, lucide ali di libellula alle spalle, rose bianche
e rosse intrecciate nei capelli. «Guarda, guarda,» bisbigliò Prospero, nascose la
canna sotto la veste da camera e subito la dama riebbe il costume di prima.
Alpano la invitò gentilmente ad accomodarsi. E Rosabella disse che da un
pezzo aveva avuto intenzione di far visita al dottore nella sua villa per conoscere
un uomo che tutta la regione indicava come saggio, benefico, dotato di grande
intelligenza. Egli avrebbe certamente accolto la preghiera di lei di svolgere la sua
attività di medico nel vicino ospizio, visto che le signore anziane vi si ammalavano
spesso e non avevano chi le soccorresse. Prospero rispose cortesemente che da
un pezzo non esercitava più, ma in via eccezionale era disposto a visitare le signore
qualora fosse necessario, e intanto chiese se lei, la signorina Rosabella, era forse
sofferente. Rosabella assicurò che solo qualche volta sentiva una fitta reumatica
nelle membra quando era raffreddata a causa dell'aria mattutina, ma ora si sentiva
meglio, e cambiò discorso. Prospero le domandò se essendo ancora presto voleva
gradire una tazza di caffè; Rosabella rispose che le signorine dell'ospizio non lo
rifiutavano mai. Il caffè arrivò, ma per quanto Prospero tentasse di versarlo, le
tazze rimanevano vuote, nonostante che il caffè uscisse dal bricco. «Ahi, ahi, che
caffè cattivo!» sorrise Prospero. «Le dispiacerebbe, signorina, versarlo lei?»
«Volentieri,» rispose lei e prese il bricco. Ora, benché non ne uscisse alcuna
goccia, le tazze si empirono tanto che il caffè traboccò e corse sulla tavola e
sull'abito della signorina. Questa depose rapidamente il bricco e subito il caffè
scomparve senza lasciare traccia. Prospero Alpano e la signorina dell'ospizio si
scambiarono in silenzio alcune strane occhiate.
«Quando sono venuta,» cominciò la dama, «lei, dottore, stava certamente
consultando un libro molto interessante.»
«Infatti,» rispose il dottore, «questo libro contiene cose molto strane.» E
stava per aprire il libretto con la rilegatura dorata posto davanti a lui sul tavolino.
Ma ogni fatica fu vana perché il libro continuava a richiudersi con un forte clip clap.
«Ahi, ahi,» disse Prospero, «provi un po' lei, signorina, a maneggiare questo coso
capriccioso!»
Porse alla dama il libro che appena toccato si aprì da sé. Ma tutti i fogli si
staccarono, formarono altri fogli smisurati e girarono per la stanza frusciando. La
signorina si ritrasse spaventata. Il dottore chiuse il libro di colpo e tutti i fogli
scomparvero.
Alzandosi in piedi Prospero Alpano disse ora con un dolce sorriso: «Le pare,
signorina, che sia il caso di sprecare il tempo con questi spregevoli trucchi? Quelli
che abbiamo presentati finora non sono che trucchi ordinari. Sarà meglio passare
a cose più elevate.»
«Me ne vado!» disse la signorina alzandosi a sua volta.
«Non credo che sarà facile senza che io lo voglia,» osservò Alpano. «Devo
dirle, signorina, che lei è da questo momento in mio potere.»
«In suo potere?» disse la dama in collera. «In potere suo, dottore? Stolta
illusione.»
Così dicendo allargò la sua veste di seta e salì al soffitto assumendo l'aspetto
di una bellissima antiopa. Ma Prospero la raggiunse come una freccia
trasformandosi in un robusto cervo volante. L'antiopa spossata svolazzò sul
pavimento e corse di qua e di là in forma di topolino. Il cervo volante la inseguì
miagolando e soffiando in forma di gatto grigio. Allora il topolino si risollevò ed era
un colibrì splendente, allorché intorno alla villa si udirono molte voci singolari e
arrivarono ronzando una quantità di insetti meravigliosi e con essi insoliti volatili
silvestri, mentre una rete d'oro chiudeva le finestre. Ed ecco apparire a un tratto la
fata Rosabelverde nel mezzo della stanza in tutta la sua magnificenza e nobiltà,
vestita di un abito bianco luminoso con la scintillante cintura di diamanti, rose
bianche e rosse intrecciate nei riccioli scuri. E davanti a lei il mago in talare
ricamato d'oro, una splendida corona in testa, la canna col pomo dai raggi di fuoco
nella mano.
Rosabelverde andò verso il mago e in quella le cadde dai capelli un pettine
d'oro che come fosse vetro s'infranse sul pavimento di marmo.
«Povera me! Povera me!» gridò la fata.
Ed ecco che la signorina Rosabella in lungo abito nero riapparve al tavolino
del caffè avendo di fronte il dottor Prospero Alpano.
«Direi,» cominciò quest'ultimo con molta calma, mentre versava senza
ostacoli il moca fumante nelle tazze cinesi, «direi, signorina, che ormai ci
conosciamo abbastanza. Mi dispiace molto che il suo bel pettine si sia rotto sul mio
duro pavimento.»
«Sono stata io maldestra,» osservò la signorina sorbendo beatamente il
caffè. «La colpa è mia. Bisogna guardarsi dal far cadere qualcosa su questo
pavimento, poiché, se non m'inganno, queste pietre recano i più meravigliosi
geroglifici che a qualcuno potrebbero sembrare soltanto comuni venature del
marmo.»
«Talismani frusti, cara signorina, sono queste pietre, nient'altro.»
«Però, ottimo dottore, come mai non ci siamo conosciuti, fin dai primissimi
tempi, le nostre vie non si sono incrociate?»
«Soltanto un'educazione diversa, gentile dama,» rispose Alpano, «ne è la
causa. Mentre lei, giovinetta di belle speranze, poté assecondare nel Ginnistan
tutta la sua ricca indole, il suo genio, io studente melanconico stavo rinchiuso nelle
Piramidi e seguivo i corsi del professor Zoroastro, un vecchio barbogio, che però
sapeva un mucchio di cose. Soltanto durante il regno dell'ottimo principe Demetrio
ho preso dimora in questo simpatico paesetto.»
«Come?» fece la signorina. «E non fu esiliato quando il principe Pafnuzio
introdusse l'illuminismo?»
«Niente affatto,» rispose Prospero. «Riuscii anzi a mascherare la mia
persona sforzandomi di mostrare in questioni illuministiche un'erudizione
particolare negli scritti che andavo diffondendo. Diedi la prova che senza la volontà
del principe non poteva mai tuonare e lampeggiare, che dobbiamo il bel tempo e
il buon raccolto unicamente all'interessamento suo e dei suoi nobili che siedono a
consiglio negli appartamenti interni, mentre fuori la gente volgare ara e semina i
campi. Quella volta il principe Pafnuzio mi nominò supremo presidente segreto
dell'illuminismo, carica che deposi insieme con la mia maschera come un peso
molesto non appena fu passata la bufera. Intanto cercavo di essere possibilmente
utile in segreto, come noi due, io e lei, intendiamo la vera utilità. Lo sa, cara
signorina, che sono stato io ad avvertirla prima che irrompesse la polizia
illuministica? Che deve a me il possesso delle graziose cosine che mi ha fatto
vedere dianzi? Dio mio, dama carissima, guardi un po' da queste finestre! Non
riconosce più il parco nel quale ha passeggiato tante volte e parlato con spiriti
amici che abitano nei cespugli, nei fiori, nelle fonti? Questo parco l'ho salvato io
con la mia scienza. È ancora com'era ai tempi del vecchio Demetrio. Grazie al cielo,
il principe Barsanufo non si cura gran che di incantesimi, è un signore cordiale e
lascia vivere il prossimo e fare incantesimi a volontà, purché non si faccia scorgere
e paghi le imposte dovute. Perciò, cara signorina, vivo qui felice e senza pensieri,
come lei nel suo ospizio.»
«Dottore,» esclamò la signorina con le lacrime agli occhi, «che cosa dice,
dottore? Quali spiegazioni! Sì, certo, riconosco questo boschetto dove ho gustato
tante gioie. Nobile dottore, quanto le devo! Ma perché perseguita così
crudelmente il mio protetto?»
«Ecco, signorina, lei, trascinata dalla innata bontà, ha sprecato le sue doti
con un indegno. Nonostante il suo benevolo soccorso Cinabro è e rimane un
furfantello deforme che, essendosi infranto il pettine d'oro, è tutto nelle mie
mani.»
«Via, dottore, abbia pietà!» implorò Rosabella.
«Guardi un po' qui, per favore,» la invitò Prospero porgendole l'oroscopo di
Baldassarre.
La signorina guardò e conchiuse con grande dolore: «Se è così dovrò ben
cedere al potere superiore. Povero Cinabro!»
«Riconosca, signorina,» soggiunse il dottore sorridendo, «che spesso le
dame si compiacciono delle cose più bizzarre, seguono risolute e senza riposo
l'idea suggerita dal momento e non tengono conto dei dolorosi contatti con altre
situazioni. Cinabro deve scontare il suo destino, ma dopo potrà assurgere a onori
immeritati. Con ciò, carissima signorina, intendo di fare omaggio alle sue facoltà,
alla sua bontà, alla sua virtù.»
«Grande, meraviglioso uomo!» esclamò la signorina. «Continui ad essermi
amico!»
«Sempre. La mia amicizia, la mia intima simpatia per lei, gentile fata, non
cesseranno mai. Si rivolga pure a me in tutti i casi difficili della vita e venga da me
a prendere il caffè ogni qualvolta ne abbia voglia.»
«Addio, degnissimo mago, non dimenticherò mai la sua benevolenza, mai
questo caffè!» Con queste parole la signorina si alzò intimamente commossa per
prendere commiato.
Prospero Alpano la accompagnò al cancello, mentre tutte le meravigliose
voci del bosco risuonavano dolcissimamente.
Davanti al cancello, invece della carrozza stava la conchiglia di cristallo del
dottore con gli unicorni al timone e in fondo il coleottero d'oro con le elitre lucenti.
A cassetta c'era il fagiano argentato che reggendo col becco le briglie d'oro
guardava la signorina con occhi arguti.
Quando il cocchio sonante passò frusciando per il bosco profumato la dama
si sentì trasportata nel tempo più felice della sua magnifica vita di fata.
CAPITOLO VII
Come il professor Mosce Terpin studiò la natura nella cantina del principe. Mycetes Beelzebub. - Disperazione dello studente Baldassarre. - Utile influsso di
una villa bene ammobiliata sulla felicità domestica. - Come Prospero Alpano porse
a Baldassarre una scatola di tartaruga e spronò via.
Baldassarre che si teneva nascosto nel villaggio di San Giacomo ricevette da
Kerepes una lettera del cancelliere Pulcher del seguente tenore: «La nostra
faccenda, caro amico Baldassarre, va di male in peggio. Il nostro nemico,
l'esecrabile Cinabro, è diventato ministro degli esteri e ha ricevuto il grande ordine
della tigre a macchie verdi con venti bottoni. Ha fatto carriera fino a diventare il
favorito del principe e ottiene tutto ciò che vuole. Il professor Mosce Terpin non sta
nella pelle e si gonfia nella sua stupida superbia. Per il tramite del futuro genero ha
ottenuto il posto di direttore generale di tutti gli affari naturali dello stato, un posto
che gli frutta molti quattrini e una quantità di altri emolumenti. Come direttore
generale controlla e rivede le eclissi di sole e di luna come pure i pronostici
meteorologici nei calendari riconosciuti dallo stato e studia particolarmente la
natura nella residenza e nel suo territorio. In virtù di questa occupazione riceve
dalle foreste principesche i volatili più pregiati, gli animali più rari che appunto per
studiarne la natura egli fa arrostire, e se li mangia. Ogni tanto scrive (o almeno lo
afferma) un trattato che dimostra perché il vino ha un sapore diverso dall'acqua e
produce anche effetti diversi; trattato che intende di dedicare a suo genero.
Cinabro ha fatto sì che per questo trattato Terpin possa studiare ogni giorno nella
cantina del principe. Ha già studiato un ettolitro di vecchio vino del Reno e
parecchie dozzine di bottiglie di sciampagna ed è arrivato a una botte di alicante.
Il cantiniere si mette le mani nei capelli! Così si è provveduto al professore che,
come sai, è il più grande ghiottone del mondo e farebbe una vita comodissima se
molte volte, quando la grandine devasta i campi, non dovesse improvvisamente
recarsi in campagna per spiegare agli affittuari del principe perché sia grandinato,
affinché quei poveri diavoli imparino qualcosa, possano in avvenire guardarsi da
siffatti infortuni e non abbiano sempre da pretendere il condono del fitto per un
guaio causato da loro stessi.
«Il ministro non riesce a dimenticare il fracco di legnate che gli hai
somministrate e ti ha giurato vendetta. Non potrai più farti vedere a Kerepes.
Perseguita anche me perché ho spiato la sua misteriosa maniera di farsi pettinare
da una signora alata. Finché Cinabro continuerà a essere il favorito del principe
non potrò certo pretendere un posto come si deve. La mia cattiva stella vuole che
io mi imbatta sempre in quel mostro dove non me l'aspetto e in un modo che dovrà
riuscirmi fatale. Ultimamente il ministro in pompa magna con tanto di spada, stella
e nastro onorifico era nel museo zoologico e alla sua solita maniera, puntellato sul
bastone, ritto sulla punta dei piedi, si era appoggiato alla bacheca che contiene le
più rare scimmie americane. Alcuni forestieri venuti a vedere il museo si avvicinano
e uno di loro scorgendo il Radicino esclama: ‹To', che bella scimmietta! Che
bestiola graziosa! È il pezzo più bello del museo. Come si chiama questa
scimmietta così carina? Da che parte viene?›
«Un custode del museo toccando una spalla di Cinabro risponde: ‹Sì, è un
bellissimo esemplare, un pregiato quadrumane brasiliano, il così detto Mycetes
Beelzebub - Simia Beelzebub Linnei - niger, barbatus, podiis caudaque apice
brunneis - una scimmia urlatrice...›
«‹Signore,› sbuffa a questo punto il nano, ‹lei deve essere pazzo o nove
volte parente del diavolo, non sono affatto Beelzebub caudaque, non sono una
scimmia urlatrice, sono Cinabro, il ministro Cinabro, cavaliere della tigre pezzata di
verde con venti bottoni!› Io sono lì a due passi e, dovessi anche rimetterci la pelle
sul momento, non riesco a trattenermi e scoppio in una risata simile a un nitrito di
cavallo.
«‹È qui anche lei, cancelliere?› mi investe, mentre i suoi occhi di stregone
mandano fiamme vermiglie.
«Dio sa come mai quei forestieri abbiano continuato a considerarlo la
scimmia più bella e più rara che avessero mai visto e a volergli far prendere a tutti
i costi le nocciole che cavavano dalle tasche. Cinabro era talmente fuori di sé che
non riusciva a prender fiato e le gambe non lo reggevano. Il suo cameriere dovette
prenderlo in braccio e portarlo giù nella carrozza.
«Per parte mia non so spiegarmi come questo episodio mi porti un barlume
di speranza. È il primo torto che venga fatto a quel mostro stregato.
«Certo è che recentemente Cinabro ritornò una mattina stravolto dal suo
giardino. Pare che la donna alata non si sia fatta vedere perché egli non ha più le
ciocche così belle. Dicono che i capelli gli scendono arruffati sulle spalle e pare che
Barsanufo gli abbia detto: ‹Non trascuri così la sua persona, caro ministro! Le
manderò il mio barbiere!› Dopo di che Cinabro avrebbe detto molto gentilmente
che se quello veniva lo buttava dalla finestra. ‹Creatura magnanima! Non si sa mai
da che parte prenderla,› disse poi il principe piangendo a calde lacrime.
«Addio carissimo, non abbandonare ogni speranza e tienti nascosto bene
perché non ti acciuffino.»
Costernato per le notizie ricevute dall'amico, Baldassarre corse nel bosco e
scoppiò in singhiozzi e lamenti. «Anche sperare dovrei dopo che ogni speranza si
è spenta, che tutte le stelle sono tramontate e che mi trovo sconsolato nella notte
nera? Destino sciagurato! Sono vittima del potere più tenebroso che abbia
incontrato nella mia vita. È follia sperare la salvezza da Prospero Alpano, che dopo
avermi adescato con arti infernali mi cacciò via da Kerepes facendo cadere le
legnate, che avrei dovuto dare all'immagine riflessa, sulle spalle vere di Cinabro.
Oh, la mia Candida! Potessi almeno dimenticare quella creatura celeste! Ma più
potente che mai e più forte arde dentro di me il fuoco amoroso. Dappertutto vedo
la dolce figura dell'amata che col suo bel sorriso tende le braccia verso di me. So
benissimo che mi ami, mia dolce Candida, ed è appunto il mio dolore mortale e
disperato di non poterti salvare dal funesto incantesimo che ti tiene prigioniera.
Oh, Prospero, traditore, che cosa ti ho fatto perché tu mi debba beffare con tanta
crudeltà?»
Era sceso il crepuscolo e tutti i colori del bosco svanirono in un cupo grigiore,
allorché uno splendore particolare come il fiammeggiare del tramonto brillò tra gli
alberi e i cespugli, e migliaia di piccoli insetti si sollevarono nell'aria ronzando con
le ali fruscianti. Coleotteri d'oro guizzavano luminosi di qua e di là insieme con
agghindate farfalle che svolazzando spargevano intorno un polline odoroso. Il
ronzio frusciante divenne una musica, fu un tenero mormorio che scese a
consolare il cuore straziato di Baldassarre. Sotto di lui lo splendore si fece più
intenso. Egli sollevò lo sguardo e con grande meraviglia scorse Alpano che arrivava
per l'aria a cavallo di un meraviglioso insetto molto simile a una libellula dai colori
pomposi.
Prospero scese fino al giovane accanto al quale si accomodò, mentre la
libellula volava su un cespuglio e partecipava al canto che empiva la foresta.
Il mago toccò la fronte del giovane coi fiori stupendi che aveva in mano
accendendo sull'istante un nuovo coraggio nel petto di Baldassarre.
«Mi fai torto,» cominciò Alpano con voce soave, «dicendomi crudele e
traditore nel momento in cui sono riuscito a dominare l'incanto che ha turbato la
tua vita e per trovarti più presto e consolarti ho inforcato il mio cavallino preferito
e vengo a te fornito di tutto quanto può servire alla tua salvezza. So che nulla è più
amaro delle pene d'amore, nulla uguaglia l'impazienza di un animo che dispera in
amore e nostalgia. Ma ti perdono perché io stesso mi sono trovato a questo punto
allorché circa duemila anni fa amavo una principessa indiana di nome Balsamina e
nella mia disperazione strappai la barba al mago Lotos: per questa ragione, per
evitare qualche cosa di simile sono sempre raso. Ma sarebbe troppo lungo
raccontarti questa storia e poi non sarebbe questo il momento perché ogni
innamorato vuol che si parli soltanto dell'amore suo, l'unico che conti qualche
cosa, come ogni poeta ascolta volentieri soltanto i propri versi. Dunque veniamo a
noi! Devi sapere che Cinabro è la mostruosa creatura di una povera contadina e in
realtà si chiama Zaches: per vanità ha assunto il superbo nome di Cinabro. La
signorina Rosabella, o dirò meglio, la famosa fata Rosabelverde è la dama che
trovò il mostricciattolo sul margine della via. Costei credette di riparare a quanto la
natura matrigna aveva negato al piccino facendogli il dono più raro e misterioso
che esiste: in virtù sua tutto ciò che di buono un altro dice o fa alla sua presenza
deve essere attribuito a lui e, quando si trova in compagnia di persone colte,
intelligenti e di spirito, anche lui deve essere considerato colto, intelligente e pieno
di spirito e passare in genere per il più dotato della categoria con la quale viene a
contatto.
«Questo fascino singolare è contenuto in tre capelli di color fuoco che gli
attraversano il cocuzzolo. Qualunque contatto con quei capelli e con la testa in
genere doveva essere doloroso, anzi pericoloso per il piccolo. Perciò la fata gli fece
scendere sulle spalle in grosse ciocche i capelli per natura radi e arruffati, affinché
gli proteggessero la testa e nello stesso tempo nascondessero quella striscia rossa
e conferissero maggior forza all'incanto. Ogni nove giorni la fata lo pettinava di
persona con un pettine d'oro e quella magica pettinatura sventava ogni impresa
mirante a rompere l'incantesimo. Ma un potente talismano che io seppi rifilare alla
buona fata quando venne a trovarmi ha distrutto il pettine.
«Ora si tratta soltanto di strappargli quei tre capelli infocati per ridurlo alla
sua nullità precedente. Questo compito, mio caro Baldassarre, è riservato a te. Tu
possiedi coraggio, forza, abilità e saprai portare l'impresa a buon fine. Prendi
questo vetrino molato, avvicinati al piccolo Cinabro dovunque tu lo trovi, dirigi il
tuo sguardo attraverso questo vetro sulla sua testa e vedrai chiaramente i tre
capelli rossi. Tienlo stretto, non badare al suo stridulo miagolio che certamente
farà sentire, cavagli con uno strappo i tre capelli e bruciali immediatamente. È
necessario che i capelli vengano tolti con un unico strappo e bruciati subito,
altrimenti potrebbero combinare ogni sorta di malanni. Stai bene attento ad
afferrare i capelli abilmente e con forza e ad assalire il piccolo quando ci sia vicino
un fuoco acceso o una candela.»
«Prospero Alpano,» esclamò Baldassarre, «assai male ho meritato con la mia
diffidenza tanta bontà, tanta generosità. Sento in fondo al cuore che le mie
sofferenze volgono al termine, che una felicità celestiale mi apre la porta dorata.»
«Io voglio bene,» continuò Prospero Alpano, «ai giovani come te che
nutrono amore e nostalgia nel cuore puro e nel cui intimo echeggiano ancora i
magnifici accordi di quel lontano paese colmo di meraviglie che è la mia patria. Gli
uomini felici, dotati di questa musica interiore, sono i soli che si possano chiamare
poeti, benché tali siano biasimati molti altri quando agguantano il primo
contrabbasso che gli capita sottomano e strofinandone le corde prendono quel
rombo confuso per splendida musica che provenga dal loro cuore. Tu, mio caro
Baldassarre, hai talvolta, lo so, l'impressione di intendere la fonte che mormora,
l'albero che stormisce, e ti sembra che il tramonto fiammeggiante dica parole
comprensibili. Sì, mio caro, in quei momenti comprendi davvero le meravigliose
voci della natura, poiché dal tuo cuore si leva il suono divino che accende la più
profonda e stupenda armonia del creato. Siccome, mio poeta, suoni il pianoforte,
saprai anche che battendo un tasto vibrano anche le note a esso affini. Questa
legge di natura è più di un vacuo paragone. Sì, poeta, tu sei molto migliore di
quanto non credano certuni ai quali hai letto i tuoi tentativi di mettere in carta con
penna e inchiostro la tua musica interiore. Non si può dire che i tuoi tentativi
valgano molto, ma nello stile storico hai fatto un bel colpo scrivendo con ampiezza
pragmatica e con precisione la storia dell'amore tra l'usignolo e la rosa purpurea,
la quale si è svolta sotto i miei occhi. È un lavoro molto prezioso...»
Prospero si interruppe e Baldassarre lo guardò meravigliato non sapendo
che cosa dire udendo che il mago considerava un tentativo storico la poesia che,
secondo lui, era la più fantastica che avesse mai scritto.
«Probabilmente,» continuò Alpano, mentre un sorriso gli illuminava il volto,
«ti meravigli delle mie parole e in genere trovi in me alcune stranezze. Considera
però: secondo il giudizio della gente ragionevole, sono una persona che può
comparire soltanto nella fiaba, e tu sai che siffatte persone possono comportarsi in
modo strano e dire un mucchio di stramberie, specie quando gli si nasconde
qualcosa che non è proprio da buttar via. Ma continuiamo! Se la fata Rosabelverde
si prese talmente a cuore il deforme Cinabro, tu, Baldassarre, sei il mio protetto.
Ascolta dunque che cosa sono disposto a fare per te. Ieri è venuto a trovarmi il
mago Lotos, e mi portò molti saluti, ma anche molte lagnanze da parte della
principessa Balsamina che si è destata dal sonno e nelle dolci note del Chartah
Bhade, antico poema che fu il nostro primo amore, tende le braccia a me con
nostalgia. Anche il ministro Yuchi, mio vecchio amico, mi fa cenni di cordiale invito
dalla stella polare. Devo partire per l'India lontana. Lasciando il mio podere
desidero che non vada a nessuno se non a te. Domani vado a Kerepes e faccio
stendere l'atto di donazione formale, presentandomi come tuo zio. Ora, rotto
l'incantesimo di Cinabro, se ti presenti al professor Mosce Terpin come proprietario
di un magnifico podere, di un cospicuo patrimonio e chiedi la mano della bella
Candida, egli ti concederà tutto con grande gioia. Dirò di più: entrando con la tua
Candida nella mia villa la felicità del tuo matrimonio è assicurata. Dietro a quei
begli alberi cresce tutto quanto occorre alla casa, oltre alla più bella frutta, i cavoli
più deliziosi e i legumi più saporiti che si possano trovare nel paese. A tua moglie
non mancherà mai la prima insalata, i primi asparagi. La cucina è sistemata in
modo che le pentole non traboccano mai, che nessun piatto si guasta, neanche se
tu dovessi arrivare un'ora intera dopo l'orario. I tappeti e le fodere delle poltrone e
dei divani sono tali che, ammessa anche la peggiore inavvertenza della servitù, è
impossibile farvi una macchia; nessuna porcellana, nessun vetro si rompe,
dovesse il personale fare i massimi sforzi e lasciarli cadere sul pavimento più duro.
Infine ogni volta che tua moglie fa il bucato, sull'ampio prato dietro alla casa regna
il più bel sereno, anche se tutto intorno dovesse piovere, tuonare e lampeggiare.
Insomma, Baldassarre mio, ho provveduto a che tu possa godere tranquillo e
indisturbato la felicità domestica al fianco della tua cara Candida.
«Ma è tempo che io ritorni a casa e insieme con l'amico Lotos cominci i
preparativi per la mia prossima partenza. Addio, Baldassarre.»
Prospero fece un fischio e la libellula arrivò subito in volo ronzando. Egli le
assestò i finimenti e balzò in sella. Ma stava già levandosi a volo allorché si fermò
e ritornò da Baldassarre. «Per poco non dimenticavo il tuo amico Fabiano. In un
momento di malizioso capriccio l'ho castigato troppo duramente per la sua
impertinenza. In questa scatoletta c'è tutto quanto occorre per confortarlo.»
Così dicendo porse a Baldassarre una scatoletta di tartaruga lucidata che
questi intascò insieme con l'occhialino ricevuto prima per il disincanto di Cinabro.
Prospero Alpano volò via frusciando nei cespugli, mentre le voci della foresta
risonavano sempre più forti e armoniose.
Baldassarre ritornò a San Giacomo col cuore gonfio di gioia e delle più dolci
speranze.
CAPITOLO VIII
Come Fabiano a causa delle lunghe falde fu preso per settario e sedizioso. - Come
il principe Barsanufo si ritirò dietro al parafuoco e licenziò il direttore generale degli
affari naturali. - La fuga di Cinabro dalla casa di Mosce Terpin. - Come Mosce
Terpin voleva partire a cavallo di una farfalla e diventare imperatore, ma poi andò
a letto.
Al primo barlume dell'alba, quando vie e strade erano ancora deserte,
Baldassarre entrò di nascosto a Kerepes e corse subito dall'amico Fabiano. Bussò
alla porta della camera e udì una voce fioca e malata che diceva: «Avanti!»
Pallido, sfigurato, disperatamente afflitto, Fabiano era a letto. «Per amor del
cielo,» esclamò Baldassarre, «dimmi, amico, che cosa ti è capitato?»
«Oh, amico mio,» rispose Fabiano con voce rotta, sollevandosi con grande
fatica, «sono un uomo finito, proprio finito. La maledetta stregoneria che Prospero
Alpano nella sua smania di vendicarsi ha voluto infliggermi mi manda alla rovina.»
«Possibile?» fece Baldassarre. «Stregonerie, incantesimi: di solito non ci
credevi.»
Fabiano replicò con voce piagnucolosa: «Ahimè, adesso credo in tutto, nei
maghi, nelle streghe, negli spiriti della terra e dell'acqua, nei ratti uniti per la coda,
nella mandragora, in tutto quello che vuoi. Quando hai sulle spalle quello che ho io
ti arrendi, no? Non avrai dimenticato lo scandalo infernale suscitato dalla mia
giacca quando ritornammo dalla visita a Prospero. Ma fosse stato solo quello!
Guardati un po' in giro in questa camera, caro Baldassarre!» Questi guardò e a
tutte le pareti vide appesa una quantità di marsine, di soprabiti, di giubbe militari,
di ogni taglio possibile, di ogni colore immaginabile. «Come?» disse. «Vuoi forse
impiantare una bottega di abiti?»
«Lascia andare l'ironia, caro amico,» rispose Fabiano. «Ho fatto fare tutti
questi vestiti dai sarti più famosi sperando sempre di sottrarmi una buona volta
alla triste condanna che grava sui miei abiti, ma sempre invano. Basta che porti per
qualche minuto una bella giacca che mi sta a pennello ed ecco che le maniche si
ritirano fino alle spalle e le falde mi scodinzolano dietro per sei braccia di
lunghezza. Nella mia disperazione mi feci fare uno spencer con le maniche da
pierrot lunghe fino a terra, e pensavo: maniche, scivolate pure! falde, allungatevi
pure, vi sarà il compenso. Invece entro pochi minuti sempre la medesima cosa!
L'arte e l'energia dei sarti più potenti non poté nulla contro quel dannato
incantesimo. Va da sé che dovunque mi facessi vedere ero beffato e deriso, ma la
mia innocente ostinazione nel mostrarmi sempre in una giacca indemoniata
provocò presto ben altri giudizi. Che le donne mi considerassero infinitamente
vanitoso e privo di gusto, perché contro ogni usanza pretendevo di farmi vedere a
braccia nude pensando probabilmente che fossero bellissime, fu ancora il meno. I
teologi invece mi dichiararono un settario, disputando soltanto se dovessero
annoverarmi tra i manichiani o i faldiani, ma sempre d'accordo che queste sette
erano tutte e due pericolosissime, perché entrambe propugnavano il completo
libero arbitrio e usavano pensare quel che volevano. I diplomatici mi
considerarono un vile sobillatore: asserivano che con le lunghe falde volevo
suscitare il malcontento nel popolo e renderlo ribelle al governo, che in genere
facevo parte di una lega segreta il cui simbolo sarebbe una manica corta; già da
molto tempo, dicevano, si erano viste qua e là tracce di brachimanichiani, terribili
come i gesuiti, anzi più ancora, perché tendevano a introdurre dappertutto la
poesia dannosa allo stato, e dubitavano dell'infallibilità del principe. Insomma, la
faccenda diventava sempre più seria finché il rettore mi mandò a chiamare.
Prevedendo un disastro se indossavo la giacca mi presentai in panciotto. Quello
montò su tutte le furie credendo che volessi prenderlo in giro e mi ordinò di
presentarmi entro otto giorni con una giacca ragionevole e decente, altrimenti mi
avrebbe espulso senza remissione. Oggi scade il termine. Disgraziato me!
Maledetto Prospero Alpano!»
«Taci,» disse Baldassarre; «zitto, caro amico, non biasimare il mio caro zio
che mi ha fatto dono di un podere. E non vuole male neanche a te, nonostante
che, devo dire, abbia punito troppo duramente la tua impertinenza. Ma sono qui a
recarti aiuto. Egli ti manda questa scatoletta che deve por fine a tutte le tue pene.»
Cavò di tasca la scatola di tartaruga, ricevuta da Alpano, e la porse all'amico
sconsolato.
«Che mi serve?» osservò quest'ultimo. «Questa sciocchezza? Come può una
scatoletta di tartaruga influire sulla forma delle mie giacche?»
«Io non lo so,» rispose Baldassarre, «ma il mio caro zio non può ingannarmi
e non mi ingannerà. Ho piena fiducia in lui. Apri dunque la scatola, vediamo che
cosa c'è dentro.»
Fabiano eseguì... e dalla scatola uscì una stupenda marsina nera di panno
finissimo. I due amici non poterono fare a meno di manifestare a gran voce il loro
grande stupore.
«Adesso capisco,» disse Baldassarre entusiasta, «adesso ti capisco, mio caro
zio Prospero! Questo abito andrà bene e romperà ogni incantesimo.»
Fabiano lo indossò senz'altro: ciò che Baldassarre aveva supposto avvenne
realmente. Il bel capo stava a Fabiano come non gli era mai stato nessun vestito,
le maniche stettero al loro posto. Fuori di sé dalla gioia, Fabiano decise di correre
subito dal rettore e di sistemare ogni cosa.
Ora Baldassarre raccontò per filo e per segno all'amico come erano andate le
cose con Prospero Alpano e come questi gli aveva fornito i mezzi per porre fine alle
malefatte del mostruoso pollicino. Fabiano pareva interamente mutato perché
ogni scetticismo lo aveva abbandonato, e lodò la nobiltà d'animo di Prospero e si
offrì di dare una mano a disincantare Cinabro.
In quel momento Baldassarre vide dalla finestra l'amico Pulcher che scuro in
volto stava per svicolare. Per suggerimento di Baldassarre, Fabiano si sporse dal
davanzale, fece un cenno al cancelliere e lo pregò di salire.
Pulcher, appena entrato, esclamò: «Che bella giacca ti sei messo oggi, mio
caro Fabiano!» Questi disse però che Baldassarre gli avrebbe spiegato ogni cosa e
corse dal rettore.
Dopo che Baldassarre ebbe spiegato tutto al cancelliere questi osservò: «È
proprio ora di ammazzare quello sconcio mostricciattolo. Sappi che oggi celebra il
fidanzamento solenne con Candida, e quel vanesio di Terpin dà una gran festa alla
quale ha invitato perfino il principe. Ecco, durante questa festa entreremo nella
casa del professore e aggrediremo il nano. Non mancheranno le candele nella sala
per bruciare immediatamente quei perfidi capelli.»
I due amici avevano discorso a lungo e preso accordi allorché Fabiano arrivò
col viso raggiante.
«La potenza della giacca scaturita dalla scatoletta di tartaruga,» disse, «ha
dato ottima prova. Appena entrai dal rettore lo vidi sorridere soddisfatto. ‹Credo›,
disse, ‹mio caro Fabiano, che si sia liberato dal suo strano traviamento. Si sa, le
teste calde come lei si lasciano facilmente trascinare agli estremi. Non ho mai
creduto che fosse esaltazione religiosa, la sua, ma piuttosto un malinteso
patriottismo, la smania dello straordinario, fondata sull'esempio degli eroi
dell'antichità. Approvo volentieri la bella giacca che le sta così bene. Fortunato lo
stato, fortunato il mondo se giovani valorosi portano giacche simili con maniche e
falde di giusta misura. Resti fedele, Fabiano, a codesta virtù, a codesta bravura: di
lì rampolla il vero eroismo.› Il rettore mi abbracciò, mentre gli occhi gli si empivano
di lacrime. Non so nemmeno io come, ma fatto sta che trassi la scatoletta di
tartaruga che avevo messo nella tasca della marsina. ‹Grazie,› disse il rettore,
premendovi i polpastrelli del pollice e dell'indice. Senza sapere se ci fosse del
tabacco, fece scattare il coperchio della scatola. Vi affondò le dita, fiutò il tabacco,
mi strinse energicamente la mano, mentre le lacrime gli rigavano le guance.
‹Buona questa presa, nobile giovane,› disse profondamente commosso. ‹Tutto è
dimenticato e perdonato. Venga a colazione da me!› Come vedete, cari amici, le
mie pene sono terminate e se oggi riusciamo, come è da prevedere, a disincantare
Cinabro, anche voi sarete felici.»
Nella sala illuminata da cento candele il piccolo Cinabro si pavoneggiava in
un abito scarlatto con ricami, a tracolla l'ordine della tigre con venti bottoni, la
spada al fianco, il cappello piumato sotto il braccio. Accanto a lui stava la bella
Candida in abito di sposa, raggiante di grazia e giovinezza. Cinabro le teneva una
mano che portava ogni tanto alle labbra con un ghigno alquanto odioso. E tutte le
volte le guance di Candida si tingevano di un rosso più intenso, mentre il suo
sguardo fissava il nano con espressione di fervidissimo amore. Era una scena
veramente raccapricciante e solo l'accecamento dal quale tutti erano colpiti in
seguito all'incanto di Cinabro faceva sì che nessuno, indignato alla vista della
povera Candida irretita, acciuffasse il mostricciattolo stregato e lo buttasse nel
caminetto. Tutta la compagnia si era raccolta a rispettosa distanza intorno alla
coppia. Al fianco di Candida stava soltanto il principe Barsanufo che si sforzava di
lanciare intorno occhiate particolarmente benevole alle quali però nessuno
badava. Tutti avevano occhi soltanto per gli sposi e pendevano dalle labbra di
Cinabro che ogni tanto farfugliava parole incomprensibili, seguite ogni volta dal
sospiro di profonda ammirazione di tutti i presenti.
Era giunto il momento in cui si dovevano scambiare gli anelli di
fidanzamento. Mosce Terpin entrò nel cerchio con un vassoio sul quale
scintillavano gli anelli. Si raschiò in gola, mentre Cinabro si sollevava il più possibile
sulla punta dei piedi arrivando quasi al gomito della fidanzata. Tutti erano in
ansiosa attesa... allorché si udirono improvvisamente voci estranee, la porta della
sala si spalancò, Baldassarre irruppe insieme con Pulcher e Fabiano dentro al
cerchio.
«Che succede? Che cosa vogliono questi estranei?» furono le domande che
si incrociavano. Barsanufo manda un grido di spavento: «Sommossa! Ribellione!
Le guardie!» e balza dietro al parafuoco. Terpin riconosce Baldassarre giunto quasi
addosso a Cinabro e grida: «È matto, lei! È forse impazzito? Come si permette di
intervenire a questo fidanzamento? Gente! Servitori, buttate fuori questo villano!»
Ma senza curarsi di nulla Baldassarre ha estratto l'occhialino di Prospero e
attraverso questo fissa lo sguardo sul capo di Cinabro. Come colpito da un raggio
elettrico, Cinabro lancia uno stridulo miagolio che riecheggia da tutte le pareti.
Candida cade svenuta su una poltrona, la stretta cerchia della compagnia si
disperde. Agli occhi di Baldassarre appare chiaramente la riga color fuoco nei
capelli, egli balza addosso a Cinabro, lo afferra, mentre questi sgambetta e
recalcitra e gracchia e morde.
«Tenetelo, tenetelo!» grida Baldassarre. Fabiano e Pulcher agguantano il
nano che non può più muoversi e Baldassarre stringe a colpo sicuro i capelli rossi,
li sradica con un unico strappo, raggiunge con un balzo il caminetto, li butta nel
fuoco dove bruciano scoppiettando. Si ode un tuono fragoroso, tutti si destano
come da un sogno.
Ed ecco il piccolo Cinabro che, sollevatosi faticosamente da terra, impreca e
insulta e comanda di arrestare subito gli impertinenti perturbatori della quiete che
hanno messo le mani addosso alla sacra persona del primo ministro, e di buttarli
nel carcere senza fondo. Sennonché gli uni domandano agli altri: «Da dove è
venuto a un tratto questo saltimbanco? Che cosa vuole il mostricciattolo?» E
siccome il pollicino continua a tempestare e a battere i piedini per terra gridando:
«Io sono il ministro Cinabro... Sono il ministro Cinabro... La tigre a macchie verdi
con venti bottoni!» tutti si sganasciano dalle risa. Circondano il nano, gli uomini lo
sollevano e se lo buttano l'un l'altro come al giuoco della palla, di modo che gli
salta via un bottone dopo l'altro, e perde il cappello, perde la spada e le scarpe.
Barsanufo, il principe, sbuca da dietro il parafuoco e si trova in mezzo al
tumulto, mentre il nano stride: «Principe Barsanufo... serenissimo... salvi il suo
ministro, il suo beniamino... Aiuto, aiuto! Lo stato è in pericolo... la tigre verde...
ahi, ahi!» Il principe lancia un'occhiata furiosa al nano e si avvia a gran passi verso
la porta. Mosce gli taglia la strada. Quello lo prende per un braccio, lo trascina in
un angolo e gli parla mandando dagli occhi lampi di collera: «E lei ha l'impudenza
di recitare una stupida commedia al suo principe, al padre del paese? Lei mi invita
al fidanzamento di sua figlia col mio degno ministro Cinabro, e invece del ministro
trovo un esecrabile mostricciattolo al quale ha fatto indossare un magnifico
vestito! Lo sa, signore, che questo scherzo è alto tradimento che dovrei punire
severamente se lei non fosse uno sciocco da manicomio! La destituisco dall'ufficio
di direttore generale degli affari naturali e le proibisco di continuare a studiare
nella mia cantina. Addio!» E infilò la porta.
Terpin schiumante di rabbia si buttò addosso al piccolo, lo prese per i lunghi
capelli scarmigliati e corse alla finestra: «Adesso ti butto giù. Mostro sciagurato, mi
hai ingannato vergognosamente, hai distrutto tutto il bene della mia vita!»
Stava per buttarlo dalla finestra allorché il custode del museo zoologico che
era là presente accorse veloce come il lampo e strappò il piccolo dalle mani di
Terpin. «Fermo,» gridò, «fermo, professore, non abusi di una proprietà del
principe! Questo non è un mostro, è il Mycetes Beelzebub, la Simia Beelzebub,
scappata dal museo.»
«Simia Beelzebub... Simia Beelzebub!» si incominciò a gridare da tutte le
parti tra matte risate. Ma appena l'ebbe presa in braccio e la guardava
attentamente, il custode gridò inviperito: «Che cosa vedo? No, questa non è la
Simia Beelzebub, questo è un brutto e miserabile Radicino. Che schifo!» Così
dicendo lo lanciò in mezzo alla sala.
Accompagnato dalle risa sarcastiche dei presenti, il piccolo uscì di corsa
grugnendo e ciangottando, scese la scala e scappò a casa senza che alcuno dei
suoi servitori si accorgesse di lui.
Mentre questo avveniva nella sala, Baldassarre era entrato nello stanzino
dove, come aveva notato, era stata portata Candida priva di sensi. Le si buttò ai
piedi, le baciò le mani, la chiamò coi nomi più dolci. Infine lei rinvenne con un
profondo sospiro e appena vide Baldassarre esclamò beata: «Sei tu finalmente?
Eccoti qui, finalmente, mio diletto Baldassarre. Mi ero quasi consunta dalla
nostalgia e dalle pene d'amore, sentivo sempre la voce dell'usignolo che spreme il
sangue dal cuore della rosa purpurea commossa.»
Dimenticando tutto quanto le stava intorno cominciò a raccontare come,
irretita in un sogno maligno, le fosse sembrato di sentirsi nel cuore un mostro
abominevole al quale non era stata capace di negare il suo amore. Disse che un
mostro aveva saputo mascherarsi in modo da sembrare Baldassarre, e quando lei
pensava vivamente a quest'ultimo capiva benissimo che l'altro non era
Baldassarre, ma poi si sentiva inspiegabilmente costretta ad amare il mostro
appunto per amore di Baldassarre.
Questi le spiegò quel tanto che era possibile senza confonderle del tutto la
mente già agitata. Poi, come avviene sempre tra innamorati, si scambiarono mille
promesse, mille giuramenti di amore e di eterna fedeltà. E si abbracciavano, si
stringevano con la più fervida tenerezza e nella loro immensa gioia avevano
l'impressione di trovarsi in paradiso.
In quella entrò Mosce Terpin torcendosi le mani tra pianti e lamenti e con lui
vennero Pulcher e Fabiano che continuamente, ma invano, cercavano di
confortarlo.
«No, no,» ripeteva il professore. «Sono un uomo rovinato... non più direttore
generale degli affari naturali, non più uno studioso nella cantina principesca...
Caduto in disgrazia... E speravo di diventare cavaliere della tigre a macchie verdi
con almeno cinque bottoni... Tutto è finito! Che cosa dirà Sua Eccellenza il ministro
Cinabro quando saprà che l'ho scambiato con un volgare mostro, con la Simia
Beelzebub cauda prehensili, o che so io! Avrò addosso anche il suo odio!...
Alicante! Alicante...»
«Via, caro professore,» lo consolavano gli amici, «egregio direttore
generale, si renda conto che non c'è più il ministro Cinabro! Lei non ha commesso
nessuna colpa, quel coso deforme ha ingannato lei come tutti noi con la virtù
magica ottenuta dalla fata Rosabelverde.»
Baldassarre raccontò allora da principio tutto quanto era avvenuto. Il
professore stava in ascolto e quando Baldassarre ebbe finito esclamò: «Sogno?
Sono desto? Streghe... maghi... fate... specchi magici... simpatie... Dovrò credere
a queste astrusità?...»
«Oh, professore carissimo,» intervenne Fabiano, «se per qualche tempo
avesse portato, come me, una giacca con le maniche corte e lo strascico lungo, le
dico io che crederebbe allegramente in tutte queste cose.»
«Ecco,» disse Mosce Terpin, «sì, deve esser così... un mostro stregato mi ha
preso in giro... non mi reggo più in piedi... salgo al soffitto... Prospero Alpano mi
viene a prendere... sto a cavallo di una farfalla... mi faccio pettinare dalla fata
Rosabelverde... dalla signorina Rosabella e divento ministro... re... imperatore!»
E intanto saltava qua e là per la stanza e gridava e mandava strilli di gioia e
tutti erano in apprensione per le sue facoltà mentali, finché cadde sfinito su una
poltrona. Candida e Baldassarre gli si accostarono, gli dissero che si amavano così
fervidamente, così sopra ogni cosa che non avrebbero potuto vivere se non
insieme: e doveva essere un discorso melanconico perché Terpin piangeva
davvero. «Tutto quel che volete, figlioli,» disse singhiozzando. «Sposatevi,
amatevi, soffrite la fame insieme, poiché a Candida non darò un soldo di dote...»
In quanto alla fame Baldassarre rispose sorridendo che l'indomani contava di
convincere il professore come non se ne sarebbe parlato mai, perché Prospero
Alpano, suo zio, aveva già provveduto.
«Fallo, fallo, figliolo caro, se puoi, fallo domani,» soggiunse il professore con
voce fioca, «poiché per non impazzire, perché non mi scoppi la testa, adesso devo
mettermi a letto.»
E così fece senza indugio.
CAPITOLO IX
Imbarazzo di un cameriere fedele. - Come la vecchia Lisetta ordì una sommossa e
il ministro Cinabro ruzzolò fuggendo. - Modo strano in cui il medico personale del
principe spiegò l'improvvisa morte di Cinabro. - Come il principe Barsanufo si
turbò, mangiò cipolle, e la perdita di Cinabro rimase incolmabile.
La carrozza del ministro Cinabro era rimasta quasi tutta la notte invano
davanti alla casa di Mosce Terpin. Il suo cocchiere era stato avvertito più volte che
Sua Eccellenza doveva aver lasciato la compagnia già da un pezzo; egli ribatteva
che non era possibile, perché Sua Eccellenza non sarebbe certo corso a casa a
piedi sotto la pioggia e il temporale. Infine quando tutte le luci furono spente e
chiuse le porte, il cocchiere dovette pur partire con la carrozza vuota, ma in casa
del ministro svegliò subito il cameriere e lo invitò a dirgli per l'amor del cielo in che
modo il ministro fosse ritornato.
«Sua Eccellenza,» sussurrò il cameriere parlandogli all'orecchio, «è rientrato
ieri sera dopo il crepuscolo, questo è certo... e ora è a letto e dorme. Ma, mio caro
cocchiere, come? Vi dirò tutto... ma acqua in bocca... se Sua Eccellenza viene a
sapere che nel corridoio al buio ero io, sono un uomo perduto... ci rimetto il posto,
perché Sua Eccellenza è, sì, di statura piccola, ma è molto violento, facilmente si
scalda, non si ritrova più nell'ira, non più tardi di ieri ha inseguito per tutta la casa
con la spada sguainata un misero topolino che aveva avuto l'ardire di attraversare
saltellando la camera dove egli dorme. Dunque, al crepuscolo, mi metto la
mantellina e sto per infilarmi nella fiaschetteria per una partita di trictràc allorché
sento uno stropiccio, un sussurro per la scala, ed ecco che nel corridoio buio
qualcosa mi passa tra le gambe e stramazza al suolo e leva alte grida e si mette a
grugnire come... Dio mio, cocchiere, state zitto, nobile cuore, altrimenti sono
rovinato!... Venite più vicino... e grugnisce come sa grugnire Sua Eccellenza
quando il fuoco brucia un cosciotto di vitello o quando nello stato c'è qualcosa che
non gli va a genio.»
Il cameriere aveva detto queste ultime parole coprendo con una mano
l'orecchia del cocchiere. Questi si ritrasse, aggrottò la fronte e disse: «Possibile?»
«Sì,» continuò il cameriere, «era indubbiamente Sua Eccellenza, quel coso
che mi scivolò tra le gambe nel corridoio. Sentivo benissimo che apriva la porta
delle stanze l'una dopo l'altra, che spostava le sedie, finché giunse alla camera da
letto. Non ebbi l'ardire di seguirlo, ma dopo un paio d'ore andai in punta di piedi
alla sua porta e mi misi ad origliare. Sua Eccellenza russava esattamente come fa
quando si prepara qualcosa di grosso. Cocchiere! In cielo e in terra ci sono cose
che la nostra filosofia non ha sognate mai: così ho sentito dire una volta a teatro
un principe malinconico, tutto in nero, che aveva una gran paura di un uomo
vestito interamente di cartone grigio. Ieri deve essere successo qualche cosa di
stupefacente se Sua Eccellenza è venuto a casa in quel modo. Dal professore c'era
il principe che tra l'altro avrà proposto qualche bella riformuccia... ed ecco che il
ministro ci si butta subito, pianta lì il fidanzamento e si mette a lavorare per il bene
del governo. L'ho capito dal modo di russare. Vedremo qualche cosa di grande, di
magnifico. Chissà, cocchiere, può darsi che prima o poi tutti ci facciamo ricrescere
il ciuffo. Ma, caro amico, scendiamo ora e da servitori fedeli andiamo ad ascoltare
alla porta della camera se Sua Eccellenza è ancora coricato ed elabora
tranquillamente le idee migliori.»
Il cameriere e il cocchiere andarono piano piano a origliare. Cinabro russava,
soffiava e fischiava nelle più strane tonalità. I due servitori erano compresi di muto
rispetto e il cameriere osservò commosso: «Grande uomo, il nostro ministro!»
La mattina per tempo si udì al pianterreno della casa un enorme strepito.
Una vecchia contadina interamente avvolta nell'abito della festa, stinto da un
pezzo, si era insinuata in casa pregando il portiere di accompagnarla
immediatamente da suo figlio, il piccolo Zaches. Il portiere le aveva spiegato che
in quella casa abitava Sua Eccellenza il ministro Cinabro, cavaliere della tigre a
macchie verdi con venti bottoni, e tra la servitù non c'era nessuno che si chiamasse
Zaches. La donna si era messa a gridare all'impazzata che appunto il ministro
Cinabro dai venti bottoni era il suo caro figlioletto, il piccolo Zaches. Alle grida della
donna, alle tonanti imprecazioni del portiere erano accorsi tutti gli abitanti del
palazzo e lo strepito andò aumentando. Nel momento in cui scendeva il cameriere
per disperdere coloro che così spudoratamente osavano turbare il riposo
mattutino di Sua Eccellenza, veniva buttata fuori la donna che tutti avevano preso
per pazza.
La poveretta andò a sedersi sugli scalini di pietra della casa di fronte e
singhiozzava lamentandosi che quei villani là dentro non permettevano che
andasse dal suo adorato figliolo, dal piccolo Zaches diventato ministro. A poco a
poco si formò intorno a lei una folla alla quale continuava a ripetere che il ministro
Cinabro era suo figlio, quello che da giovane lei chiamava Zaches; alla fine non si
sapeva se crederla pazza o magari pensare che ci fosse qualcosa di vero.
La donna non distoglieva lo sguardo dalla finestra di Cinabro. A un tratto si
mise a ridere, batté le mani e gridò tutta contenta: «Eccolo... eccolo là, il mio
omino adorato... il mio piccolo gnomo... buongiorno, piccolo Zaches!» Tutti
guardarono in quella direzione e quando videro il piccolo Cinabro in abito scarlatto
ricamato, il nastro della tigre a tracolla, davanti al finestrone che arrivava al
pavimento, di modo che attraverso i vetri si poteva vedere la persona intera, risero
di cuore, gridando: «Piccolo Zaches, piccolo Zaches! Guardatelo, il babbuino come
si è fatto bello... Il mostricciattolo... il Radicino... il piccolo Zaches! Piccolo
Zaches!»
Il portiere e tutti i servitori di Cinabro uscirono per vedere di che cosa il
popolo ridesse così di gusto e andasse in solluchero. Ma appena videro il loro
padrone si associarono più che mai alle matte risate del popolo: «Piccolo Zaches...
Radicino... Pollicino!»
Soltanto ora il ministro parve accorgersi che quella tumultuosa
manifestazione era per lui. Spalancò la finestra, guardò nella strada con gli occhi
scintillanti di rabbia, gridò, tempestò, saltellò furibondo, minacciò di chiamare le
guardie, la polizia... promise prigione e fortezza.
Ma quanto più Sua Eccellenza tempestava, tanto più aumentavano il
trambusto e le risate, finché si cominciò a lanciare all'infelice ministro sassi e
frutta, verdure e tutto quanto la gente si trovava sottomano, sicché dovette
rientrare.
«Dio del cielo,» esclamò il cameriere atterrito, «alla finestra di Sua
Eccellenza si è affacciato il piccolo mostro detestabile... Come mai? Come ha fatto
quello stregoncello a entrare nelle stanze?» Salì le scale di corsa, ma, come prima,
trovò chiusa la camera del ministro. Si fece coraggio e bussò, ma nessuno rispose.
Intanto, Dio sa in che modo, si era levato dalla gente un cupo mormorio: si
diceva che quel piccolo mostricciattolo lassù era davvero il piccolo Zaches il quale,
assunto il sonante nome di Cinabro, aveva fatto carriera con ogni sorta di
vergognosi inganni e menzogne. Le voci si andavano facendo sempre più forti:
«Abbasso quella bestiola... abbasso! Togliete al piccolo Zaches la giacca di
ministro a furia di botte... chiudetelo in gabbia... fatelo vedere alla fiera, a
pagamento!... Indoratelo e regalatelo ai bambini perché giochino!... Andiamo su;
andiamo su!» E tutta la gente mosse all'assalto del palazzo.
Il cameriere si metteva le mani nei capelli: «Sommossa... ribellione...
Eccellenza... apra... si salvi!» Così gridava ma non ottenne alcuna risposta, udì
soltanto un gemito.
Il portone fu abbattuto, il popolo salì la scala rumorosamente tra risate
selvagge.
«Non c'è tempo da perdere,» disse il cameriere e si lanciò con tutta la sua
forza contro la porta della camera sollevandola dai cardini con grande fracasso.
Sua Eccellenza non c'era! Cinabro era scomparso. «Eccellenza... non sente la
sommossa? Per carità, Eccellenza, dove mai il diavolo... Dio mi perdoni, dove si
degna di essere?»
Correva disperato da una stanza all'altra, ma dalle pareti di marmo non
veniva nessuna voce, nessuna risposta, soltanto un'eco sarcastica. Cinabro
sembrava scomparso senza aver lasciato traccia.
Fuori lo strepito era diminuito e il cameriere udì la voce sonora di una donna
che parlava al popolo: e guardando dalla finestra osservò che a poco a poco la
gente, mormorando sottovoce, lasciava la casa lanciando alle finestre occhiate
sospette. «Pare che il tumulto sia placato,» disse il cameriere. «Sento che ora Sua
Eccellenza vorrà sbucare dal suo nascondiglio.»
Si recò nella camera supponendo che il ministro doveva pur trovarsi là.
Guardando in giro notò che da un bel vaso d'argento, a due manici, il quale stava
sempre accanto al pettinatoio perché era un dono del principe e il ministro l'aveva
molto caro, sbucavano due gambette.
«Dio mio, Dio mio!» gridò costernato. «Se non m'inganno, quelle gambette
sono di Sua Eccellenza il ministro Cinabro, mio generoso signore.» Si avvicinò e
scosso da brividi per lo spavento guardò nel vaso: «Eccellenza, Eccellenza, per
carità, che cosa sta facendo lì dentro?»
Ma siccome Cinabro non rispose, il cameriere si rese conto del pericolo che
correva Sua Eccellenza e capì che era ora di abbandonare ogni rispetto. Prese
Cinabro per le gambette e lo tirò fuori. Ahimè! Morto, morta la piccola Eccellenza!
Il cameriere scoppiò in clamorosi lamenti: il cocchiere, la servitù, tutti accorsero, si
mandò a chiamare il medico del principe. Intanto il cameriere asciugò con
pannolini puliti il suo povero disgraziato padrone, lo portò a letto e lo coprì con
cuscini di seta, di modo che rimase visibile soltanto il visetto raggrinzito.
In quella entrò la signorina Rosabella. Prima aveva calmato il popolo, il cielo
sa come. Ora si avvicinò all'inanimato Cinabro, seguita dalla vecchia Lisetta, la
vera madre del piccolo Zaches. Morto, Cinabro sembrava davvero più bello di
quanto non fosse mai stato in tutta la vita. Aveva gli occhietti chiusi, il nasino
candido, la bocca leggermente atteggiata a un mite sorriso, ma soprattutto i
capelli castani fluivano ondulati in bellissime ciocche. La signorina passò una mano
sulla sua testa e in quell'istante vi balenò debolmente una striscia rossa.
«Ecco» esclamò la signorina cui gli occhi lucevano dalla gioia, «Prospero
Alpano, grande maestro, ecco che mantieni la tua parola! Il destino è scontato e
con esso ogni ignominia.»
«Oh, buon Dio,» disse Lisetta, «questo non è certo il mio piccolo Zaches, non
è mai stato così bello. Allora sono venuta per niente in città e voi, signorina, non mi
avete consigliato bene!»
«Vecchia, non borbottare!» la redarguì la signorina. «Se aveste seguito
regolarmente il mio consiglio e non foste penetrata in questa casa prima che io
fossi qui, tutto andrebbe meglio per voi. Vi ripeto, quel piccolo morto là nel letto è
in verità vostro figlio, il piccolo Zaches.»
«Allora,» osservò la vecchia con gli occhi lustri, «se quella piccola Eccellenza
è veramente mio figlio, vuol dire che erediterò tutte le belle cose che ci sono qui
intorno, il palazzo con tutto quanto contiene, non è vero?»
«No,» rispose la signorina, «son cose passate. Avete mancato il momento
giusto di acquistare beni e denaro. Ve l'ho già detto, la ricchezza non è per voi.»
«Posso allora,» continuò la donna mentre le spuntavano le lacrime,
«prendere il mio povero ometto nel grembiule e portarmelo a casa? Il nostro
signor pastore ha tanti uccelletti e scoiattoli impagliati, lo pregherò di impagliare
anche il mio piccolo Zaches e lo metterò sull'armadio a perpetuo ricordo, così come
sta, in giubba rossa, con tanto di nastro e di stella sul petto.»
«No, non è possibile,» rispose la signorina quasi seccata, «è un'idea
balorda.»
La vecchia si mise a singhiozzare e a lamentarsi: «Che cosa gliene viene se
il piccolo Zaches è salito alle alte cariche, a grandi ricchezze? Fosse piuttosto
rimasto con me, l'avrei allevato nella mia povertà, non sarebbe mai capitato in
questo maledetto coso d'argento, sarebbe ancora vivo e io forse ne avrei gioia.
Quando l'avessi portato in giro con la gerla della legna, la gente impietosita mi
avrebbe dato qualche soldino, ora invece...»
Dall'anticamera venne un rumore di passi, la signorina mandò fuori la
vecchia ordinandole di aspettare laggiù davanti alla soglia, perché prima di partire
le voleva confidare un mezzo infallibile per porre subito termine a tutte le sue
miserie.
Ed ecco entrare ancora Rosabelverde e parlare al piccolo con la voce
tremante di grande pietà. «Povero Zaches, figliastro della natura, le mie intenzioni
erano buone. Può essere stata una sciocchezza credere che il mio bel dono
esteriore recasse lume nel tuo intimo e suscitasse necessariamente una voce per
dirti: Tu non sei quello che ti si crede, ma cerca ciò nonostante di imitare colui sulle
cui ali, sciancato e implume come sei, ti sollevi in alto! Ma nessuna voce interiore
si destò. Il tuo spirito pigro e stento non ha saputo sollevarsi, e tu hai perseverato
nella tua stupidità, villania e malacreanza. Oh, fossi stato un po' meno zotico e
villano, avresti evitato la morte ignominiosa. Ma Prospero Alpano ha provveduto a
che ora, dopo la tua morte, ti si riconsideri quale in vita sembravi in virtù mia. Sarò
lieta se forse ti vedrò ancora da insettuccio, da svelto topolino o agile scoiattolo.
Dormi bene, piccolo Zaches!»
Nel momento in cui Rosabelverde usciva, entravano il medico del principe e
il cameriere. «In nome di Dio,» esclamò il medico vedendo Cinabro esanime e
convincendosi che tutti i mezzi per richiamarlo in vita sarebbero stati vani, «dica,
cameriere, come sono andate le cose?»
«Oh, caro dottore, la sommossa o rivoluzione che sia, la chiami come vuole,
infuriava e imperversava paurosamente nell'anticamera. Sua Eccellenza temendo
per la propria vita preziosa ha voluto certamente rifugiarsi nel gabinetto, è
ruzzolato e...»
«Sicché,» sentenziò il dottore commosso e solenne, «per la paura di morire,
è morto addirittura.»
La porta si spalancò e il principe Barsanufo entrò a precipizio, sbiancato in
viso, seguito da sette camerlenghi ancora più pallidi.
«È vero? È proprio vero?» gridò, ma non appena vide la piccola salma fece
un balzo indietro e alzando gli occhi al cielo parlò con una espressione di profondo
dolore: «Oh, Cinabro!» I sette camerlenghi ripeterono: «Oh, Cinabro!» e imitando
il principe trassero dalla tasca il fazzoletto e se lo portarono agli occhi.
«Quale perdita!» cominciò il principe dopo un momento di silenzioso
cordoglio. «Quale incolmabile perdita per lo stato! Dove trovare un uomo che porti
l'ordine della tigre a macchie verdi con venti bottoni con la stessa dignità del mio
Cinabro! E lei, dottore, ha potuto lasciar morire un uomo simile! Dica come è
andata, come è potuto accadere... quale ne è stata la causa... di che cosa è morto
quest'uomo eccellente?»
Il medico osservò il piccolo molto attentamente, gli tastò più volte i polsi
ormai spenti, passò una mano sulla testa, si raschiò in gola e cominciò:
«Serenissimo signore, se dovessi limitarmi a nuotare in superficie, potrei dire che
il ministro è morto per l'assoluta mancanza di respiro, e questa mancanza era
dovuta all'impossibilità di tirare il fiato. E questa impossibilità era a sua volta
causata dall'elemento, dall'umore nel quale il ministro è precipitato. Potrei dire che
in questo modo il ministro ha fatto una morte umoristica, ma lungi da me questa
superficialità, lungi da me la smania di voler spiegare con miserabili principi fisici
tutto quanto trova la sua naturale incrollabile motivazione soltanto su un terreno di
fatti puramente psichici. Mio serenissimo principe, libera deve essere la parola
dell'uomo: ecco, il ministro trovò il primo germe della morte nell'ordine della tigre
con venti bottoni.»
«Come?» esclamò il principe lanciando al medico un'occhiata piena di
sdegno. «Che cosa dice mai? L'ordine della tigre con venti bottoni? Quella che il
defunto portava con tanta grazia, con tanta dignità a beneficio dello stato, quella
sarebbe la causa della sua morte? Me lo dimostri, oppure... camerlenghi, che cosa
ne dite voi?»
«Deve dimostrare, deve dimostrare oppure...» sentenziarono i sette pallidi
camerlenghi, mentre il medico proseguiva: «Ottimo serenissimo principe, lo
dimostrerò. Perciò niente oppure!... Le cose stanno nel modo seguente: la pesante
onorificenza appesa al nastro, ma soprattutto i bottoni sulla schiena ebbero effetti
dannosi sui gangli della spina dorsale. Nello stesso tempo la stella dell'ordine
esercitò una pressione su quella cosa nodosa filiforme fra il treppiede e l'arteria
superiore del mesenterio che noi chiamiamo l'intreccio solare, il quale predomina
nel tessuto labirintico degli intrecci nervosi. Quest'organo dominante sta in
molteplici rapporti col sistema cerebrale, e naturalmente l'attacco ai gangli fu
nocivo anche a questo. Ora, il libero condotto del sistema cerebrale non è forse
condizione della coscienza, della personalità in quanto espressione della più
perfetta unione del tutto in un punto focale? Non è il processo vitale l'attività nelle
due sfere, nel sistema dei gangli e del cervello? Ebbene, quell'attacco turbò le
funzioni dell'organismo psichico. Prima sorsero idee sinistre di ignote abnegazioni
in favore dello stato, dovute alla dolorosa sopportazione di quell'ordine e così via,
le condizioni divennero sempre più insidiose finché la completa disarmonia del
sistema dei gangli e del cervello provocò la totale cessazione della coscienza, la
totale perdita della personalità. A queste condizioni noi diamo il nome di morte.
Sicuro, mio signore, il ministro aveva gia perduto la personalità, era dunque bell'e
morto quando precipitò in quel recipiente fatale. Così la sua morte non ebbe una
causa fisica, bensì una causa psichica, smisuratamente profonda.»
«Dottore,» disse il principe indispettito, «lei chiacchiera già da mezz'ora e io
voglio essere dannato se ho capito una sillaba. Dove vuol andare a parare col suo
fisico e psichico?»
«Il principio fisico,» riprese il medico, «è condizione della vita puramente
vegetativa, quello psichico invece condiziona l'organismo umano che trova la molla
motrice dell'esistenza soltanto nello spirito, nella forza del pensiero.»
«Lei è incomprensibile,» soggiunse il principe nel suo malumore, «non la
capisco ancora.»
«Voglio dire,» ribatté il dottore, «che il fisico si riferisce con la mente alla vita
meramente vegetativa, priva di pensiero, come la si trova nelle piante, lo psichico
invece alla forza di pensiero. Ora, come questa predomina nell'organismo umano,
il medico deve partire sempre dal pensiero, dallo spirito, e vedere nel corpo
soltanto un vassallo dello spirito che si deve assoggettare ogni qualvolta il suo
padrone lo vuole.»
«Bene, bene,» conchiuse il principe, «lasciamo andare, dottore! Curi il mio
corpo e lasci stare il mio spirito, di questo non ho ancora sentito mai nessun
disturbo. Lei, dottore, è un gran confusionario, e se non stessi qui davanti alla
salma del mio ministro e non fossi commosso, so io che cosa farei. Orsù,
camerlenghi, versiamo ancora alcune lacrime sul catafalco del defunto e poi
andiamocene a tavola.»
Il principe si tenne il fazzoletto sugli occhi e singhiozzò, i camerlenghi fecero
altrettanto, e poi se ne andarono tutti insieme.
Fuori della porta c'era la vecchia Lisetta che teneva appese al braccio alcune
reste delle più belle cipolle giallo-dorate. Il principe le vide per caso, si fermò,
mentre l'espressione di dolore scompariva dal suo volto, sorrise con dolcezza e
disse: «Oh, guarda, non ho mai visto cipolle così belle. Devono essere squisite. Le
vendete, buona donna?»
«Sì, sì,» rispose Lisetta con un profondo inchino, «certo, serenissimo,
appunto vendendo cipolle vado avanti come posso. Sono dolci come il miele, ne
vuole, signore?» E così dicendo porse al principe una resta delle più belle e più
lustre.
Quegli le prese ridendo, biascicò un poco e si rivolse ai camerlenghi: «Uno di
voi mi dia, per piacere, il temperino.» Ricevutolo il principe svestì una cipolla con
molto garbo e ne assaggiò un pezzo. «Che sapore! Che bontà! Che forza! Che
fuoco!» esclamò mentre gli occhi gli brillavano dalla gioia. «Mi pare quasi di vedere
davanti a me il defunto Cinabro che mi fa cenni e sussurra: Principe, le compri,
mangi queste cipolle... lo esige il bene dello stato!»
Il principe mise in mano alla vecchia alcune monete d'oro e i camerlenghi
dovettero infilarsi nelle tasche tutte le reste di cipolle. Non basta: ordinò che
nessuno tranne quella vecchia poteva fornire cipolle per le colazioni del principe.
Così la madre del piccolo Zaches, senza proprio arricchire si salvò dal bisogno e
dalla miseria, ed è certo che lo dovette a un incanto segreto della buona fata
Rosabelverde.
Il funerale del ministro Cinabro fu tra i più sontuosi che si fossero visti a
Kerepes. Il principe e i cavalieri della tigre pezzata seguivano la salma in lutto
profondo. Tutte le campane suonavano e si spararono perfino i due mortaretti che
il principe aveva acquistati a caro prezzo per i fuochi d'artificio. Cittadini, popolo,
tutti piangevano e lamentavano che lo stato avesse perduto il migliore sostegno e
probabilmente il timone del governo non sarebbe mai venuto nelle mani di un
uomo che possedesse la grande intelligenza, la magnanimità, la clemenza,
l'instancabile zelo di Cinabro per il pubblico benessere.
Infatti la perdita fu incolmabile: non si trovò mai più un ministro cui l'ordine
della tigre con venti bottoni si fosse adattato alla persona come al defunto
indimenticabile Cinabro.
CAPITOLO ULTIMO
Malinconiche richieste dell'autore. - Come il professor Mosce Terpin si calmò e
Candida non poté mai più stizzirsi, come un coleottero d'oro mormorò qualcosa
all'orecchio del dottor Prospero Alpano, come questi prese commiato e
Baldassarre ebbe una felice vita coniugale.
Siamo ora al punto nel quale colui che scrive questi fogli per te, caro lettore,
deve lasciarti, mentre lo prende una grande ansietà, una grande tristezza. Egli
saprebbe ancora molte e molte gesta memorabili del piccolo Cinabro; e, come a
narrare questa storia fu irresistibilmente spinto dal suo cuore, avrebbe una gran
voglia di raccontarti ancora, mio lettore, tutte queste cose. Però, riandando gli
avvenimenti che si sono svolti nei nove capitoli, sa che essi contenevano già tante
cose meravigliose, pazzesche, contrarie al freddo buon senso che, accumulando
ancora cose del genere, correrebbe il rischio di abusare della tua indulgenza e di
guastarsi addirittura con te. Perciò, nella tristezza, nell'angoscia che gli strinse
improvvisamente il cuore quando scrisse le parole «Capitolo ultimo», ti chiede di
accettare con animo sereno e imparziale, anzi di accogliere da amico quelle strane
invenzioni che lo scrittore deve al suggerimento di Fantaso, lo spirito estroso, alla
cui natura capricciosa e bizzarra si è affidato forse un po' troppo. Ma per questo
non tenere loro il broncio, allo scrittore e allo spirito estroso! Se, caro lettore, hai
sorriso ogni tanto dentro di te per qualche avvenimento, eri esattamente nello
stato d'animo che lo scrittore di questi fogli si augurava, e allora è convinto che
molte cose gli vorrai perdonare.
A rigore la storia poteva conchiudersi con la tragica morte del piccolo
Cinabro. Ma non è più bello che invece di un mesto funerale ci sia alla fine un gaio
matrimonio?
Diremo dunque ancora in breve della soave Candida e dell'ottimo
Baldassarre.
Generalmente il professor Mosce Terpin era un uomo illuminato, esperto del
mondo, che, conformemente al consiglio del Nil admirari, da molti anni non si
stupiva di nulla in questo mondo. Ora invece rinunciando a tutta la sua saggezza fu
costretto a meravigliarsi continuamente, al punto che infine affermava di non
sapere più se fosse realmente il professor Terpin che a suo tempo aveva diretto gli
affari naturali dello stato e se ancora camminasse con le proprie gambe e tenesse
la testa sulle spalle.
In primo luogo si meravigliò quando Baldassarre gli presentò il dottor
Prospero Alpano come zio e questi gli mostrò l'atto di donazione, col quale
Baldassarre diventava proprietario della villa distante un'ora da Kerepes, compresi
i boschi, i campi e i prati; si meravigliò quando, quasi non credendo ai propri occhi,
trovò menzionati nell'inventario oggetti preziosi, persino verghe d'oro e d'argento
il cui valore superava di gran lunga quello del tesoro principesco. Poi si meravigliò
quando guardò attraverso l'occhialino di Baldassarre il magnifico feretro nel quale
giaceva Cinabro riportando l'impressione che non era mai esistito un ministro
Cinabro, ma soltanto un mostricciattolo screanzato e zotico che per errore era
stato considerato saggio e intelligente. Ma la meraviglia di Mosce Terpin giunse al
colmo quando Alpano gli fece da guida nella villa, gli mostrò la biblioteca e altre
cose meravigliose, gli fece perfino alcuni graziosi esperimenti con piante e animali
strani. Il professore concepì l'idea che tutto il suo studio della natura fosse privo di
valore ed egli si trovasse giunto in un vario mondo incantato come dentro a un
uovo. Questo pensiero lo perseguitò talmente che finì col piangere come un
bambino. Baldassarre lo accompagnò fino nella spaziosa cantina dove apparvero
botti lucide e bottiglie scintillanti. Meglio che nella cantina principesca, osservò
Baldassarre, poteva studiare qui ed esplorare la natura nel magnifico parco. A
questo punto il professore si calmò.
Le nozze di Baldassarre vennero celebrate nella villa. Egli stesso, gli amici
Fabiano e Pulcher, tutti ammirarono stupiti la bellezza di Candida e il fascino che
emanava dal suo abito e da tutta la sua persona. Era veramente un incanto poiché
la fata Rosabelverde, che dimenticando ogni corruccio assisteva alle nozze sotto le
spoglie di Rosabella, era stata lei a vestirla e ad ornarla delle più splendide rose.
Ora tutti sanno che un abito deve star bene se vi pone mano una fata. Oltre a ciò
Rosabelverde aveva donato alla bella sposa una magnifica collana scintillante che
esercitava questa malia: chi se la metteva non poteva mai più stizzirsi di nessuna
inezia, di un nastro male annodato, di una pettinatura mal riuscita, di una macchia
sulla biancheria o altro. Questa qualità conferitale dalla collana aggiungeva al suo
volto una particolare grazia e serenità.
La coppia toccava il cielo col dito e (così bene agiva l'incanto segreto di
Alpano) non aveva ancora dedicato né una parola né uno sguardo ai cari amici
invitati. Alpano e Rosabelverde provvidero a che le più belle meraviglie
avvenissero il giorno delle nozze. Da tutti gli alberi e gli arbusti risonavano dolci
parole d'amore, mentre tavole imbandite sorgevano cariche di cibi saporiti, di
bottiglie di cristallo dalle quali usciva un vino nobilissimo che empiva di fuoco vitale
le vene di tutti gli ospiti.
Scesa la notte si videro arcobaleni di fuoco stendersi sopra il parco, uccelli e
insetti luminosi che salivano e scendevano, e quando agitavano le ali, sprizzavano
milioni di scintille, le quali formavano continuamente figurazioni cangianti che
aleggiando nell'aria scomparivano poi nei cespugli. E intanto la musica del bosco si
rafforzava e il vento notturno sussurrava misterioso spargendo deliziosi profumi.
Baldassarre, Candida e gli amici riconobbero la potente magia di Alpano,
mentre Terpin, piuttosto alticcio, si sgangherava dalle risa e andava dicendo che
sotto a tutte quelle diavolerie si nascondeva lo scenografo e pirotecnico del
principe.
A un certo punto si sentirono squillanti rintocchi di campane. Un luminoso
coleottero d'oro scese dall'alto, si posò su una spalla di Prospero Alpano e gli
bisbigliò qualche cosa all'orecchio. Alpano si alzò dalla poltrona e disse con solenne
gravità: «Baldassarre diletto, dolce Candida, amici miei! È venuto il momento,
Lotos mi chiama, devo partire.»
Si avvicinò agli sposi e parlò sottovoce con loro. Baldassarre e Candida erano
molto commossi, si capiva che Prospero impartiva loro preziosi insegnamenti
finché li abbracciò cordialmente. Poi si rivolse alla signorina Rosabella e anche con
lei parlò sottovoce: lei gli dava probabilmente incarichi in questioni di fate e magie
ed egli li accoglieva volentieri.
Intanto era sceso dall'aria un piccolo cocchio di cristallo tirato da due lucenti
libellule che erano guidate dal fagiano argentato.
«Addio, addio!» esclamò Alpano e salito sul cocchio si portò sopra gli
arcobaleni di fiamma finché il veicolo apparve un'ultima volta nell'alto come una
stellina sfavillante e poi scomparve dietro alle nuvole.
«Che bella mongolfiera!» russò Mosce Terpin e sopraffatto dalla forza del
vino cadde in un sonno profondo.
Baldassarre, memore degli insegnamenti di Prospero, amministrando bene
la splendida villa, diventò realmente un ottimo poeta, e siccome le altre qualità che
Prospero aveva fatto notare a proposito della bella Candida, diedero ottima prova,
Candida d'altro canto non si tolse mai la collana ricevuta in dono di nozze da
Rosabella, non poté mancare che Baldassarre trascorresse la più felice vita
coniugale, in gioie e bellezze che soltanto un poeta insieme con una bella e
giovane moglie poteva trascorrere...
Così la fiaba del piccolo Zaches, detto Cinabro, è arrivata realmente alla sua
gaia fine.
IL VASO D'ORO
(UNA FIABA DEI TEMPI NUOVI)
PRIMA VEGLIA
Le sventure dello studente Anselmo. - Il tabacco del vicepreside Paulmann e le
serpi verde-oro.
Il giorno dell'Ascensione alle tre del pomeriggio un giovane usciva di corsa
dalla Porta Nera di Dresda e andava diritto contro un paniere di mele e focaccine
che una brutta vecchia offriva in vendita, di modo che tutto quanto non fu
schiacciato venne scaraventato fuori e i monelli si spartirono allegramente la preda
che quel signore frettoloso aveva loro gettato. Alle strida della vecchia le comari si
alzarono dai tavolini dove vendevano dolci e grappa, circondarono il giovanotto e
si misero a insultarlo con foga plebea finché, ammutolito dalla stizza e dalla
vergogna, egli tirò fuori il borsellino non proprio gonfio e lo porse alla vecchia che
lo afferrò avidamente e lo intascò in gran fretta. Allora lo stretto circolo si aprì, ma
mentre il giovane prendeva la fuga, la vecchia gli gridò dietro: «Sì, corri... corri
pure, figlio del diavolo... dentro il cristallo presto cadrai... dentro al cristallo!»
La voce stridula e gracchiante della donna aveva un che di pauroso, di
maniera che i passanti si fermarono meravigliati e le risate che prima erano
scoppiate tutto a un tratto si spensero. Lo studente Anselmo (il giovane infatti era
lui), pur non comprendendo affatto le strane parole di quella donna, fu preso da
uno spontaneo terrore e affrettò più che mai il passo per sottrarsi agli sguardi della
folla curiosa. Mentre si faceva largo tra la gente vestita a festa udì mormorare di
qua e di là: «Povero giovane... Accidenti a quella vecchia!» Le misteriose parole di
lei avevano conferito al ridicolo incidente un certo aspetto tragico facendo sì che
tutti seguissero con occhiate di simpatia l'uomo che prima era passato inosservato.
Le ragazze perdonarono al viso gentile la cui espressione era diventata più vivace
per l'ardore del dispetto provato, come pure alla bella statura del giovane tutta la
sua sbadataggine e l'abito assolutamente fuori di moda: infatti la sua marsina
grigio-azzurra pareva tagliata da un sarto che doveva conoscere la foggia
moderna soltanto per sentito dire, e il panciotto di raso nero, ben conservato,
seguiva un certo stile pedantesco al quale però mal si adattavano il passo e il
portamento.
Era quasi arrivato in capo al viale che porta ai Bagni di Link quando lo
studente si sentì mancare il fiato. Fu costretto a rallentare il passo, ma senza osare
alzare lo sguardo perché ancora vedeva ballare intorno le mele e le focaccine, e le
occhiate cortesi di qualche ragazza gli sembravano soltanto un riflesso delle
compiaciute risate alla Porta Nera. Così giunse all'ingresso dei Bagni dove
entravano l'uno dopo l'altro gruppi di persone in abito festivo. Dall'interno veniva
l'eco di una musica di strumenti a fiato e la calca degli ospiti allegri si andava
facendo sempre più rumorosa. Il povero studente si sentì montare le lacrime agli
occhi perché aveva sempre festeggiato in famiglia il giorno dell'Ascensione e
anche lui avrebbe voluto partecipare alle beatitudini del paradiso di Link, anzi
intendeva arrivare fino a mezza porzione di caffè col rum e a un'intera bottiglia di
birra forte; e per darsi allo scialo aveva preso con sé più denaro di quanto a rigore
non gli fosse lecito o possibile. Ed ecco che la malaugurata pedata al paniere delle
mele lo aveva privato di quanto aveva con sé. Non era più il caso di pensare al
caffè, alla birra forte, alla musica, alla vista delle fanciulle in ghingheri, insomma a
tutti i godimenti sognati. Perciò passò via lentamente e infilò la via lungo l'Elba che
in quel momento era deserta. Sotto un sambuco che sbucava da un muretto trovò
un posticino coperto di erba; si sedette e caricò la pipa col tabacco che gli aveva
regalato il vicepreside Paulmann, suo amico. Davanti ai suoi piedi gorgogliavano e
sciaguattavano le onde giallo-oro dell'Elba, al di là della quale si stendeva la
bellissima Dresda che ardita e superba innalzava le torri luminose al cielo il quale
scendeva sui prati fioriti e sul fresco verde dei boschi, mentre in lontananza le
montagne dentate annunciavano la Boemia. Guardando accigliato davanti a sé
Anselmo lo studente sbuffava mandando nuvole di fumo finché il suo malumore si
sfogò con queste parole: «È pur vero che sono nato per caricarmi addosso tutte le
croci possibili. Non occorre dire che non ho mai trovato il fagiuolo nella focaccia, e
giocando a pari e caffo non ho mai colto nel segno, che la mia fetta di pane
imburrato è sempre caduta dalla parte del burro: ma non è forse un atroce destino
se, essendo finalmente arrivato all'università a dispetto del diavolo, ho dovuto e
devo vivere sotto gli occhi di babbo e mamma? Indosso io forse una giacca nuova
senza farmi subito la prima volta una macchia di unto o procurarmi uno strappo
contro un chiodo malamente infitto? Saluto mai un commendatore o una dama
senza scagliare lontano il cappello o magari slittare sul terreno liscio e fare un
vergognoso capitombolo? Non sostenevo già a Halle ogni giorno di mercato una
spesa di tre o quattro soldi per pentole rotte perché il diavolo mi mette in mente di
andare sempre per la via diritta come i lemmi? Sono forse arrivato una sola volta
puntualmente alla lezione o dove ero stato invitato? Che mi giovava uscire di casa
mezz'ora prima e mettermi davanti alla porta col picchiotto in mano? appena infatti
stavo per battere allo scoccare dell'ora, Satana mi rovesciava un catino sulla testa
o mi faceva imbattere in una persona che usciva implicandomi in qualche lite e
facendomi arrivare sempre in ritardo. Ahimè, dove siete andati a finire, sogni beati
di gioie future, quando mi figuravo di poter arrivare al posto di segretario? Ma la
mia cattiva stella non mi ha forse inimicato i più importanti protettori? So bene che
il consigliere segreto al quale fui raccomandato non può soffrire i capelli corti; il
parrucchiere mi attacca faticosamente alla nuca un bel ciuffo, ma al primo inchino
la disgraziata funicella si rompe e un allegro cagnolino che mi ha fiutato da tutte le
parti porta trionfante il mio ciuffo al consigliere. Gli corro dietro spaventato e cado
riverso sulla tavola dove sta lavorando e facendo colazione di modo che latte,
piatti, calamaio, spolverino cadono a terra tintinnando e un rigagnolo di inchiostro
e cioccolata inonda la relazione appena scritta. ‹Che cosa fa? È matto?› urla il
consigliere inviperito e mi spinge alla porta. Che mi serve se Paulmann mi ha fatto
sperare un posto di scrivano? Me lo concederà forse la cattiva stella che mi
perseguita dappertutto? E oggi stesso: volevo festeggiare tranquillamente il
simpatico giorno dell'Ascensione, ero disposto a non badare a spese. Come
qualunque altro ai Bagni di Link avrei potuto esclamare dall'alto in basso:
‹Cameriere, una bottiglia di birra forte, ma la migliore, mi raccomando!› Fino a
tarda sera potevo star là magari accanto a un gruppo di belle ragazze. Son sicuro
che mi sarebbe venuto il coraggio, sarei diventato un altro. Se l'una o l'altra mi
avesse domandato: ‹Che ora sarà mai?› oppure: ‹Che cosa stanno sonando?›
sarei stato capace di balzare elegantemente in piedi senza rovesciare il mio
bicchiere o capitombolare sulla panca; con un inchino sarei avanzato di un passo
e mezzo e avrei detto: ‹Mi permetta, signorina, che mi metta a sua disposizione:
questo è il preludio della Naiade danubiana›, oppure: ‹Manca poco alle sei.› Chi
avrebbe potuto pensar male di me? Certamente nessuno. Le ragazze si sarebbero
scambiate occhiatine maliziose come avviene quando ho l'ardire di far vedere che
anch'io so essere uomo di mondo e trattare con le dame. Ma il diavolo mi conduce
contro quella maledetta cesta di mele e ora me ne devo stare qui solo con la
pipa...»
A questo punto il soliloquio di Anselmo fu interrotto da uno strano frusciare
e ruscellare che si levò dall'Elba fino a lui e poco dopo salì tra i rami e le foglie del
sambuco che s'incurvava sopra di lui. Ora pareva che il vento della sera scotesse
le foglie, ora che gli uccellini giocassero tra i rami agitando capricciosamente le
alucce. Poi cominciò un bisbiglio, un sussurrio, come se i fiori tintinnassero al pari
di campanelle di cristallo.
Anselmo stette in ascolto ed ecco, senza che egli se ne rendesse conto, quel
tintinnio, quel bisbiglio, quel sussurrio si tramutò in parole sommesse, quasi
soffiate via dal vento: «Attraverso... dentro e fuori... tra ramoscelli, tra turgidi fiori,
oscilliamo, sventoliamo, serpeggiamo... sorellina... sorellina, lanciati alla luce...
presto presto... in su, in giù... il sole al tramonto manda i suoi raggi, il vento
sibila... fruscia la rugiada... cantano i fiori, noi moviamo la linguina, cantiamo coi
fiori e coi rami... tra poco brillano le stelle... dobbiamo scendere... attraverso, di
qua e di là, serpeggiando, intrecciando, oscillando, sorelline.»
Il discorso continuò così confuso. E lo studente pensava: «Non può essere
che il vento della sera, che oggi sussurra parole comprensibili.»
Ma in quell'istante risonò, sopra di lui, come un accordo di tre nitide campane
di cristallo: egli alzò gli occhi e vide tre serpicine brillanti nell'oro verde che si erano
avvolte ai rami e sporgevano il capino verso il tramonto. Il sussurrio e il bisbiglio
ripresero con le stesse parole, le serpi scivolarono garbatamente in su e in giù tra
i rami e le foglie e a quel loro rapido urtare sembrava che il sambuco spargesse
attraverso le foglie scure migliaia di smeraldi luccicanti.
«È il sole al tramonto i cui raggi giocano nel sambuco,» pensò Anselmo, ma
le campane ripresero a sonare ed egli vide che una di quelle serpicine volgeva la
testolina verso di lui. Sentì in tutte le membra come una scossa elettrica e tutto
tremante guardò in alto: un paio di splendidi occhi azzurri lo guardavano con
indicibile desiderio sicché un sentimento mai conosciuto di felicità suprema e di
profondo dolore parve che gli spezzasse il cuore. E mentre fissava quegli occhi
soavi con brama ardente, gli accordi cristallini delle campane risonavano più forti,
gli smeraldi scintillanti gli cadevano addosso e mille fiammelle lo attorniavano
lingueggiando e intrecciandosi a fili d'oro.
Il sambuco si mosse e parlò: «Stavi seduto alla mia ombra e il mio profumo
ti avvolgeva, ma tu non mi hai compreso. Il profumo è il mio linguaggio quando
l'amore lo infiamma.»
Il vento della sera passò alitando e disse: «Ti ho accarezzato la tempia ma tu
non mi hai compreso. Il soffio è il mio linguaggio quando l'amore lo infiamma.»
I raggi del sole sbucarono dalle nubi e il loro splendore parlò: «Ho versato su
di te l'oro infocato, ma tu non mi hai compreso. Ardore è il mio linguaggio quando
l'amore lo infiamma.»
Sempre più immerso nello sguardo di quei due splendidi occhi la brama di lui
divenne più ardente, il desiderio più bruciante. Ogni cosa si mosse quasi ridesta
alla vita gaia. Intorno a lui olezzavano i fiori il cui profumo era quasi incanto di mille
voci di flauto e questo canto era portato echeggiante in lontani paesi dalle migranti
nuvole d'oro. Ma quando dietro ai monti scomparve veloce l'ultimo raggio del sole
e il crepuscolo stese il suo velo su tutta la regione una voce brusca e profonda
esclamò da lontano: «Ahi, ahi, che mormorio, che borbottio è codesto laggiù?
Ahimè, chi mi cerca il raggio dietro ai monti? Si è cantato abbastanza, si è preso
abbastanza sole... via, via, nell'erba e nei cespugli... nell'erba e nel fiume!... Giù...
giù, giù!»
La voce si spense come nel brontolio d'un tuono lontano e le campane di
cristallo s'infransero con stridente risonanza. Tutto era ammutolito, e Anselmo
vide le tre serpi scivolare luminose nell'erba verso il fiume dove si gettarono
frusciando e sibilando. Nel punto dove erano scomparse scoppiettò sulle onde un
fuoco verde che svanì obliquo e lingueggiante in direzione della città.
SECONDA VEGLIA
Come lo studente Anselmo fu preso per ubriaco e folle. - La vita sull'Elba. - L'aria
di bravura del direttore d'orchestra Graun. - Il liquore digestivo di Conradi e la
donna delle mele bronzata.
«Il signore deve averne un ramo,» osservò una rispettabile cittadina che
ritornando dalla passeggiata con la famiglia si era fermata e incrociando le braccia
stava a guardare il buffo comportamento di Anselmo: lo studente aveva
abbracciato il tronco del sambuco e andava dicendo ai rami e alle foglie: «Oh,
luccicate ancora una volta, care serpicine d'oro, fatemi sentire una volta sola
ancora le vostre voci argentine! Guardatemi ancora una volta, soavi occhi azzurri,
una volta sola, altrimenti mi tocca morire dal dolore e dal desiderio che mi
agitano.» E intanto sospirava e gemeva miseramente dal profondo del cuore e
scrollava il sambuco dall'impazienza; ma invece di rispondere l'albero agitava
soltanto le foglie con un sussurrio cupo e incomprensibile, quasi facendosi beffe
dell'addolorato studente.
«Deve proprio averne un ramo questo signore,» ripeté la donna. Anselmo
ebbe l'impressione di essere scosso da un sonno profondo, di essere annaffiato da
un getto di acqua gelida affinché si svegliasse all'improvviso. Soltanto ora vide
chiaramente dov'era, ricordò la strana fantasia che lo aveva burlato e indotto
persino a parlare da solo ad alta voce. Spaventato guardò la donna e afferrato il
cappello che gli era caduto per terra fece per scappare. Intanto era arrivato anche
il marito della donna che, dopo aver deposto sull'erba il piccino che portava in
braccio, appoggiandosi al bastone si era fermato a guardare e ascoltare lo
studente con grande stupore. Poi raccattò la pipa e la borsa del tabacco che
Anselmo aveva lasciato cadere e porgendo una cosa e l'altra disse: «Signore, non
stia a borbottare così al buio, e non prenda in giro la gente, se non ha altro male
che quello di aver alzato un po' troppo il gomito... Faccia il bravo, se ne vada a casa
e si metta a letto!»
Anselmo si vergognò non poco e trasse un sospiro.
«Via, via,» proseguì il brav'uomo, «non se la prenda, sono cose che capitano
anche ai migliori, e il giorno dell'Ascensione, avendo l'anima in festa, si può anche
bere un po' più del necessario. Può toccare anche a un uomo di Dio... Lei
dev'essere, penso, uno studente di teologia, e se permette mi empio la pipetta col
suo tabacco perché il mio è terminato.»
Così disse quel cittadino mentre lo studente stava già per intascare la pipa e
la borsa. L'altro pulì adagio e accuratamente la pipa e con altrettanta lentezza la
caricò. Intanto erano intervenute alcune ragazze che guardando Anselmo si
misero a parlare sottovoce con la donna e a ridacchiare tra loro. Anselmo aveva
l'impressione di trovarsi sulle spine o sui carboni accesi. Appena riebbe la pipa e la
borsa partì difilato.
Tutte le meraviglie che aveva viste erano scomparse dalla sua memoria.
Ricordava soltanto che sotto quel sambuco aveva detto a gran voce ogni sorta di
sciocchezze, e ciò lo spaventava particolarmente perché aveva sempre provato
una profonda avversione contro i soliloqui. «Sono discorsi suggeriti da Satana,»
diceva il suo preside, e anche lui ci credeva. Ma l'idea di essere preso, il giorno
dell'Ascensione, per un candidatus theologiae gli riusciva insopportabile. Stava per
infilare il viale dei pioppi presso il Giardino di Kosel allorché una voce alle sue spalle
lo chiamò: «Signor Anselmo, signor Anselmo, dove diavolo corre con tanta
fretta?» Lo studente si fermò di botto, convinto che una nuova sciagura stesse per
abbattersi su di lui. E udì di nuovo la voce: «Torni indietro, signor Anselmo,
l'aspettiamo qui sulla riva.» Soltanto ora lo studente si rese conto che chi lo
chiamava era l'amico suo, il vicepreside Paulmann. Tornò indietro fino all'Elba,
trovò l'amico con le due figliole e con l'attuario Heerbrand sul punto di montare in
una barca. Paulmann invitò Anselmo a passare l'Elba con lui e a rimanere poi la
sera in casa sua nel sobborgo di Pirna. Anselmo accettò volentieri sperando di
scansare così il brutto destino di quella giornata.
Mentre passavano il fiume videro che sulla riva opposta presso il Giardino di
Anton davano uno spettacolo pirotecnico. I razzi salivano in alto frusciando e
sibilando, le stelle luminose solcavano l'aria versando intorno raggi e fiamme
scoppiettanti. Anselmo sedeva assorto presso il rematore allorché scorse
nell'acqua il riflesso delle scintille e dei fuochi crepitanti: ma a lui parve che l'acqua
fosse attraversata dalle serpi d'oro. Tutte le cose strane che aveva visto sotto il
sambuco gli si riaffacciarono alla memoria e di nuovo fu preso da quell'ineffabile
nostalgia, da quell'ardente desiderio che si era agitato nel suo cuore in una estasi
dolorosa e convulsa. «Oh siete qui di nuovo, serpicine d'oro, cantate, cantate! Nel
vostro canto mi riappaiono i soavi occhi azzurri... Siete sotto l'acqua?» Così
parlando lo studente fece un gesto inconsulto quasi volesse gettarsi dalla barca.
«Che diavolo vi prende?» gridò il barcaiolo afferrandolo per le falde. Le
ragazze mandarono un urlo spaventate e si rifugiarono sull'altro lato della barca.
L'attuario mormorò qualcosa all'orecchio del vicepreside: della risposta lo studente
poté afferrare soltanto queste parole: «Simili attacchi?... mai notati finora!»
Paulmann si alzò e facendosi serio e grave andò a sedersi accanto ad Anselmo, gli
prese una mano e domandò: «Come si sente, signor Anselmo?»
Lo studente si sentì quasi svenire perché dentro gli sorse un folle dissidio che
invano cercò di scacciare. Ma ora vide chiaramente che quelle luci che aveva prese
per serpenti d'oro non erano che i riflessi dei fuochi artificiali presso il Giardino di
Anton, ma un senso sconosciuto, non sapeva nemmeno lui se di piacere o di
dolore, gli strinse il cuore e, quando il barcaiolo tuffava il remo nell'acqua
facendola gorgogliare quasi in collera, sentì in quel rumore un bisbiglio segreto.
«Anselmo, Anselmo, non vedi che ti precediamo sempre? La sorellina ti guarda
ancora... credi, credi, credi in noi!» A lui parve di vedere nel riflesso tre strisce
verdi e luminose.
Ma poi quando fissò lo sguardo malinconico sull'acqua per ritrovare gli occhi
soavi, vide benissimo che quello splendore proveniva dalle finestre illuminate delle
case vicine. Rimase in silenzio, lottando con se stesso, mentre il vicepreside gli
domandò con maggiore insistenza: «Come sta, signor Anselmo?» Lo studente
rispose timidamente: «Oh sapesse, signor preside, quali cose singolari ho visto
poco fa ad occhi aperti e perfettamente sveglio sotto un sambuco lungo il muro dei
giardini di Link: non se la prenderebbe con me se quasi assente...»
«Senta, signor Anselmo,» lo interruppe Paulmann, «io l'ho sempre
considerata un giovane serio, ma sognare, sognare ad occhi aperti e ad un tratto
volersi buttare nel fiume, via, mi perdoni, ma è roba da pazzi o sciocchi.»
Lo studente rimase molto turbato dalle dure parole dell'amico allorché
Veronica, la figlia maggiore di Paulmann, una bella ragazza fiorente di sedici anni,
interloquì: «Ma, caro babbo, il signor Anselmo deve aver visto qualcosa di
particolare e forse crede soltanto di essere stato sveglio, mentre sotto il sambuco
in realtà dormiva e credette di vedere le follie che ancora gli si agitano nella
mente.»
«D'altro canto, cara signorina, ottimo preside,» prese a dire Heerbrand,
«non dovrebbe essere possibile immergersi anche da svegli in uno stato di sogno?
Una volta, mentre prendevo il caffè del pomeriggio ed ero meditabondo, nel vero
momento della digestione fisica e intellettuale, mi venne in mente come per
ispirazione dove si trovava un atto che avevo perduto, e non più tardi di ieri ho
visto danzare davanti agli occhi spalancati una grande scritta latina in caratteri
gotici.»
«Pregiatissimo attuario,» ribatté il vicepreside, «lei ha avuto sempre una
certa tendenza alla poesia, e allora è facile cadere nel fantastico, nel romanzesco.»
Ad Anselmo però fece bene vedersi oggetto di attenzione nella conturbante
eventualità di essere preso per ubriaco o pazzo, e quantunque fosse ormai
piuttosto buio, credette di notare per la prima volta che Veronica aveva bellissimi
occhi azzurri, senza che gli passassero per la mente quelli meravigliosi che aveva
visto tra le fronde del sambuco. In genere quell'avventura era ad un tratto
scomparsa del tutto ed egli si sentiva lieto e leggero, anzi nella sua baldanza arrivò
al punto che nello scendere dalla barca porse il suo aiuto alla fanciulla che aveva
preso le sue difese e quando se la trovò a braccetto l'accompagnò senz'altro a casa
molto abilmente e con tanta fortuna da scivolare un'unica volta nell'unico punto
fangoso della strada inzaccherando pochissimo l'abito bianco di Veronica. Al
vicepreside non sfuggì il felice mutamento dello studente, sicché prese a volergli
bene di nuovo e gli chiese perdono delle aspre parole di prima. «Sicuro,»
aggiunse, «abbiamo esempi del caso in cui certi fantasmi appaiono all'uomo e
possono angustiarlo e tormentarlo, ma questa è una malattia fisica che può
guarire con mignatte, applicate, con rispetto parlando, al di dietro, come ha
dimostrato un celebre scienziato ora defunto.»
Ora lo studente Anselmo non sapeva davvero se era stato ubriaco, matto o
ammalato, in ogni caso però le sanguisughe gli parvero inutili perché gli eventuali
fantasmi erano scomparsi ed egli si sentiva sempre più allegro quanto più sapeva
profondersi in gentilezze verso la bella Veronica.
Dopo la cena frugale si fece come al solito un po' di musica; Anselmo dovette
sedersi al pianoforte e Veronica fece sentire la sua voce chiara e limpida. «Gentile
signorina,» disse l'attuario, «lei ha una voce che suona come una campana di
cristallo.»
«Questo poi no!» scappò detto ad Anselmo, non sapeva nemmeno lui come,
e tutti lo guardarono perplessi e stupiti. «Le campane di cristallo tintinnano
meravigliosamente nei sambuchi, meravigliosamente,» continuò sottovoce
Anselmo, mentre Veronica gli posava una mano sulla spalla dicendo: «Che cosa
dice, signor Anselmo?» Lo studente si risvegliò subito e cominciò a suonare,
mentre Paulmann lo guardava accigliato. Heerbrand pose in quella un foglio sul
leggio e cantò deliziosamente un pezzo di bravura del direttore d'orchestra Graun.
Lo studente accompagnò ancora altre cose, e un duetto fugato composto dallo
stesso Paulmann ed eseguito insieme con Veronica diffuse fra tutti la più serena
allegria.
Intanto si era fatto tardi e mentre l'attuario prendeva il cappello e il bastone,
Paulmann gli si avvicinò con aria misteriosa e gli disse: «Signor attuario, non
vuole... al caro signor Anselmo... be', come dicevamo dianzi...»
«Con molto piacere,» replicò Heerbrand e quando tutti furono seduti in
cerchio cominciò senz'altro: «C'è qui da noi un uomo anziano, strano e bizzarro
che, a quanto si dice, coltiva ogni sorta di scienze occulte. Ma siccome queste non
esistono, lo considero piuttosto un dotto antiquario che forse fa anche esperimenti
di chimica. Alludo al nostro archivista Lindhorst. Come sapete, vive solitario nella
sua vecchia casa fuori mano e quando non è in servizio è facile trovarlo nella sua
biblioteca o nel laboratorio chimico dove però non fa entrare nessuno. Oltre a molti
libri rari possiede un certo numero di manoscritti con segni arabici, copti e persino
tali che non appartengono a nessuna lingua conosciuta. Ora desidera far copiare
abilmente questi manoscritti e per questo gli occorre un uomo che sappia
disegnare a penna per riportare con la massima rapidità e esattezza tutti quei
segni sulla pergamena, e precisamente con l'inchiostro di china. E fa lavorare in
una stanza particolare della sua casa e sotto la sua sorveglianza, paga oltre al vitto
per ogni giornata di lavoro un tallero e promette un cospicuo regalo per quando le
copie saranno felicemente terminate. Il lavoro si svolge ogni giorno dalle dodici
alle sei. Dalle tre alle quattro si riposa e si fa colazione. Siccome ha già provato ma
invano con un paio di giovani a far copiare i manoscritti, si è rivolto infine a me
pregandomi di mandargli un bravo disegnatore. Allora ho pensato a lei, caro signor
Anselmo, poiché so che ha una scrittura pulita e disegna a penna con molto garbo.
Perciò se vuole guadagnare un tallero al giorno in questi tempi calamitosi fino
all'assegnazione di un posto e ottenere per giunta il regalo, faccia il piacere di
trovarsi domani alle dodici in punto presso l'archivista del quale le è certo noto
l'indirizzo. Si guardi però dalle macchie d'inchiostro! Se ne fa una sulla copia deve
senza remissione cominciare da capo; se poi la macchia cade sull'originale, il
signor archivista è capace di buttarla dalla finestra poiché è un uomo irascibile.»
Lo studente fu ben contento della proposta fattagli dall'attuario Heerbrand,
non solo aveva la scrittura pulita e sapeva disegnare a penna, ma aveva una vera
passione per la copiatura attenta e calligrafica. Ringraziò pertanto vivamente i suoi
benefattori e promise di non mancare l'indomani a mezzogiorno. Durante la notte
non vide altro che talleri lustri e ne udiva il suono lusinghiero. Si poteva farne
carico a quel poveretto al quale i capricci della sorte avevano tolto tante speranze
costringendolo a misurare il centesimo e a rinunciare alle gioie della gioventù?
La mattina per tempo raccolse le sue matite, le penne di corvo, l'inchiostro di
china; di migliori, pensò, non ne poteva inventare neanche l'archivista. Soprattutto
riesaminò e mise in ordine i suoi capolavori calligrafici e i disegni per dimostrare
all'archivista la sua capacità di eseguire quanto gli veniva richiesto. Tutto
procedette felicemente, una buona stella particolare pareva lo governasse, la
cravatta andò a posto col primo nodo, nessuna cucitura scoppiò, nessuna maglia
delle calze di seta nera si strappò, il cappello, dopo che l'ebbe spazzolato per bene,
non gli cadde nella polvere nemmeno una volta. Insomma, alle undici e mezzo in
punto Anselmo in marsina grigio-azzurra e panciotto di raso nero, un rotolo di belle
scritture e disegni a penna sotto il braccio, era già nella fiaschetteria di Conradi a
bere uno o due bicchierini del miglior digestivo perché lì, pensò battendosi la tasca
ancora vuota, sarebbero entrati presto i talleri. Nonostante il lungo percorso fino
alla via solitaria nella quale sorgeva l'antica casa dell'archivista Lindhorst lo
studente si trovò davanti alla porta prima delle dodici. Si fermò a guardare il bel
picchiotto di bronzo, ma mentre all'ultimo colpo dell'orologio che dal campanile
della chiesa vicina scosse rumorosamente l'aria, stava per afferrare il picchiotto, il
viso metallico si storse in un orrido giuoco di ardenti lampi azzurri e si trasformò in
un ghigno. To', la venditrice di mele della Porta Nera! I denti aguzzi batterono nella
bocca mencia donde uscì la voce gracchiante: «Matto, matto... matto... aspetta
aspetta! Perché sei corso via?»
Lo studente balzò indietro atterrito, fece per aggrapparsi allo stipite ma le
sue dita afferrarono il cordone del campanello e lo tirarono. Si udirono più squilli,
uno più forte e risonante dell'altro, e l'eco nella casa deserta andò ripetendo
beffarda: «Presto ci cadi nel cristallo!»
Anselmo inorridì e un tremito convulso lo scosse come gelida febbre. Il
cordone del campanello scese e diventò un grande serpente bianco trasparente
che lo strinse sempre più forte tra le sue spire fino a sgretolare le membra friabili
e crocchianti e a fargli sprizzare dalle vene il sangue, che penetrò nel corpo diafano
del serpente tingendolo di rosso. «Ammazzami, ammazzami!» stava per gridare
Anselmo in quell'angoscia, ma il suo grido non fu che un sordo rantolo.
Il serpente alzò la testa e posò la lunga lingua appuntita, di bronzo
incandescente, sul petto di Anselmo cui un dolore lacerante troncò la vena vitale,
e il suo pensiero si spense. Quando ritornò in sé giaceva nel suo misero lettino e
davanti a lui il vicepreside Paulmann stava dicendo: «Ma, per carità, caro signor
Anselmo, che cosa diavolo va combinando?»
TERZA VEGLIA
Notizie intorno alla famiglia dell'archivista Lindhorst. - Gli occhi azzurri di Veronica.
- L'attuario Heerbrand.
«Lo spirito volse lo sguardo all'acqua ed essa si mosse e rumoreggiò a
ondate spumeggianti e precipitò tonando negli abissi che spalancarono le nere
fauci per ingoiarla avidamente. Come vincitori trionfanti i dirupi di granito alzarono
la loro testa incoronata di guglie a proteggere la valle, mentre il sole la accolse nel
grembo materno e abbracciandola la cullò e riscaldò coi suoi raggi simili a braccia
ardenti. Allora si destarono dal sonno profondo mille germi dopo aver
sonnecchiato sotto la rena deserta e sollevarono i loro gambi e le foglioline verdi
verso il volto dell'astro materno, e come bimbi sorridenti in una verde culla
riposarono nelle gemme fiorenti piccoli fiori finché anch'essi al tocco della madre si
destarono e si ornarono delle luci che per loro gioia la madre aveva tinto di mille
colori. Nel mezzo della valle sorgeva una collina nera che si alzava e abbassava
come il petto dell'uomo quando si gonfia di bruciante desiderio. Dagli abissi si
levarono masse di vapori che unendo i loro globi cercavano di nascondere con
ostilità il volto del sole; il quale però invocò la bufera che li investì polverizzandoli,
e quando il raggio puro colpì di nuovo la collina nera ne sbucò in un impeto di gioia
una stupenda amarillide rossa che aprì i magnifici petali come dolci labbra pronte
ad accogliere i baci materni. Tutta la valle fu invasa da un grande splendore. Era il
giovinetto Fosforo che l'amarillide di fiamma vide e, presa da un ardente
nostalgico amore, implorò: ‹Sii mio per sempre, bellissimo giovane! Ti amo e devo
morire se mi abbandoni.› Fosforo rispose: ‹Certo, voglio essere tuo, magnifico
fiore, ma allora come una figlia degenere lascerai il padre e la madre! Non
conoscerai più le tue compagne di giuochi, vorrai essere più grande e più potente
di tutti quanti fioriscono con te perché sono tuoi pari. Il desiderio che ora scalda
benefico tutto l'essere tuo si scinderà in cento raggi, ti tormenterà e torturerà,
perché il senso partorirà i sensi e la voluttà suprema, accesa dalla scintilla che
getto dentro di te, è il disperato dolore nel quale perisci per rigermogliare come
un'estranea. Questa scintilla è il pensiero!› ‹Oh,› sospirò l'amarillide, ‹non posso
essere tua nell'ardore che adesso divampa dentro di me? Potrò mai amarti più di
ora e potrò guardarti come adesso se mi annienti?› A questo punto il giovane
Fosforo la baciò e come attraversata dalla luce essa sprigionò fiamme dalle quali
uscì un essere nuovo che fuggendo velocemente dalla valle vagò per lo spazio
infinito non curandosi delle compagne della sua giovinezza né del giovane amato.
Questi pianse l'innamorata perduta perché anche lui era stato portato nella valle
solitaria dall'infinito amore per la bella amarillide, e le rocce granitiche chinarono il
capo partecipando al dolore del giovane. Una di esse però si aprì e ne uscì
svolazzando un nero drago alato che disse: ‹I metalli miei fratelli dormono lì dentro
ma io sono sempre sveglio e ti voglio aiutare.› Volando in alto e in basso il drago
riuscì ad afferrare l'essere che era sbocciato dall'amarillide, lo portò sulla collina e
lo coprì con le ali. Ed era di nuovo l'amarillide, ma un pensiero fisso la straziava e
l'amore per il giovane Fosforo era una pena lancinante per la quale i fiori che prima
avevano gioito a vederla, ora avvolti in venefici vapori avvizzivano e morivano.
Fosforo indossò un'armatura lucente che mandava luci di mille colori e combatté
col drago, il quale battendo le ali nere contro la corazza ne ricavava squilli sonori,
e a quei suoni i fiori rivissero e volarono come uccelli multicolori intorno al drago
che perdute le forze andò a nascondersi vinto nelle profondità della terra.
L'amarillide fu libera, Fosforo la abbracciò ardendo dal desiderio di un amore
celeste e in un inno di giubilo i fiori, gli uccelli, perfino le aride rocce di granito le
fecero omaggio riconoscendola regina della valle.»
«Scusi, egregio archivista, ma queste sono ampollosità orientali!» osservò
l'attuario Heerbrand, «mentre noi avevamo espresso il desiderio di sentirla
raccontare, come fa di solito, qualche fatto della sua vita curiosa, non so, delle sue
avventure di viaggio, ma qualcosa di vero.»
«Ebbene,» rispose Lindhorst, «ciò che vi ho raccontato è la cosa più vera che
io vi possa presentare, cari miei, e in certo qual modo fa parte della mia vita. Infatti
io sono oriundo appunto di quella valle e l'amarillide di fuoco, l'ultima regina che vi
regnò, è la mia lontanissima progenitrice, sicché a rigore sono un principe.» Tutti
scoppiarono in una risata rumorosa. «Sì, ridete pure,» continuò l'archivista, «il
racconto che vi ho fatto a grandi linee vi potrà sembrare assurdo o folle, ma è
tutt'altro che assurdo o diciamo allegorico, è letteralmente vero. Se però avessi
saputo che la bellissima storia d'amore alla quale devo la mia origine vi sarebbe
piaciuta così poco, vi avrei comunicato piuttosto le novità che mi recò mio fratello,
venuto ieri a trovarmi.»
«Oh, senti questa! Lei ha anche un fratello? E dove è? Dove si trova? Anche
lui è al servizio del re o è forse un erudito privato?»
«No, no,» rispose Lindhorst calmo e freddo annusando una presa di tabacco,
«è passato dalla parte malvagia e si è unito ai draghi.»
«Come dice, caro archivista?» domandò Heerbrand. «In mezzo ai draghi?»
«In mezzo ai draghi?» chiesero altri facendo eco.
«Sì, fra i draghi,» continuò l'archivista. «A dir il vero, fu per disperazione. Voi
sapete, signori, che mio padre è morto recentemente, saranno tutt'al più
trecentoottantacinque anni, per questo porto ancora il lutto, e a me che ero il suo
beniamino lasciò una magnifica onice. Mio fratello la voleva a tutti i costi. Davanti
alla salma di mio padre litigammo perciò in un modo indecente finché il defunto,
perduta la pazienza, balzò in piedi e buttò il cattivo fratello giù dalle scale.
Rodendosi per questo, andò difilato fra i draghi. Adesso vive in un bosco di cipressi
alla periferia di Tunisi dove ha il compito di custodire un famoso carbonchio mistico
al quale un dannato negromante che d'estate è domiciliato in Lapponia dà la
caccia; perciò si può allontanare al massimo un quarto d'ora, quando il
negromante coltiva nel giardino le sue aiuole di salamandre, e in tutta fretta mi
viene a raccontare ciò che succede di buono alle sorgenti del Nilo.»
Per la seconda volta i presenti scoppiarono a ridere, ma lo studente Anselmo
fu colto da un brivido e si arrischiò a malapena a guardare negli occhi severi
dell'archivista con un tremore che a lui stesso era incomprensibile; tanto più che la
voce dell'archivista, aspra, ma stranamente metallica, aveva un che di misterioso
e penetrante al punto da far venire i brividi.
Lo scopo perché l'attuario lo aveva portato con sé al caffè non era ormai
raggiungibile. Infatti dopo l'incidente davanti alla casa dell'archivista lo studente
non si era più lasciato indurre a tentare la visita una seconda volta: era
profondamente convinto che soltanto il caso lo aveva salvato se non dalla morte,
dal pericolo di impazzire. Paulmann il vicepreside era passato proprio di lì quando
Anselmo era caduto davanti alla porta privo di sensi e una vecchia, deposto il
paniere delle sue mele e delle focaccine, era affaccendata intorno a lui. Paulmann
aveva chiamato subito una bussola e lo aveva fatto portare a casa.
«Si pensi di me quel che si vuole,» disse Anselmo, «mi si prenda per matto
o no, fatto è che da quel picchiotto usciva il ghigno della maledetta strega della
Porta Nera. Di ciò che avvenne in seguito preferisco non parlare, ma se fossi
rinvenuto e avessi visto davanti a me la dannata donna delle mele (era lei infatti
quella che si dava da fare intorno a me), un colpo apoplettico mi avrebbe ucciso
sull'istante o sarei ammattito.»
Le esortazioni, le ragionevoli obiezioni del vicepreside e dell'attuario non
approdarono a nulla, e nemmeno la giovane Veronica dagli occhi azzurri fu capace
di distoglierlo dallo stato di malinconia nel quale era sprofondato. Realmente fu
considerato malato di mente e si cercarono mezzi per distrarlo, dopo di che
Heerbrand espresse il parere che nessuna cosa poteva essere utile quanto il lavoro
presso l'archivista, cioè la copiatura dei manoscritti. Si trattava di presentare in
modo garbato lo studente all'archivista, e siccome l'attuario sapeva che quello
frequentava quasi ogni sera un ben noto caffè, invitò Anselmo ad andarci tutte le
sere, a bere una birra e a fare una pipata, sempre a spese dell'attuario stesso
finché in un modo o nell'altro fosse stato presentato all'archivista e si fosse messo
d'accordo sulla faccenda della copiatura. Anselmo accettò con animo grato.
«Dio la rimeriterà, caro attuario, se riuscirà a far capire la ragione a questo
giovane,» conchiuse il vicepreside.
«Dio la rimeriterà,» ripeté Veronica alzando devotamente gli occhi al cielo,
convinta che lo studente era già un giovane molto garbato, anche senza la
ragione.
Mentre Lindhorst, preso il cappello e il bastone, stava per uscire, Heerbrand
prese Anselmo per mano e tagliando la strada all'archivista gli disse: «Egregio
signor archivista, questo è lo studente Anselmo. È abilissimo in calligrafia e
disegno e vorrebbe copiare i suoi rari manoscritti.»
«Ciò mi fa un immenso piacere,» replicò l'archivista e messosi rapidamente
in testa il tricorno militare spinse da parte l'attuario e lo studente e scese
rumorosamente le scale, sicché entrambi rimasero trasecolati e stettero a
guardare la porta che quello aveva sbattuto loro in faccia facendo cigolare i
cardini.
«Strano questo vecchio,» commentò Heerbrand.
«Strano vecchio,» ripeté lo studente balbettando e rabbrividendo come se
una gelida corrente gli passasse nelle vene riducendolo quasi alla rigidità di una
statua.
Tutti i clienti invece risero: «Oggi l'archivista era di nuovo del suo umore
particolare, domani sarà certo mansueto e non dirà una parola, si limiterà a
guardare i vortici di fumo della pipa e a leggere il giornale. Non bisogna fargli
caso.»
«Giusto,» pensò Anselmo, «chi ci farà caso? Non ha forse detto l'archivista
che gli farebbe molto piacere se gli copiassi i manoscritti? E perché mai l'attuario
gli tagliò la strada proprio nel momento che stava per rincasare? In fondo è una
cara persona, il signor archivista Lindhorst, ed è certamente strano e un po'
curioso per il modo di esprimersi... ma che male c'è per me? Domani ci vado alle
dodici in punto, dovessi incontrare l'ostacolo di cento vecchie bronzate!»
QUARTA VEGLIA
Malinconia dello studente Anselmo. - Lo specchio di smeraldo. - Come l'archivista
Lindhorst volò via sotto le spoglie di un nibbio reale e Anselmo non incontrò
nessuno.
Credo di poter domandare direttamente a te, benevolo lettore, se nella tua
vita non hai avuto ore, anzi giorni e settimane nelle quali la tua solita attività ti
dava un tormentoso disagio, nelle quali tutto quanto di solito ti sembrava
importante e degno, di considerazione, ti appariva soltanto melenso e indegno. In
quei casi tu stesso non sapevi che cosa fare e dove rivolgerti; nel tuo petto si
agitava un oscuro presentimento che in qualche luogo e in qualche momento si
adempiva un grande desiderio al di là della cerchia di ogni piacere umano, un
desiderio che la mente, come un bambino timido tenuto alla cavezza, non osava
neanche pensare, e con questo desiderio di un bene sconosciuto che ti alitava
intorno dovunque tu stessi o andassi come un sogno vaporoso di figure trasparenti
che a guardare meglio svanivano, ammutolivi, insensibile a tutto quanto ti
circondava. Con occhio velato andavi in giro come chi ama senza speranza, e tutto
ciò che vedevi fare dagli altri in tutti i modi e in grande confusione, non suscitava
in te né dolore né gioia, come se tu non fossi più di questo mondo. Se, benevolo
lettore, ti sei trovato qualche volta in questo stato d'animo, conosci per esperienza
quello in cui si trovava lo studente Anselmo. In genere vorrei essere riuscito già ora
a farti vedere lo studente con vivacità e chiarezza. Infatti nelle veglie delle quali
approfitto per scrivere la sua stranissima storia avrei da raccontare ancora tante
cose curiose, le quali sposterebbero nell'ignoto, come un'apparizione di fantasmi,
la vita quotidiana di uomini comunissimi, al punto che mi viene il timore che tu
finiresti col non credere nell'esistenza di Anselmo e di Lindhorst o addirittura
dubiteresti, ingiustamente, del vicepreside e dell'attuario, nonostante che almeno
questi due ultimi galantuomini passeggino ancora per le vie di Dresda. Nel regno
fatato pieno di meraviglie che suscitano con violente peripezie la suprema voluttà
e il più nero orrore, dove anzi la dea severa scosta il proprio velo in modo che
crediamo di scorgerne il volto - ma dallo sguardo severo brilla spesso un sorriso, e
questo è lo scherzo mordace che ci giuoca con ogni sorta di stregonerie confuse
come la madre folleggia talvolta coi suoi bimbi più cari - sì, in questo regno che la
mente ci schiude tante volte, almeno in sogno, cerca, lettore mio, di riconoscere le
ben note persone che, come si dice nella vita comune, si aggirano ogni giorno nelle
tue vicinanze. Allora crederai che quel magnifico regno ti è molto più vicino di
quanto tu non pensassi, e io te lo auguro di cuore e mi sforzo di disegnartelo con
la strana storia dello studente Anselmo.
Dunque, come dicevo, la sera in cui vide l'archivista, Anselmo si trovò
immerso in una nebbia sognante che lo rendeva insensibile a qualsiasi contatto
con la vita di tutti i giorni. Aveva l'impressione che qualcosa di ignoto si agitasse
dentro di lui e gli procurasse quel voluttuoso dolore che è appunto la nostalgia
quando promette all'uomo una esistenza diversa e superiore. Soprattutto egli
sapeva vagare da solo per boschi e prati e, quasi staccato da tutto ciò che lo
incatenava alla sua povera vita, ritrovare quasi se stesso nella contemplazione
delle varie immagini che sorgevano dalla sua mente. Così fu che un giorno,
ritornando da una lunga passeggiata, si trovò davanti a quel curioso sambuco
sotto il quale a suo tempo, come rapito in un regno fatato, aveva veduto tante
cose strane. Si sentì meravigliosamente attratto da quel terreno erboso, ma vi si
era appena seduto allorché tutto quanto allora aveva visto in un'estasi celeste e
poi era stato cancellato da un potere estraneo, gli riapparve a colori vivacissimi
come se vedesse ogni cosa una seconda volta. Anzi più chiaramente di allora gli
parve che i soavi occhi azzurri appartenessero alla serpe verde-oro che si
avvinghiava al sambuco, e dalle spire di quel corpo si sprigionassero i suoni delle
campane di cristallo che lo mandavano in estasi. Come nel giorno dell'Ascensione
abbracciò anche ora il tronco del sambuco e parlò tra i rami e le foglie: «Oh, ancora
una volta serpeggia e avvolgiti sui rami, cara serpicina verde, perché ti possa
vedere! Guardami soltanto una volta ancora coi tuoi occhi soavi! Ti amo; lo sai che
mi tocca morire di dolore e tristezza se non ritorni.»
Ma tutto rimase muto, in silenzio, e come allora il sambuco stormì soltanto
incomprensibilmente coi ramoscelli e con le foglie. Ma lo studente credette di
sapere ormai che cosa si agitava dentro di lui, che cosa gli lacerava il petto con la
pena di un'infinita nostalgia. «Non è forse,» disse, «che ti amo con tutta l'anima
fino alla morte, bellissima serpicina d'oro, che senza di te non posso vivere e mi
tocca perire disperato se non ti rivedo, se non ti possiedo come l'innamorata del
mio cuore?... ma ora so che sarai mia e allora si adempirà tutto ciò che i bei sogni
di un mondo diverso e superiore mi continuano a promettere.»
Ogni sera quando il sole spargeva l'oro scintillante soltanto sulle vette degli
alberi, Anselmo si recava sotto il sambuco e dal profondo del cuore, con voce
lamentevole parlava ai rami e alle foglie chiamando la dolce innamorata, la serpe
verde-oro. Un giorno, mentre si comportava come al solito, si trovò davanti
all'improvviso un uomo alto, scarno, avvolto in un ampio pastrano grigio chiaro
che lanciando dai grandi occhi lampi di fuoco disse: «Che vieni a lamentarti?
Perché piagnucoli così?... To', guarda, questo è il signor Anselmo che vuol copiare
i miei manoscritti!»
Lo studente si spaventò non poco a quella voce tonante poiché era la stessa
che a suo tempo, il giorno dell'Ascensione, aveva esclamato: «Ahi, ahi, che
mormorio, che borbottio è codesto laggiù, ecc.» Dallo stupore e dallo spavento
non riuscì a spiccicare una parola. «Che cos'ha, signor Anselmo?» soggiunse
l'archivista (poiché era lui l'uomo in pastrano grigio chiaro), «che cosa vuole da
questo sambuco? E perché non è venuto da me a cominciare il lavoro?»
Effettivamente lo studente non aveva ancora trovato il coraggio di andare a
trovare l'archivista in casa sua, benché ci avesse pensato tutte le sere; in quel
momento però vedendo distrutti i suoi bei sogni e per giunta da quella stessa voce
ostile che già allora gli aveva rapito l'innamorata, come preso dalla disperazione
sbottò a dire: «Signor archivista, mi prenda per matto o no, non me ne importa
niente, ma qui su questa pianta il giorno dell'Ascensione ho visto la serpe
verde-oro... l'eterna innamorata dell'anima mia, la quale mi parlò con meravigliose
note di cristallo, mentre lei, signor archivista, gridava da far paura, oltre l'acqua.»
«Ma che dice, mio benefattore!» lo interruppe Lindhorst fiutando una presa
e sorridendo stranamente.
Anselmo si sentì alleggerito poiché era riuscito a portare il discorso su quella
meravigliosa avventura e aveva l'impressione di aver fatto benissimo a incolpare
l'archivista di essere stato lui a tuonare a quel modo da lontano. Si fece ardito e
cominciò: «Ebbene, le voglio raccontare tutto ciò che di fatale mi è capitato la sera
dell'Ascensione, e poi dica e faccia e pensi di me quello che vuole.» E raccontò
davvero cominciando dall'infelice pedata al paniere delle mele fino alla fuga dei tre
serpenti verde-oro nell'acqua, e al fatto che tutti lo avevano preso per pazzo o
ubriaco: «Tutte cose,» conchiuse Anselmo, «che ho viste davvero, e ancora sento
risonare la limpida eco di quelle care voci. No, non era un sogno, e se non voglio
morire d'amore e di desiderio devo credere in quei serpenti verde-oro, anche se
dal suo sorriso, egregio archivista, rilevo che considera quei serpenti solo un parto
della mia fantasia esaltata e sopraeccitata. «Niente affatto,» replicò Lindhorst con
la massima calma e tranquillità. «I serpentelli che lei, signor Anselmo, ha visti sul
sambuco erano precisamente le mie tre figliole, e che lei si sia innamorato degli
occhi azzurri della più giovane che è chiamata Serpentina è ormai evidente. D'altro
canto già quel giorno, anche perché a casa, mentre stavo lavorando, quel
mormorio, quello scampanio mi parve eccessivo, dissi a quelle birichine che era
ora di tornare a casa, perché il sole stava tramontando ed esse si erano divertite
abbastanza a cantare e a succhiare raggi solari.»
Ad Anselmo sembrò di ascoltare soltanto con parole un po' più chiare un
discorso che aveva sospettato da un pezzo e, pur credendo di notare che il
sambuco, il muretto, le zolle erbose e gli oggetti intorno a lui cominciavano a girare
lentamente, raccolse le sue energie e stava per parlare, ma l'archivista glielo
impedì e si tolse rapidamente il guanto dalla sinistra facendo vedere allo studente
la pietra di un anello che mandava lampi e scintille meravigliosi. E intanto diceva:
«Guardi un po', caro signor Anselmo, ciò che vede le può far piacere.»
Anselmo guardò ed ecco, meraviglia! la pietra mandò come da un centro
infocato un ventaglio di raggi che si intrecciarono formando un luminoso specchio
di cristallo nel quale ora sfuggendosi, ora aggrovigliandosi danzavano e
saltellavano i tre serpentelli. Quando i corpi affusolati e sfavillanti si toccavano, ne
uscivano magnifici accordi prodotti da campane di cristallo, mentre il serpentello
mediano sporgeva dallo specchio il capino e gli occhi azzurri dicevano: «Mi
conosci, Anselmo? Credi in me? Soltanto nella fede sta l'amore, e tu puoi amare?»
«Oh Serpentina, Serpentina!» gridò lo studente nella sua estatica follia, ma
l'archivista soffiò rapidamente sullo specchio nel cui centro i raggi si raccolsero con
uno scoppiettio elettrico, mentre al dito dell'archivista riprese a scintillare uno
smeraldo che egli ricoprì col guanto. «Ha visto i serpentelli d'oro?» domandò.
«Mio Dio, sì,» rispose lo studente, «e anche la cara e bella Serpentina.»
«Zitto!» soggiunse l'archivista. «Per oggi basta. D'altro canto, se si vuol
decidere, può venire a lavorare da me, vedere più spesso le mie figlie, o piuttosto
le voglio procurare questo divertimento se si dimostrerà bravo al lavoro, voglio dire
se copierà tutti i disegni con la massima nettezza e precisione. Ma lei non viene,
nonostante che il signor Heerbrand mi abbia assicurato che sarebbe venuto
presto, e sono già parecchi giorni che l'aspetto invano.»
Quando l'archivista pronunciò il nome dell'attuario, Anselmo si rese
finalmente conto che stava coi piedi sulla terra, che era proprio lui, Anselmo, che
l'uomo che aveva di fronte era proprio Lindhorst. Il tono indifferente di
quest'ultimo, il vivo contrasto coi meravigliosi fenomeni che sapeva evocare da
autentico negromante, avevano un che di pauroso, tanto più che lo sguardo acuto
degli occhi scintillanti proveniva dalle ossute occhiaie di quel volto scarno e rugoso
come da una custodia; sicché lo studente si sentì impaurito come già nella bottega
del caffè dove l'archivista aveva fatto quei racconti avventurosi. Si riprese con
fatica e quando l'altro gli domandò un'altra volta perché non si fosse fatto vedere,
trovò il coraggio di esporgli tutto quanto gli era accaduto davanti alla porta di casa:
«Caro signor Anselmo,» disse l'archivista quando lo studente ebbe finito,
«conosco la donna delle mele della quale mi parla: è una sciagurata che mi giuoca
molti tiri, ed è molto grave, insopportabile quella sua maniera di farsi bronzare per
scacciare sotto forma di picchiotto i visitatori che mi sono graditi. Ma se domani
alle dodici vuol venire da me e nota ancora quel ghigno e quella voce gracchiante,
le sgoccioli sul naso un po' di questo liquido e vedrà che tutto si aggiusta. Addio
dunque, signor Anselmo, io cammino un po' in fretta e non posso pretendere che
lei ritorni in città insieme con me. Arrivederci a domani alle dodici.»
Così dicendo aveva dato allo studente una boccetta con un liquido giallo-oro
e si era allontanato a gran passi in modo che nel crepuscolo sceso nel frattempo
sembrava che volasse nella valle più di quanto non camminasse. Era già nei pressi
del Giardino di Kosel, allorché il vento gli si ingolfò nel pastrano e ne allargò le falde
fino a farle svolazzare nell'aria come un paio di grandi ali. Lo studente che seguì
l'archivista con lo sguardo stupito ebbe l'impressione di veder volare rapidamente
un grande uccello. E mentre guardava là fermo nel crepuscolo, un avvoltoio
bianco-grigio si sollevò con grandi strida nell'aria, ed egli avvertì come il candido
sventolio, che continuava a prendere per l'archivista in cammino, dovesse essere
stato proprio l'avvoltoio, benché non gli fosse chiaro come e dove quello era
improvvisamente scomparso.
«Però può anche essere volato via lui, l'archivista,» disse lo studente fra sé.
«Vedo infatti e sento che tutte le strane figure di un mondo lontano e
meraviglioso, come le vedevo di solito nei miei sogni, sono ora entrate nella mia
vita attiva e mi pigliano in giro... Ma, comunque sia, tu vivi e ardi nel mio cuore,
dolce cara Serpentina, e soltanto tu puoi appagare l'infinito desiderio che mi
strazia. Oh quando rivedrò i tuoi occhi soavi? Cara Serpentina!» Così parlò
Anselmo a voce alta.
«Codesto è un nome malvagio, non cristiano,» mormorò una voce di basso
accanto a lui; era un cittadino che ritornava dalla passeggiata.
Ricordandosi in tempo dove era, lo studente si allontanò a passi veloci
pensando tra sé: «Sarebbe forse una disgrazia se incontrassi ora il preside
Paulmann o l'attuario Heerbrand?»
Non incontrò invece né l'uno né l'altro.
QUINTA VEGLIA
La moglie del consigliere Anselmo. - Cicerone, De officiis. - Cercopitechi e altra
marmaglia. - La vecchia Luisa. - L'equinozio.
«Anselmo non si sa proprio da che parte prenderlo,» disse il vicepreside
Paulmann. «Tutti i miei insegnamenti, tutti i miei moniti sono vani. Non vuole
applicarsi benché abbia fatto i migliori studi che pur sono la base di tutto.»
L'attuario Heerbrand replicò con un sorriso arguto e misterioso: «Caro
preside, dia tempo e spazio ad Anselmo! È un soggetto curioso, ma promette
molto, e quando dico molto voglio dire un vero segretario o magari un consigliere
aulico.»
«Auli...» cominciò il vicepreside col massimo stupore, ma la parola gli rimase
in gola.
«Zitto, zitto!» continuò Heerbrand. «So quel che so. Per due giorni ormai è
dall'archivista Lindhorst a copiare e ieri sera al caffè l'archivista stesso mi ha detto:
‹Mi ha raccomandato un uomo di valore. Quello diventerà qualcuno.› E ora pensi
un po' alle aderenze che ha l'archivista... Ne riparleremo tra un anno.» L'attuario
continuando a sorridere con furbizia uscì e lasciò là di stucco il buon Paulmann
stupefatto e curioso.
Quel dialogo però aveva fatto una particolare impressione a Veronica. «L'ho
sempre detto io,» pensò, «che il signor Anselmo è un giovane intelligente,
amabile, e che diventerà qualcosa di grande. Sapessi almeno se mi vuol bene
davvero: ma quella sera quando eravamo in barca sull'Elba non mi ha forse stretto
la mano due volte? E durante il duetto non mi ha forse lanciato occhiate che
arrivavano al cuore? Sì, mi vuol proprio bene... E io...» Veronica, come fanno le
ragazze, si abbandonò ai bei sogni di un sereno avvenire. Era già la moglie del
consigliere aulico, abitava un bell'appartamento nella via del Castello o nel Mercato
nuovo... Un cappello moderno, il nuovo scialle turco le stavano a pennello... in
vestaglia elegante prendeva il caffè sul balcone impartendo alla cuoca gli ordini
per la giornata. «Ma non mi guasti la pietanza, è il piatto preferito del consigliere!»
Elegantoni a passeggio si voltavano in su e lei udiva chiaramente: «È una donna
meravigliosa, la moglie del consigliere, come le sta bene quella cuffietta di pizzo!»
La signora Ypsilon mandava il servitore a chiedere se la signora del consigliere
voleva avere la compiacenza di recarsi quel giorno ai Bagni di Link. «I miei rispetti,
ma mi dispiace immensamente, sono già impegnata al tè della presidentessa Tz.»
Ed ecco arrivare il consigliere Anselmo uscito assai presto per affari, vestito
all'ultima moda. «Perbacco sono già le dieci,» esclama guardando l'orologio d'oro
e dando un bacio alla mogliettina. «Come stai, amore, sai che cosa ti ho portato?»
dice con galanteria e cava dal taschino del panciotto un paio di orecchini stupendi
legati nello stile di moda. Lei se li mette al posto di quelli comuni. «Che begli
orecchini, veramente graziosi,» esclama a voce alta alzandosi dalla sedia e
buttando via il lavoro per andarsi a guardare nello specchio.
«Che storie sono queste?» domanda Paulmann che immerso nel De officiis di
Cicerone si è lasciato sfuggire di mano il libro. «Abbiamo gli attacchi come
Anselmo?»
In quel momento lo stesso Anselmo che contro al solito non si era fatto
vedere alcuni giorni, entrò con grande spavento e stupore di Veronica perché
effettivamente era tutto mutato. Con una certa risolutezza che non era punto
solita in lui cominciò a parlare di nuove tendenze nella sua vita, delle magnifiche
prospettive che gli si offrivano mentre qualcuno non avrebbe voluto saperne. E il
preside ricordando le misteriose parole dell'attuario rimase ancora più colpito e
rimase senza parola quando lo studente dopo aver accennato al lavoro urgente
presso l'archivista Lindhorst e aver baciato elegantemente la mano a Veronica era
già sceso dalle scale e partito.
«È già un consigliere aulico bell'e buono,» mormorò Veronica tra sé. «Mi ha
baciato la mano senza scivolare o pestarmi i piedi come al solito! Mi ha lanciato
un'occhiata molto tenera... mi vuol bene davvero.» E di nuovo si abbandonò ai
suoi sogni. Sennonché una figura ostile si mischiava nelle piacevoli scene della sua
futura vita domestica in quanto moglie del consigliere aulico, e la figura rideva
beffarda dicendo: «Sì, sono tutte sciocchezze volgari e per giunta menzogne
perché Anselmo non diventerà mai consigliere né tuo marito, tanto è vero che non
ti vuol bene nonostante i tuoi occhi azzurri, la tua figura snella e le tue belle mani.»
Detto ciò Veronica sentì il gelo correrle nelle vene mentre un grande
spavento annullava la tranquillità nella quale si era trovata un momento prima con
la cuffietta di pizzo in testa e gli orecchini eleganti. Stava per scoppiare in pianto e
disse ad alta voce: «È vero, è vero, non mi ama e non sarò mai la moglie di un
consigliere aulico.»
«Roba da romanzo, romanticherie!» esclamò il vicepreside e preso il
cappello e il bastone se ne andò infuriato.
«Mi mancava anche questa,» sospirò Veronica pigliandosela con la sua
sorella dodicenne che impassibile aveva continuato a ricamare al telaio. Intanto
erano quasi le tre, era ora di sparecchiare e di preparare il caffè perché le signorine
Oster avevano annunciato la loro visita. Ma dietro a ogni mobiletto che Veronica
spostava, dietro ai fascicoli di musica che toglieva dal pianoforte, dietro a ogni
tazzina e al bricco del caffè che toglieva dall'armadio quella figura balzava come un
piccolo mostro con la sua risata ironica, faceva schioccare le sottili dita da ragno e
gridava: «Eppure non sarà tuo marito, non l'avrai per marito!» Veronica piantò
ogni cosa e si ritirò nel mezzo della stanza ma quella sbucò enorme da dietro alla
stufa ringhiando e borbottando: «Eppure non sarà tuo marito!»
«Non senti nulla, sorella, non vedi nulla?» domandò Veronica che fra timore
e tremore non osava toccare nessun oggetto. Franceschina si alzò dal telaio seria
e tranquilla dicendo: «Ma che cosa hai oggi, sorella? Fai una grande confusione,
sbatti di qua e di là, bisogna proprio che ti aiuti.»
In quel momento però entrarono le ragazze con grandi risate e Veronica si
accorse che aveva preso il frontone della stufa per un personaggio e il cigolio dello
sportello della stufa chiuso male per quelle parole ostili. Presa da un grande orrore
non riuscì però a riaversi subito, sicché le amiche ebbero modo di scorgere la sua
insolita eccitazione che già il pallore e il viso stravolto tradivano. Interrompendo
bruscamente gli aneddoti allegri che stavano per raccontare, le amiche vollero
sapere che cosa le fosse accaduto e Veronica dovette confessare che si era
abbandonata a idee strane e a un tratto in pieno giorno era stata vittima di una
paura che normalmente non provava. E raccontò come da tutti gli angoli della
stanza un ometto grigio l'avesse beffata, lo raccontò così vivacemente che le
signorine si guardarono intorno con timore e quasi con un senso di raccapriccio.
Ma in quella entrò Franceschina col caffè fumante e tutte e tre riprendendosi
rapidamente risero della loro stoltezza. Angelica (così si chiamava la maggiore
delle Oster) era promessa a un ufficiale dell'esercito del quale mancavano notizie
da tanto tempo che si era potuto pensare alla morte sul campo o almeno a una
grave ferita. Angelica era rimasta costernata, ma ora appariva di un'allegria
smodata che fece stupire Veronica la quale glielo disse anche schiettamente.
«Mia cara,» rispose Angelica, «credi forse che io non abbia sempre il mio
Vittorio nel cuore e nella mente? Ma appunto per questo sono così serena, Dio mio,
così felice e beata. Vittorio infatti sta bene e tra poco lo vedrò col grado di capitano
di cavalleria, e avrà le onorificenze che si è conquistate col suo immenso valore.
Una ferita grave, ma non pericolosa al braccio destro, in seguito al colpo di
sciabola di un ussaro nemico gli impedisce di scrivere, e i rapidi spostamenti, dato
che non vuole lasciare il suo reggimento, gli tolgono per ora ogni possibilità di
mandarmi notizie, ma questa sera riceverà l'ordine preciso di badare anzitutto a
guarire. Partirà domani per venire qua e nel momento di montare in carrozza saprà
della sua nomina a capitano.»
«Ma, cara Angelica,» domandò Veronica, «come fai a saper tutto già ora?»
«Non ridere di me, cara amica,» proseguì Angelica. «So che non lo farai,
poiché per punizione l'omino grigio potrebbe far capolino dallo specchio. Insomma
non so rinunciare a credere a certe cose misteriose che sono avvenute nella mia
vita non poche volte visibilmente e direi quasi in modo da poterle toccare con
mano. Ora non mi pare affatto portentoso o incredibile come pare a tanti altri che
ci possano essere persone capaci di visioni e profezie e in grado di attuarle con
mezzi infallibili. C'è qui in paese una vecchia che possiede questo dono in misura
particolare. Non fa profezie, come altre della sua risma, con le carte, col piombo
fuso o coi fondi del caffè, ma dopo preparativi ai quali partecipa chi la interroga si
vede comparire in un lucido specchio metallico un gruppo di figure diverse e di
personaggi che lei interpreta ricavando la risposta alla domanda che le viene
rivolta. Ieri sera sono stata da lei e ho ricevuto quelle notizie intorno al mio Vittorio,
e senza alcun dubbio le considero vere.»
Il racconto di Angelica gettò una scintilla nella mente di Veronica e vi accese
l'idea di andare a interrogare la vecchia sul conto di Anselmo e delle proprie
speranze. Apprese che la vecchia si chiamava Rauer, abitava in una via remota
presso la Porta del Lago, la si trovava in casa soltanto il martedì, mercoledì e
venerdì dopo le sette di sera, ma per tutta la notte fino all'alba, e preferiva ricevere
persone sole.
Era appunto mercoledì e col pretesto di accompagnare a casa le Oster,
Veronica decise di andare dalla vecchia. E lo fece davvero. Aveva appena preso
commiato dalle amiche sul ponte dell'Elba allorché si recò con le ali ai piedi davanti
alla Porta del Lago e si trovò nel descritto vicolo remoto, in fondo al quale vide la
casetta rossa dove abitava la Rauer. Quando si trovò davanti alla porta di casa
provò effettivamente un senso di paura e fu scossa da un tremito. Poi si fece forza
nonostante la riluttanza interiore e tirò il cordone del campanello. La porta si aprì
e lei cercò nel corridoio buio la scala che portava al piano di sopra, come le aveva
spiegato Angelica. «Abita qui la signora Rauer?» domandò nel vestibolo deserto
poiché nessuno si era fatto vedere. Per tutta risposta udì un gnao lungo e distinto
mentre un grande gatto nero facendo la gobba e agitando la coda intorno a lei la
accompagnava fino alla porta di una stanza che a un secondo gnao si aprì.
«Oh, figlioletta, sei già qui? Vieni, vieni, entra!» Così disse la persona che si
era affacciata. A quella vista Veronica allibì. Era una donna lunga, magra, avvolta
in stracci neri. Mentre parlava, il mento aguzzo e sporgente tentennava, la bocca
sdentata si torceva all'ombra dell'ossuto naso aquilino, in un sorriso ghignante, e
dai grandi occhiali trasparivano occhi da gatto che mandavano lampi. Dal panno
variopinto che portava intorno alla testa le uscivano i capelli come setole nere, ma
l'orrore del viso ributtante era completato da due bruciature che dalla guancia
sinistra arrivavano oltre il naso. Veronica si sentì mancare il fiato, e un grido che
doveva darle sollievo si ridusse a un profondo sospiro quando la mano ossuta della
strega la prese e la tirò nella stanza.
Là dentro tutto si moveva ed agitava, era un confuso miagolio, un gracchiare
e pigolare che avrebbe fatto inorridire chiunque. La vecchia batté il pugno sulla
tavola e gridò: «Silenzio, marmaglia!» I cercopitechi si arrampicarono guaiolando
sul baldacchino del letto, i porcellini d'India corsero sotto la stufa, il corvo svolazzò
sullo specchio rotondo e soltanto il gatto nero, come se quelle parole non lo
riguardassero, rimase tranquillo sulla poltrona, sulla quale si era seduto appena
entrato.
Il silenzio tranquillizzò Veronica. Non aveva più paura come là fuori nel
vestibolo e perfino la donna le sembrava meno orrenda. Perciò soltanto ora si
guardò intorno: dal soffitto pendevano brutti animali impagliati, sul pavimento
erano sparpagliati oggetti sconosciuti e nel caminetto ardeva un focherello azzurro
che solo di quando in quando scoppiettava mandando faville gialle; allora però si
udiva dall'alto un fruscio e schifosi pipistrelli col ghigno di facce umane volavano di
qua e di là, talvolta la fiamma si alzava lingueggiando sul muro fuligginoso e allora
si sentivano grida di dolore laceranti che empivano di orrore e spavento il cuore
della ragazza.
«Con permesso, signorina,» disse la vecchia sorridendo e preso un gran
ciuffo di penne lo tuffò in una caldaia di rame e asperse il caminetto. Il fuoco si
spense e come avvolta in una densa fumata la stanza fu immersa nelle tenebre;
ma poco dopo la vecchia che era andata in una cameretta ritornò con un lume
acceso e Veronica non vide più nulla di quegli animali e di quegli strani oggetti ma
soltanto una camera comune ammobiliata poveramente. La vecchia si avvicinò e
disse con voce stridula: «So che cosa vuoi da me, figlia mia. Scommetto che
vorresti sapere se sposerai Anselmo quando sarà diventato consigliere aulico.»
La ragazza impietrì dallo spavento e dalla meraviglia, ma la vecchia
continuò: «Hai già detto tutto in casa di tuo padre davanti al bricco del caffè: quel
bricco ero io. Non mi hai riconosciuta? Ascolta, figliola, abbandona Anselmo, è un
individuo cattivo, ha preso a pedate in faccia le mie figliolette, le mie care figliole,
tenerine dalle guance rosse che quando qualcuna le compera gli scappano dalle
tasche e tornano nel mio paniere. Lui sta dalla parte del vecchio e l'altro ieri mi ha
versato sulla faccia il dannato orpimento che quasi mi accecava. Vedi ho ancora il
segno delle scottature. Lascialo perdere! Non ti ama perché ama una serpe
verde-oro, non sarà mai consigliere perché si è impiegato presso le salamandre e
intende sposare la serpe verde. Lascialo, abbandonalo!»
Veronica che in realtà aveva un carattere forte e saldo e sapeva facilmente
superare le paure puerili, si ritrasse di un passo e disse risolutamente: «Vecchia,
ho sentito parlare del vostro dono di vedere il futuro, perciò forse con troppa fretta
e curiosità desideravo sapere da voi se Anselmo che amo e stimo moltissimo potrà
un giorno essere mio. Se, invece di soddisfare un mio desiderio, volete prendermi
in giro con le vostre chiacchiere sciocche e assurde, agite male perché io volevo
soltanto ciò che ad altri concedete. Siccome, a quanto pare, sapete i miei più intimi
pensieri, vi sarebbe stato facile rivelarmi cose che ora mi tormentano e
angosciano, ma dopo le vostre stupide calunnie contro il buon Anselmo non voglio
saper altro da voi. Buona notte!»
Veronica stava per uscire in tutta fretta, ma la vecchia si buttò in ginocchio
piangendo e gemendo e prese la ragazza per un lembo del vestito: «Piccola
Veronica, non conosci più la vecchia Luisa che tante volte ti ha portato in braccio
e curato e accarezzato?»
Veronica non credeva ai propri occhi: riconobbe infatti, sia pure sfigurata
dalla vecchiaia e soprattutto dalle scottature, la sua antica governante che
parecchi anni prima era scomparsa dalla casa del vicepreside Paulmann. D'altra
parte la vecchia aveva un altro aspetto, invece del brutto panno multicolore
portava una cuffia decente e invece degli stracci neri una comune giacchetta a
fiorami. Si alzò e stringendo Veronica fra le braccia, continuò: «Tutto quanto ti ho
detto ti sembrerà forse pazzesco, ma purtroppo è così. Anselmo mi ha fatto un
gran male, ma certo senza volere: è caduto nelle mani dell'archivista Lindhorst che
gli vuol dare in moglie sua figlia. È il mio peggiore nemico, quell'archivista, e di lui
ti potrei dire molte cose, ma non le capiresti o non faresti che spaventarti. È un
uomo saggio, ma io sono una donna saggia. Lasciamo andare! Ora vedo benissimo
che vuoi molto bene ad Anselmo e ti voglio assistere con tutte le mie forze perché
tu sia felice e possa sposarti come desideri.»
«Ma per amor del cielo, Luisa, ditemi...» intervenne Veronica.
«Zitta, figliola, zitta!» la interruppe la vecchia, «so che cosa vuoi dire, sono
diventata quella che sono perché ho dovuto, non potevo fare altrimenti; dunque,
so il mezzo per guarire Anselmo dallo stolto amore per la serpe verde e per
portarlo fra le tue braccia quando sarà amabilissimo consigliere aulico. Ma tu mi
devi aiutare.»
«Parla chiaro, Luisa! Sono disposta a tutto perché amo Anselmo
immensamente,» bisbigliò Veronica.
«Ti conosco,» proseguì la vecchia, «so che sei una ragazza coraggiosa,
invano volevo farti dormire col babau, perché proprio allora spalancavi gli occhi
per vederlo; senza lume eri capace di andare nell'ultima stanza e spaventavi i
bimbi del vicinato indossando l'accappatoio di tuo padre. Vediamo dunque: se fai
sul serio e con la mia arte vuoi sconfiggere l'archivista e la serpe verde, se
veramente vuoi avere per marito il consigliere Anselmo, esci di nascosto dalla casa
di tuo padre la notte del prossimo equinozio alle undici e vieni da me. Andremo
insieme fino al crocicchio che attraversa la campagna non lontano di qui,
prepariamo quanto occorre e spero che sosterrai le meraviglie al loro apparire. E
ora, figliola, buona notte, il babbo ti aspetta con la minestra.»
Veronica si allontanò in fretta fermamente decisa a non mancare la notte
dell'equinozio. «Ha ragione Luisa,» pensava, «Anselmo è stretto da strani legami,
ma io lo scioglierò e voglio che sia mio per sempre, il consigliere aulico Anselmo.»
SESTA VEGLIA
Il giardino dell'archivista Lindhorst e alcuni uccelli beffardi. - Il vaso d'oro. - Il
corsivo inglese. - Brutte raspature di gallina. - Un principe degli spiriti.
«Ma può anche darsi,» disse tra sé lo studente Anselmo, «che il finissimo e
forte liquore digestivo, bevuto piuttosto avidamente presso il signor Conradi, abbia
suscitato quei folli fantasmi che mi angosciarono davanti alla porta dell'archivista.
Oggi perciò non voglio bere affatto, ma affrontare qualunque avversità che mi
capiti di incontrare.»
Come allora quando si era preparato a fare la prima visita all'archivista,
raccolse i disegni a penna, i capolavori calligrafici, i bastoncini di inchiostro di
china, le penne di corvo ben temperate e stava già per uscire quando l'occhio gli
cadde sulla boccetta col liquido giallo che aveva ricevuto da Lindhorst. Allora gli
passarono per la mente a colori vivaci le sue strane avventure e un ineffabile
sentimento di piacere e di dolore gli strinse il petto. Istintivamente chiamò con
voce lamentevole: «Dolce Serpentina, vengo dall'archivista soltanto per vedere
te?» In quel momento gli parve che l'amore di Serpentina dovesse essere il premio
di un lavoro faticoso e pericoloso al quale doveva accingersi, cioè la copiatura dei
manoscritti di Lindhorst.
Era convinto che all'ingresso in quella casa, anzi prima ancora, dovesse
accadergli, come recentemente, qualcosa di strano. Non pensando più al digestivo
di Conradi si infilò nel taschino del panciotto il liquore per procedere secondo le
prescrizioni dell'archivista qualora la bronzata venditrice di mele dovesse avere
l'ardimento di ghignargli in faccia.
E non vide forse realmente spuntare il naso aguzzo, fiammeggiare gli occhi
felini dal picchiotto nel momento in cui alle dodici in punto stava per sollevarlo?
Allora, senza riflettere schizzò il liquido sul viso metallico che immediatamente si
spianò e lisciò diventando il tondo e lucido picchiotto. La porta si aprì, i campanelli
squillarono dolcemente per tutta la casa. Anselmo salì tranquillamente lo scalone
godendosi il profumo di eletti suffumigi che erano sparsi dappertutto. Si fermò
incerto sul pianerottolo non sapendo a quale delle belle porte dovesse bussare. In
quella uscì l'archivista in un'ampia vestaglia di damasco: «Sono lieto, signor
Anselmo, che mantenga finalmente la parola. Venga, mi segua perché la devo
accompagnare subito al laboratorio.» Così dicendo attraversò il pianerottolo e aprì
una porticina che dava in un corridoio. Anselmo lo seguiva tranquillo. Dal corridoio
passarono in una sala o meglio in una splendida serra perché da ogni lato salivano
fino al soffitto ogni sorta di fiori meravigliosi, alberi addirittura con foglie e fiori
strani. Dappertutto era diffusa una luce magica abbagliante senza che se ne
vedesse l'origine perché non c'erano finestre. Quando lo studente insinuava lo
sguardo tra i fiori e nei cespugli pareva che lunghi corridoi si estendessero in
lontananza. Nelle dense ombre di fitti cipressi nani luccicavano bacini di marmo dai
quali sporgevano strane figure, zampillavano getti cristallini che ricadevano
gorgogliando in luminosi calici di gigli; era un sussurrare di strane voci e un
frusciare nel folto di quelle piante donde montavano e scendevano pregevoli
profumi. L'archivista era scomparso e Anselmo vide davanti a sé soltanto un
enorme ciuffo di amarillidi fiammanti. Inebriato da quella vista e dai dolci aromi nel
giardino fatato, Anselmo rimase affascinato. Ed ecco dappertutto un ridere e
ridacchiare di vocine sottili e ironiche: «Signor studente, signor studente, da dove
viene? Perché si è fatto così bello, signor Anselmo? Vuol fare quattro chiacchiere
con noi? Dirci come la nonna schiacciò l'uovo col deretano e il giovanotto si fece
una macchia sul panciotto della domenica? Ha già imparato a memoria la nuova
aria di babbo Starmatz? Sa che è buffo con la parrucca di vetro e con gli stivaloni
di carta da lettere?» Così gli arrivavano da tutti gli angoli i ridolini e le ironie,
venivano anzi da presso perché soltanto ora lo studente si accorse degli uccelli
colorati che gli volavano intorno e con quelle risate lo prendevano in giro.
In quell'istante il ciuffo di amarillidi fiammanti gli si mosse incontro ed egli
vide che era l'archivista la cui vestaglia fiorata di giallo e di rosso lo aveva
ingannato. «Mi perdoni, signor Anselmo,» disse Lindhorst, «se l'ho lasciato solo,
ma passando di qui sono andato a vedere il mio bel cactus che questa notte
sboccerà. Ma mi dica, questo giardinetto le piace?»
«Dio mio, immensamente, egregio signor archivista,» rispose lo studente,
«ma questi uccelli colorati si burlano troppo della mia pochezza!»
«Che andate cianciando?» esclamò l'archivista infuriato rivolgendosi agli
uccelli. In quella un grande pappagallo grigio uscì ad ali spiegate e posandosi su un
ramo di mirto accanto al padrone e guardandolo con molta gravita attraverso gli
occhiali che portava sul becco curvo bofonchiò: «Non se ne abbia a male, signor
archivista, i miei bricconcelli sono di ottimo umore, ma la colpa è del signor
studente, poiché...»
«Silenzio!» lo interruppe l'archivista. «Conosco quei birbanti, ma voi
dovreste tenere meglio le redini, caro amico. Andiamo avanti, signor Anselmo!»
Lindhorst infilò ancora alcune stanze stranamente ammobiliate così in fretta
che lo studente riusciva appena a seguirlo e a gettare un'occhiata alle forme
curiose di quei mobili e agli oggetti sconosciuti che apparivano dappertutto.
Entrarono infine in un'ampia stanza dove l'archivista si fermò alzando gli occhi e
Anselmo ebbe tempo di godersi la stupenda vista della sala decorata con
semplicità. Dalle pareti azzurre sporgevano i tronchi dorati di grandi palme che
inarcavano sul soffitto i ventagli enormi, lucidi come smeraldi scintillanti; nel
mezzo della sala su tre leoni egiziani fusi in bronzo c'era una lastra di porfido che
reggeva un semplice vaso d'oro dal quale, appena lo vide, Anselmo non sapeva più
distrarre gli occhi. Pareva che su quell'oro lucido e raggiante si movessero una
quantità di personaggi con mille riflessi. Ogni tanto vedeva anche se stesso con le
braccia bramosamente distese, ahimè, accanto al sambuco... e Serpentina vi si
avvolgeva guardandolo con gli occhi soavi. Egli era fuori di sé in un'estasi folle.
«Serpentina, Serpentina!» chiamò a gran voce. L'archivista si volse di scatto e
disse: «Come dice, signor Anselmo? Ha chiamato, credo, mia figlia, che adesso
però è in camera sua nell'altra parte della casa e prende lezione di pianoforte.
Venga, venga.»
Anselmo lo seguì quasi privo di sensi, non udiva, non vedeva più nulla, finché
l'archivista lo prese per mano: «Eccoci arrivati!» Anselmo si destò come da un
sogno e vide che si trovava in una stanza alta con le pareti ricoperte di scaffali
simili a quelli di una comune biblioteca. Nel mezzo c'era una grande scrivania e
davanti una poltrona imbottita.
«Questo,» spiegò l'archivista, «è per ora il suo studio. Non so ancora se in
avvenire dovrà lavorare nell'altra sala, nella biblioteca azzurra dove ha chiamato
per nome mia figlia. Intanto desidero farmi un'idea delle sue capacità, vedere se
realmente può eseguire il lavoro secondo il mio desiderio e bisogno.»
Anselmo si sentì incoraggiato e non senza soddisfazione, anzi convinto di
dare una gran gioia all'archivista col suo straordinario ingegno, trasse i suoi disegni
e le sue scritture. L'archivista appena vide il primo foglio, una scrittura secondo la
più elegante maniera inglese, abbozzò uno strano sorriso e scosse il capo. Lo
stesso fece ai fogli seguenti, di modo che lo studente si sentì montare il sangue alla
testa e quando quel sorrisetto si fece addirittura ironico e sprezzante sbottò a dire
indignato: «Si direbbe, signor archivista, che non è soddisfatto del mio povero
ingegno.»
«Caro signor Anselmo,» rispose l'altro, «lei ha ottime attitudini all'arte della
calligrafia, ma per il momento, a quanto vedo, devo per forza fare maggiore
assegnamento sulla sua diligenza, sulla buona volontà che sull'abilità. Può anche
darsi che dipenda dal cattivo materiale che ha usato.»
Lo studente parlò a lungo della sua bravura che tutti riconoscevano,
dell'inchiostro di china e delle sue scelte penne di corvo. L'archivista gli porse allora
il foglio inglese e disse: «Giudichi lei!»
Anselmo rimase come colpito dalla folgore quando osservò quella sua misera
scrittura. Mancava ogni profondità del tratto, la pressione era sbagliata, non c'era
proporzione tra le maiuscole e le minuscole, un raspaticcio da scolaretto rovinava
spesso la riga abbastanza ben riuscita. «E poi,» continuò Lindhorst, «il suo
inchiostro non è resistente.» Intinse il dito in un bicchiere d'acqua, lo passò
leggermente sulle lettere e tutto scomparve senza lasciare traccia. Lo studente
ebbe l'impressione che un mostro gli stringesse la gola e non poté proferire parola.
Se ne stette lì con lo sciagurato foglio in mano, mentre l'archivista si metteva a
ridere: «Non se ne faccia un cruccio, carissimo signor Anselmo! Se non è riuscito
finora, potrà riuscire meglio qui da me, e poi avrà a sua disposizione un materiale
migliore. Cominci pure e stia tranquillo!» Andò anzitutto a prendere una massa
nera liquida che mandava un odore singolare, alcune penne ben temperate di uno
strano colore, e un foglio particolarmente bianco e liscio; estrasse poi da uno stipo
un manoscritto arabo e mentre Anselmo si metteva al lavoro uscì dalla stanza.
Questi aveva già copiato altre volte caratteri arabici, sicché il primo compito non gli
sembrò difficile. «Dio solo e l'archivista sapranno come mai quella raspatura di
galline abbia deturpato il mio bel corsivo inglese,» disse, «ma voglio rimetterci il
collo se quella scrittura è di mio pugno.»
A ogni parola che riusciva bene sulla pergamena il suo coraggio aumentava
e con esso la sua bravura. Infatti si scriveva benissimo con quelle penne e il
misterioso inchiostro era nero come un'ala di corvo e scorreva docilmente sulla
pergamena abbagliante, tanto era bianca. Mentre lavorava assiduamente con viva
attenzione si sentì sempre più bene in quella stanza solitaria e si era familiarizzato
col lavoro che sperava di finire felicemente, allorché alle tre in punto l'archivista lo
chiamò nella stanza attigua per la colazione gia apparecchiata. A tavola l'archivista
fu di un umore particolarmente sereno; s'informò degli amici, di Anselmo, il
vicepreside Paulmann e l'attuario Heerbrand, e di quest'ultimo raccontò vari
aneddoti divertenti. Anselmo gustò l'ottimo vecchio vino del Reno che lo rese più
loquace di quanto non fosse generalmente. Alle quattro in punto si alzò per
ritornare al lavoro, e quella puntualità dovette piacer molto all'archivista. Se prima
del pasto la copiatura dei caratteri arabici era andata bene, adesso il lavoro fu
ancora più proficuo: anzi Anselmo non si spiegava la facilità e la destrezza con cui
riusciva a riportare i tratti arricciati di quella scrittura forestiera. Era però come se
dal fondo dell'anima una voce gli sussurrasse: «Oh, potresti forse eseguire questo
lavoro se il tuo pensiero non fosse rivolto a lei, se tu non credessi in lei, nel suo
amore?» E nella stanza entrò come un soffio di sommessi e sussurranti suoni
cristallini: «Ti sono vicina... vicina... vicina! Ti aiuto io... Abbi coraggio... Sii
costante, caro Anselmo! Lavoro con te affinché tu sia mio.» E mentre percepiva
quei suoni, i caratteri ignoti gli diventavano sempre più comprensibili... quasi non
occorreva che guardasse l'originale... anzi i segni sembravano già tracciati sulla
pergamena e bastava che la sua mano li annerisse. Così continuò a lavorare
circondato da suoni consolanti, da un dolce e delicato respiro finché la campana
suonò le sei e l'archivista entrò. Con uno strano sorriso si avvicinò alla scrivania,
Anselmo si era alzato in silenzio, l'archivista continuò a guardarlo quasi con ironia,
ma appena ebbe visto la copia, il sorriso scomparve sotto una serietà solenne che
gli si dipinse sul viso. Dopo un po' non pareva più lui, gli occhi che di solito
mandavano fiamme guardarono ora Anselmo con ineffabile dolcezza, un lieve
rossore gli tinse le guance pallide e invece dell'ironia che gli faceva stringere le
labbra queste parvero aprirsi ad arco grazioso e prepararsi a un discorso saggio e
penetrante. La sua persona era più alta, più dignitosa, l'ampia vestaglia si adattò
intorno al suo petto e alle sue spalle in larghe pieghe come un manto regale, e nei
riccioli bianchi sulla fronte alta e aperta apparve un sottile cerchio d'oro. «Caro
giovane,» cominciò l'archivista in tono solenne, «prima che tu lo sospettassi, io
sapevo già la segreta relazione che ti lega a quanto ho di più caro e di più sacro.
Serpentina ti ama e una strana sorte le cui fila fatali sono intessute a potenze ostili,
si adempirà se diventerà tua e se tu riceverai, dote necessaria, il vaso d'oro che le
appartiene. Ma soltanto dalla battaglia sboccia la tua felicità di una vita superiore.
Princìpi nemici agiscono e soltanto l'interiore energia con la quale resisti agli
attacchi ti può salvare dall'ignominia, dalla rovina. Mentre lavori qui tu superi il
periodo di apprendista; fede e conoscenza ti conducono alla vicina meta se rimani
fedele all'impresa nella quale ti sei messo. Portala fedelmente nel cuore, colei che
ti ama, e vedrai gli stupendi miracoli del vaso d'oro e sarai felice per sempre.
Addio. L'archivista Lindhorst ti aspetta domani alle dodici nel tuo laboratorio.
Addio!» Lindhorst accompagnò dolcemente Anselmo fuori della porta che poi
richiuse. Lo studente si trovò nella stanza dove aveva fatto colazione; c'era
un'unica porta che dava sul pianerottolo. Stordito dalle meravigliose apparizioni si
fermò davanti alla porta di casa. Sopra di lui si aprì una finestra alla quale apparve
l'archivista, vecchio, con la solita giacca grigio-chiaro. «Caro signor Anselmo,» gli
parlò, «a che cosa pensa, scommetto che non le esce di mente il carattere arabico.
Non è così? Mi saluti il vicepreside Paulmann, se va da lui, e ritorni domani alle
dodici. Il compenso di oggi è già nel taschino destro del suo panciotto.»
Lo studente trovò davvero un tallero lustro nella tasca indicata, ma non ne
ebbe alcuna gioia. «Chissà dove si va a finire?» disse fra sé. «Ma se anche sono
preda di un incantesimo o di una follia, nel mio cuore vive la dolce Serpentina e
prima di abbandonarla preferirei morire perché so che dentro di me il pensiero è
eterno e non vi è principe nemico che lo possa distruggere: ma il pensiero è forse
qualcosa di diverso dall'amore di Serpentina?»
SETTIMA VEGLIA
Come il vicepreside Paulmann vuotò la pipa e andò a letto. - Rembrandt e Breughel
il Giovane. - Lo specchio magico e la ricetta del dottor Eckstein contro una malattia
sconosciuta.
Infine il vicepreside Paulmann vuotò la pipa e disse: «Adesso però sarebbe
ora di andare a riposare.»
«Sicuro,» replicò Veronica, impensierita che suo padre fosse ancora alzato:
infatti erano le dieci passate.
Ora, non appena il vicepreside si ritirò nella camera da letto che gli serviva
anche da studio, non appena il respiro profondo di Franceschina rivelò che era
veramente addormentata, Veronica che era pure andata a letto per finta, si alzò
piano piano, si vestì, si buttò sulle spalle la mantellina e di nascosto uscì di casa.
Dal momento in cui aveva lasciato la vecchia Luisa, Veronica aveva sempre
Anselmo davanti agli occhi e una voce estranea che non sapeva nemmeno lei di chi
fosse le andava dicendo e ripetendo che la riluttanza di lui proveniva da una
persona a lei nemica la quale lo teneva in catene che lei poteva spezzare soltanto
con misteriosi mezzi dell'arte magica. La sua fiducia nella vecchia Luisa aumentava
di giorno in giorno, persino la sua impressione di orrore e di raccapriccio si attenuò
di modo che tutto quanto c'era di strano nei suoi rapporti con la vecchia le appariva
sotto una luce insolita e romanzesca che appunto l'attirava. Perciò era fermamente
decisa a eseguire il suo proponimento anche a rischio di essere scoperta e di
andare incontro a un mucchio di dispiaceri. Arrivata finalmente la notte fatale
dell'equinozio per la quale la vecchia le aveva promesso aiuto e conforto, Veronica,
alla cui mente quella escursione notturna era ormai familiare, si sentì piena di
coraggio. Passò come una freccia per le vie solitarie senza badare al temporale che
infuriava e le gettava in viso grosse gocciole di pioggia. Con suono cupo e
rimbombante la campana della chiesa batté undici colpi nel momento in cui la
ragazza giunse bagnata fino all'osso davanti alla casa della vecchia.
«Cara, sei già qui? Aspetta, aspetta!» sentì chiamare dall'alto e poco dopo
vide arrivare la vecchia con una cesta e col gatto che l'accompagnava. «Andiamo
dunque a fare ciò che si deve opportunamente nella notte favorevole all'opera!»
Così dicendo la vecchia prese per un braccio la ragazza tremante alla quale diede
da portare la cesta carica, mentre lei recava un paiolo, un treppiede e una vanga.
Quando furono all'aperto la pioggia era cessata, ma il vento era più forte che
mai ed empiva l'aria di mille voci. Lamenti paurosi e laceranti scendevano dalle
nuvole nere che in rapida fuga si accavallavano coprendo ogni cosa di fitte
tenebre.
La vecchia camminava di buon passo gridando ogni tanto: «Fai lume! Fai
lume, piccolo mio!» I lampi azzurri s'incrociavano serpeggiando e Veronica notò
che il gatto mandando scintille luminose e scoppiettanti saltellava davanti a loro e
quando la bufera cessava un istante, mandava miagolii terrificanti. Veronica si
sentiva mancare il fiato, le sembrava che gelidi artigli le strappassero le viscere,
ma facendosi forza e aggrappandosi alla vecchia disse: «Ora è necessario
compiere l'impresa, accada quel che vuole!»
«Brava figliola!» reagì la vecchia. «Tieni duro e vedrai che ti regalo qualcosa
di bello e Anselmo per giunta.» Poi si fermò e disse: «Ecco, siamo arrivati.» Scavò
una buca nella terra, vi versò dei carboni, vi collocò il treppiede e su questo il
paiolo, accompagnando tutto con gesti strani mentre il gatto le girava intorno:
dalla coda sprizzavano scintille e formavano un cerchio di fuoco. Dopo un po' il
carbone si accese e di sotto al treppiede si levarono fiamme azzurre. Veronica
dovette deporre la mantellina e il velo e accoccolarsi accanto alla vecchia che le
strinse le mani guardandola con occhi ardenti. Gli oggetti che la vecchia aveva
tolto dalla cesta e buttava nel paiolo - non si riusciva a distinguere se fossero fiori,
metalli, erbe, animali - cominciarono a bollire e a gorgogliare. La vecchia lasciò
andare la ragazza e prese un cucchiaio di ferro col quale si mise a girare quella
massa incandescente, mentre a un suo comando Veronica dovette fissare il
contenuto del paiolo pensando intensamente ad Anselmo. La vecchia vi gettò
ancora metalli lucenti, una ciocca che la ragazza si era tagliata dal cocuzzolo della
testa e un anellino che portava da molto tempo, e lanciò nella notte voci squillanti
e incomprensibili mentre il gatto sempre correndo miagolava e gemeva.
Vorrei, benevolo lettore, che tu fossi stato in viaggio per Dresda il 23
settembre; al cadere della notte si è cercato invano di trattenerti all'ultima
stazione; l'oste ti ha avvertito cordialmente che la pioggia e il vento erano troppo
forti e non era consigliabile viaggiare nel buio sotto l'equinozio, ma tu non gli hai
dato retta considerando giustamente che dando un tallero di mancia al postiglione
arrivavi al più tardi alla una a Dresda dove all'Angelo d'oro o all'Elmo o alla Città di
Naumburg ti aspettavano un'ottima cena e un morbido letto. Mentre ora viaggi
nelle tenebre, vedi a un tratto in lontananza un lume sfiaccolante. Arrivato più
vicino scorgi un anello di fuoco al cui centro presso un paiolo, dal quale scattano
lampi rossi e scintille in mezzo a un fumo denso, stanno sedute due persone. La
strada conduce esattamente attraverso il fuoco, ma i cavalli sbuffano e scalpitano
e s'impennano, il postiglione prega e bestemmia e li frusta. I cavalli non si
muovono. Senza volerlo balzi dalla diligenza e percorri un tratto a gran passi. Ora
vedi chiaramente la bella fanciulla in veste bianca e leggera inginocchiata presso il
paiolo. La bufera le ha sciolto le trecce e i lunghi capelli castani svolazzano
nell'aria. Il viso angelico appare negli abbaglianti riflessi delle fiamme che
lingueggiano sotto il braciere, ma per l'orrore che lo investe come un torrente
gelato è irrigidito in un pallore cadaverico; nello sguardo fisso, sulle sopracciglia
sollevate, sulle labbra che invano si aprono al grido dell'angoscia mortale incapace
di uscire dall'indicibile tortura del petto oppresso, tu vedi il suo raccapriccio, il suo
spavento; essa leva le manine convulsamente strette come per invocare e pregare
gli angeli custodi di salvarla dai mostri dell'inferno, i quali obbedienti alla tremenda
magia stanno per comparire. Così sta inginocchiata, immobile, una statua di
marmo. Per terra di fronte a lei è accovacciata una donna scarna, giallognola, con
l'acuto naso di falco e scintillanti occhi felini. Dal nero mantello che tiene sulle
spalle sbucano le braccia nude e ossute mentre rimescolando il cibreo infernale
ride e gracchia nell'infuriare della bufera. Sono convinto che, anche se tu non sai
che cosa sia la paura e il timore, alla vista di quella scena degna d'un Rembrandt
o di Breughel il Giovane, ti sentiresti rizzare i capelli sulla testa. Ma il tuo sguardo
non ha potuto staccarsi dalla ragazza coinvolta in quell'impresa infernale, e la
scossa elettrica che ti fa tremare i nervi e le fibre ha suscitato, con la rapidità del
lampo, l'idea coraggiosa di affrontare i poteri segreti di quella cerchia di fuoco;
essa ha vinto il tuo orrore, anzi l'idea stessa è germogliata da questo orrore. Ti è
sembrato di essere tu uno degli angeli custodi ai quali la fanciulla mortalmente
angosciata levava la sua preghiera, anzi di dover estrarre subito la pistola e di
ammazzare senz'altro la vecchia. Ma al balenare di questo pensiero ti sei messo a
gridare: «Olà!» oppure: «Che succede?» oppure: «Che state facendo?» Il
postiglione ha fatto squillare il corno, la vecchia è precipitata nel suo cibreo ed ogni
cosa è scomparsa a un tratto nel fumo soffocante.
Non voglio affermare che avresti trovato la ragazza che cercavi
ansiosamente nelle tenebre, ma avresti distrutto l'incantesimo della vecchia e
rotto l'incanto del cerchio magico nel quale Veronica era entrata con troppa
leggerezza.
Sennonché né tu, mio lettore, né altri era in viaggio quel ventitré settembre
nella notte tempestosa, favorevole alle arti magiche, e Veronica dovette
perseverare vicino al paiolo in angoscia mortale finché l'opera fu quasi compiuta.
Sentì certamente urlare e rombare intorno a sé, udì ogni sorta di voci odiose che
belavano e gracidavano ma non aprì gli occhi perché sentiva che la vista di quegli
orrori l'avrebbe portata alla pazzia inguaribile. La vecchia aveva smesso di
rugumare nel paiolo, il fumo si fece sempre più rado e infine sul fondo del paiolo
non rimase che una fiammella a spirito. «Veronica, figlia mia,» esclamò la vecchia
a questo punto. «Guarda, guarda qua dentro! Che cosa vedi?»
Ma Veronica non fu in grado di rispondere per quanto le sembrasse che là
dentro si movesse un confuso gruppo di persone; queste però divennero sempre
più riconoscibili finché dal fondo del paiolo sorse lo studente Anselmo che porse la
mano alla ragazza guardandola amorevolmente. Questa esclamò: «Oh, è
Anselmo, è Anselmo!»
La vecchia aprì immediatamente il rubinetto applicato al paiolo e il metallo
incandescente empì sibilando e scrosciando una piccola forma che la vecchia
aveva collocato accanto al paiolo. Poi si agitò berciando e danzando con gesti
orribili e selvaggi: «L'opera è compiuta! Grazie, piccolo mio. Hai fatto la guardia...
uh; uh, ecco che viene! Mordilo a morte, mordilo a morte!»
In quella si udì un rombo nell'aria come se un'aquila enorme scendesse
frusciando e sbattendo le ali e gridando con voce spaventevole: «Ah, marmaglia!
Ora è finita... è finita. Via di qua! A casa.» La vecchia stramazzò con un urlo e
Veronica cadde priva di sensi.
Quando si riebbe era giorno chiaro, stava nel suo letto e Franceschina era
davanti a lei con una tazza di tè fumante: «Sorella, dimmi che cos'hai, sono qui da
un'ora o forse più, e tu nell'arsura della febbre gemi e sospiri svenuta mettendomi
addosso una grande paura. Per causa tua il babbo non è andato a scuola e
ritornerà subito col dottore.»
Veronica prese il tè in silenzio; e mentre lo centellinava le riapparvero
vivacemente le orride scene notturne. «Sicché è stato soltanto un sogno
angoscioso a torturarmi? Eppure ieri sera sono andata veramente dalla vecchia.
Non era forse il ventitré settembre? Ma solo ieri mi devo essere ammalata e ho
soltanto immaginato tutto quanto, e nulla mi ha fatto male quanto il continuo
pensare ad Anselmo e alla strana vecchia che si è spacciata per Luisa e non ha
voluto altro che prendermi in giro.»
Franceschina che era uscita rientrò recando la mantellina di Veronica ancora
grondante. «Vedi, sorella,» disse, «che fine ha fatto la tua mantellina: questa
notte il vento ha spalancato la finestra e rovesciato la sedia sulla quale era la
mantellina; poi la pioggia deve essere entrata perché come vedi, gronda ancora.»
Veronica si rattristò accorgendosi che non era stato un sogno a tormentarla,
ma era andata davvero dalla vecchia. In preda alla paura e all'orrore si mise a
tremare per la febbre, che l'agghiacciava. Convulsamente si tirò la coperta fin sugli
occhi, ma in quella avvertì qualche cosa di duro che le premeva il petto e quando
allungò la mano trovò come un medaglione; uscita sua sorella lo guardò e vide che
si trattava di uno specchietto rotondo, di metallo brunito. «Un dono della vecchia,»
esclamò e le parve che raggi infocati uscissero da quello specchio e le
penetrassero nel cuore emanando un calore benefico. I brividi della febbre erano
passati e un indescrivibile senso di benessere la pervase tutta piacevolmente. Non
poté fare a meno di pensare ad Anselmo e mentre i suoi pensieri si concentravano
su di lui, egli le sorrideva dallo specchio come un vivace ritratto in miniatura. Ma
dopo un po' non ne vide più l'immagine... vide invece lo studente in carne ed ossa.
Era seduto in una sala alta dai mobili strani e scriveva assiduamente. Veronica
avrebbe voluto avvicinarsi, posargli una mano sulla spalla e dirgli: «Signor
Anselmo, si volti, sono qua io.» Ma non era possibile perché sembrava circondato
da un luminoso cerchio di fuoco e guardando meglio Veronica vide che si trattava
di grossi volumi dal taglio dorato. Infine però riuscì a guardarlo negli occhi; e allora
parve che egli dovesse riflettere per rammentarsi di lei, ma poi sorrise e disse:
«Ah, è lei, cara signorina Paulmann! Ma perché si compiace di presentarsi talvolta
in veste di serpe?» A queste strane parole Veronica scoppiò a ridere e così si
svegliò da un sonno profondo e nascose rapidamente lo specchietto perché la
porta si apriva e Paulmann entrava insieme col dottor Eckstein.
Questi si avvicinò subito al letto, prese il polso di Veronica, si immerse in
profonde riflessioni, e disse: «Ahi, ahi!» Scrisse poi una ricetta, tastò ancora una
volta il polso, ripeté: «Ahi, ahi!» e uscì.
Ma dalle parole del dottore il vicepreside non riuscì a capire precisamente
che male avesse Veronica.
OTTAVA VEGLIA
La biblioteca delle palme. - Vicende di una salamandra infelice. - Come la penna
nera accarezzò una barbabietola e l'attuario Heerbrand prese una solenne sbornia.
Lo studente Anselmo lavorava ormai da parecchi giorni presso l'archivista
Lindhorst; quelle ore erano per lui le più felici della sua vita perché, circondato
sempre da musiche gentili, dalle parole confortanti di Serpentina, talvolta sfiorato
da un soffio fuggevole, si sentiva pervaso da una gradevolezza che non aveva mai
provata e ora saliva fino alle gioie più elevate. Dalla sua mente erano scomparse
tutte le miserie, tutte le meschine apprensioni della sua povera esistenza, e in
quella nuova vita presentatasi come la più viva luce del sole afferrava tutte le
meraviglie di un mondo superiore che di solito lo avevano riempito di stupore e
persino di spavento. La copiatura procedeva rapidamente in quanto sempre più gli
sembrava di scrivere sulla pergamena soltanto segni già noti senza quasi guardare
l'originale per imitare ogni cosa con la massima precisione.
Salvo che al momento di andare a tavola l'archivista si faceva vedere solo
raramente, ma ogni volta compariva esattamente nel momento in cui Anselmo era
arrivato agli ultimi caratteri di un manoscritto, e gliene dava un altro, ma usciva
subito in silenzio dopo aver rimescolato l'inchiostro con un bastoncino nero e aver
sostituito le penne usate con altre meglio temperate e più appuntite.
Un giorno, mentre era salito per la scala al suono delle dodici, Anselmo trovò
chiusa la porta dalla quale era solito entrare, e l'archivista gli venne incontro da
un'altra parte, avvolto nella curiosa vestaglia tutta cosparsa di fiori luminosi:
«Oggi, caro Anselmo, entri di qui perché dobbiamo andare nella stanza dove ci
attendono i maestri di Bhovogotghita.» E attraversato il corridoio lo condusse per
le medesime stanze e sale della prima volta.
Anselmo si stupì di nuovo allo splendore del giardino, ma notò chiaramente
che certi fiori strani appesi ai cespugli in realtà erano insetti di magnifici colori, i
quali sbattevano le ali e danzando in turbine si accarezzavano coi loro succhiatoi.
Per contro gli uccelli color di rosa o celesti erano fiori profumati, e l'aroma che
diffondevano saliva dai loro calici con piacevoli suoni sommessi che morivano in
misteriosi e nostalgici accordi col mormorio delle fontane, col fruscio degli arbusti
e degli alberi. Gli ironici uccelli che la prima volta lo avevano beffato gli
svolazzavano di nuovo intorno e facevano udire continuamente la loro vocina:
«Signor studente, non abbia tanta fretta... non stia a guardare così le nuvole...
potrebbe cascare e battere il naso. Olà, signor studente, si metta l'accappatoio...
compare Gufo le vuol pettinare il tuppè.» Così echeggiavano quelle frasi sciocche
finché Anselmo non uscì dal giardino.
Lindhorst entrò finalmente nella stanza azzurra: il porfido col vaso d'oro era
scomparso, al suo posto c'era un tavolino coperto d'un tappeto di velluto viola sul
quale stava l'occorrente per scrivere, ben noto ad Anselmo, e davanti al tavolino
una poltrona ugualmente tappezzata. «Caro signor Anselmo,» cominciò
l'archivista, «ora lei ha già copiato parecchi manoscritti, presto e bene, con mia
grande soddisfazione, si è acquistato la mia fiducia, ma rimane da fare la parte più
importante, cioè la copiatura o meglio pittura di certe opere in caratteri particolari
che conservo in questa stanza e si possono copiare soltanto qui. Perciò da ora in
poi lavorerà in questa stanza, ma le devo raccomandare la massima prudenza e
attenzione; un tratto sbagliato, o, il cielo non voglia, una macchia d'inchiostro
sull'originale sarebbe la sua rovina.»
Anselmo osservò che dai tronchi dorati delle palme sporgevano foglioline
d'un verde smeraldo; l'archivista ne prese una e Anselmo vide che in realtà la
foglia era un rotolo di pergamena che l'archivista svolse e stese davanti a lui sulla
scrivania. Anselmo si meravigliò non poco di quei segni intrecciati e alla vista dei
numerosi puntini, delle aste, degli svolazzi che pareva rappresentassero piante o
muschi o figure di animali, fu quasi sul punto di scoraggiarsi disperando di poter
riprodurre esattamente tutti quei segni. Si fece meditabondo, ma l'archivista gli
suggerì: «Coraggio, giovanotto! Se la tua fede è salda e sincero il tuo amore avrai
l'aiuto di Serpentina.» La sua voce era come metallo sonante e quando Anselmo
alzò lo sguardo impaurito l'archivista stava davanti a lui in abito regale come gli era
apparso alla prima visita nella biblioteca. Per il rispetto Anselmo fu in procinto di
piegare un ginocchio, ma l'archivista salì lungo il tronco di una palma e scomparve
tra le foglie di smeraldo. Lo studente si rese conto che chi gli aveva parlato era il
principe degli spiriti, il quale salito nel suo studio intendeva discorrere coi raggi che
alcuni pianeti gli avevano mandato e decidere l'avvenire di lui e di Serpentina.
«Può anche darsi,» pensò, «che lo aspettino novità dalle sorgenti del Nilo o la
visita di un mago della Lapponia... ma a me conviene accingermi al lavoro.» E
cominciò a studiare i nuovi caratteri del rotolo di pergamena.
A lui giungeva la meravigliosa musica del giardino, dolci profumi alitavano
intorno a lui, udiva anche ridacchiare i sarcastici uccelli senza però comprenderne
le parole, e di ciò era ben contento. Talvolta stormivano anche le foglie smeraldine
delle palme irradiando quei piacevoli suoni cristallini che Anselmo aveva uditi sotto
il sambuco il fatale giorno dell'Ascensione. Meravigliosamente confortato da quelle
note e dalle luci lo studente considerò con sempre maggiore attenzione la
soprascritta del rotolo ed ebbe l'impressione che quei segni dovessero significare:
Sposalizio del salamandro con la serpe verde.
In quella squillò un forte accordo di limpide campane di cristallo. «Anselmo,
caro Anselmo,» disse una voce dalle foglie, ed ecco che, meraviglia!, lungo il
tronco della palma scendeva la serpe verde.
«Serpentina, dolce Serpentina!» chiamò Anselmo nell'estasi quasi folle
poiché, guardando più attentamente, vide una splendida fanciulla dagli occhi
azzurri come quelli che vivevano nel suo cuore, la quale gli andava incontro
guardandolo con indicibile desiderio. Le foglie si abbassarono, si allargarono, dai
tronchi germogliarono aculei, ma Serpentina vi passava in mezzo torcendosi
abilmente e tirandosi dietro l'abito svolazzante che tinto di colori cangianti e
aderendo al corpo snello non rimaneva mai attaccato agli aculei o alle spine
sporgenti dalle palme. Si sedette accanto ad Anselmo sulla medesima poltrona, lo
cinse con un braccio e strinse talmente da fargli sentire il respiro che usciva dalle
sue labbra e il calore elettrico delle sue membra. «Caro Anselmo,» cominciò a dire,
«presto sarai tutto mio, tu mi conquisti con la tua fede e con l'amore, e io ti porterò
il vaso d'oro che ci renderà felici per sempre.»
«Dolce, cara Serpentina, purché abbia te, che m'importa il resto? Purché tu
sia mia, morirò volentieri in mezzo alle meraviglie che mi tengono stretto da
quando ti ho incontrata.»
«So bene,» proseguì Serpentina, «che le ignote meraviglie delle quali mio
padre si circonda talvolta secondo che gli frulla, hanno suscitato in te orrore e
raccapriccio, ma ciò non si ripeterà, spero, perché in questo momento sono qui
soltanto per raccontare per filo e per segno a te, mio caro Anselmo, dal profondo
del cuore tutto ciò che è necessario tu sappia per conoscere a fondo mio padre e,
in genere, per capire chiaramente la sua e la mia sorte.»
Anselmo aveva l'impressione di essere avvinto e stretto da quella soave
figura al punto di potersi muovere soltanto insieme con lei, e di sentire nei propri
nervi e nelle proprie fibre battere soltanto il polso di lei; ascoltava le sue parole che
gli sonavano dentro e come raggi luminosi accendevano in lui le gioie del paradiso.
Aveva posato un braccio intorno a quel corpo più che snello, ma la stoffa dell'abito
cangiante e luminosa era così liscia, così. viscida da sembrargli che lei potesse
sfuggirgli irresistibilmente, e a questo pensiero tremò. «Non abbandonarmi, cara
Serpentina,» disse quasi senza volere, «tu sei la mia vita.»
«Non prima,» rispose Serpentina, «che ti abbia raccontato tutto ciò che puoi
comprendere per l'amore che mi porti: sappi dunque, mio caro, che mio padre
discende dalla meravigliosa stirpe delle salamandre e io devo la vita al suo amore
per la serpe verde. In antichissimi tempi regnava nella portentosa Atlantide
Fosforo, il potente principe degli spiriti elementari. Un giorno il suo salamandro
prediletto (era mio padre) passeggiava nel magnifico giardino che la madre di
Fosforo aveva adornato coi suoi doni più belli e udì un'alta amarillide che cantava
sommessa: ‹Chiudi bene gli occhi, mio diletto, finché il vento mattutino non ti
svegli!› E gli si avvicinò e, tocca dal suo fiato ardente, aprì i petali sicché egli ne
vide la figlia, la serpe verde, chiusa dentro al calice. Il salamandro fu preso allora
da violento amore per la bella serpe e la rapì all'amarillide il cui profumo
lamentevole chiamava invano per tutto il giardino la figlia adorata. Il salamandro
l'aveva portata nel castello di Fosforo pregandolo: ‹Fammi sposare la diletta
perché voglio che sia mia per sempre.› ‹Stolto, che cosa chiedi mai?› disse il
principe degli spiriti. ‹Sappi che una volta l'amarillide è stata la mia diletta e
regnava insieme con me, ma la scintilla che gettai dentro di lei minacciò di
annientarla, e soltanto la vittoria sul drago nero, che gli spiriti della terra tengono
ora incatenato, mantenne in vita l'amarillide di modo che i suoi petali rimasero
abbastanza forti per racchiudere e conservare la scintilla. Se tu invece arrivi
all'amplesso della serpe verde il tuo ardore la consumerà e un nuovo essere,
germogliando rapidamente, sorgerà da te.› Il salamandro non tenne conto del
monito del principe, ma ardente di desiderio strinse la serpe tra le sue braccia e
così la ridusse in cenere, mentre un essere alato, nato da quella serpe, volò via per
l'aria. Il salamandro preso dalla follia e dalla disperazione si diede a correre per il
giardino vomitando fuoco e fiamme e nella sua furia selvaggia lo devastò
bruciando fiori e piante che empirono l'aria dei propri lamenti. Il principe degli
spiriti montò in collera, afferrò il salamandro e disse: ‹Il tuo fuoco ha cessato
d'imperversare... spente sono le tue fiamme, accecati i tuoi raggi... sprofonda fino
agli spiriti della terra che ti tengano prigioniero e ti insultino finché l'ignea sostanza
si riaccenda e salga radiosa dalla terra insieme con te rinnovellato.› Il povero
salamandro cadde spento, ma il vecchio burbero spirito della terra che faceva il
giardiniere di Fosforo intervenne: ‹Signore, chi dovrebbe lagnarsi del salamandro
più di me? Non avevo forse ornato dei miei più bei metalli i fiori che quello ha
bruciato, non ne avevo curato e allevato i germi e prodigato loro molti bei colori?
Eppure mi prendo a cuore il povero salamandro cui soltanto l'amore, dal quale tu
stesso, signore, fosti preso molte volte, portò alla disperazione e alla devastazione
del giardino. Condonagli la pena troppo dura!› ‹Per ora il suo fuoco è spento,›
disse il principe degli spiriti. ‹Nel tempo infelice quando il linguaggio della natura
non sarà più compreso dalla degenere stirpe degli uomini, quando gli spiriti
elementari esiliati nelle loro regioni parleranno all'uomo soltanto dalle lontananze
con muti accenti, quando lontano dal circolo armonioso soltanto un'infinita
nostalgia darà all'uomo l'oscura nozione del regno meraviglioso che prima gli era
lecito abitare, mentre ancora albergava nell'animo la fede e l'amore, in quell'epoca
disgraziata si accenderà un'altra volta l'ignea sostanza del salamandro che però
diventerà soltanto uomo e, entrando nella misera vita, ne dovrà sopportare le
pene e i disagi. Ma non gli rimarrà soltanto il ricordo delle sue origini, rivivrà anche
nella sacra armonia con la natura intera, ne comprenderà le meraviglie e avrà a
sua disposizione il potere degli spiriti affratellati. In un ciuffo di amarillidi egli
ritrova poi la serpe verde e il frutto della loro unione sono tre figlie che appaiono
agli uomini sotto l'aspetto della madre. A primavera si tengono avvinte al sambuco
e fanno sentire le loro dolci voci cristalline. Se poi nella misera epoca degli animi
induriti si trova un giovane che ne ode il canto, se anche una delle serpi lo guarda
coi suoi begli occhi, questo sguardo suscita in lui il presentimento del lontano
meraviglioso paese al quale può coraggiosamente arrivare, e se si libera dal peso
della volgarità, se insieme con l'amore per la serpe coltiva la fede nei miracoli della
natura e nella propria esistenza in mezzo a questi miracoli con vivacità e ardore, la
serpe diventa sua. Il salamandro però non può gettare il peso molesto e andare dai
suoi fratelli prima che si trovino tre giovani così fatti e abbiano sposato le tre figlie.›
‹Permetti, signore,› disse lo spirito della terra, ‹che a queste tre figlie io faccia un
dono per glorificare la loro vita con lo sposo trovato. Consegno a ciascuna un vaso
del più bel metallo che possiedo, lucidato coi raggi che ho colti dal diamante: in
esso dovrà rispecchiarsi il nostro magnifico regno che ora è in pieno rigoglio con
tutta la natura, con abbaglianti riverberi, da esso però nel momento dello
sposalizio sboccerà un'amarillide di fuoco il cui fiore perpetuo avvolgerà nel suo
profumo il giovane che avrà dato buona prova. Ed egli ne comprenderà subito il
linguaggio, si renderà conto delle meraviglie del nostro regno e abiterà con la
sposa amata nell'Atlantide.› Ora, caro Anselmo, tu sai già che mio padre è il
salamandro del quale ti ho parlato. Nonostante la sua natura superiore ha dovuto
assoggettarsi ai più meschini disagi della vita comune e di qui viene probabilmente
il suo capriccio, la gioia del male altrui con la quale talvolta prende in giro. Più volte
mi ha detto che per quell'intimo atteggiamento spirituale che Fosforo, il principe
degli spiriti, pose allora come condizione delle nozze con me e con le mie sorelle,
si è introdotta ora una definizione che però fin troppo spesso è usata in modo
sconveniente: dice che questo è detto oggi animo puerile e poetico e lo si trova in
giovani che, per la grande semplicità dei loro costumi e perché manca loro del
tutto la così detta pratica del mondo, sono oggetto di ironia da parte della plebe.
Caro Anselmo, tu hai inteso sotto il sambuco il mio canto, hai compreso il mio
sguardo, ami la serpe verde, credi in me e vuoi essere mio per sempre. Dal vaso
d'oro sorgerà la bella amarillide fiorita e noi vivremo felici e beati nell'Atlantide! Ma
non ti devo nascondere che nell'orrenda battaglia con le salamandre e con gli
spiriti della terra il drago nero si liberò e fuggì rombando per l'aria. Vero è che
Fosforo lo tiene di nuovo incatenato, ma dalle penne nere che in quella lotta si
sparsero per la terra sono germogliati spiriti nemici che resistono dappertutto alle
salamandre e agli spiriti della terra. Quella donna che ti è così avversa e, come mio
padre sa benissimo, aspira al possesso del vaso d'oro, deve la sua esistenza
all'amore di una di quelle penne, staccatesi dall'ala del drago, con una
barbabietola. Lei sa la sua origine e il suo potere perché nei gemiti, nelle
convulsioni dei drago prigioniero le si manifestano i segreti di talune mirabili
costellazioni, e ricorre a tutti i mezzi per agire sull'animo, mentre mio padre la
combatte con le folgori che scattano dall'animo del salamandro. Essa raccoglie i
principi ostili contenuti nelle erbe dannose e negli animali velenosi e mescolandoli
sotto costellazioni favorevoli produce stregonerie malvagie che insinuano nei sensi
dell'uomo orrore e spavento e lo sottomettono al potere di quei demoni che il
drago produsse soccombendo nella battaglia. Guardati da quella vecchia, caro
Anselmo, ti è nemica perché il tuo cuore infantile e pio ha già distrutto parecchi dei
suoi incantesimi. Tienti a me fedelmente, ti manca poco per toccare la meta!»
«Oh, mia, mia Serpentina!» esclamò lo studente. «Come potrei lasciarti,
come potrei non amarti in eterno?»
Un bacio ardente sfiorò le sue labbra ed egli si destò come da un sogno.
Serpentina era scomparsa, l'orologio suonò le sei ed egli pensò con rammarico di
non aver copiato nulla. Pensando a ciò che avrebbe detto l'archivista guardò il
foglio ed ecco, meraviglia! la copia del misterioso manoscritto era felicemente
terminata e, guardando attentamente i caratteri, gli sembrò di aver copiato il
racconto di Serpentina.
In quella entrò l'archivista in soprabito bianco-grigio, il cappello in testa, il
bastone in mano. Guardò la pergamena scritta da Anselmo, aspirò un'abbondante
presa e disse sorridendo: «Volevo ben dire! Bene, ecco qui il tallero. E adesso ce
ne andiamo ai Bagni di Link. Mi segua!» A passi rapidi attraversò il giardino nel
quale c'era un tale frastuono di canti e fischi e discorsi che lo studente rimase
stordito e ringraziò il cielo quando fu nella strada.
Avevano fatto pochi passi quando incontrarono l'attuario Heerbrand che
gentilmente si accompagnò a loro. Fuori porta caricarono la pipa, l'attuario si
lamentò di non aver portato l'acciarino, ma l'archivista lo rimbeccò: «Ma che
acciarino! Ecco qui il fuoco, quanto ne vuole!» E facendo schioccare le dita ne fece
uscire grosse faville che in un momento accesero le pipe.
«Ha visto il trucchetto chimico?» fece l'attuario, ma lo studente, non senza
che il cuore gli tremasse, pensò al salamandro.
Ai Bagni di Link Heerbrand bevve tanta birra forte che, benché fosse di solito
un bonaccione tranquillo, si mise a cantare canzoni goliardiche con una voce fessa
da tenore, e a tutti domandava se fossero o no amici suoi, e infine dovette essere
accompagnato a casa dallo studente, mentre Lindhorst se ne era andato da un
pezzo.
NONA VEGLIA
Come lo studente Anselmo mise un po' di giudizio. - Il ponce in compagnia. - Come
Anselmo prese il vicepreside per un gufo e questi andò perciò su tutte le furie. - La
macchia d'inchiostro e le sue conseguenze.
I fatti strani e mirabili che Anselmo aveva vissuti ogni giorno lo straniarono
del tutto dalla vita comune. Non vedeva più nessuno degli amici e aspettava ogni
mattina con impazienza le dodici, l'ora che gli apriva il paradiso. Eppure mentre il
suo spirito era continuamente rivolto alla soave Serpentina e al regno fatato
dell'archivista, talvolta pensava istintivamente a Veronica, anzi di quando in
quando gli sembrava che la ragazza andasse da lui e arrossendo gli confessasse
quanto lo amava e quanto era impegnata a liberarlo dai fantasmi che si burlavano
di lui. Qualche volta gli pareva che un potere estraneo lo trascinasse
irresistibilmente verso l'obliata Veronica ed egli fosse costretto a seguirlo quasi
fosse legato alla ragazza da ferree catene. Proprio nella notte in cui per la prima
volta aveva visto Serpentina sotto l'aspetto di una fanciulla meravigliosa, in cui
aveva appreso il grande segreto delle nozze tra il salamandro e la serpe verde,
Veronica gli apparve più viva che mai. E solo quando si svegliò capì di aver soltanto
sognato poiché aveva avuto la convinzione che Veronica fosse venuta veramente
da lui e con un'espressione di profondo dolore si fosse lamentata di vederlo
disposto a sacrificare il vivo amore di lei alle visioni fantastiche provocate soltanto
dal suo sconquasso interiore, per cui avrebbe finito con l'andare in disgrazia e in
rovina. Veronica era amabile più di quanto non l'avesse mai vista ed egli non
riusciva a levarsela dalla mente: era un tormento al quale sperava di sfuggire con
una passeggiata mattutina.
Una forza magica lo trasse davanti alla Porta di Pirna e stava per imboccare
una via traversa allorché Paulmann lo rincorse chiamando: «Ehi, ehi, caro signor
Anselmo! Amico mio, dove si è mai cacciato? Non la si vede più... Lo sa che
Veronica non vede l'ora di cantare un duetto con lei? Venga, venga. Non veniva da
me?»
Lo studente non poté fare a meno di andare col vicepreside. Appena
entrarono, Veronica andò loro incontro vestita con molta cura, tanto che Paulmann
domandò meravigliato: «Perché così in ghingheri? Aspettavi visite? Ecco che ti
porto il signor Anselmo!»
Quando questi baciò elegantemente la mano a Veronica provò come un urto
che gli accese e fece vibrare i nervi. Veronica era l'allegria, la grazia in persona e
quando Paulmann si ritirò nel suo studio si occupò di Anselmo e con raggiri e
malizie seppe farlo alzare di tono al punto che, superata la sua timidezza, si diede
a rincorrere per la stanza l'allegra fanciulla. Sennonché il demone della sua
goffaggine gli fu di nuovo addosso e lo mandò a sbattere contro il tavolino
facendone cadere il grazioso cestino da lavoro che la ragazza vi teneva. Anselmo
lo raccolse, vide che il coperchio si era rotto, ma scoprì lo specchietto rotondo nel
quale si guardò. Veronica si mise alle sue spalle, gli posò una mano sul braccio e
stringendosi a lui guardò anche lei nello specchio. Anselmo sentì scatenarsi una
lotta dentro di lui, un guizzare di pensieri, di immagini che poi sparivano...
l'archivista Lindhorst, Serpentina, la serpe verde... finché tutto fu calmo e la
confusione si assestò e compose in un ordine cosciente. Allora comprese che
aveva pensato sempre a Veronica, che la figura apparsagli il giorno prima nella
stanza azzurra anche lei era stata Veronica, e la fantastica leggenda delle nozze tra
il salamandro e la serpe verde egli l'aveva soltanto scritta, ma non gli era stata
raccontata. Si stupì quindi dei propri sogni e li ascrisse unicamente al suo stato
d'animo esaltato dall'amore per Veronica e al lavoro presso l'archivista le cui
stanze erano piene di quel greve profumo inebriante. Non poté fare a meno di
ridere della folle illusione di essere innamorato di una serpicina e di aver preso
l'altolocato archivista per un salamandro. «Ma sì, sì, è Veronica!» esclamò ad alta
voce. Voltandosi guardò Veronica negli occhi azzurri che brillavano d'amore e
desiderio, mentre un profondo sospiro le usciva dalle labbra che in quel momento
ardevano su quelle di lui.
«Felice me,» disse lo studente estasiato, «quello che ieri fu un sogno oggi è
diventato realtà.»
«E mi sposerai davvero quando sarai diventato consigliere aulico?»
domandò la ragazza.
«Certamente,» rispose Anselmo mentre la porta cigolava e il vicepreside
entrava dicendo: «Ottimo signor Anselmo, oggi non mi scappa, si accontenterà
della nostra minestra dopo di che Veronica ci preparerà un delizioso caffè che
prenderemo insieme con l'attuario Heerbrand, il quale mi ha promesso di passare
di qua.»
«Egregio preside,» ribatté Anselmo, «non sa che devo andare dall'archivista
Lindhorst per quelle copiature?»
«Guardi qua, amico mio!» disse Paulmann mostrandogli l'orologio che
segnava le dodici e mezzo. Era troppo tardi per andare dall'archivista e perciò
Anselmo accolse il desiderio del vicepreside, tanto più che sperava di poter vedere
Veronica tutto il giorno, di ricevere da lei qualche occhiata furtiva, qualche tenera
stretta di mano e di darle magari un bacio. A questo punto erano saliti i desideri
dello studente il quale si sentiva sempre più a suo agio quanto più si convinceva
che si sarebbe liberato in breve da quelle fantastiche illusioni che potevano
portarlo veramente alla pazzia.
L'attuario arrivò alla fine della colazione e preso il caffè mentre già calava il
crepuscolo sollevò le mani sorridendo e disse di aver portato una cosa che
manipolata e sistemata dalle belle mani di Veronica, impaginata e rubricata,
avrebbe recato molto piacere a tutti in quella fresca sera di ottobre.
«Be', egregio attuario, fuori fuori! Vediamo il segreto che ci ha portato!»
disse Paulmann. L'altro si mise la mano nel tascone del soprabito e ne cavò in tre
riprese una bottiglia di rum, zucchero e limoni. Non era passata mezz'ora e sulla
tavola di Paulmann fumava un ponce delizioso. Veronica versò a ciascuno la
bevanda, mentre tra gli amici si intrecciava una allegra conversazione. Ma quando
i fumi della bevanda montarono alla testa di Anselmo gli ritornarono anche le
visioni delle meraviglie vissute in quegli ultimi tempi. Vide l'archivista in vestaglia di
damasco che brillava come fosforo, vide la stanza azzurra, le palme dorate e gli
parve di dover assolutamente aver fede in Serpentina. Dentro di lui c'era un
grande fermento. Veronica gli porse un bicchiere di ponce e prendendolo egli le
sfiorò la mano.
«Serpentina! Veronica!» sospirò, poi s'immerse nei sogni, ma l'attuario
osservò: «Strano quel vecchio, l'archivista Lindhorst, chi capisce qualcosa? Ma via,
facciamogli un brindisi! Tocchi il mio bicchiere, signor Anselmo!»
Lo studente si riscosse e brindando con l'attuario spiegò: «Dipende dal fatto
che il signor archivista è in realtà un salamandro che nell'ira devastò il giardino di
Fosforo, il principe degli spiriti, perché la serpe verde gli era scappata.»
«Come? Cosa?» fece il vicepreside.
«Sì,» continuò Anselmo, «per questo gli tocca fare il regio archivista e vivere
qui a Dresda con le tre figlie, le quali però non sono altro che serpentelle verde-oro
che prendono il sole tra i rami del sambuco, cantando con voce affascinante e
seducendo i giovani come le sirene.»
«Signor Anselmo,» esclamò Paulmann, «le ha dato di volta il cervello? Che
sciocchezze mi viene sciorinando?»
«Ha ragione lui,» interloquì l'attuario. «Quel bel tipo di archivista è una
salamandra che il diavolo lo porti, schiocca le dita sprizzando scintille che come
esca accesa bucano il soprabito. Certo, fratellino Anselmo, hai ragione tu, e chi
non crede è mio nemico.» E con queste parole Heerbrand batté un pugno sulla
tavola facendo tintinnare i bicchieri.
«Attuario, è forse impazzito?» gridò il vicepreside immusonito. «Signor
studente, che cosa mi combina?»
«Ahimè,» sospirò Anselmo. «Anche lei non è altro che un uccello, un gufo,
signor preside, che pettina i tuppè.»
«Come? Io un uccello? Un gufo? Un parrucchiere?» gridò Paulmann
infuriato. «Caro signore, lei è matto, matto da legare!»
«Ma la vecchia gli piomba addosso,» esclamò l'attuario.
«Si, la vecchia è potente,» lo interruppe Anselmo, «anche se è di umile
origine, poiché il suo babbo è un miserabile pennacchio e la sua mamma una vile
barbabietola, ma la sua forza la deve soprattutto a creature nemiche, a canaglie
velenose che le stanno intorno.»
«Questa è una calunnia!» intervenne Veronica adirata. «La vecchia Luisa è
una donna saggia e il gatto nero non è affatto una creatura nemica, bensì un
giovane colto, gentile, e suo cugino.»
«Ma quella salamandra là può forse mangiare senza bruciarsi la barba e
perire miseramente?» domandò l'attuario.
«No, assolutamente no!» gridò Anselmo. «Non lo potrà mai e poi mai. E la
serpe verde mi vuol bene perché ho un cuore infantile e ho sempre guardato
Serpentina negli occhi.»
«Glieli caverà il gatto,» sentenziò Veronica.
«La salamandra, la salamandra li sconfigge tutti,» urlò il vicepreside su tutte
le furie. «Ma sono forse in un manicomio? Sono matto anch'io? Che follie vado
dicendo? Sì, anch'io, anch'io sono matto, matto anch'io!» E levatosi con un balzo si
strappò dalla testa la parrucca e la scagliò contro il soffitto facendovi frusciare i
riccioli schiacciati che sciolti e rovinati sparsero intorno tutta la cipria.
Allora lo studente e l'attuario afferrarono la coppa del ponce e i bicchieri e li
scaraventarono gridando di gioia contro il soffitto di modo che i cocci volarono da
ogni parte tintinnando. «Viva la salamandra... Abbasso, abbasso la vecchia...
rompete lo specchio! Cavate gli occhi al gatto! Uccellino... uccellino dell'aria...
evviva, evviva la salamandra!» urlavano tutti e tre come ossessi. Franceschina
scappò piangendo, Veronica si buttò sul divano piagnucolando.
La porta si aprì, subito si fece un grande silenzio e un omino in cappotto
grigio entrò nella stanza. Aveva la faccia stranamente seria, stinta, dal naso
aquilino sul quale portava un paio di grandi occhiali. Aveva anche una parrucca
particolare, simile a un berretto di piume.
«Buona sera a tutti,» gracidò il buffo omino, «penso che sia qui il signor
Anselmo. Tanti ossequi da parte del signor archivista Lindhorst il quale oggi lo ha
aspettato invano. Prega però umilmente di non mancare domani alla solita ora.»
Così dicendo uscì e tutti si accorsero che l'omino così impettito era in realtà un
pappagallo grigio.
Paulmann e Heerbrand scoppiarono in una risata che rintronò nella stanza
mentre Veronica, straziata da una pena indicibile, piagnucolava e sospirava.
Anselmo invece, scosso dalla follia del suo terrore, uscì di corsa per le vie della
città. Trovò macchinalmente la sua abitazione, la sua cameretta. Poco dopo arrivò
Veronica tranquilla e cordiale a domandargli perché l'avesse angustiata talmente
nella sua ubriachezza e a pregarlo di guardarsi da altre fantasie durante il lavoro
presso l'archivista. «Buona notte, caro amico, buona notte,» bisbigliò posando un
bacio sulle sue labbra. Egli fece per prenderla tra le braccia, ma la visione
scomparve ed egli si svegliò confortato e sereno. Né poté fare a meno di ridere
cordialmente degli effetti di quel ponce. Pensando poi a Veronica si sentì pervaso
da un senso di pace. «A lei sola,» disse tra sé, «devo a lei sola se ho abbandonato
i miei stupidi grilli. In verità ero come quel tale che credeva di essere di vetro o
quell'altro che non usciva dalla stanza per paura di essere mangiato dai polli
perché si era messo in capo di essere un granello d'orzo. Ma non appena divento
consigliere sposo senz'altro la signorina Paulmann e sarò felice.»
A mezzogiorno, passando per il giardino dell'archivista, non finiva di stupirsi
come mai tutte quelle cose avevano potuto sembrargli singolari e meravigliose.
Non vide che comuni piante in vaso, una quantità di gerani, alberelli di mirto e
simili. Invece degli uccelli multicolori che gli avevano dato la baia non c'erano che
passeri i quali volavano di qua e di là con incomprensibili e sgradevoli pigolii non
appena scorgevano Anselmo. Anche la camera azzurra gli si presentò tutta diversa
ed egli non capiva come mai quell'azzurro violento e i tronchi delle palme con
quell'oro artificiale e le brutte foglie luccicanti avevano potuto piacergli sia pure un
istante.
L'archivista lo guardò con un particolare sorriso ironico e domandò:
«Ebbene, caro Anselmo, le è piaciuto ieri il ponce?»
«È stato certamente il pappagallo a...» rispose lo studente umiliato, ma si
interruppe pensando che anche l'apparizione del pappagallo doveva essere stata
un abbaglio dei sensi illusi.
«Facevo parte anch'io della compagnia,» spiegò l'archivista. «Non mi ha
visto? Eppure in quel pandemonio per poco non riportavo danni sensibili: infatti nel
momento in cui l'attuario prese la coppa per scaraventarla contro il soffitto, ero
ancora là dentro e dovetti rifugiarmi in tutta fretta nella pipa del vicepreside.
Arrivederci dunque, signor Anselmo... Sia bravo, le pago il tallero anche per la
perduta giornata di ieri, poiché finora ha lavorato così bene.»
«Possibile che l'archivista dica tante scemenze,» disse lo studente tra sé
sedendosi alla scrivania per cominciare la copia del manoscritto che, come al
solito, egli aveva davanti. Ma in quel rotolo di pergamena vide una tale confusione
di ghirigori e svolazzi da turbare la vista, che gli parve quasi impossibile riportare
tutto con esattezza, anzi guardando il foglio intero gli parve di vedere un marmo a
venature di vario colore o una pietra picchiettata di muschi.
Ciò nonostante voleva fare tutto il possibile e cominciò con l'intingere la
penna, ma siccome l'inchiostro non scorreva, la scosse con impazienza e... cielo!
una grande macchia cadde sull'originale. Una folgore azzurra scattò sibilando dalla
macchia e serpeggiò fragorosa attraverso la stanza fino al soffitto. Dalle pareti
sgorgò un fumo denso, le foglie cominciarono a stormire come agitate dalla
tempesta, schizzando basilischi lucenti dentro fiamme lingueggianti e appiccando
il fuoco al gran fumo finché la fiammata si rovesciò su Anselmo. I tronchi dorati
delle palme diventarono serpenti giganteschi che cozzando tra loro le orribili teste
mandarono squilli metallici e avvolsero Anselmo con le loro spire squamose.
«Matto che sei, subisci ora il castigo per l'impudente delitto che hai commesso!»
così gridò la terribile voce del salamandro coronato apparso al di sopra dei serpenti
come un raggio abbagliante, mentre da quelle fauci spalancate cadevano sopra ad
Anselmo cateratte di fuoco e pareva che quei torrenti infocati si consolidassero
intorno a lui formando una massa ghiacciata. Mentre le sue membra sempre più
strette si irrigidivano, Anselmo svenne.
Quando ritornò in sé era incapace di muoversi, gli pareva di essere
circondato da una gran luce contro la quale urtava non appena egli cercava di
alzare una mano e in genere di muoversi. Ahimè, era dentro a una ben tappata
bottiglia di cristallo, posata su uno scaffale nella biblioteca dell'archivista
Lindhorst.
DECIMA VEGLIA
Le pene dello studente nella bottiglia. - La vita beata dei liceali e dei cancellieri. La battaglia nella biblioteca dell'archivista. - Vittoria della salamandra e liberazione
di Anselmo.
A buon diritto credo di poter giudicare che tu, benevolo lettore, non sia mai
stato chiuso in una bottiglia di vetro, a meno che un sogno vivo e burlone non ti
abbia illuso con simili arti magiche. Se ti è capitato, capirai benissimo le misere
condizioni del povero studente; ma se non lo hai mai sognato, la tua vivace
fantasia, per far piacere a me e ad Anselmo, si chiuda per alcuni istanti entro il
cristallo.
Sei tutto circondato da uno splendore abbacinante, gli oggetti tutti intorno ti
appaiono illuminati dai raggi dell'arcobaleno. Tutto trema e romba nella luce... tu
nuoti immobile come in un etere congelato che si comprime in maniera che la
mente cerca invano di comandare al corpo morto... Il peso di quintali ti preme il
petto e continua ad aumentare... Ogni respiro consuma quel poco d'aria che può
ancora agitarsi nel breve spazio... Le tue arterie si gonfiano e ogni nervo graffiato
da un'orrenda paura guizza e sanguina nell'agonia. Caro lettore, abbi pietà dello
studente che nella sua prigione di vetro sopporta questo indescrivibile martirio.
Egli sentiva che la morte non lo poteva salvare, poiché non si era riavuto forse
dallo svenimento, dal quale era stato sopraffatto per l'effetto dei tormenti, nel
momento in cui il sole mattutino era entrato bello e luminoso nella stanza, e non
cominciava di nuovo il suo martirio? Non poteva muovere le membra ma i suoi
pensieri urtavano contro il vetro e lo stordivano con vibrazioni risonanti. E invece
delle parole che la mente pronunciava dentro di lui percepiva soltanto il cupo
fragore della follia.
Disperato gridò: «Serpentina, Serpentina, salvami da quest'inferno!» Allora
gli parve di sentir aleggiare lievi sospiri che si posavano sulla bottiglia come verdi
e diafane foglie di sambuco, il rombo cessò, la luce abbagliante scomparve ed egli
poté respirare più liberamente.
«Non è forse colpa mia se soffro così? Non ho commesso un delitto contro di
te, dolce e amata Serpentina? Non ho forse concepito dubbi sul conto tuo? Non ho
perduto la fede e con essa tutto ciò che mi doveva rendere felice? Ahimè, non sarai
mia mai più, il vaso d'oro è ormai perduto, non vedrò mai le meraviglie. Oh una
volta vorrei vederti ancora, ascoltare la tua bella voce, dolcissima Serpentina!»
Così si lamentava Anselmo dilaniato dal più profondo dolore allorché accanto a lui
qualcuno disse: «Non capisco, signor studente, che cosa vuole? Perché si lamenta
cosi?»
Anselmo notò che accanto a lui su quello stesso scaffale c'erano altre cinque
bottiglie che contenevano tre liceali e due cancellieri. «Oh, signori, miei compagni
di sventura,» disse, «possibile che siate così tranquilli, anzi contenti come mi
sembra di leggervi in viso! Anche voi siete imprigionati come me in bottiglie di
cristallo e non potete muovervi, anzi nemmeno concepire pensieri ragionevoli
senza suscitare un frastuono infernale e senza che la testa vi rintroni con rombi
paurosi. Certamente voi non credete nel salamandro e nella serpe verde.»
«Lei vaneggia, caro studente,» ribatté uno dei liceali, «non ci siamo mai
sentiti bene come qui, perché ci confortano i talleri ricevuti da quel matto di
archivista per le nostre copie più o meno confuse. Ora non abbiamo più bisogno di
imparare a memoria cori italiani, andiamo tutti i giorni da Giuseppe o in altre
bettole, beviamo birra forte, e poi guardiamo negli occhi qualche bella ragazza,
cantiamo da veri studenti il gaudeamus igitur e siamo contenti e beati.»
«Dicono bene questi signori,» intervenne uno dei cancellieri, «anch'io sono
provvisto di talleri come il mio caro collega e vado a spasso sul colle delle vigne
invece di star seduto tra quattro muri a copiare quei documenti esecrabili.»
«Ma, signori miei,» obiettò lo studente, «non vi accorgete di essere tutti
rinchiusi in bottiglie di vetro e di non potervi muovere e nemmeno andare a
spasso?»
I liceali e i cancellieri si misero a ridere e gridarono: «Lo studente è matto, si
figura di essere dentro a una bottiglia invece si trova sul ponte dell'Elba e guarda
nell'acqua. Andiamo, andiamo via!»
«Ahi,» sospirò Anselmo, «costoro non hanno mai visto la bella Serpentina,
non sanno che cosa sia la libertà e la vita nella fede e nell'amore, per questo non
sentono l'oppressione del carcere nel quale li ha rinchiusi il salamandro a causa
della loro stoltezza e volgarità. Io invece, disgraziato me, vivrò nell'ignominia e
nella miseria se non mi salva colei che amo immensamente.»
Nella stanza la voce di Serpentina bisbigliò: «Anselmo, credi, ama, spera!» E
ogni parola entrava luminosa nella prigione dello studente sicché il cristallo era
costretto ad allargarsi e a consentirgli di gonfiare il petto. Le sue penose condizioni
andarono migliorando ed egli comprese che Serpentina lo amava ancora ed era lei
a rendergli sopportabile il soggiorno nella bottiglia. Senza occuparsi più degli
spensierati compagni di sventura rivolse tutti i suoi pensieri a Serpentina. Ma a un
tratto udì da un'altra parte un sordo sgradevole mormorio, e notò che proveniva
da un vecchio bricco da caffè col coperchio rotto, posato di fronte a lui sopra un
armadietto. Guardando con maggiore attenzione vide formarvisi gli odiosi
lineamenti di una faccia di vecchia raggrinzita; davanti allo scaffale stava la
venditrice di mele della Porta Nera che ghignando gli rideva in faccia e gridava con
la sua voce stridula: «Ehi, ehi, bimbo, ti è toccata bella. Presto presto nel cristallo
sei cascato senza fallo! Te l'avevo detto!»
«Ciancia pure, maledetta strega,» la ingiuriò lo studente, «tua la colpa di
tutto, ma il salamandro ti colpirà, vile barbabietola!»
E la vecchia: «Oh oh, quanta superbia! Hai pestato la faccia alle mie
figliolette, mi hai scottato il naso, ma ti voglio ancora bene, brutto briccone, perché
di solito eri un bravo ragazzo, e anche la mia figliola ti vuol bene. Dal cristallo però
non esci se non ti aiuto io. Stai troppo in alto, non posso salire, ma il ratto mio
compare che abita sopra di te nella soffitta taglierà coi denti l'asse che ti regge e
allora cadrai quaggiù. Io ti prendo nel grembiule perché tu non abbia a pestarti il
naso, ma possa conservare il visetto liscio, e ti porto di volo dalla signorina
Veronica che devi sposare appena sarai consigliere aulico.»
«Va' via di qua, figlia di Satana,» gridò Anselmo furibondo. «Sono state le
tue arti infernali a istigarmi a commettere il male che ora devo scontare. Ma
sopporto tutto con pazienza perché posso stare soltanto qui dove la dolce
Serpentina mi offre amore e conforto. Sappilo, vecchia, e dispera... Affronto il tuo
potere, amo in eterno soltanto Serpentina, non mi importa di diventare
consigliere, non voglio vedere Veronica che per opera tua mi ha spinto al male! Se
la serpe verde non sarà mia, posso morire di dolore e desiderio. Levati, levati,
mostro schifoso!»
La vecchia fece una risata che echeggiò nella stanza, e borbottò: «Stattene
dunque costì e crepa, ma per me è ora di mettermi all'opera perché qui ho anche
altro da fare.» Si tolse il manto nero presentando la sua nauseante nudità, poi si
mise a correre in circolo facendo cadere grossi volumi dai quali strappava fogli di
pergamena, che ordinava bellamente e cuciva in fretta adattandoli alla sua
persona la quale apparve vestita come di una strana corazza a scaglie. Schizzando
fuoco il gatto nero balzò dal calamaio che era sulla scrivania e urlò verso la vecchia
che con un grido di giubilo scomparve dalla porta insieme col gatto. Anselmo
comprese che andava nella stanza azzurra e poco dopo udì sibilare e frusciare in
lontananza, gli uccelli del giardino stridevano, il pappagallo bofonchiava: «Aiuto,
aiuto! Al ladro, al ladro!» In quell'istante la vecchia ritornò a balzi nella stanza
reggendo sul braccio il vaso d'oro e gridando selvaggiamente: «Buona fortuna,
buona fortuna! Figlio mio, ammazza la serpe verde! Coraggio, coraggio!»
Anselmo credette di udire un gemito profondo, la voce di Serpentina. Preso
dall'orrore e dalla disperazione raccolse tutte le sue forze, urtò contro il cristallo
con tale violenza da far quasi scoppiare le sue vene, ed ecco che un tuono squarciò
l'aria e l'archivista comparve sulla soglia in vestaglia dì damasco: «Ahi, ahi,
marmaglia, stregonerie... a me!... Qua, avanti...» A queste grida i capelli neri della
vecchia si rizzarono come setole, i suoi occhi infocati brillarono di vampe infernali
e stringendo i denti aguzzi la si udì sibilare: «Fischia fischia... Stendi stendi!» e
ridere e belare con sarcasmo, mentre stringendo al petto il vaso d'oro ne cavava
manciate di terra splendente e la lanciava contro l'archivista. Ma non appena la
terra toccava la vestaglia si trasformava in altrettanti fiori che cadevano al suolo.
I gigli della vestaglia si misero a fiammeggiare e l'archivista li prendeva
scoppiettanti e li scagliava contro la strega che urlava dal dolore; e mentre saltava
in alto e scrollava la corazza di pergamena i gigli si spegnevano, cadevano e si
scioglievano in cenere.
«Dalli, dalli, piccolo mio!» incitò la vecchia. Il gatto fece un balzo in aria e
schizzò contro la porta passando sopra all'archivista, ma il pappagallo grigio gli
volò contro e col becco curvo lo agguantò per la nuca facendogli uscire dal collo
uno spruzzo di sangue rosso e rovente.
In quella si udì la voce di Serpentina: «È salvo, è salvo!» La vecchia si lanciò
furiosa e disperata contro l'archivista, buttò il vaso dietro di sé e divaricando le
lunghe dita legnose fece per artigliare Lindhorst, ma questi si tolse subito la
vestaglia e la scagliò addosso alla vecchia. Dai fogli di pergamena uscirono allora
sibilando e crepitando fiamme azzurre, la vecchia si torse urlando dal dolore e
tentò ancora di togliere manciate di terra dal vaso, di strappare pergamene dai
libri, per soffocare le fiamme, poiché quando riusciva a buttarsi addosso terra o
pergamene il fuoco si spegneva. Ma dal petto dell'archivista scaturirono raggi
sfiaccolanti contro a lei. «Addosso, addosso! La vittoria al salamandro!» rimbombò
la voce dell'archivista mentre cento lampi serpeggiavano intorno alla vecchia
urlante. Il gatto e il pappagallo correvano intorno in aspra battaglia sollevando un
immenso fragore, ma infine il pappagallo abbatté il gatto con le ali robuste e,
tenendolo stretto tra gli artigli mentre quello nel terrore mortale mandava urli
spaventosi, gli cavò col becco tagliente gli occhi infocati.
Dal punto dove la vecchia era stramazzata al suolo coperta dalla vestaglia si
levò un gran fumo, mentre i suoi urli, le sue orrende grida di dolore si spegnevano
in lontananza. Il fumo che si era sparso intorno con un puzzo penetrante si
dileguò, l'archivista sollevò la vestaglia e vi trovò una schifosa barbabietola.
«Stimatissimo signor archivista, ecco qua il nemico sconfitto,» disse il
pappagallo porgendogli col becco un capello nero.
«Benissimo, mio caro,» rispose l'archivista. «Qui c'è anche la mia nemica
sconfitta. Faccia il favore di provvedere al resto. Oggi stesso riceverà una piccola
leccornia, sei noci di cocco, e un nuovo paio di occhiali, perché vedo che il gatto le
ha rotto le lenti.»
«Sempre suo, stimatissimo amico e protettore,» disse il pappagallo
soddisfatto e, presa col becco la barbabietola, volò dalla finestra che Lindhorst gli
aveva aperto.
Questi afferrò il vaso d'oro e chiamò: «Serpentina, Serpentina!»
Ma appena Anselmo, molto lieto della scomparsa di quella vecchia che
l'aveva portato alla rovina, vide l'archivista, questo era di nuovo il maestoso
principe degli spiriti che lo stava a guardare con grande dignità e bellezza.
«Anselmo,» gli disse, «non tu, ma un principio nemico che tentava di penetrare nel
tuo intimo e di metterti in discordia con esso, era colpevole del tuo scetticismo. Tu
invece sei rimasto fedele. Sii dunque libero e felice.»
Anselmo fu scosso da una folgore, lo stupendo accordo delle campane di
cristallo risonò più forte di quanto non l'avesse mai udito, i suoi nervi tremarono,
ma mentre l'accordo inondava la stanza, il cristallo che racchiudeva lo studente
s'infranse ed egli cadde tra le braccia della soave dolce Serpentina.
UNDICESIMA VEGLIA
Il cattivo umore del vicepreside per la pazzia nella sua famiglia. - Come l'attuario
Heerbrand divenne consigliere aulico e nel rigore del gelo andò in giro con le calze
di seta. - Confessioni di Veronica. - Fidanzamento davanti alla minestra fumante.
«Mi dica, carissimo attuario, come è andata che ieri quel maledetto ponce ci
ha dato alla testa e ci ha fatto fare ogni sorta di buffonate?» Così parlò il
vicepreside Paulmann entrando la mattina seguente nella stanza ancora piena di
cocci, dove la disgraziata parrucca in pieno disfacimento nuotava ancora nel
ponce, Quando Anselmo era uscito di corsa, Paulmann e Heerbrand stavano
ancora vagando e barcollando per la stanza, gridavano come ossessi e si urtavano
picchiando la testa l'uno contro l'altro finché Franceschina con molta fatica portò a
letto il brillo genitore, e l'attuario cadde spossato sul divano che Veronica aveva
abbandonato scappando in camera sua. L'attuario si era fasciato la testa col
fazzoletto turchino e pallidissimo e malinconico gemette: «Oh, caro preside, non è
stato il ponce che la signorina Veronica aveva preparato in modo squisito, ma la
colpa della gazzarra è tutta di quel dannato studente. Non ha notato che da un
pezzo è mentecatto? E non sa che la pazzia è contagiosa? Un matto ne fa molti,
perdoni se cito questo vecchio proverbio; specialmente poi quando si è bevuto un
bicchiere è facile dare i numeri, senza volere si scimmiottano gli altri e si fanno gli
esercizi che ci mostra il capofila. Vuol credere che quando penso al pappagallo
grigio mi vengono ancora le vertigini?»
«Oh, via,» lo interruppe Paulmann, «quante storie! Quello era il vecchio
famulo dell'archivista con un mantello grigio sulle spalle venuto a cercare
Anselmo.»
«Può darsi,» ribatté l'attuario, «ma devo confessare che sto molto male:
tutta la notte non ho sentito che fischi e musiche d'organo.»
«Ero io,» spiegò il vicepreside. «Russo molto forte.»
«Sia pure,» continuò l'altro, «ma, preside mio, non senza motivo avevo
provveduto ieri a un po' di allegria se non fosse stato quell'Anselmo a sciupare ogni
cosa. Lei non sa... preside, preside!» Heerbrand gli strappò il fazzoletto dalla testa,
abbracciò Paulmann, gli strinse la mano con forza, esclamò ancora una volta in
tono commovente: «Preside, preside!» e preso il cappello e il bastone scappò via.
«Non voglio che Anselmo oltrepassi mai più la mia soglia,» disse Paulmann
tra sé, «vedo infatti che con la sua ostinata follia fa perdere un po' la ragione anche
ai migliori. Ormai anche l'attuario è spacciato... Finora mi sono salvato, ma il
diavolo che è venuto ieri a bussare durante la sbornia potrebbe ritornare e
combinare i suoi malanni. Perciò apage Satanas! Via di qua Anselmo!»
Veronica si era fatta pensosa, taceva, sorrideva soltanto stranamente e
desiderava star sola. «Anselmo ha anche lei sulla coscienza,» disse il vicepreside
con cattiveria, «ma meno male che non si fa vedere, so benissimo che ha paura di
me. Perciò non viene più.»
Paulmann disse queste ultime parole ad alta voce. Veronica era presente e si
mise a piangere e a sospirare: «Come fa a venire Anselmo? Da parecchio tempo è
prigioniero nella bottiglia.»
«Come?» esclamò il vicepreside. «Dio mio, Dio mio, anche lei straparla come
l'attuario. La vedo già ammattita. Oh maledetto, odioso Anselmo!»
Corse dal dottor Eckstein che sorridendo ripeté: «Ahi, ahi.» Non prescrisse
nulla ma soggiunse a quel poco che aveva detto: «Attacchi nervosi... passerà,
passerà... portare all'aria... passeggiate... distrazioni... opere buffe a teatro...
passerà.»
«Rare volte è stato così eloquente il dottore,» pensò Paulmann, «persino
loquace.»
Erano passati parecchi giorni e settimane e mesi da quando Anselmo era
scomparso. Anche l'attuario non si faceva vedere. Finché il quattro febbraio arrivò
con un nuovo abito moderno, del panno migliore, in scarpette e calze di seta
nonostante il gelo, recando un gran mazzo di fiori recisi, a mezzogiorno in punto,
nella stanza del vicepreside che rimase non poco meravigliato vedendolo così
azzimato. Heerbrand gli andò incontro, lo abbracciò con garbo e parlò: «Oggi,
onomastico della sua cara e stimatissima signorina figlia Veronica, voglio dire tutto
ciò che da molto tempo ho nel cuore. Allora, quella brutta sera in cui portai nelle
tasche del soprabito gli ingredienti di quel ponce sciagurato, avevo intenzione di
comunicarle una bella notizia e di festeggiare in allegria quella giornata felice,
perché già allora avevo saputo che mi avevano nominato consigliere aulico, e di
questo riconoscimento ho ricevuto adesso il decreto cum nomine et sigillo principis
e lo tengo in tasca.»
«Oh, signor at..., signor consigliere Heerbrand!» balbettò il vicepreside.
«Ma soltanto lei, egregio preside,» proseguì l'ormai consigliere, «soltanto lei
può completare la mia felicità. Da un pezzo amo in silenzio la signorina Veronica e
posso vantarmi di aver ricevuto da lei qualche occhiata amichevole che mi ha fatto
capire come non dovrei proprio esserle indifferente. Per farla breve, egregio
preside, io consigliere aulico Heerbrand chiedo la mano della sua gentile signorina
figlia che, se lei non ha niente in contrario, desidero sposare al più presto.»
Paulmann giunse le mani con grande stupore ed esclamò: «Oh, oh, signor
at..., signor consigliere aulico, chi l'avrebbe mai pensato? Be', se Veronica è
veramente innamorata di lei, io per parte mia non ho niente in contrario. Può
anche darsi che la sua attuale malinconia sia soltanto il celato amore per lei, signor
consigliere. Si sa bene come vanno queste cose.»
In quel momento entrò Veronica pallida e stravolta come era sempre in quel
periodo. Il consigliere le andò incontro, menzionò con un bel discorsetto il suo
compleanno e le porse il mazzo olezzante insieme con un pacchettino dal quale,
quando lei lo aprì, uscì lo scintillio di un paio di orecchini. Le guance di lei si tinsero
di un lieve rossore, gli occhi le brillarono con maggiore vivezza, infine disse: «Dio
mio, sono gli stessi orecchini che portai parecchie settimane fa con mia grande
gioia!»
«Possibile?» obiettò il consigliere un po' spaventato e anche urtato. «Se ho
acquistato questa gioiello un'ora fa nella via del Castello per vile denaro!»
Veronica non gli dava retta, era già davanti allo specchio a studiare l'effetto
del gioiello che aveva già appeso alle orecchie.
Paulmann le comunicò in tono grave e solenne il riconoscimento che aveva
avuto l'amico Heerbrand e la sua richiesta.
Veronica lanciò al consigliere un'occhiata penetrante e aggiunse: «Sapevo, e
non da oggi, che lei mi voleva sposare. Ebbene sia! Le prometto la mia mano e il
cuore, ma nello stesso tempo devo dirle, anzi devo dirvi, al babbo e allo sposo,
cose che mi pesano sul cuore... Subito subito, anche se si fredda la minestra che,
a quanto vedo, Franceschina ha scodellato.» E senza attendere la risposta del
padre e del consigliere che apparivano pronti a parlare continuò: «Caro babbo, mi
potete credere che ho amato profondamente Anselmo, e quando l'attuario
Heerbrand, ora consigliere aulico, mi assicurò che Anselmo poteva diventare
qualcuno decisi che lui e nessun altro sarebbe stato mio marito. Si vide però che
non so quali nemici me lo volevano strappare e allora mi rifugiai dalla vecchia
Luisa, che a suo tempo era la mia governante e adesso è una donna saggia, una
grande maga. Lei promise di aiutarmi e di consegnare Anselmo nelle mie mani. Il
giorno dell'equinozio andammo verso mezzanotte al crocicchio dove lei evocò gli
spiriti infernali e con l'aiuto del gatto nero riuscimmo a fondere uno specchietto di
metallo nel quale, concentrando il mio pensiero su Anselmo, bastava che io
guardassi per dominarlo. Ora però sono pentita di quello che ho fatto e abiuro tutti
i malefizi di Satana. Il salamandro ha sconfitto la vecchia, io ne udii le grida e i
lamenti, ma non c'era modo di soccorrerla; appena il pappagallo ebbe mangiato la
barbabietola, il mio specchietto si infranse con grande fragore.» Veronica andò a
prendere dal cestello di lavoro i pezzi dello specchio rotto e una ciocca di capelli e
porgendo tutto al consigliere soggiunse: «Ecco, prenda, mio diletto consigliere, i
pezzi dello specchio, li butti questa notte alle dodici dal ponte dell'Elba, dove c'è la
croce, giù nel fiume che in quel punto non è gelato. Conservi invece la ciocca sul
suo cuore. Ancora una volta abiuro a tutte le sataniche macchinazioni e auguro
cordialmente ogni bene ad Anselmo poiché è ormai legato alla serpe verde che è
molto più bella e più ricca di me. Per lei, caro consigliere, sarò sempre una brava
moglie innamorata e devota.»
«Dio buono,» esclamò il vicepreside addoloratissimo, «è pazza, è
ammattita... non può essere la moglie di un consigliere aulico... è matta, è matta!»
«Niente affatto,» lo interruppe Heerbrand. «So che la signorina Veronica ha
avuto qualche simpatia per quello strambo di Anselmo, può darsi che in un
momento di esaltazione si sia rivolta alla saggia vecchia che, se ho ben capito, non
può essere che la cartomante della Porta del Lago, cioè la vecchia Rauer. Ora non
si può negare che esistono veramente arti magiche le quali esercitano influssi
sull'uomo, sono cose che si leggono già negli antichi, ma ciò che ci ha detto la
signorina Veronica circa la vittoria del salamandro e l'unione di Anselmo con la
serpe verde è, secondo me, soltanto un'allegoria poetica... direi una poesia, con
cui ci ha cantato il totale distacco dallo studente.»
«La prenda come vuole, caro consigliere,» intervenne Veronica, «magari per
un sogno alquanto sciocco.»
«Non lo farò,» ribatté il consigliere, «perché so che anche Anselmo è nelle
mani di poteri misteriosi che si burlano di lui e lo spingono a commettere pazzie.»
Paulmann non poté più tenersi e sbottò a dire: «Basta, per carità, basta...
Abbiamo forse ecceduto di nuovo con quel dannato ponce o sentiamo l'influenza
della pazzia di Anselmo? Consigliere, che diavolerie mi va dicendo? Io invece credo
che nella vostra testa si agiti l'amore, ma il matrimonio è una rapida cura,
altrimenti starei in pensiero che anche lei, egregio consigliere, ne abbia preso un
ramo, e non vorrei che i discendenti abbiano a ereditare questo malanno. Do
quindi la mia paterna benedizione alla lieta unione permettendovi di scambiarvi il
bacio del fidanzamento.»
Ciò avvenne subito, prima ancora che la minestra scodellata fosse fredda.
Dopo qualche settimana la moglie del consigliere aulico Heerbrand se ne
stava realmente, come aveva preveduto a suo tempo, sul balcone di una bella casa
nel Mercato nuovo e guardava sorridendo gli elegantoni che passando per la
strada e guardando in su con l'occhialino dicevano: «È una donna meravigliosa, la
moglie del consigliere.»
DODICESIMA VEGLIA
Notizie della tenuta che Anselmo, genero dell'archivista Lindhorst, ha occupato, e
come vive laggiù con Serpentina. Conclusione.
Come ho sentito in fondo al cuore la grande beatitudine dello studente
Anselmo il quale, intimamente legato alla soave Serpentina, si era recato nel
misterioso e meraviglioso regno che ora considerava suo dopo aver tanto
sospirato con singolari presentimenti! Ma vani furono tutti gli sforzi per farti
intendere, benevolo lettore, sia pure con parole approssimative, la magnificenza
che lo circondava. Con disgusto dovetti notare la fiacchezza di ogni frase. Mi
sentivo prigioniero delle miserie della vita quotidiana e meschina, mi ammalavo di
disagio e tormento, andavo in giro come un sognatore, mi trovavo insomma nelle
condizioni dello studente che ti ho descritte nella quarta veglia. Scorrendo le undici
veglie felicemente composte rimasi molto afflitto e pensai che non mi sarebbe mai
concesso di aggiungere come chiave di volta la dodicesima, poiché ogni qualvolta
di notte mi accingevo all'opera era come se perfidi spiriti (già forse erano parenti,
forse cugini della strega ammazzata) mi presentassero un metallo lustro nel quale
scorgevo il mio io, pallido per le notti vegliate e malinconico come l'attuario
Heerbrand dopo la sbornia di ponce. Allora buttavo via la penna e correvo a letto
per sognare almeno il felice Anselmo e la cara Serpentina.
Questa faccenda durava ormai da parecchi giorni e parecchie notti finché
inaspettatamente vidi arrivare un biglietto dell'archivista Lindhorst che scriveva
quanto segue:
«La Signoria Vostra, a quanto ho capito, ha descritto in undici veglie le
strane vicende del mio ottimo genero Anselmo, già studente e poi poeta, che si sta
torturando per dire qualcosa, nella dodicesima e ultima veglia, della sua vita felice
nell'Atlantide, dove si è ritirato con mia figlia in una bella tenuta che possiedo
laggiù. Benché non veda proprio di buon occhio la Sua fatica di aver rivelato al
pubblico dei lettori la mia vera natura, perché nelle mie odierne condizioni di
archivista potrei incontrare un mucchio di dispiaceri, anzi provocare tra i colleghi la
discussione del problema come mai un salamandro possa legalmente e con
conseguenze impegnative impegnarsi con giuramento a servire lo stato, e come
mai gli si possano affidare affari importanti dato che secondo Gabalis e
Swedenborg non c'è affatto da fidarsi degli spiriti elementari - benché ora i miei
migliori amici eviteranno di abbracciarmi per timore che in un improvviso impeto di
spavalderia mi metta un po' a lampeggiare rovinando loro la pettinatura e la
marsina delle feste - nonostante tutto questo, dico, sono disposto ad aiutare la
Signoria Vostra nel compimento dell'opera nella quale si dice alquanto bene di me
e della mia cara figlia maritata (così potessi aver accasato anche le altre due!).
Perciò, se vuol scrivere la dodicesima veglia, scenda quelle sue dannate cinque
scale, lasci la sua cameretta e venga da me. Nella azzurra stanza delle palme che
Lei già conosce, troverà l'occorrente per scrivere e con poche parole potrà
spiegare ai Suoi lettori le cose viste. Per Lei sarà meglio che descrivere in lungo e
in largo una vita a Lei nota soltanto per sentito dire. Con molta stima della S.V.
dev.mo
Salamandro Lindhorst
Regio archivista
Questo biglietto un po' rude, se vogliamo, ma amichevole, mi giunse
graditissimo. Era certo, sì, che il vecchio stravagante doveva essere ben informato
dello strano modo in cui avevo appreso le vicende di suo genero delle quali, legato
al segreto, dovetti fare mistero anche con te, mio lettore, ma non vi aveva dato
tanto peso quanto potevo temere. Tanto è vero che egli stesso si offriva di
compiere l'opera mia e da ciò potei dedurre che in fondo era d'accordo che si
diffondessero per le stampe le notizie della sua strana esistenza nel mondo degli
spiriti. «Può darsi,» pensai, «che egli stesso ne tragga la speranza di maritare
tanto più presto le due figlie rimaste, poiché una scintilla potrebbe cadere nel petto
di qualche giovane e suscitarvi la nostalgia della serpe verde spingendolo poi a
cercarla e trovarla il giorno dell'Ascensione tra i rami del sambuco. Dalla disgrazia
capitata ad Anselmo cacciato nella bottiglia il giovane trarrà il monito a guardarsi
seriamente dai dubbi e da qualunque scetticismo.»
Dunque alle undici in punto spensi il lume e scesi dall'archivista Lindhorst che
già mi aspettava sul pianerottolo. «Bene arrivato... i miei ossequi, ben lieto che
riconosca le mie buone intenzioni... venga, venga!» E attraverso il giardino
inondato di una luce abbagliante mi accompagnò nella stanza azzurra dove vidi la
scrivania viola, il posto di lavoro di Anselmo.
L'archivista scomparve, ma ritornò poco dopo con in mano una coppa d'oro
dalla quale si levava scoppiettando una fiamma azzurra. «Ecco,» mi spiegò, «le
porto la bevanda preferita del suo amico Giovanni Kreisler, il direttore d'orchestra.
È rum acceso nel quale ho versato un po' di zucchero. Ne assaggi un po', io mi
leverò subito la vestaglia e, per godermi la sua preziosa compagnia, mentre lei sta
scrivendo e guardando, andrò su e giù nella coppa.»
«Come crede, egregio archivista,» soggiunsi, «ma se devo assaggiare
questa bevanda, lei non... ?»
«Stia tranquillo, mio caro,» disse l'archivista, si tolse rapidamente la
vestaglia e con mio grande stupore montò nella coppa e scomparve nella fiamma.
Senza timore, scostando un po' la fiamma col fiato, assaggiai la bevanda: era
deliziosa.
Non si muovono forse con dolce fruscio le foglie smeraldine delle palme
accarezzate dal soffio del vento mattutino? Destate dal sonno si sollevano, si
muovono, sussurrano misteriosamente i miracoli che dolcissime note d'arpa
annunciano da lontano. L'azzurro si stacca dalle pareti e sale e scende come una
vaga nebbia, mentre raggi abbacinanti attraversano i vapori che turbinano nell'aria
con giubilo infantile e salgono all'altezza incommensurabile che si inarca sopra le
palme. Ma i raggi si moltiplicano sempre più abbaglianti, finché al vivo splendore
del sole si apre un bosco sterminato nel quale scorgo Anselmo. Giacinti e tulipani
e rose fiammanti sollevano il capo, e il loro profumo parla con suono gradevole al
fortunato: «Cammina, diletto, cammina tra noi, tu che ci comprendi... il nostro
profumo è desiderio d'amore, noi ti amiamo e siamo tuoi per sempre! I raggi d'oro
ardono con suono incandescente: noi siamo fuoco acceso dall'amore... nostalgia è
il profumo, ma fuoco il desiderio: e non siamo forse nel tuo cuore? Noi siamo tuoi.»
Si sente un fruscio nei cespugli ombrosi, negli alberi maestosi: «Vieni da noi,
diletto! Fuoco è il desiderio, ma speranza la nostra fresca ombra. Noi alitiamo
amorevolmente intorno al tuo capo perché ci comprendi, perché nel tuo petto
alberga l'amore.»
Le fonti e i ruscelli gorgogliano e mormorano: «Non passar via così rapido,
diletto, guarda nel nostro cristallo: la tua immagine è in noi che ti conserviamo
amorevolmente perché tu ci hai compreso.»
Uccelli di tutti i colori cinguettano e cantano un coro di giubilo: «Ascolta noi,
ascolta noi che siamo la gioia, la voluttà, l'estasi dell'amore!»
Anselmo però guarda ansioso il tempio stupendo che si innalza lontano. Le
belle colonne sembrano alberi e i capitelli e le cimase foglie d'acanto che con
meravigliosi intrecci formano bellissimi ornamenti. Anselmo si avvia verso il tempio
e osserva con intima gioia il marmo colorato, i gradini muscosi. «No, no,» esclama
in un eccesso di gaudio, «non è più lontana.» Ed ecco uscire dal tempio Serpentina
bella e graziosa recando il vaso d'oro dal quale è sbocciata una splendida
amarillide. I suoi occhi soavi ardono per l'indicibile gioia d'un desiderio senza fine,
e così guarda Anselmo e dice: «Mio diletto, l'amarillide ha aperto il calice... il bene
supremo si adempie. Può darsi una felicità pari alla nostra?»
Anselmo la abbraccia col fervore del desiderio più ardente: l'amarillide irradia
fiamme sopra il suo capo. Alberi ed arbusti stormiscono più forte, le sorgenti
esultano più limpide e gioiose, uccelli e insetti di ogni colore danzano nei vortici
dell'aria in un tumulto gaio e lieto, nelle acque e sulla terra si celebra la festa
dell'amore. Folgori luminose guizzano tra i cespugli, diamanti mandano dalla terra
occhiate scintillanti, alti zampilli salgono dalle fonti, strani profumi arrivano con un
sonoro battito d'ali: sono gli spiriti elementari che rendono omaggio all'amarillide e
proclamano la felicità di Anselmo.
Questi alza la fronte cinta dall'aureola della trasfigurazione. Sono sguardi?
Sono parole? È un canto? Sono suoni comprensibili: «Serpentina, la fede in te e
l'amore mi hanno dischiuso le viscere della natura! Tu mi hai recato l'amarillide
germogliata dall'oro, dalla forza primigenia della terra, prima ancora che Fosforo
accendesse il pensiero... Essa è la conoscenza della sacra armonia di tutti gli esseri
e in questa conoscenza vivo per sempre nella suprema beatitudine. Sì, io nella mia
felicità ho conosciuto la vetta suprema... devo amarti in eterno, Serpentina! I raggi
d'oro dell'amarillide non si spegneranno mai perché, come fede e amore, eterna è
la conoscenza.»
La visione in cui vidi Anselmo in carne e ossa nel suo podere dell'Atlantide la
dovetti probabilmente alle arti del salamandro, e fu una bella cosa, quando tutto
svanì come nella nebbia, trovarmela scritta da me stesso in bei caratteri sulla carta
stesa sopra la scrivania viola.
Ora però mi sentii trafitto e straziato da un acuto dolore. «Oh, felice Anselmo
che hai gettato il peso della vita quotidiana, che nell'amore per la soave Serpentina
hai agitato con forza le penne e ora vivi di gioia e voluttà nel tuo podere
dell'Atlantide! Io invece, povero me, presto, anzi tra pochi minuti sarò fuori di
questa bella sala che non è neanche lontanamente una tenuta dell'Atlantide,
trasferito nella mia soffitta, circondato dalle miserie della povera vita, lo sguardo
velato da cento malanni come da una nebbia talmente fitta che forse non vedrò
mai l'amarillide.»
In quella l'archivista Lindhorst mi batté leggermente una spalla e disse:
«Zitto, zitto, mio caro, non si lamenti cosi! Non è stato un momento fa
nell'Atlantide, e non ricorda di aver visto là almeno una graziosa fattoria che è la
sua proprietà poetica? In genere, la felicità di Anselmo è forse qualcosa di diverso
dalla vita nella poesia, cui la sacra armonia di tutti gli esseri si manifesta come il più
profondo mistero della natura?»
SINGOLARI PENE D'UN DIRETTORE DI TEATRO
PREMESSA
Una dozzina di anni fa il curatore di queste pagine si trovò quasi nelle stesse
condizioni del signor Grünhelm, il noto spettatore nel Mondo a rovescio di Tieck. Il
truce destino di quel tempo, denso di avvenimenti, lo sbalzò violentemente dalla
platea dove aveva trovato il suo posto comodo e tranquillo, e lo costrinse a
rischiare un salto che giunse, non dirò fin sul palcoscenico, bensì fino all'orchestra,
fino al posto del direttore.
Da quel posto poté osservare proprio da vicino lo strano lavorio del curioso
piccolo mondo che si agita e muove dietro quinte e sipario, e quelle osservazioni,
ma soprattutto gli sfoghi di un valentissimo direttore di teatro, che aveva
conosciuto nella Germania meridionale, gli offrirono la materia del dialogo fra due
direttori di teatro, che annotò già allora, quando non era ancora ribalzato in platea,
come infatti fece in seguito.
Una parte di quella conversazione, che ora si pubblica qui per intero, uscì
prima nella locale «Gazzetta teatrale», beatamente defunta qualche tempo fa.
Ora, benevolo lettore, il suddetto curatore ti prega vivamente di non cercare, per
carità, in questo dialogo discussioni profonde, magari erudite, sulla
rappresentazione teatrale, ma di accogliere amichevolmente, senza pretendere di
più, le frettolose osservazioni e allusioni al teatro in genere, come capita di fame
nel discorso, e sia pure anche qualche troppo spinta facezia che vi si possa essere
furtivamente insinuata.
Fatica vana sarebbe la tua, caro lettore, se tu volessi darti da fare per
rintracciare nelle tue prossime vicinanze gli originali dei ritratti che appartengono
a un'epoca tramontata da un pezzo. Con siffatti sforzi il carattere innocuo, sul
quale vogliamo contare soprattutto, se ne andrebbe a rotoloni.
E.T.A. Hoffmann
Berlino, ottobre 1818
SINGOLARI PENE D'UN DIRETTORE DI TEATRO
Il giorno di San Dionigi, cioè il 9 ottobre, alle 11 del mattino, la «Corona di
ruta», la celebre locanda della ancor più celebre città libera di R., sembrava un
mortorio. Infatti, un unico forestiero, un uomo in età, non troppo alto, avvolto in
un soprabito di finissimo panno marrone, faceva colazione solo soletto in un
angolo della piccola sala. La sua faccia aveva un'espressione di calma interiore e di
soddisfazione, e tutto il suo comportamento era placido, ogni suo gesto rivelava
che si sentiva a suo agio. Si era fatto servire del vecchio vino francese e aveva
cavato di tasca un manoscritto che si mise a leggere con molta attenzione
segnandovi ogni tanto qualcosa con una matita rossa. E intanto prendeva sorsetti
di vino e mangiava qualche biscotto. Ora atteggiava le labbra a un sorrisetto
ironico, ora aggrottava le sopracciglia, serio e grave; ora alzava lo sguardo come
seguendo un suo pensiero, ora crollava la testa o annuiva come ripudiando o
approvando quel pensiero. Chi non l'avrebbe preso per uno scrittore, capitato
forse a R. per far pubblicare qualche prodotto del suo ingegno?
La quiete che regnava nella sala fu turbata in maniera singolare.
Spalancatasi la porta entrò di corsa un tale, in abito grigio moderno, il cappello in
testa, gli occhiali sul naso. «Sciampagna! una dozzina di ostriche!» gridò
buttandosi su una sedia, senza notare l'uomo vestito di bruno. Lesse un biglietto
che teneva in mano, lo lacerò e ne pestò i pezzi coi piedi. Poi sfogò il suo furore con
una risata, si diede un pugno sulla fronte e borbottò: «Ammattire, ammattire mi
fanno! La vita dei galeotti è una delizia in confronto della mia miseria!»
Il cameriere aveva portato lo sciampagna, l'uomo in grigio ingollò un paio di
bicchieri, cavò un pacco di lettere, le aprì e, mentre leggeva, tirava moccoli e
maledizioni. Quella scena non poteva non suscitare la più viva pietà, la più
profonda simpatia. Doveva aver passato da poco l'estrema giovinezza, e quel viso
pallido, macilento, lo sguardo stravolto, qualche capello bianco nei riccioli scuri lo
facevano evidentemente sembrare più vecchio di quanto non fosse a giudicare dal
portamento e dai gesti. Probabilmente mirava a stordirsi e a dimenticare, almeno
in quel momento, la sua sventura o il fatto terribile che minacciava di schiacciarlo,
perché aveva già vuotato la bottiglia e, quando il cameriere gli portò le ostriche,
gliene ordinò un'altra! «Sì, sì, è finita!» mormorò tra i denti. «Proprio finita. Quale
mortale può avere tanta forza, tanta calma da resistere?»
Cominciò a mangiare le ostriche, ma aveva appena inghiottito la seconda,
accompagnandola con un bicchiere di sciampagna, allorché incrociando le braccia
si abbandonò sulla spalliera, alzò lo sguardo allucinato e disse con la più profonda
tristezza: «Abbandonerò tutto... tutto... anche me stesso. Al sole eterno gli atomi
qui rendo che in me si sono uniti in gioia e pena... Oh, eppure è dolce, dolce
sognare... Se non ci fosse questo sogno... Quest'è il riguardo che consente al
misero d'avanzare negli anni!» Aveva quasi le lacrime agli occhi, ma si fece
coraggio e sorbì le ostriche alternandole col vino.
A un tratto si riscosse, si batté la fronte con uno schiocco e sghignazzando
esclamò: «Per Ecuba?... Che cosa è Ecuba per lui?... Pur io, ottuso briccone
temprato di fango, mi struggo, come Gianni che sogna, non compreso della mia
causa, e non so dir nulla, no, nemmeno per un poeta, sulla cui proprietà e molto
cara vita un dannato misfatto fu compiuto. Son io un vile? chi mi chiama furfante?
mi spezza il capo? mi strappa la barba, e me la butta in faccia? mi tira per il naso?
mi dà la mentita per la gola, fin giù ai polmoni? chi mi fa questo?»
«Io,» esclamò il Bruno che non aveva distolto lo sguardo e l'udito dal Grigio,
e infine alzatosi gli si era avvicinato. «Io non intendo certo fare tutto quello che Lei
dice, ma mi scusi, signore, se non posso assistere indifferente e vedere come Lei
si vada abbandonando a un umore sempre più spiacevole. Penso che conforto e
aiuto non siano impossibili. Non mi consideri un estraneo, mi prenda per uno che
è il più sincero, il più attivo amico di chiunque si trovi in conflitto con la sorte o con
se stesso.»
Il Grigio si alzò allibito, si levò di scatto il cappello, ma si riprese subito e disse
con un lieve sorriso: «Signor mio, devo proprio vergognarmi. Raramente questa
sala è frequentata al mattino, e io credevo di essere solo... distratto com'ero, anzi
fuori di me, non mi sono accorto di Lei, e così Lei è stato testimone di uno sfogo di
stizza e dispetto che di solito tengo per me e cerco di reprimere.»
«E codesto dispetto, la Sua traboccante disperazione?», lo interruppe il
Bruno.
«È la conseguenza,» continuò il Grigio, «di certe scene ormai
necessariamente intrecciate con la mia vita, ma non arrivate ancora mai allo
sconforto. Lo so, mi sono comportato in modo che a Lei, signore, deve sembrare
sciocco e stravagante. Devo rimediare: faccia colazione con me!... Cameriere!»
«No, no, lasci stare,» rifiutò il Bruno rimandando il cameriere che era
comparso sulla soglia. «No, perbacco,» soggiunse, «non voglio fare colazione con
Lei, voglio sapere la causa del Suo cordoglio, della Sua disperazione, afferrare il
nemico per il petto e buttarlo a terra, come si conviene a chi è in gamba, e...»
«Ahi,» lo interruppe il Grigio, «mio caro signore, abbattere il nemico che mi
perseguita, anzi talvolta mi fruga diabolicamente nelle viscere, no, non è semplice.
Le teste gli ricrescono come all'idra invincibile, ha cento braccia come il gigante
Gerione, e le agita in modo spaventoso.»
«Lei vuole sfuggire,» disse il Bruno, «ma non mi scappa, troppo mi ha
sconvolto il dolore che parla chiaro dal Suo viso pallido e afflitto. Quelle Sue
lettere... Certo ciascuna conteneva una speranza mancata. Se non m'inganno, Lei
è avversato anche da quella sorte nemica che fa dipendere la nostra esistenza dal
denaro, dagli averi. In questo momento è forse sotto la minaccia d'un creditore
duro e avaro. Io sono in condizioni di poterLa aiutare, sempre che la somma non
sia troppo elevata; e La aiuterò. Certo, La aiuterò. Qua la mano!» Il Grigio afferrò
la mano che gli era porta e se la strinse al petto guardando il Bruno negli occhi,
serio e cupo.
«Vero che ho indovinato? Dica dunque, chi?... quanto?... dove?» esclamò il
Bruno tutto contento, ma il Grigio che ancora stringeva quella mano obiettò: «No,
signor mio, no. Le mie condizioni non sono tali che io possa considerarmi
benestante, ma debiti non ne ho, parola d'onore! Difficoltà finanziarie non sono e
non possono essere la causa della mia afflizione. Ma la Sua offerta mi ha
enormemente sorpreso e profondamente commosso. Questa simpatia per la sorte
di uno sconosciuto rivela una sensibilità che va sempre più scomparendo nel cuore
arido e angusto dei nostri fratelli.»
«Lasci andare,» lo interruppe il Bruno impaziente. «E mi dica piuttosto,
carissimo signore, subito subito, di che malanno si tratta e come potrei essere
utile. È stato abbandonato dalla moglie, dall'amante infedele?... Qualche mala
lingua ha attentato al Suo onore? Oppure... già, è un poeta, e la razza dei critici Le
ha sputato addosso il suo veleno?»
«Ma no, no,» rispose il Grigio.
«Allora, che diavolo... vorrei proprio sapere...» cominciò il Bruno
sconcertato, ma il Grigio gli prese ambedue le mani e dopo una breve pausa
dichiarò con grande solennità: «Sappia dunque la disgraziata origine di infiniti
tormenti, di inenarrabili fastidi e dispetti che avvelenano la vita in mezzo a lavori e
a fatiche che sorpassano le forze umane: io sono il direttore del locale teatro di
prosa!»
Il Bruno guardò il Grigio con un sorriso ironico come se aspettasse un
commento più eloquente. «Ah, signore,» riprese il Grigio, «vedo che il mio
lamento Le sembra quello di un paranoico, Lei non conosce queste sofferenze, non
può capire la mia disperazione. Non c'è forse per un direttore di teatro anche il
demone malvagio che, felice dell'altrui danno, abbaglia i non iniziati in modo che
non possano penetrare con lo sguardo nella vita intima del povero direttore
torturato in mille modi e nei tenebrosi misteri del mondo teatrale?... Soltanto un
collega può capire il direttore... e deriderlo, come fanno appunto gli uomini per
loro natura. Ma Lei, signore, che non conosce queste miserie, Lei non deve ridere.
Ride delle cicatrici chi non è mai stato ferito.»
«In verità,» lo interruppe il Bruno, «Lei mi fa torto. Sono ben lontano dal
ridere perché forse non capisco come i soli rapporti tra Lei e un teatro possano
portare a quella disperazione che Lei ha espressa così vivacemente. Sappia che io
posso ben condividere i Suoi sentimenti perché fui parecchi anni capocomico di
una compagnia viaggiante e in un certo senso lo sono ancora. Se dianzi non ho
saputo trattenere un sorrisetto involontario, fu perché senza di esso non so
riguardare il quadro vario, grottesco, affollato da ogni sorta di ceffi e grinte, del
mio passato teatrale che, come evocato da una bacchetta magica, mi si e
presentato alla vista quando Lei disse: Sono il direttore del teatro locale! Mi creda,
partecipo con tutto il cuore alle Sue vicende. E dia sfogo al Suo dolore, ciò
alleggerisce la pena, e io La posso aiutare.»
Con l'espressione della più fervida bonomia il Bruno aveva preso la mano del
Grigio, il quale però la ritirò indignato e con la faccia scura sbottò: «Come, signore?
Lei è il capocomico di una compagnia viaggiante? Ha intenzione di recitare qui?
Non sa che io ho il privilegio e l'esclusiva? Vuol venire a patti con me? Per questo
la gentilezza, la simpatia! Adesso capisco. Lei mi conosceva già quando sono
entrato. Le dichiaro, mi permetta, che cotesta maniera di prendere confidenza non
può che dispiacermi, e Le dico che non riuscirà in alcun modo a rizzare qui neanche
una quinta contro la mia volontà. Oltre a ciò la Sua compagnia si esporrebbe al
pericolo di essere fischiata sonoramente perché il mio teatro, che accoglie i più
eccellenti artisti, è, posso dire, il primo di tutta la Germania. Le consiglio di partire
immediatamente. Addio, signore!»
Così dicendo il Grigio prese il cappello e fece per allontanarsi, mentre il Bruno
con grande stupore giunse le mani ed esclamò: «Possibile? Si può essere cosi?...
No, no, carissimo amico e collega... Sì, sì, collega,» ripeté il Bruno, poiché l'altro lo
squadrava da capo a piedi con un'occhiata superba, quasi sprezzante, «non La
lascio andar via così, in collera e stizza. Resti qui, si sieda.» E fattolo sedere per
forza, si sedette accanto a lui ed empì i bicchieri. «Sappia che non mi passa
neanche lontanamente pel capo di gareggiare con Lei o di danneggiarLa in qualche
modo. Lo sono agiato, posso quasi dire ricco.» Il Grigio si rasserenò in viso e dopo
un breve inchino vuotò il bicchiere che aveva davanti. «Potrei mai essere così
stolto da ficcarmi in un'impresa dalla quale non potrei avere che danno e noie?
Sono abbiente, ripeto, ma ciò che, secondo me, conta assai più, sono uomo di
parola. Garantisco che i miei affari non potranno mai incrociarsi con disagio
dell'uno o dell'altro. Brindiamo, carissimo collega! E abbia fiducia! Si lamenti,
brontoli fin che vuole, imprechi contro il pubblico, contro il gusto, i poeti, i
compositori e magari contro gli eccellenti artisti del primo teatro della Germania
che, penso, Le procurano non pochi dolori e grattacapi!»
«Oh, signor mio,» disse il Grigio con un profondo sospiro, «col pubblico, col
mostro dalle mille teste, bizzarro e camaleonte, si potrebbe, in fondo, anche
spuntarla... Se anche, secondo il consiglio di quel poeta, non lo si rivolta sulla
schiena, affinché l'orrido mostro si tramuti in una volgare ranocchia, si cuociono
ancora da qualche parte biscottini zuccherati che al momento buono si devono
cacciare in quelle fauci pronte ad abbaiare... Il gusto? Questo è soltanto un'idea da
fiaba... un fantasma di cui tutti parlano e nessuno ha mai visto. Se la gente
chiedesse, come nel Gatto con gli stivali: Vogliamo buon gusto... buon gusto! non
sarebbe che espressione del senso malato d'un troppo sazio che cerca un cibo
nuovo, ideale, per eliminare il vuoto che ha dentro. Poeti e compositori contano
poco, oggi, sul teatro, per lo più sono considerati manovali perché offrono soltanto
l'occasione del vero e proprio spettacolo che è fatto di splendidi scenari e di abiti
stupendi.» Il Grigio sospirò ancora profondamente, dopo di che la conversazione si
svolse nel modo seguente.
Il Bruno Ah, come capisco i Suoi sospiri! Hinc illae lacrymae... Già, quale
direttore può vantarsi di essere sfuggito ai continui ben assestati colpi e alle botte
dei suoi protagonisti e delle prime donne?... Ma si sfoghi, mio caro! Fuori le
lagnanze, i lamenti!
Il Grigio Da dove comincio?... E dove finire?
Il Bruno Cominciare?... Tranquillamente dal fatto che deve essere appena
avvenuto e probabilmente Le è stato molto doloroso. Lei ha ricevuto una lettera il
cui tenore l'ha spinto quasi alla disperazione.
Il Grigio Ora m'è passata e con molta calma Le posso dire che rischio di
essere maltrattato dal pubblico e di vedermi arrivare per molto tempo il cassiere,
con aria sconsolata, la cassa sotto il braccio, leggera come una piuma. Lei conosce
il geniale Ampedo, il magnifico direttore d'orchestra, ugualmente grande nel
genere tenero e nell'eroico, nel tragico e nel burlesco, nel forte e... nel debole! Il
grand'uomo, una volta, voleva unire tutta la dolcezza e la potenza del canto in un
unico capolavoro. Non c'era libretto che gli andasse bene, allorché, finalmente,
trovò il poeta, e così possediamo l'opera di tutte le opere: Gusmann il Leone.
Il Bruno Ahi, ahi! Gusmann il Leone! Un'opera cavalleresca. Un eroe che
per il suo valore e la sua forza fu detto «Leone».
Il Grigio Sbagliato, mio caro, sbagliato di grosso! Gusmann è un leone
vero, simpatico, carino, educato, di mentalità garbata, di gentili costumi, d'una
fedeltà a tutta prova. La sua parte può essere recitata degnamente e con efficacia
soltanto da un cane bene ammaestrato cui si metta in testa una conveniente
parrucca da leone.
Il Bruno Dio buono... ancora un cane... di nuovo un cane!
Il Grigio Zitto, mio caro, zitto! Il genio dell'epoca, questa potenza
spirituale in perenne progresso, che trascina anche noi nei suoi vortici, esige ormai
i cani sulla scena, ed è bene che educhi quest'intelligente animale a
rappresentazioni di livello superiore, dalla comune gentilezza del dramma alla
romantica cavalleria della tragedia e dell'opera eroica. Un capocomico voleva fare
un passo avanti e, lanciando il tema più sublime, portare in scena un asinello di
giuste proporzioni nelle parti di amoroso. Ma tutti furono contrari e fecero notare
che non era una novità, sicché l'idea fu abbandonata.
Il Bruno Noto che le corde del Suo cuore sono allentate e mandano un
putiferio di amarissime ironie. - Ma andiamo avanti! Le hanno offerto il lavoro? E
Lei lo voleva i mettere in scena.
Il Grigio Volevo? Io volevo? Caro amico, non si trattava di volere.
Insomma, ecco qui: Ampedo, il geniale direttore d'orchestra, è uno di coloro che,
come il cane nel Principe Zerbino, vanno dicendo e ripetendo «Sono un
grand'uomo» finché il mondo ci crede e gli riconosce il titolo, sotto il quale manda
nel mondo, col marchio di «prima qualità», tutto quanto produce, quando è di
buono o di cattivo umore, di qualunque colore, di qualunque gusto sia. Bastò che
dicesse «Ho terminato il mio Gusmann il Leone», perché gli entusiasti gli
gridassero: «Un capolavoro! splendido!... meraviglioso!... Quando avremo questo
divino godimento?» Ampedo si stringe nelle spalle, assume un cipiglio tra
altezzoso e sprezzante e dice: «Già, se il direttore volesse... Se fosse d'accordo di
impegnarsi davvero... a qualche spesa... Se mi paga bene...» Ed ecco tutti
addosso a me, tutti a minacciare. Mi dissero persino che dovevo essere un
ignorante, senza cervello, senza gusto, che dovevo aver dato l'anima al diavolo, se
non mi decidevo a spendere fior di baiocchi per il capolavoro dei capolavori. Che
potevo fare se non acquistare l'opera ad un prezzo inadeguato tanto alle mie forze
quanto ai meriti di Ampedo? Ecco: acquistai l'opera.
Il Bruno E probabilmente si è trovato sul gobbo un misero pasticcio.
Il Grigio Niente affatto. Leggendo il testo trovai scene che o non possono
mancare una energica scossa o devono suscitare in tutti un'intima tenera
commozione. Tra le prime metterei... Ma anzitutto devo avvertire che la protetta di
Gusmann è una dolce e cara principessina, ancora bimba e infantile, Bettina si
chiama... dicevo dunque, tra le scene impressionanti metto anzitutto quella in cui
Gusmann a un tratto riconosce nel principe Carco, colui che sette anni prima aveva
voluto baciare la principessa Bettina, e perciò gli si avventa addosso con un
orrendo ruggito e gli strappa con un morso la borsa dei capelli. Per contro c'è una
scena commovente, un vero idillio dolce, familiare, dove la gentile e carezzevole
Bettina dà da mangiare l'uva passa a Gusmann: butta in alto i chicchi ed egli li
acchiappa con agili salti, ma non li inghiotte prima che l'adorata fanciulla non
esclami o, meglio, canti: «Mangia!»
Il Bruno Magnifico, incredibile davvero!... E la musica? la musica?
Il Grigio L'ho udita purtroppo soltanto alle prove, perché la
rappresentazione andò a monte. Ma vi sentii le più stupende e più geniali idee di
maestri immortali, i quali purtroppo erano mortali; e non è forse meritorio
ricuperare e salvare in tal modo per la generazione attuale oro e gioielli, tesori che
il Tempo, nababbo tracotante, scaglia nell'abisso? Oltre a ciò il mastice col quale
Ampedo sa incollare abilmente ha un suo colore, una sua consistenza; che si vuole
di più?
Il Bruno Ahimè, che cosa posso dire? Lei ce l'ha con quest'opera perché
sorse certamente all'orizzonte teatrale come una cometa infocata che nella coda
reca guerre e tempi tristi, temporali e uragani. Ma continui... continui...
Il Grigio Mi sono rifatto da lontano... dall'uovo di Leda, a quanto vedo. Ma
Lei, che mi si è avvicinato con tanta benevolenza, mi conceda di essere prolisso;
lasciando che il nemico si avanzi adagio, mi avvezzo alla sua vista, e se lo guardo
fisso può darsi che scompaia senza far danni... Avevo acquistato l'opera e dopo
notai le infinite difficoltà che si sarebbero opposte alla rappresentazione.
Il Bruno Già, il cane che bisognava addomesticare perché facesse la parte
del leone Gusmann...
Il Grigio Oh, carissimo, questo era il meno. La sorte, la mia buona stella
mi fece trovare subito un mastino intelligente, umano, dal pelo dorato, e nel mio
parrucchiere un geniale istruttore della bestia. Tutto andò a gonfie vele. In breve
il degnissimo cane dimenticò il suo vero nome Lep e cominciò a rispondere al nome
di Gusmann! Imparò a stare in piedi sulla scena, a camminare, a muoversi, che
non è poco, mangiava uva passa e azzannava borse di capelli nelle quali l'accorto
pedagogo aveva nascosto salsicce. Le spese non erano elevate perché, oltre agli
alimenti, non cari salsicce comprese, e al modesto compenso, dovevo pagare
soltanto cinquanta talleri per panciotti e calzoni, lacerati al docente durante le
prove artistiche. Per la guarigione dei graffi che il giovane artista di buone
speranze, nell'ardore delle recite, aveva causato al naso del secondo tenore
(Carco) il chirurgo del teatro non presentò nessuna parcella. Disse che molto va
perdonato a un giovane genio, e per parte sua era pronto a fornire gratis cinque
braccia di cerotto inglese per guarire ferite inferte da siffatti eroi nel loro giovanile
entusiasmo per l'arte. Modo di cattivarsi il pubblico!
Il Bruno Dunque i veri ostacoli, le autentiche difficoltà...
Il Grigio In genere ci sarebbe già da criticare il fatto che in un'opera il vero
protagonista non canta. L'ingegno umano non ha ancora inventato il modo di
insegnare il canto ai cani, e pertanto Ampedo avrebbe scritto invano una parte per
Gusmann; ma qui si potrebbe anche chiudere un occhio, perché ci sono già opere
con protagonisti muti. Al canto si sostituisce la bravura mimica che non si può
certo negare alle bestie. Ma... ma l'opera si chiama Gusmann il Leone, grave
inconveniente, perché scontentava la primadonna, il primo tenore, il primo basso,
i quali volevano tenere a battesimo l'opera e darle, tutti, il proprio nome. Un altro
ostacolo: Bettina il personaggio più importante dopo Gusmann, non ha una parte
di bravura, doveva quindi essere affidata a una cantante giovane, mentre il grande
Ampedo aveva caricato di fulmini e tuoni la parte della Regina
Micomicona,componendola evidentemente per la primadonna. Poi: la parte di
Caio, tiranno e re d'un'isola deserta, scritta per il primo basso, conteneva un'unica
aria, e infine: nella parte del tenore il la sopra il rigo appariva soltanto due volte.
Insomma, mi pareva già di vedere le gentili letterine: «Allegando la parte di
Micomicona ecc.» e le facce disgustate e sprezzanti alle prove. Come difatti
avvenne puntualmente.
Il Bruno Ho capito. Tutti, tranne l'intelligente Gusmann, si rifiutarono di
cantare, di recitare... Micomicona è stata la prima a rimandare la parte?
Il Grigio Eh sì. Ma io l'avevo previsto ed ero preparato. Secondo le mie
istruzioni il vestiarista andò dalla primadonna con un bel disegno che
rappresentava la Regina Micomicona in abito di gala. Il vestito era nuovo,
Pomposo, magnifico, con molto velluto, molto raso, molti ricami, molti merletti,
colori vivaci, ciuffi di piume, pietre. Il vestiarista suscitò entusiasmi quando, con
profonda sottomissione, fece notare che la signora non avrebbe forse mai
sfolgorato sopra tutti, proprio tutti i presenti, come nell'opera «Micomicona». Lo
scambio apparentemente involontario del titolo fu una musica lusinghiera alle
orecchie della signora: «Crede, mio caro, che questo manto di porpora ricamato in
oro mi starebbe bene?» Così bisbigliò soavemente la donna sorridendo e
osservando il disegno. Il vestiarista giunse le mani estatico ed esclamò: «Oh
donna meravigliosa, celeste, divina! Come arderanno e sfavilleranno queste
argentee scintille di cristallo, questi aurei baleni, combattendo come salamandre
corazzate di scaglie contro i raggi vittoriosi di cotesti occhi soavi! Permetta, angelo
del cielo, che questa sottoveste sia scorciata di mezzo centimetro, la pesante
guarnizione la tira in giù, ma allo sguardo del pubblico estasiato non deve sfuggire
il delizioso piedino, l'ornato piedistallo della colonna d'alabastro!»
Il Bruno Egregio collega, si vede che al Suo vestiarista non mancano le
espressioni poetiche.
Il Grigio È vero. Le basi della sua poesia sono dovute alla lettura di tutti i
manoscritti di vecchi drammi e tragedie, in parte orrende, che gli diedi affinché ne
ritagliasse i suoi modelli. Non so se lo faccia ancora, ma a suo tempo si spremeva
il cervello per adattare e ritagliare - quando doveva fornire i costumi per
determinate rappresentazioni - i modelli dai drammi che a lui parevano omogenei
e metterli in prova. Per il Regolo ritagliò il Codro, per gli abiti di Re Yugurd una
vecchia tragedia di Gryphius, della quale mi sfugge il nome, per la Vestalei Soldati
di Reinhold Lenz. Quest'ultimo accoppiamento non me lo so spiegare, non vedo il
nesso, d'altro canto quel mio fantasioso vestiarista è un po' matto.
Il Bruno Ma non ha notato, stimatissimo e grigio amico, che tutti i
subalterni del teatro hanno, come si suol dire, un ramo? Fanno un mestiere
borghese, diciamo il sarto, il barbiere ecc., e s'infilano nelle parti degli attori
pensando che i prodotti del loro lavoro debbano servire esclusivamente a quegli
dei di carta dorata lassù, che così servono e pongono al di sopra di tutto, anche se
ne dicono male. Infatti gli scandali del teatro sono per loro una chiave che apre
tutte le porte. Non è facile trovare una città con teatro dove almeno i giovani,
uomini e donne, per aggiustarsi i capelli non ricorrano al figaro del teatro.
Il Grigio Ben detto, caro amico. Ci sarebbero anche altri problemi da
toccare. Ma per ritornare al mio sarto, Le dirò che fece trionfare la mia volontà con
la massima finezza. La fantasia di madama non vide che la fulgida immagine di
Micomicona, non le passò per la mente che mi aveva restituito la parte. Io non
chiedevo di meglio. Le scrissi che capivo benissimo come quella parte non si
prestasse a mettere in piena evidenza il suo raro ingegno, ma la pregavo di
risolversi ad accettare questa volta per amore del compositore, di me stesso, ma
soprattutto del pubblico che non ne aveva mai abbastanza di ascoltarla e
ammirarla. Dopo un quarto d'ora avevo la risposta: «Egregio direttore, perché lei
si convinca che non sono testarda come sarebbe certo, e giustamente, un'altra
cantante che avesse le mie capacità, dichiaro che canterò la parte di Micomicona.
Rileggendo meglio ho anche riscontrato che vi sono passi molto belli. Senza
pensare a me faccio tutto per l'arte, e Lei lo sa. I miei rispetti e saluti. P.S. Mi mandi
un campione del velluto rosso e della stoffa ricamata in oro, E il sarto venga subito
da me.»
Il Bruno Dunque, affare fatto.
Il Grigio Sì, ma una lotta ancora peggiore ho dovuto sostenere col tiranno
Caio, il re dell'isola deserta. Costui (parlo del mio basso), dotato di una voce
mediocre, e tutt'altro che di bella presenza, è il mio castigo. Le sue interpretazioni
sono buone, ma dovute soprattutto ad ogni sorta di ciarlatanerie musicali che gli
servono per incatenare la folla o meglio suscitare quell'ammirazione a bocca
aperta, quell'imbambolato stupore che scoppia in irrefrenabili applausi non
appena un funambolo ha eseguito felicemente l'audace capriola. Il popolo gli ha
rizzato il trono di carta sul quale ora si pavoneggia. Accecato dalla vanità e
dall'egoismo considera se stesso il solo centro dal quale tutto deve partire. Perciò
nessuna parte gli va bene. Nella veste di padre amoroso esige arie robuste, in
quelle di vecchio ridicolo vuole scene serie, da tiranno tenere romanze, poiché
sempre e da per tutto vuol essere il più versatile. «Fatemi fare anche il leone.
Ruggirò in modo da far piacere a chi mi sente. Ruggirò in modo che il duca chieda:
‹Fatelo ruggire ancora!› Forzerò la voce e ruggirò con la dolcezza della colombella
da latte, ruggirò come un usignolo!»
Il Bruno Oh Bottom! Bottom!
Il Grigio Santissimo Shakespeare! Conoscevi dunque il mio basso,
quando creasti il magnifico Bottom che è una bella lezione per i folli sproloqui di
tutti i commedianti presuntuosi! Si figuri che Caio fu scontento anche della
composizione di Ampedo, ma soprattutto del dramma, perché scorgeva nel cane
un formidabile rivale. Dichiarò che non avrebbe cantato mai la parte di Caio. Gli
feci notare che a causa del suo rifiuto l'opera così ardentemente desiderata dal
pubblico sarebbe rimasta nel cassetto, ma credevo forse - ribatté - che fosse
venuto per l'opera, e poi, che ne importava a lui dell'opera? Obiettai allora
umilmente che a cominciare da sabato avrei seguito il medesimo principio nel
versare la paga e l'avrei considerato inesistente. Le mie parole gli fecero una certa
impressione, sicché ci mettemmo d'accordo sui punti seguenti che io firmai come
un trattato di pace:
1. Nell'opera Gusmann il Leone il signor Caio accetta di cantare e canterà la
parte del re di un'isola deserta.
2. Il Direttore promette di indurre il signor direttore d'orchestra Ampedo a
comporre ancora un tenero rondò o una romanza in stile francese. Il signor Caio
propone a tal fine la IV scena dell'atto II, nella quale Caio pugnala il più vecchio
principe della regina Micomicona sotto gli occhi di lei, perché la scena è
esattamente alla metà dell'opera. Commesso l'omicidio, Caio può ricordare il dolce
tempo della giovinezza quando era lui a leggere: «La scimmia è proprio buffa ecc.
ecc.» Ciò lo intenerisce. Comincia a fantasticare e prorompe: «Oh dolce gioventù
ecc. ecc.» nella tonalità di mi bemolle maggiore; e quattro volte vi può, ricorrere
un colla-parte. Meglio è però che il signor Ampedo scriva tutta l'aria colla-parte e
soltanto tre accordi dell'accompagnamento; il resto viene alle prove.
3. Al signor Caio si permette espressamente di applicare speroni d'oro ai suoi
stivaletti, di impugnare il bastone del comando e di recitare la scena:, nella quale
appone la firma alla sentenza di morte di Micomicona, stando a cavallo. Può essere
un sauro, e soltanto in caso di necessità il baio inglese stellato, che è in dotazione
al teatro.
Firmammo questo patto, ci abbracciammo e quando arrivò Ampedo, Caio
con un dolce sorriso gli batté una mano sulla spalla e disse: «Stia tranquillo, mio
caro, canto io il tiranno!» Ampedo lo guardò sbalordito e io approfittai del
momento per fargli digerire l'idea della tenera aria con tre accordi. Accettò... e
l'affare era fatto!
Il Bruno E gli altri?
Il Grigio Ben detto! - Denaro! Abiti nuovi! Oh, tutto filava, ma nello sfondo
Satana stava in agguato. Oh, chi può opporsi al potere del diavolo?
Il Bruno Che c'entrava Satana con la grande opera del grande Ampedo?
Il Grigio Lui - il diavolo voglio dire - esercita il suo potere con deboli
strumenti e s'inalbera ferocemente in cuori miti. Ben contento di me stesso, ben
felice che la difficile impresa mi sia riuscita, cullandomi in rosei sogni e speranze,
pregustando il successo del leone Gusmann e il mucchio di quattrini che mi doveva
rendere, me ne stavo nella mia camera. A un tratto sento aprirsi la porta
dell'anticamera. Qualcuno entra, sento uno strano rumore di pianti e singhiozzi,
esclamazioni, smozzicati lamenti. Quale spettacolo mi si presenta! Roba da matti!
Il sarto e il parrucchiere, addetti al teatro, si tengono abbracciati, cuore contro
cuore. Singhiozzano e piangono, con parole stentate, soffocate dalle lacrime, si
lagnano di un'amarezza subita. «Caro amico, sopportare un simile affronto! Egregio collega, dover accettare un'onta così! - Quella iena - quel drago - quel
disgraziato - quel vieto soggetto - quel romanzo antiquato col titolo nuovo - fiaba
antidiluviana - roba abusata, da parrucconi - l'abito della festa ormai smesso.»
Infine si accorsero che ero là, si sciolsero dall'abbraccio e, dilaniati dal dolore, mi
vennero addosso.
Soltanto allora notai che il sarto aveva sul naso uno sfregio sanguinante,
come una graffiatura di unghie affilate, e il figaro una guancia visibilmente gonfia
e paonazza.
«Vendetta, vendetta per noi offesi, mortificati... vendetta, egregio...
buono... giusto direttore!» Così gridarono all'unisono. Infine li costrinsi a
raccontare con calma l'accaduto e venni a sapere cosette amene.
Il Bruno Quasi mi par d'indovinare l'origine della graffiatura, l'origine della
guancia gonfia.
Il Grigio Ecco: il mio sarto ha compiuto la stupenda opera d'arte, ha
confezionato l'abito della regina Micomicona; egli stesso ammira il capolavoro così
ben riuscito, è convinto di aver creato una cosa mai vista, si crogiola nel suo trionfo
e non vede l'ora di udire gli elogi dalle labbra di Madonna. Corre là con gli abiti che
sono veramente di buon gusto, e Madonna li indossa. Qua e là c'è qualcosa fuori
di posto, la veste specialmente, nel punto dove secondo un'antichissima usanza si
è soliti sedersi, fa certe strane pieghe che sciupano persino il drappeggio del
mantello sovrapposto, e per quanto si tiri di qua, si stenda di là, non vogliono
sparire. Il bravo artista aveva in mente una Micomicona ideale e non si figurava le
forme di Madonna, un po' insolite, piuttosto larghe, che la fanno assomigliare a
una Miss Billington. Madonna - caso raro - nota lei stessa le sproporzioni. Il sarto
assicurò che in quei vestiti giovanili sembrava un po' stregata, un mostricciattolo
camuffato per burla.
Madonna invece diede la colpa al taglio degli abiti e cominciò a criticare di
qua, criticare di là. L'ambizioso artista ne fu contrariato, e sottovoce cominciò a
parlare degli slanci geniali che la natura pone talvolta nelle forme, quando, per
esempio, fa una parte diversa dall'altra, e così via. Vedendo poi che Madonna non
la smetteva di biasimare e disapprovare accennando persino a incapacità e totale
mancanza di gusto, l'offeso sbottò a gridare che, certo, bisogna essere giovani e
belle, non simili a un sacco imbottito, se si vuole che un abito così faccia bella
figura. Udire queste parole, strapparsi di dosso il mantello e il vestito, buttare tutto
in faccia al sarto, lasciargli, forse senza volere, un bel segno sul naso, fu affare di
un momento. Il sarto, temendo le unghie aguzze della gatta infuriata, infila la
porta e s'imbatte nel barbitonsore che arriva con la parrucca da far provare a
Madonna. La sua cattiva stella gli ha fatto prendere però un abbaglio ed ecco che,
con un sorriso soddisfatto, egli porge alla donna la gialla, dorata, riccioluta criniera
destinata a Gusmann, il leone! La donna, già agitata, si crede vittima di una beffa
e con quella stessa mano, le cui dita sono provviste di unghie affilate, allunga allo
sfortunato artista delle forbici un tale manrovescio da fargli rombare le orecchie e
schizzare mille folgori dagli occhi. Anche lui infila la porta, raggiunge il sarto sulle
scale e tutti e due corrono da me: ecco l'origine della scena nella mia anticamera.
Il Bruno Noto che Madonna è di temperamento italiano, forte in mimica
espressiva e, secondariamente, pronta ad ammazzare il prossimo, adottando la
simbolica somministrazione dei graffi e degli schiaffi. Le nostre cantanti tedesche
non arrivano però fino a questo punto.
Il Grigio La mia attrice è ben oriunda dell'Italia. E potrà sembrare un
paradosso se preferisco affrontare le furie di un'italiana irritata anziché perire di
morte lenta, torturato dalle critiche meschine, dalle smorfiette, dai capricci, dagli
attacchi di nervi, dai disturbetti delle nostre lunatiche teatranti tedesche...
Il Bruno Lei è troppo sensibile, caro amico. I piccoli difetti delle nostre
signore, il loro debole sistema nervoso... la loro sensibilità...
Il Grigio Già, la loro maledetta sensibilità! Una parte assegnata o non
assegnata, la tinta sgradita d'un vestito... una collega molto applaudita o magari
chiamata al proscenio... il silenzio o il moderato applauso del pubblico invece
dell'atteso trionfo, persino l'aria nelle sale di prova, tutto le investe come una
folata di scirocco e le butta se non sul letto, almeno sul divano, dove, con la testa
fasciata o con la cuffietta di pizzo ben pieghettata e in graziosa vestaglia,
confidano in tono melodioso le loro pene al dottorino giovanissimo, galante e
intellettuale. Costui tiene in tasca l'intero arsenale della morte. Febbri d'ogni
genere... polmonite... mal sottile... meningite... empie d'una girandola di attacchi
orripilanti i suoi certificati che poi mi vengono inviati in una letterina, dai cui
caratteri già si rileva il tremore della morte vicina.
Il Bruno Ma se quello vuol essere un medico deve ben fare l'impossibile e
opporsi valorosamente persino alla morte con energici rimedi che i malati non
possono fare a meno d'ingollare.
Il Grigio Il mio sublime dottore, invece, ha in dispregio tutte le medicine
che combattono il male nella solita maniera terrena. Il suo metodo terapeutico è
puramente psichico. Egli magnetizza e nessun magnetizzatore riesce così
facilmente come lui ad addormentare i pazienti. Dopo aver sciabolato un po' con la
mano magnetica l'atmosfera del malato, gli pone sul petto, come una volta si
faceva con la bacchetta magica, dodici sonetti fabbricati apposta, che a tal fine egli
porta con sé. E quello chiude subito gli occhi; se c'è ancora qualche indugio,
aggiunge una tragedia. Ed ecco, già a metà del primo atto anche le fibre più
robuste crollano, come travolte da un sonno mortale.
Il Bruno Giusto. Faccio tanto di cappello all'applicazione di mezzi psichici
quando il caso è disperato... Tra essi pongo la magia del linimento d'oro.
Il Grigio Capisco, capisco... Mi par di avere davanti agli occhi lo
spiritosissimo disegno di Gillray, il celebre caricaturista. La Billington in tutta la sua
prospera pinguedine, ma col pallido languore di un finto malessere, è seduta su
un'ampia poltrona. A destra e a sinistra, in piedi, i direttori dei teatri Drurylane e
Coventgarden. Il primo cerca di confortarla e di farle prendere un po' del prezioso
infuso che le ha preparato il più famoso medico di Londra; ma con garbata
benevolenza lei scosta il capino volgendolo verso il direttore del Coventgarden che
col cucchiaio in mano fa per somministrarle... ghinee, tolte da un gran sacco con
l'etichetta: «Cinque volte ogni quarto d'ora!» Il farmaco farà effetto e l'ammalata
ritroverà le forze per il Coventgarden.
Il Bruno Già, ma il povero direttore d'una compagnia di giro non dispone
purtroppo di un siffatto linimento d'oro, sicché bisogna ricorrere ad altri rimedi
psichici che spesso producono effetti molto drastici. Vuole un esempio? vuole che
le racconti come una volta applicai un simile rimedio con ottimo esito?
Il Grigio Sì, sì, così mi diverto e imparo.
Il Bruno La mia malasorte mi fece trovare una volta nel mio modesto
teatrino due pulzelle... pulzelle d'Orléans, s'intende. È inutile che spieghi a un
collega come questo malanno, che io stesso avevo provocato sconsideratamente,
abbia messo abbondanti polloni e germogli e viticci di diaboliche liti e noie...
Chiamerò le mie due donzelle con nomi romantici: Desdemona e Rosaura.
Dunque, Desdemona era di indole piuttosto infernale e soffriva talvolta di attacchi
di pazzia furiosa, come la Sua Micomicona, mio caro. Rosaura invece,
atteggiandosi a malata grave, con un'aria di amaro rimprovero, mostrandosi
vittima di un torto imperdonabile, e sfogandosi con grida brevi, ma laceranti,
sapeva schiantare il cuore di chi l'ascoltava. C'era da sentirsi scoppiare il petto dal
dispiacere quando, respinta qualche sciocchezza, si annunciavano quei sintomi.
Desdemona era senza dubbio migliore attrice, Rosaura invece più giovane e più
bella, e siccome quell'aria sofferente le donava molto, era naturale che avesse
dalla sua i giovani della platea, i quali vanno facilmente in estasi; e io mi trovavo
nelle peste. Come Desdemona non era in grado di recitare le parti di Turandot e
della Giulietta shakesperiana, perché richiedono assolutamente giovinezza e
bellezza fisica, così la mia piccola graziosa Rosaura sciupava la pulzella eroica. Ora,
Lei penserà che è perfettamente regolare se quelle due s'incocciarono ad avere
proprio le parti contrarie alla loro natura. - Ecco, oggi si dà la Pulzella, pochi giorni
dopo la Turandot, novissima allora e ansiosamente attesa dal pubblico. Chi recita
è Desdemona, poiché per la seconda volta ho rifiutato la parte della pulzella a
Rosaura, nonostante che lei si pavoneggi nell'elenco dei personaggi. I sintomi del
dolore si manifestano e due giorni prima della Turandot Rosaura è a letto, malata
da morire. La perfida sapeva che quella parte non poteva essere affidata ad altri e
un rinvio della recita era un brutto colpo per me. Corro da lei. Pallida come un
cencio (senza belletto, voglio dire), smunta per le sofferenze, mi balbetta
semisvenuta: «Sto molto, molto male.» Il sospiro che segue significa: Lei, Lei,
brutto mostro, mi ha assassinata! E tanto il primo tenore quanto il giovane
sentimentale che nella commedia fa il secondo amoroso, ma nella camera di
Rosaura il primo, entrambi vicino al letto profondamente addolorati, si portano il
fazzoletto agli occhi. Io mi siedo al capezzale partecipando al dolore, prendo
dolcemente la mano abbandonata di Rosaura, e con voce tenera, commossa, nel
tono che i giovani spasimanti senza speranze adottavano trent'anni fa, le bisbiglio
tristemente: «Oh, Rosaura... come mi tocca vederla... le mie belle speranze sono
distrutte... il pubblico perde un immenso godimento artistico...» Quella crede che
io parli di Turandot e un sorriso maligno le guizza agli angoli della bocca.
«Oh, Lei non sa,» continuo alzando il tono del dolore, «non sa che tra
quindici giorni volevo dare la Maria Stuarda e questa parte l'avevo riservata a Lei.
Così invece...» Rosaura rimase cheta cheta, perché io proseguissi, ma io tacqui
prudentemente e accompagnai la pausa soltanto con sospiri, assecondato dal
tenore e dal primo amoroso. «Per allora,» cominciò pian piano Rosaura, levandosi
a sedere, «per allora, caro direttore, potrei anche essere guarita. Mi mandi la
parte, soltanto da ripassare, l'ho già recitata quattro volte... con parecchi
applausi... come Maria Stuarda ho avuto cinque chiamate!» E con queste parole
ricade spossata sui guanciali. «Oh, Rosaura, cara figliola,» riprendo asciugandomi
le lacrime dagli occhi, «Lei sa già come stiamo con la distribuzione degli spettacoli
e col pubblico. Se si rinvia la Turandot quale altro dramma se non la Maria Stuarda
ha il potere di abbonire il pubblico curioso e deluso? E ora, che vuole? sarà
Desdemona a recitare la Stuarda e la nostra Elisa a fare la parte della regina.»
«Come?» esclama Rosaura un po' più forte di quanto la sua malattia e la
fiacchezza dovrebbero consentirle. «Desdemona la esile Stuarda, Elisa la superba
regina?... Non si può davvero trovare un altro dramma?» Con dolcezza, ma con
tono piuttosto deciso le rispondo: «No, cara Rosaura! Invece della Turandot si dà
ora la Maria Stuarda. Il pubblico è già avvertito!» Altro silenzio... sospiri... raschi in
gola ecc. «Devo ammettere,» osserva Rosaura, «che questa mattina già mi
sentivo meglio di ieri sera...»
«Illusione, probabilmente, cara ragazza, perché si vede proprio che è
straordinariamente pallida e debole... Sono molto in pensiero.»
«Caro, ottimo direttore, non sa che, ad onta di tutto, posdomani potrei forse
recitare la Turandot? E se anche non fossi del tutto ristabilita... lo potrei fare per
lei.»
«Che dice, Rosaura? Mi prende per un mostro selvaggio, per un barbaro
senza cuore? No, la Turandot non va in scena se dovessi avere soltanto il più vago
sospetto che la Sua preziosa salute possa correre il sia pur minimo pericolo!»
A questo punto si scatenò una gara di generosità, la cui decisione fu affidata
al medico. Lei, carissimo amico, può immaginare come costui abbia deciso; fatto è
che Turandot fu rappresentata il giorno fissato e, in seguito (bisogna pur
mantenere la parola!), Rosaura recitò la Maria Stuarda.
Certe lingue sottili credettero di notare nella celebre scena della lite fra le
due sovrane (Desdemona era Elisabetta) un saporino leggermente acido di
persona grossolana. Ma chi andrà mai a guardare così per il sottile!
Il Grigio Ottimo amico e collega - lasci che La chiami cosi! mi viene dal
cuore - io L'ammiro perché certo non possiedo la tranquillità di spirito che ci vuole
per procedere così. Ah, la mia irruenza, i bollori che mi trascinano spesso a gesti
assurdi!
Il Bruno Oh, Lei è ancora giovane. Bisogna aver percorso un lungo
cammino per non ammaccarsi i piedi contro le pietre aguzze che sono sparse
dappertutto... Ma troppo ci siamo allontanati dal suo Gusmann, dalla Sua
Micomicona! Per favore, riprenda il racconto!
Il Grigio Ciò che aspettavo con certezza avvenne realmente. Non era
passata un'ora allorché mi venne recapitato un biglietto di Madonna insieme con la
parte di Micomicona. L'interno furore aveva trasformato la sua scritturina, di solito
aggraziata, in sgorbi barbarici, dai quali però non era difficile ricavare che, come
sempre, addossava ogni colpa a me e attaccava la lite partendo dal «quarto
grado».
Il Bruno O senti! Vedere il matto Touchstone nel Come vi piace di
Shakespeare. Cominciò dunque dalla «risposta animosa», vero?
Il Grigio Giusto. Dichiarò cioè chiaro e tondo che, dopo aver studiato bene
la parte della regina, questa non le pareva adatta alla sua gola, che tutta la
maniera di quel canto tedesco le era estranea e si meravigliava che io pretendessi
di farle cantare quella roba! Ora, non potevo né volevo respingere quel rifiuto.
Il Bruno Capisco, altrimenti quella s'intestava e passando per i diversi
gradi arrivava fino a una guerra incresciosa. Ma come sostituirla?
Il Grigio Ne avevo il modo e lo feci sui due piedi. Una brava ragazza,
ancora nelle condizioni di chi senza scrupoli va a caccia di parti, ottima d'altronde
nella sua mediocrità, fu scritturata per l'occasione, e tutto pareva dovesse filare
per il meglio, benché dovessi temere Caio il tiranno, che sapevo benissimo quanto
subisse l'influenza della terribile donna. Ma rimasi un poco stupito quando vidi che
Caio stava quieto e partecipava assiduamente alle prove. Faccia conto che
posdomani si debba andare in scena, e oggi, oggi, in questo istante mi arrivi il
nefando biglietto dello sciagurato tiranno! Stia a sentire: «Mi rincresce di non poter
cantare la parte di Caio che infatti non canterò. Soltanto per compiacere Lei mi
sono abbassato a studiare quella confusa roba gotica, e ad assistere alle prove, ma
ora m'accorgo che quel canto, cioè non-canto, da pazzi non farebbe che guastare
la mia gola. Sono già rauco e non sarò così sciocco da peggiorare il malanno.
Addio.»
Il Bruno Naturalmente Lei lo licenzia in tronco, vero?
Il Grigio Vede, mio caro diletto amico, questo è appunto il mio tormento:
non lo posso fare senza urtare il pubblico, del quale è diventato il beniamino, sia
pure in certo qual modo.
Il Bruno Dia retta a un esperto: nel teatro nulla è da temere tanto poco
quanto il momentaneo borbottare del pubblico al congedo d'un così detto
beniamino. Anzi, assicuro che di questi non ce ne sono più... Permetta che mi
rifaccia da lontano! A noi tedeschi calmi e posati è mancato da sempre
quell'entusiasmo, confinante con la pazzia, col quale altrove, oggi ancora in
Francia e in Italia si festeggiavano e si festeggiano gli attori drammatici. Nessun
principe tedesco ha mai creato cavaliere un eunuco effeminato per i suoi smidollati
gorgheggi, come è toccato a Farinelli;nessun pubblico tedesco ha mai divinizzato
l'attore, il cantante ancora in vita, come pur è accaduto più volte. Quando il celebre
Marchesi cantava a Venezia, ho visto io, coi miei occhi, quella gente, ormai rauca
dal tanto gridare, incapace di muovere le mani rattrappite a furia di applaudire,
contorcersi pazzamente sui sedili e stralunare gli occhi gemendo e sospirando.
L'applauso, o meglio l'estasi, somigliava alle nocive conseguenze dell'oppiomania.
Ma torniamo a bomba! L'animo tedesco è simile a un lago limpido e tranquillo che
nelle sue profondità accoglie con chiarezza tutte le immagini della vita e le
conserva con grande amore. Questo amore era la vera ricca ricompensa
dell'artista, ed esso creò il beniamino. Siffatti beniamini del pubblico furono gli
Eckhof, gli Schröder e altri. Quando Schröder parlava sulla scena, regnava una tale
attenzione, un tale silenzio che si sarebbe sentito il più lieve sospiro. Se poi, dopo
un riuscitissimo discorso, scoppiavano i fragorosi applausi, erano l'involontaria
esplosione di ciò che uno sentiva nel proprio intimo, non già la gioia puerile per
qualche spericolata bravura, eseguita col canto, con la parola o con i gesti.
Nell'arte drammatica vigeva allora una serietà degna dei tedeschi: a teatro noi non
ci picchiavamo, non ci rompevamo l'osso del collo nelle antisale, come a suo tempo
a Parigi fra gluckisti e piccinisti, ma nelle campagne critiche manifestavamo
l'insonne aspirazione a quel livello superiore che è la meta di ogni arte. Si pensi agli
scritti drammaturgici di Lessing. Non occorre dire come quella serietà sia andata
via via scomparendo di fronte alla fiacca leggerezza che infatuò il mondo intero. Da
notare che a poco a poco le opere puramente drammaturgiche scomparvero del
tutto e le riviste vaganti nel territorio dell'arte s'impadronirono del teatro fornendo
sotto il titolo fisso di «Notizie teatrali» superficiali giudizi su drammi noiosi e su
ignoti commedianti. È fin troppo vero che oggi chiunque abbia occhi per vedere,
orecchie per udire e una mano per scrivere si reputa chiamato e capace di fare il
censore teatrale. A uno Sperling, commissario bietolone, domiciliato in questa o
quella cittadina di provincia, gli occhi azzurri di madama Ypsilon hanno piantato
una freccia nel cuore, e ora il mondo apprende il fatto inaudito. La prima Musa
tragica, l'insuperabile ideale dell'arte, vive nella detta cittadina di provincia, si
chiama Madama Ypsilon, ha avuto, appena calata la tela, le sue chiamate nella
Giovanna di Montfaucon e ha ringraziato con le frasi più cortesi.
Ho detto che a suo tempo era l'animo degli spettatori, il loro amore a creare
i beniamini. Quell'amore è stato sommerso dal rilassamento e dalla fiacchezza, e
con esso sono tramontati i beniamini. Ciò che una volta proveniva dall'esuberanza
del cuore nasce oggi dall'impulso del momento, e come allora si applaudiva
l'interpretazione dell'artista, nel suo complesso, oggi sono soltanto singoli
momenti, indifferente se adeguati o no all'insieme, a mettere in moto le mani. Non
vi è nulla di più facile al mondo che suscitare in tal modo l'applauso del momento;
se ne potrebbe formulare un catechismo: mandare un grido quando il piede è già
alzato per la partenza... lanciare qualche urlo... battere i piedi per terra... darsi una
pacca sulla fronte... eventualmente mandare in frantumi un paio di bicchieri...
spaccare una sedia: ecco quello che ci vuole per i nostri odierni eroi, i quali non
somigliano punto al dragone ubriaco nell'osteria, bensì molte volte al ragazzo
scappato da scuola che, tormentandosi nella sua mansueta selvatichezza, per la
prima volta si è infilato gli stivaloni e ha fumato... Ma ho divagato troppo!
Il Grigio Tutt'altro. Anche Lei comincia a manifestare un po' di rancore, e
come Jacques, l'umorista misantropo in Come vi piace, io sono ben lieto di
gonfiarmi di rancore con chi di rancore è gonfio.
Il Bruno Volevo dire che la facilità, la comoda maniera di suscitare gli
applausi produce nell'attore non solo una puerile fiducia in se stesso, ma ad un
tempo un certo disprezzo del pubblico, che egli crede di dominare; disprezzo
abbondantemente ricambiato dal pubblico che tende a equiparare persino
l'autentico artista al vile giocoliere, quando quello non disdegna di servirsi dei bassi
trucchi che questo adotta.
Ahimè, un attore, morto or non è molto, che il mondo, almeno sotto qualche
aspetto, dovette riconoscere per artista veramente grande, non fu forse parecchie
volte vittima di quella stoltezza? Al fragoroso applauso del momento sacrificava la
verità e la dignità della recita.
Il Grigio Ma quale superficialità di spirito, quale senso impudente e
antiartistico si richiede per attribuire qualche valore a siffatte esplosioni di
applausi, generate dal nulla?
Il Bruno Dica Lei, mio caro; una simile esplosione non somiglia forse a un
improvviso starnuto dopo una presa di tabacco forte?
Il Grigio Ah, ah, ah! proprio cosi. E tutti sappiamo che lo starnuto è
contagioso - Però, però... In che conto tiene Lei le infauste chiamate? Io mi sento
torcere le budella. Quando il pubblico grida, tintinnano i talleri nella mia cassetta,
perché è certo che la mattina seguente mi arriva la letterina con la tracotante
pretesa d'un aumento: «Siccome, egregio direttore, come Lei ha potuto
persuadersi ieri sera, io ho ricevuto gli unanimi applausi del pubblico, è logico ed
equo che ecc. ecc.» Dio buono, come si fa a stornare l'assalto al peculio così
faticosamente acquistato, se un vento malvagio e capriccioso lo disperde come
pula? - Dica, in che conto tiene Lei le chiamate?
Il Bruno La mia opinione è fondata sulla teoria dell'amore e dei beniamini.
La chiamata era una rara onorevole ricompensa per l'artista benemerito e amato,
oggi fa per lo più da farsa divertente, simile a quella che gli inglesi accordano al
dramma serio. I tedeschi se la imbandiscono da soli. Bisogna dire però che in tal
maniera si mantiene un certo equilibrio.
Il Grigio A che cosa allude?
Il Bruno Se (ma accade di rado) si tien conto del vero merito e l'attore, cui
è riuscita tutta la parte, non un momento di essa, è chiamato al proscenio; se sta
per godersi il riconoscimento dei suoi meriti, ecco che, subito dopo, con lo stesso
puerile entusiasmo il pubblico chiama un poveraccio qualsiasi, perché ha fatto
gesti pazzi o gridato a squarciagola: e in quanto al vero applauso che onora
l'artista, tutto è come prima.
Il Grigio D'altro canto mi sembra naturale che l'attore vada in cerca
dell'applauso più di altri artisti, i quali presentano opere che non trapassano come
la voce e il gesto.
Il Bruno D'accordo, ma l'autentico artista saprà distinguere il vero
applauso dal falso e apprezzerà soltanto quello e solo di quello subirà l'influsso.
Come nelle parti comiche la risata cordiale, prorompente dall'intimo piacere, darà
all'attore la migliore conferma che egli recita o ha recitato bene, così nella tragedia
la tensione veramente tragica del pubblico farà testimonianza della verità della
recita. Che impressione farebbe mai un artista se, investito della parte di Franz
Moor nei Briganti, udisse il fragore degli applausi dopo il raccapricciante racconto
del terribile sogno? Non dovrebbe pensare che, invece di recitare con verità, ha
offerto uno sfoggio falso? Invece, il silenzio di tomba e, appena ha finito, il
sommesso brusio di gravi e profondi sospiri, qua e là un cupo ah! sfuggito
spontaneamente dal petto angosciato, ecco, tutto ciò gli dimostrerà che è riuscito
a scuotere l'animo degli spettatori così profondamente come soltanto la perfetta
verità della recita può fare. Ho conosciuto un eccellente attore, un vero artista che
parlava di questi fenomeni. Egli asseriva che, quantunque non gli fosse possibile
distinguere, al di là degli abbaglianti lumi della ribalta, alcun viso del pubblico,
quantunque non rivolgesse mai al pubblico occhiate precise, vedeva però con la
mente, in scene del genere, le facce degli spettatori irrigidite dallo spavento, dalla
paura, dall'orrore; ed egli stesso, rappresentando i fatti orribili, sentiva il gelo
scorrergli nelle vene; attraverso quei brividi però si destava in lui uno spirito
superiore, sotto la specie del suo personaggio, e questo, non lui, continuava a
recitare, pur essendo controllato e guidato dall'io, la cui coscienza non gli sfuggiva
mai.
Il Grigio Il Suo attore ha saputo descrivere la vera indole creatrice
dell'artista. Soltanto l'entusiasmo, dominato e moderato dalla sovrastante
intelligenza, crea la classica opera d'arte. La parte è inventata da una persona
entusiasta, dal poeta nascosto, mentre la coscienza del proprio io è l'intelligenza
che evoca il latente poeta e gli conferisce la forza di presentarsi fisicamente in
carne ed ossa. Ma quanto pochi sono coloro che sanno attuare questa duplice
esistenza! Certo è che un artista geniale incarna spesso un personaggio che il
poeta non aveva affatto davanti agli occhi.
Il Bruno Ah, Lei mi porta a un argomento che è tutto diverso da quello di
cui parlavo. Al solo pensarci un brivido mi percorre le membra. Come dev'essere
misero e insulso il dramma in cui, contro le intenzioni del poeta, si può infilare o
meglio modificare un personaggio senza mandare all'aria ogni cosa! Purtroppo ci
furono e ci sono tanti drammi i cui personaggi somigliano a fogli bianchi che
l'attore deve pensare a riempire. Molti così detti poeti solleticano in tal modo
apposta il vanitoso attore e somigliano a quel compositore di teatro che costruisce
una fragile impalcatura per i salti del cantante spavaldo e da padrone si abbassa a
fare il manovale. Rimango stomacato quando sento che la tale e tal parte è scritta
per il tal attore o cantante. È forse lecito che il vero poeta si agganci a un
individuo? I personaggi da lui ideati in tutta la loro verità non appartengono invece
al mondo intero? Purtroppo questi eccessi hanno viziato gli attori, e siccome molto
raramente il cielo ha conferito loro una vera sensibilità poetica, un giusto senso
critico, fanno d'ogni erba un fascio e danno a qualche personaggio d'un dramma
veramente poetico un aspetto particolare, a loro piacimento. Si può figurarsi che
cosa ne venga fuori. Ricordo che una volta un giovane attore, entrato nella mia
compagnia, voleva recitare il Correggio. Gli feci notare che correva un grave
rischio, perché il suo predecessore era stato bravissimo. «L'ho visto,»
m'interruppe con aria indifferente, quasi sprezzante, soggiungendo con un
risolino: «Io prendo la parte per un altro verso. Io creo il carattere!» A quelle
parole fui preso da un brivido e domandai timidamente che cosa intendesse
creare. Pieno di sé mi rispose: «Io do un Correggio pittore entusiasta, vivente nelle
divine regioni dell'arte.» Va da sé, osservai, che si debba fare così, perché soltanto
così emerge il tragico conflitto con la misera e meschina vita nel mondo esteriore,
e aggiunsi che proprio così il suo predecessore aveva inteso la parte. Egli sorrise di
nuovo, seccato e beffardo, e mi fece capire che soltanto un geniale artista come lui
era capace di rendere vivo quel magnifico personaggio mediante una unica ed
energica trovata, alla quale nemmeno il poeta aveva mai pensato. «E come fa?»
domandai alquanto impaziente. Facendo un breve inchino disse con molto garbo:
«Io recito tutto il Correggio presentandomi sordo come una campana!»
Il Grigio Magnifico! stupendo! Credo però che persino nei drammi
mediocri sia pericoloso scavalcare le intenzioni dell'autore e buttare sul mercato
roba propria, alla quale egli non ha pensato. Spesso si sente dire che questo o quel
grande attore recita una particina forse insignificante, estranea al dramma, ma
così egregiamente e con un'originalità così particolare da mettere in ombra tutto il
resto. Ciò può essere molto bello da vedere, non dico di no, ma non v'è alcun
dubbio che in questo modo l'insieme del dramma va a Patrasso.
Il Bruno Vero, verissimo. E la molla di questa sconvenienza non è che
un'illimitata vanità, la smania di mettersi in mostra a dispetto del Poeta e dei
collaboratori...
Il Grigio E come va che questa speciale vanità puerile si riscontra soltanto
negli attori?
Il Bruno Lei mi ripete la lagnanza di prima e io - dopo aver borbottato
abbastanza contro i nostri giovani artisti - non esito ora a citare anche in loro
favore parecchi punti assai notevoli. Vero è che per la maggior parte (di eccezioni
ce n'è poche) sono vanitosi, intrattabili, testardi, capricciosi, cervellotici, ma come
la maledizione del peccato originale che tutti dobbiamo portare, pare che, se non
sull'arte stessa, almeno sul mestiere che le è collegato gravi una maledizione cui
quelli non riescono a sottrarsi. Ho conosciuto giovani di carattere sereno che,
animati da uno stimolo interiore, si dedicavano al teatro e, pur essendo sani, non
appena avevano messo piede su un palcoscenico, erano travolti dalla speciale
follia degli attori.
Il Grigio Che ci sia nelle particolarità dell'arte un pericolo nascosto, non
immaginato, e meno ancora combattuto dagli spiriti deboli?
Il Bruno Certo. Vedo che Lei, caro amico ed egregio collega, sa già dove
lo scoglio affiora dall'acqua tenebrosa... Non mi sento di continuare.
Il Grigio Anzi, La prego vivamente di farlo.
Il Bruno Esiste forse oltre l'arte drammatica un'altra arte che ugualmente
dipenda dalla personalità dell'artista? Essa si può esercitare solo mettendo in
mostra la propria persona. Se non che proprio questo mettere in mostra se stesso
è il più grossolano errore che l'attore possa commettere. Il vero artista che recita
deve possedere la particolare facoltà spirituale di figurarsi il personaggio che il
poeta presenta, animato e vivo, dotato di tutti i motivi interiori che regolano
l'aspetto esteriore nel linguaggio, nell'andatura, nel gesto. Nel sogno noi creiamo
persone sconosciute che, come altrettanti sosia, ci si presentano in perfetta verità,
persino coi tratti più insignificanti. Questa operazione spirituale che le condizioni
del sogno, oscure e per noi misteriose, ci rendono possibile, l'attore la deve saper
eseguire in piena coscienza, a suo arbitrio; deve cioè, quando legge il dramma,
essere in grado di evocare con verità e vivezza il personaggio voluto del
drammaturgo. Ma questa facoltà spirituale non basta. Le si deve aggiungere anche
il dono (concesso ben raramente dal cielo), col quale l'attore può governare alla
perfezione il suo aspetto esteriore, al punto da dominare con la volontà anche il
minimo movimento: allora la dizione, il passo, il portamento, il gesto non
appartengono più all'attore, bensì alla persona che, creata dallo scrittore, gli si
forma dentro viva e vera e da lui emana così luminosa da far scomparire il suo io,
come fosse una scialba nullità. Rinnegare dunque o, meglio, dimenticare il proprio
io, ecco il primo postulato dell'arte drammatica.
Il Grigio Eh sì, ma quanti sono quelli che possiedono codesta facoltà?
Il Bruno Magnifico dev'essere stato il paese le cui ricchezze furono
spazzate via dal diluvio, ma nella sabbia delle pianure luccicano ancora granelli
d'oro che fanno intuire un tangibile eldorado. Nella facoltà intellettuale si possono
distinguere diversi gradi e, in verità, la sola intima conoscenza dei principali
postulati che si pongono all'attore, il desiderio di attuarli e la buona volontà
dovrebbero ottenere lodevoli effetti, anche se l'attore possedesse quelle facoltà
soltanto in misura limitata. La maggior parte, invece, degli attori, schiavi purtroppo
della volgarità, adattano la parte alla loro individualità, come il sarto adatta al loro
corpo l'abito che devono indossare. Essi vedono non già il personaggio dello
scrittore, ma se stessi, e fanno come uno che dica: «In questa faccenda mi
regolerò secondo il mio carattere e le mie inclinazioni.» E senza rendersene conto
diventano il carattere stereotipato che, mettendosi addosso ogni volta un mantello
diverso, corbella il pubblico. Lo scrittore scompare, poiché, non trovando
nell'attore un'ugola obbediente, a sua volta è obbligato all'obbedienza.
Il Grigio Mi pareva che Lei volesse parlare in favore dei nostri artisti,
invece dalle Sue labbra non ascolto che inconvenienti.
Il Bruno Ho indicato soltanto le rare agevolazioni della natura, il sistema,
grazie al quale l'attore può elevarsi fino a toccare la verità artistica. Assiduità e
intima conoscenza possono molto, ma, come ogni vero artista, anche l'attore
nasce. L'insonne battaglia, per esempio, contro certe particolarità svantaggiose
alla recita può spesso riuscire in modo che proprio di qui sembra derivi una certa
originalità. Sembra, dico, perché questa originalità apparente non è che maniera,
e nessun'arte dev'essere di maniera. Insomma, attori geniali si nasce! Ma siccome
l'economia della Natura non è prodiga nell'assegnare quel dono insigne e
preferisce riservarlo alle creature nate sotto una costellazione particolarmente
propizia, e pertanto un teatro formato tutto di artisti così eccezionali si potrà forse
trovare soltanto in un eldorado celeste, noi direttori dovremo ridurre le nostre
esigenze e badare soprattutto a illudere il pubblico. Beato quel teatro che possiede
due, tre di quei fenomeni! Tanto più che spesso vediamo brillare un'unica stella nel
cielo fosco del teatro!
Il direttore deve perciò apprezzare altamente e coltivare coloro che almeno
sono dotati di vera conoscenza la quale produce serie e sempre benefiche
aspirazioni. Al direttore occorre inoltre l'accorgimento di collocare gli attori, ai quali
manchi del tutto questa conoscenza, ai quali, irretiti nel proprio io, capita di
aggirarsi soltanto nella breve cerchia che i loro deboli occhi possono abbracciare;
di collocarli, dico, in maniera da conseguire mediante la collocazione stessa un
certo effetto. Si tratta di servirsi della personalità di questi attori come d'uno
strumento cieco, inconsapevolmente attivo. Ma quanto perdonabili appaiono tutti
i brutti difetti degli alunni dell'arte se si considera che sono prodotti dal conflitto tra
la loro debole natura e l'arte potente cui cercano di assoggettarsi! Dati questi miti
giudizi, dato il placido riconoscimento del minore ingegno e soprattutto la perfetta
conoscenza di tutte le debolezze dei nostri alunni, la quale ci procura facilmente un
ironico dominio su di esse, non può mancare che il rancore e il dispetto logorante
scompaiano dal nostro cuore. Una volontà salda e incrollabile in cose che
influiscono sul tutto, insieme con una mite, spesso soltanto apparente
condiscendenza in cose secondarie, insignificanti, ma importantissime per gli
irragionevoli, è un buon piedestallo per erigervi il trono del teatro.
C'è bisogno di menzionare i piccoli trucchi, e persino quel tantino di saggia
malizia, di cui il direttore non può fare a meno? Lei ne è informato quanto me; ci
sarà soltanto da aggiungere che i nostri alunni dell'arte e in particolare le nostre
attrici, alle quali si rimprovera di essere puntigliose e lunatiche, in fondo non hanno
malizia e somigliano a bambini cattivi che smettono subito di piangere non appena
si dà loro una bambolina vistosa.
Ma perché mi guarda così scontento? Ha ancora qualche peso sul cuore? O
non è d'accordo con la mia teoria direttoriale ?
Il Grigio Oh, Lei ha espresso esattamente il mio pensiero! Però... Quanto
non ho fatto per conquistare i miei alunni! Ma... lasciamo le lamentele. Perché
dovrei annoiarla con malcontenti che trovano sempre da ridire su tutto, con uomini
che avendo la testa tentennante e le gambe tremolanti vogliono fare ancora gli
amorosi, con donne che, come un orologio italiano fermatosi segnano, nelle loro
parti, sempre le ventiquattro?... Dio mio però, come ci siamo allontanati dal mio
ottimo Caio!
Lei dunque sarebbe del parere che non devo dar retta alla voce pubblica, ma
soltanto a me stesso, e dovrei lasciare che quell'insopportabile vanesio se ne
vada?
Il Bruno Così direi, e senza alcun indugio!
Il Grigio Il pubblico protesterà.
Il Bruno Sì, otto giorni, poi comincerà a rammaricarsi, ad applaudire a più
non posso ogni nota che Caio potrebbe ancora cantare, e se parte davvero... dopo
due settimane sarà bell'e dimenticato.
Il Grigio Dovrò sostenere la prima, la più paurosa burrasca non appena si
saprà che la rappresentazione del Gusmann è sospesa. Il primo a muovere
all'attacco sarà Ampedo con un subisso di rimproveri e insulti. Parlerà di indolenza,
di cattiva volontà ecc. e io dovrò mandarle giù. Alla prossima prova: musi lunghi e
borbottio dei cantanti e delle cantanti che, sì, è vero, hanno sprecato tempo ed
energie per imparare parti difficili che ora non canteranno. Lo stesso vale per il
direttore d'orchestra che, instancabile, col sudore della fronte, ha insegnato ciò
che doveva insegnare, e ora non raccoglierà ciò che ha seminato.
Arriva poi il macchinista: «A che, corpo d'un cane, tutte queste splendide
macchine che non fischiano e non stridono e...» Il parrucchiere si stringe al petto
le parrucche, accarezza il suo Gusmann e lanciandomi un'ambigua occhiata in
tralice sospira: «Così gli ingegni, i genii restano nell'ombra... Che? non si dà l'opera
di Ampedo? Già, così si fa quando si devono mettere in scena opere geniali!»
Seguono villanie che colpiscono me, me solo, il vero innocente.
Il Bruno Veda di placare il pubblico con qualche novità interessante,
magari di minimo valore. Gli presenti un giocattolo luccicante e vedrà che la
burrasca passerà rapidamente. Oppure, che ne direbbe se sfruttasse il cane?
Ormai è istruito per il teatro.
Il Grigio Magnifica idea! Ma il talento del cane è unilaterale. Non sarà
facile che apprenda in fretta una nuova parte.
Il Bruno Mantenga quello che sa, infili la sua scena in un dramma non
conosciuto del repertorio corrente. Ci sono lavori teatrali, nei quali si può inserire
quel che si vuole. Che ne dice? se introducesse qualcosa di genialmente canino
nelle Parti di prova, nell'Attore suo malgrado o in simili proteiformi lavori?
Il Grigio No, non si può. Il cane è troppo addestrato alle scene
sentimentali. Potrebbe, se mai, figurare in Misantropia e pentimento come
cagnolino e protetto di Eulalia e assalire felicemente lo sconosciuto, il suo ex
padrone, diventatogli antipatico da quando ripudiò la moglie. Questa salva il
marito dalle zanne del cane: sarebbe una scena commovente!
Ma il dramma è ormai invecchiato e, con esso, le Eulalie. Forse potrebbe
presentarsi bene nella Edvige, ringhiare e mordere e inferocire con garbo nella
Furia dei partiti.
Il Bruno Faccia Lei come crede meglio, ma in genere io consiglierei di
dare alle scene del cane un accompagnamento musicale, perché, pur non essendo
un cantante famoso, dev'essere pur avvezzo alla musica.
Il Grigio Oh, adesso riconosco in Lei il più esperto maestro nell'arte di
cuocere e servire in tavola le pietanze teatrali... Ma ora mi troverò in grande
imbarazzo con attori e attrici che non vogliono mai quello che voglio io. Sono
sempre discordi, ma diventano tutti d'un pensiero quando si tratta di opporsi al
mio volere e di sventare i miei progetti.
Il Bruno Sfortunato Lei se la sorte ostile ha voluto che Lei raccogliesse
sotto un capo tante teste irrequiete e ostinate!
Il Grigio Non creda però che non mi sia mai riuscito di legare a me artisti
capaci di unire alla loro arte un'equa mentalità e un'onesta diligenza, benché, direi
quasi, ognuno di essi abbia anche qualche difetto. Con tutta l'anima, per esempio,
mi è affezionato l'attore che impersona caratteri in modo così egregio da meritare
di essere il beniamino del pubblico, in quel senso superiore che Lei ha descritto
dianzi. Egli prende l'arte sul serio, e di lì viene l'instancabile assiduità con la quale
non solo studia le parti ma le accoglie nel proprio intimo. Se non che la perfetta
riuscita della recita non è mai completamente sicura, perché un'inspiegabile
irritabilità, prodotta da una grande diffidenza e da un profondo malumore, gli può
far perdere le staffe in un baleno: la diffidenza non solo verso gli altri, ma anche
verso se stesso. Un attacco suggerito al momento sbagliato, l'entrata intempestiva
di un personaggio, persino la caduta d'una spada, d'un candeliere ecc. durante il
monologo, soprattutto un bisbiglio vicino, nel quale egli crede per lo più di udir
pronunciare il suo nome, ogni possibile debolezza umana e non so quali
avvenimenti casuali, tutti sono, secondo lui, voluti, calcolati disturbi delle sue
recite; così, sotto i morsi della stizza, s'imbroglia e poi s'infuria, anche contro amici
a lui devoti. Se la prende anche con se stesso quando s'impapera o nella propria
recita gli pare che qualcosa sia fuori di posto.
Il Bruno Dio del cielo, Lei mi descrive esattamente quell'ottimo attore che
per vari anni venne da me con la primavera, perché poi si trovava a suo agio nella
serena regione meridionale dove lavorava la mia compagnia. Il malumore del
quale era vittima, non aveva quel fondamento fisico che egli immaginava; invece,
come spesso accade, la volontà non ancorata alla vita assieme alla non raggiunta
conoscenza del fine prefisso, della meta delle sue aspirazioni, erano la causa
meramente psichica di quel malumore. Con la sua diffidenza o, meglio, col
sospetto, al quale Lei accennava dianzi, quell'attore arrivava al punto da prendere
i fatti più futili, più estranei alla recita, per frecce scoccate maliziosamente contro
di lui. Una sedia spostata in un palco, una parola scambiata sottovoce tra gli
spettatori, che pur essendo quasi impercettibile egli udiva con Dio sa quali
orecchie o magari vedeva soltanto, mentre in un punto saliente portava la sua
voce al massimo volume, bastavano per farlo uscire talmente dai gangheri che
qualche volta s'interrompeva e lanciando insulti villani usciva di scena.
Io stesso l'ho visto nella parte di Re Lear; nella scena della maledizione,
mentre recitava, come tutto il resto, come tutta la parte, con vigore e verità
travolgente, si fermò all'improvviso, abbassò lentamente il braccio che aveva
alzato, rivolse lo sguardo ardente verso un palco dove un paio di ragazze
discorrevano, benché molto piano, probabilmente di qualche importante novità
della moda, poi, avanzando fino alla ribalta, abbozzò un inchino verso quel palco
disgraziato e disse con voce ben chiara: «Quando le oche schiamazzano, non
tocca a me parlare!» E misurando i passi uscì. Si figuri le proteste del pubblico e le
scuse formali che egli fu costretto a presentare!
Poco fa si è parlato delle chiamate. Ora, per il mio uomo non c'era niente di
più insopportabile che essere applaudito e chiamato quando reputava di aver
recitato male la sua parte.
Una volta recitò egregiamente l'Amleto, ma secondo lui qualche passo non
gli era riuscito; ebbene, ancora mi pento di averlo spinto, nonostante il suo rifiuto,
a presentarsi al pubblico acclamante. Eccolo: si avanza lento e patetico fino ai lumi
della ribalta, gira lo sguardo stupefatto sulla platea e lungo i palchi, alza poi gli
occhi al cielo, incrocia le braccia sul petto e con voce solenne esclama: «Signore,
perdona loro perché non sanno quel che si fanno!»
Queste parole, come può immaginare, provocarono un fragore assordante di
fischi e sibili e batter di piedi. Lui invece, come liberato da un gran peso, se ne
ritornò gentile e allegro nel suo carnerino!
Il Grigio No, il mio diletto caratterista non arriva a questi eccessi. Vero è
che quando vuol recitare o ha recitato una parte importante non la smette di
parlarne e di chiedere com'è andata. È un effetto della diffidenza, che lo onora,
perché è indizio dell'autentico artista.
Il Bruno Giusto. Soltanto gli insulsi mestieranti sono sempre d'accordo
con se stessi, sempre soddisfatti di ciò che dà il loro diletto io. Non può darsi artista
senza la chiara visione di un ideale irraggiungibile, senza l'indefessa tendenza a
conquistarlo. Ma questa diffidenza non deve degenerare in malumore né diventare
ipocondria e tortura tale da paralizzare le energie creative. Nel momento della
creazione l'entusiasmo deve sollevarsi con serena naturalezza; basta che
l'intelletto tenga salde le redini. Nell'attore, del quale ho parlato, la diffidenza e il
malumore erano degenerati in una vera malattia psichica. Gli capitava infatti, nelle
notti insonni, di udire intorno a sé conversazioni sul conto suo, piene generalmente
di amare osservazioni sui difetti delle sue recite. Mi riferiva poi ogni cosa, con mio
grande stupore, perché ci trovavo la più sottile critica artistica, la più acuta
intuizione dei particolari, eppure per dirla con Schubert,* tutto era un prodotto del
«poeta interiore».
Il Grigio Della coscienza parlante, dica piuttosto! Della profonda
coscienza, espressa in parole, del proprio io e della propria indole. Lo «spirito
familiare» balza dall'intimo ed, essere autonomo, parla con frasi sublimi. Dio
buono, vorrei che tutti i miei attori e le mie attrici possedessero un diavoletto così,
che li scrollasse!
Il Bruno Ci vorrebbe un orologio di Re Filippo.
Il Grigio Che orologio è quello di Filippo?
Il Bruno Filippo di Macedonia si faceva dire ogni giorno: «Tu sei un
uomo!» Ciò suggerì al più umorista di tutti gli umoristi tedeschi (occorre dire che
alludo a Lichtenberg?) la luminosa idea degli orologi parlanti. Ricorda?
Il Grigio Orologi parlanti? Di questa idea ho soltanto un ricordo molto
vago.
Il Bruno Ci sono orologi a cariglione che al primo quarto suonano un
quarto d'un brano musicale, alla metà la metà, ai tre quarti i tre quarti; all'ora
l'intero brano. Ora, dice Lichtenberg, sarebbe bello che, mediante un meccanismo
particolare, l'orologio pronunciasse le parole «tu sei un uomo», ma
suddividendole, come il pezzo di musica, in quattro parti. Al primo quarto l'orologio
dice: «Tu», al secondo: «Tu sei», al terzo: «Tu sei un» e allo scoccare dell'ora la
frase intera. Lichtenberg aggiunge giustamente che le parole ai tre quarti: «Tu sei
un» darebbe modo, per un quarto d'ora, di riflettere che cosa uno sia realmente.
Pensò in verità che questo esame, a cui uno sarebbe costretto tra sé e sé,
risulterebbe per più d'uno, noioso, angoscioso, inquietante.
Il Grigio Ma ancora non ho capito come il Suo filippico orologio...
Il Bruno Immagini che un siffatto orologio meccanico stia nella sala delle
riunioni... immagini che un borioso attore, paludato da eroe, da re, si pavoneggi
davanti al grande specchio e sorrida compiaciuto al dio che scintilla dai suoi occhi,
che aleggia sulle sue labbra, che gli pieghetta l'antica gorgera tedesca o gli
aggiusta le pieghe del manto greco... un momento prima il dio ha lanciato forse i
suoi fulmini su un poveraccio di collega... forse ha tuonato brutalmente... o sfidato
il direttore a un'inutile battaglia... forse è gonfio del dolce nettare che la propria
stupidità gli ha porto... I lumi sono accesi, gli strumenti si fanno sentire
nell'orchestra... sono le cinque e tre quarti... Ed ecco la voce lenta e cupa
dell'orologio: «Tu sei un». Non crede che il dio si sentirà un po' a disagio? Non
potrebbe darsi che a quel monito spettrale gli venga in mente qualche dubbio, o
debba chiedersi se egli non sia qualcosa di diverso da un dio?
Il Grigio Secondo me, il Suo attore completerebbe senz'altro il «Tu sei
un» con le parole: «grande insuperabile genio... sovrano del mondo teatrale...
virtuoso stupendo».
Il Bruno No, no! Ci sono momenti nei quali un potere misterioso sfronda
d'ogni orpello anche il più vanitoso egoista, costringendolo a vedere chiaramente
e a riconoscere la sua meschina nudità. In una notte di tempesta, per esempio,
nell'afa e nella veglia, l'io si comporta spesso in modo ben diverso che di giorno.
Quanto più a un tale inatteso monito spettrale che echeggia nell'anima come un
colpo di martello contro una campana metallica!
Ma ritorniamo al Suo attore dalla coscienza parlante. Lei ha detto poco fa che
merita di diventare il beniamino del pubblico all'alto livello degli Eckhoff, degli
Schröder, dei Fleck: in questo caso Lei è davvero un direttore invidiabile, se può far
brillare una stella così nel firmamento teatrale.
Il Grigio Non dirò mai abbastanza bene del mio caratterista. A lui devo se,
di fronte alle continue richieste di novità, posso imbandire al pubblico, senza
correre imminenti pericoli, gli insignificanti prodotti di menti oziose, gli sciocchi,
così detti «drammi da cassetto», le variazioni, ripetute fino alla nausea, di uno
stesso misero soggetto, le superficiali traduzioni di insipide abborracciature
francesi.
Il mio piccolo Garrik, infatti, riesce sempre a ricavare dalla vita vissuta un
personaggio per la sua parte, e a rappresentarlo con vivezza e verità, in modo che
per merito suo la figura incolore del poeta acquista forma e colore, e alla vista di
questa figura si dimentica volentieri la miseria del quadro complessivo, anche se
questo, svigorito dalla interiore impotenza, si estingue rapidamente e precipita
nell'Orco.
Il Bruno Sicché il Suo piccolo Garrik (per usare la Sua definizione) si
investe continuamente di parti prive d'importanza e deve affannarsi a rinfrescare
figure esangui?
Il Grigio Certo, non passa settimana senza che non debba sobbarcarsi a
parti di questo genere.
Il Bruno E non protesta? E le accetta?
Il Grigio Col massimo piacere. Se la gode persino a istillare nell'inanimato
personaggio dello scrittore o, meglio, del produttore la scintilla di Prometeo, e mi
pare cosa da lodare.
Il Bruno A me pare invece cosa riprovevole! In genere, se è come dice
Lei, attribuirei al Suo piccolo Garrik più ingegno che vero e artistico genio, a meno
che un'esagerata bonarietà o un puerile diletto ai lampi sgargianti d'un fuoco
d'artificio, che in pochi istanti sfuma senza effetto, lo inducano a immergere il
pugnale nel proprio cuore.
Lei, mio caro collega, invece di dargli una mano in questa pericolosa
tendenza, dovrebbe opporsi con tutta la Sua energia, perché - mi scusi - altrimenti
fruga dentro le Sue proprie viscere o, favorendo quel suicidio, ingolla una
qualunque acqua tofàna e va a morire miseramente prima del tempo.
Il Grigio Come mai? Non capisco. Lei parla per enigmi.
Il Bruno I cernecchi grigi sulla mia testa, le rughe sulla fronte e sulle
guance non dovrebbero scusarmi se, conversando con Lei, egregio collega, mi
accade talvolta, senza volere, di montare in cattedra? In genere, La prego di
accogliere tutto ciò che dico come giudizio mio personale, della cui giustezza, io,
vecchio, non dubito perché mi sembra il risultato d'un'esperienza di lunghi anni!
A me sembra pertanto che il Suo Garrik, se non ha solo ingegno, ma
veramente genio, depresso forse da qualche circostanza, di quelle che
l'insufficienza della vita terrena ci reca, non possieda quella inflessibile forza
interiore che è propria degli uomini geniali; altrimenti si opporrebbe con tutta la
sua energia a ogni tentato abuso del suo genio.
Il Grigio Per carità, sono ben contento che gli manchi codesta energia, la
quale sarebbe la mia rovina.
Il Bruno Zitto! Un momento! Mi lasci finire! Niente accade più facilmente
se non che attori di questo genere - figli di Apollo che portano l'arco del padre
divino senza mai tenderlo - si avvezzino al peggio e si accontentino anche di ciò
che non è degno del loro genio. E questo atteggiamento paralizza sempre più la
loro forza e ben presto non sono più capaci di aprire le ali per voli più alti. La loro
più pericolosa illusione consiste in questo: che plasmano personaggi propri e li
inseriscono in un'opera della quale non possono essere entusiasti, sicché, per
usare un paragone musicale, eseguiscono un assolo inventato da loro, nel quale
altri intervengono con accordi arbitrari, senza curarsi dell'effetto. Perdono la
consuetudine di aprire il loro cuore ai raggi della vera opera poetica, affinché il
fantastico personaggio del drammaturgo vi si accenda e fiammeggi di vita
incandescente. Dirò di più. Sguazzando sempre nel pantano il viandante stanco e
seccato finisce col dubitare che esistano ancora alture con l'erba fresca e
verdeggiante, e ne perde il senso e il gusto.
Conviene essere pratici. Il Suo Garrik, avvezzo, e anzi chiamato a
rappresentare sempre invece delle parti assegnate, personaggi creati da lui, deve
attenersi a questi senza badare minimamente a quelle. In questo modo
disimparerà a studiare la parte, quand'anche sia notevole. D'altro canto non riesco
a capire come mai un uomo ragionevole possa mandare a memoria le noiose
assurdità di tante tragedie e commedie, ma è evidente che presto quell'attore non
sarà in grado di imparare a memoria e non potrà dedicarsi a capolavori, specie se
scritti in versi. Legato al successo del momento, Lei perde i valori durevoli. Perde
gli ingegni che erano l'ornamento del Suo teatro. Altri attori, meno dotati, non
mancheranno di alimentare le Sue convinzioni con benevoli consigli, con
osservazioni sopraffine, e occuperanno pian piano il posto lasciato dai pericolosi
rivali. Essi però cercheranno invano di conquistare il favore del pubblico che il
maestro, superiore a loro, ha perduto. Sì, ripeto, perduto, perché, creda a me, il
pubblico arriva presto al punto di prendere il diamante, che ogni giorno gli viene
mostrato sotto luce falsa, per un volgare ciottolo.
Il Grigio
C'è del vero nelle Sue parole, me ne rendo conto, ma anche, date
le attuali condizioni del nostro teatro, l'impossibilità di tener occupato il geniale
versatile attore con sole parti importanti. Lei è direttore di teatro, La prego di
considerare la povertà del nostro repertorio, e non occorre che Le dia altre
spiegazioni.
Il Bruno Non creda che io voglia a tutti i costi vedere in scena il Suo Garrik
soltanto nelle così dette prime parti. Ci sono molte cose che, senza un aspetto
esteriore abbagliante, si sviluppano da motivi profondi. Secondo la volontà
dell'autore e piuttosto secondo le esigenze dell'opera, una parte apparentemente
secondaria deve talvolta sostenere l'intera opera, in quanto proprio nei momenti di
questa parte coincidono le fila tese da ogni lato: e chi se non un genio può
rappresentare una tal parte? Nossignore: del vero genio, ripeto, non si abusi mai
per gli effimeri effetti della giornata, che mirano soltanto al solletico momentaneo
anziché alla vera commozione. All'artista serio e profondo si affidino soltanto parti
profonde, serie, vere, di qualunque forma siano, magari scherzose, frutto della
baldanza d'uno spirito ardito.
Il Grigio Lei mi sfugge ignorando le condizioni del nostro teatro, da me
ricordate. Se Lei le considera come si deve, ammetterà che un attore versatile
deve abbassarsi a contribuire agli effetti della giornata, qualunque forma essi
assumano.
Il Bruno Chi è, secondo Lei, un attore versatile?
Il Grigio Che domanda! Versatile chiamo quell'attore che recita parti
comiche e tragiche con la stessa forza e verità.
Il Bruno Io non credo in codesta versatilità, a meno che non s'intenda il
comico in un senso superiore.
Il Grigio Come?... Eppure non mancano esempi di questo genere.
Il Bruno Permetta che mi spieghi meglio! Se con la parola versatilità Lei
indica quella forza, insita nell'attore, in virtù della quale egli, rinunciando alla
propria persona, si presenta di volta in volta col peculiare carattere della sua parte
e come Proteo appare sempre diverso, sono d'accordo con Lei, non solo perché
questa qualità rivela appunto la genialità dell'attore, ma perché, grazie al cielo,
siffatti attori esistono ancora. Ma il fatto che Lei ha menzionato il comico in antitesi
al tragico, mi fa pensare che dicendo versatile Lei condivida l'idea che ne ha la
gente comune. Si ammira a bocca aperta, con stupore, si proclama grande,
insuperabile, quell'artista che come un abile giocoliere versa dalla medesima
bottiglia vino bianco e vino rosso, liquore e latte. Colui che oggi è Macbeth, domani
il sarto Wetzwetz, che oggi fa la parte del padre di famiglia, domani quella di Franz
Moor. «Ecco un genio versatile, multiforme, poliedrico!» esclama l'onesta
plebaglia accettando di buon grado la mistificazione, e magari credendo che quel
diavolo di raffinato giocoliere possa realmente essere padrone della sua bottiglia,
e, nonostante gli sia stata empita dal suo vinaio, ne possa spillare a suo
piacimento, per magica virtù, qualunque altro principio fluido.
Il Grigio Lei ha scelto come esempio parti che formano i più violenti
contrasti, eppure ho visto attori eccellere proprio in siffatti contrasti.
Il Bruno No, no e no! Non è possibile. O è falso l'uno o è falso l'altro.
All'attore, nel cui petto alberga il meraviglioso mistero dei poemi attinti dai più
profondi abissi della natura umana, sfugge la celia che, frutto di spensierato
arbitrio, vagola senza patria via per l'aria. Nello sforzo di attirare nell'intimo il
farsesco che ha le radici soltanto nel mondo esterno o, meglio, di plasmarlo
dall'interno, la figura burlesca sfuma nella nebbia. L'attore, intendo, non sarà
capace di rappresentare qualcosa che non abbia il fondamento nella vita interiore
e non provenga da questa; nello stesso modo che all'attore, che non possieda la
profonda nozione della natura. umana, che prenda per uomini vivi e veri le
caricaturali marionette di qualche capriccioso burattinaio, resterà precluso per
sempre il territorio del vero poeta. Ma anche per questo attore c'è un virtuosismo
che, per quanto possa sembrare strano, consiste nella fedelissima e spregiudicata
rappresentazione di quelle marionette, la quale con una profonda intuizione del
vero diventerebbe impossibile. Ora, l'uno e l'altro attore, nel loro contrasto,
devono diventare non veri, in quanto quello si sforza di ridare per vera la figura
burlesca e questo, per rappresentare personaggi vivi, prende a prestito dal mondo
esterno i mezzi che si trovano soltanto nell'interno. E non basta. L'artista che si
aggira nella vita profonda conferisce istintivamente alle cose volgari un aspetto
superiore, mentre l'altro veste la volgarità col solo involucro del mistero a lui
precluso. In questo modo i personaggi di entrambi si presentano in una strana
ambiguità. Se Raffaello avesse dipinto una scena di nozze rurali, vedremmo
apostoli in giubba campagnola, come in una deposizione di Tenniers ci sarebbero
certamente vispi contadini, usciti dall'osteria col naso rosso, che in abito talare
porterebbero al sepolcro nostro Signore.
Il Grigio Tutte belle cose, dette con acume, ma io resto del parere che
l'esperienza è contro di Lei. Possibile che in un'anima ricca non alberghi il senso del
comico e del tragico? Possibile che una fantasia fervida e vivace non sia in grado
d'intendere e rappresentare con uguale intensità l'uno e l'altro? Possibile che
artista e scrittore, i quali possiedono la massima serietà, la più toccante ironia,
come Shakespeare...?
Il Bruno Alto là! Ho forse parlato del comico vero e proprio? Con le parti
che ho contrapposto a titolo di esempio non ho forse fatto capire abbastanza che
alludevo soltanto allo scherzo da nulla, al farsesco, che d'altro canto non intendo
affatto di ripudiare quando sia rappresentato con estrema libertà? Tanto è vero
che anche in animi più elevati persino la smorfia può suscitare un momentaneo
solletico che non è da buttar via.
Il Grigio Ecco, Lei cerca di evadere!... Lei si ritira.
Il Bruno Niente affatto. Parliamo pure, se vuole, del comico vero e
proprio! Chi vorrà mai negare l'ironia che è radicata profondamente nella natura
umana, che anzi è un presupposto dell'intima natura dell'uomo, donde con la
massima serietà sgorgano lo scherzo, la freddura, la malizia? «Voler ignorare nelle
cose più sacre e più gentili l'arguzia e la malizia della natura è probabilmente
possibile solo quando si diventa certosini e del tacere, del silenzio si fa una
professione»: così dice Tieck nell'Introduzione al Phantasus, sia pure ad altro
proposito. I convulsi sussulti del dolore, i più laceranti lamenti della disperazione
sfociano nella risata del meraviglioso piacere, prodotto un momento prima dal
dolore e dalla disperazione. La perfetta conoscenza di questo strano organismo
della natura umana vorrebbe essere precisamente quello che chiamiamo
umorismo, e così si determinerebbe da sé l'intima essenza dell'umorismo che,
secondo me, s'identifica col comico vero e proprio. Ora faccio un passo avanti e
affermo che appunto quella conoscenza o quasi dell'umorismo alberga nel petto di
quell'attore che attinge le sue rappresentazioni dalle profondità della natura
umana. Ne segue ovviamente che questo attore molto dotato reciterà con ugual
forza e verità parti comiche e tragiche: raggi emanati da un unico centro.
Il Grigio Adesso mi pare di capir bene il suo concetto e ammetto
umilmente di aver confuso il vero comico col farsesco o, meglio, di aver collocati
entrambi in una medesima categoria. Ho fatto il nome di Shakespeare, e ora vedo
con chiarezza che i suoi personaggi sono animati precisamente da quell'umorismo,
del quale Lei ha fissato il concetto.
Il Bruno Certo. Nessun poeta ha mai saputo vedere nel profondo e
concretare la natura umana come Shakepeare; perciò i suoi caratteri
appartengono al mondo e durano finché esistono uomini nel tempo. Ai suoi matti
egli affidò il compito di proclamare a gran voce il vero e proprio umorismo che è il
comico e il tragico insieme. I suoi eroi recano poi tutti l'impronta di quell'ironia che
spesso, nei momenti più elevati, si esprime in spiritose fantasticherie, come
d'altronde i suoi caratteri comici hanno una base tragica. Pensi al Re Giovanni, a
Lear, al divertente Malvolio, la cui buffa stramberia è frutto d'un'idea fissa che
s'annida in lui e gli turba stranamente i sensi. È superfluo citare Falstaff, portento
della più stupenda ironia e del più dovizioso umorismo. Quale forza irresistibile,
quale potere sull'animo dello spettatore dovrebbe possedere l'attore che fosse
animato da un vero intimo umorismo, e cui il cielo avesse largito il dono di
estrinsecare e proiettare nella vita esteriore questo umorismo attraverso la parola,
il tono, il gesto! Lei possiede una fenice se il Suo piccolo Garrik è realmente di
questa costituzione, mentre io forse ne dubito a torto, come dubito di tutte le
meraviglie che, chi sa? si sono avverate o si avverano nella realtà. Devo dire che,
almeno in questi ultimi tempi, non ho trovato un siffatto eroe.
Il Grigio In questo momento mi sorge qualche dubbio contro il mio
piccolo Garrik, e perciò Le ricordo subito il vecchio grande Garrik, che era
certamente un attore animato da quel vero profondo umorismo che Lei vorrebbe.
Il Bruno Nonostante la intelligente descrizione che Lichtenberg ci dà della
recitazione di Garrik; nonostante lo spiritoso entusiasmo col quale parla della
pieghetta che nel nero abito di gala, di taglio francese, si formava sotto la spalla
sinistra, quando Garrik lottava con Laerte nella fossa di Ofelia; nonostante tutti gli
aneddoti che si raccontano delle magie di Garrik, ecco, quando penso a tutta la sua
personalità, non riesco a farmi un'idea chiara della sua recitazione tragica.
Il moretto di Hogarth in La via della cortigiana, il quale si spaventa al
rovesciarsi del tavolino da tè, è, come tutti sanno, Garrik nella parte di Otello; e io
confesso che questa beffa mi guasta un po' troppo la figura di Garrik. E qui mi
viene in mente che la recita dell'Otello da parte di Garrik deve aver presentato
qualche guaio, altrimenti Hogarth non sarebbe arrivato a questa idea. Ma,
comunque sia, sembra accertato che sul terreno umoristico Garrik sia stato
superato da Foot.
Il Grigio Ma a quale breve cerchia di parti tragiche e comiche dovrebbe
limitarsi l'attore umoristico, se rifiutasse tutto ciò che non nasce dal vero
umorismo. Le sue esibizioni finirebbero col formare una galleria shakespeariana, e
Lei, penso, sarà d'accordo con me che, data la trista tendenza del nostro teatro, è
ben difficile portare quel gigante sul palcoscenico, troppo fragile per sostenerlo.
Il Bruno Bisognerebbe posare travi robuste sotto le sottili assicelle dei
nostri palcoscenici. Ma per siffatte armature, che pur si fanno sempre più
necessarie, ci manca l'abilità e soprattutto il coraggio. Ma, prescindendo da ciò, la
cerchia delle parti da Lei indicate non dovrebbe risultare ristretta come si potrebbe
pensare.
Lei mi ha rimproverato perché, impugnando la vantata versatilità di certi
attori, avrei scelto esempi troppo smaglianti di parti eterogenee. Mi permetta ora
di accennare a due parti che formano il più vivo contrasto, eppure possono essere
rappresentate dal medesimo attore veramente geniale con uguale efficacia e
verità. Intendo l'Otello di Shakespeare e l'Avaro di Molière.
Il Grigio Che affermazione! Come si accorda coi principi da Lei formulati?
Cioè, sento vagamente che Lei può aver ragione, e Le sarei grato di maggiori
spiegazioni.
Il Bruno In entrambi, nell'Otello e nell'Avaro, si agita una passione che
dall'intimo sale alle più paurose altezze, l'uno compie l'azione più orrenda, l'altro,
in preda al più odioso sospetto contro tutto il genere umano che egli reputa
congiurato contro di lui, calpesta i più sacri rapporti che la natura e la vita civile
abbiano stabiliti. Soltanto per l'individuale interpretazione della passione di
ciascuno crea la diversità del loro aspetto e determina il tragico o il comico. Amore
e onore esaltano il Moro magnanimo, solo il folle piacere del vile denaro anima
l'Avaro. Entrambi, colpiti nell'intimo, urtati nel vivo della loro natura, esplodono in
dissennato furore, e in questo loro aspetto più acuto i raggi prorompenti da loro
con rifrazione diversa convergono in un fuoco suscitando nel cuore dello
spettatore là tragica stupefazione, qui ironiche risate. Chi non si sente preso da
profondo orrore alle tremende parole di Otello: «Spegni la luce!» E chi, mentre
ride, non proverà anche orrore quando l'Avaro, nella sua follia, afferra il proprio
braccio credendo di acciuffare il ladro che gli ha rubato la cassetta, e quando nella
sua disperazione cerca il traditore persino tra gli spettatori?
L'Avaro di Molière è un carattere veramente comico, del quale il vuoto
Arpagone, trasportato sul piano della comune volgarità, non dà un aspetto
adeguato, come il modo in cui un grande attore, da poco defunto, lo presentava,
fu una delle più curiose aberrazioni che possano darsi.
Qui mi lasci ricordare un carattere shakespeariano in cui il tragico e il comico,
convergendo pienamente, producono l'orrore: Shylock. Di questa difficilissima fra
tutte le parti difficili, fondate su siffatti elementi, si è parlato tanto che le mie
osservazioni arriverebbero troppo tardi. Ma Lei mi concede che questa parte
risponde alla mia teoria delle parti intimamente comiche e può essere recitata con
efficacia e verità soltanto da un attore che sia effettivamente unilaterale o
bilaterale come intendo io.
Il Grigio E proprio questa parte che Lei comprende nella categoria delle
più difficili viene recitata dal mio piccolo Garrik così egregiamente che competenti
di difficile contentatura non gli hanno mai negato i più calorosi applausi. In fondo,
se vogliamo, questo Shylock è un eroe ebreo, poiché l'odio profondo e feroce
contro i cristiani si fa patetico in quanto elimina ogni altra passione e genera la
tremenda vendetta cui l'ebreo sacrifica denaro, averi e la figlia. La sua rovina è
veramente tragica e forse più terribile della rovina di altri eroi o tiranni. Che cos'è
il tossico o la pugnalata, di fronte alla totale distruzione della vita civile, che viene
inflitta all'ebreo e gli consuma le viscere come un lento veleno? Quando il mio
Garrik dice: «Non sto bene...» tutti gli ascoltatori, la cui indole non sia molto
robusta e impenetrabile, si sentono certamente scossi da un brivido gelato.
Il Bruno Che dire della scena dove l'ebreo disperato invoca la figlia e i
propri ducati e dove gli si annuncia la disgrazia di Antonio, che è ristoro al suo
cuore, e intanto deve udire notizie di Jessica che gli straziano il petto?
Il Grigio Vedo dove vuol arrivare. Proprio in queste scene è più che mai
difficile conservare puro ed efficace il personaggio sullo sfondo cangiante. Lo
spettatore deve ridere dell'ebreo senza che questi sia affatto ridicolo. Proprio in
queste scene il mio Garrik supera un grande attore che una volta vidi recitare
questa parte, cadendo in una volgare imitazione degli ebrei e straziando così tutta
la sublime poesia della parte. Probabilmente fu traviato dall'esperienza fatta nella
vita comune, secondo la quale gli ebrei, quando sono travolti da una passione,
mutano stranamente la voce e il gesto, e assumono atteggiamenti buffi che
muovono irresistibilmente le risa. E come s'intona tutto ciò a Shylock, il cui
linguaggio è sufficientemente caratterizzato da una più aspra pronuncia, da una
sfumatura di ebraico. Il mio attore è sicuro padrone di quelle reminiscenze
orientali che conferiscono alla parte di Shylock un'enfasi singolare.
Il Bruno E da questo Shylock non è che un passo fino a quelle
meravigliose parti shakespeariane che si basano sull'umorismo in un senso diverso
o, meglio, più stretto. Il sentimento della sproporzione tra lo spirito e la vita
terrena che si agita intorno genera la morbosa sovreccitazione che prorompe in
amare beffarde ironie. È il solletico convulso che l'animo dolorosamente colpito e
ferito percepisce, e il riso non è che la dolorosa espressione della intima nostalgia
della propria origine. Siffatti caratteri sono il buffone nel Re Lear, Jacques in Come
vi piace, ma sulla più alta vetta sta l'incomparabile Amleto. «È un animo troppo
debole da portare ciò che il destino gli ha imposto,» si dice non so dove, e io
aggiungo che Amleto appare tentennante e irresoluto specialmente a causa del
profondo sentimento di quella sproporzione che nessun atto può spianare, talché
finisce soltanto col proprio terreno tramonto. Ora, questo è l'Amleto che in verità
solo l'attore pervaso dal più profondo umorismo può rappresentare. Non ho
ancora visto nessuno che recitando questa parte non si sia sperduto in falsi
meandri o almeno non abbia sbagliato questa o quella parte integrante del
carattere, non presentando quindi nessun carattere. Con particolare riferimento
all'Amleto ripeto ciò che ho detto dianzi. Quale potere irresistibile dovrebbe
esercitare sull'animo dello spettatore quell'attore cui fosse largito il dono di
proiettare nella vita esteriore l'intimo vero umorismo attraverso la parola, il tono,
il gesto!
Intorno a quali parti furono scritte più cose sagge, profonde e stupende, che
proprio intorno all'Amleto? Non è possibile, credo, dare su questo argomento
lezioni più pratiche di quelle che si leggono nel Guglielmo Meister, ma che giova la
lezione di ballo a chi è zoppo?
Il Grigio Non si è accorto che Lei parla sempre e soltanto di Shakespeare?
L'esperienza non ha insegnato a Lei, come a me, che, ripeto ancora una volta, la
rappresentazione di drammi shakespeariani è un affar serio? Creda a me, il genio
di Shakespeare ha afferrato anche me, anch'io leggendo parecchi suoi drammi
pensai che dovessero produrre effetti titanici e travolgere ogni cosa. Io non ho
scansato fatiche, non ho lesinato scenari e vestiario, non ho limitato le prove, ho
cercato di entusiasmare ciascun attore per la sua parte, tutti recitavano bene, non
dico di no, ma il dramma non faceva alcun effetto o almeno non faceva
quell'effetto che giustamente avevo creduto di potermi ripromettere.
Il Bruno E alla fine ha perduto la voglia e l'amore, vero?
Il Grigio Non lo posso negare. Non sono più i tempi del teatro
shakespeariano, me ne sono convinto da un pezzo.
Il Bruno Ha mai dato un'opera di Shakespeare pienamente conforme
all'originale?
Il Grigio Eh sì... beninteso coi soli mutamenti che l'organizzazione del
nostro teatro e la chiarezza esigevano. Alcune scene vennero soltanto spostate,
altre, troppo lunghe, accorciate...
Il Bruno Ahi! Ahi!
Il Grigio Lei non approva? Ma, mi dica, come si fa quando, per esempio,
come accade spesso in Shakespeare, c'è un improvviso mutamento di scena e lo
spettatore è trasportato in un luogo lontano per ascoltare un breve discorso o un
breve dialogo, dopodiché la scena muta di nuovo e tutto procede sul binario di
prima?
Il Bruno Quando, mio caro amico, durante la lettura di un dramma
shakespeariano le capitò d'incontrare una così fatta scena, non si è mai messo
mentalmente davanti, anziché sopra il palcoscenico? Se avesse fatto così avrebbe
sentito molto chiaramente la necessità di quella scena che a prima vista le era
parsa piovuta dal cielo. Per preparare svolgimenti successivi poteva essere
necessario rammentare qualcosa allo spettatore o buttare là una favilla che più
tardi divamperà.
Non c'è errore più grave che quello di credere che Shakespeare, trascinato
dall'entusiasmo del momento, anzi dominato dal fantasma che lo spirito in
fermento stava generando, abbia buttato giù le sue opere con sregolato arbitrio.
«Il genio,» dice un profondo conoscitore dell'arte,* «agisce con certezza e in
libertà anche quando è preso dal più alto entusiasmo. Il suo soggetto lo pervade,
lo innalza, lo ispira, ma non lo domina.» Quanto ciò possa dirsi di Shakespeare è
provato nel modo più convincente dal fatto che proprio nel punto più difficile di
ogni opera drammatica, nel punto che presuppone il più limpido accorgimento, il
perfetto dominio della materia e della sua struttura, la maestria del poeta appare
quanto mai luminosa. Alludo all'esposizione dell'antefatto. Pensi alle prime scene
di Giulio Cesare, di Amleto, di Otello, di Romeo e Giulietta ecc. È mai possibile
afferrare il pubblico con maggior vigore fin dai primi momenti, trasportarlo in altra
maniera subito medias in res, al centro dell'azione?
Il Grigio
Eppure persino grandi poeti hanno introdotto molti mutamenti
proprio nell'esposizione dell'antefatto; Romeo e Giulietta, per esempio, è apparso
in forma, del tutto diversa.
Il Bruno Be', non parliamo di questo inesplicabile passo falso! Il
rimaneggiamento, a cui Lei allude, mi è sembrato una beffa atroce dei nostri
palcoscenici. Passiamo subito all'Egmont, la cui magistrale esposizione è degna di
Shakespeare. Il sipario si alza non già perché si debbano ascoltare lunghi racconti
di cose che non ci riguardano; noi stessi invece entriamo nel tempo del dramma,
davanti ai nostri occhi avvengono cose dalle quali l'azione sboccia come da un
germe fecondo e si sviluppa fino alla conclusione. Chi potrà credere che un
maestro come Shakespeare, riflessivo e padrone dell'argomento, abbia inserito
nella sua opera un sia pur minimo particolare senza una precisa intenzione, senza
l'intima convinzione della sua necessità? Non dal maestro, ma da noi potrà
dipendere se talvolta, non vediamo quell'idea profonda. Con il deplorevole
spostamento delle scene smontiamo poi violentemente la struttura artistica e ci
meravigliamo se il bel quadro, le cui parti non si combinano più, è diventato uno
stupido aborto. È veramente ridicolo vedere giovani mediocri che osano
manipolare il grande maestro, non come fosse un loro pari, no, ma come
dovessero correggere un compitino a quel misero scolaretto. L'uno comincia e
modifica e taglia, l'altro muta i mutamenti, il terzo non è ancora soddisfatto e
aggiunge del suo a tutto andare, e adatta il testo ai suoi fondali, al suo
palcoscenico, finché il nome di Shakespeare sul cartellone diventa una nefanda
ironia. Purtroppo... Persino poeti buoni o, diciamo, veri si sono lasciati indurre a far
da corifei di queste malefatte.Il vasto pubblico - mi sento giustamente autorizzato
ad affermare - non conosce ancora affatto l'insigne maestro, perché non ha mai
visto un'opera sua senza le irragionevoli mutilazioni, che non si possono
giustificare in nessun modo e non sono che una prova dell'imbecillità di chi le
intraprende. Ma, come sempre quando parlo del mio meraviglioso Shakespeare,
esco dai gangheri più di quanto non dovrei.
Il Grigio Però deve ammettere che quasi in ogni dramma shakespeariano
si trovano espressioni che offendono la decenza e i buoni costumi, sicché non si
può farle pronunciare in scena.
Il Bruno È vero, siamo diventati così schizzinosi che ad ogni scherzo
grossolano arricciamo il naso e preferiamo accettare la perversità di certi drammi
francesi piuttosto che il nome naturale di una cosa naturale; e omettiamole
dunque queste espressioni, queste frasi, l'opera non ne avrà alcun danno, anche
se ogni volta un tratto del carattere robusto, e attinto dal profondo, se ne andrà
alla malora. Quando Sir Tobia in Quel che volete maledice le aringhe che lo fanno
ruttare, basta questo tratto per farci vedere il villano. Pensi poi alla scena dei
carradori in Enrico Quarto, e riconoscerà che soltanto con questa scena, anche se
a taluno sembrerà una toppa inutile, si ottiene il quadro vivo dell'osteria di
Gadshill, e dell'onorata compagnia, che l'allegro principe vuol praticare. Certo,
oggi non si può recitare una scena simile, perché altrimenti dovremmo ridurre un
po' la stupefacente finezza del nostro galateo.
Il Grigio Ho capito: Lei non tollera nessuna macchia sul suo beniamino.
Ma pur concedendo che un'opera shakespeariana possa esercitare il massimo
effetto sul pubblico, solo quando sia data con perfetta fedeltà all'originale, Lei
dovrà ammettere che difficilmente si troverà un teatro fornito di tanti attori
intelligenti ai quali si possa affidare degnamente l'infinito numero di parti in quei
drammi che non ne devono trascurare nessuna.
Il Bruno Che l'imbarazzo o forse soprattutto la mancanza di abitudine dei
nostri attori costituisca, nel campo drammatico, una grave difficoltà, voglio, anzi
devo riconoscere. I drammaturghi influiscono sugli attori e viceversa. Quelli danno
il tono che questi imparano, e l'eco di questo tono spinge quelli a scegliere
continuamente la medesima intonazione, perché ormai sono sicuri della giusta eco
e se ne rallegrano. Sarebbe stolto credere che ai tempi di Shakespeare ci fossero
soltanto degli attori eccellenti e anche le particine secondarie venissero affidate ai
campioni del teatro, ma certo è che il genio del maestro dava l'impulso a tutti, che,
insomma, comprendendo l'insieme, ognuno sapeva inserirsi giustamente nel
dramma e questo risultava perfettamente organico.
Ho parlato delle magistrali presentazioni dell'antefatto nei drammi di
Shakespeare. Considerando solo questa parte integrante delle sue opere, appare
evidente quali cantonate abbiano preso i drammaturghi recenti determinando la
decadenza dell'arte drammatica.
Il Grigio Come? Non ci sono anche capolavori recenti?
Il Bruno Oh, si sono tessuti splendidi veli preziosi, di modo che noi, come
il principe nel Trionfo del sentimento, ci accontentiamo della pupattola che sta
dietro, e non vogliamo più la regina.
Ma in che consiste la divina potenza del dramma, che irresistibilmente ci
afferra come nessun'altra opera d'arte, se non nel fatto che, tolti per magia dalla
vita quotidiana, vediamo svolgersi davanti ai nostri occhi i meravigliosi eventi
d'una vita fantastica? Perciò non è forse contrario all'intima natura del dramma, la
sua peculiare potenza non viene forse paralizzata quando il fatto che pensavamo
di guardare coi nostri occhi ci viene soltanto raccontato? Shakespeare ci presenta
l'antefatto trasformandolo in vivissima azione, mentre altri ci stancano fin
dall'inizio con noiosi racconti e ci colmano di belle parole e frasi che non lasciano
nel nostro spirito alcuna immagine viva. Ma non parliamo soltanto dell'antefatto; i
nostri recenti drammoni di soggetto storico sono per la maggior parte poverissimi
d'azione; non sono che esercitazioni retoriche dove i personaggi entrano in scena
l'uno dopo l'altro e, siano re, eroi, servitori ecc., si dilungano in eleganti e fioriti
discorsi. Andrei troppo lontano se volessi dire come, alla mia solita maniera, mi
spiego il progressivo distacco dei nostri scrittori di teatro dal vero campo
drammatico; ma è certo che Schiller, il quale come pochi altri possedeva la
potenza della parola, nonostante il suo splendore e la sua grandezza, è stato la
causa prima di quell'aberrazione. Una certa forza, con la quale i versi generano
versi, è la sua peculiarità.
Il Grigio Mentre Lei prende le difese del suo vecchio Shakespeare al punto
da volerlo assolutamente senza macchia, io lodo invece il mio stupendo Schiller
che come una stella luminosa sovrasta a parecchi famosissimi poeti. Lei chiede
azione: dica dove ce n'è tanta come nel Guglielmo Tell?
Il Bruno Io ho forse voluto dir male del grand'uomo? No. Parlavo soltanto
dell'imitatorum servum pecus, il quale sempre si attiene alla debolezza che più
facilmente si accoppia col proprio principio. Si potrebbe discutere a lungo se
Schiller sia da annoverare tra i poeti veramente drammatici. Certo è però che un
genio altamente dotato come lui deve ben possedere la visione di ciò che è
veramente drammatico. La sua aspirazione a raggiungerlo è, nei suoi ultimi anni,
manifesta. Lei ha citato il Tell: lo confronti col Don Carlos e vedrà l'abisso che c'è
tra i due drammi. Mentre considero mancante di forza drammatica il Don Carlos,
ammetto volentieri e sono convinto che il Guglielmo Tell, almeno nei primi atti, è
un vero dramma. La meravigliosa esposizione dell'antefatto in questo capolavoro
sta anche a dimostrare quanto poco il vero poeta abbia bisogno del racconto che,
per quanto sia ben fatto, in e per sé non entusiasmerà mai lo spettatore. Ma molti
scrittori recenti si sono impuntati sul narrare e parecchie tragedie non contengono,
a rigore, altro che, con belle parole e insolite frasi, il ben ordinato rapporto di un
grave delitto, esposto da più persone di diversa condizione ed età, seguito
dall'esecuzione della sentenza pronunciata contro il colpevole malfattore.
Insomma, i nostri scrittori sono passati dal drammatico al retorico trascinando con
sé gli attori che a loro volta attribuiscono troppo valore alla parte retorica della loro
arte.
Il Grigio Non vorrà mica criticare lo sforzo che i nostri artisti fanno di
parlar bene nel pieno significato di questa parola?
Il Bruno Oh via, la buona declamazione è la base di tutto, ma questo non
basta. Si può declamare benissimo una parte e guastare tutto miseramente.
Un fenomeno singolare, ma spiegabile, del nostro tempo è quello di
frazionare l'arte drammatica e di mettere in mostra le membra del corpo mutilato.
Mentre alcuni viaggiavano da un luogo all'altro e come muti automi assumevano
strane pose o facevano discutibili smorfie, altri declamavano in recite drammatiche
fino ad arrochire, e affinché l'assurdo trastullo toccasse il culmine, si ricorse alla
musica che dovette prestarsi ad accompagnare con magnifici accordi quel cupo
afono cicaleccio. Lo scandalo era troppo grave perché lo si potesse tollerare a
lungo... Ma è ora di ritornare al mio argomento.
Appunto perché gli attori, trascinati dalle opere dei nostri scrittori datisi alla
retorica, si sono allontanati dal campo drammatico, la recitazione di parti
shakespeariane che poggiano unicamente su basi drammatiche riesce loro
difficile, anzi impossibile. Qui la declamazione non basta. Attore dev'essere in tutta
l'accezione della parola colui che recita Shakespeare, e non è detto che tutte le sue
parti esigano un attore più che eccellente. Un ingegno mediocre, pur che sia preso
dall'azione e si muova davvero come un uomo vivo e attivo, può superare qui
l'attore fondamentalmente più bravo che, nello sforzo continuo di afferrare con la
parola, dimentica tutto intorno a sé. C'è anche un'altra cosa da considerare.
Appunto perché i caratteri veramente drammatici devono far effetto con l'aspetto
esteriore, la personalità dell'attore ripugna spesso talmente al carattere che
dovrebbe rappresentare che qualunque tentativo di illudere lo spettatore riesce
vano. Qui però l'innata vanità soccorre alquanto l'imbecillità dell'attore meramente
retorico. Egli ragiona: «.È vero, la mia voce è debole, i miei movimenti sono incerti,
da malato, tutto sembra contrario alla natura del personaggio che ho intrapreso a
rappresentare, ma chi è capace di recitare come me la parte, con la mia
espressione, con l'intonazione giusta? Questo ripaga tutto il resto.» L'attore
s'inganna, perché, invece di vedere davanti a sé il personaggio, lo spettatore vede
soltanto uno che gli parla bellamente del personaggio e cerca di essere lui il
personaggio; ma lo spettatore non gli crede né ora né mai. Se poi la parte richiede
un impiego della forza fisica che all'attore manca, e questi ricorre a qualche
surrogato, di solito scelto male, egli corre il rischio di essere ridicolo e di guastare
disgraziatamente ogni cosa. Ciò si manifesta in modo quasi più evidente nelle parti
femminili che spesso sono fondate con la loro intima essenza sulla personalità
dell'attrice! Pensi a Turandot!
Il Grigio Già, Turandot! Con questo nome Lei mi ridesta un ricordo che
ancora mi scuote con dolci brividi. Parecchi anni or sono, ero ancora molto
giovane, feci un viaggio in Italia. A Brescia trovai una piccola compagnia che, caso
molto raro in Italia, dava spettacoli teatrali. Ci meravigliammo assai io e il mio
compagno di viaggio, di trovare ancora sulla scena Carlo Gozzi, molto
ingiustamente dimenticato. Per la sera successiva era annunciata Turandot, Fiaba
Chinese teatrale tragicomica in cinque Atti. Il caso volle che il giorno prima io
vedessi molto da vicino l'attrice che doveva recitare la Turandot. Era di statura
media, non direi bella, ma non ho mai visto proporzioni più armoniose né una
maggiore grazia di movimenti. Aveva il viso d'un ovale purissimo, il naso ben fatto,
le labbra un po' tumide, i capelli molto scuri, ma i grandi occhi neri, soprattutto,
mandavano una luce celestiale. Parlava col contralto delle italiane che, come Lei
saprà, penetra fino in fondo al cuore. Fin dal suo apparire, nelle prime scene, la
signora si rivelò attrice perfetta. Non saprei descrivere l'espressione dell'animo
meravigliosamente e profondamente commosso del momento in cui alla vista di
Calaf disse piano a Zelima le significative parole che contengono il filo sottile di
tutto il tessuto:
«Zelima, oh cielo! alcun oggetto, credi
Nel Divan non s'espose, che destasse
Compassione in questo sen. Costui
Mi fa pietà.»
Ma quando, avendo Calaf risolto due dei suoi enigmi, lei ebbe proposto il
terzo con voce cupa e solenne, avanzando nella sua abbagliante maestà; quando
a un tratto sollevò il velo che le copriva il viso, la folgore mortale dei suoi occhi
raggianti di fuoco divino colpì non solo il petto di Calaf, ma il «petto di tutti gli
spettatori!
«Guardami in volto, e non tremar. Se puoi
Spiega chi sia la fera, o a morte corri!»
Chi non sentì scorrere nelle vene tutti i brividi della più dolce voluttà,
dell'estasi, della stupefatta angoscia? Chi non avrebbe voluto esclamare come
Calaf, disperato nella sua beatitudine: «Oh bellezza! Oh splendor!»
Il Bruno Ecco, vede? Se la sua signora non avesse avuto quegli occhi
splendenti, l'effetto della scena principale in tutto il dramma andava perduto.
Stavo appunto per citare la Turandot come una delle parti più difficili per le
esigenze che pone all'attrice. Soltanto un'artista perfetta saprà intendere l'eroico
o, meglio, il folle furore di Turandot senza distruggere il fascino della più splendida
femminilità. E per giunta la perfetta artista dev'essere giovane e bella, di una
bellezza che non si possa produrre neanche ricorrendo a tutti gli immaginabili
barattolini di colore che ci sono al mondo. Se non investe Calaf con sguardi
raggianti come quelli della Sua bresciana, o sollevando il velo scopre soltanto un
visetto mediocre e indifferente, la confusione di Calaf diventa ridicola, e così
l'intera scena. Io poi ho avuto la fortuna di vedere una Turandot tedesca che
poteva stare a fianco della bresciana, e aveva una voce di contralto che non
lasciava niente a desiderare. Sua Maestà invece portava un enorme cappello
cinese e nell'abito pesante si moveva lento, patetico, solenne, come si addice a un
sovrano. Così avvolto in un alone di serietà sostenuta, il suo tono continuamente
commosso faceva uno strano effetto. Seduto sul trono nella sala delle udienze,
agitava un grande insolito fazzoletto, col quale, in maniera sua particolare, si
asciugava le lacrime, e la sua voce fendeva le mobili frasi rivolte a Turandot come
un cariglione cinese. L'attore aveva capito la profonda ironia di questa magnifica
parte. Lui, Turandot e Adelma, che era toccata alla più brava attrice di questo
mondo, mi risarcirono della povertà di tutto il resto, la quale andava attribuita
soprattutto alla pessima riduzione. Anche qui il passo falso di un grande scrittore
conferma la mia tesi che il rimaneggiamento è una faccenda seria. Facendo il
confronto con l'originale, non si capisce come l'elaboratore tedesco abbia potuto
cancellare i tratti più belli, e soprattutto presentare così pallide e insipide le
caratteristiche maschere.
Il Grigio Perché ha sorriso dianzi con aria satirica quando parlavo della
mia bresciana?
Il Bruno Varie cose mi passavano per la testa a proposito della bellezza
che si pretende dalle donne che recitano. Anzitutto mi viene in mente una facezia
sbocciata allegramente nella platea d'un vicino teatro: anzi la racconterò subito
per portare una nota gaia nella nostra conversazione che si è fatta quasi troppo
seria. Dunque: poche settimane fa si dava nel detto teatro l'opera Don Giovanni.
Io avevo un posto in platea. La cantante che faceva la parte di Donna Anna era
italiana di nascita, ma esattamente l'opposto della Sua signora bresciana, era
vecchia e devo dire assai brutta. Ciò indusse un giovane, seduto poco lontano da
me, a rivolgersi al vicino e a fargli notare indispettito come quella brutta vecchia,
la quale per giunta stonava, distruggesse ogni illusione; chi poteva credere che il
ghiotto Don Giovanni potesse invogliarsi di quel fiore appassito? Il vicino replicò
con aria molta scaltra: «Lei, mio caro, non ci ha capito niente. L'illuminata
direzione ha affidato a ragion veduta la parte di Donna Anna a quella degna, anche
se brutta signora. Soltanto così infatti si manifesta chiaramente tutta la ribalderia
di Don Giovanni: il cielo non ha donato bellezza alla buona Donna Anna, ricca non
è nemmeno, come risulta dalle fonti, poiché cosa vuole che frutti la prebenda di
una cittadina di campagna? e la statua nel giardino non è che polvere negli occhi,
perché è fatta di cartone e dipinta di bianco. Quanto è contento perciò il buon
genitore che il bravo signor Ottavio gli sia venuto inaspettatamente a tiro e la
figlia, anche se parecchio avanti negli anni, finisca felicemente col trovare marito.
Tutte queste cose l'infame Don Giovanni le sa. Non c'è bellezza, non c'è gioventù,
non c'è grazia che lo possono allettare, anzi reprimendo forse il disgusto e il
ribrezzo insidia la brava Donna soltanto per il gusto di distruggere per sempre la
pace e la felicità d'una famiglia per bene. Vede? questo piacere del dispiacere è il
diabolico principio che lo anima.»
Il Grigio
Buona questa, magnifica! E qui ricordo come una volta, quando
sulle scene non si tolleravano che commoventi quadri familiari, un tale, con ironia
inventiva, trasformò Il flauto magico in un dramma familiare e riuscì a tranquillare
pienamente un altro che deplorava vivamente l'assurdità di quel fantastico
pasticcio. «Vede, mio caro,» cominciò, «il defunto marito della Regina della Notte
era il fratello maggiore di Sarastro, sicché Sarastro era zio di Pamina; siccome la
Regina della Notte a causa del suo cattivo carattere faceva una brutta vita
coniugale, tutta liti e baruffe, e di straforo aveva anche una relazione segreta col
Duca Pappagallo, il cui frutto fu Papageno, il defunto nel suo testamento nominò
Sarastro tutore di Pamina, e tale fu confermato dal collegio dei pupilli. Sarastro
notò quanto male Pamina fosse educata dalla madre e come la brava ragazza
venisse corrotta dalla precoce lettura di romanzi scelti male (per esempio, I dolori
del giovane Werther, Espero, Le affinità elettive ecc.) e anche dal ballo eccessivo.
Giustamente, in quanto zio e tutore, prese la piccola con sé e la educò lui stesso
prendendo per base della sua istruzione scientifica l'Opera elementare di Basedow
(i misteri di Iside e Osiride). Di qui e dal fatto che Sarastro, prima che l'eredità
fosse sigillata, reclamò la famosa orbita solare come proprietà di famiglia, proviene
l'odio feroce della Regina della Notte. Il padre di Tamino, il cui regno non è affatto
lontano come si potrebbe credere, poiché si trova subito a sinistra accanto al
tempio di Iside dietro il monte grigio-scuro, è il fratello minore di Sarastro. E
appunto perché vuol sposare sua cugina, Tamino deve prima attraversare il fuoco
e l'acqua, dopo di che il concistoro, la adunanza dei sacerdoti, vedendo che è
uomo da sopportare tutto ciò, gli concede la dispensa. Sarastro, in quanto
presidente concistoriale, venendosi a discutere nell'adunanza l'ammissione di
Tamino e la sua richiesta di matrimonio, seppe volgere l'opinione di tutti i
consiglieri in favore del suo diletto nipote, soprattutto assicurando che non solo
era principe, ma anche veramente uomo; e ciò gli fa onore. «Vede, mio caro,»
continuò quello con ironia, «come questi rapporti di parentela s'ingranano
perfettamente, costituendo il lato commovente del soggetto. Notando questi
delicati rapporti ognuno dovrà anche ammirare la divina idea che, contrariamente
alla saggezza, la natura è rappresentata dal figlio naturale della Regina della
Notte.
«Il serpente è soltanto allegorico, è il principio velenoso nella vita domestica,
una specie di segretario Wurm.» Ma è ora di troncare questo folle spasso... io l'ho
interrotta con la mia Turandot...
Il Bruno Ma in modo che quello che stavo per dire ha trovato la più solida
conferma. Altre parti, anche se non puntano proprio sull'abbagliante bellezza,
richiedono assolutamente il fascino della più fresca giovinezza che nessun artificio
è in grado di produrre. Pensi alla Miranda di Shakespeare (di cui Gurli è la
caricaturale parodia); pensi a Giulietta, alla Caterina di Heilbronn, alla Chiarina
dell'Egmont! È mai possibile che la più azzeccata recitazione d'una brava attrice
con le rughe in viso (anche se queste si possono eventualmente cancellare) e con
la voce cavernosa possa suscitare, per un solo istante, nel cuore dello spettatore
quei meravigliosi sentimenti che lo trasportano nel paradiso perduto del primo
amore e gli rievocano tutta la delizia, tutta l'estasi di quell'aurea e radiosa
primavera? Parti come quelle di Miranda e di Chiarina, quando l'attrice non
possieda la grazia della gioventù, diventano ridicole, quelle di Giulietta e di
Caterina addirittura deplorevoli e insopportabili. Pensi a Giulietta e alle fiamme del
suo primo amore che le daranno la morte! Immagini il monologo: «Correte veloci,
o cavalli dai piedi di fuoco! ecc.» detto da una donna vecchiotta: che sentimenti
proverà? Quali pensieri Le passeranno per il capo invece di quelli che il poeta ha
espressi dal cuore ardente? «Copri col nero manto il sangue acceso che batte sul
mio viso, e fai l'amore timido più audace, ma sempre puro in ogni suo
abbandono!» Oh non è indifferente se il tizio che canta ha venti o quarant'anni...
ma basta cosi. Lei mi ha bell'e capito.
Il Grigio Perfettamente. Lei non può essere più convinto di me che siffatte
rappresentazioni sono disdicevoli e, d'accordo con Lei, devo censurare
l'incomprensibile malinteso dei recenti drammaturghi che persino in parti come
quelle citate badano unicamente ai meriti retorici.
Il Bruno Perché essi stessi vivono su un piano retorico e non hanno né le
forze né il genio di creare un'opera veramente drammatica.
Il Grigio C'è chi prende le difese delle donne in età, si dice, e, mi pare, non
senza buone ragioni, che lo studio dell'arte richiede moltissimo tempo, tanto che,
quando l'artista è un'attrice perfetta, con la perfezione sono venuti anche gli anni,
di modo che non si può neanche pensare che una giovane possa essere una brava
artista.
Il Bruno Ho già detto che veri artisti si nasce. In fondo al cuore deve stare
la scintilla che, appena è accesa, erompe con tutta la sua potenza. Non c'è niente
da imparare, si tratta soltanto di perfezionare la capacità innata e naturale. Si
aggiunga che le donne hanno uno sviluppo precoce, e il dono di afferrare
giustamente le situazioni e di riprodurle poi fedelmente è dato più a loro che a noi.
Si dice infatti che la donna è un'attrice nata. Ha mai osservato i giochi infantili delle
bambine? Con quale convincente verità riproducono, con la voce, col passo, col
gesto, la vita reale che si svolge intorno a loro! Vanno a passeggio... incontrano
conoscenti... sono liete di vederli... s'informano di questo e di quello... prendono
commiato con mille proteste di amicizia... chiedono il ricambio della visita... si
rammaricano della lunga assenza... si fanno riunioni, la padrona di casa riceve gli
ospiti... parla di suo marito, dei figlioli che (bamboline ben vestite) vengono anche
presentati e accarezzati, si fanno elogi della graziosa mobilia, delle belle tazze...
l'una o l'altra ospite racconta un fatto avvenuto qua o là... stupore e meraviglia si
alternano nelle risate. In tutto ciò non è forse contenuto il germe dell'ingegno
drammatico? Perché mai, domando io, una ragazza di vero ingegno drammatico,
cui la natura avrà certamente aggiunto libertà e grazia di movimenti e una giusta
sonora pronuncia, dovrebbe aver bisogno di lunghi studi per recitare quelle parti
che (voglio eccettuare la Turandot) non richiedono se non la sincera espressione
d'un animo fervido? Non è vero che queste parti siano difficili, esse si recitano, per
così dire, da sé. I caratteri femminili, via via che si elevano esigendo il
perfezionamento drammatico rigorosamente compiuto, che presuppone
intelligenza, discernimento, riflessione, valutazione di ogni movimento, si
espandono sul terreno dove può muoversi soltanto la gioventù senza toccare il
limite dell'età matura. Pensi a Lady Macbeth e all'Isabella schilleriana, anzi io
metterei tra queste parti persino l'eroica Pulzella di Schiller.
Il Grigio E quale ciclo stupendo offrono queste parti, sicché non si riesce
proprio a capire come mai attrici, alle quali non si può certo negare una profonda
comprensione dell'arte, non se ne vogliano contentare, ma vadano sempre in
cerca di quello che hanno irrimediabilmente perduto.
Il Bruno Non abbiamo lamentato abbastanza lo strano inganno in cui le
nostre dive del teatro vogliono cadere a tutti i costi?
Non vogliamo però dimenticare che la capricciosa natura, compiacendosi di
essere bizzarra, crea talvolta eccezioni alla regola. Ci furono attrici e ce ne sono
probabilmente ancora, sul cui organismo il tempo pare non abbia alcun poterei
perché continuano a fiorire in perfetta giovinezza e, cosa molto importante, nel
tono della voce non lasciano trapelare l'età che si avanza. Io stesso, parecchi anni
fa, ho conosciuto due attrici che chiamerei arabe fenici del loro tempo. Entrambe
erano già nonne, e mentre l'una, con estro inesauribile, con tutta la grazia della
giovinezza recitava parti da fanciulla scherzosa e birichina, come si trovano
specialmente in vecchie commedie e opere in musica, l'altra, giovane e fresca di
viso, di statura, di movimenti, ci trasportava con la sua voce meravigliosa, dolce,
nostalgica, in una Arcadia di sogni d'amore. Sovente facevano sfigurare certe
giovani con vent'anni di meno, che stavano al loro fianco rigide e legnose,
dimodoché il bel visetto e la graziosa persona erano doni senza vita donde non
sapevano trarre alcun vantaggio. Ma nessuno si richiami a queste rarissime
eccezioni che sono appunto eccezioni e possono destare grande ammirazione.
Il Grigio «Sovente facevano sfigurare certe giovani...» Le Sue parole,
caro collega, mi hanno rattristato assai. Ricordo infatti una disgrazia singolare, una
pena che mi tormenta non poco. Il caso mi ha recato due, tre ragazze, piuttosto
belline, di graziosa statura, non prive d'ingegno, ma, Dio buono, dove andrei a
finire con le Giuliette, le Mirande, le Caterine ecc. Pare impossibile che con tanta
giovinezza si possa essere così poco giovanili come le mie care piccine! Sono
smorfiosette, patetiche, poi sentimentali e piagnucolose, non riescono a
comprendere l'azione drammatica. E nulla si muove, nulla si agita, né dentro né
fuori; sempre rigide e impacciate, e dovendo assegnare parti giovanili non so dove
battere il capo. Eppure non ho risparmiato fatiche né spese per inoculare loro il
massimo possibile.
Il Bruno Forse è dipeso proprio dalle inoculazioni, saranno capitate tra le
mani di un individuo retorico, portato ad affogare la forza drammatica nel largo
rombante fiume del discorso. Non c'è niente di più insulso del tono in cui i nostri
scrittori retorici vogliono ascoltare non solo i propri capolavori (questo
importerebbe poco), ma anche le opere veramente drammatiche. È il «tono
accademico» del teatro, e se Turandot deve recitare i suoi enigmi in tono
accademico, certe parti, dette in quel tono, rimangono in perpetuo un enigma
insolubile. Così si spiega lo scarso interessamento dei pubblico al dramma vero e
proprio. E non si dica che la maggiore affluenza di questi ultimi tempi sia una prova
del contrario. I nostri teatri sono diventati panorami, baracconi ottici, nei quali si
danza, si tira di scherma e si cavalca, si fanno fuochi e giochi d'acqua, tutti corrono
a vedere, dato che la recita non basta ad attirarli.
Il Grigio Poi mi si guasta il sangue se penso che, stando le cose come
stanno, ogni lavoro richiede per scenari e vestiario somme assolutamente
inadeguate all'incasso. Ma dove trovare il rimedio se il pubblico pretende questi
palazzi di fate, questi parchi illuminati, questi abiti ricamati in oro e argento?
Il Bruno Non necessariamente, come si potrebbe credere. Ai tempi di
Shakespeare non usavano vesti e scenari splendidi, coi quali oggi si sopraffà
l'azione drammatica; questa era un brano di vita e per gli accessori si ricorreva alla
fantasia dello spettatore che si prestava ben volentieri. Il Coro, per esempio, nel
Prologo dell'Enrico Quinto dice: «Scusate, gentili signori, se uno spirito basso e
senza slancio ha osato portare su questo indegno palco un soggetto così grande;
può forse quest'arena da galli contenere i vasti campi di Francia? o potremmo noi
stipare entro questo cerchio di legno soltanto gli elmi che empirono di spavento
l'aria di Azincourt? Oh, perdonate! Siccome un segno contorto può significare in
breve spazio un milione, fate che noi, zeri in questo grande conto, si possa contare
sulla vostra immaginazione! Immaginate che entro le cinta di questi muri siano
compresi due potenti regni le cui fronti erette e minacciose sono divise da uno
stretto di mare pericoloso; supplite col vostro pensiero alle nostre mancanze;
dividete un sol uomo in mille e create un esercito immaginario; quando parliamo di
cavalli, pensate di vederli imprimere gli zoccoli orgogliosi nel molle suolo; poiché il
vostro pensiero deve ora vestire i nostri re, portarli qua e là; scavalcando i tempi
e condensando gli eventi di molti anni dentro una clessidra...»
Per avvicinare rapidamente una scena lontana, come quelle citate, non c'era
bisogno di un cambiamento di scena, il cui strepito strappa per forza lo spettatore
dal cerchio magico del dramma più di quanto il dramma stesso lo costringa a
portarsi improvvisamente in un altro luogo dell'azione.
Il Grigio Ma oggi si potrebbe fare a meno degli scenari?
Il Bruno Siamo creature viziate, il paradiso è perduto, non possiamo
tornare indietro. Oggi abbiamo bisogno degli scenari come dei costumi. Ma non
per questo il nostro teatro deve somigliare a un caleidoscopio. Il vero scopo dello
scenario è di solito frainteso. Non c'è nulla di più ridicolo che pretendere di portare
lo spettatore, senza che ci metta un po' di fantasia, a credere realmente nei palazzi
dipinti, in alberi e rocce, di sproporzionata grandezza e altezza. Tanto più ridicolo
in quanto per antichi abusi ogni momento accade qualcosa che annulla di botto
l'illusione desiderata. Potrei addurre cento esempi, ma per menzionarne uno solo,
Le rammenterò le nostre infelici finestre e porte praticabili che vengono collocate
tra le quinte e distruggono immediatamente la più studiata prospettiva
dell'architettura, la quale, vista solo da un unico punto, può apparire giusta. Ci si
vuol avvicinare alla natura con le reali dimensioni delle masse e chi pretende di
creare l'illusione non fa che un gioco puerile e inutile; ma oggi lo si fa dappertutto
con gli scenari, con la rappresentazione di battaglie, di cortei ecc. Un direttore mi
assicurò seriamente che, per rappresentare la battaglia con naturalezza, aveva
raccolto quaranta comparse... e io gli domandai se aveva anche suddiviso quelle
quaranta persone in fanteria, cavalleria, artiglieria, truppe leggere e così via.
Gli spettatori che si cerca di illudere con questi mezzi restano freddi e
formano un'opposizione come chi mira a scoprire i trucchi del prestigiatore e a
fargli fare brutta figura. Così avviene che al minimo inconveniente, quando per
esempio un albero ostinato non vuole uscire dal palazzo, quando una parte del
soffitto minaccia di crollare, tosto si levano grida e risate. Tutto deve servire
all'azione drammatica; scene, costumi ed accessori devono far sì che lo spettatore,
senza sapere con quali mezzi, sia portato nell'atmosfera favorevole al momento
dell'azione, anzi sia trascinato entro l'azione stessa. Ne consegue che anzitutto
occorre evitare con la massima cura ogni inconveniente, poi afferrare i vari
elementi fantastici che devono agire sullo spettatore e mettere le ali alla sua
fantasia. Lo scenario non deve attirare l'occhio dello spettatore come uno
splendido quadro a sé stante, ma nel momento dell'azione lo spettatore, senza
rendersene conto, deve sentire l'impressione del quadro nel quale l'azione si
svolge. Mi accorgo che mi esprimo con parole troppo povere e temo che Lei non mi
abbia nemmeno capito.
Il Grigio Ho capito benissimo. Come dianzi, quando si parlava di parti
giovanili, ho citato l'esempio di Turandot, così mi permetta di menzionare un caso
che dimostra quanto conti talvolta lo scenario; è un caso che capitò nel mio teatro.
Lei ricorderà nel Mercante di Venezia la magnifica scena notturna di Jessica col suo
innamorato nella villa di Porzia. Si era scelto uno scenario effettivamente artistico
e ben eseguito, un'ala del castello con portici e scale, plasticamente prominenti
fino al proscenio. Da una parte sotto un arancio erano seduti Bassanio e Jessica.
Lo scenario attirò tutti gli sguardi, mentre la scena si svolse in un'atmosfera di
fredda indifferenza. Jessica e Bassano erano freddini e il celato amore, il giuoco
erotico con la ripetuta ripresa «In quella notte ecc.» non riusciva a imporsi e a
scaldare il cuore di nessuno. Me ne dolsi con un amico intelligente che, senza far
lunghi discorsi, sa colpire sempre nel segno. Mi rispose soltanto: «Non poteva
essere diverso: ogni ardore doveva raffreddarsi vicino a tanto gelido marmo.»
Doveva avere ragione. La volta seguente invece dello splendido palazzo mandai
avanti un giardinetto: pochi alberi scuri, dai quali trapelava la luna, folti cespugli e
praticelli fioriti ai lati del proscenio, dove Jessica parlava con l'innamorato, tutto
assai tetro, misterioso... e copia fedele della natura: pareva di respirare l'aria
profumata del Sud, di udire il fruscio del vento notturno. E tutto fu diverso: si stava
seduti nella notte italiana e si ascoltava il dolce sussurro delle parole d'amore e
nessuno pensava allo scenario.
Il Bruno Così dev'essere. La fedele imitazione della natura non deve
servire, se è possibile, al pittore di scene per far pompa, ma soltanto per produrre
quella superiore illusione che col movimento dell'azione genera se stessa nel cuore
dello spettatore. La errata tendenza a far impressione con grandi folle, col puerile
sfoggio di numerose comparse che portando magnifici abiti non sanno muoversi e
guastano ogni armonia, e con l'interminabile monotonia dei balletti nulladicenti ha
prodotto anche la necessità di costruire grandi teatri, eccessivamente profondi, del
tutto contrari agli effetti drammatici. Sui nostri stragrandi palcoscenici l'attore si
perde, dice Tieck, come un ritrattino in miniatura dentro una enorme cornice.
Il Grigio Mi consenta di osservare a questo punto che, secondo me,
l'illuminazione dei nostri palcoscenici non permette che un gruppo, e meno ancora
un singolo personaggio, emerga bene in rilievo tra luce e ombra.
Il Bruno Giusto. Data l'attrezzatura dei palcoscenici i nostri attori sono
illuminati ugualmente da tutte le parti e sembrano quindi spiriti trasparenti che,
senza corpo, non gettano ombra. Deplorevole poi è l'abbacinante illuminazione del
proscenio, dal basso in alto, di modo che il viso dell'attore, quando egli si avanza
fino alla ribalta, e lo fa volentieri per via della cara buca del suggeritore, si deforma
in un'anticipata smorfia. I nostri gruppi somigliano a disegni cinesi, senza
prospettiva, senza un'impalcatura a causa di quell'illuminazione irrazionale. Per
ogni raggruppamento valgono naturalmente le norme del quadro ben disposto e
ben colorito, onde segue ovviamente che nello scegliere il colore del costume
bisogna chiedersi subito come l'azione raggrupperà i diversi personaggi. Un vestito
visto da solo, può essere bellissimo, eppure sciupare l'armonia dell'insieme. Una
volta in un'opera vidi che i quattro personaggi principali portavano ciascuno una
cappa rossa, ed era molto divertente vederli, come d'altronde vediamo spesso il
popolo delle comparse in abiti di ugual colore e di taglio uguale, per far capire che
lo spettacolo si svolge in uno stato commerciale chiuso. In tutti i moderni quadri di
famiglia di alcuni anni fa tutti gli uomini giovani erano vestiti di nero, a meno che
uno sconosciuto non dovesse presentarsi in soprabito, e tutte le giovani donne in
bianco: molto brutto da
vedere, ma adatto alle frasi commoventi e agli
scrosci di lacrime che ci piovevano addosso. Tutti i sentimenti esaltati, tutte le
angosce, tutte le miserie umane ci erano offerti nero sul bianco! Ora magari si
esagera con la varietà dei colori, ma finché un accozzamento stridente non
offende l'occhio, è meglio questo che quella monotonia da funerale.
Il Grigio Io stesso, costretto a dare rappresentazioni in un vasto teatro,
sostenendo appunto per l'ampiezza spese esorbitanti, mi auguro cordialmente un
teatro più piccolo, anche se vedrei ridotti gli incassi e benché non creda nella
possibilità di offrire spettacoli con marce, cortei e simili, come sono attualmente
richiesti.
Il Bruno Lei non avrebbe che da elevare il più possibile il tono drammatico
del Suo teatro e suscitare così nel pubblico un interessamento maggiore che gli
faccia dimenticare la baraonda invalsa sui palcoscenici.
Il Grigio In questi giorni conto di dare l'Enrico Quarto. Come rendere la
battaglia in un teatro ristretto?
Il Bruno Non vorrà mica rappresentare combattimenti di comparse! Sono
sempre di cattivo gusto e di solito interviene qualche episodio buffo che spinge la
gente a ridere e sciupa integralmente qualsiasi effetto.
Il Grigio Ma, dato che si tratta della battaglia, dato che un combattimento
comincia addirittura in scena...
Il Bruno ... non vuol dire che lo spettatore abbia da vedere la battaglia, la
quale distruggerebbe il quadro fantastico che possiamo far sorgere nella sua
mente con mezzi artificiali. Suoni di corno lontani... che s'avvicinano... che si
allontanano... squilli di tromba... simili richiami... grida scomposte... tamburi, ora
vicini, ora lontani, ecc. ecc., questo basterà a conferire un orribile sfondo al quadro
formato dai personaggi che agiscono sul palco. Ma evitiamo, per carità, musiche
guerriere o addirittura marce dietro la scena! Nessuno le intende chiaramente o,
se le intende, ha bisogno della riflessione per ravvisarvi il quadro della battaglia, e
con ciò l'effetto è perduto.
Il Grigio Infine però non vorrà negare che, nelle odierne condizioni del
nostro teatro, i teatri piccoli presenterebbero parecchi disagi.
Il Bruno Nel secondo volume del Fantaso Tieck ha scritto alcune stupende
verità circa lo svantaggio dei palcoscenici grandi, eccessivamente fondi. Ad esse
vorrei richiamarmi. Ma mi consenta di rammentare, a memoria, così alla meglio,
ciò che ne dice un vecchio maestro del canto e ad un tempo ottimo e profondo
conoscitore del teatro, il Grétry, nei suoi Mémoires ou Essais pour la musique.
«Oggi si chiedono e si costruiscono continuamente teatri grandi. Se dovessi
attrezzarne uno, direi al mio architetto: ‹Consideri che qui non si tratta di erigere
un monumento che dia nell'occhio e faccia effetto su chi lo guarda! Quel che conta
è che si oda perfettamente tutto quanto è detto e cantato sulla scena. Se nel suo
vasto edificio non riesco a intendere una musica in pianissimo, la voce d'una
donna, d'un bambino; se dei versi d'un poeta, dei quali non vorrei perdere una
sillaba, ci rimetto la metà, che mi giova la sua ampia costruzione? Chiedo perciò
che il teatro sia costruito in misure adeguate alla vista e all'udito non già delle
persone che hanno orecchie e occhi acuti, ma della media degli spettatori, La
prospettiva del palco può essere fonda quanto si vuole; ne derivano certo parecchi
vantaggi; ma il proscenio deve sorgere possibilmente vicino agli spettatori se si
vuole che ascoltino tranquilli e senza dar disturbo. O se proprio si vuol costruire un
teatro di vaste proporzioni, lo si destini esclusivamente a pantomime e balletti in
grande stile, a drammi spettacolari, all'opera eroica e tragica. Il teatro grande
esige grandi masse, grandi cortei. Quel che vale per le recite nel dramma, vale per
il canto nell'opera; l'azione è pur sempre la stessa. In quanto alla musica, il
compositore e poi il cantante e anche l'orchestra possono esprimere i piacevoli
particolari d'un'azione moderata soltanto con le mille sfumature dal piano al forte,
con mille piccoli tratti graziosi, notine, fiorettature e abbellimenti della melodia,
con assoli d'uno strumento e simili. Tutto ciò ha molto valore e produce begli
effetti in uno spazio limitato, in uno grande invece va perduto; e non si ode o si ode
a metà a causa sia dell'ampiezza, sia del rumore, inevitabili con tanta gente; e se
anche si sentisse, l'effetto verrebbe a mancare, perché non sarebbe in armonia
con l'insieme, del quale l'ambiente è parte precipua.› Il mio costruttore obietterà:
‹Ma in un teatro grande ci sono abbastanza posti, dai quali si vede e si sente tutto.›
Io rispondo: ‹È sempre possibile avere uno di quei posti? e il teatro è forse
costruito per quattromila persone affinché cento trovino un buon posto? C'è un
punto, oltre il quale non si sente più chiaramente e direttamente, ma soltanto
grazie all'eco; e quel che si ode in tal modo, anche se non c'è un'eco vera e propria,
è impreciso, sproporzionato alle minuzie e alquanto faticoso. La sproporzione,
ripeto, tra una voce debole, una recitazione graziosa, delicata, e la vastità del
locale non manca mai di fare un effetto sgradevole, anche se non se ne conosce
veramente la causa.›»
Il Grigio
Grétry pensa soprattutto alla commedia musicale e la
contrappone alla vera grande opera.
Il Bruno È vero, ma tutto quanto dice intorno alla scomodità dei teatri
troppo grandi calza perfettamente ai lavori rigorosamente drammatici, indifferente
se sono opere in musica o se assumono altre forme. Ma in quanto a effetti
drammatici non c'è giudice più competente del vecchio Grétry. Chi meglio di lui ha
dato composizioni drammatiche disprezzando il vuoto nulladicente tintinnio che
può soltanto appagare l'orecchio, ma non certo commuovere?
Il Grigio Non c'è dubbio però che il pubblico avvezzo a un teatro grande
difficilmente si accontenterà di uno piccolo.
Il Bruno Certo, da principio non mancherebbero aspre critiche, ma un po'
alla volta la più intensa impressione drammatica, il piacere di vedere e di ascoltare
comodamente riporterebbe la vittoria. All'obiezione che soltanto una piccola parte
del pubblico verrebbe soddisfatta, si può rispondere che, trattandosi d'una grande
città, vi saranno parecchi teatri i quali, se indipendenti l'uno dall'altro, si
metteranno presto in gara con grande vantaggio dell'arte.
In una importante capitale si parla ora dell'erezione di un nuovo teatro, e
come già a proposito di scenari vi si sta da qualche tempo attuando quella
superiore illusione che ho menzionato poco fa, così pare che, cercando solo
l'effetto veramente drammatico, si voglia procedere secondo i principi del vecchio
Grétry e di tutti i veri drammaturghi.
Il Grigio Già da un po' di tempo ho una domanda sulla punta della lingua.
Lei che venera Shakespeare con tanto fervore, che non vuole accettare, si può
dire, altro che i suoi drammi, che ad onta del mutevole spirito dei tempi non
rinuncerebbe neanche a una parola, neanche a una sillaba dell'originale, ha mai
messo in scena Shakespeare coi suoi antichi immutati costumi?
Il Bruno Le potrei rispondere che le forze di un direttore di teatro
viaggiante sono appena sufficienti a nuotare con la corrente senza affondare; che
il continuo avvicendarsi del suo personale gli permette soltanto di formare il
repertorio secondo l'elenco delle parti che gli attori, fortuitamente raccolti, sanno
recitare; che occorre pertanto lasciare ai maggiori teatri stabili il compito di fare
esperimenti, dei quali garantirei la buona riuscita, con drammi che stanno fuori
della cerchia di quelli coi quali si colma generalmente il repertorio. Invece Le dico
che una volta, parecchi anni fa, quando mi si aprì un porto dove potetti stare
tranquillamente all'ancora, almeno un po' di tempo, realizzai subito la mia idea
preferita e diedi nel mio piccolo, piccolissimo teatro opere della cui superiore
efficacia drammatica ero convinto.
Il Grigio Avrà dato Re Lear... Amleto... Otello... Macbeth...
Il Bruno Niente affatto. Di tutte codeste grandi tragedie, per le quali non
avrei neanche trovato gli attori, esistono riduzioni, rifacimenti, e non avrei mai
persuaso i miei attori ad abbandonare queste riduzioni. No, no. Scelsi lavori che
essi non conoscevano neanche di nome. Breve: misi in scena le commedie di
Shakespeare.
Il Grigio Con successo?
Il Bruno Un esempio per tutti. Lei conosce Quel che volete di
Shakespeare. Ne abbiamo parlato dianzi. Nella mia compagnia c'era un eccellente
Malvolio, un'altrettanto eccellente Maria, un bravissimo Buffone e un passabile
Orsino. Si dava poi il caso che il mio giovanile tenore assomigliasse per statura e
lineamenti a una giovane bella, ma per il resto del tutto insignificante, che si
compiaceva di parti molto sentimentali. Di quella somiglianza, con un po' di
belletto e col vestito, si poteva arrivare alla più ingannevole uguaglianza, di
maniera che nessuno poteva dubitare che Sebastiano e Viola sono fratelli e
vengono continuamente scambiati fra loro. I rimanenti erano i soliti avventizi
d'una compagnia di giro. Con forze così esigue ebbi l'ardire di mettere in scena
quella splendida commedia. Non mi comportai come se fosse qualcosa di grande,
come se la commedia avesse un'importanza particolare, finsi invece di non tenerci
più che a qualunque lavoro di Kotzebue o di Schröder, e così fu considerato anche
dagli attori che se la presero soltanto con la metrica, ma io replicai che ormai, dopo
Schiller, i versi erano di moda, e bisognava quindi imparare le parti con la massima
precisione. E fu strano, molto strano, vedere come, una volta familiarizzatisi con
quella novità, gli attori s'interessassero, di prova in prova, sempre più al
capolavoro. E così anch'io esposi via via la mia opinione sulle squisitezze della
commedia, come se le andassi scoprendo soltanto allora, e sul modo in cui
andavano rappresentate. Era, più che un'istruzione, una discussione amichevole.
Riuscii persino a scuotere le menti pigre e a incatenarle all'argomento. La partita
era vinta! Anche i due Sir, autentici villani per natura, si adattarono
magnificamente e, coprendo d'una leggera vernice 2la nativa rozzezza, divennero
molto buffi e divertenti. La lunga commedia fu rappresentata con la massima
fedeltà all'originale senza alcun taglio.
Il Grigio Comprese le aringhe di Sir Tobia?
Il Bruno Non ci fu bisogno di aringhe, caro amico. La commedia aveva
abbastanza sale per tenere il pubblico costantemente assetato, anziché impinzarlo
di quel pane secco che gli offrono oggi le nostre nuove tragedie e commedie. La
rappresentazione riuscì perché tutti collaborarono volentieri e nessuno vi infilò
alcunché di estraneo, nessuno trasmodò nella sua parte. Tutto apparve chiaro in
virtù della perfetta unità della recitazione e nessuna scena, che dico? nessuna
parola parve superflua. L'effetto sul pubblico fu quello che avevo previsto. Già la
prima volta i due Sir, ma particolarmente Malvolio, specie nella scena della torre,
fecero ridere di gusto, il resto non fu avvertito. Ma ecco emergere Maria... poi le
tenere scene di Olivia, del Duca... la sorprendente somiglianza tra fratello e sorella
aveva fatto grande impressione fin da principio.
Feci seguire due serate con Misantropia e pentimento e Una giornata
d'autunno. I due drammi, di solito molto applauditi, produssero - nessuno sapeva
perché - noia e malumore. Poi venne la ripresa di Quel che volete che, vedi un po',
interessò vivamente dal principio alla fine... applausi scroscianti... chiamate... tutti
indizi che il nuovo spettacolo aveva messo radici e con la sua vitale freschezza
aveva superato gli altri lavori, pallidi e nebbiosi. E noti che avevo a che fare con un
pubblico alquanto tardo!
Si figuri poi la venerazione che gli attori applauditi ebbero da quel momento
per il mio Shakespeare.
Il Grigio Lei parla di un fatto, di un'esperienza Sua personale, contro la
quale non c'è nulla da obiettare. Ma com'è andata con le tragedie?
Il Bruno Le ho già detto perché non misi in scena i drammi eroici di
Shakespeare. Per la tragedia mi ero scelto un poeta sublime, i cui drammi fecero
al pubblico un'impressione indimenticabile. La sua Devozione della Croce, il primo
dramma che rappresentai, suscitò l'entusiasmo generale e divenne un'attrazione,
uno spettacolo da cassetta. Ma non mi trattengo a parlarne, perché il merito del
poeta, degli attori, persino del pubblico conquistato dall'argomento, è unilaterale.
Il mio teatro si trovava in una località cattolica: lavori come la Devozione della
Croce, Il principe costante, Il mago prodigioso, che si basano sul più profondo
principio cattolico, su un'idea estranea a tutte le altre Chiese, possono essere
rappresentati con verità ed efficacia soltanto da attori cattolici per un pubblico
cattolico. Quando vedo un attore non cattolico, che pertanto non può
entusiasmarsi all'idea della parte che deve recitare, quando lo vedo impersonare
Eusebio o Fernando con tutti i possibili artifici retorici e mimici, e affaticarsi a
fingere una vita che non arde dentro di lui, mi vien male, e mi sento come quando
un individuo del popolo che ammazzò nostro Signore dipinge ai miei occhi una
madonna o canta in chiesa: «Kyrie eleison, Christe eleison!»
Così, un pubblico non cattolico non si commuoverà a quel capolavori, dei
quali non può intendere l'idea profonda nella quale si concentra ogni azione.
Soltanto il vero cattolico, per dirne una, comprenderà giustamente la contrita
umiltà di Fernando e la saprà collegare col senso eroico sinceramente cattolico che
lo pervade.
Chi vuol dare drammi calderoniani in località non cattoliche scelga La grande
Zenobia o Il ponte di Mantible, un dramma meraviglioso dove il grande fracasso è
al posto giusto e il gigante Fierabraccio con le sue orgogliose iperboli è un
personaggio delizioso, o prenda drammi simili - ne trova a centinaia, ma non
ancora tradotti in tedesco. In genere c'è ancora da scoprire tutto un regno
sommerso di eccellenti opere drammatiche, e parecchi nostri giovani poeti,
conoscitori di lingue straniere, farebbero bene a sostenere questa utile fatica
anziché scavare gemme false dalle proprie sterili miniere!
Il Grigio Ahi, egregio amico!... Giovani poeti... in genere, poeti... ahimè,
ahimè!...
Il Bruno Che c'è? Lei impallidisce?... si frega la fronte... Quanta pena nel
suo sguardo! Perché tanto dolore, così, all'improvviso?
Il Grigio Lo sa che con le parole «giovani poeti» ha aperto una cameretta
di tortura? Mi si è spalancata davanti agli occhi e ho visto gli infernali strumenti coi
quali vengo continuamente attanagliato, trafitto, scottato, messo insomma, in tutti
i modi, alla tortura.
Il Bruno Non La capisco bene, ma mi par d'indovinare...
Il Grigio Ahi, quella maledetta camera di tortura è lo stanzino dove
conservo i manoscritti che mi vengono mandati. Non passa una settimana, non un
giorno senza che mi piovano addosso tragedie, drammi, commedie, operette... Le
follie di drammaturghi esaltati che in négligé ideale fanno divertenti capriole sono
ancora le più simpatiche. Si riconoscono fin dal primo foglio, e non è necessario
continuare la lettura. Con l'idea tranquillante che non è il caso di pensare alla
rappresentazione, si continua però a leggere ed ecco che qua e là sprizza una
scintilla luminosa, gradevole, salvo che non si accende né al momento giusto né in
luogo conveniente. Per amore di queste scintille viene la tentazione di scendere a
trattative con l'esaltato autore... si richiama l'attenzione su questo, su quello, si
propone persino un soggetto eseguibile! Il biglietto della lotteria è acquistato... si
imbocca la via della speranza... Se sarà un biglietto non vincente, pazienza!... Ma
quella dannata merce mediocre che con superficiale imitazione e a passo di
lumaca tien dietro ai capolavori, che si gonfia e pavoneggia come fosse chissà che
cosa, che scimmiotta perfettamente la melodia dei maestri, e non si può neanche
dire che sia merce da buttar via, pur essendo un cibreo dolciastro e smidollato che
non può non guastare lo stomaco... ecco, questa roba mi tormenta, mi fiacca,
m'immalinconisce. E leggo e leggo una scena dopo l'altra, sperando, aspettando
finalmente il colpo dell'ala drammatica, che rimane invece inerte, floscia, finché, se
Dio vuole, arrivo al «cala la tela», ma con la tela cala anche la mia fiducia nella vita.
Le tragedie in versi sono ancora passabili. Seguendo la tiritera degli endecasillabi
abbastanza buoni, poiché di questi s'intendono i nostri giovani poeti, attenti alla
forma, perché credono che questa sia tutto... seguendo questa solfa si finisce con
l'appisolarsi. Così, nel pomeriggio distesi sul divano, in un vago oscillare tra la
veglia e il sogno, si può anche leggere questa roba. I rari urti che si provano di
quando in quando non provengono da pensieri acuti, ma dalle scosse elettriche
scoccate dal poeta che d'un tratto, senza particolare motivo, irrompe con nuove
esplosive forme metriche, di modo che i poveri endecasillabi fuggono atterriti di
qua e di là. Ma intollerabili, anzi disgustose sono le commedie senza una struttura,
senza un filo interiore, senza caratteri, dove invece di spirito si servono in tavola
sconcezze, insulsi giuochi di parole, frasi scurrili e scipite. Leggendo si rimane
svegli e si prova tutta intera la nausea che siffatte abboracciature producono.
Il Bruno E perché legge tutto? A un esperto di teatro non basta dare una
scorsa per capire se un dramma merita di essere letto?
Il Grigio Caro amico, non devo forse rendere conto a tutti i poeti che,
appostati da per tutto, finiscono con l'acciuffarmi e puntarmi il pugnale sul cuore?
«La borsa o la vita!» m'impongono. «Dimmi le ragioni perché il mio dramma è
brutto, indica le scene che non ti sono piaciute oppure... ti pugnalo con affilate
recensioni del tuo lavoro quotidiano!»
La lettura dei drammi è ancora il minore dei mali, ma la corrispondenza, la
dannata corrispondenza coi poeti! Gli esaltati sono villani e scrivono che si
degnano bensì di far rappresentare il loro capolavoro nel mio teatro, ma in quanto
alla distribuzione delle parti e alla messa in scena bisogna procedere in un
determinato modo, che di solito è mostruoso e ineseguibile. Se rispondo che il
dramma non è rappresentabile, mi guardano con disprezzo, e fin qui poco male.
Ma i modesti che presentano i loro «tentativi» in copia pulita, su carta finissima, e
ammettendo di aver poca pratica di cose teatrali credono che il loro dramma avrà
infallantemente un grande successo, quelli sono i più pericolosi. Ogni rifiuto,
espresso come si vuole li fa nemici implacabili del povero direttore. E schizzano il
loro veleno da tutti i giornali disposti a stampare roba simile, e non la smettono
finché le loro grida non abbiano attirato almeno un piccolo crocchio intorno a loro.
Il Bruno Non mette conto di prenderli sul serio. Ma, per dirla
incidentalmente, è una singolare mania quella dei nostri giovani poeti, di pensare
che il direttore, cui presentano i loro lavori, debba sempre essere ostile a queste
opere. Come se i direttori non dovessero essere ben lieti di ricevere cose nuove ed
eccellenti per il loro repertorio; come se, invece, non presumendo di dare un
giudizio e rimpinzando a casaccio il repertorio, non fossero responsabili verso il
pubblico di ogni loro fallo! Ora, il germe di questa mania sta nell'impaccio, nella
prosaica mentalità di quasi tutti i nostri cari colleghi, i quali disdegnano l'opera
bella e geniale riconosciuta da tutti e, quando incontrano qualcosa di simile,
ricorrono subito a opere comuni, ordinarie, come chi abbia mangiato senape deve
annusare subito il pane quotidiano, perché altrimenti gli vengono le lacrime. Tutti
i giovani, senza eccezione, ci prendono per ciocchi insensibili che non vogliono
riconoscere la loro genialità.
Il Grigio Oh, quante volte me l'hanno fatto capire! Dio mio, che tormento!
Ci si trova talvolta in circostanze che ci costringono a lisciare lo scrittore non
chiamato, o magari a mettere in scena il suo lavoro, contro la propria convinzione.
Le previste conseguenze si avverano, il dramma viene fischiato, e l'ira, la rabbia si
scatena, più che se il lavoro fosse stato respinto, contro il direttore, contro gli
attori, contro il suggeritore, magari contro il lampista, perché tutti hanno
congiurato contro il successo, nonostante che si sia fatto tutto il possibile per
mascherare i punti deboli e per far trionfare lo scrittore. Ma l'ingrato non ci crede
e dà addosso al direttore.
Il Bruno Quale autore di teatro cercherà la causa del fiasco nella propria
opera, anche se la si può toccare con mano? Se non può trovare difetti nella
rappresentazione, l'infelice si acquieta sognando un terribile intrigo nelle file del
pubblico. Questo invece non ci pensava nemmeno, esigeva, come è giusto, un po'
di divertimento, e non trovandolo affatto, si è impermalito. «Non vi è nulla di più
strano della gente strana,» dice Sancio Panza, ma i più strani s'incontrano
probabilmente tra gli autori di teatro.
Molti anni fa, quando il mio teatro era in piena efficienza, avevo un amico che
a un tratto si mise in capo di essere un ottimo commediografo: intinse la penna e
combinò un mostriciattolo in tre atti che, nato cieco, si reggeva sulle tre gambette
tentennanti. E io dovevo assolutamente metterlo in scena! Dissi al brav'uomo,
chiaro e tondo, che il suo lavoro non valeva niente e senza alcun dubbio avrebbe,
come dicono in Italia, fatto fiasco. Mi rispose adirato che non capivo un accidente,
non ero in grado di giudicare se la commedia era buona o cattiva e che non facevo
che oppormi a tutte le opere geniali e straordinarie. Divenne sempre più freddo
con me e infine mi scansò del tutto. «Voi brave persone e cattivi musicanti» si
legge in Ponce de Leon di Brentano: io stesso potevo dire del mio amico che era
uomo buono, cordiale, intelligente, ma pessimo poeta: due qualità che non sono
incompatibili. Addolorato per quella rottura mi prefissi di guarirlo dalla mania
drammatica e di estirpare dalle radici il malanno che ci aveva separati. Distribuii le
parti, provvidi agli scenari nel miglior modo possibile, seguendo le mie forze, e si
andò in scena. Accadde quel che doveva accadere. La commedia fu fischiata di
santa ragione. Ecco, pensai, adesso il buon uomo capirà che non è facile scrivere
per il teatro, si metterà una mano sul cuore e dirà: «Il mio direttore aveva proprio
ragione.» Niente di tutto questo! Durante le prove era ridiventato gentile, anzi più
gentile e affettuoso che mai. Pareva in estasi, lodava sperticatamente gli attori,
invitava amici e conoscenti, vicini e lontani, a godersi il delizioso spettacolo.
Il mattino dopo la serata fatale che lo aveva fatto precipitare dalle altezze
sognate andai a trovarlo pensando che fosse pentito. Mi accolse con stizza e
malumore e mi disse che la colpa della sua disgrazia era tutta mia. «Ho distribuito
male le parti?» cominciai. «No, no.» «Gli attori, secondo te, non hanno fatto il loro
dovere?» «No, no, anzi hanno recitato benissimo.» «C'erano stonature? è
mancata l'armonia dell'insieme?» «No, no.» «Non andavano bene i costumi?» «Ma
no, li avevo voluti io così.» «Be', vorrei proprio sapere...» «Oh, quel fallo grave,
imperdonabile! e il più sublime capolavoro è andato a rotoli irrimediabilmente!»
«Fallo grave, imperdonabile? Per amor del cielo, dillo...» «Non darmi ad intendere
che non lo sapevi! Mi sei stato amico da anni, perciò non posso credere che sia
stata malignità o gioia dei male altrui, ma soltanto la tua smania di aver sempre
ragione: avevi detto che la commedia non valeva niente, perciò mi hai fatto questo
torto.» «Parola d'onore, non ti capisco. Potrei sapere...? Parla!» «Pensa alla quarta
scena del secondo atto!» «Be' la scena è stata recitata benissimo, ma il pubblico fu
irrequieto perché la scena, diciamolo pure, è troppo lunga e, insignificante com'è,
rallenta l'azione senza alcuna necessità, proprio nel momento in cui dovrebbe
svolgersi più velocemente.» «Vero, proprio in quella scena il pubblico fin lì
entusiasta, anche se non applaudiva apertamente, cominciò a dar segni di
malumore, benché anche questo fosse da attribuire soltanto al fatto che qualcuno
casualmente batté un po' forte il bastone per terra e gli altri sciocchi lo presero per
un segno di disapprovazione e fecero eco. Lasciamo andare: può darsi che la
scena sia dispiaciuta al pubblico... non poteva essere altrimenti, ma la colpa non è
certo mia, perché proprio quella scena che tu giudichi così male è la più geniale, la
più riuscita di tutta la commedia. E tu... tu hai guastato ogni cosa!» «Corpo d'un
accidente... io? In quella scena?» «Ah, ah, mio caro, non te l'avevo detto mille
volte... che in quella scena la poltrona del vecchio colonnello ha da stare a destra?
Era, sul palcoscenico, a sinistra!... addio armonia, l'unità era perduta... rovinato il
carattere di tutta la commedia... non poteva che fallire.»
Il Grigio Buona questa, magnifica! Ma creda a me, se anche mi capita di
ricevere lavori che metto in scena a ragion veduta e con vero piacere, mi avviene
molto raramente di poter accontentare, almeno un poco, l'autore. In primo luogo
quasi tutti pretendono che il loro dramma sia messo immediatamente allo studio e
rappresentato dopo una settimana. Se ciò è impossibile, e anzi l'interesse dello
scrittore stesso richiede che l'opera venga preparata come si deve e studiata con
calma a tutto comodo, dopo le prime quattro settimane è lì immusonito e, secondo
lui, è imperdonabile che non si abbandoni tutto il resto e non si lavori che al suo
dramma. Ed ecco arrivare le odiose lettere monitorie che danno tanto più fastidio
quanto più si sa di fare tutto il possibile per rappresentare il lavoro presto e bene.
Infine si arriva alla rappresentazione, il dramma piace, lo si replica. Ma l'autore non
è soddisfatto, si aspettava che facesse furore, era convinto che la sua opera
avrebbe oscurato tutte le altre, che avrebbe tenuto il cartellone due, tre volte la
settimana, e se ciò non avviene e non può avvenire, cerca e trova la cagione nella
scarsa buona volontà del direttore. Egregio collega, per queste cose vien voglia di
dar l'anima al diavolo.
Il Bruno Ah, ahi, mi sembra che anche qui Lei prenda la cosa troppo sul
tragico, per quanto Le debba concedere che il poetarum irritabile genus s'intende
assai bene delle maledette torture da Lei menzionate e può davvero amareggiare
l'esistenza al povero direttore. Se questi però possiede il vero senso poetico, se ha
una formazione artistica non superficiale ma veramente profonda, in modo da non
compromettersi come qualche volta avviene, può giustamente affrontare l'assalto
degli autori drammatici d'ogni genere, e in quanto alla stizza, può anche superarla,
purché abbia una buona dose di quel temperamento allegro che dobbiamo
augurare a tutti i direttori di teatro.
Noi due, caro collega, ci annoveriamo tra i più eccelsi direttori che ci siano
mai stati e perciò possiamo anche imprecare contro i nostri colleghi. Tra loro molti
sono del tutto scemi. Ma il buon Padre Celeste, come è il tutore di tutti gli stupidi,
dona talvolta anche a loro qualche buona idea e mette loro al fianco un visibile o
invisibile cherubino che traffica e si affanna in loro vece, sicché spesso fanno
centro senza volere. Molto più dannosi sono tra i nostri buoni colleghi quelli che,
come si suol dire, hanno fatto le scuole e, pur essendo privi d'intelligenza, credono
di capire tutto. Costoro «offrono il petto nudo all'alabarda» voglio dire che col loro
sempre incerto giudizio artistico, coi loro continui falsi sillogismi si oppongono
persino alla morte, e anche contro di noi, gente per bene, avveduta e tetragona,
aizzano quell'irritabile genus. Ma Lei, carissimo, è ben saldo, armato e catafratto.
Il Grigio Lo può ben dire. Me ne vanto, ma forse mi manca un po' la dose
di temperamento allegro che Lei giustamente augura a tutti i direttori. Io,
insomma, m'infurio.
Si parlava dianzi della sconfinata vanità degli attori. Ma in realtà la maggior
parte degli autori di teatro li supera in questo punto. Qualche tempo fa
rappresentai l'opera di un giovane scrittore pieno d'ingegno; in alcune parti l'opera
era ottima, nell'insieme sbagliata, ma pur sempre tale da interessare vivamente
quel settore del pubblico che a teatro è disposto a riflettere. Infatti il dramma trovò
il suo pubblico e fu replicato con successo. Ma crede che ciò sia bastato a quel
giovane? No, era di malumore, seccato. Pretendeva nientemeno che il pubblico,
prendendo in considerazione soltanto l'opera sua, dimenticasse non solo tutti gli
altri lavori teatrali, ma persino gli importanti, anzi inauditi avvenimenti della
sciaguratissima epoca alla quale ci affacciavamo. Se poi la città esultava per una
vittoria, se la gente si assembrava per le vie parlando e riparlando della grande
novità, egli si mordeva le labbra dalla stizza perché non si discorreva dell'opera
sua, bensì della battaglia vinta che aveva salvato lo stato.
Il Bruno Sto appunto pensando donde provenga l'irresistibile smania di
scrivere per il teatro, e trovo la ragione nel fascino tutto particolare che si gode
vedendo il quadro sorto dentro di noi uscire da noi e assumere la forma d'un
evento vivo e reale. La forma vivente e concreta del quadro interiore accresce
l'entusiasmo dell'io creatore, e questo entusiasmo produce una più elevata
coscienza di sé che facilmente degenera in ridicola vanità. E qui mi viene in mente
che or non è molto ebbi il piacere di ammirare un gruppo, il quale meritava di
essere eternato col bulino e appeso nell'angolo delle tristezze di ogni direttore di
teatro, affinché lo potesse rasserenare nelle tribolazioni.
Il Grigio Che gruppo era?
Il Bruno Due uomini che si abbracciavano guardando ciascuno al di sopra
della spalla dell'altro col sorriso agrodolce di chi gode del male altrui e soltanto
nelI'uno appare un velo di malinconia.
Il Grigio E questi due?
Il Bruno Erano due commediografi recentemente fischiati. Leandro e
Marcello hanno scritto una commedia ciascuno e la presentano alla direzione del
teatro affinché sia rappresentata. Tra loro parlano a lungo dell'opera propria,
s'incensano opportunamente a vicenda, ma ciascuno pensa tra sé: «Come mai
costui... una roba simile?» ecc. La commedia di Leandro va in scena ed è fischiata.
Marcello si rammarica cordialmente del torto fatto al collega... la colpa è stata della
messa in scena... del pubblico sciocco, e così via, ma a tutti va dicendo con
profonda convinzione: «La commedia non valeva una sverza, e i giudici laggiù nel
tenebroso recesso sono stati giusti.» Leandro è piuttosto indispettito e pensa:
«Possibile che il misero pasticcio di Marcello sia superiore al mio, capolavoro?»
Viene il giorno fatale: la commedia di Marcello viene rappresentata... ed è
fischiata. Arriva Leandro ed esclamando: «Oh, mio caro, diletto compagno di
sventura!» abbraccia Marcello e sospira: «Questo tocca a noi, ingegni
incompresi!»
E tutti e due, uniti nell'amarezza, nel dolore, nell'acerba sorte, vanno a bere
una buona bottiglia. Ma appena Marcello esce, Leandro esclama: «La tua
commedia, Marcello, brutta com'è, ha avuto quel che si meritava! Io non ho scritto
una roba simile, è stato l'intrigo di giudici imberbi a farmi ruzzolare.» E appena
esce Leandro, Marcello esclama: «Leandro, come hai potuto illuderti che le tue
insulse spiritosaggini venissero applaudite? La mia commedia invece... la mia
bellissima commedia... guastata da un vergognoso raggiro!»
Infine entrambi si trovano d'accordo nell'ammettere che si è stamburato un
po' in fretta e che i fischietti erano intonati sul secondo la sopra il rigo, come un
musicista presente poté confermare. Rimane una cortese disparità d'opinioni solo
in un punto: in quale delle due commedie abbiano prevalso i tamburi, in quale i
pifferi, e tutti i presenti cantano in chiave di basso il coro: «Chi vorrà qui
giudicare?»
Il Grigio
Divertente, in verità! Ma è certo che per poco o per tanto
entrambi furono temibili avversari del povero direttore che si era fatto
infinocchiare e indurre ad accettare le commedie, indubbiamente senza valore,
poiché, si dica quel che si vuole, il pubblico ha un fiuto sicuro. Chi sa che pioggia
di critiche amare!
Il Bruno Lei deve detestare le critiche teatrali, no?
Il Grigio Infatti, ogni critica che attacca il mio teatro, i miei attori, mi fa
l'effetto di una pugnalata al cuore. Non posso sopportare che mi si osteggi, si
disconoscano i miei continui sforzi, si denigri ciò che intraprendo dopo matura
riflessione. Grazie al cielo, sono arrivato al punto che i critici del mio teatro mi sono
amici.
Il Bruno Che dice? Se ho ben capito, è Lei che ora discute il suo proprio
teatro per il tramite degli amici!
Il Grigio Non posso negare che mi sforzo di combattere gli errati giudizi
sul mio teatro parlando io stesso, iniziato come sono ai reconditi misteri del teatro,
al pubblico interessandovi gli amici.
Il Bruno E non si accorge che proprio così demolisce il principio, che solo
può apportare al teatro vita e movimento?
Permetta che anche qui mi rifaccia a vecchie esperienze. Ero esattamente
del Suo parere quando per la prima volta afferrai il timone di un teatro. Ogni
critica, anche la più giustificata, mi feriva dolorosamente. Non ebbi pace finché con
buone parole, con biglietti gratuiti non riuscii a tirare dalla mia il temuto censore
della cittadina. Allora furono elogi, elogi anche per ciò che non era da elogiare, e
ad ogni rappresentazione di lavori nuovi la saggia, la sapientissima direzione del
teatro, sempre pronta a dedicare con abnegazione tutte le sue energie ai più alti
godimenti artistici, aveva dato un'altra prova della sua insonne aspirazione al
massimo perfezionamento del teatro.
Quegli smaccati incensamenti non mancarono di farmi apparire assai ridicolo
agli occhi dei competenti, benché allora non mi facesse difetto la buona volontà,
ma soltanto l'energia e l'accortezza di elevare il mio teatro al di sopra della
mediocrità. Quei giudizi sul mio teatro ai cui grossolani elogi si aggiungevano di
solito assurdità che pretendevano di essere dotte, e torrenti di parole vane sulla
recitazione dei miei poveri commedianti, divennero oggetto di amari sarcasmi, e
negli altri fogli che circolavano nella cittadina grandinarono le barzellette sul conto
mio e del teatro senza che nessuno si prendesse la briga di studiare a fondo la
qualità del mio teatro e di farmi notare gli errori, anche se palesi. Nella mia cecità
giunsi al punto di conquistare la censura del luogo, sicché nulla si poté più
stampare contro il mio teatro. Fu la mia condanna!
Le persone intelligenti, oneste, mi voltarono le spalle con disprezzo. I miei
attori riposavano sugli allori, offerti loro in abbondanza come fosse paglia, e
diventarono trascurati e prepotenti. Il vero interessamento drammatico svanì a
poco a poco, sicché fui costretto a far vile pompa di costumi e scenari e a
trasformare il teatro in un baraccone delle meraviglie, pur di attirare la gente. Così
non si poteva andare avanti molto. Vidi il mio errore e me ne andai.
Poco dopo ottenni la direzione di un teatro più importante. Dopo un paio di
mesi comparve nel foglio, che circolava nella città, un giudizio sull'attività della mia
compagnia. Lessi con stupore l'acuta e ampia descrizione dei miei attori, ammirai
la profonda competenza con cui lo scrivente valutava ciascuno e a ciascuno
assegnava il suo posto. Ogni fallo, anche il più piccolo, era criticato senza pietà,
ogni trascuratezza mi era rinfacciata apertamente; mi si diceva che ero anzitutto
privo di discernimento nel compilare il repertorio, e così via.
Mi sentii dolorosamente colpito; ma, scaltrito dall'esperienza precedente, mi
feci forza e superai quel disagio. Ragionando a mente fredda dovetti riconoscere
che il censore aveva ragione nel giudicare così aspramente il mio teatro, anche nei
minimi particolari. Ogni settimana compariva poi una critica. Non mancavano le
giuste lodi al merito; con poche parole, invece, energiche e persuasive, senza
declamazioni enfatiche, erano colpiti i difetti, né erano risparmiati i sarcasmi,
quando non si trattava di sola mancanza d'ingegno, ma dell'insolente baldanza
d'uno pseudoartista. Il critico scriveva con tanto spirito, colpiva sempre il bersaglio
così bene, era così profondo conoscitore dell'intima natura del teatro, che per forza
doveva interessare il pubblico e conquistarlo. Di certi numeri si raddoppiava la
tiratura quando davamo una novità importante. Il giornale seminava scintille che
nel pubblico divampavano poi allegramente. Ma insieme con quelle critiche crebbe
anche il vero interessamento al mio teatro, nella misura in cui andava
perfezionandosi grazie alla continua vigilanza mia e degli attori. Ogni attore, anche
il più ragionevole, s'infuria e borbotta quando gli si fa un'osservazione, per
giustificata che sia. Ma soltanto lo sciocco e spavaldo, quando abbia ritrovato la
calma, non si sentirà toccato dalla verità che è sempre vittoriosa. Così i miei
migliori attori seppero stimare il critico spietato, e contro gli sfacciati egoisti quel
galantuomo mi offrì un'arma potente. La paura di essere messi moralmente alla
gogna fu più efficace di tutte le rimostranze, le preghiere, le ammonizioni. Né io né
i miei attori, che pur si diedero in questo punto un gran da fare, riuscimmo a
rintracciare l'ignoto critico. Fu e rimase un oscuro mistero e quindi, anche per il
mio teatro, uno spettro, un babau, che teneva continuamente in ansia me e gli
attori. Così dev'essere. Chi intraprende a scrivere critiche teatrali non deve avere
neanche il minimo contatto col teatro stesso, o deve almeno sapersi dominare
abbastanza da conservare la sua libertà di giudizio, e possedere i mezzi per
nascondere la propria persona.
Il Grigio
Non fosse altro, direi, per non esporsi agli attacchi personali degli
eroi del teatro da lui criticati. Io conoscevo un attore che possedeva un bastone
piuttosto grosso - lo chiamava il bastone del recensore - e una sera al mese, dopo
aver bevuto col critico tranquillamente all'osteria, mentre tornavano a casa, lo
bastonava perché durante il mese l'aveva trattato male.
Il Bruno Dio ci scampi e liberi! Questo è il diritto del più forte! Certo che il
recensore meritava le bastonate, appunto perché si lasciava bastonare.
Ma ritorniamo al mio critico. Alcuni anni erano passati, da un pezzo avevo
abbandonato la direzione di quel teatro, allorché uno strano caso mi fece scoprire
il critico. E con quanto mio stupore! Era un uomo serio, piuttosto anziano, uno dei
primi funzionari del luogo, che io stimavo moltissimo, che spesso m'invitava in
casa sua, e spesso si compiaceva di venire da me, la cui intelligente conversazione
mi ristorava specialmente perché con me non parlava mai di questioni teatrali. Non
potevo supporre neanche lontanamente che l'amico fosse un ardente ammiratore,
un ferrato conoscitore dell'arte drammatica, al punto che non mancava mai alle
mie recite. Soltanto allora appresi da lui stesso che ogni sera, cercando di non farsi
notare, entrava e occupava un posto nelle ultime file della platea. Quando gli
rinfacciai le severe osservazioni che mi aveva fatte, mi guardò negli occhi con quel
suo fare pacato e cortese, mi prese le mani e mi disse con sincera cordialità:
«Vecchio mio, non lo facevo forse per il tuo bene?» E ci abbracciammo con grande
affetto.
Tutto questo però, mio caro collega, avveniva più di venticinque anni or
sono. Ripeto ora, come ho già detto, che quella seria e nobile maniera di scrivere
critiche teatrali appartiene al passato, da quando l'ondata di effimeri periodici,
dove il teatro ha il suo articolo fisso, ci ha sommersi. Oggi le condizioni sono
diverse, il direttore non ha più nulla da temere dalle critiche, ma neanche nulla da
aspettarsi. Per lo più sono superficiali, pronte a incensare per ragioni soggettive,
oppure, per le stesse ragioni, negative, sfavorevoli, prive di nozioni sul teatro,
prive di spirito. Ora, dico io, un direttore deve avere le gambe assai fiacche se
crede di doverle temere o magari di farle scrivere lui stesso indirettamente. Sono
convinto che oggi al direttore d'un teatro non può toccare niente di meglio che
un'opposizione seria e capace. Così dovrebbe essere possibile destare il pubblico
dal suo sonnambulismo, in cui non vuol vedere altro che fantasmagorie, e
interessarlo alla vera arte drammatica. Soltanto in questa, infine, il teatro, dopo
aver ecceduto in tutti gli spettacoli possibili, può trovare la salvezza. Soltanto dalla
lotta movimentata può venire qualcosa di buono, la soporifera melodia dell'eterna
immobile uniformità paralizza ogni energia e ostacola qualunque tensione. Quale
sarà lo stato d'animo d'un direttore quando il pubblico, non curandosi più
dell'autentico dramma, accetta con indifferenza il buono e il cattivo? quando la
recita magistrale del più eccellente ingegno non suscita entusiasmi, ma è accolta
con applausi allo stesso modo del più goffo tentativo d'un principiante privo
d'ingegno?
In verità, soltanto una forte e decisa opposizione può ovviare a questo
letargo, e bisognerebbe che il direttore stesso incoraggiasse il sorgere
dell'opposizione.
Il Grigio Come dice? Il direttore provocare la nascita dell'opposizione?
Creare un proprio nemico sostenendo magari un eventuale pericoloso conflitto con
lui?
Il Bruno Il nemico che ci procuriamo noi stessi è certo il meno
pericoloso...
Il Grigio Oh, via, l'opposizione... forse è il più paradossale di tutti i
paradossi che, devo dire, ha tirato fuori finora in notevole abbondanza. Al Suo
amaro rimprovero che il direttore deve avere le gambe fiacche, se teme le critiche
contro il suo teatro, mi voglio rassegnare, ma non senza farLe notare che
l'istruzione del pubblico intorno all'arte drammatica può venire dal teatro stesso e
perciò è opportuno che anche la critica, avviata sulla strada giusta e pronta a
guidare il pubblico, venga dal teatro stesso.
Il Bruno Lei confonde due cose nettamente distinte. È bensì giusto che la
direzione farà bene a imbandire il vero dramma al pubblico che ne è dissuefatto.
Ma il cibo sarà di nuovo gradito solo quando la preparazione sia senza difetti. Non
basta quindi la scelta dei drammi, occorre anche il modo di rappresentarli, e qui il
direttore non può dare giudizi competenti perché è implicato nel suo mestiere.
L'opera veramente egregia sarà riconosciuta dal pubblico senza alcun bisogno di
segnalazioni, e gli elogi che se ne faranno dopo la rappresentazione, quando il
pubblico abbia trovato giustamente parecchio da ridire, saranno più dannosi che
utili. D'altro canto, chi è il pubblico sopra il quale il direttore vuole innalzarsi, il
pubblico che egli vuole istruire? Forse una massa grossolana e irragionevole?
Lei stesso ha riconosciuto che il pubblico ha sempre un fiuto sicuro; ciò prova
a sufficienza che quella massa misteriosa possiede la facoltà di giudicare.
Misteriosa la chiamo perché quello che diciamo pubblico si presenta
inspiegabilmente come un tutto nel quale scompare l'individualità di ogni singola
parte integrante. Il quesito «di che cosa consta il pubblico?» non si risolve con la
risposta «di Gianni, Giorgio, Pietro e i loro vicini».
Capirà adesso, egregio collega, che non facevo proprio sul serio, quando le
diedi il consiglio di buttare nelle fauci del pubblico, invece dell'infortunato
Gusmann il leone, un qualunque altro giocattolo luccicante.
Il Grigio Eh sì, per quanto le nostre opinioni concordino spesso, devo dire,
carissimo, che Lei mi confonde e non riesco a capacitarmi che sia un direttore di
teatro.
Il Bruno
ci sia al mondo.
Il Grigio
Eppure lo sono davvero, anzi in questo momento il più felice che
Ah... ho capito! Il manoscritto che stava leggendo con visibile
piacere... Scommetto che ha avuto la fortuna di ricevere un'opera egregia da
rappresentare!... Forse di un giovane scrittore, intelligente, che comincia ad aprire
le ali?... Dica, parli! Posso acquistarla per il mio teatro?... Va da sé che pago un
prezzo decente... Proprio ora mi sono intestato a scoprire un giovane poeta e la
sua opera prima...
Il Bruno Leggevo infatti il progetto d'un lavoro squisito, ma non credo che
sia adatto al Suo teatro.
Il Grigio Perché?
Il Bruno Piuttosto ampio... personaggi numerosi... molto macchinario...
Il Grigio Signor mio, Lei dimentica che sono il direttore di un teatro
grande! Per magnificenza di scenari, di guardaroba, per impiego di macchine,
credo che nessun teatro possa misurarsi col mio. Dei miei attori ho spesso da
lamentarmi, è vero, ma nessuna compagnia di giro può vantare, credo, tanti
ingegni quanti sono raccolti nella mia.
Il Bruno Ogni direttore reputa che la sua compagnia sia la migliore di
tutte. Per parte mia credo che i drammi romantici, come quello che ho tra le mani,
non possono essere rappresentati oggidì da nessun'altra compagnia con la
bravura, la maestria, la perfezione che garantiamo noi. I Suoi migliori ingegni si
sforzerebbero invano a presentare al pubblico solo passabilmente questo
meraviglioso spettacolo.
Il Grigio Sono proprio curioso di conoscere il miracolo di poesia che Le è
toccato. È un segreto? Non se ne può sapere nulla?... Chi sarà questo giovane
esaltato scrittore?
Il Bruno Non si tratta di un giovane, ma di uno scrittore vecchio,
ingiustamente dimenticato. Sono in procinto di sceneggiare per il mio teatro la
magnifica fiaba delle tre melarance che l'ottimo Gozzi ci ha lasciato soltanto in
abbozzo.
Il Grigio Come? Vuol mettere in scena la fiaba delle tre melarance? Lei ha
voglia di scherzare!
Il Bruno Niente affatto. Non conosco altro dramma in cui oltre alla
comicità ci stia tanta parte patetica. Nel momento in cui Lei è entrato stavo
appunto pensando al modo più conveniente di tradurre la maledizione della
gigantessa Creonta... Ma io presuppongo che la magnifica fiaba Le sia presente.
Il Grigio Confesso che non è così, perché di roba simile mi occupo ben
poco.
Il Bruno
Dunque: Tartaglia, figlio di Silvio, Re di Coppe, è stregato dalla
Fata Morgana che gli ha fatto prendere nella cioccolata due o tre tragedie
fatalistiche ridotte in polvere sottile. Egli è malato di ipocondria, parla
continuamente delle grandi fatali forbici, con le quali il suo trisavolo, volendo
ritagliare un breve, lo aveva invece tagliato in due, e del nero giorno di San
Bartolomeo, in cui si apre la caccia alla lepre. Si sa che l'incantesimo è rotto non
appena l'infelice principe scoppia in una gran risata, ma tutti i tentativi di farlo
ridere restano infruttuosi, e il Re e la Corte sono afflitti e costernati. Infine
Pantalone, Primo Ministro a Corte, è venuto a sapere che c'è in paese un tipo
faceto alla cui vista nemmeno un Catone saprebbe trattenersi dal ridere. Si va
dunque a chiamare Gaspare (cosi si chiama quel tizio) e difatti i suoi lazzi fanno
piacere al melanconico Principe. Ma non lo inducono a ridere, troppo forte è
l'effetto della polverina. Il fatale giorno di San Bartolomeo non è lontano,
l'ipocondria del Principe diventa sempre più nera. Pantalone si ricorda che quando
era precettore del Principe fanciullo, proprio in quel giorno gli aveva appioppato
una paterna punizione sul di dietro, perché il giovinetto aveva fatto una
scorpacciata di fichi: pensa pertanto che lì debba ricercarsi la causa della malattia
che tormenta il Principe. Per sua iniziativa viene quindi diramato un ordine a tutti
i padri e agli istitutori del palazzo per proibire loro di bastonare in quel giorno i
rampolli, affinché il ben noto strepito dei puniti non rievochi nel Principe l'idea
dell'orrenda fatalità e non lo spinga a risoluzioni disperate. E per distrarlo del tutto
dai suoi tenebrosi pensieri si bandiscono per quel giorno feste e baccanali. Su un
verone compaiono il Re, il Principe ipocondriaco tutto impellicciato, Pantalone e
tutta la Corte. Gaspare è tra la folla ed eseguisce le più matte buffonate. Si fanno
ridicole giostre, arrivano strane maschere, il popolo concorre alle due fontane,
l'una zampilla olio, l'altra vino, e là si fanno contrasti trivialissimi... Ma tutto è vano,
il Principe piange come un bambino, si lagna che l'aria lo molesta, che il rumore gli
introna il capo, e prega infine la Maestà paterna di farlo porre a letto ben caldo. Il
Re e tutta la Corte si sciolgono in lacrime!
In quella compare la Fata Morgana, una ridicolissima vecchierella, con un
vaso per prendere dell'olio alla fontana. Gaspare le fa varie burle e infine la investe
così abilmente da farla cadere a gambe alzate. Nel momento in cui la vecchia cade
il Principe dà in uno scoppio di risa sonore e lunghe. L'incantesimo è rotto.
Morgana, levandosi da terra, rabbiosa, scaglia al Principe queste tremende
parole:
«Apri l'orecchio, o barbaro; passi la voce al core;
Né muro, o monte fermino il suon del mio furore.
Come spezzante fulmine si ficca nel terreno,
Così questi miei detti ti si ficchino in seno.
Come burchio al remurchio tirato è dal cordone,
Te conduca pel naso questa mia imprecazione.
Imprecazione orribile! Solo in udirla mori,
Come nel mar quadrupede, pesce in sui prati e i fiori.
L'altro Plutone io supplico, e Pindaro volante,
Delle tre Melarance che tu divenga amante.
Minacce, preghi e lacrime sien vane larve, e ciance.
Corri all'orrendo acquisto delle tre Melarance.»
Morgana scompare. Tartaglia entra subito in un robusto entusiasmo per
l'amore delle tre Melarance, è condotto via con grandissima confusione della
Corte. Così il primo atto termina in maniera molto patetica.
Nel secondo atto Pantalone, fuori di sé, narra lo stato furioso del Principe che
invoca, come un ossesso, le tre Melarance e vuole dal padre un paio di scarpe di
ferro per poter tanto camminare nel mondo da ritrovare le tre Melarance. E il
Principe disperato per la tardanza delle scarpe di ferro, minaccia di precipitare di
nuovo nell'ipocondria ecc. ecc. Il Re cerca di dissuadere il figliolo con preghiere
commoventi, ma invano. Il Principe insiste, calza le scarpe di ferro e parte con
Gaspare. Il Re cade in deliquio su una sedia, Pantalone lo annaffia con l'aceto e
tutta la Corte si veste a lutto. Il mago Celio, grande amico del regno di Coppe,
s'interessa al Principe e manda il Diavolo Farfarello che con un mantice soffia
dietro a lui e a Gaspare sicché in dieci minuti percorrono duemila miglia. Il vento
cessa all'improvviso ed essi cadono battendo il naso per terra: da ciò argomentano
che le tre Melarance sono vicine. Infatti si trovano nei pressi del Castello della
gigantessa Creonta, la custode delle Melarance. Il mago Celio procura invano di
dissuadere il Principe dalla sua impresa descrivendo i perigli insuperabili connessi
col ratto delle Melarance. Questi perigli consistono in una fornaia che, per non
avere scopa, spazza il forno con le proprie poppe, in una corda da pozzo mezzo
fradicia, in un cane affamato e in un portone di ferro coperto di ruggine per il
tempo. Celio, vedendo il principe risoluto, gli consegna una boccetta d'olio da
ungere il catenaccio del portone, scope da consegnare alla fornaia e del pane da
gettare al cane. Ricorda loro di stendere la corda al sole e, appena rapite le
Melarance, di fuggire dal castello. E scompare. Cambiamento di scena. Si vede il
castello di Creonta, nel fondo un portone fatto a cancello, un cane che passeggia
e ulula affamato, un pozzo con un viluppo di corda appresso, e la fornaia. Tartaglia
e Gaspare ungono il catenaccio del cancello, che tosto si spalanca! Il cane è
chetato col pane, e mentre Gaspare stende le corde al sole e porge le scope alla
fornaia, Tartaglia corre nel castello e ne esce allegro con le tre Melarance rapite.
Improvvisamente si fa notte, si odono gran tuoni, guizzano i lampi e dal
castello esce un'orrenda voce cavernosa:
«O Fornaia, Fornaia, non patire il mio scorno,
Piglia color pe' i piedi, e gettali nel forno.»
Ma la fornaia risponde:
«Io no, che son tanti anni, e tanti mesi, e tanti
Che le mie bianche poppe logoro in doglia, e pianti.
Tu, crudele, una scopa giammai non mi donasti,
Questi un mazzo ne diedero: vadano in pace; e basti.»
La voce urla più terribile:
«O corda, o corda, impiccali.»
E la corda ribatte:
«Barbara, ti ricorda
Tanti anni, e tanti mesi che abbandonata e lorda
Mi lasciasti nell'umido in un crudele oblio,
Questi al sol mi distesero; vadano in pace: addio.»
Sempre più terribile, la voce grida:
«Cane, guardia fedele, sbrana que' sciagurati.»
E il cane risponde:
«Come posso io, Creonta, sbranar gli sventurati?
Tant'anni e tanti mesi ti servii senza pane.
Questi mi satollarono; le tue grida son vane.»
Cavernosa come l'urlo del vento, fragorosa come il tuono, la voce insiste :
«Ferreo Porton, ti chiudi; stritola i ladri infami.»
Il Portone risponde:
«Crudel Creonta, indarno il mio soccorso chiami.
Tanti anni, e tanti mesi ruggine, ed in cordoglio
Tu mi lasciasti: m'unsero; ingrato esser non voglio.»
Ora appare Creonta, la gigantessa, e a questa orribile comparsa Tartaglia e
Gaspare fuggono. Lei con voce tonante lancia loro una maledizione. Appunto a
questa maledizione ero arrivato, quando La vidi entrare e stavo riflettendo sul
modo migliore di tradurre i versi martelliani di Carlo Gozzi. Ascolti queste quanto
mai patetiche parole:
«Ahi ministri infedeli, Corda, Cane, Portone,
scellerata Fornaia, traditrici persone!
O Melarance dolci! Ahi, chi mi v'ha rapite?
Melarance mie care, anime mie, mie vite.
Oimè crepo di rabbia. Tutto...»
...Mentre il Bruno un po' raccontava, un po' leggeva dal manoscritto, il Grigio
faceva capire in tutti i modi possibili la sua impazienza. Balzava in piedi... si
risedeva... beveva rapidamente un bicchiere di vino dopo l'altro..., tamburellava
con le dita sulla tavola, si copriva il viso con ambo le mani, si tappava le orecchie
come chi non vuol più vedere né sentire nulla. Il Bruno pareva non se ne
accorgesse e continuava a parlare con comodo e con calma. Ma il Grigio interruppe
ora i versi italiani che il Bruno veniva recitando.
Il Grigio Basta, basta! Per carità, la smetta!
Il Bruno Non vuole più sentire la storia delle tre figlie di Concul, il Re degli
Antipodi, che erano dentro nelle Melarance? della Principessa Ninetta, vestita di
teletta bianca, che Tartaglia trae dalla Melarancia, e dopo aver bevuto la limonata
da una delle scarpe di ferro rimane viva e, per la malvagità di Morgana, è mutata
in colomba? E come Gaspare nella cucina regia lascia cadere l'arrosto nel fuoco? e
come la colomba lo viene a trovare?
Il Grigio Ma no... no... no!
Il Bruno «Bondì, cogo de cusina. Prego el Cielo che ti te possi
indormenzar, che el rosto se possa brusar; perché la Mora, brutto muso, no ghe ne
possa magnar...»
Il Grigio Pietà, abbia pietà!
Il Bruno E come il Re... e tutta la Corte viene in cucina e Sua Maestà in
collera vuol sapere dell'arresto, perché da un pezzo hanno mangiato il lesso e i
legumi... e come la colomba è presa e, rotto l'incantesimo, si muta in Ninetta...
Come il Principe mezzo svenuto per l'allegrezza, cade tra le braccia di Pantalone,
come si sente male e rutta, come, esclamando: «Questo sì che è un San
Bartolomeo!» rigetta l'ultimo residuo della polverina di Morgana e soltanto così si
sente perfettamente sereno e abbastanza in forze da sposare la bella Ninetta!
Nozze... nozze... rape in composta e sorci pelati...
Il Grigio Non ne posso più!... In verità Lei ha ottenuto il Suo scopo. Le Sue
facezie, la Sua strana ironia mi hanno travolto... Non ho potuto fare a meno di
figurarmi codeste follie sulla scena rappresentate, e la testa mi girava, mi girava...
Il Bruno Non si tratta di facezie, né d'ironia, Le assicuro invece,
seriamente, che darò nel mio teatro la grandiosa fiaba delle Tre Melarance, e
siccome la mia compagnia recita queste cose alla perfezione, sono sicuro che il
pubblico mi compenserà con vivissimi unanimi applausi.
Il Grigio Lei mi vuol gabbare... Parla ancora per enigmi. È forse risorta la
truppa del Sacchi? la dirige Lei? va a recitare nelle fiere, in Italia? Nelle fiere dico:
poiché persino laggiù le fantasticherie che il bizzarro Gozzi imbandisce nelle sue
fiabe sono ripudiate dai teatri stabili, i quali danno soltanto le sue commedie
regolari.
Il Bruno Non offenda il grande genio! Quanta grandezza, quanto
movimento, quanta vita regnano nelle fiabe del Gozzi! Pensi soltanto al Corvo, al
Re Cervo! È inconcepibile come questi stupendi lavori, che contengono situazioni
più forti di quelle che appaiono in certe lodatissime tragedie nuove, non vengano
utilizzati opportunamente almeno come libretti d'opera. Ma le concedo che è
assolutamente impossibile portare ora questi drammi sulle scene, quando non lo
faccia un direttore che disponga di una compagnia eccellente come la mia.
Il Grigio E dalli! Lei parla continuamente dell'eccellenza della Sua
compagnia e cade nel medesimo errore che va rimproverando ai direttori di teatro,
i quali affermano che la loro compagnia è la migliore di tutte. Vorrei proprio sapere
come il direttore d'una compagnia di giro possa...
Il Bruno Pensi pure che tutto quanto ho detto della scelta dei lavori e della
mia compagnia sia una favola, ma è la pura e schietta verità. Finalmente, dopo
molte amare esperienze, dopo tante pene e tanti tormenti sono riuscito a
combinare una compagnia che per la sua bravura, ma soprattutto per l'eccezionale
concordia, non mi ha mai dato fastidi, anzi soltanto gioia. Non c'è componente che
non voglia obbedire al mio volere nel modo di parlare, di gesticolare, di vestirsi,
ecc. in conformità all'opera che stiamo per dare, e non eseguisca la parte secondo
queste direttive anche nei minimi particolari.
Il Grigio Nessun componente?... nessuna opposizione, mai?
Il Bruno Mai! Aggiunga che ognuno e ognuna studia la parte appuntino e
non si permette mai un cambiamento, un'omissione. Noi recitiamo senza
suggeritore.
Il Grigio Impossibile! Gli attori, anche se sanno la parte a memoria, sono
sgomenti appena vedono che nella buca non c'è nessuno.
Il Bruno Noi recitiamo senza suggeritore e non abbiamo mai un intoppo,
mai neanche un attimo d'incertezza, di esitazione. Se Le dico che nelle entrate e
uscite, nei raggruppamenti non c'è mai confusione, poiché a nessuno passa per la
mente di spingersi avanti a scapito degli altri, può immaginare la piacevole
armonia delle nostre recite. Vi contribuisce la grande concordia, l'intima e serena
convivenza che regna nella nostra compagnia. Niente gelosie, niente invidie per
l'assegnazione delle parti, nessun odioso alterco, nessuna frivola canzonatura,
mai! Da noi, grazie al cielo queste cose non ci sono. L'amore nasce dalla reciproca
considerazione del valore artistico. Non s'è mai visto il minimo litigio.
Il Grigio E le donne?
Il Bruno Si abbracciano.
Il Grigio Ahimè, a questo spettacolo mi corrono i brividi lungo la schiena.
C'è sempre da aspettarsi un guaio, un guaio peggiore di quando quel ghiottone
dopo un pranzo stringeva tutti, amici e non amici, al petto o anzi alla pancia,
soltanto per garantirsi una migliore digestione. Già lo sguardo solare in un viso
somiglia spesso al nefasto colpo di sole, cui sogliono succedere tempesta e
temporale, un abbraccio, peggio ancora, somiglia alla «vergine di ferro» che
abbracciando taglia. Mi è occorso di vedere una cantante che buttando le braccia
al collo di un'altra le strinse talmente la gola da impedirle di cantare per parecchie
sere.
Il Bruno Quella era un demonio. L'abbraccio delle mie, invece, è uno
sfogo di sincero affetto. Ed è incredibile quanto poche necessità abbiano i miei
artisti e di quale esigua paga si accontentino!
Il Grigio Artisti!... attori!... poche necessità, esigua paga! Lei mi prende in
giro, Dove ha trovato simili elementi?
Il Bruno Ne ho sempre a disposizione, trovo da per tutto giovani ingegni
desiderosi di dedicarsi all'arte; e, poiché mi pare cosa molto sagace, so come farne
uso. Non più in là di ieri l'altro ho assunto un amoroso, un giovane di ottima indole
e istruzione, di gran talento e d'animo nobilissimo. E qui conto di trovare un padre,
tenero che in questo momento mi manca...
Il Grigio Ehi, che dice? Spero che non vorrà reclutare la sua gente
stornandola dal mio teatro! Stia pur sicuro che, avvezzi come sono alla grandiosità,
non si adatteranno a far parte d'una compagnia di giro.
Il Bruno Che Le viene in mente? Nessuno dei Suoi attori mi può servire.
Il Grigio Dovrò farmi un alto concetto del Suo teatro, se Le pare che i miei
bravi artisti non siano utilizzabili!...
Il Bruno No, infatti, secondo il mio concetto. Io però assumo soltanto
artisti che non abbiano mai messo piede in un teatro.
Il Grigio
Il Bruno
Codesti giovani, senza esercizio, senza pratica...
Recitano, dopo alcune ore di lezione da parte mia, egregiamente
e non si possono distinguere dai miei attori più esperti.
Il Grigio Ah, adesso capisco; come prima con fantasticherie
drammatiche, ora mi burla con una compagnia ideale: artisti come potrebbero
essere. Un castello in aria... della Sua ironica e capricciosa fantasia.
Il Bruno Niente affatto. La mia compagnia ha preso alloggio in questo
stesso albergo. Tutti i miei attori sono nelle camere qui sopra.
Il Grigio Come? Han preso alloggio qui e io non sento alcun rumore. Non
voci squillanti, non gorgheggi, non risate, non persone su e giù per le scale, che
chiamano il cameriere!... Non è pronta la colazione calda? non la colazione
fredda?... Nessun tintinnio di bicchieri?... No, non è possibile!
Il Bruno Eppure sì! Il contegno tranquillo è una delle grandi virtù della mia
compagnia che per questo, arrivando in luoghi sconosciuti, si acquista subito
molta stima. Scommetto che se ne stanno tutti insieme in una camera e mandano
a memoria le parti!
Il Grigio Mio carissimo collega, andiamo di sopra! Coi miei occhi devo
vedere la Sua compagnia: se trovo la conferma delle Sue parole, questo sarà il
giorno più felice, più istruttivo della mia vita. E se poi l'uno o l'altro dei Suoi bravi
artisti avesse voglia di scambiare il teatro di giro con quello stabile...
Il Bruno Come i Suoi attori, egregio collega, non sono adatti per il mio
teatro, così i miei non servirebbero al Suo. Lei sa che un attore, il quale agisce con
pieno successo in un teatro fondato e perfezionato secondo solidi principi, se ne
viene staccato, non fa bella figura su un teatro diverso. Però, andiamo! Venga con
me!
Il Bruno prese il Grigio per mano, salì le scale con lui e aprì una stanza al cui
centro c'era un grande cassone. Dicendo: «Ecco qui la mia compagnia!» ne sollevò
il coperchio...
E il Grigio vide una folla delle più graziose e più ben fatte marionette che
avesse mai viste!